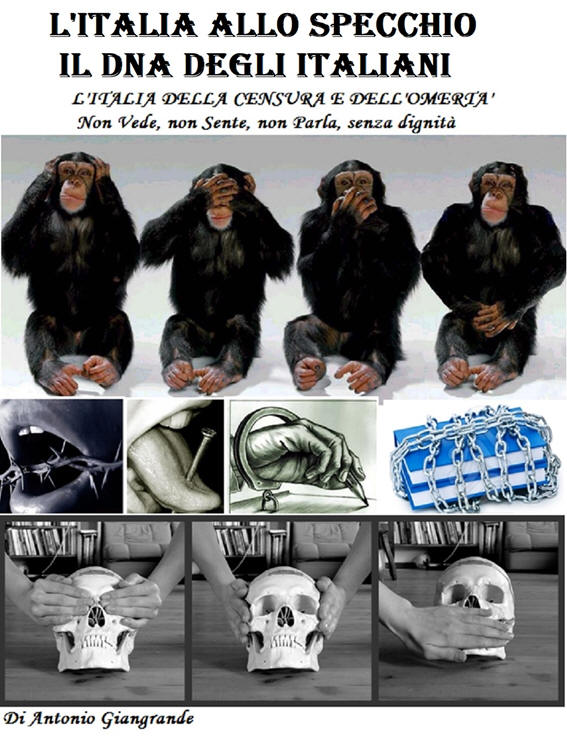Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
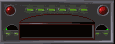
 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA -
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
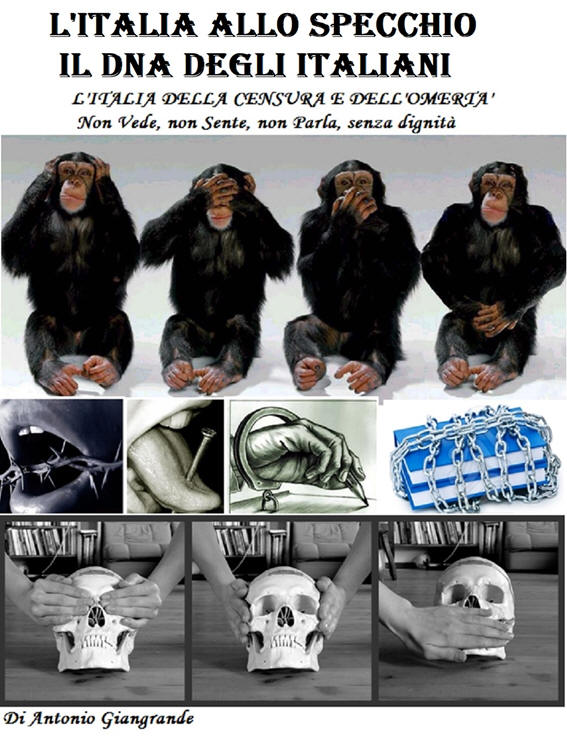
L’ITALIA
ALLO SPECCHIO
IL DNA
DEGLI ITALIANI
ANNO 2022
LA
GIUSTIZIA
SECONDA
PARTE
DI
ANTONIO GIANGRANDE
L’APOTEOSI
DI UN POPOLO
DIFETTATO
Questo saggio è un aggiornamento temporale,
pluritematico e pluriterritoriale, riferito al 2022, consequenziale a quello del
2021. Gli argomenti ed i territori trattati nei saggi periodici sono completati
ed approfonditi in centinaia di saggi analitici specificatamente dedicati e già
pubblicati negli stessi canali in forma Book o E-book, con raccolta di materiale
riferito al periodo antecedente. Opere oggetto di studio e fonti propedeutiche a
tesi di laurea ed inchieste giornalistiche.
Si troveranno delle recensioni deliranti e
degradanti di queste opere. Il mio intento non è soggiogare l'assenso parlando
del nulla, ma dimostrare che siamo un popolo difettato. In questo modo è ovvio
che l'offeso si ribelli con la denigrazione del palesato.
IL GOVERNO
UNA BALLATA
PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
L’ITALIA CHE SIAMO.
UNA BALLATA PER AVETRANA
(di Antonio Giangrande). L’AVETRANA CHE SIAMO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
LA SOLITA INVASIONE
BARBARICA SABAUDA.
LA SOLITA ITALIOPOLI.
SOLITA LADRONIA.
SOLITO GOVERNOPOLI.
MALGOVERNO ESEMPIO DI MORALITA’.
SOLITA APPALTOPOLI.
SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED
ESAMI DI STATO TRUCCATI.
ESAME DI AVVOCATO. LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE
TRUCCATA.
SOLITO SPRECOPOLI.
SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE
SPECULAZIONI.
L’AMMINISTRAZIONE
SOLITO DISSERVIZIOPOLI. LA DITTATURA DEI
BUROCRATI.
SOLITA UGUAGLIANZIOPOLI.
IL COGLIONAVIRUS.
SANITA’: ROBA
NOSTRA. UN’INCHIESTA DA NON FARE. I MARCUCCI.
L’ACCOGLIENZA
SOLITA ITALIA RAZZISTA.
SOLITI PROFUGHI E FOIBE.
SOLITO PROFUGOPOLI. VITTIME E CARNEFICI.
GLI STATISTI
IL SOLITO AFFAIRE ALDO
MORO.
IL SOLITO GIULIO ANDREOTTI. IL DIVO RE.
SOLITA TANGENTOPOLI. DA CRAXI A BERLUSCONI. LE
MANI SPORCHE DI MANI PULITE.
SOLITO BERLUSCONI. L'ITALIANO PER ANTONOMASIA.
IL SOLITO COMUNISTA BENITO
MUSSOLINI.
I PARTITI
SOLITI 5 STELLE… CADENTI.
SOLITA LEGOPOLI. LA LEGA DA LEGARE.
SOLITI COMUNISTI. CHI LI
CONOSCE LI EVITA.
IL SOLITO AMICO TERRORISTA.
1968 TRAGICA ILLUSIONE
IDEOLOGICA.
LA GIUSTIZIA
SOLITO STEFANO CUCCHI &
COMPANY.
LA SOLITA SARAH SCAZZI. IL DELITTO DI AVETRANA.
LA SOLITA YARA GAMBIRASIO. IL DELITTO DI
BREMBATE.
SOLITO DELITTO DI PERUGIA.
SOLITA ABUSOPOLI.
SOLITA MALAGIUSTIZIOPOLI.
SOLITA GIUSTIZIOPOLI.
SOLITA MANETTOPOLI.
SOLITA IMPUNITOPOLI.
L’ITALIA DELL’IMPUNITA’.
I SOLITI MISTERI ITALIANI.
BOLOGNA: UNA STRAGE
PARTIGIANA.
LA MAFIOSITA’
SOLITA MAFIOPOLI.
SOLITE MAFIE IN ITALIA.
SOLITA MAFIA
DELL’ANTIMAFIA.
SOLITO RIINA. LA COLPA DEI PADRI RICADE SUI
FIGLI.
SOLITO CAPORALATO. IPOCRISIA E SPECULAZIONE.
LA SOLITA USUROPOLI E
FALLIMENTOPOLI.
SOLITA CASTOPOLI.
LA SOLITA MASSONERIOPOLI.
CONTRO TUTTE LE MAFIE.
LA CULTURA ED
I MEDIA
LA SCIENZA E’ UN’OPINIONE.
SOLITO CONTROLLO E MANIPOLAZIONE MENTALE.
SOLITA SCUOLOPOLI ED IGNORANTOPOLI.
SOLITA CULTUROPOLI. DISCULTURA ED OSCURANTISMO.
SOLITO MEDIOPOLI. CENSURA, DISINFORMAZIONE,
OMERTA'.
LO SPETTACOLO E LO SPORT
SOLITO SPETTACOLOPOLI.
SOLITO SANREMO.
SOLITO SPORTOPOLI. LO SPORT COL TRUCCO.
LA SOCIETA’
AUSPICI, RICORDI ED ANNIVERSARI.
I MORTI FAMOSI.
ELISABETTA E LA CORTE DEGLI SCANDALI.
MEGLIO UN GIORNO DA LEONI O CENTO DA AGNELLI?
L’AMBIENTE
LA SOLITA AGROFRODOPOLI.
SOLITO ANIMALOPOLI.
IL SOLITO TERREMOTO E…
IL SOLITO AMBIENTOPOLI.
IL TERRITORIO
SOLITO TRENTINO ALTO ADIGE.
SOLITO FRIULI VENEZIA GIULIA.
SOLITA VENEZIA ED IL VENETO.
SOLITA MILANO E LA LOMBARDIA.
SOLITO TORINO ED IL PIEMONTE E LA VAL D’AOSTA.
SOLITA GENOVA E LA LIGURIA.
SOLITA BOLOGNA, PARMA ED EMILIA ROMAGNA.
SOLITA FIRENZE E LA TOSCANA.
SOLITA SIENA.
SOLITA SARDEGNA.
SOLITE MARCHE.
SOLITA PERUGIA E L’UMBRIA.
SOLITA ROMA ED IL LAZIO.
SOLITO ABRUZZO.
SOLITO MOLISE.
SOLITA NAPOLI E LA CAMPANIA.
SOLITA BARI.
SOLITA FOGGIA.
SOLITA TARANTO.
SOLITA BRINDISI.
SOLITA LECCE.
SOLITA POTENZA E LA BASILICATA.
SOLITA REGGIO E LA CALABRIA.
SOLITA PALERMO, MESSINA E LA SICILIA.
LE RELIGIONI
SOLITO GESU’ CONTRO MAOMETTO.
FEMMINE E LGBTI
SOLITO CHI COMANDA IL MONDO: FEMMINE E LGBTI.
LA GIUSTIZIA
INDICE PRIMA
PARTE
SOLITO STEFANO CUCCHI & COMPANY. (Ho scritto un
saggio dedicato)
Una presa per il
culo.
Gli altri Cucchi.
LA SOLITA SARAH SCAZZI. IL DELITTO DI AVETRANA.
(Ho scritto un saggio dedicato)
Un processo
mediatico.
LA SOLITA YARA GAMBIRASIO. IL DELITTO DI
BREMBATE. (Ho scritto un saggio dedicato)
Senza
Giustizia.
SOLITO DELITTO DI PERUGIA. (Ho scritto un
saggio dedicato)
Qual è la
Verità.
SOLITA ABUSOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Parliamo di
Bibbiano.
Vietato scrivere:
“Devastato dalla separazione” o “Il dramma dei padri separati”. Il politicamente
corretto ed i padri mostri folli assassini.
Scomparsi.
La Sindrome
di Stoccolma.
INDICE
SECONDA PARTE
SOLITA MALAGIUSTIZIOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Giustizia
Ingiusta.
La durata
delle indagini.
I
Consulenti.
Incompatibilità ambientale: questa sconosciuta.
Il Diritto di
Difesa vale meno…
Gli
Incapaci…
Figli di
Trojan.
Le
Mie Prigioni.
Le fughe
all’estero.
Il 41 bis
ed il 4 bis.
INDICE TERZA
PARTE
SOLITA GIUSTIZIOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Ingiustizia. Il caso Mani Pulite spiegato bene.
Ingiustizia. Il caso Eni spiegato bene.
Ingiustizia. Il caso Consip spiegato bene.
Ingiustizia. Il caso Monte Paschi di Siena spiegato bene.
Ingiustizia.
Il caso David Rossi spiegato bene.
INDICE QUARTA
PARTE
SOLITA GIUSTIZIOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Ingiustizia. Il
caso Simone Renda spiegato bene.
Ingiustizia. Il
caso Regeni spiegato bene.
Ingiustizia. Il caso Angelo Vassallo
spiegato bene.
Ingiustizia. Il caso Mario Paciolla spiegato bene.
Ingiustizia. Il
caso Alex Schwazer spiegato bene.
Ingiustizia.
L’inchiesta "Why not" spiegata bene.
Ingiustizia. Il
caso di Novi Ligure spiegato bene.
Ingiustizia. Il caso Garlasco spiegato bene.
Ingiustizia.
Il caso
Pietro Maso spiegato
bene.
Ingiustizia. Il
caso Raciti spiegato bene.
Ingiustizia. Il
caso Alma Shalabayeva spiegato bene.
Ingiustizia. Il caso Alberto Genovese spiegato bene.
Ingiustizia.
Il caso Marcello Pittella spiegato bene.
Ingiustizia.
Il caso Angelo Burzi spiegato bene.
Ingiustizia. Il caso Cogne spiegato bene.
Ingiustizia. Il caso Ciatti spiegato bene.
INDICE QUINTA PARTE
SOLITA GIUSTIZIOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Il
tribunale dei media.
Soliti casi
d’Ingiustizia.
Angelo
Massaro.
Anna Maria
Manna.
Cesare
Vincenti.
Daniela
Poggiali.
Diego
Olivieri.
Edoardo
Rixi.
Enrico
Coscioni.
Enzo Tortora.
Fausta
Bonino.
Francesco Addeo.
Giacomo
Seydou Sy.
Giancarlo
Benedetti.
Giulia
Ligresti.
Giuseppe
Gulotta.
Greta Gila.
Marco Melgrati.
Mario
Tirozzi.
Massimo
Garavaglia e Mario Mantovani.
Mauro
Vizzino.
Michele
Iorio.
Michele Schiano di Visconti.
Monica
Busetto.
Nazario
Matachione.
Nino Rizzo.
Nunzia De
Girolamo.
Piervito Bardi.
Pio Del
Gaudio.
Samuele
Bertinelli.
Simone
Uggetti.
INDICE
SESTA PARTE
SOLITA MANETTOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
I Giustizialisti.
I Garantisti.
INDICE
SETTIMA PARTE
SOLITA IMPUNITOPOLI. L’ITALIA DELL’IMPUNITA’.
(Ho scritto un saggio dedicato)
La Cupola.
Gli
Impuniti.
INDICE OTTAVA
PARTE
SOLITA IMPUNITOPOLI. L’ITALIA DELL’IMPUNITA’.
(Ho scritto un saggio dedicato)
Comandano loro!
Fiducia nella Magistratura? La Credibilità va a farsi fottere.
Palamaragate.
Magistratopoli.
Le toghe
politiche.
INDICE NONA
PARTE
I SOLITI MISTERI ITALIANI. (Ho scritto un
saggio dedicato)
Il Mistero
di piazza della Loggia.
Il Mistero
di piazza Fontana.
Il Mistero della
Strage di Ustica.
Il mistero della
Moby Prince.
I Cold Case
italiani.
Il Caso del
delitto del Circeo: Donatella Colasanti e Rosaria Lopez.
La vicenda
della Uno Bianca.
Il mistero
di Mattia Caruso.
Il caso di
Marcello Toscano.
Il caso di
Mauro Antonello.
Il caso di
Angela Celentano.
Il caso di
Tiziana Deserto.
Il mistero di Giorgiana Masi.
Il Giallo
di Ponza: Gian Marco Pozzi.
Il caso di
Cristina Mazzotti.
Il Caso di
Marta Russo.
Il
giallo di Polina Kochelenko.
Il Mistero
di Martine Beauregard.
Il Caso di
Davide Cervia.
Il Mistero
di Sonia Di Pinto.
La vicenda
di Maria Teresa Novara.
Il Caso di
Daniele Gravili.
Il mistero
di Giorgio Medaglia.
Il mistero
di Eleuterio Codecà.
Il mistero
Pecorelli.
Il Caso di
Ernesto Picchioni: il primo assassino seriale italiano del '900.
Il Caso
Andrea Rocchelli e Andrej Mironov.
Il Caso
Bruno Caccia.
Il mistero
di Acca Larentia.
Il mistero
di Luca Attanasio.
Il mistero
di Lara Argento.
Il mistero
di Evi Rauter.
Il mistero di Marina Di Modica.
Il mistero di Milena Sutter.
Il mistero
di Tiziana Cantone.
Il Mistero di
Sonia Marra.
Il giallo
di Giuseppe Pedrazzini.
Il giallo
di
Mauro Donato Gadda.
Il giallo
di Piazzale Dateo, la strage di Capodanno a Milano.
Il Mistero
di Nada Cella.
Il Mistero
di Daniela Roveri.
Il caso di
Alberto Agazzani.
Il Mistero
di Michele Cilli.
Il Caso di
Giorgio Medaglia.
Il Caso di
Isabella Noventa.
Il caso di
Sergio Spada e Salvatore Cairo.
Il caso del serial killer di Mantova.
Il mistero
di Andreea Rabciuc.
Il caso di
Annamaria Sorrentino.
Il mistero
del corpo con i tatuaggi.
Il giallo
di Domenico La Duca.
Il mistero
di Giacomo Sartori.
Il mistero
di Andrea Liponi.
Il mistero
di Claudio Mandia.
Il mistero
di Svetlana Balica.
Il mistero
Mattei.
Il caso di
Benno Neumair.
Il mistero
del delitto di via Poma.
Il Mistero
di Mattia Mingarelli.
Il mistero
di Michele Merlo.
Il Giallo
di Federica Farinella.
Il mistero
di Mauro Guerra.
Il caso di
Giuseppe Lo Cicero.
Il Mistero
di Marco Pantani.
Il Mistero
di Paolo Moroni.
Il Mistero
di Cori: Elisa Marafini e Patrizio Bovi.
Il caso di
Alessandro Nasta.
Il Caso di
Mario Bozzoli.
Il caso di
Cranio Randagio.
Il Mistero
di Saman Abbas.
Il Caso
Gucci.
Il mistero
di Dino Reatti.
Il Caso di
Serena Mollicone.
Il Caso di
Marco Vannini.
Il mistero
di Paolo Astesana.
Il mistero
di Vittoria Gabri.
Il Delitto
di Trieste.
Il Mistero
di Agata Scuto.
Il mistero
di Arianna Zardi.
Il Mistero
di Simona Floridia.
Il giallo
di Vanessa Bruno.
Il mistero
di Laura Ziliani.
Il Caso
Teodosio Losito.
Il Mistero
della Strage di Erba.
Il caso
di Gianluca Bertoni.
Il caso di Denise
Pipitone.
Il mistero di Lidia Macchi.
Il Mistero
di Francesco Scieri.
Il Caso Emanuela
Orlandi.
Il mistero
di Mirella Gregori.
Il giallo
del giudice Adinolfi.
Il Mistero
del Mostro di Modena.
Il Mistero
del Mostro di Roma.
Il Mistero
del Mostro di Firenze.
Il Caso del
Mostro di Marsala.
La misteriosa
morte di Gergely Homonnay.
Il Mistero
di Liliana Resinovich.
Il Mistero di
Denis Bergamini.
Il Mistero di Lucia Raso.
Il Mistero
della morte di Mauro Pamiro.
Il mistero di
«Gigi Bici».
Il Mistero di
Anthony Bivona.
Il Caso di
Diego Gugole.
Il Giallo di
Antonella Di Veroli.
Il mostro di
Foligno.
INDICE DECIMA
PARTE
I SOLITI MISTERI ITALIANI. (Ho scritto un
saggio dedicato)
Il Mistero
di Ilaria Alpi.
Il mistero
di Luigi Tenco.
Il Caso
Elisa Claps.
Il mistero
di Unabomber.
Il caso degli "uomini d'oro".
Il mostro di Parma.
Il caso
delle prostitute di Roma.
Il caso di Desirée Mariottini.
Il caso di Paolo Stasi.
Il mistero di Alice Neri.
Il Mistero di Matilda Borin.
Il mistero di don Guglielmo.
Il giallo del seggio elettorale.
Il Mistero di Alessia Sbal.
Il caso di
Kalinka Bamberski.
Il mistero di Gaia Randazzo.
Il caso di Giovanna Barbero e Maria Teresa Bonaventura.
Il mistero
di Giuseppina Arena.
Il Caso di Angelo Bonomelli.
Il caso di
Massimiliano Lucietti e Maurizio Gionta.
Il caso di
Sabina Badami.
Il caso di
Sara Bosco.
Il mistero
di Giorgia Padoan.
Il mistero
di Silvia Cipriani.
Il Caso di
Francesco Virdis.
La vicenda di
Massimo Alessio Melluso.
La vicenda di Anna
Maria Burrini.
La vicenda
di Raffaella Maietta.
Il Caso di
Maurizio Minghella.
Il caso di Fatmir
Ara.
Il mistero
di Katty Skerl.
Il caso Vittone.
Il mistero
di Barbara Sellini e Nunzia Munizzi.
Il Caso di
Salvatore Bramucci.
Il Mistero
di Simone Mattarelli.
Il mistero
di Fausto Gozzini.
Il caso di
Franca Demichela.
Il Giallo
di Maria Teresa “Sissy” Trovato Mazza.
Il caso di
Giovanni Sacchi e Chiara Barale.
Il caso di
Luigia Borrelli, detta Antonella.
Il mistero di
Antonietta Longo.
Il Mistero
di Clotilde Fossati.
Il Mistero
di Mario Biondo.
Il mistero
di Michele Vinci.
Il Mistero
di Adriano Pacifico.
Il giallo
di Walter Pappalettera.
Il giallo
di Rosario Lamattina e Gianni Valle.
Il mistero
di Andrea Mirabile.
Il mistero
di Attilio Dutto.
Il mistero
del marchese Camillo Casati Stampa di Soncino.
Il mistero
di JonBenet Ramsey.
Il Caso di
Luciana Biggi.
Il mistero
di Massimo Melis.
Il mistero
di Sara Pegoraro.
Il caso di
Marianna Cendron.
Il mistero
di Franco Severi.
Il mistero
di Norma Megardi.
Il caso di
Aldo Gioia.
Il mistero
di Domenico Manzo.
Il mistero
di Maria Maddalena Berruti.
Il mistero
di Massimo Bochicchio.
Il mistero
della morte di Fausto Iob.
Il Delitto
di Ceva: la morte di Ignazio Sedita.
Il caso di
Stefano Siringo e di Iendi Iannelli.
Il delitto
insoluto di Piera Melania.
Il giallo
dell'omicidio di Nevila Pjetri.
Il mistero
di Jessica Lesto.
Il mistero
di Stefania Elena Carnemolla.
L’omicidio
nella villa del Rastel Verd.
Il
Delitto Roberto Klinger.
BOLOGNA: UNA STRAGE PARTIGIANA. (Ho scritto un
saggio dedicato)
Il mistero della
strage della Stazione di Bologna: E’ Stato la Mafia.
LA
GIUSTIZIA
SECONDA
PARTE
SOLITA MALAGIUSTIZIOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
·
Giustizia Ingiusta.
Giustizia solerte e giustizia inerte.
C'è una giustizia
che si muove quando un Pm esonda dai suoi poteri e addirittura se ne infischia
delle decisioni della Cassazione. Augusto Minzolini su Il Giornale il 2 Dicembre
2022
C'è una giustizia
che si muove quando un Pm esonda dai suoi poteri e addirittura se ne infischia
delle decisioni della Cassazione. E il fatto che il Guardasigilli in questione
abbia anche un passato da Pm, come Carlo Nordio, dimostra che non sono i ruoli
che contano ma le persone che li ricoprono. Il ministro della Giustizia ha
deciso su richiesta di Matteo Renzi (che ieri ha sollevato l'argomento nel
question time al Senato) di vederci chiaro sulla decisione dei Pm di Firenze che
hanno condotto l'indagine sulla vicenda «Open» basata sull'accusa di
finanziamento illecito ai partiti: i magistrati, infatti, di fronte all'ordine
dell'Alta Corte di distruggere il materiale sequestrato a Marco Carrai (grande
amico del leader di Italia Viva) senza trattenerne copia perché l'acquisizione
non era stata regolare, hanno fatto spallucce e lo hanno inviato ad un organismo
parlamentare come il Copasir, cioè il comitato di controllo dei servizi segreti.
Una decisione, quella dei pubblici ministeri fiorentini, priva di logica, che è
sfociata solo in una dimostrazione di Potere, o meglio in una vera e propria
sfida nei confronti non solo della Politica ma anche delle altre gerarchie
togate: l'ennesimo messaggio in codice per dire agli altri Palazzi che i Pm
possono tutto. Solo che questa volta ai Pm Nordio ha risposto da Pm e mezzo e
senza scomporsi ha promosso un'indagine conoscitiva «rigorosa» e «con priorità
assoluta» sull'accaduto. Insomma, conoscendo i suoi colleghi il Guardasigilli
non si è fatto intimidire e ha risposto per le rime. Con decisione e in tempi
rapidi, come si dovrebbe non solo per rispetto della Cassazione ma anche degli
imputati.
Sempre ieri, invece,
la Cedu, cioè la Corte europea dei diritti dell'uomo, ha dichiarato
inammissibili i ricorsi di Silvio Berlusconi e della Fininvest per le vicende
delle quote che hanno in Mediolanum. Quote che con una decisione paradossale la
Banca d'Italia ha chiesto di sequestrare perché il Cav avrebbe perso i requisiti
di onorabilità per la condanna di frode fiscale; richiesta che il Consiglio di
Stato avrebbe bocciato senza, però, dare attuazione alla sua decisione. La Cedu
se ne è lavata le mani dicendo che la vicenda riguarda tutti, dall'Unione
Europea alla Bce, meno che lei per cui i ricorrenti non possono chiamare in
causa la responsabilità dello Stato italiano. La Corte europea dei Diritti
dell'Uomo, a quanto pare, decide su tutto, sui migranti, sulle Ong, ha dato
ragione ad un terrorista come Abu Amar in poche settimane e in due anni è
intervenuta in favore di un transessuale georgiano. Ma sulle scelte più delicate
si tira indietro vestendo i panni, a seconda del momento, di don Abbondio o
dell'Azzeccagarbugli. Ad esempio, il ricorso intentato dal Cav sull'assurda
condanna per frode fiscale contro il giudice Esposito pende di fronte alla Corte
di Strasburgo dal 2014. Insomma, sui «casi» più controversi la Cedu, che
preferisce non essere tirata in mezzo nelle polemiche, usa la carta
dell'inerzia. Forse ci sarà un giudice a Berlino ma sicuramente non a
Strasburgo. Appunto, per la giustizia non bastano le toghe, contano soprattutto
gli uomini che le indossano. E il loro coraggio: ieri i giudici della Consulta,
che pure non sono dei cuor di leone, per rispetto e in ossequio al buonsenso,
hanno risposto picche dando cinque schiaffoni ai ricorsi dei medici e dei
professori «no vax».
Da Mannino a
Stasi: ecco perché l’appello del pm è una forzatura del diritto.
Impugnare un
proscioglimento vuol dire forzare i principi del diritto internazionale. Tra i
casi recenti, ci sono quelli clamorosi di De Girolamo e dell’ex primario di
Montichiari, Mosca. Valentina Stella su Il Dubbio il 3 dicembre 2022.
Martedì prossimo in
commissione Giustizia al Senato, nell’ambito del Dl "anti-rave", sarà messo ai
voti anche l’emendamento di Pierantonio Zanettin sull’inappellabilità delle
sentenze di assoluzione.
In realtà il
tentativo di introdurre subito la riforma, pure inserita nel programma di
centrodestra, sembrerebbe destinato a infrangersi su un nulla di fatto. Sarà
quasi certamente così nonostante il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in
una intervista al Gazzettino resa lo scorso 24 ottobre, abbia detto: «Mi chiedo
come si possa condannare in appello qualcuno che è stato già assolto in primo
grado, almeno con la procedura attuale». Ancor prima al Corriere del Veneto
aveva dichiarato: «Se un giudice ha già dubitato al punto da assolvere, o quel
magistrato è irragionevole, e va cacciato via, oppure è sbagliata la norma».
In realtà per
l’Anm si tratta un falso problema, come ci aveva detto il presidente Giuseppe
Santalucia in una intervista: «Il problema vero è quello dell’enorme quantità
dei processi, su cui le impugnazioni del pm non incidono, attestandosi su una
percentuale inferiore al 2%». Al di là delle percentuali, dietro le quali però
si nascondono storie individuali, ci sono tre ragioni che vengono addotte a
supporto dell’inappellabilità delle sentenze di assoluzione: «L’impugnazione del
pm contro questo tipo di decisioni non può convivere con il principio dell’al di
là di ogni ragionevole dubbio», ci disse il presidente dell’Unione Camere penali
Gian Domenico Caiazza, in una intervista. Mentre il professor Paolo
Ferrua ricorda spesso che se l’imputato venisse condannato per la prima volta in
appello, subirebbe un grave pregiudizio, potendo esperire contro la sentenza
solo il ricorso in Cassazione, tanto è vero che il Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici prevede che "ogni individuo condannato per un reato
ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano
riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge".
Più voci sostengono
che dopo una assoluzione non si può rimanere prigionieri del sistema giustizia
per un tempo lungo o indeterminato. E a proposito di storie personali, diversi
sono i casi di cronaca giudiziaria che si muovono tra gli scenari appena
tracciati. Nunzia De Girolamo, ex ministro delle Politiche agricole, nel 2020 è
stata assolta "perché il fatto non sussiste" dalle accuse di associazione a
delinquere, concussione e voto di scambio. Il pm aveva chiesto 8 anni e 3 mesi
di carcere. I giudici del Tribunale di Benevento non riconobbero l’impianto
accusatorio riguardo quella che per la Procura sarebbe stata una «gestione
opaca» del sistema sanitario sannita, con nomine, consulenze e appalti
utilizzati per creare consenso elettorale. L’inchiesta Sanitopoli fu
completamente smontata. Infatti insieme con De Girolamo furono assolti con la
stessa formula tutti gli altri sette imputati. Eppure la Procura fece appello:
quest’anno tutte le assoluzioni sono state confermate in secondo grado.
Nel dicembre 2020 la
Cassazione aveva confermato l’assoluzione dell’ex ministro Calogero Mannino nel
processo stralcio sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. L’uomo era accusato
di violenza o minaccia a Corpo politico dello Stato. L’indagine era partita nel
2012. Nel 2015 viene assolto, sentenza confermata in appello. Nonostante una
"doppia conforme" assolutoria, i pg di Palermo andarono in Cassazione, la quale
diede loro torto.
E che dire
di Alberto Stasi? Accusato per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto
in una calda mattina di agosto a Garlasco, fu assolto con rito abbreviato in
primo e secondo grado, poi la Cassazione annullò la sentenza di assoluzione e
rinviò ad altro appello che lo condannò. Sentenza poi confermata dalla
Cassazione bis. Risultato: 16 anni di carcere e un dubbio enorme sulla sua
colpevolezza.Ci solo altre vicende che ancora non si sono concluse in via
definitiva ma che comunque sono nel solco del tema trattato.
A gennaio di
quest’anno la Corte d’assise del tribunale di Viterbo ha assolto Andrea
Landolfi dalle accuse di omicidio volontario e omissione di soccorso, per cui il
pm aveva chiesto una condanna a 25 anni. Era stato sbattuto su tutte le prime
pagine come l’ennesimo autore di un femminicidio. Tutto falso per i giudici di
primo grado. Nonostante questo la Procura ha fatto appello, iniziato da un mese.
Altro caso recente è quello di Gianni Ghiotti. Nel 2020 si era presentato dai
carabinieri dicendo che aveva soffocato con un cuscino la madre, anziana e
gravemente malata, per mettere fine alle sue sofferenze. Il giudice di Asti però
lo assolve perché stabilisce che la madre era morta per cause naturali. «Ha
raccontato – scrive il giudice nella decisione – qualcosa di cui è intimamente
convinto ma che non corrisponde alla realtà dei fatti». Due giorni fa invece la
Corte di Appello di Torino lo ha condannato a 6 anni e 8 mesi accogliendo la
tesi del Pg.
Altra vicenda: l’ex
primario del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari Carlo Mosca era stato
arrestato per omicidio volontario: secondo la Procura, nel pieno della pandemia
(marzo 2020), l’uomo avrebbe somministrato farmaci poi risultati letali a due
pazienti. La Corte d’assise di Brescia lo ha assolto motivando così: è stato
vittima di "un’accusa calunniosa di omicidio, tanto più infamante in quanto
rivolta a un medico, ossia a una persona avente vocazione salvifica e non
certamente esiziale. Di enormi proporzioni è stata soprattutto l’afflizione
arrecata all’imputato, che ha patito un’ingiusta e prolungata limitazione della
libertà personale e rischiato di subire una condanna all’ergastolo, con
gravissime ripercussioni sul piano sia umano che professionale, cui il verdetto
assolutorio può porre solo parziale rimedio". Un mese fa la Procura ha
annunciato il ricorso in appello.
Caos sul blocco
della norma "Salvaladri". Ogni giudice la interpreta a suo modo.
Luca Fazzo il 13
Novembre 2022 su Il Giornale.
Altro che giustizia
uguale per tutti. Da un tribunale all'altro, la legge contenuta nella riforma
Cartabia è applicata discrezionalmente
«Io sono Dio e posso
prendere tutto quello che mi serve»: arrestato mentre cercava di rubare,
tranciando con i denti il cavo di sicurezza, un iPhone da un negozio milanese,
un afgano di trent' anni si è giustificato così davanti al giudice. La commessa
che aveva cercato di fermarlo lo ha denunciato. Ma il giudice Mariolina Panasiti
ha deciso che non poteva tenerlo in carcere: merito (o colpa) del decreto
«salvaladri» firmato in agosto dall'allora ex ministro della Giustizia Marta
Cartabia. Un decreto di cui il nuovo governo ha deciso di rinviare l'entrata in
vigore, ma che intanto ha dispiegato in parte i suoi effetti. Facendo uscire dal
carcere qualche ladro, come l'afghano di cui sopra. E soprattutto aprendo uno
scontro all'interno della magistratura, tra il politico e il dottrinale, su come
comportarsi davanti a una norma congelata quando mancavano poche ore alla sua
entrata in vigore.
A catapultare in
orbita la faccenda è stato il giudice senese Simone Spina, che l'altro ieri -
sospendendo il processo a un imputato di violenza privata - ha trasmesso alla
Corte Costituzionale il provvedimento con cui il premier Giorgia Meloni e il suo
ministro Carlo Nordio hanno stoppato l'entrata in vigore della riforma Cartabia:
il provvedimento sarebbe addirittura incostituzionale. Ma in attesa che si
pronunci la Consulta, e che il Parlamento a egemonia centrodestra ratifichi o
modifichi il decreto «salvaladri», cosa fare delle migliaia di accusati di furto
che non sono stati querelati dalle vittime, che la «Cartabia» avrebbe reso non
punibili ma che attualmente si trovano in carcere?
Nei giorni scorsi
sul tema è intervenuto il Massimario della Corte di Cassazione, l'ufficio che si
occupa di evidenziare i principi di diritto contenuti nelle sentenze, e che
stavolta si è addentrato in una analisi approfondita della situazione inedita
creata dal blocco in extremis della riforma. Ebbene, secondo il Massimario non
ci sarebbe dubbio: visto che le vittime dei reati hanno novanta giorni di tempo
per sporgere querela, «in questo limbo di procedibilità la misura dovrebbe
essere mantenuta». Chi è in carcere, insomma, dovrebbe restare in carcere. Il
giudice milanese Marco Tremolada, coordinatore delle sezioni penali del
tribunale meneghino, ha diramato a tutti i suoi colleghi la circolare del
Massimario. Non c'è un obbligo di attenersi alle indicazioni, ma il messaggio è
chiaro: per adesso non scarcerate. Peccato che ci siano giudici che non la
pensano affatto così: come la Panasiti, il magistrato milanese che ha scarcerato
il ladro afghano. La quale rimarca come il nuovo governo non abbia cancellato la
riforma Cartabia, ma solo rinviato al 30 dicembre la sua entrata in vigore.
«Appare di intuitiva evidenza - scrive -, che la imminenza dell'entrata in
vigore del decreto legislativo» fa sì che il ladro quando verrà giudicato verrà
assolto, e questo rende fin da subito impossibile tenerlo in carcere.
Capire chi ha
ragione e chi torto risulta, davanti alla complessità tecnica della faccenda,
praticamente impossibile. Di fatto, da un tribunale all'altro, e all'interno
dello stesso tribunale, si stanno verificando interpretazioni diverse, e di
conseguenza trattamenti diversi per imputati identici.
Il grande squilibrio dei poteri. Lo strapotere dei pm e le
ingerenze nella politica sui migranti: le Procure indagano a loro piacimento.
Gennaro De Falco su Il Riformista l’11 Novembre 2022
I recentissimi
sbarchi di massa dalle navi della Ong di immigrati in corso in Italia non
possono non indurre ad alcune riflessioni di ordine politico istituzionale. Non
è questa la sede per affrontare il fenomeno in termini ideologici o etici su cui
possono esistere ed esistono posizioni assolutamente divergenti e su cui non
voglio entrare perché tutte le diverse sensibilità che esistono meritano
comunque il massimo rispetto ed anche per non abusare dello spazio che mi viene
assai generosamente concesso su queste pagine, ma è assolutamente un fatto che
il fenomeno in tutto il bacino mediterraneo interessi in maniera assai massiccia
soprattutto il nostro Paese.
È inoltre
assolutamente un fatto che i governi “politici” che si sono susseguiti in questi
anni ricevendo, piaccia o non piaccia, un ampio consenso elettorale proprio su
questi temi hanno poi dovuto abdicare immediatamente lasciando scendere e
rimanere in Italia tutti coloro che sono riusciti a giungere sulle nostre coste.
È inoltre un fatto che anche la Chiesa, che in un primo momento ha
esplicitamente sostenuto gli arrivi, ora sembra avere assunto un atteggiamento
più prudente ma, nonostante il più o meno condivisibile atteggiamento
chiaramente ostile dell’elettorato e delle forze politiche prevalenti, il
fenomeno, giusto o non gusto che sia, si sta intensificando e sembra del tutto
inarrestabile. A questo punto bisogna chiedersi le ragioni per le quali
l’Italia, nonostante gli esiti elettorali, sia divenuta ormai stabilmente
la porta di ingresso dell’Europa. A ben vedere la ragione è evidente e
chiarissima e la si trova nelle intercettazioni emerse nella
vicenda Palamara. Secondo quanto riportò La Verità nell’agosto 2018, a proposito
della questione migranti e le presa di posizione di Salvini, il capo della
Procura di Viterbo Paolo Auriemma (non indagato) disse a Palamara: «Salvini
indagato per i migranti? Siamo indifendibili». Ma Palamara replicò: «No hai
ragione, ma ora bisogna attaccarlo».
Queste conversazioni
finite tutte nel dimenticatoio, come sempre accade in questo Paese quando un
fatto è troppo grosso per poterlo affrontare, unitamente alle successive vicende
giudiziarie e la sconcertante vicenda dello speronamento della motovedetta
della Guardia di Finanza ci spiegano le ragioni del fenomeno che ci rende
assolutamente unici in tutta Europa. Ripeto, in questa sede non voglio entrare
nel merito di quanto è accaduto ed accade e dire se secondo me sia giusto o
sbagliato ed anche se sia sostenibile dall’ Italia o dall’Europa ma solo
comprendere ed interpretare le ragioni di questo stato di cose. Ebbene, secondo
me la ragione di quanto accade, piaccia o non piaccia, sta soprattutto nella
riforma legislativa che nel 1993 ha soppresso l’immunità parlamentare
determinando il totale squilibrio dei poteri e nei poteri e svuotando di ogni
contenuto reale la democrazia rappresentativa. Non nascondiamoci dietro un dito,
la vera ragione di questo stato di cose è il fondato timore della politica di
assumere iniziative di contrasto effettivo verso gli sbarchi per il timore di
subire gli attacchi del potere giudiziario o meglio dei pm.
In effetti al giorno
d’oggi i poteri dei singoli uffici di Procura sono amplissimi e sono acuiti dal
fatto che le norme sulla competenza territoriale sono opinabilissime. In pratica
ogni pm può indagare ed emettere provvedimenti a suo piacimento. Del resto mi
pare che anche l’attuale ministro della giustizia ritenga necessario il
ripristino proprio dell’immunità parlamentare, staremo a vedere. Si potrà dire
che se ciò avvenisse la lotta alla corruzione si indebolirebbe; ora, a parte il
fatto che non mi pare che con la riforma del ’93 il fenomeno della corruzione si
sia ridotto, certamente si è molto ridotta la nostra libertà e, a questo punto,
c’è da chiedersi quale è il prezzo che su questi temi ancora si vuole e si può
pagare. Oggi è così con l’immigrazione ma se il fenomeno si consolidasse e
ampliasse anche in ambito industriale, come del resto è già avvenuto
a Taranto, cosa accadrebbe o magari accadrà? A me pare evidente, quale che sia
l’atteggiamento verso le migrazioni, che un riequilibrio del rapporto tra e nei
poteri dello Stato sia indispensabile ed urgente e che lo snodo fondamentale di
questo riequilibrio non possa non essere il ripristino dell’immunità
parlamentare e magari anche l’introduzione di rigide incompatibilità che
regolino l’accesso in politica dei magistrati. Gennaro De Falco
Così le leggi
d’emergenza hanno generato mostri… Mostri in carne e ossa.
Erano gli anni del
terrorismo e della repressione di uno Stato impaurito che si aggrappò a risposte
che fecero vacillare lo Stato di diritto. Lanfranco Caminiti su Il Dubbio il 12
novembre 2022.
Mi chiesero: «Lei è
responsabile dei reati che le sono ascritti?» Risposi veloce: «Sì».
Non era vero, e lo
sapevano anche loro – ma non importava. C’era il reato associativo e questo
bastava. E con il “concorso morale”, di qualunque gesto fosse stato responsabile
uno di noi, ne eravamo tutti colpevoli. D’altra parte, anche noi la pensavamo
così: “loro” erano una associazione, “loro” erano tutti colpevoli, fosse anche
per omissione, e quanto meno per concorso morale. Gli uni e gli altri, ci
eravamo comportati di conseguenza.
Al primo processo a
Napoli mi diedro 8 anni, era caduta l’accusa di banda armata
Il primo processo a
Napoli – per associazione sovversiva e banda armata che aveva operato al Sud –
mi diedero otto anni; era caduta l’accusa di banda armata: non eravamo così
temibili, non c’erano gravi reati di sangue, qualche attentato, qualche rapina.
Mi andò bene perché l’avvocato mi convinse a prendere parte a un riconoscimento:
c’era un testimone. Io non ne avevo intenzione – non partecipavamo ai “riti del
processo”, ma lui mi disse una cosa del tipo: “Che ti costa, tanto non ti
riconosce”. Così andai, e in effetti il testimone disse che – no, non ero io
l’affittuario del covo. Così evitai forse qualche anno in più, anche se invece
lo diedero a un mio compagno che era rimasto fedele all’impegno di non accettare
confronti e venne considerato, lui, l’affittuario del covo dove avevano trovato
tutto il materiale che riconduceva ai vari attentati. Ero io, l’affittuario, ma
andò così: a loro serviva uno qualunque.
Nel secondo processo
a Roma, il primo costruito intorno ai “pentiti”, mi diedero 30 anni
Il secondo processo,
a Roma, mi diedero invece trent’anni. Qui c’era un’altra banda armata e c’erano
tanti reati, al nord, al sud e al centro: non c’erano morti, per fortuna. Fu il
primo processo costruito intorno ai “pentiti”. Tutti venimmo considerati
responsabili di tutto. Era il “concorso morale”, dispiegato in pieno; al di là
anche di una mera considerazione “geografica”: che i meridionali fossero
colpevoli dei reati al Sud, e i settentrionali di quelli a Nord – macché.
Stavolta tutti avevamo degli avvocati – tutti quelli in aula, altri erano
latitanti da anni. Ma erano come imbambolati, basiti – aspettavano che passasse
la buriana. Ma il pm giocava sporco.
Durante
l’interrogatorio di uno di noi il pm citò il processo di Napoli per costruire
connessioni e responsabilità e aggravare un quadro fosco di pericolosità – a
esempio, la quantità di armi a disposizione. Che era stata invece proprio la
motivazione in sentenza per attenuare la nostra pericolosità. Dalla gabbia in
aula, chiesi di intervenire e spiegai. La cosa irritò molto il pm. Irritò anche
gli avvocati difensori – era una osservazione banale ma puntuale che avrebbe
potuto fare uno qualunque di loro, ma non conoscevano la cosa e d’altronde
quanti mai procedimenti avrebbero dovuto conoscere, quante migliaia di carte
avrebbero dovuto sapere? Loro aspettavano che passasse la buriana.
Avevo scritto di
aver “contribuito all’estinzione di quella organizzazione”, ma per il pm era
“all’estensione dell’organizzazione”
A me avevano
sequestrato in carcere dei fogli su cui stavo scrivendo una sorta di mia memoria
difensiva. Nei carceri speciali – e io li ho girati quasi tutti – facevano di
queste cose: servivano per le loro “prove”. Bene: avevo scritto che avevo
“contribuito all’estinzione di quella organizzazione” – e era andata proprio
così: ci eravamo sciolti, troppo militarismo e il rapporto con strutture di base
di lotta, di cui ci consideravamo solo il braccio operativo, armato, si stava
perdendo, si era perso. Non volevamo essere come le Br.
Il pm usò quei fogli
per dire che io avevo contribuito “all’estensione dell’organizzazione”: un
piccolo slittamento semantico che diceva proprio l’opposto: d’altronde, ero un
“colonnello” – e quei gradi dovevano ben significare qualcosa. Lo feci notare,
come prima; e come prima, il pm stizzito, gli avvocati impagliati. E
così, arrivammo ai trent’anni.
In Cassazione il
giudice Carnevale smontò il nostro “concorso morale”
In appello,
divennero ventitrè. Non cambiava poi molto. Poi, finimmo in Cassazione, e qui
trovammo il giudice Carnevale. Non sono in grado di dare un giudizio sull’uomo,
che suscitò molte controversie e una campagna aggressiva, anche perché la sua
“linea di condotta” non si applicò solo alla nostra sentenza ma,
successivamente, a altre per associazione mafiosa; ma Carnevale smontò il nostro
“concorso morale”. Fu la prima volta, il primo processo per il quale decadde –
anche se la cosa non provocò un “ripensamento” dei legislatori. Così, noi
tornammo in appello.
Avevamo iniziato uno
sciopero della fame. Durò trentadue giorni e io arrivai a pesare cinquantadue
chili
Nel frattempo, era
intervenuta la legge per la dissociazione – e io ne ero stato, nell’Area
autonoma di Rebibbia, tra quelli che si era impegnato di più negli incontri con
politici, dirigenti dell’amministrazione penitenziaria (con qualcuno sono ancora
in contatto), personalità ecclesiastiche, giornalisti, per portarla avanti.
Quasi tutti noi del secondo processo vi aderimmo. Ma io uscii per il mio stato
di salute: ero prostrato e frustrato, anche per vicende personali. Ero stato
arrestato a aprile del 1978 – in pieno sequestro Moro: eravamo finiti a
Poggioreale, sparsi tra i padiglioni dei detenuti comuni; poi, avevano deciso di
isolarci in un repartino, e lì avevamo iniziato uno sciopero della fame. Durò
trentadue giorni, e io arrivai a pesare cinquantadue chili e un mio compagno
perse un rene; ma dissero che ci avrebbero riportato nei padiglioni e intanto ci
misero in quello sanitario per riprenderci; poi, di notte, ci impacchettarono e
ci portarono negli speciali: il generale dalla Chiesa aveva deciso così, eravamo
sulla sua lista. E iniziò il mio percorso nel “circuito dei camosci”: uscii a
febbraio del 1985, ma agli arresti domiciliari, fino a novembre – altri nove
mesi infernali. Poi, tra cumulo e legge della dissociazione finì che feci più
carcere di quello che mi toccava. Capitava, con la giustizia forfettaria. Un
tanto a chilo – che faccio, lascio? Lasci.
Le leggi di
emergenza sono state mostruose
La legislazione
d’emergenza è stata mostruosa e ha costruito mostri: non parlo solo delle
“figure giuridiche” ma delle persone in carne e ossa. E dalla parte dei
“combattenti” e dalla parte dello Stato. C’è un episodio emblematico. Siamo
verso i colpi di coda del terrorismo – dopo le confessioni di Peci e le
centinaia di arresti. Un gruppo che si era costruito intorno la figura di un ex-
detenuto che si era politicizzato in carcere avvicinandosi alle Br e era poi
uscito a fine pena – compie una rapina alla fine della quale uccide due guardie
giurate, ormai disarmate e a terra, lasciando un volantino di “campagna contro
la dissociazione” accusando un’altra terrorista, da poco arrestata, di essere in
realtà un’infiltrata dei servizi segreti. Nell’aula di un processo che si
svolgeva in quei giorni, viene letto un comunicato delle BRrche smentisce
categoricamente che la terrorista accusata sia un’infiltrata – avevano fatto una
“indagine interna”; implicitamente, prendono le distanze da quella azione. Il
gruppo viene arrestato e succede che alcuni finiranno con chiedere la legge
sulla dissociazione. È il caos totale.
Ci trovammo
imprigionati tra leggi di emergenza e terrorismo
In un bel libro
di Fernando Aramburu, Patria, i cui personaggi vivono in una cittadina dei Paesi
Baschi dilaniata dalle azioni dell’Eta e dagli schieramenti, anche all’interno
di una stessa famiglia, che esse provocano, un giovane militante accusato di
gravi reati finisce all’ergastolo: è arrogante, rabbioso, fragile nella sua
ideologia. Aramburu non ha tentennamenti nel mostrarci l’insensatezza delle
azioni armate, l’alone di sostegno, convinto o forzato, e la scia di dolore che
esse provocano – non ha neppure tentennamenti nell’additare la violenza dello
Stato e del carcere e delle torture. Era quella stessa spirale di violenza in
cui ci trovammo imprigionati qui – tra legislazione d’emergenza e
terrorismo. Quando l’Eta dichiara finita la lotta armata, quelli rimasti in
carcere erano i più refrattari, e chi mostrava dubbi o perplessità veniva
ostracizzato, isolato. Tra loro, il giovane protagonista della storia, che
intanto è invecchiato, che intanto si è staccato da tutto, dai suoi antichi
compagni e anche da se stesso. Gli rimane solo un pezzo della sua famiglia.
In Italia mancò una
soluzione politica al terrorismo: la “linea della fermezza” dal sequestro Moro
non ebbe più incrinature, ripensamenti, riletture
Quello che mancò
anche in Italia – e che finì per caricare tutto sulle spalle discrezionali della
magistratura, che assunse un ruolo di supplenza e salvifico, quindi con una
sorta di “investitura” sociale e morale – fu una soluzione politica al
terrorismo. Il che significa che una questione politica venne trattata solo come
questione criminale – fatto questo che nella storia di questo paese non è
propriamente del tutto nuovo. Mancò, quel ruolo, soprattutto quando le due
principali organizzazioni della lotta armata, le Brigate rosse e Prima linea,
l’avevano sostanzialmente dichiarata finita. Mancò, intendo, da parte delle
principali forze politiche del paese: la “linea della fermezza” che era scesa in
campo, con enorme sostegno della stampa, durante il sequestro Moro non ebbe più
incrinature, ripensamenti, riletture. Non le ha mai più avute.
E in un modo e
nell’altro – sempre lì si viene rimandati. Sono passati quarantaquattro anni dal
16 marzo 1978 – e la “soluzione biologica”, ovvero la naturale morte sta ormai
prendendo il posto di ogni ipotesi di soluzione politica. Chissà, magari prima
di arrivare a cinquanta se ne potrebbe riparlare. Giusto per dire, che ormai.
Capita ripetutamente che negli istituti superiori dove qualche insegnante si
avventura nei territori della storia contemporanea, alla domanda sui
responsabili della strage di piazza Fontana la risposta degli studenti sia: le
Brigate rosse. Nel buio della conoscenza, tutte le vacche sono nere.
Errore di
battitura nell’accusa, l’indagato resta in carcere.
Una svista, un
semplice errore materiale - questa la spiegazione del giudice -, ma tale da
condizionare il diritto di difesa di un uomo. Canestrini: «La libertà vale così
poco?» Simona Musco su Il Dubbio il 24 novembre 2022.
«Una storiella di
diritti e giochetti». L’avvocato Nicola Canestrini, del foro di Rovereto, è
letteralmente infuriato. Avvilito, verrebbe da dire, di fronte ad un caso tanto
semplice quanto assurdo da raccontare.
La storia è quella
di un 31enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di 30 grammi lordi di
cocaina, il cui principio attivo risulta ancora sconosciuto. Una storia comune,
una di quelle che affollano quotidianamente le aule di tribunale, se non fosse
per un particolare: la contestazione è cambiata dopo l’udienza di convalida, di
fatto impedendo al legale di poter difendere il proprio assistito adeguatamente.
Una svista, un semplice errore materiale – questa la spiegazione del giudice -,
ma tale da condizionare il diritto di difesa di un uomo che così è rimasto in
carcere.
«Secondo il codice
procedurale, l‘arresto deve essere convalidato da un giudice entro quattro
giorni. In questo periodo, l’accusa deve anche decidere se chiedere una misura
cautelare, cioè se ritiene che ci sono oltre gravi indizi di colpevolezza, anche
pericolo di fuga o di reiterazione del reato o di inquinamento probatorio –
racconta Canestrini in un post-sfogo su Facebook -. La Procura chiede dunque il
carcere per l’arrestato, ma contesta il fatto di lieve entità (articolo 73 testo
unico stupefacenti, comma 5)».
A seguito della
sentenza della Corte costituzionale che dichiarò illegittime le previsioni della
legge Fini-Giovanardi, infatti, il legislatore modificò, tra le altre cose, i
limiti edittali contemplati dal comma 5, riconoscendo lo stesso articolo quale
fattispecie autonoma di reato, modificando il precedente dl 146 del 2013 che lo
concepiva quale mera circostanza attenuante. Le modifiche portarono ad una
riduzione della pena e così si è passati dalla reclusione da uno a cinque anni
alla reclusione da sei mesi a quattro anni, se la condotta criminosa, per i
mezzi, le modalità o le circostanze ovvero per la quantità e qualità delle
sostanze, è di lieve entità. La modifica incise anche sulle misure precautelari
e cautelari, data l’impossibilità di procedere all’arresto obbligatorio in
flagranza e/o di disporre la custodia cautelare in carcere.
Da qui la chiara
strategia difensiva di Canestrini, che con una breve memoria esplicativa – dopo
aver visitato l’uomo in carcere di domenica e aver rassicurato la famiglia – si
è opposto alla richiesta di convalida davanti al giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Rovereto. Insomma, un caso semplice e subito
chiuso, normalmente. Ma non nel caso in questione: «Incredibilmente il giudice,
dopo aver interloquito con il pm dopo l’udienza (dato che in udienza in carcere
il pm non si è presentato), espone la strabiliante tesi che la contestazione del
comma 5 era un “errore materiale”, che al posto del “5” doveva leggersi “1”,
dato che il comma 1 prevede lo spaccio grave che sorregge arresto e misura
cautelare carceraria», afferma Canestrini.
Un errore
rettificato dal pm solo successivamente all’udienza di convalida e che dunque ha
impedito allo stesso difensore di preparare una strategia alternativa per la
difesa del suo assistito, che, dunque, è rimasto in carcere. Il giudice parla di
un «un evidente errore materiale di battitura», ravvisabile nel «riferimento al
comma 5 dell’articolo 73 Dpr 309/1990, anziché al comma 1, relativo alle
sostanze di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14 del Dpr 309/1990, tra
cui rientra la cocaina, alla quale sia nella parte in fatto dell’imputazione,
così come nella parte motiva, vi è il chiaro e inequivoco riferimento, quale
oggetto dell’illecita detenzione per cui è stato disposto l’arresto.
Trattasi dunque, in
concreto, di fattispecie che rende non solo obbligatorio l’arresto in flagranza,
ma che sorregge la misura cautelare detentiva in carcere a norma dell’articolo
280 del codice di procedura penale». E tanto basta, dunque. «La nostra libertà è
quindi appesa alla possibilità che un 5 significhi in realtà un 1 – ha concluso
il legale -. Ma la libertà è davvero così poco importante da meritarsi questo?».
Denuncia la
figlia per errore, una vicenda assurda per una carta di credito “rubata” al
padre.
Alberto Cisterna su Il Riformista l’11 Novembre 2022
Una storia come
tante altre. Una carta di credito qualunque, l’avviso sul cellulare di un
addebito. L’uomo che, preoccupato dall’importo, cerca di capire cosa sia
accaduto e scopre subito l’acquisto di qualcosa di molto costoso in uno dei
negozi dello shopping di lusso della Capitale. Di lì a chiamare i Carabinieri un
attimo. Una pattuglia si fionda al negozio e chiede di visionare le telecamere
di sicurezza. Si vedono due ragazze e un ragazzo intente all’acquisto di
qualcosa. Si vede la borsa costosa finire impacchettata e una delle due ragazze
accostarsi alla cassa per pagare con una carta di credito.
I Carabinieri,
giustamente soddisfatti, avvisano l’uomo che può recarsi in caserma per
denunciare l’accaduto, ci penseranno loro a identificare i tre mascalzoni.
L’uomo torna a casa, racconta l’accaduto in famiglia e si accorge, però, che la
carta di credito non era nel solito cassetto della sua scrivania, che qualcuno
l’ha portata via. Corre in caserma e racconta l’accaduto ai militari i quali, a
quel punto, mostrano il video al malcapitato che, con sgomento e sorpresa,
scopre che la ragazza alla cassa intenta a pagare è sua figlia. Ovviamente
lavata di capo, urla e strepiti. La ragazza, da poco maggiorenne, si era
invaghita di un tizio belloccio che, insieme alla sua complice, aveva convinto
la poverina al gesto ossia a fare un regalo alla tipa che l’accompagnava e così
la frittata era stata fatta.
Il codice
penale di Mussolini, quello che il ministro Nordio giura di voler modificare, in
una norma di straordinaria saggezza prevede che il furto di denaro tra familiari
conviventi non sia punibile. Persino il fascismo comprendeva che doveva evitare
di mettere il naso tra le mura del focolare domestico e che se la moglie portava
via soldi al marito o un figlio al padre erano pur cavoli loro. La morale
fascista è un conto, ma la pace familiare è questione delicata da cui persino un
regime totalitario preferiva stare alla larga. Tutto a posto, quindi. Manco a
dirlo. Nel 2007, in ossequio ai soliti obblighi eurocomunitari, il legislatore
aveva previsto un apposito reato – poi confluito nel Codice penale (art.
493.ter) – in forza del quale chiunque utilizza indebitamente «non essendone
titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai
contanti» è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310
euro a 1.550 euro.
Vabbè e che importa?
direbbe l’uomo qualunque, il saggio cittadino, la brava madre di famiglia. Se la
figlia avesse prelevato il denaro in contanti dalla cassaforte o dal cassetto
della camera da letto dei genitori non sarebbe stata punibile, a chi importa
che, invece, abbia comprato la borsa di lusso con la carta di credito
dell’ignaro genitore? Sempre soldi sono. In un paese normale il discorso non
farebbe una piega. Anche in un ordinamento giuridico normale. Ma la Corte
costituzionale, prima, e la Cassazione, dopo, hanno sempre negato che
l’esclusione della punibilità, concepita dal ministro fascista Rocco nel
lontano 1930 per la moneta contante rubata tra le mura di casa, si possa
applicare alla moneta elettronica. Si dice con estrema e curiale precisione che
l’art.493-ter ha natura «plurioffensiva» (una sorta di trappola definitoria che
rappresenta uno dei caposaldi della cultura penale ipogarantista di questo
paese) ossia tutela non solo il patrimonio personale del titolare della carta di
credito (il padre), «ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle
transazioni commerciali e alla fiducia nell’utilizzazione di tali strumenti da
parte dei consociati» (la finanza internazionale).
Siamo una nazione
strana e sorprende che qualcuno si sorprenda di una norma come quella che
punisce i rave party. Insomma, come dire, puniamo i rave party non solo perché
minacciano la salute dei ragazzi, mettono spesso a rischio la loro incolumità
personale, ma perché sono un pericolo per la sicurezza pubblica, per cui anche
se non circolasse una goccia d’alcol o un grammo di droga (può essere), il
delitto resta. Si celebra, quindi, il processo con la fedifraga figlia, poco più
che diciottenne, come imputata e con il padre disperato nelle vesti di una
riluttante parte offesa. La Corte costituzionale ha parlato chiaro,
la Cassazione pure, la partita è chiusa c’è poco da discutere; fedina penale
macchiata a vita e chissà quanti impicci.
Si dice che anche i
carabinieri, presidio di saggezza in questa malcapitata patria, si fossero
scusati col padre ignorando che, denunciando alla Procura i due
truffatori, avrebbero messo nei guai anche la ragazza. Si racconta che il
giudice, infischiandosene degli illustri precedenti, abbia assolto la
pasticciona e allungato di qualche anno la vita al povero genitore assillato e
tormentato dai sensi di colpa per aver fatto una denuncia al buio. Strano paese
questo, in cui la giustizia – se vuole – non conosce alcun padrone se non quello
della propria coscienza. Strano, ma a volte così bello. Alberto Cisterna
L’efficientismo non è
giustizia. Reati e processi, la riforma della giustizia e le 12 proposte degli
avvocati.
Viviana Lanza su Il Riformista il 30 Ottobre 2022
La riforma Cartabia, la sua
entrata in vigore, il futuro della giustizia, le iniziative del nuovo governo.
Sono tanti i temi sul tavolo del dibattito giudiziario. La Camera penale di
Napoli, presieduta dall’avvocato Marco Campora, ha preso posizione rispetto a
tali temi con un documento in cui si analizzano nel dettaglio le criticità
della giustizia penale e si elencano proposte, sintetizzabili in dodici punti:
1) Seria e profonda
depenalizzazione; 2) Amnistia e indulto; 3) Revisione del catalogo dei reati
previsti dal codice penale e dalle leggi penali e delle relative pene;
4) Abrogazione della improcedibilità e ritorno alla prescrizione sostanziale
ante-riforma; 5) Sancire con chiarezza, impedendo interpretazioni distorsive, la
necessità che vi sia identità tra il giudice che ha assunto le prove e il
giudice che emette la sentenza; 6) Abolizione della norma che impone, a pena di
inammissibilità dell’impugnazione, il rilascio di una nuova nomina al fine di
proporre appello in caso di imputato dichiarato assente nel corso del giudizio
di primo grado; 7) Abolizione della norma che impone, a pena di inammissibilità
dell’impugnazione, di allegare all’atto una nuova dichiarazione/elezione di
domicilio dell’imputato; 8) Rivedere la norma in materia di intercettazioni nel
rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale; 9) Ampliamento dei
casi in cui è possibile accedere al patteggiamento; 10) Reintroduzione della
possibilità di accedere al rito abbreviato per i delitti punibili con la pena
dell’ergastolo; 11) Modifica delle disposizioni in tema di custodia cautelare
sulla base della proposta contenuta nel recente quesito referendario;
12) Riforma dell’ordinamento accogliendo ed approvando le proposte della
“Commissione Giostra”.
«La riforma Cartabia è
divenuta legge e tra pochi giorni comincerà ad essere applicata nei Tribunali
italiani – si legge nel documento firmato dal presidente Marco Campora e dal
segretario Angelo Mastrocola –. Dopo l’incubo del triennio Bonafede, che ha
rappresentato senz’altro il punto più basso della giustizia italiana in cui il
mix esplosivo tra il più feroce populismo penale e la più grossolana insipienza
ha prodotto guasti difficilmente emendabili, le attese erano alte e si auspicava
un reale cambio di passo rispetto al nefasto recente passato». La riforma, per
i penalisti napoletani, non è tutta da cassare ma non convince affatto. «In
questa riforma – dicono i vertici dei penalisti napoletani – c’è sicuramente del
buono e sarebbe sciocco non riconoscerlo. Il totem della pena detentiva e del
carcere inizia ad essere scalfito dalla possibilità di applicare, già in fase di
cognizione, le sanzioni sostitutive che da decenni noi penalisti indicavano
quale strada maestra da seguire per assicurare la reale risocializzazione dei
condannati, per ridurre i pericoli di recidiva e per dare respiro agli istituti
penitenziari ridotti a luoghi crudeli, criminogeni e tecnicamente illegali».
Fiducia, poi, nella giustizia
riparativa (sperando che però nei fatti venga realmente messa in atto); ok
all’ampliamento del catalogo dei delitti procedibili a querela (anche se sarebbe
meglio metterci più coraggio) e delle categorie di reato per le quali può
applicarsi la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Ok
anche alle modifiche del codice di rito che ampliano la democrazia all’interno
del processo e potenzialmente attenuano il rischio di arbitrii nella fase
investigativa. Ma i veri nodi della giustizia penale, quelli seri, non sono
risolti. Un esempio. «La riforma, senza neppure intervenire in modo deciso
sul patteggiamento, e cioè sul più laico dei riti alternativi, lungi
dall’affrontare i nodi essenziali che ingabbiano e paralizzano la giustizia si
limita (oltre ad auspicare che l’udienza preliminare e la nuova udienza
pre-dibattimentale sfoltiscano sensibilmente il numero dei processi)
a “sponsorizzare” come rito principe del nostro ordinamento il giudizio
abbreviato (storicamente la tipologia di giudizio meno adeguata a far emergere
una verità processuale che quantomeno tenda ad una verità sostanziale,
fondandosi lo stesso su atti strictu sensu polizieschi); arrivando addirittura a
prevedere – in aperta distonia con il principio in forza del quale l’imputato ha
diritto ad un secondo grado di giudizio nel merito senza subire qualsiasi tipo
di condizionamento – lo sconto di pena di un sesto per l’imputato che,
condannato in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, rinunzi a proporre
impugnazione», dicono Campora e Mastrocola.
«La realtà è che la riforma
mira a raggiungere un obiettivo (minor numero di processi, maggiore efficienza e
più celerità) servendosi di mezzi a nostro parere inadeguati allo scopo. Si
limita in gran parte, infatti, ad intervenire sul codice di
rito, sulla procedura (che ha esclusivamente funzioni di garanzia e detta le
regole del gioco) lasciando per lo più inalterato il codice penale e le migliaia
di leggi in materia penale disseminate nelle più disparate disposizioni
normative. Di contro, è evidente che l’unico mezzo per ridurre i processi senza
diminuire le garanzie dei cittadini (imputati e parti offese) è quello di
ridurre in modo significativo il catalogo dei reati attraverso una massiccia
depenalizzazione. Vi sono, invero, nel nostro codice e soprattutto nelle cd.
leggi speciali centinaia di fattispecie che ben potrebbero essere regolate e
demandate ad altre branche dell’ordinamento. Così come – ed al netto dell’ovvia
considerazione che per fare qualsiasi tipo di riforma è necessario il consenso
della maggioranza parlamentare – sarebbe stato del tutto logico (come di regola
è sempre avvenuto di fronte a riforme di una certa rilevanza), al fine di
ridurre il cd. arretrato e per consentire alle nuove norme di esplicare i loro
effetti, varare un provvedimento di amnistia e di indulto che avrebbe altresì
consentito di porre un argine allo sfacelo che registriamo da decenni (ed in
modo particolare nell’ultimo anno) negli istituti penitenziari».
Il ragionamento è: se
l’intento della riforma è quello di modernizzare il diritto (e il processo)
penale e renderlo più mite e meno terribile occorreva intervenire sulla
tipologia delle pene e sui limiti edittali previsti dalle varie fattispecie
del codice penale, «ancor oggi incentrato esclusivamente sulla pena detentiva in
linea con l’ideologia imperante negli anni ‘30», osservano i vertici dei
penalisti di Napoli, «limiti che continuano ad essere esorbitanti e che
gioco-forza, considerata l’enorme posta in palio, impongono l’aumento
progressivo delle garanzie e non già la loro progressiva erosione».
«Banalizzando – aggiungono – per ridurre il numero dei processi, e dunque per
migliorare l’efficienza e favorire una maggiore celerità, è necessario ridurre
l’ambito di intervento del diritto penale a monte, apparendo una mera chimera il
raggiungimento dell’obiettivo attraverso vie traverse (il sistema che si
auto-regola e che blocca la trasformazione in processi delle centinaia di
migliaia di notizie di reato) o peggio attraverso l’erosione delle garanzie e
degli spazi di intervento del singolo imputato».
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Arrestano la sposa per
droga il giorno delle nozze. Poi la scoperta: "Un errore".
Rosa Scognamiglio su Il
Giornale il 29 Ottobre 2022
La sposa, 42 anni, stava per
pronunciare il fatidico "sì" quando i carabinieri hanno interrotto la cerimonia
con un mandato di arresto. Per fortuna, si è trattato solo di un equivoco ma le
nozze sono saltate
"Nel bene e nel male, in
salute e in malattia, in ricchezza e in povertà finché morte non ci separi",
recita la formula del consenso al matrimonio. Oppure "finché mandato di arresto
ci separi", dipende dai punti di vista. Lo sa bene una sposa 42enne di Seveso
(Monza) che è stata arrestata il giorno delle sue nozze proprio mentre era ad un
passo dal fatidico "sì". Per fortuna, si è trattato solo di un terribile
equivoco ma la celebrazione è saltata.
La storia
A raccontarla non ci si crede.
Eppure la storia è vera, verissima. Stando a quanto riporta l'Agenzia
stampa Ansa, l'episodio è accaduto a Seveso, una piccola cittadina in provincia
di Monza e Brianza, qualche giorno fa. Tutto pronto per la cerimonia: l'abito
bianco, le fedi nuziali e la festa in famiglia. E invece, quella che doveva
essere una giornata da sogno si è trasformata in un vero e proprio incubo. La
sposa, con accanto anche il futuro marito, si è vista letteralmente piombare
davanti i carabinieri. I militari dell'Arma le hanno notificato l'esecuzione di
una misura cautelare in carcere per un cumulo di pene legato a reati di droga
proprio mentre si stava celebrando il matrimonio con rito civile. Ma si trattava
di un frainteso.
L'arresto
La sposa ha rischiato di
finire in manette per via un errore di trascrizione. In buona sostanza, i
carabinieri hanno interrotto le nozze per eseguire l'ordine di carcerazione,
trasmesso alla Procura di Monza dal Tribunale brianzolo per una sentenza passata
in giudicato, nonostante ci fosse stato il ricorso in Appello. A confermare
l'equivoco è stato l'avvocato della donna che, interpellato sui fatti, ha
mostrato ai militari dell'Arma un'anomalia nei documenti. Una volta accertato
l'equivoco, la Procura ha immediatamente ritirato il provvedimento. Fatto sta
che la festa è saltata comunque e gli sposi sono stati costretti a fissare una
nuova data per le nozze.
Scatti di
ordinaria “mala edilizia” giudiziaria.
L'Anm ha
pubblicato sul proprio sito centinaia di foto, raccolte dagli stessi
protagonisti della giurisdizione: una mappa, da Nord a Sud, della condizione di
aule e uffici giudiziari nei quali sono costretti a lavorare magistrati,
avvocati e personale amministrativo. Gennaro Grimolizzi su Il Dubbio il 24
ottobre 2022.
Il nostro
giornale lo dice da sempre. La giustizia non ha bisogno di proclami e di effetti
speciali, se poi, scendendo sul pianeta terra, le aule e gli uffici frequentati
dai magistrati, dagli avvocati e dai cittadini sembrano più a delle piccionaie o
a dei tuguri. Per questo motivo l’Associazione nazionale magistrati ha voluto
far conoscere lo stato in cui versa l’edilizia giudiziaria. Come? Nella maniera
più semplice ed accessibile, pubblicando sul proprio
sito (associazionemagistrati. it) centinaia di foto, scattate dagli stessi
protagonisti della giurisdizione e quotidiani frequentatori dei Tribunali.
La galleria
fotografica – in alcuni casi una vera e propria galleria degli orrori –,
composta da otto sezioni, mostra da Nord a Sud, passando per la capitale, lo
stato pietoso in cui versano le aule d’udienza e altri locali dei Tribunali
italiani. Ogni galleria fotografica ha un titolo e i magistrati hanno dato adito
al loro estro: le locuzioni utilizzate vanno da “Impressionismo giudiziario”, a
“Vostro onore”, “Giustizia 6.0” e “Con gli occhi all’insù” per giungere alla
“Raccolta differenziata”. Le altre gallerie si intitolano “Terzo potere”,
“Lavori in corso” e “Il vizio della memoria”. Scatti non d’autore che non hanno
la velleità di vincere premi fotografici, ma che intendono portare a conoscenza
di tutti la realtà, senza filtri, senza infingimenti, senza, appunto, effetti
speciali.
Nel suo saluto di
commiato, rivolto ai dipendenti e a funzionari del ministero della
Giustizia, Marta Cartabia, ha dichiarato che nei seicento giorni trascorsi in
via Arenula ha voluto «contribuire a realizzare quel volto costituzionale della
Giustizia». Chissà cosa ha pensato la ministra uscente sfogliando il dossier
fotografico dell’Associazione nazionale magistrati.
“MALA EDILIZIA”
I componenti
della VIII Commissione permanente di studio dell’Anm evidenziano le motivazioni
che li hanno indotti a fare questo singolare viaggio nell’Italia della “mala
edilizia” giudiziaria. «Per ottenere un quadro aggiornato della “salute” dei
nostri palazzi di giustizia – spiegano abbiamo ritenuto utile effettuare un
monitoraggio dell’edilizia giudiziaria, chiedendo a tutti i magistrati di
documentare fotograficamente lo stato in cui versano gli uffici in cui
quotidianamente prestano servizio e in cui, ogni giorno, migliaia di cittadini
(personale amministrativo, avvocati, parti processuali), fanno ingresso. Grazie
al contributo delle Giunte Esecutive Sezionali e di tanti colleghi abbiamo così
realizzato un dossier fotografico sull’edilizia giudiziaria composto da circa
500 foto relative a più di 50 Tribunali e Procure della Repubblica».
L’edilizia
giudiziaria è una sorta di specchio dell’Italia, secondo l’Associazione
nazionale magistrati. «Quella che emerge da questa “istantanea” – affermano i
componenti della VIII Commissione permanente di studio – è la fotografia di un
Paese i cui palazzi di giustizia presentano strutture sovente inadeguate e
uffici troppo spesso inospitali e, in alcuni casi, persino insalubri: insomma,
luoghi di lavoro non dignitosi per quanti vi prestano servizio o anche solo li
frequentano come utenti.
Al fine di
evidenziare le situazioni di maggiore criticità che, a nostro giudizio,
richiedono interventi urgenti, tra tutte le foto raccolte ne abbiamo selezionate
alcune, che abbiamo suddiviso in otto categorie in base all’oggetto raffigurato
e al contesto in cui la foto è stata scattata. L’intera raccolta fotografica,
comprensiva di documenti e relazioni, suddivisa in base all’ufficio giudiziario
da cui provengono, è, invece, consultabile navigando attraverso la cartina
geografica».
A ROMA SPAZI
INSUFFICIENTI E INADEGUATI
A denunciare
questa situazione è il presidente del Tribunale, Roberto Reali, che si sofferma,
in una relazione inviata al presidente della Giunta dell’Anm Lazio (Sezione di
Roma) tanto sul settore civile quanto su quello penale, senza tralasciare l’Aula
Bunker di Rebibbia.
Gli immobili in
cui si svolgono le attività del civile si caratterizzano per la loro vetustà.
Reali pone l’attenzione sull’immobile di via Lombroso, che ospita dal lontano
1977 l’Archivio di Stato Civile, concesso in uso gratuito per tre anni al
Ministero di Grazia e Giustizia dalla Provincia di Roma. Sono trascorsi
quarantacinque anni e la montagna di faldoni è ancora lì. La struttura «risulta
inagibile e interdetta ai lavoratori» dal 2015 ed è incustodita.
La Città
giudiziaria, situata in Piazzale Clodio, ospita il settore penale: necessita di
interventi di ristrutturazione e di ampliamento. Servono, evidenzia il
presidente del Tribunale di Roma, investimenti mirati per la «riqualificazione
complessiva della Città giudiziaria» e l’ampliamento della tessa «mediante la
costruzione di un nuovo Palazzo che possa affiancare i già esistenti Edifici A,
B e C di Piazzale Clodio». Nell’Aula Bunker di Rebibbia avvocati, magistrati,
parti processuali e forze dell’ordine nelle giornate di pioggia farebbero bene
ad indossare l’impermeabile o ad usare l’ombrello a causa delle infiltrazioni di
acqua piovana dalle coperture, denunciate dallo stesso Reali. Nella
documentazione allegata al dossier si nota, inoltre, che nei pressi delle aule
di udienza il problema dei rifiuti è di portata eccezionale. Decine di sacchi
formano montagne di spazzatura.
Ambienti
condivisi nella gallery di Cassino, dove spicca una foto di alcuni armadi e
fascicolatori, pieni zeppi di faldoni, sistemati in un bagno. Nella stessa
stanza in cui si trovano un lavabo e la carta per pulirsi.
PIEMONTE: TORINO
RIDE, ALESSANDRIA PIANGE
Se il Palazzo di
Giustizia di Torino, intitolato a Bruno Caccia (magistrato martire, ucciso dalla
criminalità organizzata nel 1983) si presenta ordinato, non può dirsi lo stesso
per le aule di udienza del Tribunale di Alessandria. Qui, le infiltrazioni che
mangiano gli intonaci e i cavi volanti sono un pugno nell’occhio. In uno spazio
ricavato alle spalle della postazione dei giudici, arredata con elementi di
almeno settant’anni fa – poltrone comprese -, si nota un deposito in cui sono
ammassate sedie, cartoni e addirittura alcuni televisori. Come il deposito di un
rigattiere.
A Biella, oltre
ai muri scrostati e ad alcune cabine dalle quali debordano centinaia di cavi,
spicca un vecchio telefono pubblico. Il pezzo da museo è sovrastato da un muro
ridotto a gruviera. “Pronto, ministero della Giustizia?”. Non risponde
nessuno. Stranamente…
A PAOLA
L’ASCENSORE VA SOLO GIÙ
Il viaggio nella
“mala edilizia” prosegue a Sud. La Giunta sezionale dell’Anm di Catanzaro, nei
mesi scorsi, ha denunciato l’improvvisa rottura di un cavo dell’ascensore del
Palazzo di Giustizia di Paola. L’impianto di sollevamento è precipitato nel
vuoto. Il caso ha voluto che non ci fossero persone nell’ascensore. In Tribunale
per lavorare non per rischiare la vita. A Crotone, invece, i magistrati hanno
protestato per «le criticità strutturali del Tribunale» e hanno altresì
rappresentato «la nocività degli ambienti di lavoro» a causa dell’umidità dei
locali, delle perdite d’acqua al piano terra e al secondo piano. A ciò si
aggiunge il blocco totale degli impianti di riscaldamento. Per il momento, viste
le alte temperature delle “ottobrate” che si susseguono, il pericolo di
congelamento non sussiste.
FOGGIA. UNA
STANZA PER 4 NEL PENALE. MA NEL CIVILE VA PEGGIO
Nel Tribunale
penale di Foggia i quattro giudici del dibattimento devono lavorare nella stessa
stanza. Ma i conti non tornano. Ci sono tre scrivanie ed una sola postazione
fissa dotata di computer. Forse, serve una calcolatrice in via Arenula. Nel
Tribunale civile va peggio. Ben sette magistrati condividono la stessa stanza,
sprovvista di computer e di telefono. E non hanno neppure distinte scrivanie.
Insomma, nel capoluogo da uno si sperimenta il coworking giudiziario
all’italiana.
BARI E I
FASCICOLI NEI BAGNI
In piazza De
Nicola, sede del Tribunale Civile, della Corte di Appello penale e civile, e del
Tribunale di Sorveglianza si ricava spazio pure nei bagni per conservare i
fascicoli. Al piano terra, nel sottoscala si trova invece di tutto: sedie e
poltrone rotte, armadi inutilizzati, vecchie macchine da scrivere, monitor,
stampanti fuori uso, fascicolatori metallici arrugginiti ed ammaccati. Dal
rigattiere all’isola ecologica è un attimo (per la gioia dei ratti per possono
insinuarsi ovunque).
TRANI. PALAZZI
STORICI CHE RICHIEDONO MANUTENZIONE
Chi non vorrebbe
fare udienza a due passi dal mare? A Trani la sede delle Esecuzioni mobiliari,
ospitata nel Palazzo Gadaleta, si trova in una posizione felice. All’interno,
però, i magistrati sono preoccupati. In alcune stanze le crepe evidenti non
fanno immaginare niente di buono. Le cose non vanno meglio nella sede centrale
del Tribunale, a Palazzo Torres, a due passi dalla splendida Cattedrale
romanica. Lo stabile, risalente alla metà del XVI secolo, richiede di essere
sottoposto ad urgenti interventi di ristrutturazione. Alcuni cornicioni sono
pericolanti.
IL PALAZZO DI
GIUSTIZIA DI CATANIA CADE A PEZZI
A riprova
dell’emergenza edilizia giudiziaria vi è il crollo parziale, pochi giorni fa,
nel Palazzo di Giustizia di Catania, del tetto della cancelleria del Giudice per
le indagini preliminari. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. La Giunta
etnea dell’Associazione nazionale magistrati è ritornata a porre all’attenzione
i gravi problemi che si affrontano nella città siciliana e ha espresso «ancora
una volta la massima preoccupazione e il vivo allarme per le condizioni in cui
versano gli uffici giudiziari catanesi».
L’Anm chiede con
urgenza che vengano svolte attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
«per evitare tragedie che questa volta sono state solo sfiorate». «Non è
ammissibile – si legge in una nota – che in un edificio pubblico, e a maggior
ragione in un Palazzo di Giustizia, dove devono trovare tutela i diritti di
ciascuno, i lavoratori che ivi operano debbano temere per la propria incolumità.
Non è altresì ammissibile che, a seguito di tali eventi, alcuni magistrati
dell’ufficio non dispongano attualmente di un ufficio dove poter celebrare le
udienze e non siano pertanto messi in condizione di adempiere ai propri doveri».
Grande
preoccupazione viene espressa da Rosario Pizzino, presidente del Coa
di Catania. «Il crollo di un soffitto, verificatosi nel Palazzo di Giustizia –
dice al Dubbio -, è un incidente che, purtroppo, non ci sorprende. Ricordiamo
ancora il distacco della lastra di marmo dalla parete di un’aula d’udienza e le
recenti piogge torrenziali all’interno dei locali. Da anni denunciamo i problemi
strutturali del Palazzo di Giustizia e, più volte, abbiamo posto all’attenzione
delle istituzioni le carenze dell’edilizia giudiziaria nella nostra città ».
Silenzio di tomba da via Arenula. «Dagli uffici ministeriali – aggiunge il
numero uno delle toghe etnee non sono pervenute risposte adeguate e vane sono
pure rimaste le richieste loro inoltrate dai vertici giudiziari di Catania.
Così siamo
arrivati a questo ennesimo episodio che poteva anche essere tragico. Adesso, a
causa dell’inagibilità di un intero settore del Palazzo, ci sarà da fare i conti
con una serie di inevitabili ritardi e disfunzioni nell’attività giudiziaria e
di problemi organizzativi per gli uffici che si riverseranno sull’intera
struttura giudiziaria, sui cittadini e sui difensori. Un altro duro colpo per
noi avvocati, ancora alle prese con le restrizioni anti-Covid, e proprio nel
momento in cui l’Ufficio per il processo iniziava ad avviarsi. Ci auguriamo che
gli interventi di ripristino siano immediati e che questo ennesimo episodio sia
uno sprone per affrontare e risolvere la questione dell’edilizia giudiziaria a
Catania».
Sul crollo
nell’ufficio del Gip intervengono pure Antonino La Lumia, presidente del
Movimento Forense, e Giuseppe Casabianca, presidente della sezione di Catania di
MF. «Secondo i primi accertamenti – affermano -, la causa sarebbe da individuare
nelle recenti infiltrazioni d’acqua piovana. Solo la mera casualità, dunque, ha
consentito di evitare una tragedia, perché nella notte nessuno era presente nei
locali.
Ciò è
inaccettabile: gli avvocati e tutti coloro che quotidianamente operano nei
Tribunali non possono vedere la propria incolumità messa a rischio dalle pessime
condizioni nelle quali versano gran parte degli edifici giudiziari in Italia. Il
Movimento Forense, da anni, denuncia, anche attraverso ripetute mozioni
congressuali, tale perdurante stato di degrado, inconcepibile in un ordinamento,
che dovrebbe invece garantire l’efficienza e la funzionalità dell’intero
sistema: una vera riforma della Giustizia, piuttosto che fermarsi esclusivamente
ai profili del rito, deve partire da queste basi e non può trascurare seri e
concreti investimenti». Gli esponenti del Movimento Forense chiedono «un
intervento immediato da parte delle istituzioni, al fine di assicurare il
regolare svolgimento di tutte le attività processuali e, nel contempo, di
inserire il tema tra le priorità dell’agenda politica del nuovo governo».
Quando si
trascurano i luoghi in cui si amministra la Giustizia, i diritti rischiano di
essere abbandonati. Proprio come gli oggetti dei depositi improvvisati in alcuni
Tribunali. Con buona pace del «volto costituzionale della Giustizia».
Sedici giudici per un solo
processo: record choc a Roma.
Nel corso del processo a carico del clan camorristico Moccia si sono avvicendati
16 magistrati in quindici udienze. La protesta dell'Unione delle Camere Penali:
"Incompatibile con il principio del giusto processo". Rosa Scognamiglio il 25
Ottobre 2022 su Il Giornale.
Sedici giudici in 15 udienze.
È il caso da guiness world record che è esploso a Roma dove, nel corso del
processo al clan camorristico Moccia, scaturito dall'operazione di settembre
2020 della Dda che portò al sequestro di alcuni locali nel cuore della Capitale,
si sono avvicendati una lunga scia di magistrati. Al punto che la protesta da
parte della categoria forense è stata inevitabile. "Una gravità inaudita", ha
denunciato l'Unione delle Camere Penali attraverso le pagine del quotidiano Il
Messaggero.
Il caso
La storia, raccontata dalla
giornalista Valeria Di Corrado, è a dir poco paradossale. Al punto che gli
stessi addetti ai lavori, quando lo scorso 5 ottobre (la data dell'ultima
udienza) uno dei giudici è risultato "incompatibile", hanno ironizzato: "si è
attinto a chi passava in corridoio", è stato il commento sarcastico dei legali.
Del resto, è andata proprio così: è stato necessario l'intervento di un altro
magistrato che stava celebrando un processo per direttissima in un'altra aula
dello stesso Tribunale. Ed è stata proprio quella la goccia che ha fatto
traboccare il vaso. Tanto che la Camera Penale di Roma ha proclamato
l'astensione in vista dell'udienza programmata per il prossimo 2 novembre "per
manifestare la propria solidarietà al collegio difensivo in quello che si è
trasformato nel funerale del processo accusatorio".
La protesta
L'Unione delle Camere
Penali ha indetto una protesta a livello nazionale. Pare, infatti, che la misura
fosse colma da un pezzo. A monte del problema ci sarebbe una carenza di organico
nella magistratura che, a conti fatti, rischia non solo di inficiare il regolare
svolgimento dei processi ma anche di diventare endemica. Un'emergenza che, come
ben chiarisce la cronista de Il Messaggero, ha portato "il presidente del
Tribunale di Roma a stabilire un tetto nel numero dei processi per mafia". In
questo modo "si riduce la funzione giudiziaria a una mera formalità - ha
commentato al quotidiano romano Vincenzo Comi, presidente della Camera penale di
Roma - Il dibattimento dovrebbe essere il cuore del procedimento penale, invece
così viene svilito. La sostituzione in corsa del magistrato non può essere la
soluzione al deficit d'organico. E comunque dovrebbe essere l'eccezione, non la
regola".
Il principio di immutabilità
del giudice
Il "cambio in corsa" del
magistrato dovrebbe essere un evento sporadico se non addirittura eccezionale.
La sentenza Bajrami delle sezioni unite della Corte di Cassazione ha abrogato,
nel 2019. il principio di immutabilità del giudice. "Immaginiamo di essere sotto
processo e che la decisione sulla innocenza o colpevolezza la prenda un
magistrato diverso da quello che ha seguito tutto il dibattimento. - ha concluso
l'avvocato Comi - Non conosce nulla, arriva e decide. Si può chiamare processo
rispettoso dei diritti fondamentali delle persone? È una giustizia credibile?
Tutto questo nel tribunale più grande d'Europa".
Lede il
diritto all’immediatezza del processo. Processi penali impazziti: l’assurdo turn
over dei giudici.
Gian Domenico Caiazza su Il Riformista il 23 Ottobre 2022
Abbiamo più volte
ricordato quanto sia fondamentale una regola del processo penale che si
chiama “immediatezza della deliberazione”: il giudice che emette la sentenza
deve essere il medesimo che ha partecipato all’intero dibattimento, ha ascoltato
i testimoni, i consulenti, i periti, ed ha acquisito (o non acquisito) documenti
ed altre prove. Se il giudice cambia, occorre ripetere l’istruttoria (“a pena di
nullità assoluta” proclama severamente la norma).
Abbiamo anche
detto che questo elementare principio di civiltà, sancito senza equivoci
dall’art. 525 del nostro codice di rito, è stato letteralmente sovvertito dalla
interpretazione giurisprudenziale, con un significativo contributo, purtroppo,
della stessa Corte Costituzionale. Di fatto, ora la situazione è l’opposto di
quanto previsto dalla norma, formalmente ancora vigente: se cambia il giudice,
pazienza. Il giudice nuovo si legga i verbali (se ne ha voglia), si faccia
un’idea di quello che è successo, e pronunci la sentenza. La cosa più scandalosa
– anche in questo ci ripetiamo, ma ne vale la pena, così comprenderete meglio il
fatto che mi appresto a raccontarvi – è la logica che ha ispirato questo
sovvertimento interpretativo.
Chi pretende di
ripetere il processo per non essere giudicato da un giudice diverso da quello
che ha raccolto la prova attenta alla ragionevole durata del processo, e mena il
can per l’aia, secondo inveterato costume degli avvocati difensori. Invece,
tutti zitti sulle ragioni per le quali il giudice cambia, che evidentemente sono
considerate convenzionalmente nobilissime e comunque insindacabili. Peccato che,
nel 90% dei casi, sono ragioni di carriera: voglio cambiare sezione, o funzione,
o sede, e quindi arrangiatevi. Da quando le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno definitivamente sancito questi principi, e queste priorità
valoriali, in tutti i Tribunali italiani si è scatenata – complici ovviamente
anche le croniche carenze di organico – una sarabanda che definire indecorosa è
il minimo che si possa dire. Inizi i processi con un giudice (o tre, se il
giudizio è collegiale) e da quel momento assisti inerme a un continuo
modificarsi del giudicante.
Recentemente
a Roma un nutrito gruppo di valorosi Colleghi ha denunciato un caso che ha
davvero dell’incredibile. Si tratta di un processo a carico di numerosi imputati
di gravi fatti di estorsione ed interposizione fittizia, aggravate dal metodo
mafioso. Ebbene, in un processo di questa complessità, che prevede in caso di
condanna pene davvero molto gravi, è accaduto in pratica che in nessuna udienza
il collegio fosse il medesimo dell’udienza precedente. Ad ogni udienza almeno un
giudice, ma a volte anche due, erano nuovi. Facciamo qualche esempio, in modo
che la denunzia del fatto non scolori in una eccessiva genericità.
Il Collegio che
ammette le prove è subito diverso da quello che inizia a raccoglierle. E sia. Ma
si veda l’esame delle persone offese: due udienze, alla seconda cambia un
giudice. Esame – ovviamente cruciale – della Polizia Giudiziaria che ha svolto
le indagini, e degli altri testi dell’accusa: cinque udienze. Dopo la prima
udienza, a quella successiva ne cambiano due; alla terza altri due; alla quarta
altri due, alla quinta uno. Udienze per esame testi della difesa: quattro, ad
ognuna è cambiato uno dei tre giudici. Ma l’acme si raggiunge nella fase della
discussione. La requisitoria del Pubblico Ministero avviene in presenza di due
giudici nuovi su tre (e parliamo di due nuovi giudici che non avevano mai
partecipato nemmeno ad una delle udienze precedenti).
Alla udienza
fissata per l’inizio delle arringhe difensive, cambia nuovamente uno dei tre
giudici, che però si rende conto di versare in una condizione di
incompatibilità; quindi l’udienza viene sospesa, e si va alla ricerca di un
qualsivoglia altro giudice che possa comporre il collegio. Quando infine si è
trovato il malcapitato (che non sa nulla di nulla del processo, ovviamente, e
non ha nemmeno sentito la requisitoria del pm), i difensori sollevano tutte le
eccezioni possibili, ma il Tribunale ritiene di superarle senza battere ciglio.
La fine della storia la apprenderemo dalle cronache.
Non credo ci sia
bisogno di ulteriori commenti. Mettetevi nei panni degli imputati, con onestà
intellettuale, e ditemi cosa provereste ad essere giudicati in queste inaudite
condizioni. Ecco, quando si parla di regole processuali noi avvocati siamo
sempre gli azzeccagarbugli che piantano grane per non fare i processi. Ed usiamo
termini di difficile comprensione, quali appunto quelli del diritto
alla “immediatezza del processo”. Forse oggi avete capito un po’ meglio di cosa
stiamo parlando; e cioè della libertà e dei diritti fondamentali di tutti e di
ciascuno di noi. E di come essi siano oggi quotidianamente mortificati ed
umiliati, nel generale disinteresse. Si tratta, tuttavia, di non mollare; e noi,
statene certi, non molliamo.
Gian Domenico
Caiazza. Presidente Unione CamerePenali Italiane
Respinta la richiesta di alcune ore di
libertà: "Non è affidabile". Domiciliari isolato: “Ha
70 anni, non può fare neanche spesa: aveva provato a rubare un maglione”. Vito
Califano su Il Riformista il 19 Ottobre 2022
La denuncia del suo avvocato descrive un uomo solo
in casa, con problemi di salute, agli arresti domiciliari nella sua abitazione
dopo una condanna per il tentato furto di un maglione in un grande magazzino.
Così solo che anche fare la spesa può diventare un’impresa. Quell’uomo ha 70
anni, leccese, e vive questa situazione dallo scorso agosto. E agli arresti
domiciliari l’uomo dovrebbe rimanere fino al prossimo giugno.
Il legale Giuseppe Russo ha reso noto il caso,
preoccupato dalla situazione soprattutto dopo che il magistrato del Tribunale di
Sorveglianza ha respinto l’istanza avanzata per far ottenere alcune ore di
libertà all’uomo per permettergli di uscire e provvedere egli stesso alle
proprie necessità oltre che per favorire al condannato un graduale reinserimento
sociale.
“Il magistrato ha ritenuto al momento di non
accogliere la richiesta ritenendo il mio assistito non affidabile“, ha spiegato
l’avvocato a Il Corriere del Mezzogiorno Puglia. “La sua è una situazione al
limite del paradosso. Non ha nessuno. L’unica figlia dopo aver provveduto per
alcuni mesi a lui, ora con la riapertura delle scuole, non può più perché lavora
ed è madre di quattro figli – ha aggiunto ancora Russo – Senza nessun aiuto,
ultrasettantenne, che deve fare questa persona da sola chiusa in casa, in questo
rione dove non c’è niente nel raggio di due chilometri e non può neppure
chiedere ad un vicino di comprargli del pane e della pasta?”.
L’avvocato ha precisato che il 70enne aveva
ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali alla fine del processo ma
dopo aver tenuto alcune condotte illecite – sorpreso una volta alla guida senza
patente e in compagnia di persone con precedenti penali – era finito agli
arresti domiciliari.
Vito Califano. Giornalista. Ha studiato Scienze
della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di
cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e
teatro.
Così il processo diventò
vittima collaterale dell’emergenza terrorismo.
La lotta alla mafia e al terrorismo hanno determinato una torsione di diritti e
garanzie. È così che la magistratura ha perseguito non più il reato ma il
fenomeno. Giorgio Spangher su Il Dubbio il 17 ottobre 2022.
Credo sia difficile delineare
– anche solo parzialmente – la direttrice lungo la quale si è venuto evolvendo
il sistema della giustizia penale, anche se lo si volesse limitare al processo
penale. Ciò non significa che, seppure con i riferiti limiti, qualche
riflessione non possa essere sviluppata.
È dato acquisito che la
bonifica del codice di procedura penale avviata dalla Corte costituzionale si
sia in qualche modo arenata con il dispiegarsi del fenomeno terroristico di
matrice domestica. In quel tempo è chiaramente emersa la consapevolezza che
significativi risultati in termini di accertamento di responsabilità potevano
ottenersi non tanto con l’inasprimento delle pene e la creazione di nuove
ipotesi criminose (o di aggravamento circostanziato di quelle esistenti) quanto
attraverso lo strumento del processo. È la cosiddetta stagione dell’emergenza,
alla quale deve riconoscersi (o attribuirsi) il fatto di essere stata
l’incubatrice delle modifiche sostanziali, ma soprattutto processuali,
relativamente ai reati di criminalità organizzata.
Nascono e si sviluppano in
questa stagione – dello stragismo e del terrorismo – le espressioni “lotta”,
“contrasto” e “fenomeni criminali”. Inevitabilmente il processo subisce una
“torsione” finalistica. Certamente vengono ridefinite le ipotesi delittuose, man
mano che i fatti criminali evidenziano significative manifestazioni fattuali, ma
è il processo, rimodulato nei suoi sviluppi e nei suoi strumenti, ad assumere
rilievo. È inevitabile che la tenuta democratica del Paese, e la stessa tenuta
delle istituzioni, siano messe a dura prova da una criminalità così strutturata
se anche lo Stato, la magistratura, gli organi investigativi, l’intelligence,
operando in sinergia, non affrontano con la legalità (le leggi del Parlamento)
le diffuse e radicate questioni criminali che rischiano di minare la stessa
sopravvivenza del Paese.
È inevitabile che, fermi i
confini invalidabili tracciati dalla Corte costituzionale, spetti al Parlamento
affrontare l’emergenza con leggi che mettono in tensione princìpi e garanzie.
Democrazia e diritti, processo e criminalità. Su questo elemento, in qualche
modo fisiologico del rapporto tra criminalità e giustizia penale si è inserito,
spesso molto al di là del dato “fisiologico”, un elemento finalistico: l’azione
di lotta e di contrasto, tesa non già al solo accertamento, ma per così dire
finalizzata a piegare il processo al risultato di argine, non già al reato, ma
al fenomeno, in una dimensione che, collegando i due elementi oggettivo e
soggettivo, altera la natura e l’essenza del processo penale, strumento di
verifica di responsabilità e di esistenza del fatto delittuoso.
Certo il processo, nato per
verificare fatti isolati, spesso oggetto di semplice accertamento di
responsabilità, si deve misurare con la struttura del reato che trascende
l’individuo per collocarlo nella dimensione associativa, nonché nell’espansione
territoriale dei fatti che supera gli ambiti ristretti delle competenze
storicamente ritagliate per una diversa tipologia di reati. Tutto ciò non poteva
lasciare indifferente la politica, il Parlamento, la legge. Della
predisposizione di questo strumentario, votato all’acquisizione di questo
arsenale (ancorché non sacro ma egualmente funzionale) si è impadronita la
politica, una larga parte della politica, mossa da esigenze securitarie,
definite anche sovraniste e populiste, in quanto originate e alimentate dal
cortocircuito tra politica (parte della società) e popolo (parte di esso) che lo
ha progressivamente esteso e ne fa fatto una prospettazione sempre più ampia. In
altri termini, il meccanismo ha progressivamente contagiato larghi settori della
fenomenologia criminale, in una dimensione non rispettosa del principio di
proporzionalità.
Non sono mancate lungo questo
percorso che ha attraversato la fine e l’inizio di questo secolo anche delle
controspinte, evidenziatesi da interventi sulla Costituzione (art. 111),
sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale,
con varietà di effetti che non hanno alterato, tuttavia, il non marginale
retrogusto di sapore autoritario della nostra legislazione e della sua
interpretazione giurisprudenziale. È facile attribuire a queste situazioni –
vere o comunque di non agevole quantificazione – la responsabilità di una
progressiva attenuazione delle garanzie processuali dell’imputato, accentuata
dallo spostamento del baricentro del processo nella fase investigativa delle
indagini preliminari e da un progressivo rafforzamento del ruolo della polizia
giudiziaria e del pubblico ministero, non adeguatamente bilanciato da un
significativo potere di controllo e di garanzia del giudice delle indagini
preliminari che troppo spesso asseconda la Procura avallandone acriticamente le
iniziative.
Sarebbe, tuttavia, riduttivo
in contesti così complessi, attribuire solo a questo elemento la matrice del
progressivo indebolimento dell’impianto garantista, al di là del vulnus di
sistema determinato dalle notissime decisioni della Corte costituzionale del
1992, figlie della ricordata stagione. In altri termini, non sono solo le spinte
e le propensioni riferite, a incidere sul sistema delle garanzie, ma altre
visioni della funzione delle regole finiscono per intaccare, erodendole, quelle
forme consolidate di tutela dei diritti non solo individuali, ma che pur sotto
questa dimensione incidono su aspetti di garanzia più ampi.
Il riferimento è alle istanze
sempre più accentuate tese alla semplificazione, all’economicità, alla
compressione temporale, alla dimensione sostanzialistica, alla
smaterializzazione in una dimensione ispirata ad una logica di funzionalità
della macchina giudiziaria. Gli attori della giurisdizione, ispirati da una
logica che potremmo definire, a volte, proprietaria della stessa, nella volontà
di gestire i percorsi processuali, dettano un’agenda di riforme mascherate da
esigenze di funzionalità degli uffici, attraverso azioni organizzative che non
sono mai solo tali, essendovi sottese scelte processuali valoriali; governata
dalla giurisprudenza cosiddetta creativa, finiscono per modellare il processo in
termini di efficienza, pur nell’affermata esigenza, ritenuta però in qualche
modo subvalente, delle garanzie. Invero, non è un elemento inedito, al quale
sono funzionali istituti come le sanatorie, la mera irregolarità, il
raggiungimento dello scopo, gli oneri a carico delle parti private, la natura
ordinatoria dei termini, la sanzione di inammissibilità.
Sono tutte occasioni per
adeguare il rito, come – ecco il riferimento al virus – nel caso dell’emergenza
epidemiologica, colta quale occasione per adeguare i comportamenti alle mutate
situazioni ambientali, per poi trasformare le eccezioni, destinate alla
temporaneità, in regole permanenti. Al rispetto formale delle regole, si
affianca una interpretazione meno rigorosa, sfocata che tende a fare del giudice
il codificatore delle regole attraverso la prassi e i comportamenti formalmente
non irrituali, spesso delineati attraverso correzioni attuate anche con la
softlaw (normativa secondaria). La logica si attua anche attraverso percorsi
processuali acognitivi e induzioni a comportamenti che pongono alternative da
“soave inquisizione” suggerendo adesioni vantaggiose a fronte di incerti esiti
processuali.
La logica dell’accertamento
investigativo, del resto, non si innesta in una fase a forte connotazione
garantista, come era alle origini del modello accusatorio, ma in un percorso
ibrido, con accentuati recuperi del materiale d’accusa e da marcati interventi
del giudicante. C’è sicuramente diversità tra una consapevole – ancorché
agevolata – accettazione delle proprie responsabilità, alla quale non è estranea
anche una funzione rieducativa, ed una scelta indotta da molteplici fattori
condizionanti (economici, sociali), oltre a quelli più strettamente processuali.
Inevitabilmente, l’accentuazione dell’autoritarismo favorisce logiche ispirate a
deformare il processo dei suoi connotati storici per collocarlo in una
dimensione efficientista, spesso ispirata ad altri modelli processuali dalle cui
impostazioni siamo lontani per la forte diversità dei contesti storici, politici
e strutturali di quelle giurisdizioni.
Entro questa tenaglia – da un
lato pulsioni autoritarie e dall’altro propensioni efficientiste, anche
variamente combinate tra loro – si snatura il senso “classico” e “storico” del
processo penale, che spesso smarrisce la propria essenza. Per un verso, in
relazione alle emergenze criminali (o presunte tali) si accentuano le spinte
repressive; dall’altro, per la criminalità a medio-bassa intensità si pregiudica
la sua natura sostanziale-qualitativa che le è propria, considerati i valori in
gioco, per approdare a una burocratico-quantitativa di impostazione quasi
aziendalista che dovrebbe esserle estranea, sempre considerati i beni coinvolti.
Gian Antonio Stella per
il “Corriere della Sera” il 12 ottobre 2022.
Cos' hanno in comune il
tossicodipendente marocchino Youssef Fahmi e il grande imprenditore vinicolo ed
ex monarca della Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin?
L'immigrato disoccupato,
sbandato e schiavo dell'eroina e l'imprenditore-banchiere sono stati condannati
alla stessa pena: poco meno di quattro anni di carcere. Per l'esattezza, il
tossico si è beccato tre anni e otto mesi per avere preso per il collo un
ragazzo rubandogli nel marzo 2020 uno smartphone per strada, il banchiere a tre
mesi in più (tre anni e undici mesi in appello: la metà della condanna in primo
grado) perché ritenuto il principale responsabile del buco di oltre 6 miliardi
di euro della Bpv che ridusse sul lastrico 127 mila risparmiatori italiani
concentrati soprattutto nel mitico Nordest.
Due pesi e due misure così
abissalmente sproporzionati da togliere il fiato.
Tanto più davanti alla lettura
degli atti della commissione d'inchiesta usciti proprio in questi giorni. Basti
prendere la deposizione in Parlamento di Marino Smiderle, il cronista (oggi
direttore del Giornale di Vicenza ) che più ha seguito tutta la vicenda. Dove si
ricordano gli inaccettabili vuoti legislativi sulle responsabilità delle
«società cooperative a responsabilità limitata non quotate, nel caso specifico,
banche popolari non quotate» che permisero a chi le guidava «di rimanere al
comando per decenni senza detenere quote di capitale significative» e costruire
castelli di carta nel silenzio (se non talora tra gli elogi) di chi doveva
controllare, inclusa Bankitalia.
Fino al crac di Lehman
Brothers, quando le banche precipitarono e gli azionisti della Popolare berica
esultavano: «Noi siamo sempre attorno ai 60 euro!» Una quotazione casareccia.
Fasulla. Che per altri cinque anni illuse tutti, fino all'obbligo della
trasformazione in Spa imposto dall'Europa e introdotto dall'oggi al domani da
Renzi, e tutto crollò. Travolgendo i risparmiatori che, imbrogliati dai
funzionari delle filiali Bpv (loro stessi imbrogliati e rovinati dai vertici)
avevano addirittura finanziato nuovi aumenti di capitale convinti di aver messi
«i schei» al sicuro come fossero depositati «nel "libretto" o, come la chiamava
Zonin, nella "musina"». Cioè il salvadanaio di cui si fidavano ciecamente perché
veneto: «nostro, de nialtri». Un'illusione tradita.
La classifica del Sole 24
Ore: la città è decima. Perché a Napoli i cittadini denunciano meno che nelle
altre città: la storia del salumiere Scarciello.
Francesca Sabella su Il
Riformista il 4 Ottobre 2022.
Il Sole 24 ore ha tracciato
la “mappa del crimine” con informazioni estratte dalla banca dati interforze
dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno relative
all’anno 2021. Ebbene, con grande sorpresa, soprattutto di coloro che
continuamente indicano Napoli come la città peggiore del Paese, è Milano la
città nella quale si consumano più reati e si registra il maggior numero di
denunce. Ora, frenate l’entusiasmo, siamo comunque alla decima posizione
nella top ten delle grandi città con più reati, ma c’è da dire anche che qui i
cittadini sono più restii a denunciare. Andiamo con ordine.
Milano, quindi, si conferma al
vertice dell’Indice della criminalità, che entrerà nell’indagine della Qualità
della Vita 2022 a fine anno, con 193.749 reati denunciati nel corso del 2021:
5.985 ogni 100mila abitanti. Per dare un peso al fenomeno, la cifra risulta pari
alla somma di tutti i crimini denunciati nello stesso arco di tempo a L’Aquila,
Pordenone e Oristano, le tre province con meno densità di illeciti che si
posizionano in fondo alla classifica. E così tra le 107 province italiane Milano
è quella con più furti rilevati ogni 100mila abitanti, in particolare nei negozi
e nelle auto in sosta; è settima per denunce di violenze sessuali; seconda per
rapine in pubblica via; terza per associazioni per delinquere. Seguono per
densità di crimini le altre grandi città: tra le prime dieci classificate si
incontrano – oltre a Milano –
anche Torino (3ª), Bologna (4ª), Roma (5ª), Firenze (7ª) e Napoli (10ª).
Sì, la sorpresa: Napoli è in
fondo alla classifica per densità di atti criminali. Ma è prima per furti con
strappo e di motocicli, ma anche di contrabbando. Ma qui c’è un ragionamento
importante da fare: più denunce, però, non significa per forza meno sicurezza.
Ma anche perché i dati sulle denunce riflettono la propensione dei cittadini a
presentarle, legata a diversi fattori: la differente “soglia del dolore” della
cittadinanza verso il crimine; il grado di fiducia nelle forze dell’Ordine; la
più o meno efficace presenza delle istituzioni sul territorio. Soffermiamoci
sulla propensione dei cittadini di Napoli a sporgere denuncia, sono centinaia le
storie degli imprenditori che raccontano della paura di denunciare e rimanere
poi soli, abbandonati dallo Stato e preda della criminalità organizzata che si
ha avuto il coraggio di denunciare.
L’omertà non è un problema
solo del Sud, sia chiaro, ma che qui le istituzioni abbiano abbandonato fette
delle città è altrettanto chiaro e che questo si rifletta in una sfiducia nei
confronti di forze dell’ordine e politica, anche. La frase che centinaia di
volte abbiamo sentito dire è “ma che denuncio a fare” oppure “se denuncio mi
fanno pure qualcosa”. Sono frasi che fanno parte del quotidiano di questa città.
La sfiducia nelle forze dell’ordine e nella giustizia c’è e ed è concreta. Certo
il decimo posto fa piacere, ma bisogna considerare il perché Napoli va a
guadagnarsi l’ultima posizione. Basti pensare che in città la metà dei cittadini
non denuncia i reati di camorra per paura di ritorsioni. Parliamo di un numero
enorme di reati che non compaiono nei database della Polizia e quindi nelle
classifiche. E basta ricordare due storie che fanno parte di una lista
lunghissima di imprenditori che hanno denunciato e poi sono rimasti soli.
Luigi Leonardi, denunciò la
camorra che gli chiese il pizzo per il suo negozio di articoli di illuminazione,
lasciato solo dallo Stato e poi addirittura sospettato lui stesso di aver
commesso un reato. Lui come il salumiere Ciro Scarciello che dopo aver
denunciato la camorra, fu costretto a chiudere il suo negozio a Forcella. Sono
solo alcuni esempi. Una bella notizia il decimo posto per Napoli, ma guardiamo
oltre i numeri.
Francesca Sabella. Nata a
Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole ha deciso, non
senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro. Giornalista
pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi protagonisti.
Risarcimento del danno:
tutto quello che c'è da sapere.
Il risarcimento del danno, sia
questo patrimoniale o non patrimoniale, ha una logica proprietaria che si
estende al diritto penale come a quello civile. Ecco come funziona. Giuditta
Mosca il 2 Settembre 2022 su Il Giornale.
I criteri
del risarcimento del danno hanno una natura variegata e complessa che vive di un
lessico proprio e che va approfondita per carpirne la filosofia e gli obiettivi
di fondo. Qui si parla delle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali e
delle pratiche risarcitorie in ambito penale e civile, proponendo al lettore le
sentenze che evidenziano i principi e il funzionamento delle logiche attualmente
applicate nell’ordinamento giuridico italiano. Partiamo dalla definizione di
risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno
È descritto all’articolo 2043
del Codice civile il quale sancisce come un atto doloso o colposo che arrechi un
danno ingiusto debba essere risarcito da chi lo cagiona. Il medesimo articolo
rimanda al capo 2058 che assume importanza, giacché prescrive che il danneggiato
può chiedere la reintegrazione in forma specifica ma anche che il giudice possa
decidere altrimenti se questa risulta insopportabile per chi deve risarcire il
danno.
In parole più immediate,
qualora fosse danneggiato un bene fisico, se ne può chiedere la sostituzione o
l’equivalente in denaro per ripararlo. Il giudice può decidere per quest’ultima
se il debitore non può affrontare il costo della sostituzione integrale. La
legge è orientata a riconoscere la reintegrazione della forma specifica perché è
quella che più tiene conto dell’interesse del danneggiato e del danneggiatore e
che meglio incarna i principi di solidarietà descritti nell’articolo 2 della
Costituzione.
Il danno può
avere un’origine illecita contrattuale, extracontrattuale oppure
precontrattuale. Nel primo caso ci si trova nell’ambito di una condotta che lede
i principi stabiliti in un contratto mentre, nel secondo caso, vengono lesi i
principi della convivenza della comunità. La responsabilità precontrattuale
ricorre nel momento in cui, nella fase in cui si sta formando un contratto, una
delle parti non rispetta gli obblighi eventualmente previsti. Per tutte queste
tre condizioni valgono le sanzioni del codice civile, ossia il risarcimento del
danno.
Responsabilità civile e
responsabilità penale
Quando si lede una delle norme
del diritto civile si creano i presupposti per l’omonima responsabilità. In
questo ambito si situano, per esempio, la responsabilità medica, quella degli
avvocati e dei professionisti in genere. La responsabilità civile prevede il
risarcimento del danno che consta sia dei danni patrimoniali che di quelli non
patrimoniali, ossia i danni alla persona.
A differenza di quanto si
possa credere, la differenza tra responsabilità civile e penale non ha nulla a
che vedere con la gravità del fatto, ma riguarda la natura delle norme violate e
nelle sanzioni che queste comportano. Nei perimetri della causa civili si può
ottenere un risarcimento del danno, nei confini della legge penale si situano
invece le applicazioni delle pene.
L’indennizzo
Come scritto, il risarcimento
del danno è il metodo usato per rimediare a una condotta illecita e ha il
compito di ripristinare la situazione a come era prima che il danno fosse
inferto. L’indennizzo esce da questo canone ed è di norma riconosciuto a chi ha
subito un pregiudizio non proveniente da un atto illecito o da responsabilità
civile. I libri di legge citano come esempio quello dell’espropriazione per
pubblica utilità. Pure essendo del tutto lecita, chi perde la proprietà che
possedeva riceve un indennizzo, ovvero una indennità.
I danni non patrimoniali
Quando il danno è facilmente
quantificabile, per esempio la riparazione di un veicolo coinvolto in un
incidente, la situazione è chiara e l’importo del risarcimento anche. Quando si
entra nella complicata materia dei danni non patrimoniali, ossia i danni alla
persona, la questione si fa più interessante.
Il danno non
patrimoniale identifica i pregiudizi che susseguono la lesione dei diritti della
persona e non hanno rilievo economico. Frase che merita un approfondimento e che
non si esaurisce nelle disposizioni dell’articolo 2059 del Codice civile il
quale è stato reinterpretato da quelle che sono note con il nome di “Sentenze di
San Martino”, ovvero le sentenze 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11 novembre
2008 che hanno chiarito quali sono le voci che sottostanno al risarcimento in
caso di danno alle persone. Il danno non patrimoniale è stato quindi
circoscritto a quello biologico e quello morale ed esistenziale che meritano di
essere quantificati come voci distinte e non più tutte insieme.
Il danno biologico è
estensione dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private e, pure
riferendosi a lesioni di entità non superiori al 9% di invalidità causate da
sinistri stradali, viene applicata a tutte le situazioni nelle quali un
individuo subisce danni causati da condotte illecite. Rientra quindi nella sfera
del danno biologico, per esempio, anche la responsabilità medica.
Si parla quindi di
microlesioni che, per la disciplina, sono quelle temporanee o permanenti che
hanno conseguenze sulle attività quotidiane e sulla vita relazionale di chi le
ha subite. In questa definizione non sono però contemplate le ripercussioni che
le lesioni hanno sulla capacità del danneggiato di produrre reddito.
Le lesioni superiori al 9%
vengono quantificate in base alle “tabelle di Milano” le quali sono punto di
riferimento in tutto il Paese.
Il danno esistenziale è
argomento controverso, perché con il passare degli anni diverse sentenze della
Cassazione hanno più volte corretto il tenore del danno esistenziale volendolo
prima collegare a quello morale e poi ritornando a uno stato in cui le due
tipologie di danno fossero da considerare ognuna per sé. Ciò che ne è emerso è
che il danno esistenziale può essere riconosciuto a fronte di un fatto che lede
i diritti inviolabili di una persona. Deve trattarsi di una lesione di un certo
rilievo (per quanto il termine possa essere vago) e il danno non può essere una
condizione di fastidio o di disagio.
Il danno morale riguarda una
lesione fisica o la perdita di un congiunto o di una persona cara e si propone
di riparare una sofferenza "interiore". Il danno morale veniva riconosciuto solo
alle vittime di reati penali ma, con gli interventi della Cassazione, accompagna
di norma il danno biologico e, anche in questo caso, non è collegato alla
capacità del danneggiato di generare reddito. Per la Cassazione deve trattarsi
di un dolore sofferto che non degeneri in conseguenze patologiche. Poiché il
danno morale rimanda al danno biologico, non obbliga chi ne soffre di
richiederne esplicitamente il risarcimento, è di fatto sufficiente aumentare
l’importo del danno biologico.
Il risarcimento del danno
patrimoniale
Riguarda gli impatti che un
illecito extracontrattuale ha sul patrimonio del danneggiato. È disciplinato
dagli articoli 1223, 1226 e 2056 del Codice civile e si suddivide in:
Danno emergente, ossia un
danno immediato che impatta sulla diminuzione delle sostanze patrimoniali del
danneggiato. Un esempio è riconducibile alle spese necessarie alla riparazione
di una vettura in seguito a un sinistro ma anche ai costi di un intervento reso
necessario da una prestazione male effettuata da un professionista.
Il lucro cessante è relativo
al danno futuro di un mancato guadagno. Il risarcimento è riconosciuto dal
giudice soltanto quando c’è la certezza oppure una prova rigorosa della sua
probabilità.
I criteri per il risarcimento
Vigono tre criteri: il
risarcimento in forma specifica, il risarcimento equivalente e la via
equitativa.
Il risarcimento del danno
in forma specifica permette di ripristinare la situazione a come era prima del
danno. Se questa formula risulta onerosa per chi è chiamato a risarcire, il
giudice può ricorrere al risarcimento equivalente che, peraltro, è la via più
canonica mediante la quale un giudice individua una somma che traduca in denaro
il valore il danno.
Infine, il risarcimento del
danno in via equitativa, è la formula usata quando un danno è certo ma
difficilmente quantificabile. Si applica sia alle violazioni di tipo
contrattuale sia a quelle extracontrattuali e, nel valutare il risarcimento,
occorre esaminare la specificità del singolo caso senza sovrastimarlo o
sottostimarlo.
E nel processo penale?
La persona offesa può chiedere
il risarcimento del danno cagionato da un reato e, per farlo, può:
Costituirsi parte civile nello
svolgimento del procedimento penale.
Avviare un’azione
risarcitoria in ambito civile. In questo caso il processo civile è del tutto
scisso da quello penale e, per principio, l’esito di un procedimento non inficia
sull’altro, a meno che sul fronte penale non si sia già giunti almeno alla
sentenza di primo grado
Gli illeciti di natura penale
danno accesso al risarcimento del danno morale.
Settant’anni di processo
per un’eredità: «Una vita persa a cercare giustizia».
La denuncia: «Ormai non ne
vale più nemmeno la pena: per pagare tutte le spese non basterebbe l’intera
proprietà di cui stiamo discutendo ormai da una vita». Simona Musco su Il Dubbio
l'1 settembre 2022.
«Ormai non ne vale più nemmeno
la pena: per pagare tutte le spese non basterebbe non solo la mia parte, ma
l’intera proprietà di cui stiamo discutendo ormai da una vita». Se mai servisse
un esempio concreto della lunghezza dei processi civili in Italia, la storia di
Antonietta Caparra e suo marito Vincenzo Crea sarebbe da manuale. I due,
infatti, da 70 anni combattono in tribunale per poter finalmente mettere le mani
sull’eredità lasciata alla donna dal padre, Salvatore Caparra, deceduto nel
1952. Antonietta, ultima sopravvissuta di 10 figli, ha infatti dovuto affrontare
il giudizio di divisione ereditaria prima contro i quattro fratelli e poi contro
gli eredi, «detentori a non domino dell’intero compendio ereditario».
Il giudizio, dopo 18 sentenze
intermedie di tutte le giurisdizioni a favore della donna, si è inceppato per
ben 14 anni davanti alla Corte d’appello di Catanzaro, che solo nel 2019 si è
pronunciata, di fatto confermando la divisione decisa dal Tribunale di Crotone
in primo grado nel 2005. Ma il 21 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha deciso
di rinviare tutto di nuovo davanti ai giudici del capoluogo calabrese, dove ora
inizierà un nuovo giudizio d’appello. A 87 anni, dunque, Antonietta Caparra nei
suoi terreni non ha potuto piantare nemmeno una piantina. Così nel 2018 ha
deciso di presentare un esposto al Csm, chiedendo di fare chiarezza sul
comportamento dei giudici che si sono occupati del caso, rei, secondo la donna e
il marito, di aver perso colpevolmente tempo. Quell’esposto, racconta oggi al
Dubbio Vincenzo Crea, ex avvocato, è però finito nel nulla. «Ci è stato detto di
rivolgerci all’autorità ordinaria», ha evidenziato l’uomo, che per risolvere la
questione dovrebbe, dunque, rivolgersi ancora una volta ai giudici. Antonietta e
suo marito le hanno provate tutte: dalla protesta con il presidente del
tribunale a quella col giudice istruttore, passando per un appello al ministro
della Giustizia. E nel frattempo hanno continuato a spendere soldi, osservando
quel patrimonio farsi via via più esiguo, da dividere per un numero sempre
crescente di eredi.
«Abbiamo già speso centinaia
di migliaia di euro tra avvocati, perizie e viaggi. Ne avremo fatti almeno 400 –
avevano protestato -. E nonostante tutto non abbiamo mai potuto mettere mano
alle risorse che stiamo reclamando. Eppure ci sono diverse perizie a nostro
favore. Non vogliamo niente di più rispetto a quello che ci tocca, solo la
nostra parte». Anche perché, dicono i due, i giudici hanno più volte ribadito il
diritto di tutti i figli all’eredità, disponendo la consulenza tecnica per
determinare a chi assegnare cosa. La quota della signora Antonietta, però, nel
frattempo è passata da 160 a 16 ettari. «Alla morte di mio padre ero appena
tredicenne e quindi alla mercé dei miei fratelli, patologicamente attaccati alla
terra», aveva segnalato nel suo esposto al Csm. Il processo d’appello, iniziato
nel 2005, per anni è stato scandito da udienze interlocutorie ed inutili,
«riservando le stesse domande platealmente infondate e più volte rigettate».
Fino ad una sentenza interlocutoria «fuori del diritto», affermano, avendo
escluso dalla collazione 533 ettari. «Esclusione illegale, non solo sotto il
profilo costituzionale, ma anche perché le donazioni sono state concesse con la
clausola donativa come “anticipata quota sulla futura quota legittima”,
chiaramente implicante la collazione, totalmente ignorata in sentenza, come se
non esistesse, dando luogo ad una sentenza antigiuridica e inqualificabile che
favorisce i donatari, abusivi detentori dell’intero compendio dal 1952», si
leggeva nell’esposto.
Una situazione che, dopo 50
anni di contenzioso, ha depauperato le risorse economiche della famiglia. Nel
2019, finalmente, la Corte d’appello di Catanzaro ha deciso la restituzione dei
beni in conformità del progetto di divisione precedentemente approvato. E in
nome del giusto processo e del principio di ragionevole durata, i giudici
avevano applicato quanto previsto dal decreto legislativo numero 154 del 2013,
contenente la disciplina transitoria della riforma della filiazione di cui alla
legge numero 219 del 2012. Secondo i giudici di appello, dunque, la
parificazione compiuta da tale legge tra i figli nati al di fuori del matrimonio
e quelli invece nati all’interno del matrimonio era applicabile alla causa in
questione, risolvendo la controversia in base alla norma sopravvenuta e, quindi,
confermando quanto deciso in primo grado, circa la necessità di tenere conto
anche delle donazioni ai fini della collazione. Secondo la Cassazione, però, la
sentenza d’appello sarebbe errata «nel momento in cui, sia pur facendo richiamo
all’intervento dello ius superveniens, ha disapplicato indebitamente le
decisioni prese in punto di collazione con la precedente sentenza, in quanto in
tal modo, ancorché motivando con il riferimento all’art. 111 Cost., ha
riconosciuto un diritto senza che però fosse stata validamente proposta la
domanda, in quanto la riforma della decisione non definitiva doveva avvenire
tramite la sua impugnazione».
Insomma, come in un eterno
gioco dell’oca, i protagonisti della vicenda sono costretti a tornare indietro
di una casella, ancora una volta. «Mia moglie ha 87 anni e diverse patologie: in
questo modo verrà privata della legittima, perché bisognerà rifare il progetto
di divisione – spiega Crea -, il che richiederà anni. E la prima udienza è già
stata rinviata al 6 dicembre». Un vero e proprio calvario per i due, che avevano
denunciato l’irragionevole durata del processo a Palazzo dei Marescialli.
«L’eccessivo tempo trascorso è di per sé dimostrativo di gravi responsabilità –
aveva sottolineato Caparra -. La magistratura rappresenta un baluardo di
legalità a cui nessun magistrato deve discostarsi».
Giustizia ingiusta. Prima
in carcere e poi a processo: una persona su tre aspetta la sentenza dietro le
sbarre.
Viviana Lanza su Il Riformista il 28 Luglio 2022.
Carcere, diritti,
giustizia. Se ne tornerà a parlare durante la prossima campagna elettorale, c’è
da aspettarselo. Questi argomenti sono in genere molto buoni per riempire di
contenuti discorsi e proclami politici, salvo poi essere abbandonati nel deserto
di iniziative che separa le parole dai fatti. Uno degli scogli più grandi da
superare, per chi davvero volesse affrontare seriamente il tema carcere è quello
della detenzione preventiva. Cioè, il ricorso alla custodia cautelare che
da extrema ratio, da adottare in casi di conclamata e reale pericolosità
sociale, è finita per essere una pratica molto usata dai pm.
Tutto questo, in un sistema
giustizia che non funziona come dovrebbe e che ha tempi di definizione dei
processi estremamente lunghi, biblici si direbbe, genera drammi e casi
di malagiustizia. Perché? Perché in molti casi la custodia cautelare si tramuta
in una sorta di anticipazione della condanna, a prescindere quindi dall’esito
del processo: della serie, prima ti sbattiamo in carcere e poi verifichiamo se
sei innocente o no. Nei paesi dell’Unione europea un detenuto su cinque si trova
in cella pur non essendo stato condannato per alcun crimine. SI contano in
totale oltre 98mila persone in detenzione detentiva. In Italia circa un terzo
della popolazione è in carcere in via cautelare. In Campania idem: su 6.687
detenuti presenti nelle carceri della regione si contano 4.367 detenuti con
almeno una condanna e 2.500 che sono invece in cella senza ancora una condanna
definitiva.
Tutto questo –
sottolinea Openpolis riportando i dati di un’inchiesta di Deutsche welle –
accade «nonostante gli studi suggeriscano che la detenzione preventiva, nella
maggior parte dei casi, non sia necessaria. Oltre al fatto che ricorrere a
modalità alternative per gestire persone non ancora condannate aiuterebbe a
contestare il sovraffollamento carcerario. Un problema sentito in tutti i Paesi
dell’Unione europea». Già, il sovraffollamento quello che ogni politico in
campagna elettorale promette di voler contrastare e che poi puntualmente ignora.
È bene ricordare che quando si parla di detenzione preventiva si parla
di presunti innocenti per i quali non c’è stata ancora una sentenza, non una
condanna definitiva. «Come evidenzia l’ultimo report del Consiglio d’Europa –
ricorda Openpolis – si tratta di quasi 100mila persone detenute senza condanna
per periodi estremamente variabili, che possono essere di alcuni mesi come di
più di un anno, a seconda del Paese». Secondo gli studi condotti sulla
detenzione preventiva, la maggior parte delle persone detenute preventivamente
sono accusate di aver commesso crimini minori e in prevalenza sono stranieri,
disoccupati e senzatetto.
Dati che stridono enormemente,
soprattutto in Italia, con i principi costituzionali per cui il carcere dovrebbe
essere l’extrema ratio e non la soluzione ai drammi sociali e alle carenze delle
istituzioni. Se si considera la condizione delle carceri in Europa, e in Italia
(pensiamo, noi che siamo napoletani, a quel che sono Poggioreale, per esempio,
carcere vecchio e superaffollato, o Santa Maria Capua Vetere, carcere senza
acqua potabile), è chiaro che la detenzione preventiva si rivela particolarmente
dura e devastante per una persona innocente fino a prova contraria. «Le persone
possono essere rinchiuse per 23 ore al giorno e avere pochi contatti con il
mondo esterno e poche attività a disposizione per trascorrere il tempo. Come
mostra un recente studio – si legge nel report sulla detenzione preventiva – le
misure di reintegrazione come il lavoro e i programmi sociali non sono messe a
disposizione dei presunti innocenti, i quali sono inoltre esposti a una
condizione di forte incertezza rispetto al proprio futuro». Una devastazione
nella vita di troppi: dagli studi è emerso, infatti, che circa la metà dei casi
di custodia cautelare terminano senza una condanna.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Vite sospese per anni,
impigliate nell’attesa di un verdetto. Una malattia chiamata processo: quando
tutto termina assolti o condannati resta un vuoto.
Alberto Cisterna su Il
Riformista il 21 Luglio 2022.
Esistono
i “nonluoghi” insegnava Marc Augè. Spazi in cui le vite degli uomini si
incrociano, si sfiorano senza tessere tra loro alcuna relazione. Ambiti in cui
non si consuma neppure l’apparenza di un rapporto, in cui le individualità si
contano, si sommano, ma senza che ciascuna vita abbia la minima rilevanza in sé
considerata per gli altri. Trovarsi imputato in un processo, rispondere di un
reato per anni e anni crea un “nonluogo” dell’anima, uno spazio indeterminato in
cui la vita fluttua nella sola attesa di un verdetto.
Certo non tutta la vita, ma
una parte importante di essa resta come sospesa, impigliata: aspetta, spera,
dispera, impreca, blandisce, teme, minaccia. Sentimenti sprecati, emozioni
indotte, paure provocate, speranze ondivaghe. Quando tutto termina, quando
l’innocenza risuona si ha l’impressione di un vuoto da colmare, di nuove
emozioni da sperimentare, di un guado da cercare nel fiume impetuoso della vita,
forse, un po’ più a monte o, forse, un po’ più a valle e, comunque, altrove.
Certo la malattia genera paesaggi interiori in gran parte simili. La guarigione
lascia l’anima senza un obiettivo preciso da raggiungere e senza lo scopo verso
il quale era proteso fino a poco prima ogni soffio vitale. La vita sanata dal
male resta priva di quel velo di incertezza e di inquietudine che la rendeva,
comunque, tenace, fragile, reattiva.
Poi tutto riprende a scorrere:
un po’ più in là, in un altro punto. Nel punto in cui i rugosi e taglienti
canali carsici della sofferenza restituiscono l’acqua alla luce del sole dopo
averla imprigionata in mille meandri e dispersa per mille anfratti bui e
tortuosi. Accettare il processo come si accetta una malattia, sperando in
un’assoluzione che possa suonare come una guarigione. Ma assolti o guariti il
problema resta lo stesso: dove guadare nuovamente il torrente dell’esistenza, a
partire da quale roccia saltare gli argini per fare rientro a casa. L’illusione
di tornare indietro, di poter volgere lo sguardo a un passato divenuto
irraggiungibile e che, quindi, è definitivamente seppellito. Peggio, crogiolarsi
nella retorica dell’ingiustizia, dell’autocommiserazione affidandosi al
vaticinio ingannatore di una ricompensa impossibile, credendo alle sirene di una
riparazione che nessuno può dispensare.
Oppure tener dritto lo sguardo
in avanti e riprendere la vita esattamente nel punto in cui era stata sfregiata;
senza rievocare sogni e progetti, divenuti ormai fantasmi, ma anche senza
rinunciare al tentativo di riannodare fili, di ricomporre la tela, di ultimare i
dettagli di un bozzetto rimasto incompiuto e senza autore per un calcio sferrato
alla tavolozza dei colori. Quando uno dei più importanti intellettuali del
secondo scorso, cacciato dal fascismo e privato della sua cattedra
universitaria, fece ritorno – oltre venti anni dopo – nel suo ateneo trovò ad
attenderlo i suoi nuovi studenti. Non erano, certo, quelli della sua ultima
lezione bruscamente interrotta dai picchiatori in camicia nera. Erano altri,
molti dei quali neppure nati al tempo dell’infamia. Il professore si accomodò
sulla sua cattedra, la stessa di quel giorno di vergogna, sfogliò lentamente il
libro di testo in un silenzio composto, alzò lo sguardo verso quei ragazzi e
disse: «allora, se non sbaglio, eravamo rimasti a pagina…». Alberto Cisterna
La macchina della giustizia
è in ginocchio: a forza di riforme non ci sono più giudici.
Pensionamenti, stop ai
concorsi, improcedibilità. Nell’organico mancano 1.442 magistrati e ci vorranno
tre anni per vedere all’opera i nuovi assunti. E così i processi vanno al
macero. Simone Alliva su L'Espresso il 18 Luglio 2022.
L’allarme lanciato dal
Consiglio superiore della magistratura si dipana sotto silenzio, in tono minore.
Scivola nella categoria “notizie smarrite”, quelle che circolano per un momento
e poi si estinguono senza che nessuno le raccolga, sopraffatte dall’ondata delle
altre. In tutta Italia mancano 1.442 magistrati rispetto quelli previsti in
organico. Il tasso di scopertura a livello nazionale si avvicina ormai al 15 per
cento.
L’enorme carico di lavoro
vale bene un sotterfugio. I processi e la teoria della finzione: l’enorme carico
di lavoro è solo un sotterfugio.
Andrea R. Castaldo su Il
Riformista il 17 Luglio 2022.
Make-believe è un’efficace
espressione inglese che fotografa alla perfezione lo stato attuale
della giustizia penale in Italia. Non esiste una parola corrispondente precisa
in italiano, ma traducendo con ‘fare finta’ si rende bene l’idea. Come ben sanno
attori e comprimari (avvocati, ma soprattutto imputati e vittime) che affollano
quotidianamente i Tribunali, da anni va in scena lo spettacolo ormai rodato
della finzione. E i segnali provenienti da differenti contesti non sono
incoraggianti, al contrario inclinano al pessimismo. E allora proviamo a mettere
ordine, quanto meno per dismettere quel velo di ipocrisia e retorica che
peggiora la situazione.
Cominciando dalla definizione.
Ora, la finzione ha un doppio volto e ciascuno di noi può scorgervi quello
preferito. Nel linguaggio comune, la fictio viene convenzionalmente associata
all’idea di menzogna, di inganno; ma nella versione nobile e più sofisticata
assume contorni quasi positivi. Infatti, per i filosofi del finzionalismo la
finzione svolge un ruolo fondamentale nell’individuazione della realtà, sino a
costituirne una forma di manifestazione. Non resta che applicare il principio
nella prassi. Entrando in un’aula di Tribunale qualsiasi in un giorno qualsiasi,
l’incauto osservatore si troverà di fronte un ruolo di udienza particolarmente
carico, anche di 30-40 processi. Una concezione meccanica della giustizia, che
si muove per numeri e statistiche. Ma dietro l’assurdità delle cifre compaiono
con prepotenza le persone e le loro storie, in un tessuto di sofferenze che
coinvolge indifferentemente autore e vittima del reato. E dove lo sbocco finale
inevitabilmente deluderà una parte. Ma la quantità non è l’unico problema, forse
neppure quello maggiormente rilevante. Intanto è da considerare il peso. In
senso fisico e virtuale.
Ogni fascicolo è composto da
molte, troppe pagine, spesso da atti inutili. Un peso che si trasferisce sulle
spalle del giudice, sotto forma di zavorra, che dovrà decidere. E per leggere
(tutto?) occorre tempo e per comprendere e valutare ciò che si legge ne occorre
di più. Peraltro, a ogni stazione della via crucis (le diverse fasi e i vari
gradi del giudizio) il peso aumenta. Ora, bisogna compiere un ulteriore sforzo e
dalla immaginazione calarsi nella realtà. Il nostro processo penale è (o almeno
dovrebbe essere) imperniato sul modello accusatorio. In parole semplici,
significa che la prova si forma nel contraddittorio tra le parti dinanzi a un
giudice terzo, privilegiandosi oralità e celerità. Ma se il dibattimento si
celebra a distanza di anni dai fatti, l’attendibilità dei testimoni è
inevitabilmente compromessa e i ‘non ricordo’ vengono costantemente suppliti
dalle precedenti dichiarazioni scritte. La finzione si autolegittima. Ma il
giudice, dopo l’esame di quel teste, non si ritira in camera di consiglio;
semplicemente, rinvia a una prossima udienza; che si terrà a distanza di mesi, o
addirittura di un anno.
Con l’inevitabile conseguenza
che il suo giudizio si fonderà sulla trascrizione fredda nei verbali e non
nelle ‘sensazioni’ raccolte in presenza. La ciliegina sulla torta è che sarà
molto probabile che il giudice (monocratico o collegiale) che emetterà la
sentenza non sarà neppure colui che ha partecipato alle precedenti udienze.
L’immutabilità del decisore, un principio di civiltà ancor prima che di diritto,
è stata infatti sacrificata sull’altare del pragmatismo nell’orientamento
giurisprudenziale attuale, ammettendosi in buona sostanza la deroga, sulla base
del consenso delle parti e con qualche garanzia formale e non sostanziale. Di
nuovo la teoria della finzione. Se si prova a trasferire questo desolante
affresco nei processi di criminalità organizzata o con una molteplicità di
imputati, o dalle contestazioni tecniche, il modello (concreto) che viene fuori
è francamente impressionante. Eppure, è ciò che quotidianamente si avvera in
Italia.
Con l’aggravante che le
indagini replicano il sistema della pesca a strascico: prendere ogni carta
possibile per la selezione futura. ‘Fare finta’ diventa dunque una necessità: il
carico di lavoro per essere smaltito vale bene un sotterfugio. La finzione della
conoscenza e dello studio si accompagna però sul versante psicologico all’alibi
del principio di affidamento, noto soprattutto nel lavoro di équipe. Confidare
cioè nella correttezza e diligenza professionale di terzi. Che si traduce nel
processo penale nel neutralizzare il senso di colpa auspicando che qualcun altro
nella cinghia di trasmissione del processo avrà tempo (e voglia) di leggere e
studiare. Make-believe, per l’appunto. Andrea R. Castaldo
Milano, il paradosso del
processo ai quattro operatori Amsa: stesse accuse, ma tre modalità di pena
diverse.
Luigi Ferrarella su Il Corriere della Sera il 16 Luglio 2022.
Due uomini e due donne hanno
perso il posto perché filmati mentre portavano via alcuni oggetti destinati alla
ricicleria di via Corelli. Ma due hanno avuto la libertà temporanea, una i
servizi sociali e l’altra il carcere.
Due condannati liberi in
attesa della modalità di espiazione della pena, una in carcere ma poi liberata e
ammessa ai servizi sociali, la quarta invece detenuta da aprile: eppure tutti e
quattro sono accomunati dalla medesima condotta (aver trattenuto per sé nel 2019
qualche oggetto consegnato alla ricicleria dell’Amsa dove lavoravano in via
Corelli, e aver accettato qualche mancia da cittadini che da soli facevano
fatica a portare gli oggetti); dagli stessi reati («peculato» e «corruzione»,
essendo questi operatori ecologici ritenuti «incaricati di pubblico servizio»);
dalla stessa pena patteggiata a 2 anni e 2 mesi; e pure dalla stessa «sfortuna»
di dover fare i conti con la novità della legge cosiddetta «Spazzacorrotti».
Cioè con le norme che ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione
impediscono l’espiazione della pena in misura alternativa al carcere, salvo
prova di fattiva collaborazione. Eppure questo quartetto, in partenza analogo,
si sfrangia in esiti tutti differenti sul sensibile tema della libertà
personale.
La curiosa vicenda inizia
quando Amsa, che evidentemente nutriva qualche sospetto, ingaggia una agenzia di
polizia privata che filma i lavoratori mentre portano via magari lo schermo di
un vecchio tv, cornici di quadri, vecchi notebook dismessi (presumibilmente
venduti per poco a qualche mercatino), e mentre ricevono qualche spicciolo da
cittadini (rimasti non identificati) che si facevano aiutare a portare in
discarica oggetti ingombranti. Queste immagini vengono poste poi a base sia
dei licenziamenti (sebbene infine tradottisi in una transazione con i lavoratori
che accettano di perdere il posto a fronte al versamento da parte di Amsa di
10.000 euro), sia della denuncia alla Procura: la quale dai video trae le
imputazioni di peculato (l’essersi appropriati in ragione del proprio ufficio di
cose appartenenti alla pubblica amministrazione, quali sono i rifiuti una volta
consegnati alle riciclatorìe) e corruzione (l’aver accettato denaro da chi si
faceva aiutare).
I quattro lavoratori, due
uomini e due donne, con il difensore Pasquale Cuomo scelgono di patteggiare 2
anni e 2 mesi senza sospensione condizionale. Ma in sede di esecuzione della
pena la dea bendata della giustizia si rivela strabica. Ai due uomini, infatti,
l’ufficio esecuzione della Procura (forse concentrato in quel momento sul rebus
giuridico della tempistica della nuova legge) sospende l’ordine di
carcerazione appena emesso, come se non ci fosse il problema dei reati ostativi.
A una delle due donne, al contrario, l’ordine di carcerazione sempre della pm
Adriana Blasco viene invece eseguito in forza appunto dell’obbligo dettato dalla
«Spazzacorrotti», ma l’arrestata, quando da detenuta fa domanda di misura
alternativa presso la Sacra Famiglia di Cesano Boscone e con donazione di 500
euro alla Caritas, viene ammessa dai giudici di sorveglianza ai servizi sociali
anche senza collaborazione: perché? Perché «i fatti risultano integralmente
accertati, e una eventuale collaborazione della detenuta non sembra essere utile
e rilevante, visto che anche il pm non ha segnalato la necessità di svelare
altre attività rimaste oscure». L’esatto contrario di quanto la quarta
condannata legge invece nel provvedimento con il quale a inizio luglio altri
giudici di sorveglianza rinviano la sua udienza a fine settembre, per chiedere
ai pm se esistano «possibili spazi collaborativi» su «il denaro ricevuto da
terze persone non identificate». Richiesta che pare ardua da esaudire, visto che
nei video gli elargitori dei pochi euro non erano identificabili, i lavoratori
non li conoscevano, e non vi furono indagini sul punto.
Gli italiani non credono
più nella giustizia: crolla la fiducia nelle toghe.
Il Rapporto Eurispes: per due
cittadini su tre il sistema giudiziario non funziona. I mali principali? La
lentezza dei processi e una legge che non è uguale per tutti... Simona Musco su
Il Dubbio il 20 giugno 2022.
Sempre più giù. Il livello di
fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia è ai minimi storici. E chi
pensa che i cittadini siano poco interessanti ai temi toccati dal referendum del
12 giugno, al netto dei risultati, probabilmente non ha un quadro chiaro della
situazione. Perché se c’è una cosa sicura, almeno a guardare la fotografia
scattata dal 34esimo rapporto Eurispes, è che una rivoluzione nel campo della
giustizia al Paese non dispiacerebbe. Il rapporto è chiarissimo nella sua
collezione di numeri e dati: due italiani su tre non sono soddisfatti del
sistema giudiziario italiano.
I numeri sono sconfortanti: il
20,6% degli intervistati esprime un giudizio totalmente negativo, dichiarando di
non avere per niente fiducia nella giustizia italiana. Ne ha poca, invece, il
45,3%, abbastanza il 28,2% e molta solo il 5,9%. Il dato più drammatico, però,
riguarda l’identikit del cittadino disilluso: non solo adulti ormai inseriti nel
mondo del lavoro e avvezzi a scandali come quello del caso Palamara o casi di
malagiustizia storici, bensì giovani, soprattutto di età compresa tra i 18 e i
24 anni. Ovvero coloro che rappresentano il futuro del Paese. In questa fascia
“critica”, infatti, si trovano coloro che hanno poca (50,9%) o nessuna (22,4%)
fiducia nella giustizia, giudizio negativo che va via via mitigandosi nelle
fasce di età superiori, collocando i più fiduciosi tra coloro che hanno un’età
compresa tra i 45 e i 65 anni. Una delle conseguenze più immediate è che se la
fiducia scarseggia pensare di affidarsi alla giustizia sembra quasi una
sciocchezza. Così più di un cittadino su quattro – il 27,3 per cento –
preferisce non denunciare reati o illeciti. Il che non consente nemmeno di
stilare statistiche affidabili sull’andamento dei reati nel nostro Paese.
Ma perché tanta riluttanza?
L’11% confessa che i fastidi di un procedimento legale sono superiori ai
vantaggi che potrebbe ottenere denunciando, il 10,1% dichiara di aver desistito
dall’intento per non dover sostenere spese legali e il 6,2% perché sfiduciato
nei confronti della giustizia.La sfiducia ha una gradazione diversa a seconda
delle convinzioni politiche. I più disillusi sono coloro che non si sentono
rappresentati da alcun partito (73,4%), ma la vera sorpresa è che anche gli
elettori del Movimento 5 Stelle – partito iper giustizialista e da sempre
idolatrante le toghe, a prescindere dai risultati – nutrono poca fiducia nel
sistema, ovvero il 69,7%. Diffidenti anche gli elettori di sinistra (66,8%),
mentre la diffidenza cala tra i sostenitori del centro (61,7%), della destra
(58,9%), del centro-destra (57,5%) e del centro-sinistra (51,6%). A creare
questa crepa tra cittadino e giustizia è soprattutto la lentezza cronica dei
processi, lentezza sulla quale l’Europa ha puntato un faro, tant’è che i fondi
del Pnrr sono legati a doppio filo alla capacità delle riforme in atto di
ridurre i tempi elefantiaci della giustizia italiana.
Le lungaggini sono al primo
posto in classifica per il 23% degli intervistati. Per il 19,8%, invece, il
problema è un altro: a non convincere è che la legge sia uguale per tutti,
lamentando, dunque, privilegi e ingiustizie a seconda di chi finisce nelle
maglie della giustizia. Per il 13,6% il problema è nell’assenza di certezza
della pena, mentre per l’11,9% le cause sono da ricercare nelle scelte sbagliate
operate dai magistrati. L’11,6%, infine, sostiene che siano le leggi ad essere
inadeguate. Solo l’8% è invece convinto che la giustizia in Italia funzioni
bene. I temi del referendum vengono sfiorati nel capitolo che riguarda la
responsabilità dei giudici e compiti della giustizia.
Secondo l’80,2% dei cittadini
intervistati, i giudici dovrebbero essere giudicati con lo stesso sistema
applicato a tutti i cittadini, affermazione che fa venire in mente il quesito –
bocciato dalla Consulta – sulla responsabilità civile delle toghe. A sostenere
il contrario è il 19,8%. Il che fa pensare che se tale domanda fosse stata
ritenuta ammissibile dal giudice delle leggi, forse gli italiani si sarebbero
precipitati a votare in massa. Per il 78,2% il primo compito della giustizia è
garantire una pena adeguata per chi ha sbagliato, mentre al secondo posto, con
il 60,5%, si piazza il recupero ed il reinserimento sociale di coloro che sono
stati condannati per gli errori commessi – che vede contrario il 39,5% degli
intervistati. Ma la sfiducia nel sistema giustizia è visibile anche nella
convinzione manifestata dal 57,8% degli intervistati – secondo cui l’azione dei
giudici sarebbe condizionata dall’appartenenza politica (è poco d’accordo con
questa posizione il 31,1% e non lo è affatto l’11,1%).
Ma qual è la visione che gli
italiani hanno della pena e delle sanzioni alternative? Il 29,5% afferma di non
volere che coloro che si sono macchiati di colpe gravi abbiano l’opportunità di
usufruire di misure alternative al carcere, come arresti domiciliari,
affidamento ai servizi sociali, semilibertà, eccetera, il 27,3% è favorevole
all’abolizione degli sconti di pena per i reati più gravi, il 24,7% si schiera a
favore dell’abolizione dell’ergastolo e “solo” il 15,8% si dice favorevole alla
reintroduzione della pena di morte. Sono contrari all’abolizione dell’ergastolo
soprattutto i cittadini di destra (82,7%) e quanti non si sentono politicamente
rappresentati (82,9%). Di destra anche la maggior parte di quanti si dicono
d’accordo con l’abolizione degli sconti di pena per i reati più gravi e dei
provvedimenti alternativi alla detenzione per i reati più gravi. La possibilità
di reintrodurre nel nostro ordinamento la pena di morte vede più consensi
espressi dai cittadini di centro-destra (20,1%), seguiti dai 5 Stelle (19,7%) e
da quelli di destra (19%).
Magistratura, mancano i
cancellieri: giudici e pm vadano a fare le fotocopie.
Iuri Maria Pirado su Libero
Quotidiano il 23 giugno 2022.
Pare che in alcuni tribunali
manchino i cancellieri, per capirsi quelli che tengono in ordine i fascicoli,
aggiornano le agende delle udienze, rilasciano le copie degli atti, insomma
fanno andare avanti l'ufficio. Nell'attesa che il problema di organico sia
risolto, si potrebbe forse immaginare che il corpo giudiziario contribuisca
autonomamente a prestare un po' di servizio supplementare.
Non sarà un dramma né
rappresenterebbe una degradazione intollerabile dedicare un'oretta al giorno a
fare fotocopie, a sistemare i faldoni e magari perché no, se occorre? - a
spolverare le scrivanie e a svuotare i cestini. Al giovane magistrato, vincitore
del concorso che gli attribuisce il potere di arrestare la gente, di sequestrare
patrimoni e di confiscare i beni altrui, si potrà ben richiedere di fare ciò che
in qualunque azienda fa del tutto normalmente persino il titolare, il quale
senza tante storie si mette a spostare gli scatoloni quando il magazziniere è in
malattia.
Nulla di punitivo, per carità.
Il potere di accusare le persone e di scrivere le sentenze non lo toglie
nessuno, però accanto a quello si potrebbe prevedere il dovere di rassettare le
aule, un po' come al militare si consegna un fucile ma gli si chiede di farsi la
branda. Dopotutto l'autonomia e l'indipendenza della magistratura potranno anche
realizzarsi nell'uso del toner e dello strofinaccio.
Rossi: «Gli errori
giudiziari devono allarmare tutti. Anche chi ne è estraneo».
Intervista al direttore della
rivista "Questione giustizia". «Il processo ha tre gradi proprio per ridurre al
minimo la possibilità di errore». Valentina Stella su Il Dubbio il 5 luglio
2022.
Qualche giorno fa Nello Rossi,
direttore della rivista di Magistratura Democratica “Questione giustizia”, ha
pubblicato un articolo dal titolo “Md e il caso Tortora. Ma l’errore interroga
tutti i magistrati”‘.
Perché ha sentito l’esigenza a
partire dal quel caso di compiere una “operazione verità” sulla fisionomia di
Md?
La tragica vicenda di Enzo
Tortora deve essere sempre presente ai cittadini e ai magistrati. Nello
scriverne ho voluto rievocare la posizione critica assunta da Md sul processo e
sull’operato di alcuni magistrati e le veementi reazioni che suscitò in seno
alla corporazione. Per ribadire che il garantismo di Md, spesso investita da
polemiche pretestuose, ha radici lontane. Ma mi interessava ancora di più
riproporre il tema, spinosissimo, dell’errore nel giudizio penale.
Quando parla di “polemiche
pretestuose” si riferisce a quelle di Matteo Renzi?
Anche. Penso al tormentone sul
preteso “cordone sanitario” di Md intorno a Renzi e “alle sue idee”. Solo il
Dubbio, in una recente intervista, mi ha consentito di sgonfiare questo
palloncino. Riportando “esattamente” la mia frase critica sulla visita di Renzi
al despota saudita Bin Salman, indicato dall’intelligence americana come il
mandante del barbaro omicidio del giornalista Khashoggi. Altri giornali non
hanno ritenuto utile porre a Renzi le classiche domande: in che contesto, quando
e perché?
Lei scrive: ‘ L’errore del
giudice e l’errore giudiziario sono eventi diversi’. Non tutti gli errori
giudiziari dipendono da un errore del giudice?
Tutti gli errori commessi nel
processo penale hanno un drammatico impatto su beni fondamentali come la
libertà, l’onore, la reputazione. Ed il processo è articolato in tre gradi
proprio per ridurre al minimo la possibilità dell’errore. Ma a volte l’errore si
ripete sino alla sentenza definitiva perché la disattenzione, la superficialità,
lo spirito burocratico che l’hanno generato coinvolgono tutta la catena dei pm e
dei giudici ( e magari anche dei difensori). Questo è l’errore giudiziario in
senso tecnico: un fallimento del sistema che deve allarmare “tutti” i
magistrati, anche quelli che non l’hanno commesso, e che può essere ridotto al
minimo solo mettendo in campo un estremo rigore professionale e la cultura del
dubbio.
Mille risarcimenti all’anno
tra ingiusta detenzione ed errori giudiziari sono fisiologici o patologici?
Benvenuta nel labirinto del
nostro processo penale. In altri ordinamenti la decisione del primo giudice o
della giuria popolare è immediatamente esecutiva, l’appello solo eventuale, il
giudizio di una Corte suprema è una ipotesi eccezionale. È una giustizia più
rapida della nostra e che subisce meno smentite. Da noi molti errori vengono
accertati nei diversi gradi di giudizio e grazie ai procedimenti di controllo
sulle misure cautelari; e questo è un bene. Ma il meccanismo si scarica sulla
lunghezza dei processi e questa, a sua volta, può stimolare il ricorso a misure
cautelari, che comunque dovrebbero essere sempre applicate con mano tremante.
La sen. Giulia Bongiorno ha
stigmatizzato una intercettazione di un vostro iscritto riportata nel libro di
Palamara: ‘ Magistratura democratica è nata con una cultura della corporazione
dicendo noi non siamo giudici imparziali, o meglio non siamo degli indifferenti,
siamo di parte, siamo dalla parte del più debole perché questo è scritto nella
Costituzione non perché questo è una rivoluzione’. In cosa consiste la vostra
parzialità?
Potenza dei ruoli! In veste di
avvocato la sen. Bongiorno avrebbe avuto vita facile nel demolire
quell’intercettazione. Nessun appartenente ad Md direbbe mai che essa è nata
“con una cultura della corporazione” ma, se mai, l’esatto contrario. Dunque il
maresciallo ha capito male e trascritto peggio. E lo stesso vale per il più
sofisticato discorso sulla non indifferenza rispetto ai valori e sulla
imparzialità nel giudicare. Se anche fosse vuoto di idee e “atarassico”, un
magistrato avrebbe comunque esperienze di vita ( un divorzio, un furto subito,
una lite condominiale e così via). E su tutte queste materie potrebbe essere
chiamato a giudicare. Quello che si può e si deve pretendere è che il magistrato
sappia tendersi verso l’imparzialità all’atto del decidere, facendo la tara del
proprio vissuto e delle proprie idee in vista della rigorosa applicazione della
legge. Questa consapevole tensione verso l’imparzialità è la più alta
prestazione professionale del magistrato.
Lei rivendica che Md “da
decenni è il luogo nel quale, con più coerenza e ampiezza di riflessioni, si
difendono le garanzie processuali ed i diritti dei cittadini”. Gli altri gruppi
associativi non lo fanno o lo fanno meno?
Non si tratta di stilare
graduatorie. Ma sul terreno del garantismo ribadisco quello che ho detto e sono
aperto ad ogni confronto.
Ma voi non siete le famose
“toghe rosse” politicizzate in lotta con Silvio Berlusconi?
Detesto la definizione
giornalistica di toghe rosse; ma fa troppo caldo per protestare con la
necessaria vivacità. Però, sul filo dell’ironia, le regalo una piccola chicca.
Da Procuratore aggiunto a Roma ho chiesto, silenziosamente e con la dovuta
rapidità, l’archiviazione di una denuncia – infondata – sporta contro l’on.
Silvio Berlusconi per il reato di manipolazione del mercato nella vicenda
Alitalia. Ho fatto solo il mio dovere; ma conosco pubblici ministeri che hanno
tenuto in piedi per anni procedimenti nei confronti di uomini politici e che,
quando hanno chiesto, magari tardivamente, l’archiviazione, sono stati colmati
di elogi e presentati come campioni della “giustizia giusta”.
Sta parlando di Carlo Nordio e
della sua inchiesta su D’Alema?
Personalizzare sarebbe
ingiustificato e riduttivo. Parlo di fenomeni, di tendenze. Non è materia di
battibecchi stizzosi. Ma su questi temi un dibattito pubblico approfondito,
serio e sereno, ci starebbe tutto.
L’Unione Camere penali è
mobilitata in difesa del principio di immutabilità del giudice. Concorda che sia
un problema quello di essere giudicati da un giudice che non ha raccolto la
prova?
È disperante dover rispondere
in tre righe a questa domanda. Comunque ci provo. L’immutabilità del giudice o
della giuria popolare è un dogma assoluto in un processo immediato e concentrato
in poche udienze. Per intenderci quello che si vede nei film americani. Ma
quando questa immediatezza è pressocchè impossibile (per il numero dei processi,
i carichi di lavoro, i rinvii a lungo termine della udienze etc) il principio
dell’immutabilità del giudice può e deve essere ragionevolmente contemperato con
altri principi ed esigenze. La sentenza delle Sezioni Unite, Bajrami, ha
percorso questa strada, a mio avviso con equilibrio.
Ritiene che il sistema del
disciplinare dei magistrati vada cambiato per rendere accessibili a tutti le
motivazioni delle archiviazioni in nome di una giustizia sempre più trasparente?
Francamente no. E sono in
buona compagnia, se ha presente le pronunce sul punto di Tar e Consiglio di
Stato.
Sì, ho presente. Ne ho scritto
qualche giorno fa. Prego continui.
I magistrati lavorano immersi
nei più aspri conflitti e spesso sono dei parafulmini. Rendere pubblici –
attraverso le motivazioni delle archiviazioni – i contenuti di esposti non solo
infondati ma spesso solo insinuanti, malevoli, ostili significherebbe aprire in
quest’ambito una rincorsa senza fine di polemiche, di ricorsi, controricorsi; e
magari di denunce per diffamazione.
“Questione giustizia”
rivendica quella stagione. Magistratura Democratica rivendica il caso Tortora e
ne va fiera…Gian Domenico Caiazza su Il Riformista il 3 Luglio 2022.
Questione Giustizia, la
rivista di Magistratura Democratica diretta da Nello Rossi, ha appena scelto di
pubblicare alcuni interessanti documenti relativi al caso Tortora. Essi
ricostruiscono con chiarezza la dura presa di posizione che assunse all’epoca MD
nei confronti sia dei magistrati responsabili di quella sciagurata indagine, sia
della decisione del CSM di archiviare ogni procedimento disciplinare sui
medesimi. Presa di posizione pubblica di una tale durezza che portò addirittura
alla crisi della Giunta di A.N.M., che dovette dimettersi.
La ragione di questa scelta
editoriale, per molti versi sorprendente, è chiarissima, ed è d’altronde
rivendicata nell’editoriale di questo importante numero della rivista. Si
intende orgogliosamente rivendicare una precisa identità culturale e politica di
quella parte della magistratura italiana, proprio in relazione al caso simbolo
della malagiustizia italiana. La magistratura italiana, si vuole dire insomma,
non è (o non è stata?) una indistinta espressione di desolanti riflessi
corporativi. E le correnti, intese come espressione di pensiero e culture
differenti all’interno della giurisdizione, sono (o sono state?) occasione di
confronto, di crescita civile, di ricchezza culturale.
La provocazione è coraggiosa e
feconda, e merita attenzione e rispetto. Intanto, vediamo i fatti che essa
documenta. Siamo nel marzo del 1989. All’indomani della definitiva assoluzione
di Enzo Tortora, Giovanni Palombarini e Franco Ippolito, rispettivamente
Presidente e Segretario di MD, nonché Sandro Pennasilico, segretario della
sezione napoletana di MD, convocano una clamorosa conferenza stampa a Napoli,
per denunciare le inammissibili “storture” di quel processo, l’inconcepibile
gestione dei pentiti, il rapporto ancillare dell’ufficio istruzione rispetto
alla Procura, la gestione della informazione giudiziaria.
Tra l’altro, la denuncia
contro gli uffici giudiziari napoletani viene estesa anche alla oscura gestione
dell’inchiesta sull’omicidio del giovane giornalista Siani, in ordine alla quale
ben 400 avvocati del Foro hanno chiesto la rimozione del Procuratore
capo Vessia. MD chiede con forza che il CSM dia seguito a severi provvedimenti
disciplinari nei confronti dei magistrati resisi responsabili “del più
dirompente caso della vita politico-istituzionale italiana” (così
testualmente Palombarini). Denunciano l’assurdità che uno di essi, il
dott. Felice di Persia, sia stato nel frattempo eletto proprio al CSM (in quota
magistratura Indipendente). Sarà tutto inutile, il CSM archivierà ogni accusa
(anzi, premierà quei magistrati, aggiungo io). MD, che guidava l’ANM insieme
ad Unicost, si dimette e determina la crisi della Giunta. Lo scontro è
durissimo, MD denuncia che “la logica corporativa non tollera che dall’interno
della magistratura vengano critiche alla gestione degli uffici giudiziari o allo
stesso CSM”. E molto altro, che suggerisco davvero di andare a leggere con
attenzione.
Se questa iniziativa di
“Questione Giustizia” e del suo direttore vuole rivendicare una nobiltà della
storia del correntismo all’interno della magistratura, con noi penalisti sfonda
una porta aperta. Da sempre diciamo: stiamo attenti a non replicare il tragico
errore qualunquista e populista fatto con la politica (per enorme responsabilità
proprio della magistratura, però, caro Direttore Rossi!), con la distruzione dei
partiti ridotti ad icona di ogni nequizia. Il problema non sono “le correnti”,
ma la loro degenerazione in meri luoghi di amministrazione del potere
(giudiziario). Comprendo l’orgoglio per quella rivendicazione, ma ciò che
dobbiamo domandarci oggi è cosa sia rimasto di quelle spinte ideali, di quella
indipendenza di pensiero, e soprattutto di quella attenzione alle garanzie ed ai
diritti nei processi; e semmai, come poterli recuperare. Il Paese ha
attraversato anni di drammatica alterazione degli equilibri costituzionali, con
una esondazione catastrofica del potere giudiziario in danno del potere
politico.
Il potere ipertrofico ed
incontrollato delle Procure ed il suo micidiale connubio con i media ha la
responsabilità storica di avere spostato l’oggetto del giudizio sociale sui
fatti penali dalla sentenza alla incriminazione. Possiamo davvero dire che
almeno una parte della magistratura italiana sia stata attraversata da una
riflessione critica ed autocritica su questi temi cruciali? O quella bella
pagina “napoletana” è solo un lontano e sbiadito ricordo, da guardare con
malinconica trepidazione, come si fa con gli album di famiglia? Parliamone, con
lealtà e chiarezza: noi siamo pronti a farlo. Gian Domenico Caiazza. Presidente
Unione CamerePenali Italiane
Gli esami di maturità.
Altro che Promessi Sposi, per spiegare la giustizia andrebbe spiegato come un
magistrato perseguita un uomo.
Iuri Maria Prado su Il
Riformista il 23 Giugno 2022.
Nel suo dialogo con Liliana
Segre, finito tra gli argomenti d’esame di Maturità e ripubblicato ieri
dal Corriere della Sera, Gherardo Colombo dice: “Puoi immaginarti quanto si
potrebbe trasmettere ai ragazzi in tema di giustizia illustrando loro I promessi
sposi!”. Non c’è dubbio che dalla lettura di quel capolavoro i ragazzi possano
ritrarre nobili motivi di meditazione “in tema di giustizia” (magari “tema”
d’ora in poi lo aboliamo, che proprio non si può sentire): ma più e meglio si
trasmetterebbe ai ragazzi illustrando loro le pagine meno romanzate della
giustizia italiana, facendo loro conoscere le colonne infami recanti la lunga
teoria dei nomi sconosciuti appartenenti alle vittime della giustizia.
Sarebbe lettura magari più
noiosa, ma altrettanto istruttiva, quella che indugiasse sulle lapidi dei
suicidi in carcere, i morti di galera imprigionati – spesso inutilmente, sempre
ingiustamente – in nome del popolo italiano. Sarebbe conoscenza forse
spiacevole, ma assai formativa, quella offerta da una ricognizione della vita
negletta delle mogli, dei figli, dei fratelli e delle sorelle, dei genitori di
chi senza motivo, senza necessità, senza diritto è stato rinchiuso in una cella.
I ragazzi potrebbero imparare da questa storia clandestina come nel loro Paese –
non nel secolo decimo settimo, ma in questo – un magistrato possa arrestare la
libertà di chiunque, sequestrargli ogni bene e innanzitutto il primo, la vita, e
privarlo di tutto, del patrimonio, della casa, della famiglia, del lavoro, della
reputazione, della salute, senza risponderne in nessun modo e nemmeno nel caso
che quello scempio sia oltretutto avvenuto per trascuratezza, per errore, per
abuso.
Imparerebbero, i ragazzi, che
tra le disgrazie che possono capitare a un essere umano – proprio come una
malattia maledetta che se lo mangia, come un rovescio professionale che lo manda
sotto a un ponte, come un’auto impazzita che lo investe – c’è quella di trovarsi
soggetto al potere di un magistrato che decide di perseguitarlo, e lo
perseguita, prendendo il corso normale della sua vita e stravolgendolo,
violentandolo, lo immette con i sigilli di Stato in un buco nero di
sopraffazione, di degradazione, di disperazione, mentre nel mondo di fuori
risuona il verbo del collega togato che spiega che tutto questo è fisiologico. I
ragazzi sarebbero così proficuamente indotti a farsi della giustizia di questo
Paese un’idea un po’ più aderente. E a esprimerla, magari, al prossimo esame di
Maturità. Iuri Maria Prado
Lo sciopero dei penalisti.
Cambio del giudice a processo in corso, il malcostume italiano: l’esempio Johnny
Depp-Amber Heard.
Gian Domenico Caiazza su Il Riformista il 18 Giugno 2022.
Ci sono diritti che la gente
non sa di avere, ed ancor meno sa quanto siano messi in pericolo. Come penalisti
italiani abbiamo proclamato due giorni di astensione dalle udienze (26 e 27
giugno prossimi) in difesa di uno di questi, oggi di fatto praticamente
vanificato nelle aule di giustizia del nostro Paese. Parlo del diritto –
fondamentale- dell’imputato ad essere giudicato dallo stesso giudice che ha
raccolto la prova.
Per spiegare l’importanza
della partita in gioco, mi avvalgo di una esemplificazione comprensibile per
tutti. Prendete il processo Johnny Depp c. Amber Heard, che l’intero pianeta,
piaccia o no, ha seguito con morbosa attenzione. Meglio, così capirete bene di
cosa stiamo parlando. Dunque provate ad immaginare questo scenario: dopo decine
di udienze nel corso delle quali il Giudice, o meglio la giuria popolare in
questo caso, ha ascoltato i protagonisti e decine di testi e di consulenti,
scrutando espressioni, sospiri, imbarazzi, contraddizioni, dei protagonisti
avvicendatisi sullo scranno dei testimoni, il Giudice (la giuria popolare)
cambia. Va via, per qualsivoglia ragione, e viene sostituito da altro giudice
(giuria popolare). A pronunciare la sentenza sui fatti ricostruiti nelle lunghe
e tumultuose udienze dibattimentali saranno persone diverse da quelle che hanno
raccolto la prova per mesi. I nuovi giurati giudicheranno leggendo i verbali di
tutte le udienze precedenti, alle quali ovviamente non hanno partecipato. Sono
certo stiate tutti trasalendo: come sarebbe possibile un simile scempio?
Nessuna lettura di verbali
potrà mai equivalere all’ascolto diretto, personale, fisico dei testimoni e dei
protagonisti della vicenda. Insomma, è ovvio che il giudice che emette la
sentenza debba essere lo stesso che ha raccolto la prova. Perciò, se cambia il
giudice, il processo va ripetuto, non può esserci il minimo dubbio. Ed infatti,
il nostro codice di procedura penale prevede esattamente questo: se cambia il
giudice, il processo va ripetuto (salvo accordo tra le parti). Ora, dovete
sapere che questa norma, espressiva di un diritto delle parti processuali
talmente elementare che non dovrebbe essere oggetto della pur minima
discussione, è entrata da subito nelle mire della magistratura italiana, che
l’ha sempre vista come il fumo agli occhi, perché sarebbe una norma all’origine
di inaccettabili rallentamenti del processo. Quindi è iniziata
una giurisprudenza “interpretativa” di una norma invece chiarissima, che non
lascia alcun margine di interpretazione.
Interpretazione culminata in
una sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che ha letteralmente
riscritto quella norma, fissando il principio inverso. Se cambia il giudice, la
regola è che il processo va avanti lo stesso: le parti possono eventualmente
chiedere che questo o quel testimone, o un nuovo testimone, debba essere
sentito, ma badino bene di motivarlo con chiarezza, altrimenti non se ne fa
nulla. Incredibile, vero? Quella sentenza è andata non solo contro la inequivoca
testualità della norma, ma anche contro un pronunciamento della stessa Corte
Costituzionale, che almeno subordinava la legittimità del cambio del giudice
alla esistenza, per esempio, di videoregistrazioni delle udienze, in modo che
almeno il nuovo arrivato se le debba guardare. La riforma Cartabia del
processo sta cercando di recuperare i principi fissati dalla Consulta (vedremo
cosa stabiliranno i decreti delegati).
Il risultato di quella
sentenza delle sezioni unite è un autentico disastro. Assistiamo ormai
quotidianamente a collegi che cambiano in corso di giudizio, magari dopo decine
di udienze e di testimoni escussi dal precedente giudice, e senza che nessuno
sia tenuto ad alcuna giustificazione. Perché questo è l’aspetto più odioso: che
le esigenze personali (di carriera, familiari, occasionali) del giudice
prevalgono sul diritto dell’imputato ad essere giudicato dallo stesso giudice
che ha raccolto la prova.
È un fatto di una gravità
inaudita, un malcostume inaccettabile, una manifestazione di tracotanza
corporativa davvero senza eguali. Perciò scioperiamo, chiedendo alla Ministra di
intervenire in modo efficace nei decreti delegati, dove è sì inserita la
videoregistrazione come condizione di legittimazione del cambio del giudice, ma
al momento senza alcuna garanzia nemmeno che il nuovo giudice se la vada a
vedere davvero. Il minimo che debba prevedersi è che ciò accada in una pubblica
udienza. Così come occorre prevedere uno specifico intervento normativo che
imponga al magistrato che voglia trasferirsi ad altro ufficio o ad altra sede di
poterlo fare solo dopo aver esaurito il ruolo delle udienze che ha già iniziato.
Quindi, di questo stiamo parlando, cioè – ancora una volta- di diritti
fondamentali della persona: ed è una battaglia che vogliamo vincere.
Gian Domenico Caiazza.
Presidente Unione CamerePenali Italiane
Referendum giustizia, le
assurde tesi di Letta e Conte.
Claudio Romiti su
Nicolaporro.it il 6 Giugno 2022.
A meno di una settimana dai
referendum sulla giustizia, un settore della cosa pubblica da sempre ostile a
qualunque tentativo di riforma, si segnala l’esilarante presa di posizione di
Enrico Letta in versione cerchiobottista: “Il Pd non è una caserma e men che
meno su questi temi. C’è la libertà dei singoli, essa rimane a maggior ragione
per una materia come questa, così complessa, rispetto a quesiti molto diversi
tra di loro”. “Tuttavia, – ha poi sottolineato il segretario del Pd – questi
referendum aprirebbero più problemi di quanti ne risolverebbero”.
Ancora più netta la posizione
di Giuseppe Conte, leader del partito più forcaiolo della storia patria: “I
quesiti sono frammenti normativi che intervengono quasi come una vendetta della
politica nei confronti della magistratura”. La magistratura – ha proseguito il
presidente del Movimento 5 Stelle – ha delle colpe, tra cui la deriva
correntizia. Di qui ad assumere, da parte della politica, un atteggiamento
punitivo, ne corre. Ecco perché noi siamo assolutamente contrari al referendum
continueremo a lavorare per progetti di riforma organici e sistematici”.
Ergo, in merito forse al più
significativo dei referendum, quello che tende ad imporre una rigida separazione
tra funzione giudicante e funzione requirente, secondo Letta ciò provocherebbe
ulteriori problemi, mentre per Conte questa elementare regola di civiltà
giuridica sarebbe addirittura punitiva nei confronti dell’ordine giudiziario.
Eppure colpisce che questa
difesa d’ufficio dei magistrati provenga da un avvocato, la cui categoria ha
sempre combattuto per una riforma del giudizio penale in cui venisse affermata
una volta per tutte la terzietà del giudice. Terzietà che con la disfunzionale
commistione tra togati che svolgono mansioni tra loro incompatibili, i quali
spesso lavorano a stretto contatto di gomito, rappresenta in molti casi una pura
utopia. A tale proposito risultano piuttosto illuminanti le parole di Antonio
Giangrande, avvocato di Avetrana che ha pubblicato un libro su uno dei casi più
controversi della nostra giustizia spettacolo: il processo per l’uccisione della
povera Sarah Scazzi. Scrive infatti Giangrande: “Come è possibile che a
presiedere la Corte di Assise di Taranto per il processo di Sarah Scazzi, in
violazione al principio della terzietà ed imparzialità del giudice, sia il
giudice Cesarina Trunfio, ex sostituto procuratore di Taranto, già sottoposta
del Procuratore Capo di Taranto Franco Sebastio, nonché collega dell’aggiunto
Pietro Argentino e del sostituto Mariano Buccoliero, cioè ex colleghi facenti
parte del collegio che sostiene l’accusa nel medesimo processo sul delitto di
Sarah Scazzi dalla Trunfio presieduto?”
Un dubbio più che legittimo
che l’attuale normativa non sembra assolutamente in grado di tacitare, dal
momento che attualmente, il passaggio tra i due ruoli è limitato a un massimo di
quattro volte con alcune regole, tra cui l’impossibilità di svolgere entrambe le
funzioni all’interno dello stesso distretto giudiziario. Tuttavia, se la riforma
presentata dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia dovesse venire
approvata, il numero di passaggi possibili scenderebbe a uno.
Se poi a tutto questo ci
aggiungiamo la deriva correntizia sottolineata dallo stesso Conte, la quale con
il meccanismo della valutazione quadriennale dei magistrati, che uno dei
referendum vorrebbe estendere anche agli avvocati e ai professori universitari
di materie giuridiche – i quali attualmente svolgono solo un ruolo consultivo
nel consiglio disciplinare – l’obbligo di raccogliere almeno 25 firme di
magistrati per candidarsi al Consiglio superiore della magistratura – obbligo
che i promotori del referendum intenderebbero abolire -, dal punto di vista di
un garantista si ha l’impressione di doversi confrontare con una casta quasi
intoccabile.
D’altro canto, occorre
ricordare, per decenni soprattutto dal versante politico e culturale della
sinistra nella terminologia comune non si è mai fatta molta distinzione tra
giudici e pubblici ministeri. Ricordo che durante il periodo oscuro di Mani
pulite, in cui un avviso di garanzia equivaleva ad una condanna passata in
giudicato, i membri della Procura di Milano venivano spesso e volentieri
definiti giudici. Una confusione che ancora oggi ogni tanto si ripresenta nelle
sue sinistre sembianze e che tende a rafforzare l’idea che nei fatti non siamo
ancora usciti dal modello inquisitorio del processo penale, in cui la figura del
giudice e del magistrato inquirente risultano ancora troppo sfumate
nell’immaginario collettivo.
Ovviamente nell’acqua
stagnante di una giustizia che continua a partorire mostri – pensiamo, ad
esempio, ai cinque gradi di giudizio, con addirittura due assoluzioni, che hanno
portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi per il delitto di Garlasco – i
cinque referendum rappresenterebbero solo un piccolo ma significativo passo
nella direzione del tanto decantato “giusto processo”. Per questo motivo è
importante che il 12 giugno, andando a votare, venga sconfitta la cultura della
forca, del sospetto e del giudizio sommario che sembra avere ancora molto
seguito in questo disgraziato Paese. Claudio Romiti, 6 giugno 2022
In carcere senza richiesta
del pm. Per una (sola) volta il gip paga.
La Corte dei Conti ha
evidenziato la mancanza di azioni di rivalsa per il recupero delle somme pagate
per ingiuste detenzioni ed errori giudiziari. Riccardo Radi, (Avvocato), su Il
Dubbio il 17 giugno 2022.
A fronte del pagamento di più
di 894 milioni di euro, lo Stato ha intrapreso una sola azione di rivalsa per un
danno erariale da 10mila euro nei confronti di una toga. La vicenda è accaduta
a Salerno ed è stata “scoperta” leggendo la relazione della Corte dei Conti
sulle spese sostenute dallo Stato per le ingiuste detenzioni e gli errori
giudiziari negli anni 2017- 2020.
Nella relazione si indica il
caso in maniera generica senza entrare nei particolari. Noi siamo riusciti a
ricostruire la storia giudiziaria recuperando anche l’atto di citazione per
danno erariale, unico caso in Italia dal 1992 ad oggi, notificato dal ministero
della Giustizia al giudice disattento che ha emesso una misura cautelare di
arresti domiciliari senza che il pubblico ministero ne avesse fatto richiesta.
In pratica un giudice delle
indagini preliminari, non di prima nomina, riceve una richiesta di misura
cautelare per un signore accusato in concorso con la figlia di false
fatturazioni. Non si sa come è perché, il Gip emette una misura cautelare degli
arresti domiciliari nei confronti della figlia in assenza di una richiesta del
pubblico ministero che la riguardasse. La polizia giudiziaria esegue la misura e
arresta la donna, che solo in sede di interrogatorio di garanzia, su istanza
difensiva, verrà liberata in “assenza dei presupposti di legge”. La malcapitata,
di fatto sottoposta a un sequestro di persona, propone richiesta di risarcimento
del danno per illegittima detenzione che viene accolta con la liquidazione della
somma di euro 21.170,91.
La Corte dei Conti, sul
presupposto della esistenza di danno erariale a carico del giudice che ha emesso
la misura cautelare senza l’esistenza dei requisiti di legge, e a carico del pm
che la ha comunque eseguita senza averla richiesta, notifica a entrambi una
richiesta con contestazione del danno per i comportamenti tenuti.
La tragicomica avventura si è
definita all’italiana. Il pubblico ministero ha evitato la richiesta di danno
erariale sostenendo con particolare vigore la sua completa estraneità ai fatti
accaduti. In pratica in sua discolpa ha dedotto: “Quando la misura cautelare gli
è stata portata per la esecuzione, non aveva il relativo fascicolo, trattenuto
dal Gip per gli adempimenti successivi (interrogatorio di garanzia). A sostegno
della sua tesi ha depositato attestazione del cancelliere”. Vi chiederete: e
allora? Come puoi chiedere la misura cautelare per un uomo e la ricevi emessa, e
la esegui, nei confronti di una donna e ritieni che “non avendo il fascicolo”
sei esente da ogni responsabilità?
Eppure la tesi difensiva ha
funzionato, e il ministero della Giustizia ha ritenuto che le argomentazioni del
pm consentono di “escludere la gravità della colpa”. Quindi è rimasto solo il
Gip a dover rispondere del fattaccio, e il ministero non ha potuto esimersi, con
linguaggio burocratico, dal sottolineare che “l’errore emerge laddove il Pm ha
richiesto la applicazione della misura della custodia cautelare in carcere solo
nei confronti di C. G.” e non della donna. Quindi la colpa grave è riscontrabile
avendo emesso la “misura cautelare senza i presupposti di legge”. In conclusione
il giudice ha definito la propria colpa grave pagando il 50% dell’iniziale
richiesta di risarcimento, e con circa 10.000 euro ha “patteggiato” il danno
erariale.
Possiamo concludere che
l’episodio, più che un errore, sia un gesto simbolico del Gip che, facendo a
meno del Pm, esprime la sua solidarietà alla battaglia dell’avvocatura per la
separazione delle carriere? A parte il sarcasmo, proviamo a riflettere su un
dato inquietante: in Italia dal 1992 al 31 dicembre 2021 ci sono stati 30.133
innocenti indennizzati dallo Stato per errori giudiziari o ingiuste detenzioni.
Badate bene che il numero
rappresenta la punta di un immenso iceberg, in quanto solo il 24% delle domande
di riparazione per ingiusta detenzione viene accolta. In ogni caso, per gli
innocenti conclamati e indennizzati lo Stato ha pagato 894 milioni e spicci di
euro. Su questi dati la Corte dei Conti ha posto l’attenzione, evidenziando la
mancanza delle azioni di rivalsa dello Stato nei confronti dei magistrati per il
recupero delle somme pagate per le ingiuste detenzioni e gli errori giudiziari.
La magistratura risulta essere una sorta di isola felice in cui l’operosità e
l’efficienza regnano sovrane, eppure la realtà e i dati dicono il contrario.
Ebbene, a fronte del pagamento
di più di 894 milioni di euro, lo Stato ha intrapreso una sola azione di rivalsa
per danno erariale nei confronti di un magistrato recuperando la somma di euro
10.425,68. Quali sono gli ostacoli legislativi e di sistema che impediscono alla
magistratura contabile di intraprendere le azioni di rivalsa? Questo è il tema
focale sotteso alla storia che abbiamo raccontato. È necessario gettare un faro
sulla questione per individuare “casi nei quali possano ravvisarsi i presupposti
per l’esercizio da parte dello Stato di un’azione di rivalsa nei confronti del
soggetto al quale risulti imputabile l’errore giudiziario o l’ingiusta
detenzione nei casi previsti”. Parole della Corte dei Conti.
Abuso di potere. Abbiamo le
prove della malagiustizia in Italia, manca solo il processo ai responsabili.
Iuri
Maria Prado su L'Inkiesta il 6 Giugno 2022.
Ogni giorno assistiamo alla
strage di diritti e di legalità senza che gli esecutori siano chiamati a
renderne conto. Dagli innocenti nelle carceri al comportamento di alcuni
magistrati che interferiscono nell’attività dei poteri legittimi.
Com’è che diceva quello? «Io
so. Ma non ho le prove». Noi invece – oggi, ma non da oggi – le prove del
crimine giudiziario le abbiamo. Non occorre provare che le carceri sono ricolme
di innocenti. Non occorre provare che funzionari dello Stato, abusando del
proprio potere, violentano le libertà private, distruggono l’immagine, i
patrimoni, la vita altrui senza risponderne in nessun modo.
Non occorre provare che
l’esistenza di centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone è affidata al
capriccio, all’arbitrio, alla noncuranza persecutoria di pubblici impiegati che
fanno malgoverno della propria funzione riducendosi a sgherri di Stato, a
teppisti di Stato, ad aguzzini di Stato.
Non occorre provare che una
parte, ovviamente non tutta ma una significativa parte, della cerchia
giudiziaria è gravemente contaminata dalla presenza di malversatori che,
protetti dal proprio potere irresponsabile, coltivano e difendono interessi
particolari in plateale conflitto con quelli generali.
Non occorre provare che
fazioni influenti e aggressive del potere togato si sono costituite in una
centrale di sistematico hackeraggio dell’organizzazione
democratico-rappresentativa, un contro-governo di ammutinati che interferisce
nell’attività dei poteri legittimi e pubblicamente li intimidisce, li ricatta,
li minaccia.
Non serve nessuna prova per
documentare tutto questo, perché la prova di tutto questo è quotidianamente
disponibile, quotidianamente squadernata sulla scena della giustizia italiana.
Una diuturna strage di diritti e di legalità si compie e prosegue senza che i
responsabili siano chiamati a renderne conto. Ma non mancano le prove. Manca il
processo.
Riforma giustizia e la
soppressione dei tribunali. Massimo Carugno, Scrittore, su Il Riformista il
9 Maggio 2022.
Erano gli ultimi giorni di
agosto del 2011 quando Michele Vietti, avvocato e cattedratico, insediato sullo
scranno di Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
dall’amico Pier Ferdinando Casini, lanciò un proclama che avrebbe avuto
conseguenze negativissime nel panorama della giustizia italiana.
La grande crisi economica del
2009 aveva appena investito il pianeta e l’ansia di tutti i governi era quella
di accelerarne l’uscita, affastellati tra uno spread crescente e le 3 A di
un ranking, che cadevano come birilli, mentre a Wall Street si contavano i cocci
dei fallimenti delle grandi banche stelle e strisce.
“Il riordino della geografia
giudiziaria e la soppressione dei tribunali minori ci farà guadagnare 3 punti di
P.I.L.”, disse l’uomo della politica neo-democristiana, fiero di essersi
riempito la bocca del tema del momento e non sapendo, poverino, quel che stava
per scatenare.
Il governo Berlusconi, il IV
di questo nome, era alla frutta ma cercava disperatamente di resistere dando
segnali a destra e a manca di efficienza e controllo della spesa e l’allora
Ministro della Giustizia Francesco Nitto Palma, subentrato appena un mese prima
al dimissionario Angelino Alfano, si affannò a presentare un decreto legge,
convertito poi in una legge delega, che conteneva i criteri per la soppressione
di numerosi tribunali. Era il 14 settembre del 2011 e la legge portava il numero
148.
Appena un anno dopo il
Ministro Paola Severino, lanzichenecca nel governo Monti, il cui epinomo nel
frattempo era subentrato a Palazzo Chigi nel tentativo di ridare credibilità al
paese dopo i disastri dell’uomo di Arcore, varò il decreto legislativo 155/2012
con il quale furono cancellati 37 tribunali e 220 sezioni distaccate.
“Una svolta epocale,” la
definì il Ministro, una dei tanti cattedratici di quel governo che dimostrarono,
come sempre, che l’eccesso di teoria allontana dai problemi del paese reale.
E fa niente che poi di quel
risparmio, del quale la politica aveva innalzato il vessillo, non si vide nulla,
visto che le spese dei tribunali le pagavano i comuni che li ospitavano e il
costo più rilevante, quello del personale, non era stato risparmiato perché non
si potevano licenziare le persone.
“Ma ne miglioriamo
l’efficienza” , si disse da più parti, specie dalla magistratura e da quei
giudici che, fuggiti dalle aule dei processi, occupavano i posti tecnici del
Ministero rappresentandone la vera volontà esecutiva a dispetto di quella
politica.
Peccato che i monitoraggi e
gli studi successivi, tra cui uno mirabile di un noto giornale
finanziario, stimarono tra quelli più efficienti d’Italia proprio quei tribunali
la cui soppressione, in esecuzione di quel provvedimento definito dalla Severino
epocale, era in itinere.
Parliamo per esempio dei 4
tribunali abruzzesi, di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, la cui
cancellazione era stata congelata per i problemi legati alla Corte d’Appello di
L’Aquila ancora precaria per il terremoto del 2009.
Perché l’efficienza proclamata
dai boiardi del ministero è ben diversa da quella d’uso comune nel pensiero
dominante della buona amministrazione.
In effetti verrebbe spontaneo
pensare, per efficiente, a un tribunale che sia a dimensione d’uomo, che abbia
una durata breve dei processi, dei tempi ristretti per l’accesso agli uffici e
per il ritiro dei documenti, una evasione puntuale di fascicoli e processi. E
ancora che sia vicino ai cittadini, moralmente e fisicamente, e che non si
debbano fare ore di percorrenza per raggiungerlo da uno qualunque dei comuni del
suo circondario, appesantiti da una orografia montana e da una viabilità
tortuosa che per fare 40 chilometri richiede due ore di viaggio, magari anche
allietati da ghiaccio e neve.
Ma dalle parti di via Arenula
non la pensavano così, anzi, di tali considerazioni non gliene poteva fregà di
meno (ci si perdoni il francesismo).
E già. Perché di questa storia
dei Tribunali ne parlavano da tempo, anzi, loro ne stavano parlando da decenni.
Solo che nella prima repubblica c’era una politica che governava la grande
finanza e gli apparati amministrativi dello stato. Le repubbliche successive (
seconda e l’attuale terza) sono state, aimè, dominate dai poteri economici e
tirannegiate da quelli tecnocratici (vedi i disastri dei governi tecnici). Dalle
parti del Palazzo dei Marescialli infatti hanno sempre avuto in testa l’idea che
un giudice non dovesse saltare dal civile al penale, dai divorzi ai decreti
ingiuntivi, dai pignoramenti immobiliari all’ordinanza di custodia cautelare da
comminare nell’udienza preliminare.
Questo cambio continuo di
materie era robaccia da avvocati e non una palestra ove cimentarsi in esperienze
nuove ed allargare il proprio scibile giuridico. Non era una opportunità
formativa ma piuttosto un faticoso fastidio a cui dare rimedio. E venne fuori il
concetto tutto particolare di efficienza legata ovviamente a quello di
specializzazione. Si pensò quindi che i tribunali ideali fossero quelli composti
da un numero tale di giudici (oltre una trentina) da permettere a ognuno di essi
di dedicarsi ad un pezzettino della scienza giuridica e pronunciare ed emettere
sentenze con i container (tanto sarebbero state tutte le stesse: solo da
cambiare, con il copia/incolla, i nomi delle parti) e fare quello per tutta la
vita.
E fa niente se una
tale riforma avrebbe creato solo delle megalopoli giudiziarie che avrebbero
investito il cittadino con una agilità elefantiaca, fa niente se si sarebbero
create delle cattedrali nel deserto distanti mille miglia dal paese reale, fa
niente se un povero sventurato, per muoversi all’interno di tali alveari di
giudici e cancellieri, avrebbe avuto bisogno del navigatore e del GPS, fa niente
se interi territori della penisola sarebbero rimasti sguarniti di presidi
giudiziari ancorché fossero all’interno, o adiacenti, a zone ad alta densità
criminale, fa niente se aree che ospitavano, e ospitano, carceri importanti e
ad alta sicurezza, si sarebbero trovate all’improvviso sguarnite di uffici
giudiziari esponendosi ai rischi di lunghi e pericolosi trasferimenti per
permettere a detenuti temutissimi di partecipare alle udienze.
Come si dice dalle mie
parti “se sta bene Rocco, sta bene tutta la Rocca”.
Poi le cose sono cambiate,
quella riforma, che giaceva nelle fantasie di qualcuno tra i corridoi grigi del
Ministero ed è stata silente per anni perché sopita da una politica che teneva a
guardia certe spinte corporative, con il degrado della autorevolezza della
classe di governo è rispuntata fuori ed è stata prepotentemente adottata proprio
sulla spinta della tecnocrazia dei giudici.
Ed oggi ce la troviamo
adottata con tutte le negatività di cui abbiamo fatto cenno.
Si potrebbe fare lo stesso
discorso anche per altri settori della amministrazione pubblica come la Sanità,
anch’essa spettatrice inerme di gravosi tagli di presidi in nome del risparmio
della spesa, lasciando poveri di essi territori e popolazioni.
Ci si dimentica che certi
settori della vita pubblica come la Giustizia o la Sanità sono servizi e non
aziende e rispondono al criterio del soddisfacimento dei bisogni della comunità
e non al realizzo di un profitto.
Sono comparti che devono
andare incontro al cittadino e non obbligarlo a inseguirli.
In fondo lo dissero anche i
padri costituenti quando, formulando l’art.5 della Carta, sancirono che la
Repubblica avrebbe favorito e adottato il decentramento amministrativo.
Solo che di questi sani
principi ce ne siamo presto dimenticati e oggi guardiamo, in maniera bolsa e
miope, alla riforma della Cartabia, (che si occupa solo di come eleggere i
giudici nel plenum del C.S.M.), come a l’unica possibile e necessaria.
Più che quella, il Ministro
proveniente dal Palazzo della Consulta avrebbe dovuto fare tante altre cose.
Ne abbiamo fatto cenno in una
precedente riflessione pubblicata su queste colonne. E tra esse riformare la
riforma della geografia giudiziaria, anzi adottare una vera controriforma e, se
proprio volessimo spingerci all’estremo, non solo riaprendo tutti i tribunali
chiusi, ma istituendone di nuovi per avvicinare tali servizi ai cittadini e i
cittadini ai giudici con più fiducia e maggiore speranza di ottenere giustizia
vera.
Ma questi sarebbero sogni e i
sogni, si sa, non si avverano mai, o quasi.
La riforma
giustizia. Ingiusta imputazione, un risarcimento per frenare la caccia alle
streghe dei pm.
Giovanni
Varriale su Il Riformista l'1 Giugno 2022.
La riforma del
processo penale voluta dalla guardasigilli Marta Cartabia è stata a lungo
discussa, soprattutto in riferimento alla volontà di ridurre drasticamente i
tempi del processo penale che, da molti operatori del diritto, viene considerato
lesivo dei diritti costituzionali. A ben vedere, tutti gli ultimi interventi
legislativi in tema di giustizia hanno avuto quale fine ultimo quello di ridurre
il numero di processi nelle aule di giustizia senza però pregiudicare la tutela
dei diritti dei cittadini.
Proprio in
quest’ottica, già con la riforma Orlando prima e con la riforma Bonafede poi, si
era provato sia ad aumentare il numero dei reati procedibili a querela, così da
subordinare l’azione penale alla volontà della persona offesa dal reato, sia a
eliminare l’istituto della prescrizione, in modo da rendere praticamente sempre
esigibile la eventuale pretesa di condanna da parte dello Stato. La riforma
Cartabia, se possibile, cambia del tutto prospettiva. Infatti, se il fine ultimo
resta quello di ridurre il carico di procedimenti pendenti nelle aule di
giustizia, il modus agendi attraverso il quale ottenere tale risultato, è del
tutto innovativo.
Invero lo scopo
della attuale riforma è quello di intervenire sin dalle fasi delle indagini
preliminari, nel corso della quale, alle Procure viene chiesto un lavoro di
accurata valutazione rispetto ai procedimenti per i quali richiedere il rinvio a
giudizio. Infatti, con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale,
le Procure saranno chiamate a svolgere un vaglio tra quei procedimenti che, così
come recita la norma, possano giungere ad una sentenza di condanna e quelli,
invece, destinati a una archiviazione. È chiaro come la ratio non sia quella di
affidarsi alle capacità indovine dei Pm né tanto meno quella di pretendere che
si svuotino le aule di giustizia, bensì l’intento della riforma appare quello di
evitare che le Procure possano, magari ingolosite dal risalto mediatico che
potrebbe avere un determinato processo, intraprendere, come per altro spesso
successo, una caccia alle streghe.
Proprio, sulla
scorta della necessità di responsabilizzare le Procure, viene introdotto un
nuovo e rivoluzionario istituto, ovverosia quello della riparazione per ingiusta
imputazione, che si affianca al già presente istituto della riparazione per
ingiusta detenzione. L’introduzione del suddetto rimedio riparativo vede la sua
essenza proprio nella necessità, percepita a buon diritto dal Legislatore, di
tutelare coloro i quali si trovino ad affrontare ingiustamente un processo
penale. Tale aspetto non può in alcun modo essere sottovalutato, poiché sono
svariati i pregiudizi che un soggetto, seppur non detenuto, debba subire quando
veste i panni dell’imputato. Infatti, si va dall’annoso problema del c.d. carico
pendente che comporta una serie di limitazioni (non poter partecipare ad un
concorso pubblico) o mere lungaggini burocratiche (es rilascio del passaporto),
fino alla necessità di dover sopportare le annose spese legali.
Finalmente il
Legislatore sembra aver empatizzato con i cittadini che, con troppa facilità,
loro malgrado, si trovano avviluppati nel turbinio delle maglie di una giustizia
spesso veloce nelle fasi di rinvio a giudizio e lenta nei momenti successivi.
Aver quindi previsto l’istituto della riparazione per ingiusta imputazione
appare, a parere di chi scrive, essere non solo dimostrazione di grande civiltà
ma anche dimostrazione concreta di effettivo garantismo. In conclusione,
il progetto di riforma appare particolarmente ambizioso ma interessante e
soprattutto innovativo poiché richiede un cambiamento di approccio da parte
degli operatori del diritto sin dall’iscrizione della notizia di reato. Giovanni
Varriale
Cinque mesi in galera senza
titolo, scarcerato Cirinnà.
Il legale di Cirinnà,
l’avvocato Cataldo Intrieri, aveva immediatamente presentato al giudice
dell’esecuzione penale la richiesta di annullamento del decreto di revoca della
sospensione della pena emesso dalla Procura. Valentina Stella su Il Dubbio il 15
giugno 2022.
Ricordate il caso di Claudio
Cirinnà, trattenuto in carcere sulla base di un atto del Tribunale di
Sorveglianza di Roma annullato dalla Cassazione? Riassumiamo la storia per chi
si fosse perso le scorse puntate.
In breve: l’11 novembre 2021
era stata rigettata la richiesta di misure alternative in relazione alla pena di
un anno, un mese e 4 giorni di reclusione come residuo della maggiore pena a 2
anni e 8 mesi. Tuttavia l’ordinanza era stata annullata con rinvio dalla
Cassazione lo scorso 11 maggio. Inoltre anche l’ufficio esecuzione della Procura
capitolina aveva respinto la richiesta di sospensione della pena in carcere «non
potendosi sospendere più di una volta l’esecuzione della stessa condanna».
Il legale di
Cirinnà, l’avvocato Cataldo Intrieri, aveva immediatamente presentato al giudice
dell’esecuzione penale la richiesta di annullamento del decreto di revoca della
sospensione della pena emesso dalla Procura. Ebbene, ora il giudice gli ha dato
ragione, argomentando come segue. «Condivise le argomentazioni esposte dalla
difesa del condannato – si legge nel provvedimento – dovendosi ritenere nulla
l’attività posta in essere a seguito di atto dichiarato nullo dispone la
liberazione del condannato». E così abbiamo chiesto all’avvocato Cataldo
Intrieri di fare un’analisi dell’accaduto e se è soddisfatto di quanto ottenuto.
«Non si tratta di questo – ci dice – come avvocato sono stupito che sia successa
una cosa del genere».
Per poi spiegare gli eventi.
«Un cittadino ha subìto oltre cinque mesi di carcerazione senza titolo –
continua l’avvocato – primo perché il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha
sbagliato a decidere su di lui senza neanche avere le relazioni dei servizi
sociali per valutare il suo comportamento dopo la commissione dei fatti; secondo
per l’opposizione strenua della Procura della Repubblica di Roma, che è arrivata
a negare ciò che non si poteva negare, ossia che la nullità dell’ordinanza
rendesse impossibile far restare in galera il mio assistito».
Ma dal momento che la notizia
è arrivata a poche ora dal fallimento dei cinque referendum sulla giustizia, tra
cui quello che si poneva l’obiettivo di limitare l’abuso della custodia
cautelare in carcere, ecco che la chiosa finale dell’avvocato Intrieri non si
limita soltanto a fornire una visione delle cose ma non nasconde anche
l’amarezza per lo stato dell’arte in Italia. «Alla luce anche del fiasco dei
referendum – conclude infatti l’avvocato – fatti come questi dovrebbero invece
far riflettere sull’uso del carcere in questo Paese».
Quella misura cautelare un
sequestro legalizzato: storie di “ordinaria” ingiusta detenzione.
Dieci giorni ai
domiciliari, ma mancavano i presupposti. Il Dubbio il 22 maggio 2022.
L’ennesimo paradosso
giudiziario si compie a Roma, dove un uomo si ritrova con una misura cautelare
degli arresti domiciliari che non poteva e non doveva essere emessa.
Si avete capito bene, non
c’erano i presupposti per emettere la misura. Una sorta di sequestro di persona
“legalizzato”. La vicenda vede protagonisti tre giudici della Corte di appello
di Roma, tutti con una certa esperienza, che ricevono una segnalazione da parte
dei carabinieri di Acilia per una presunta violazione della misura cautelare del
divieto di avvicinamento. I tre giudici si riuniscono in camera di consiglio e
dispongono di aggravare la misura con gli arresti domiciliari lontano dal nucleo
familiare. G. I., padre di quattro figli, si vede i carabinieri in casa che gli
intimano di uscire immediatamente e fornire un possibile domicilio alternativo
per scontare gli arresti domiciliari altrimenti lo condurranno a “Regina Coeli”.
La realtà è ben diversa, in
primo luogo la misura del divieto di avvicinamento era stata già revocata nel
corso del giudizio di primo grado, inoltre il reato ipotizzato inizialmente di
maltrattamenti era stato riqualificato, nel meno grave, di minacce che non
prevede la possibilità di applicazione di alcuna misura cautelare, tutto questo
sembra surreale, ma è avvenuto. Evidentemente i tre giudici non hanno letto gli
atti del fascicolo che era a loro disposizione.
Dopo 9 giorni di arresti
domiciliari senza titolo a G. I. viene revocata la misura a seguito dell’istanza
del difensore che scrive ai giudici «attenzione, il vostro provvedimento è
“palesemente erroneo in fatto e in diritto, tale da determinare un arresto privo
delle condizioni di applicabilità e tale da determinare una futura richiesta di
ingiusta detenzione”» . Ieri ( giovedì, ndr) il provvedimento di revoca che,
beffa nella beffa, è stato eseguito nella giornata di oggi ( ieri, ndr).
I tre giudici si sono
“giustificati” scrivendo, testuali parole: «L’aggravamento è stato disposto
sulla base di erronei presupposti emersi unicamente dalla segnalazione fatta dai
carabinieri».
Ma i giudici non dovrebbero
leggere gli atti del fascicolo?
Come è possibile disporre
della vita delle persone senza verificare e sincerarsi della bontà delle proprie
decisioni?
Altro caso di ingiusta
detenzione senza alcuna conseguenza per chi ha errato in maniera grossolana.
La follia della Giustizia che
non riesce ad ammettere neanche lo sbaglio.
La magistratura continua a
predicare per gli altri quello che non si applica per i suoi sodali: “Il maggior
errore del giudice è di credersi immune dalla responsabilità del delitto per il
quale un altro è condannato; è di credersi membro di una società migliore, di
una società di eletti” ( Gustavo Zagrebelsky). Riccardo Radi, Avvocato
I dati della relazione annuale al
Parlamento. Manette facili, a Napoli si ama sbattere le persone in carcere:
record di ingiuste detenzioni. Viviana Lanza su Il
Riformista il 20 Maggio 2022.
Se i numeri dicono qualcosa, quelli sulle ingiuste
detenzioni contenuti nell’annuale relazione sulle misure cautelari presentata
giorno in Parlamento dicono che si fa ancora ampio ricorso alle manette, che pm
e gip ancora troppo facilmente firmano ordini di carcerazione preventiva, che la
giustizia continua a non essere giusta e innocenti finiscono in cella. Perché?
Sicuramente perché prevale una cultura giustizialista. perché di fronte a
processi che hanno tempi lunghissimi si pensa di intervenire con la misura
cautelare nella fase preliminare delle indagini come se si trattasse di
un’anticipazione della condanna che si è convinti di ottenere al termine del
processo.
Una distorsione del nostro sistema, il
cortocircuito che brucia vita e diritti in un caso su tre. Sì, perché tanti, uno
su tre, sono gli innocenti che ogni giorno finiscono in cella per una svista di
chi indaga, per una lettura degli indizi errata, frettolosa o superficiale,
perché le indagini finiscono per essere orientate a trovare il reato più che la
prova di esso. Consideriamo poi che un arresto fa più notizia di un non arresto,
una condanna più clamore di una assoluzione. Ed ecco che la gogna è servita. Se
si è innocenti il calvario dura anni e anni, e i danni subiti nessuno li ripaga.
I più preferiscono non ricorrere allo Stato per chiedere un risarcimento, tra
quelli che invece lo fanno – decidendo di affrontare un nuovo iter giudiziario
complesso e lungo quasi come quello che li aveva portati ingiustamente in
carcere – non tutti alla fine ottengono l’indennizzo perché lo Stato ha previsto
una serie di paletti per limitare al massimo i casi di risarcimento Assume, per
questo, un valore ancora più emblematico il dato che emerge dalla relazione
annuale presentata l’altro giorno in Parlamento.
Nel 2021 a Napoli si sono contati 178
provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta
detenzione: il numero più alto tra le Corti di Appello d’Italia. Un numero su
cui incide l’accelerazione allo smaltimento dei fascicoli data dai vertici degli
uffici giudiziari, ma che sicuramente dà la misura di quanto sia ancora diffuso
nel nostro distretto il problema della ingiusta detenzione. In tutta Italia i
provvedimenti sopravvenuti nel 2021 sono stati 1.284, 178 dei quali provenienti
dalla sola Corte di Appello di Napoli. Nell’anno appena trascorso, sempre a
Napoli, sono stati 169 i procedimenti esauriti e 40 i provvedimenti accolti con
ordinanze definite, con una media di accoglimento pari ad appena il 24%. Una
media che cresce, seppure di poco, a livello nazionale: 33%. Quanto alle misure
cautelari, la relazione annuale al Parlamento ha registrato, a livello
nazionale, un complessivo calo delle misure coercitive rispetto al biennio che
ha preceduto la pandemia.
Ma i numeri restano sempre alti: nel 2021 le
misure coercitive sono state 81.102 mentre nel 2018 superavano la soglia delle
95mila. I dati contenuti nella relazione dicono anche che i 3/4 delle misure
vengono emesse dalle sezioni gip mentre solo il restante 1/4 viene emesso dalle
sezioni dibattimentali. Questo vuol dire che prevale la carcerazione
preventiva nella fase delle indagini. Nel 2021, in Italia, il 73,2% delle misure
cautelari sono state firmate da un gip (giudice delle indagini preliminari)
mentre solo il 26,5% da un giudice del dibattimento. Il braccialetto
elettronico è usato pochissimo. Il carcere resta la misura cautelare più
diffusa, seguito dagli arresti domiciliari. E se a livello nazionale il carcere
è la misura decisa nel 29,7% dei casi e gli arresti domiciliari nel 22,2%,
seguite dalle altre misure (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria,
divieto di avvicinamento, divieto di dimora, obbligo di dimora, custodia
cautelare in luogo di cura), è a Napoli che il carcere raggiunge la percentuale
più alta (51,2%), il 26% delle misure emesse impone arresti domiciliari, solo il
9,6% l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Intanto le carceri sono strapiene e, nonostante si
faccia un gran parlare di misure alternative, le celle continuano ad essere
affollate e negli istituti di pena circa la metà della popolazione detenuta è in
attesa di sentenza. Secondo dati del ministero della Giustizia, nelle carceri
della Campania al 30 aprile erano presenti 6.806 detenuti a fronte di una
capienza di 6.113 posti. A gennaio erano 6.702.
Viviana Lanza. Napoletana, laureata in Economia e
con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal
2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca
nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli
per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie
di stampa (TMNews, Askanews).
Manette facili, Napoli capitale degli
innocenti in carcere. Viviana Lanza su Il Riformista
il 3 Agosto 2022
Celle sovraffollate, strutture penitenziarie
fatiscenti, educatori e psicologi in numero irrisorio, attività di rieducazione
non per tutti, assistenza medica a singhiozzo, a singhiozzo e non per tutti
anche i percorsi per detenuti con problemi psichiatrici o di tossicodipendenza.
E poi, le celle chiuse, l’ozio forzato, la convivenza in ambienti angusti, lo
spazio vitale non sempre assicurato, i detenuti stranieri che non hanno
mediatori culturali, i detenuti malati che vengono curati a stento, quelli
anziani che non ce la fanno a essere autonomi. E ancora, il caldo asfissiante,
la penombra perenne, una stanza per quattro dove si vive in otto, una finestra
con le sbarre troppo piccola per far passare luce e aria, l’acqua potabile che
manca e i rubinetti da cui esce acqua marrone, l’acqua potabile che c’è ma dai
rubinetti ne esce soltanto un filo. Si potrebbe continuare ancora e descrivere
l’inferno senza fine che sono le carceri, un inferno ancora più inumano se si
considera il numero di persone che ci restano recluse da innocenti. Numeri
agghiaccianti che scivolano sulle coscienze dei più, pur descrivendo una realtà
drammatica, ingiusta e per questo pesante come un macigno. Ma questo è ancora il
Paese dove la polvere si nasconde sotto il tappeto, dove le situazioni si
affrontano solo dopo che si verificano i disastri, dove le emergenze diventano
l’ordinario, dove i problemi assumono valore solo per chi li vive in prima
persona altrimenti si fanno spallucce. In particolare, poi se si affronta
l’argomento carcere. I dati emersi dal rapporto di metà anno dell’associazione
Antigone fotografano una realtà sempre più disastrosa ma per la quale quasi
nessuno si scandalizza.
I numeri contenuti nel report presentato nei
giorni scorsi sono scivolati rapidi nell’indifferenza collettiva, pur meritando
ben altro clamore. Proviamo quindi a leggerli bene quei numeri, per comprendere
quale realtà ci illustrano e quali emergenze la politica e l’opinione pubblica
stanno continuando a trascurare. Nella prima parte dell’anno i dati confermano
che circa il 29% dei detenuti non ha una condanna definitiva, il 15% è in attesa
di primo giudizio mentre resta ampio il ricorso alla custodia cautelare. Poco
conta che nel 2021 siano stati pagati 24 milioni di euro per indennizzi per
ingiusta detenzione, la politica giustizialista, il panpenalismo la fanno ancora
da padrone. A fronte di 54.841 presenze nei penitenziari del Paese, si contano
ancora troppi detenuti in attesa del primo giudizio, quindi presunti innocenti a
tutti gli effetti, persone solo sfiorate da un’indagine penale, raggiunte da
accuse rispetto alle quali non c’è stata ancora nemmeno una sentenza. Difficile
pensare che si tratti di tutti criminali pericolosissimi, del resto le
statistiche dicono che la metà delle inchieste si risolvono in un nulla di fatto
per cui almeno la metà dei detenuti in attesa di sentenza definitiva sono in
carcere ingiustamente. In particolare, i detenuti in attesa di primo giudizio
sono 8.329, gli appellanti cioè quelli condannati in primo grado e in attesa di
processo d’appello sono 3.658, i ricorrenti in Cassazione 2.693. La percentuale
dei detenuti definitivi – pari al 71% – è in aumento rispetto al semestre
precedente. Quanto alla custodia cautelare e alle ingiuste detenzioni, nel
dossier si riportano i dati ministeriali. «Dati sorprendenti – sottolinea
Antigone provando a squarciare il velo di indifferenza che l’opinione pubblica e
una gran parte della politica mette sul tema carcere -. Innanzitutto, colpisce
il fatto che la più restrittiva delle misure cautelari personali, la custodia
cautelare in carcere, è anche la più diffusa, adottata nel 29,7% dei casi in cui
nel 2021 si è ritenuto che fosse necessario applicare una misura, e la seconda
misura più restrittiva, gli arresti domiciliari, è anche seconda per diffusione,
scelta nel 25,7% dei casi». Secondo Antigone sono «altrettanto sorprendenti le
differenze di applicazione delle misure cautelari, e in particolare della
custodia cautelare in carcere, guardando ai diversi tribunali».
E qui la lente si posa sulla realtà giudiziaria
napoletana evidenziando quanto ampio sia il ricorso alle manette facili. «Se,
come detto, in Italia in media si opta per la custodia cautelare nel 29,7% dei
casi in cui si applica una misura, questa percentuale – sottolinea Antigone – a
Napoli è del 51,2%, a Roma del 25,6%». Se si confronta il dato sulle misure
cautelari emesse con il dato delle ingiuste detenzioni (circa cento ogni anno a
Napoli solo tra le istanze arrivate a sentenza, ci sono quindi centinaia di
altri casi non denunciati o ancora sub iudice) è chiaro che si è ancora in
presenza di abusi della misura cautelare da parte di pm e giudici. Inoltre, in
relazione agli indennizzi che lo Stato paga alle persone che sono state in
custodia cautelare o agli arresti domiciliari per un procedimento per il quale
sono state poi prosciolte o assolte, oppure nei casi in cui è accertato che la
misura cautelare è stata adottata in violazione dei presupposti di legge, in
Italia, nel 2021, sono stati pagati 24.506.190 euro (nel 2020 erano stati
36.958.291) per 565 indennizzi (750 nel 2020), per una cifra media di 43.374
euro per indennizzo (nel 2020 la cifra media era stata di 49.278 euro). Il
fenomeno dietro questi numeri è ben più ampio, perché c’è un gran parte di casi
non denunciati, centinaia di innocenti che escono stravolti dall’esperienza del
carcere e non hanno la forza né psicologica né economica per affrontare altri
processi. «Ventiquattro milioni possono in effetti sembrare molti – osserva
infatti Antigone – ma il numero degli indennizzi riconosciuti è in effetti
piuttosto basso»
Viviana Lanza. Napoletana, laureata in Economia e
con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal
2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca
nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli
per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie
di stampa (TMNews, Askanews).
Il report annuale.
Innocenti in carcere, a Napoli pochi risarcimenti e carriere dei pm salve.
Viviana
Lanza su Il Riformista il 22 Maggio 2022.
Una misura su dieci risulta
emessa in un procedimento che ha avuto poi come esito l’assoluzione o il
proscioglimento. Un innocente ogni tre finisce in carcere. Chi paga per
le ingiuste detenzioni? Lo Stato qualche volta (a Napoli nel 24% dei casi, a
fronte di una media nazionale del 33%), i magistrati mai. Dalla relazione
annuale sulle misure cautelari, presentata l’altro giorno in Parlamento, emerge
il divario tra i dati sulle ingiuste detenzioni e quelli relativi ai
risarcimenti riconosciuti dalle Corti di Appello e alle azioni disciplinari
intraprese e concluse nei confronti dei magistrati.
Ebbene, dalla relazione emerge
che nel 2021 i pagamenti per riparazioni per ingiusta detenzione hanno raggiunto
la cifra di 24.506.190 euro (erano quasi 37 milioni nel 2020). Questa somma fa
riferimento a un totale di 565 ordinanze. A Napoli si sono contate 72 ordinanze
per una spesa di due milioni e mezzo di euro (2.517.100 per l’esattezza). Il
dato è in lieve calo rispetto al 2020 (101 ordinanze per una spesa di tre
milioni e 100mila euro sempre con riferimento al distretto giudiziario
napoletano) ma descrive una situazione di malagiustizia comunque ancora diffusa.
Basti pensare che con 72 ordinanze in un anno Napoli è in cima alla classifica
delle città italiane, seconda dopo Reggio Calabria. Bisogna anche considerare
che, se a Napoli la percentuale delle richieste di risarcimento accolte è pari
al 24%, il numero dei casi di innocenti in cella che si verificano sono molti
molti di più. La tabella contenuta nella relazione annuale sulle misure
cautelari, nel tracciare una panoramica dei risarcimenti accordati e pagati,
quindi parliamo di quei risarcimenti che rientrano nel 24% accolti, evidenzia
anche un altro fatto: gli esborsi di maggiore entità riguardano provvedimenti
dell’area meridionale e i pagamenti più consistenti sono stati emessi
dalla Corte di Appello di Reggio Calabria seguita da quella di Napoli.
Di fronte a tanti arresti
infondati, a tanti innocenti in carcere, a tante vite devastate da inchieste che
si sono rivelate poi flop finendo con assoluzioni o proscioglimenti, di fronte a
tutto questo a farne le spese sono sempre e solo i cittadini. Nella relazione si
sottolinea come la richiesta e l’applicazione di misure cautelari si basino su
emergenze istruttorie ancora instabili e, comunque, suscettibili di essere
modificate o smentite in sede dibattimentale, e si specifica che «il
riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione – cosi come,
del resto, del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario di cui all’art.
643 c.p.p. – non possa essere ritenuto, di per sé, indice di sussistenza di
responsabilità disciplinare a carico dei magistrati che abbiano richiesto,
applicato e confermato il provvedimento restrittivo risultato ingiusto». Un
paletto che diventa un muro, sicché nessun magistrato risulta responsabile per
l’arresto di un innocente. Nei tre anni a cavallo tra il 2019 e il 2021, a
fronte di centinaia di ingiuste detenzioni ogni anno, le azioni disciplinari a
carico di magistrati sono state in totale 50 in tutta Italia e, tra assoluzioni
e procedimenti in corso, nessuna si è conclusa con una sanzione.
Nel 2021, in particolare, sono
state soltanto 5, di cui 3 promosse dal procuratore generale della Corte di
cassazione e 2 dal ministro della Giustizia, e si sono risolte due in
un’assoluzione, una in un non doversi procedere e due sono ancora in corso. Il
dato, che pure è tra quelli contenuti nella relazione annuale sulle misure
cautelari presentato al Parlamento dal ministero della Giustizia, è riferito –
si badi – alle sole scarcerazioni intervenute oltre i termini di legge, senza
prendere quindi in considerazione tutti gli altri casi, che sono poi quelli più
gravi. Giudice non condanna giudice, viene da pensare. Eppure le storie degli
innocenti in carcere parlano di indagini frettolose, di indizi mal valutati, di
intercettazioni male interpretate, di un uso eccessivo della carcerazione
preventiva tanto, in molti casi, da far parlare di abuso o di anticipazione
della condanna, e di processi lunghissimi che finiscono per essere una pena
accessoria. Tutto normale?
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Errori giudiziari,
giustizia-show: mille innocenti in cella ogni anno.
Viviana Lanza su Il Riformista
il 3 Luglio 2022.
Confronto tra esperti del
diritto e un docufilm per parlare del più grande male della giustizia: gli
errori giudiziari. Il 4 luglio la Camera penale di Napoli nord, presieduta
dall’avvocato Felice Belluomo, con l’associazione Nessuno Tocchi
Caino, il Movimento forense, l’associazione Errorigiudiziari, Radio Radicale e
con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli nord si
confronteranno su questo spinoso e mai risolto problema della giustizia.
Dal 1992 al 31 dicembre 2021
si sono registrati 30.017 casi di errori giudiziari in Italia, numeri che stanno
a indicare una media di circa mille innocenti in custodia cautelare ogni anno.
Il tutto per una spesa che supera gli 819 milioni e 277mila euro in indennizzi,
per una media di circa 27 milioni di euro all’anno, secondo le statistiche
di Errorigiudiziari.com, il primo archivio digitale dei casi
di malagiustizia. Nasce, quindi, da questi dati la necessità di confrontarsi, di
parlare e di comprendere le ragioni di questi errori della giustizia che
rovinano vite e distruggono carriere, che possono cambiare il corso della storia
di una persona, di una collettività, di una città, di un Paese intero. Al
convegno parteciperanno avvocati e magistrati, esponenti di associazioni che si
occupano di giustizia e di carcere. L’evento sarà anche l’occasione per
assistere alla proiezione del primo docufilm italiano sugli errori giudiziari
“Non voltarti indietro”, che racconta cinque storie vere interpretate e
raccontate dai diretti protagonisti attraverso un ritratto a più voci di chi è
finito in carcere ingiustamente.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Parla il fondatore di
Errorigiudiziari.com. “Troppe firme facili sull’ordinanza di custodia
cautelare”, parla Benedetto Lattanzi di Errori giudiziari.
Viviana Lanza su Il Riformista il 20 Maggio 2022.
Nascono da intercettazioni male interpretate,
indagini definite con troppa fretta o superficialità, testimonianze fuorvianti,
riscontri che mancano, sviste. Quel che è certo è che producono un effetto
devastante. Condizionano il corso della storia, di quella personale, familiare o
professionale di chi le subisce in prima persona ma anche di quella politica,
economica o sociale di un determinato territorio. Le scuse non arrivano mai.
Difficile anche vedersi riconosciuto un risarcimento. Parliamo degli errori
giudiziari e delle ingiuste detenzioni, esempi di una giusta sempre meno giusta.
Secondo le statistiche va in galera un innocente su tre.
Numeri da brividi, considerate le condizioni delle
nostre carceri e i danni della gogna mediatico-giudiziaria a cui, nel nostro
Paese, si espone facilmente chi subisce un’indagine, figurarsi un arresto. «Un
po’ di tempo fa il presidente emerito della Corte costituzionale, Giovanni Maria
Flick, ci disse in un’intervista che il carcere è un veleno e va usato con il
contagocce. Parole da scolpire negli uffici giudiziari e nelle aule di Tribunale
insieme alla scritta “La legge è uguale per tutti”. Sulle ordinanze di custodia
cautelare si mette troppo facilmente la firma. In Italia c’è un abuso della
custodia cautelare», commenta Benedetto Lattanzi, giornalista e fondatore, con
il collega Valentino Maimone, di Errorigiudiziari.com, un’associazione che da
oltre anni raccoglie dati e storie di malagiustizia.
Come nacque l’idea? «Da oltre 25 anni,
con Valentino Maimone, lavoriamo su questo tema. Abbiamo cominciato agli inizi
degli anni ’90: da giovani cronisti avevamo appena assistito alla vicenda
di Enzo Tortora, morto pochi anni prima per quella che lui stesso definì “la
bomba al cobalto che mi è scoppiata dentro” con la sua vicenda giudiziaria.
All’epoca avemmo la fortuna di incrociare sulla nostra strada
professionale Roberto Martinelli, il numero uno dei cronisti giudiziari. Ci
suggerì di approfondire le storie di errori giudiziari e noi seguimmo il suo
consiglio: ci si aprì un mondo che fino ad allora in pochissimi avevano
raccontato. In questi anni abbiamo raccolto centinaia di casi, che
nel 1996 finirono in un (“Cento volte ingiustizia”), cento storie emblematiche
di errori giudiziari dal Dopoguerra ai giorni nostri. Con l’avvento di Internet
– racconta Lattanzi – decidemmo di fondare un database on line, aggiornato in
tempo reale: nasceva così il primo archivio sul web di errori giudiziari e
ingiuste detenzioni, errorigiudiziari.com, unico nel suo genere in Italia e in
Europa».
Il 12 giugno si voterà per il referendum sulla
giustizia, perché è importante? «La riforma Cartabia non è andata in profondità
su diversi punti, per esempio la separazione delle carriere, che secondo noi
servirebbe invece a dare una svolta al sistema giustizia. La questione è solo
sfiorata, perché si parla di separazione delle funzioni. Il referendum è
un’opportunità, andare a votare è importante anche per dare un segnale alla
politica e al Parlamento che da troppo tempo su questi temi si dimostrano
colpevolmente inerti».
Viviana Lanza. Napoletana, laureata in Economia e
con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal
2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca
nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli
per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie
di stampa (TMNews, Askanews).
Tre innocenti in cella al
dì. E il Sistema teme le urne.
Anna Maria Greco il 10 Maggio
2022 su Il Giornale.
La convention dei Radicali
sugli "orrori" giudiziari Salvini: "Con i cinque quesiti noi a mani nude contro
tutti".
Errori, o meglio «orrori»
giudiziari, che travolgono le vite di semplici impiegati e politici affermati,
di amministratori locali, ambasciatori, giornalisti, imprenditori, avvocati,
docenti universitari, architetti, commercianti...Tutti accusati, sbattuti in
prigione, condannati ingiustamente, poi assolti. E nella sede romana del Partito
Radicale 30 di queste storie sono protagoniste di una convention, aperta
dall'intervento dell'avvocato Annamaria Bernardini de Pace, che vuole tenere
alta l'attenzione sui referendum di giugno, quelli che potrebbero cambiare il
sistema giustizia più radicalmente della riforma Cartabia.
I nomi delle vittime sono
tanti, dall'ex sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo, assolto dall'accusa del
2015 di lesioni colpose per un pattinatore caduto in una buca a Marcello
Pittella, ex presidente della Basilicata assolto per la Sanitopoli lucana, dopo
le dimissioni per le accuse del 2018 che hanno portato la Regione al voto
anticipato.
La Campagna per il Sì, dice
Matteo Salvini, in questi 33 giorni «dobbiamo farcela da soli, a mani nude e
contro tutti, gli spazi tv li hanno chiesti Radicali, Lega e socialisti, per
tutti gli altri va bene così? Con 1000 errori giudiziari all'anno e 6 milioni di
processi pendenti?». Il leader del Carroccio siede accanto alla radicale Irene
Testa, che ha raccolto i casi di ingiuste detenzioni ed errori giudiziari nel
libro «Il fatto non sussiste. Storie di orrori giudiziari», con la prefazione di
Gaia Tortora.
L' appuntamento delle urne del
12 giugno ancora troppi neppure lo conoscono mentre, spiega Salvini, «non sarà
una rivoluzione copernicana, ma un mattoncino per costruire la casa sì», perché
quei 5 quesiti sono altrettante possibili «pacifiche rivoluzioni» del sistema
giustizia. Se, «guarda caso», è stato bocciato il quesito sulla responsabilità
civile delle toghe rimangono altri importanti, a cominciare da quello sulla
separazione delle carriere.
Salvini crede ai referendum
perché non crede alla riforma approvata dalla Camera e ora all'esame del Senato.
«Abbiamo parlato con i partiti e con la ministra Cartabia, la cui riforma non
passerà alla storia e abbiamo capito che aria tirava, così abbiamo deciso con i
Radicali, portatori di idee sane, di fare la nostra parte». La battaglia sarà
dura, in un momento particolare, tra guerra, coda della pandemia, crisi
economica, in cui sui referendum è calato il silenzio. «Sarà difficile
raggiungere il quorum del 51%? Sì. Sarà impossibile? No. E se milioni di
italiani chiederanno il cambiamento, per il parlamento sarà difficile far finta
di niente», dice il leader leghista. Salvini promette il suo impegno e
raccomanda a tutti di informare sui quesiti. «Magari ci fossero i sostenitori
del No - sbotta-, io li pagherei, invece ci sono i sostenitori del niente, del
silenzio, che ammazza la democrazia».
Lui parla per esperienza, da
imputato per le scelte da ministro sui migranti, raccontando dei processi
nell'aula bunker dell' Ucciardone. «L'ultima udienza è durata 12 ore e capisci
che la tua libertà è in mano a tre persone, le vedi lì, magari sono nervose,
hanno i loro problemi. Ma decidere della vita e della libertà delle persone non
è un mestiere come un altro. Quando Silvio Berlusconi parlava di test
attitudinali per fare il giudice aveva ragione. Non basta un concorso, servono
tante prove, non solo professionali. E invece sento di nomine in base
all'appartenenza correntizia, a logiche politiche».
Tra le testimonianze di chi da
innocente ha vissuto processi, carcere, gogna mediatica, «perché ormai i
processi non si fanno in tribunale ma prima in tv», arriva il turno del
vicepresidente leghista del Senato Roberto Calderoli, introdotto dal direttore
di Radio Radicale Alessio Falconio. «Devo fare mea culpa su alcune valutazioni
del passato sul diritto: ringrazio il partito radicale per aver trasformato un
giustizialista in un garantista convinto. Ora dico che è meglio dichiararsi
colpevole. Perché, se non hai fatto niente e qualcuno si è convinto del
contrario, alla fine ti rovini la vita per sempre. Mi dichiaro colpevole di aver
scritto i referendum, di aver raccolto le firme. Siamo più di 3,
un'organizzazione a delinquere».
Parla il
professore del collegio difensivo di Giuseppe Mussari. “Innocenti vittime di
errori giudiziari? Avranno comunque la vita distrutta”, intervista a Tullio
Padovani.
Angela Stella su Il Riformista il 12 Maggio 2022.
Il professore
avvocato Tullio Padovani, Accademico dei Lincei, fa parte del collegio difensivo
di Giuseppe Mussari, l’ex presidente di Mps, assolto qualche giorno fa dalla
Corte di Appello di Milano. A partire da questa vicenda, tracciamo le
distorsioni che riguardano in primis il potere di accusa nel nostro Paese.
“Questo è il
disvelamento di come si esercita il terribile potere di accusa in Italia, dove,
per fortuna, esiste ancora un giudice, immigrato da Berlino”. Così lei e i suoi
colleghi Francesco Marenghi e Fabio Pisillo avete commentato la sentenza. Cosa
intendevate dire?
Il potere di
accusa, come ha sostenuto il grande magistrato francese Antoine Garapon, è
“anomico e terribile”. Esso sfugge alle maglie della legalità proprio mentre è
alla ricerca della legalità. Il potere di accusa può muovere da qualsiasi
impulso. Il nostro codice dice che il pm procede alla ricerca della notizia di
reato, non la riceve soltanto. In questa attività comincia a sviluppare i poteri
di accusa che si rivolgono in mille direzioni – interrogatori, perquisizioni,
sequestri – per diventare sempre più invasivo. Ad un certo punto la notizia deve
essere pubblicata sul giornale: basta una perquisizione, atto non soggetto a
divieto di pubblicazione, specialmente se compiuta alle prime luci dell’alba,
col fragore di molte auto a sirene lanciate che si precipitano sotto la casa del
malcapitato, e il gioco è fatto. L’indagato viene sbattuto sui giornali e la sua
reputazione viene rovinata. Così il potere di accusa si è manifestato in forma
devastante. Ma questo potere si giustifica invocando che è la legge che impone
di perseguire ogni reato.
Però poi c’è il
vaglio del Gip.
Sulla figura del
Gip si potrebbe scrivere un romanzo non a lieto fine. Si prospetta una garanzia
tanto lussureggiante quanto inconsistente. Ovviamente ci sono giudici
impeccabili e pm scrupolosi. Ad esempio Carlo Nordio: quando faceva il pm poteva
essere un modello per chiunque. Per questo non ha fatto carriera: gode di una
stima che non è proporzionata alla dimensione professionale che un uomo come lui
avrebbe dovuto assumere. Quindi le eccezioni ci sono, ma è il sistema che alla
fine prevale. Ricordo un episodio lontano.
Prego.
Era appena
entrato in vigore il Codice Vassalli che sembrava lasciare poco spazio al pm. Mi
trovai ad un convegno sul lago di Garda, durante il quale molti magistrati
lamentavano queste restrizioni alle funzioni del pm. Un alto magistrato, mio
carissimo amico, mi disse: «Tullio, i miei colleghi non hanno capito nulla, non
hanno capito che questo è in realtà il codice dei pubblici ministeri». Da allora
miriade di processi, grandi o piccoli che siano stati, hanno testimoniato di
come ci si debba inorridire nel vedere come quel potere dell’accusa sia stato
esercitato.
Avete anche
aggiunto: «L’avvocato Mussari non è più quel che era quando questa vicenda è
iniziata, e nessuno gli restituirà nulla. Su questo, forse, dovremmo tutti
riflettere».
L’avvocato
Mussari impersona plasticamente e drammaticamente la figura del soggetto a cui
io mi riferisco con una massima che sono solito ripetere ai miei assistiti
innocenti, i quali versano in situazioni processuali prevedibilmente lunghe,
logoranti, devastanti con una prospettiva secondo me certa di uscirne, ma dopo
molti anni di patimenti: «Se tutto va bene lei è rovinato». Questo si realizza
in Italia: dopo essere stati stritolati nel tritacarne giudiziario se ne esce
annullati, senza alcuna consistenza, con una vita distrutta insieme ai rapporti
familiari e professionali. Io ho una casistica per tutte le cose che affermo: la
moglie ti abbandona, i figli ti rifiutano, un mio cliente è persino diventato
barbone prima di essere assolto.
Chi si assume la
responsabilità di questo?
Nessuno. A fronte
di questo immenso potere non esiste alcuna responsabilità. Tra l’altro il nostro
è un Paese che miniaturizza l’idea di errore giudiziario. Esso è considerato
tale solo quando produce una condanna ingiusta rispetto alla quale c’è da
risarcire una detenzione. Ma a mio parere siamo in presenza di un errore
giudiziario ogni volta che si subisce un processo per poi essere assolto. I
cittadini dovrebbero essere tenuti indenni, quantomeno sul piano delle
conseguenze economiche. L’imputato dovrebbe essere immediatamente risarcito,
perché sottoposto ingiustamente a processo. Anche se non sarò andato in carcere,
la mia vita è stata rovinata. E nessuno neanche chiede scusa.
A proposito di
responsabilità, l’Anm non condivide affatto la parte di riforma del Csm e
dell’ordinamento giudiziario in cui si prevede di valutare il magistrato anche
in base agli esiti.
Constato che
esiste una massima eterna: chi ha un potere su cui non grava una corrispondente
responsabilità non è mai disposto ad accettarla, perché significherebbe
rinunciare a una fetta di quel potere e alla serenità di non dover render conto
delle proprie azioni. Invece potere e responsabilità dovrebbero andare a
braccetto, essere due facce della stessa medaglia. Altrimenti quel potere si
trasforma in una sovranità assoluta.
Soprattutto
quando quel potere può privare della libertà personale.
In questo caso la
tecnica per deresponsabilizzarsi è ripartire il potere. Ad esempio, il pm
sosterrà che ha fatto la richiesta di arresto, ma è il giudice che ha poi
spedito la persona in galera. L’articolo 1 della Costituzione (“L’Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”) alla luce di
quello che ci siamo detti fino ad ora va riletto così: L’Italia è una Repubblica
giudiziaria, fondata sull’esercizio dell’azione penale. La sovranità appartiene
ai pubblici ministeri, che la esercitano in modo discrezionale.
L’Anm lunedì
prossimo sciopera, anche per questa questione del fascicolo di valutazione. Che
pensa?
Lo sciopero è
considerato un diritto intoccabile. In realtà il nostro sistema contempla ancora
uno sciopero illegittimo. L’articolo 504 cp stabiliva che quando lo sciopero è
commesso con lo scopo di costringere l’Autorità a dare o ad omettere un
provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si
applica una certa pena. La norma è stata sottoposta al vaglio della Corte
Costituzionale nel 1983. La sentenza 165 la dichiarò costituzionalmente
illegittima, salvando però l’ipotesi che lo sciopero sia diretto a sovvertire
l’ordinamento costituzionale, ovvero ad impedire od ostacolare il libero
esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. E
allora mi chiedo: l’Anm non intende forse influenzare l’attività parlamentare?
Non sta chiedendo appunto che il Parlamento cambi indirizzo? Non è forse il
tentativo di ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si
esprime la sovranità popolare? Ovviamente sono consapevole che per applicare
l’articolo 504, nella forma residua dopo il vaglio costituzionale, ci vogliono
magistrati, e cioè quegli stessi magistrati pronti a scioperare.
Ultima domanda:
cosa ne pensa della decisione della Corte Costituzionale di rinviare la
decisione sull’ergastolo ostativo?
In Italia la
regola numero uno è quella del rinvio, la panacea di tutti i mali. Invece la
Corte costituzionale, riconoscendo che la norma era illegittima, avrebbe dovuto
subito dichiararne l’incostituzionalità. E il Governo avrebbe potuto intervenire
con un decreto legge per dettare una disciplina costituzionalmente corretta. La
soluzione c’era. Il sistema ha invece partorito questa situazione paradossale
per cui l’incostituzionalità resta sospesa: non riesco proprio a capirlo. Lo
stupore mi ha colto fin dalla vicenda Cappato (tesoriere dell’Associazione Luca
Coscioni, ndr): sono rimasto esterrefatto nel leggere del rinvio anche in quel
caso. E poi, come sappiamo, il Parlamento non ha fatto nulla. E così accadrà in
questo caso. L’8 novembre non credo proprio che avremo una legge approvata in
via definitiva. Nessuno se ne vorrà assumere la responsabilità, soprattutto a
ridosso delle elezioni. Angela Stella
Palamara: «In Italia la
legge non è uguale per tutti».
L'ex pm di Roma: «È giusto
dirlo: la magistratura è una comunità composta da 10.000 magistrati che riflette
un po' la vita politica, sociale, istituzionale dell’Italia». Il Dubbio il 5
aprile 2022.
«In magistratura il manuale
Cencelli, in Italia la legge non è uguale per tutti». Lo ha detto Luca
Palamara al Congresso di Grande Nord a Milano. «Un auspicio di cambiamento è
quello che mi ha caratterizzato nella mia esperienza professionale. Come tutte
le vicende umane e che hanno a che fare con la politica, riproducono su se
stesse le vicende della politica. È giusto dirlo: la magistratura è una comunità
composta da 10.000 magistrati che riflette un po’ la vita politica, sociale,
istituzionale dell’Italia», sottolinea.
«In magistratura –
continua Palamara – c’è una parte più ideologizzata, quella che noi chiamiamo
della sinistra giudiziaria, c’è poi una parte più attenta ai problemi del
sindacato, e una parte che è moderata dall’interno» e «a torto o a ragione
l’orientamento culturale della magistratura parte dalla sinistra giudiziaria,
che crea un cortocircuito anche nel rapporto tra magistratura e politica».
«Qualcosa bisogna fare: ad
esempio – spiega – stabilendo come si vuole organizzare internamente la
magistratura. L’autonomia e l’indipendenza viene organizzata oggi attraverso
questi gruppi associativi, queste correnti, e le correnti determinano la vita
della magistratura. Stabiliscono chi diventa procuratore della Repubblica, chi
diventa Presidente del Tribunale e chi diventa consigliere superiore della
magistratura».
Laicità e
sentenze. Alla giustizia italiana serve un Concilio Vaticano II per guardare
negli occhi i reali bisogni della società.
Alberto Cisterna su
Il Riformista l'1
Maggio 2022.
Tra le pieghe
delle riforme approntate dal ministro Cartabia e tra gli obiettivi del Pnrr sta
lentamente erodendo spazi una profonda ristrutturazione della giustizia nel
nostro paese. Persino l’emergenza pandemica sta spingendo in modo sostanziale
perché il servizio giustizia assuma una collocazione, come dire, meno tolemaica
e più periferica nel complesso sistema delle istituzioni democratiche.
L’introduzione
dell’improcedibilità in appello e in cassazione; la prevista, massiccia erosione
delle pendenze entro tempi rapidi; l’iniezione di un numero senza precedenti di
collaboratori dei giudici per smaltire pratiche; due anni di trasformazione dei
tribunali e delle corti in “sentenzifici” vuoti dalle aule deserte; e, ora, le
pagelle di valutazione stanno inesorabilmente sospingendo gli apparati di
giustizia verso l’angolo chiaroscurale di una posizione meno austera e
appagante. Qualcuno lamenta, addirittura, che si vogliano privare i giudici di
quarti di nobiltà istituzionale assimilandoli a una qualunque pubblica
amministrazione. Senza neanche considerare che un processo è per ciascun
cittadino né più né meno che una pratica di cui attende il disbrigo al pari di
una licenza o di una concessione.
Le riforme, e lo
spirito laicizzante che le sospinge per la prima volta a ranghi serrati tra la
politica, sembrano condannare le toghe a scendere dai piani alti della
Repubblica e a dover far di conto con le drammatiche urgenze della nazione;
urgenze che, sinora, erano state nei fatti sempre postergate rispetto alla
primaria necessità di conservare integre le guarentigie della giurisdizione.
Mancano migliaia di giudici rispetto alla domanda di giustizia, ma la geografia
dei tribunali è intangibile e sperpera risorse; l’obbligatorietà dell’azione
penale produce milioni di processi spesso inutili e bagatellari; le sentenze
devono essere cesellate e, quindi, sono rade; i carichi di lavoro non possono
compromettere i riti e le movenze di liturgie processuali spesso barocche. Tutto
questo prevale e precede ogni altra istanza o necessità, perché ciò che conta è
piuttosto l’immutabilità e l’intangibilità dell’apparato ideologico che sorregge
e giustifica la magistratura in Italia.
La giustizia
avrebbe bisogno di un suo Concilio Vaticano II, di una rivoluzione che guardi
ai “fedeli” e parli con essi per comprenderne le necessità e i bisogni. La
Chiesa decise che l’officiante non avrebbe dato più le spalle ai credenti
durante la celebrazione e che tutti gli altari sarebbero stati visibili e
rivolti verso il popolo, costitutivo dell’Ecclesia e protagonista del mistero
eucaristico. Un simbolo, ovvio, ma al pari la manifestazione tangibile di un
cambiamento profondo. È di questo guardare negli occhi i reali bisogni di
giustizia della società, di questo mettere da parte qualche decennio di pulsioni
mitologiche e autocelebrative che il dibattito, entro e fuori la magistratura,
ha una necessità estrema. Le discussioni sulla giustizia sono avvelenate da tre
decenni dalla schizofrenia che tiene separate la declamazione astratta di
principi che hanno al centro le istanze dei cittadini e la concreta
conservazione iper-corporativa dello status quo.
Al profilarsi di
ogni progetto di riforma si alza la cortina fumogena dell’attacco
all’indipendenza, della necessità di preservare l’autonomia; il tutto come un
riflesso condizionato in risposta a una politica infida e complottista. Per la
giustizia è la conseguenza peso di anni di politiche miopi, predatorie,
antagoniste per interessi personali ad aver inquinato i pozzi e a spingere anche
il più tranquillo e pacato dei giudici a metter mano alla pistola se sente
parlare di separazione delle carriere o di controllo sull’azione penale dei
quali, in fondo, non gli importa granché, ma che considera costitutivi del
proprio dna costituzionale. Occorrerebbe un Concilio. Un luogo di consiglio per
la conciliazione.
Per tornare a
riflettere sul semplice fatto che quasi tutti, praticamente tutti, i processi
civili e penali che si celebrano ogni giorno nelle aule di giustizia riguardano
casi minuti, vicende importanti per i cittadini, talvolta vitali per loro, ma
pressoché tutte saldamente al riparo da condizionamenti e pressioni di sorta. Ed
esposte, invece, all’inefficienza o alla onerosità dei carichi. Si è costruito
un modello ideologico e culturale che rappresenta la cittadella giudiziaria come
assediata ogni giorno da poteri forti, da politici intrallazzatori, da pervicaci
depistatori. Che pur ci sono, come l’affaire Palamara e altro dimostrano, ma
quei processi costituiscono un infinitesimo degli affari di giustizia e né
questa autonomia né questa indipendenza hanno impedito nefandezze, anzi.
Invece importa ai
cittadini sempre, quasi sempre, una giustizia minuta che dovrebbe essere rapida,
efficiente, sobria, mite, capace di risolvere i mille affanni della vita o di
valutare con serenità devianze e errori. È facile obiettare che, in tanto questo
“servizio” può essere reso, in quanto esista un corpus giudiziario autonomo,
qualificato, indipendente. In realtà non accade quasi da nessuna parte in
Occidente, ma è innegabile che questo assetto giovi a meglio garantire gli
utenti. Tuttavia, ha un costo enorme che rischia di diventare insopportabile. La
qualità della giustizia negli Stati uniti, nel Regno Unito, in Francia o
in Germania è pessima se rapportata a quella italiana, ma nessuno in quei paesi
si sogna di dire che pone un freno allo sviluppo economico e sociale di quelle
nazioni o crea gabbie giustizialiste.
Già solo l’aver
imposto la questione giustizia tra gli obiettivi del Pnrr dovrebbe far
comprendere che la rinascita del paese non può avvenire in queste condizioni e,
soprattutto, dovrebbe indurre a mettere da parte la solita litania corporativa,
visto anche lo schiaffo assestato dall’Europa. Occorre, quindi, accettare gli
aggiustamenti che l’efficienza complessiva del servizio impone e di cui ancora
si parla pochissimo, presi come si è dalla fretta di approvare la nuova legge
per l’elezione del Csm. Nel mare di questo vasto programma di riforme, le
pagelle di professionalità dei giudici sono un affluente del tutto secondario.
Ammesso che mai
funzioneranno, può anche darsi che saranno scritte sulla pelle di qualche
magistrato colpito da un rating basso per i suoi insuccessi, ma il loro
inchiostro rosso viene distillato dalla vita delle persone che subiscono
ingiustizie, che vedono i loro diritti negati o finanche la loro libertà
compromessa da qualche sprovveduto e superficiale. A quanti dicono che la
pagella “frenerebbe” i pubblici ministeri o i giudici occorre ricordare che quei
freni sono posti a tutela dei cittadini e che la carriera disturbata di qualche
magistrato vale certo un’ingiustizia in meno. Alberto Cisterna
La polvere sotto il
tappeto. Il diritto nel degrado e nessun Cicerone in vista.
Otello Lupacchini su Il
Riformista il 28 Aprile 2022.
Il cittadino appare sfiduciato
e intuisce l’ostilità del sistema giudiziario nel suo complesso: il diritto è
percepito come strumento di alterazione di tutto un contesto storico, al punto
di negare se stesso e diventare strumento di legittimazione di menzogne
istituzionali. A questo sconfortante risultato concorrono: la legislazione
malamente concepita e coordinata che riduce il diritto a un discorso verboso, a
disposizione di interpreti che cercano di forzarlo a vantaggio di interessi di
parte; l’inefficienza del processo penale, conseguenza
dell’«obbligatorietà» puramente nominale, ma pervertita di fatto in
assoluta «arbitrarietà», dell’azione penale e delle complicazioni processuali,
che produce impunità diffusa, frustrante per il cittadino onesto e osservante,
ma anche «errori giudiziari», intesi come tali sia i deragliamenti della
giurisdizione penale, costituiti dal fatto che il tribunale imputa una
fattispecie che non si è affatto realizzata o la imputa a persona diversa da
quella che l’ha posta in essere, sia l’inesatta qualificazione giuridica del
fatto o in una non corretta applicazione delle norme di procedura; la formazione
professionale difettosa, affidata a università che restituiscono alla società
dei tecnici, ma non dei giuristi in grado di percepire i contesti
socio-politici da cui le regole scaturiscono e a cui sono destinate; la
magistratura costituzionalmente disegnata più come centro di potere che come
potere di servizio, con un tasso di entratura in organi di garanzia eccessivo e
sproporzionato; l’avvocatura a cui la Costituzione ha assegnato la funzione
della difesa processuale, gravata, e quindi per questo delegittimata, dal
«sospetto» di agire per sviare la retta applicazione della legge.
Ai fini dell’indispensabile e,
al tempo stesso, indifferibile recupero di credibilità del diritto, perché non
venga più percepito soltanto come strumento per giochi di potere e torni a
essere, piuttosto, una scommessa sul futuro che tutti prendano sul serio, c’è
bisogno, innanzi tutto, di operatori più dotti e più eticamente attrezzati, meno
tecnici e meno formalisti; di una robusta opera di riacculturamento, insomma,
che si generi a partire dalle facoltà giuridiche. Personalmente, mi
intrigherebbe il ritorno alle magnifiche orazioni dei grandi avvocati
dell’antichità, ma non vedo all’orizzonte novelli Cicerone, capaci di dipingere,
come ad esempio nella difesa di Cluenzio, l’atmosfera torbida e corrotta delle
classi ricche di una cittadina molisana al tempo della dominazione
di Silla, capaci di narrare una serie di delitti, omicidi, avvelenamenti,
procurati aborti, testamenti falsificati, facendo emergere a tinte fosche
l’avidità rapace, e criminale, l’ossessione per il patrimonio, la tetra
superstizione di personaggi in una esistenza provinciale; vedo piuttosto tanti
epigoni di Euricio, accusatore falsario, negligente e svogliato, il quale mentre
teneva l’arringa ogni tanto si interrompeva, per bisbigliare nell’orecchio di
uno schiavo, per dettargli la lista del pranzo, di fronte a costoro, rifugiarsi
nell’orgoglio della più classica oratoria forense è come andare all’assalto di
un carro armato con una spada di legno.
Devo, dunque, prendere, e dare
altresì, atto che per più di millecinquecento anni, in tutta Europa, ci si è
affidati ai giuristi per la determinazione delle regole giuridiche del presente
e del futuro, ma oggi non ne esistono più le condizioni: prudentes, iuris
consulti, iuris periti, iuristae, padroneggiavano saperi oltre il diritto, come
filosofia, retorica, storia, letteratura, di cui essi si avvalevano nella
creazione delle forme giuridiche mediante le quali ordinavano, dopo averla
conosciuta e analizzata, la complessità del sociale; con le codificazioni della
modernità e la riduzione del diritto a legge, però, la figura del giurista
«intellettuale» è progressivamente entrata in crisi e dentro l’universo
giuridico è cominciato un processo di rarefazione culturale. Gli effetti di
questo impoverimento epocale sono oggi evidentissimi nelle facoltà giuridiche e,
giù per li rami, negli uffici di procura, negli studi legali, nelle aule dei
tribunali, nelle camere di consiglio.
In queste condizioni, si fa
fatica a conoscere quelle relazioni intersoggettive alla base di ogni sistema
giuridico o, forse, non le si vuole neppure conoscere, sicché ci si ritrova
nelle leggi dell’ultim’ora, casuali, raffazzonate, vuote di vita. Perso ogni
significato sequenze metodiche del tipo esperienza, intuizione, sapienza,
giustizia, la dura realtà è che sono spariti o vanno almeno sparendo i
tradizionali iuristae: per dirla con il cardinale Giambattista De Luca (Il
Dottor Volgare [proemio 7.10]), l’universo giuridico è ormai popolato da «puri
testuali», i quali credono che esiste un’identità assoluta fra legge e diritto e
che nella legge si trovi quel tutto che si dovrebbe conoscere e coltivare. Sol
che abbia un po’ d’esperienza e qualche raccolta di sentenze sulla scrivania, un
operatore mediamente diligente, non dovendo più scavare nei fatti sociali e
individuarne la misura più corretta, riesce oggi a cavarsela nella maggior parte
dei casi: leggi e codici ben redatti ne semplificano il lavoro e riducono la
competenza richiesta nella ricerca della soluzione.
Se Benedetto Croce, citato
da Piergiorgio Odifreddi (“La bellezza matematica nascosta nel mondo”, La
Repubblica, 28 marzo 2014) poteva sostenere che, nella società, «comanda chi ha
studiato greco e latino e lavora chi conosce le materie utili» e, addirittura,
degradare la scienza a semplice suppellettile, sorta di libro di ricette di
cucina: priva di valore conoscitivo, oggi, per quanto attiene al diritto, simili
proposizioni non hanno più cittadinanza: per un verso, vi sono filosofi e
letterati, come ad esempio Claudio Giunta (“Ripensare l’umanesimo”, in Il Sole
24 Ore, 16 ottobre 2011), per il quale l’Italia è un «paese di avvocaticchi con
le loro plaquettes di poesie pubblicate in proprio», che hanno espunto la
giurisprudenza dal novero delle scienze umane; per altro verso, non manca chi
sostiene, è il caso di Umberto Vincenti (Diritto e menzogna, Donzelli Editore,
Roma 2013), che la iurisprentia abbia addirittura perso la qualità di scientia
iuris, degradata com’è a pura tecnica: «Tecnica giuridica e non più
giurisprudenza, ma anche tecnici del diritto e non più giuristi; tecno-diritto e
non più (assolutamente) diritto».
Del resto, l’esperto legale
dei nostri giorni, operando solo attraverso le parole della legge vigente, è
appiattito sul presente: passato e futuro non gli interessano, fuoriuscendo
dalla trama entro cui lavora; né è interessato a capire cosa ci sia dietro le
regole scritte, la ragione storica di una singola disciplina o le idee che hanno
determinato una certa opzione di regime; è altresì alieno alla critica
all’assetto in vigore: poiché è il presente, non già i futuribili o il
riformato, a garantirgli competenza e qualità di esperto, è di solito ostile ai
cambiamenti. Complice di questo disastro lo sciagurato rinnovamento della scuola
italiana, affidato a sbrigative potature come quelle abbattutesi sulle scienze
umanistiche che taluni demodementi vorrebbero completare con l’ostracismo della
filosofia dall’insegnamento universitario, punto di approdo del maldestro
tentativo di impedire il formarsi dello spirito critico su cui si fonda, in una
vera democrazia, la possibilità di esercitare forme di controllo tese a evitare
che il potere si trasformi in arbitrio e che si nasconda nell’opacità.
Assunto, infatti, a unico bene
da salvaguardare la velocità dei processi decisionali, l’esercizio dello spirito
critico, implicante discussione, finisce inesorabilmente per rallentarli. Di
qui, la riduzione degli spazi dove lo spirito critico può essere accettato, o
benevolmente tollerato: spazi privati, ovviamente, dove rifugiarsi per praticare
un irrilevante otium, che non inneschi alcuna forma di contagio. Immanuel
Kant, nel saggio Il conflitto delle Facoltà (in Scritti di filosofia della
religione, Mursia, Miano 1989, p. 244) aveva indicato come compito della facoltà
di Filosofia, quello che forse ancor più è il compito delle facoltà giuridiche:
sviluppare e affinare «la capacità di giudicare con autonomia, vale a dire
liberamente (…) poiché l’unica cosa importante è la verità»: innegabile che
competa alla facoltà di Giurisprudenza tramettere i fondamenti del pensiero
critico, l’attitudine alla problematizzazione, il sentimento e la consapevolezza
della relatività di ogni ordinamento giuridico; devastante, dunque da combattere
con ogni mezzo e in ogni sede, il tentativo di trasformare le università in
scuole professionali o, peggio, di professioni legali, quali magistratura,
notariato e avvocatura. È necessario, allora, pretendere che le facoltà
giuridiche tornino a formare autentici giuristi, uomini di cultura raffinata, in
possesso di una tecnica peculiare, ma in grado di leggere la realtà sub specie
iuris, ispirata dal dubbio metodico.
Otello Lupacchini.
Giusfilosofo e magistrato in pensione
"Può reiterare il reato
perché ha affinato le sue indiscusse capacità". Detenuto si laurea in carcere ma
per i magistrati è più pericoloso… perché ha studiato: domiciliari negati.
Redazione su
Il Riformista il 3 Maggio 2022.
Studiare in carcere non è cosa
ben gradita perché si rischia di affinare alcune peculiarità e reiterare
condotte illecite. E’ quanto emerge dalle motivazioni del Tribunale di
Sorveglianza di Bologna che ha rigettato la richiesta di differimento della pena
avanzata dal legale di un detenuto all’inizio del primo lockdown (2020). Istanza
presentata a causa di motivi di salute e respinta dai magistrati del capoluogo
emiliano con una frase che lascia interdetti: “La laurea conseguita durante la
detenzione e la frequentazione di un master per giurista di impresa ove si
consideri la sua personalità per come emerge dalle relazioni di sintesi, si
ritiene possano aver affinato le sue indiscusse capacità e gli strumenti
giuridici a sua disposizione per reiterare condotte illecite in ambito
finanziario ed economico, che possono essere svolte anche se ristretto in
detenzione domiciliare”.
A raccontare la vicenda è il
settimanale L’Espresso secondo cui il detenuto, complice anche l’inizio della
pandemia, aveva richiesto un differimento della pena sulla base di un’asserita
situazione di fragilità sanitaria che lo rendeva particolarmente esposto alle
conseguenze di un eventuale contagio. Da qui la richiesta del passaggio
agli arresti domiciliari, negata dal Tribunale di Sorveglianza che tra le
motivazioni alla base del rigetto ha anche battuto sulla pericolosità
dell’istruzione perché considerata come fattore potenzialmente pericoloso in
grado di affinare la capacità criminale della persone detenuta, esperta in reati
economico-finanziari.
Parole che hanno indignato il
Dipartimento universitario dove il giovane detenuto ha studiato con giuristi e
docenti. Ma non solo. Anche il presidente merito della Corte
Costituzionale, Giovanni Maria Flick, insieme all’avvocata Francesca Cancellaro,
hanno presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione
dell’articolo 2 del primo protocollo integrativo della Convenzione, che prevede
il diritto allo studio, e di altri articoli.
Una cosa da cui ci si può
difendere in tanti modi: una replica, una diffida. Tre toghe mi vogliono in
galera per un apprezzamento sgradito.
Iuri Maria Prado su Il
Riformista il 28 Aprile 2022.
L’altro giorno trovo nella
cassetta delle lettere una busta verde con un cartiglio inequivocabile:
“NOTIFICHE PENALI”. Tre magistrati mi hanno querelato. Dice: e allora? E allora
niente, so bene che è routine (non per me, che non ho mai ricevuto querele): ma
m’interessa capire che cosa spinge qualcuno a fare istanza affinché qualcun
altro sia processato e sottoposto una sanzione penale, possibilmente la galera.
E non perché il querelante lamenti una coltellata, o di essere passato
pubblicamente per stupratore di bambini, ma perché si duole di un apprezzamento
sgradito: che è una cosa da cui ci si può difendere in tanti modi (una replica,
una richiesta di scuse, persino una diffida), senza che sia necessario reclamare
la gattabuia per il presunto colpevole.
Inutile precisare che in
materia ho un pregiudizio. Io sono per l’abolizione del carcere, persino per
l’abolizione della pena: figurarsi, dunque, quanto sia lontana da me anche la
sola idea che un mio simile, su mio impulso, possa finire in prigione. È una
questione culturale, civile, di impostazione umana, e certamente non posso
pretendere che sia condivisa. Nell’ambiente in cui ho cominciato, ahimè troppi
anni fa, a fare il mestiere che faccio (sono avvocato, mi occupo di proprietà
industriale), si guardava con compatimento, e forse con un po’ di disprezzo, ai
colleghi che si affidavano al giudice penale per risolvere i casi della nostra
materia. Non ci piaceva, anzi ci ripugnava proprio, che una lite su un marchio o
su un brevetto finisse in perquisizioni e anni di prigione. Le norme penali
esistevano, ma erano lasciate lì, inerti, e nessuno tra noi si sognava di farvi
ricorso.
Ora non importa riferire chi
siano i magistrati che mi hanno querelato (son tra quelli più noti, quelli
sempre in Tv), né importa (se non a me) che abbiano querelato me: e piuttosto,
come dicevo, mi interessa e credo sia di interesse capire come e con quale
coscienza si possa richiedere che una persona sia processata e condannata alla
privazione della libertà. Devo ritenere che il querelante ritenga giusto,
civile, appropriato che un essere umano – non un soggetto pericoloso, non una
persona che, se lasciata libera, potrebbe arrecare nocumento all’incolumità
altrui – sia imprigionato. Voglio sperare che la risposta non stia
nell’osservazione che tanto in galera non ci finisce mai nessuno, e che quindi
chiedere il carcere è innocuo perché poi uno lo scampa.
Né ovviamente ci si può
aspettare che certe meditazioni turbino gli intendimenti di chi si è fatto un
nome mandando in galera la gente. Ma un fatto è certo: la giustizia di questo
Paese sarebbe diversa, pur a norme invariate, se quelli che la amministrano non
nutrissero la fede che invece dimostrano per il sistema penale; se non
dimostrassero questa totale noncuranza nell’essere causa dell’afflizione altrui;
se provassero pena per le pene che chiedono per gli altri. Infine: se sentissero
il peso del male che sono chiamati a fare. Perché se lo sentissero, credo, tanto
più rigorosamente eviterebbero di farne quando nemmeno vi sono chiamati. E non
farebbero più querele, credo. Iuri Maria Prado
Processo in diretta. La
logorrea televisiva dei magistrati e il silenzio di chi subisce i loro errori.
Iuri
Maria Prado su L'Inkiesta il 27 maggio 2022.
Nell’equilibrio dei palinsesti
italiani si assiste allo strano fenomeno per cui i togati, che non sono persone
qualsiasi, possono fare requisitorie televisive sul bene comune, e nel caso,
dare la linea delle politiche giudiziarie. Forse si esagera nel dare loro
spazio? Un rimedio ci sarebbe.
Bisogna sgomberare il campo da
un piccolo fraintendimento quando si discute di giustizia e del diritto dei
magistrati di occupare giornali e tv facendo il bello e il cattivo tempo nel
dibattito pubblico. E il fraintendimento sta in questo: nell’idea, completamente
sbagliata, che in quel modo il magistrato eserciti un diritto di parola
equiparabile a quello del cittadino comune.
Perché questa, pressappoco, è
l’idea: che il magistrato sia uno qualunque, e che non concedergli quotidiani
ettari di interviste e intere maratone televisive equivalga a imbavagliarlo
privandolo di un diritto elementare. Ma a parte il fatto che a uno qualunque non
si concede nemmeno un centimetro della ribalta invece garantita all’eloquio
togato, c’è che il magistrato non è per niente uno qualunque, ma un funzionario
cui la società (non Dio) attribuisce il potere di applicare la legge, non quello
di dare la linea delle politiche giudiziarie né tanto meno quello di fare
requisitorie televisive sul bene comune.
C’è poi il fatto che quel
potere (il potere di applicare la legge) implica il dettaglio della vita altrui,
che può essere travolta da un tratto di penna: il che dovrebbe consigliare
maggior cautela nel lasciar libero il magistrato di tracciare l’indirizzo
politico del Paese in argomento di giustizia, proprio come non accetteremmo la
conferenza stampa di un colonnello che con la pistola alla cintola contesta le
politiche di governo per il mantenimento dell’ordine pubblico. Il caso del
manipolo di magistrati che chiama in adunata le televisioni e denuncia le
malefatte della politica marcia ce lo ricordiamo bene; una junta di militari che
allestisce in caserma un set analogo e reclama politiche dell’onestà invece non
ce lo ricordiamo, e fino a prova contraria è un bene, ma sarebbe esattamente la
stessa cosa. Con la differenza che il giorno dopo non intervisteremmo quei
sediziosi per chiedergli come si fa a rimettere in riga la società corrotta.
Tutto questo per dire che ai
magistrati dovrebbe essere impedito di parlare? No, per carità. Diciamo nella
giusta misura: gli diamo lo spazio normalmente concesso ai destinatari dei loro
provvedimenti sbagliati, i cittadini arrestati ingiustamente, quelli che hanno
perso il lavoro, la famiglia, il patrimonio a causa degli errori e degli abusi
del potere giudiziario. Sarebbe un’informazione magari un po’ meno
scoppiettante, un po’ meno da far sognare il popolo dell’onestà, ma forse più
civile, più giusta.
Toghe e informazione, il
bavaglio non esiste.
Armando Spataro su Il Corriere del Giorno il 4 Giugno 2022.
Sono preferibili comunicati
stampa sobri ed essenziali che hanno il pregio di diffondere parole e notizie
precise, senza possibilità di interpretazioni forzate, come accade con i
"racconti" a voce. Vanno evitati però eccessi comunicativi anche della polizia
giudiziaria (spesso dovuti al fine di acquisire titoli utili per la progressione
in carriera, mediante visibilità e impatto mediatico delle proprie attività) o
anticipate diffusioni di notizie che possono determinare il rischio di
pregiudicare il buon esito delle operazioni.
Il corretto rapporto tra
giustizia ed informazione-comunicazione è oggi uno dei pilastri cui si fonda la
credibilità dell’amministrazione della giustizia, mentre a comunicazione
scorretta ed impropria genera tra i cittadini errate aspettative e distorte
visioni della giustizia, così determinando ragioni di sfiducia nei confronti
della magistratura. Infatti il CSM ha più volte emanato linee guida per gli
uffici giudiziari “ai fini di una corretta comunicazione istituzionale”, anche
se quelle determinate in passato da vari magistrati non sono certo le uniche
criticità che ormai si manifestano sul terreno dei rapporti tra giustizia ed
informazione. L’approvazione del decreto legislativo n.188/2021 ha determinato
commenti negativi.
Alcuni a partire da Paolo
Colonnello su La Stampa hanno parlato un inaccettabile bavaglio che si vorrebbe
imporre al dovere-diritto di informazione su vicende e procedure penali. Non si
può ovviamente alcuna forma di censura sulla diffusione di notizie di pubblico
interesse per i cittadini, ma non condivido tali critiche le quali,
innanzitutto, non considerano che, al di là di marginali aspetti critici, la
normativa è imposta da una precisa direttiva europea. E’ innanzitutto corretto
che sia vietato per le autorità pubbliche (quindi non solo la magistratura)
indicare pubblicamente come colpevoli indagati o imputati non definitivamente
condannati, così come correggere la propalazione di notizie inesatte.
Ma l’allarme-bavaglio riguarda
soprattutto il divieto di conferenze stampa (salvo eccezionali motivate) in
favore della prassi di comunicati. Condivido totalmente questa previsione poiché
conferenze stampa teatrali e comunicati stampa per proclami hanno inquinato
l’immagine della giustizia e alimentano la creazione di magistrati icone, non
caso tra i primi a lamentarsi della scelta legislativa. Sono preferibili
comunicati stampa sobri ed essenziali che hanno il pregio di diffondere parole e
notizie precise, senza possibilità di interpretazioni forzate, come accade con i
“racconti” a voce. Vanno evitati però eccessi comunicativi anche della polizia
giudiziaria (spesso dovuti al fine di acquisire titoli utili per la progressione
in carriera, mediante visibilità e impatto mediatico delle proprie attività) o
anticipate diffusioni di notizie che possono determinare il rischio di
pregiudicare il buon esito delle operazioni.
Sono pure condivisibili le
disposizioni riguardanti la tecnica di redazione degli atti giudiziari destinati
a diventare pubblici, quali decreti di perquisizione, avvisi di garanzia,
provvedimenti cautelari, decreti penali e sentenze, che coerentemente non
possono essere motivati in modo ultroneo rispetto ai fini cui sono diretti tra i
quali non rientra la loro amplificazione mediatica. I protagonisti della
comunicazione relativa alla giustizia non sono però solo i magistrati e la
polizia giudiziaria ma anche gli avvocati, i politici, ed i giornalisti. e’
virtuoso il protagonismo di magistrati ed avvocati civilmente impegnati a
fornire corrette informazioni ai cittadini nell’interesse della amministrazione
della giustizia e della sua credibilità, ma non si può tacere in ordine a certi
comportamenti di non pochi avvocati che sfruttano la risonanza mediatica delle
inchieste in cui sono coinvolti i loro assistiti, ed anzi le amplificano. Anche
grazie a tale propensione si afferma il processo mediatico, che – maggiormente
deprimente se vi partecipano magistrati diventa spesso più importante ed
efficace di quello che si celebra nelle Aule di Giustizia e della sentenza cui è
finalizzato.
Quanto al comportamento di
alcuni politici, con incarichi governativi o meno, non si può tacere su quanti
sono ben attenti a sfruttare le modalità di comunicazione che i tempi moderni
hanno imposto, specie a proposito di procedimenti che vedono indagati o imputati
coloro che per comune appartenenza partitica o per parentela ed amicizia, sono a
loro vicine. Il brand utilizzato continua ad essere sempre eguale: si tratta
di processi frutto dell’orientamento politico dei magistrati che non rispettano
la legge ! I giornalisti, ovviamente, dovrebbero essere gli osservanti più
scrupolosi delle regole della corretta informazione. E fortunatamente molti lo
sono. Ma anche per questa categoria la modernità ha imposto “anti-regole”
pericolose ed inaccettabili, mentre dovrebbero valere quelle del giornalismo
d’inchiesta senza cedimenti alle logiche del captare attenzione e scatenare
interesse sulla base di informazione inesatte o superficiali. Condivido,
comunque, la necessità di disciplinare legislativamente l’accesso agli atti, per
evitare dipendenza da fonti portatrici di interesse e per esaltare la libertà e
professionalità dei giornalisti.
Ma è giusto anche che le
conferenze stampa siano limitate ai fatti di pubblico interesse e che sia il
procuratore a deciderlo: si potrebbe mai operare una simile scelta d’intesa con
organismi rappresentativi del giornalismo ? Se tutto avviene correttamente e
nello spirito della legge, i giornalisti non vedranno mai depotenziato il loro
ruolo e diritto di selezionare le notizie di interesse: le indagini non nascono
per tale fine, bensì per accertare i reati consumati e toccherà ai giornalisti
ricercare le notizie correttamente, attraverso le fonti possibili.
Infine un’ultima domanda: si
continua a denunciare il rischio di bavaglio all’informazione sulla giustizia,
ma non rilevo affatto che, dall’entrata in vigore del decreto sulla presunzione
d’innocenza, tale informazione abbia patito penalizzazioni di qualsiasi tipo ! O
sbaglio ? Riflettiamo tutti insieme, dunque, su informazione e giustizia, tra
magistrati, avvocati e giornalisti, cercando di risolvere ogni criticità, ma si
eviti per favore di denunciare un’inesistente bavaglio all’informazione come se
vivessimo fuori da una democrazia.
No al decreto sciagurato
che censura i nomi di arrestati e indagati.
La tutela del diritto di
cronaca: occorre rivedere la norma scritta troppo in fretta per evitare la
procedura d’infrazione dall'Ue. Michele Partipilo su La Gazzetta del Mezzogiorno
l'11 Giugno 2022.
Le persone più attente avranno
notato che dalle cronache giudiziarie vanno via via scomparendo i nomi di
persone arrestate o accusate di reati. Apprendiamo che la tale Procura ha
condotto un’indagine che ha portato all’arresto o alla denuncia di un certo
numero di persone, ma non sappiamo chi sono. Fra loro potrebbe esserci il vicino
di casa, un parente, l’insegnante accusato di pedofilia che è anche l’insegnante
di nostra figlia. Ma non lo sapremo. O meglio non lo sapremo ufficialmente,
perché la polizia giudiziaria e i Pm che conducono le indagini non possono più
fornire notizie. Solo il Procuratore della Repubblica può interloquire con i
giornalisti.
Sono gli effetti dello
sciagurato decreto legislativo 188/2021 entrato in vigore il 14 dicembre scorso.
Il decreto nasce per attuare la direttiva europea 2016/343 sulla presunzione
d’innocenza. Si dirà: allora colpa della solita Europa. Nient’affatto, poiché la
direttiva chiede ai Paesi membri solo di adeguare la loro legislazione in modo
da proteggere la non colpevolezza dell’imputato fino a una sentenza e di evitare
anticipazioni di condanna. L’Italia per cinque anni ha ignorato la questione
ritenendo sufficiente quanto previsto dall’articolo 27 della Costituzione
(«L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva») che
risulta più garantista della direttiva Ue in quanto richiede una «condanna
definitiva», mentre per la normativa europea – compresa la Convenzione per i
diritti dell’uomo – è sufficiente che vi sia una condanna, quindi anche solo in
primo grado.
Il decreto legislativo
188/2021 è rivolto alle autorità pubbliche (magistrati, forze di polizia) ma
estende i suoi deleteri effetti sull’informazione e sui giornalisti. Al di là
delle modifiche ad alcuni articoli del codice penale, introduce infatti il
divieto per Pm e polizia giudiziaria di fornire notizie sulle attività di
indagine. Può farlo solo il Procuratore della Repubblica che di volta in volta
deve stabilire quali indagini o quali operazioni di Pg siano meritevoli di
essere comunicate ai media. Lo potrà fare solo con comunicati stampa o,
eccezionalmente, con conferenze stampa, trasformandosi così in addetto stampa
del suo ufficio e caricandosi ogni volta l’onere di individuare quale sia
l’interesse pubblico di un determinato fatto. I giornalisti, poiché non toccati
direttamente dal decreto legislativo, possono continuare ad attingere notizie da
tutte le altre fonti (avvocati, testimoni, parti lese eccetera) ma non potranno
mai verificarle con l’unica fonte diretta e attendibile, cioè con chi ha
condotto le indagini.
A prescindere dalle
considerazioni di natura tecnica che si potrebbero fare circa il rischio di
censura, la difficoltà di stabilire quale sia l’interesse pubblico e via di
seguito, è sufficiente una considerazione pratica: come farà un Procuratore
della Repubblica, che di solito non sta in ufficio a fare i cruciverba, a
valutare ogni singola notizia, a stendere comunicati stampa e diffonderli, a
indire e tenere conferenze stampa? Delle due l’una: o si trasforma in un bravo
addetto stampa o fa il lavoro per il quale ha studiato, ha acquisito competenze
ed è pagato. Il rischio, per non dire la certezza, è che dovrà fare scelte di
comunicazione privilegiando inevitabilmente le indagini relative ai reati più
gravi o di maggior impatto sociale e per evitare richieste di rettifica – che
comportano ulteriore lavoro – tenderà a non fornire nomi se non in casi
eccezionali. Ecco spiegato l’anonimato di molte cronache.
Non solo, ma cominciano a
sparire le notizie relative a indagini o operazioni di polizia che riguardano
reati forse minori, ma di grande impatto sul senso di sicurezza dei cittadini
come furti, scippi, aggressioni, spaccio di droga. Un’assenza che porterà
discredito su magistratura e polizia in quanto, visto che non se ne saprà nulla,
la percezione pubblica sarà che nessuno fa niente per reprimere questi reati.
Che fare? Semplicemente rivedere il decreto legislativo in questione, scritto
troppo in fretta per evitare la procedura d’infrazione da parte dell’Europa. Il
costume italico di fare le cose all’ultimo minuto spesso porta a non ponderare
in maniera attenta gli effetti di certe scelte. Senza contare che questo dlgs
non inciderà sui cosiddetti processi mediatici, che davvero possono
compromettere la presunzione d’innocenza di un accusato, o sulla «gogna
mediatica» cui è esposta una persona che a qualsiasi titolo «entri» in
un’inchiesta.
Nell’impossibilità di
verifiche, le notizie non solo saranno sempre più anonime, ma anche più incerte
facendo riferimento non a fatti verificati ma a supposizioni, deduzioni,
«soffiate» di vario genere. Avranno campo libero tutti i venditori di fumo e gli
odiatori che attraverso i social potranno disinformare a gogo. Tanto nessuno li
potrà smentire con dati certi provenienti da fonti note e attendibili. Col dlgs
188/2021 si amputa di fatto il diritto di cronaca poiché si impedisce al
giornalista di attingere alle fonti – a tutte le fonti – che ritiene utili per
fornire al pubblico notizie veritiere. Uno studioso come Glauco Giostra ha
rilevato che in democrazia «è inconcepibile una giustizia segreta», che
rischierebbe di diventare «torbido strumento di affermazione di parte»,
determinando una «gravissima involuzione civile e democratica».
Ben prima c’era stato tale
Cesare Beccaria che aveva sentenziato che «Il segreto è il più forte scudo alla
tirannia». In questo caso la tirannia sarà quella della informazione
irresponsabile, delle ricostruzioni fantasiose e delle fake news. Con buona pace
per la presunzione d’innocenza.
“Scarcerato il mostro…”.
Così i giornali scatenano la gogna.
Titolano “Scarcerati assassini e spacciatori”, mentre in realtà dopo anni
scontano pene alternative. “Farla franca”, mentre invece sono stati assolti.
Tanti gli articoli che non osservano i doveri deontologici del giornalismo sul
tema penitenziario. Damiano Aliprandi su Il Dubbio il 5 luglio 2022.
Abbiamo la costituzione più
bella del mondo, ma spesso i suoi ideali enunciati rimangono solo sulla carta.
Così come abbiamo il testo unico dei doveri del giornalista, che se venisse
rispettato avremmo una informazione che ci porterebbe al primo posto nel mondo
per la qualità del giornalismo. Invece no. Basti pensare al tema penitenziario.
I detenuti usufruiscono di misure alternative? La maggior parte dei giornali
titolano “Scarcerati assassini e spacciatori”, dando così una percezione errata
all’opinione pubblica, abbassandone il livello e alimentando il populismo
penale. Teoricamente è vietato.
Le terminologie usate danno un
valore negativo ai trattamenti penitenziari verso la libertà
Il giornalista ha il dovere di
usare la giusta terminologia, ma non lo fa più nessuno. Anzi, alcune firme
“rischiano” anche di vincere un premio o addirittura fare corsi di giornalismo.
Sono tante le terminologie che imperversano in numerosi articoli di giornale e
dove si fa anche una effettiva disinformazione dando come valore negativo il
trattamento penitenziario che prevede – tra i vari benefici – l’affidamento al
servizio sociale, la semilibertà o i permessi premi, e quindi una graduale
proiezione verso la libertà.
Nel 2013 è stata approvata la
“Carta di Milano’’, relativa ai diritti dei detenuti
In realtà nel 2013 il
Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti ha approvato all’unanimità la
“Carta del carcere e della pena” o più semplicemente la “Carta di Milano’’,
relativa ai diritti dei detenuti, che diventa così un protocollo deontologico
obbligatorio per tutti i giornalisti italiani. La “Carta di Milano” ha una
origine particolare: viene dal basso, non direttamente dall’Ordine dei
giornalisti. È, infatti, il risultato di una lunga riflessione, nata dai
giornalisti interni alle carceri, dagli operatori dell’amministrazione
carceraria e dagli stessi detenuti a partire dal 2011.L’esigenza di uno
strumento regolativo sull’informazione carceraria viene inizialmente maturata in
tre regioni: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Le tre redazioni carcerarie
promotrici della sua nascita erano state, rispettivamente, quella di Carte
Bollate, periodico diretto da Susanna Ripamonti all’interno del carcere di
Bollate, quella di Ristretti orizzonti, giornale diretto da Ornella Favero e
promosso dalla Casa di reclusione di Padova e dall’Istituto di Pena Femminile
della Giudecca e quella di Sosta forzata, rivista della Casa circondariale di
Piacenza, diretta da Carla Chiappini.
Numerosi sono stati, in
seguito, i seminari sulla rappresentazione mediatica del carcere, organizzati
nei mesi di marzo e aprile 2011 dalla redazione di carte Bollate e rivolti sia
agli allievi del Master di giornalismo dell’Università Iulm e dell’Università
statale di Milano, sia ai giornalisti professionisti. L’obiettivo di questi
incontri era quello di sensibilizzare maggiormente il bisogno di un’informazione
deontologicamente corretta nei confronti di chi vive tutti i giorni nel mondo
carcerario o a contatto con esso.
Nel corso del 2012 la Carta si
è diffusa progressivamente in tutta Italia ed è stata sottoscritta anche dagli
Ordini dei giornalisti di Toscana, Basilicata, Liguria, Sardegna e Sicilia. La
Carta, però, era valida ancora solamente a livello regionale. La spinta
definitiva alla sua approvazione a livello nazionale è avvenuta l’ 8 gennaio
2013, data in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia
per violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel
trattamento dei detenuti.
La Carta riafferma il dovere
fondamentale di rispettare la persona detenuta
La sensibilità comune nei
confronti delle condizioni degradanti del mondo carcerario, inoltre, è aumentata
notevolmente in seguito al discorso pronunciato dall’allora presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione della visita alla casa
circondariale di San Vittore, avvenuta il 6 febbraio 2013. L’ 11 aprile 2013,
con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti, la “Carta di Milano” è diventata ufficialmente un protocollo
deontologico obbligatorio per tutti gli operatori dell’informazione. La Carta
riafferma il dovere fondamentale di rispettare la persona detenuta e la sua
dignità, contro ogni forma di discriminazione, tenendo ben presente i principi
fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Costituzione
italiana e dalla normativa europea.
La Carta raccomanda ai
giornali l’uso di termini appropriati
Raccomanda l’uso di termini
appropriati in tutti i casi in cui il detenuto usufruisca di misure alternative
al carcere o di benefici penitenziari, un corretto riferimento alle leggi che
disciplinano il procedimento penale, una aggiornata e precisa documentazione del
contesto carcerario, un responsabile rapporto con il cittadino condannato non
sempre consapevole delle dinamiche mediatiche, una completa informazione circa
eventuali sentenze di proscioglimento e tenere conto dell’interesse collettivo
ricordando, quando è possibile, i dati statistici che confermano la validità
delle misure alternative e il loro basso margine di rischio. Tutto ciò non viene
rispettato. Non solo. Si arrivano a riportare vere fake news, ma l’Ordine dei
giornalisti che dovrebbe vigilare, non ha mai fatto nulla. La deontologia rimane
così un optional e la cultura del nostro Paese scivola sempre più in basso.
Nel processo mediatico
l’indagato è diventato “un colpevole in attesa di giudizio…”
Nel prezioso saggio del professor Vittorio Manes le degenerazioni della nostra
giustizia penale. Valentina Stella su Il Dubbio il 24 maggio 2022.
Dal 5 maggio è in libreria il
nuovo saggio di Vittorio Manes, avvocato e professore ordinario di Diritto
penale all’Università di Bologna, dal titolo Giustizia mediatica – Gli effetti
perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo (Il Mulino, pagine 168,
euro 15). La premessa dell’autore non lascia dubbi: «La giustizia penale è
diventata spettacolo». Non siamo dinanzi a pura e semplice informazione o
cronaca giudiziaria, «ma anche autentico intrattenimento, sempre più incline al
voyeurismo giudiziario». È il cosiddetto processo mediatico parallelo, senza
tempo, senza spazio, senza regole rispetto a quello che si celebra nelle aule di
tribunale, che condanna prima di una sentenza definitiva.
Infatti, scrive
l’autore, l’indagato si trasforma in «un colpevole in attesa di
giudizio» assoggettato «a un’immediata degradazione pubblica» e avviato «a
un’irrefrenabile catàbasi personale e professionale». A venire profondamente
lesa è dunque prima di tutto la garanzia della presunzione di innocenza. A causa
della «curvatura inquisitoria» del trial by media, l’onere della prova si
inverte: non sarà più il pm a dover provare la colpevolezza dell’imputato ma la
difesa la sua innocenza. Il dubio pro reo si rovescia nel dubio pro republica.
In questa mise en scene delle indagini e del dibattimento su stampa e in tv, ad
essere coinvolti sono tutti i soggetti del processo.
La vittima, prendendo in
prestito una definizione di Filippo Sgubbi, è per Manes «l’eroe moderno, ormai
santificato», istituita come tale «ante iudicium, ma anche fortemente
protagonizzata a scapito del presunto reo». Come co- protagonista troviamo il
magistrato dell’accusa: «sedotto dall’ammaliante convinzione che vincere nei
cuori della gente può essere – e molto spesso è più importante che vincere in
aula» il pubblico ministero diviene «il tribuno dei diritti della vittima o
comunque paladino delle aspettative pubbliche». E l’avvocato? Molto interessante
la doppia rappresentazione che ci restituisce Manes: «Anche l’avvocato può
occupare un ruolo di rilievo, anche se questo è molto diverso a seconda della
posizione processuale rivestita e dalla parte che assiste, che può condurlo ad
agire o patire il processo mediatico. Se tutela l’interesse della vittima – o se
opera come patrono di parte civile – può fruire di riflesso del protagonismo di
questa, e non di rado può lasciarsi irretire dalla forza seduttiva dei media
sino a prendere parte a programmi di informazione, di infotainment o a talk show
contribuendo bon gré mal gré alla spettacolare ricostruzione collaterale dei
fatti. Al netto di ogni valutazione deontologica, quando l’avvocato si presta a
questo gioco lo fa però a suo rischio e pericolo, perché difficilmente governerà
le correnti di opinione che si agitano nel vortice mediatico, dove il passo dai
Campi Elisi alle paludi dello Stige può essere davvero breve». Se viceversa
tutela l’indagato l’avvocato «versa in una posizione decisamente scomoda: il
rovesciamento della presunzione di innocenza lo colloca in posizione di ‘
minorata difesa’, se non sostanzialmente “fuori gioco”».
Non è immune al bombardamento
mediatico persino il giudice che, nonostante il suo corredo professionale, si
sentirà inevitabilmente chiamato a dire da che parte sta, se dalla parte della
pubblica opinione o dalla parte degli indagati che la vox populi considera già
presunti colpevoli. Ormai nel nostro sistema assolvere o derubricare un reato è
divenuto un atto di coraggio.
Tutto questo ha pertanto delle
ricadute sul piano processuale: oltre all’eclissi della presunzione di innocenza
si assiste anche alla lesione del diritto di difendersi nel contraddittorio tra
le parti. L’autore allude, ad esempio, «al rischio che la parodia televisiva
eserciti una silenziosa manipolazione del ricordo nei soggetti chiamati a dare
il loro contributo testimoniale, e che tale alterazione conduca a quella che è
stata finemente descritta come una sorte di subornazione mediatica». Di fronte a
tale scenario perde ogni efficacia maieutica lo strumento di verifica
dell’attendibilità del teste, il cosiddetto contro esame.
Per non parlare poi del
rischio di condizionamento irreversibile della stessa persona offesa. Come
invertire la rotta? Manes suggerisce «un approccio rights-based» da parte della
magistratura e della stampa che permetta di bilanciare, anche in linea con le
disposizioni europee, l’interesse pubblico ad essere informati con il rispetto
dei diritti fondamentali delle persone coinvolte in una indagine e/ o processo.
Il processo mediatico?
Colpa degli avvocati. Parola di Salvi.
Presunzione d’innocenza, il pg
di Cassazione: «La comunicazione non va abbandonata alla disponibilità delle
parti private, non hanno obbligo di correttezza nell’informazione». Simona Musco
su Il Dubbio il 16 aprile 2022.
Il processo mediatico? Colpa
degli avvocati. A sostenerlo è il procuratore generale della Cassazione Giovanni
Salvi, in un documento con il quale definisce gli orientamenti della Suprema
corte in materia di comunicazione istituzionale sui procedimenti penali.
Ben vengano il rispetto della
presunzione d’innocenza e della dignità della persona, afferma il pg – che, è
bene ribadirlo, è anche il titolare dell’azione disciplinare a carico dei
magistrati – ma la direttiva europea recepita dal governo italiano, che impone
ai capi delle procure una comunicazione più sobria, avrebbe come effetto quello
di lasciare tutto in mano alle parti private – gli avvocati, appunto –, con il
rischio «che il processo si svolga non nelle aule di giustizia, ma in quelle dei
mezzi di comunicazione di massa».
Il tutto, aggiunge Salvi,
«senza alcun contraddittorio in grado di ripristinare, non si dice la parità
delle armi, ma almeno la verità di quanto accertato nelle aule giudiziarie
rispetto alle prospettazioni mediatiche delle parti».
Insomma, in 10 pagine Salvi
ribadisce quanto già affermato al convegno di “Giustizia Insieme”, quando aveva
evidenziato che «il pubblico ministero e il giudice devono contrastare le
informazioni errate e fuorvianti che vengono fornite dalle parti che non hanno
obbligo di verità, non hanno obblighi specifici di correttezza. Anche questa è
una cosa che dobbiamo discutere: il difensore ha obbligo di verità? Ha obbligo
di correttezza? Non so, è un tema però che forse va posto, perché non è
possibile che la disciplina sia solo quella del magistrato».
Il suo pensiero, ora, viene
condiviso con tutti i procuratori delle Corti d’Appello e tramite loro con i
capi di tutti gli uffici inquirenti d’Italia, che useranno proprio questa
circolare per applicare la direttiva sulla presunzione d’innocenza. Salvi ha
ricordato che informare l’opinione pubblica «non è un diritto di libertà del
magistrato del pubblico ministero o del giudice, ma è un dovere preciso
dell’Ufficio». Che dovrà, certamente, preoccuparsi di fornire un’informazione
«corretta e imparziale», «rispettosa della dignità della persona», «completa ed
efficace», oltre che rispettosa della segretezza di alcuni atti. Ma senza nessun
altro limite.
E la presunzione di innocenza,
dunque, «non deve comportare che la comunicazione sia interamente abbandonata
nella disponibilità delle parti private, nel corso del procedimento; parti per
le quali non è invece posto alcun obbligo di rispetto di canoni seppur minimi di
correttezza nella informazione».
Il rischio è, appunto, il
processo mediatico, del quale il pg dà la colpa ai soli avvocati, nonostante il
loro ovvio interesse a garantire il rispetto della presunzione d’innocenza e
nonostante siano stati proprio i magistrati, negli anni, a monopolizzare la
comunicazione, sia sulla carta stampata sia nei salotti televisivi, spesso
presentando come colpevoli i semplici indagati.
E Salvi critica anche «il
sempre più frequente commento mediatico alla decisione del giudice, in termini
spesso offensivi e aggressivi». Condotte che, se poste in essere dai magistrati,
«costituiscono illecito disciplinare», mentre non esisterebbero «sanzioni
analoghe» nei confronti dei difensori delle parti private. Da qui l’invito ai
colleghi a segnalare ai Consigli di disciplina forense tali condotte «nei casi
gravi».
La diffusione di informazioni
sui procedimenti penali «è consentita solo quando è strettamente necessaria per
la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse
pubblico», ribadisce il pg. Sarà il procuratore a stabilire quando tale
interesse sussista, sulla base di «circostanze fattuali, temporali, e
territoriali che non possono essere univocamente previste». Di conseguenza la
scelta «non può essere sindacata, se non nei casi di palese irragionevolezza».
Insomma, il margine d’azione
rimane amplissimo, secondo l’interpretazione data da Salvi alla direttiva e al
decreto che le dà attuazione. E se è necessario motivare la convocazione di una
conferenza stampa, tale obbligo anche per i comunicati stampa sarebbe
irragionevole, in quanto contrasterebbe non solo con la norma, ma anche «con la
tutela dell’interesse pubblico all’informazione, avente certo rilievo
costituzionale».
Non sono vietate le
interviste, anche perché, «come per qualunque altro cittadino, la manifestazione
del pensiero è libera e costituzionalmente garantita» dall’articolo 21 della
Carta. «Ad essere regolamentata è soltanto la comunicazione “istituzionale”»,
afferma Salvi, ma va «evitata ogni indebita espressione di opinioni,
considerazioni e notizie, che ove non trasfuse negli atti dell’indagine divenuti
sino a quel momento pubblici, deve considerarsi illecita».
Ogni violazione della
presunzione d’innocenza si trasformerebbe, comunque, in violazione degli scopi e
della lettera della direttiva, «con ogni conseguenza». La comunicazione diretta
con il giornalista è dunque lecita, ma «non deve trattare delle posizioni di
singoli indagati», mentre sono “vietate” interviste, «specialmente in esclusiva,
volte alla trattazione di questioni inerenti singoli procedimenti o specifiche
posizioni processuali».
Sarà possibile ancora
consegnare ai giornalisti copie delle ordinanze di custodia cautelare, ma non
gli atti di indagine. Ma nel redigere l’ordinanza, il giudice ha «il dovere
della presentazione degli elementi indiziari a carico dell’indagato in termini
tali da un lato, da giustificare l’adozione di un provvedimento restrittivo
della libertà personale, e dall’altro da lasciare impregiudicata la presunzione
di innocenza».
Ci mancava pure la gelosia
per i penalisti “esonerati” dal riserbo sulle indagini.
Le nuove norme sulla presunzione d’innocenza sono sgradite ai pm anche perché
non estese agli avvocati penalisti. Valentina Stella Il Dubbio l'11 aprile 2022.
Partiamo da alcuni dati: una
ricerca condotta qualche anno fa da parte dell’Osservatorio Informazione
giudiziaria dell’Unione Camere penali, presieduto ai tempi da Renato Borzone, in
collaborazione con il dipartimento di Statistica dell’Università di Bologna, ha
rilevato che il contenuto degli articoli di cronaca giudiziaria «è fondato
essenzialmente su fonti di carattere accusatorio (circa il 70% degli articoli
non riporta la difesa quale fonte di informazione), e comunque larga parte di
esso è, ancora una volta, modellato sulle tesi d’accusa, siano esse oggetto di
apprezzamento e consenso o di mera esposizione». Inoltre, sempre quella ricerca
ci disse che oltre il 60% delle notizie riguarda l’arresto e le indagini
preliminari, solo l’11% la sentenza. Quindi, a causa di una certa stampa
“embedded” presso le Procure, in questi anni abbiamo assistito a un racconto
unilaterale delle vicende giudiziarie, dimenticandoci della fase del
dibattimento.
Sapete invece cosa teme ora
parte della magistratura? Che saranno gli avvocati a prendersi la scena e/o a
divenire le nuove fonti privilegiate della stampa, visto che la direttiva ha
imposto dei limiti alla comunicazione della magistratura requirente e alla forze
di polizia giudiziaria. La preoccupazione è emersa anche recentemente in un
interessante convegno organizzato da “Giustizia Insieme”, la “piattaforma
permanente dedicata al confronto tra magistrati, avvocati, studiosi del diritto
e società civile”, dal titolo Processo mediatico e presunzione di innocenza (lo
potete riascoltare su Radio radicale). Durante uno dei panel è stata sollevata,
anche giustamente, la seguente questione dalla dottoressa Donatella Palumbo, pm
alla Procura di Lecce: considerato che la norma si riferisce alle autorità
pubbliche, le fonti del giornalista potrebbero ora essere in maniera prevalente
le difese e/o le parti offese, che non rientrano in quella categoria. In pratica
ci si è chiesto se non possa verificarsi una indiretta lesione della presunzione
di innocenza.
In altri contesti altri
magistrati hanno rilevato che, già prima dell’entrata in vigore della norma, a
contattare i giornalisti sono stati spesso gli avvocati per farsi pubblicità.
Pur di incassare una citazione su un giornale, alcuni difensori sarebbero capaci
di danneggiare persino la reputazione dell’assistito, hanno detto. Siccome in
ogni categoria c’è sempre qualcuno che agisce in maniera poco ortodossa,
possiamo anche immaginare che in alcuni casi sia così. Ma di certo, come ha
sottolineato recentemente in un altro convegno l’avvocato Lorenzo
Zilletti, responsabile del Centro studi giuridici “Aldo Marongiu” dell’Unione
Camere penali, «non è paragonabile il fenomeno delle conferenze stampa o delle
veline delle Procure con i comportamenti deontologicamente scorretti tenuti in
modo occasionale da avvocati spregiudicati. Il lettore del giornale o lo
spettatore del tg sono certamente più influenzati dalla comunicazione ufficiale
della pubblica autorità che non dalla notizia filtrata ai giornalisti da altre
fonti». Anche perché nella fase interessata dalla normativa, ossia quella delle
indagini preliminari, gli avvocati non hanno tutte le informazioni di cui
dispone invece il pubblico ministero. Certo, un problema potrebbe essere
generato dalla mediatizzazione delle parti civili e delle persone offese prima
del processo.
Apriamo una parentesi: non ha
torto il professore e avvocato Ennio Amodio quando sostiene che nel processo
penale la presenza della parte civile costituisce un aspetto incompatibile con
il rito accusatorio, in quanto la difesa deve giocare una partita contro
l’accusa e contro la parte civile, avendo davanti a sé anche un giudice non
sempre terzo e imparziale. Chiusa la parentesi, pensiamo ad esempio ai casi di
violenza sessuale. Abbiamo visto tante trasmissioni televisive con le presunte
vittime in studio a raccontare la loro esperienza e i loro avvocati in
collegamento. Questa è sicuramente una profonda distorsione della comunicazione
giudiziaria, tesa a ledere la presunzione di innocenza. Ma comunque: esiste
davvero il rischio che oggi a condurre la narrazione giudiziaria ci siano altri
protagonisti con lo stesso potere mediatico delle Procure? Ora andiamo verso una
inversione di tendenza? Impossibile, per le ragioni che vi abbiamo esposto.
Piuttosto, come ha sottolineato il direttore scientifico di “Giustizia Insieme”,
il dottor Roberto Conti, occorre promuovere una «leale cooperazione» fra «i
diversi attori nella rappresentazione della giustizia, lasciando ai margini
atteggiamenti assolutistici, onniscenti, a volte supponenti e boriosi di coloro
che, pur legittimamente espressivi di una di quelle verità, la contrabbandano
come l’unica verità. Tutto questo impone dunque una grande dose di coraggio in
tutti i protagonisti».
Eppure durante lo stesso
convegno di “Giustizia Insieme”, il procuratore generale della
Cassazione Giovanni Salvi ha tirato in ballo sempre l’avvocatura: «Per il
magistrato informare è un dovere, non è un diritto. Resta ancora inaffrontato il
tema del processo mediatico, perché il pubblico ministero e il giudice devono
contrastare le informazioni errate e fuorvianti che vengono fornite dalle parti
che non hanno obbligo di verità, non hanno obblighi specifici di correttezza.
Anche questa è una cosa che dobbiamo discutere: il difensore ha obbligo di
verità? Ha obbligo di correttezza? Non so, è un tema però che forse va posto,
perché non è possibile che la disciplina sia solo quella del magistrato».
Innanzitutto sarebbe interessante capire come si concilia il dovere comunicativo
evocato da Salvi con le recenti parole del presidente della Repubblica, e del
Csm, Sergio Mattarella: «A voi», ha detto rivolto ai giovani magistrati, «è
chiesto di amministrare la giustizia con professionalità e con riserbo». Per il
resto, la sensazione è che alla magistratura non solo dia fastidio questa nuova
norma, come spesso vi abbiamo raccontato, ma che il fastidio aumenti perché ad
esserne interessati sono solo i magistrati e non anche gli avvocati. Si sta
guardando forse il dito e non la luna?
La polvere sotto il
tappeto. I pm demagoghi contro la presunzione d’innocenza, l’assurdo argomento
che qualcuno vuole “tappargli la bocca”.
Otello Lupacchini su Il
Riformista il 3 Aprile 2022.
Aristotele, nei Topici [VIII
164b], raccomanda di non discutere con chiunque, perché, in realtà, quando si
discute con certe persone, le argomentazioni divengono necessariamente scadenti:
quando ci si trova di fronte a un interlocutore, che cerca con ogni mezzo di
uscire indenne dalla discussione, lo sforzarsi di concludere la dimostrazione
sarà certo giusto, ma non risulterà comunque elegante. Per questa ragione,
dunque, eviterò di confrontarmi con faciloneria coi primi venuti, poiché non
intendo giungere a discussioni velenose e voglio evitare confronti agonistici.
In fondo, che senso avrebbe, per esempio, opporre a chi polemizza a proposito
del d.l.gs 188/2021 sulla presunzione di innocenza, arrivando ad affermare, con
buona pace della necessità incontrovertibile di tutelare gli imputati, che non
possono definirsi colpevoli fino alla sentenza definitiva, che la nuova legge «A
me non (…) chiude la bocca. Sono una persona che non ha timore di niente e di
nessuno, dico sempre quello che penso e se non posso dire la verità è perché non
posso dimostrarla. Continueremo a parlare e a spiegare all’opinione pubblica,
che ne ha diritto.
Ancora in Italia non è stato
negato il diritto di informazione della stampa», che uniche danneggiate dalla
legge stessa sarebbero «certe Procure, che fino ad oggi hanno campato sul
marketing giudiziario, che è quanto ci possa essere di più pericoloso, incivile,
illiberale e arbitrario per far conoscere ed apprezzare un prodotto parziale,
non verificato, non definitivo: l’accusa»? Nessuno, se non magari quello di
radicalizzare le posizioni senza costrutto. Il primo ribadirebbe, infatti: «non
ho alcun dubbio sugli effetti negativi della legge sulla presunzione di
innocenza (…), che vieta a pm e polizia giudiziaria di “indicare come colpevole”
l’indagato o l’imputato fino a sentenza definitiva, e impone ai procuratori di
parlare con la stampa solo tramite comunicati ufficiali». Il vero problema,
aggiungerebbe, è che la rilevanza sociale del diritto all’informazione e del
diritto alla verità delle vittime di gravi reati rischia di essere offuscata da
un sistema che impedisce di spiegare ai cittadini l’importanza dell’azione
giudiziaria nei territori controllati dalle mafie, rendendo molto più difficile
creare quel clima di fiducia che consente alle vittime di rompere il velo
dell’omertà. Ed esternerebbe, finalmente, il timore che «non parlandone,
la ’ndrangheta e Cosa Nostra non esistano»; la paura che «di questo “silenzio
stampa” le mafie ne approfitteranno, perché le mafie da sempre proliferano nel
silenzio»; non senza aggiungere: «Se la ’ndrangheta oggi è la mafia più potente
è perché per anni non se ne è parlato. Molte notizie, anche su politici e
funzionari pubblici, verranno così nascoste». A questo punto, occorrerebbe
involgersi in faticose spiegazioni di teoria generale del processo, peraltro con
poco profitto per l’interlocutore, che, ne sono convinto, s’annoierebbe
moltissimo.
Il problema, piuttosto, è un
altro. Non vi è giorno, infatti, in cui non sia dato di constatare
l’organizzazione scientifica della ciarlataneria. Le ragioni che inducono a una
così cupa constatazione sono le più svariate, non ultima, se non addirittura la
prima fra tutte, che l’uomo non sa più tacere: se il silenzio è d’oro, parrebbe
proprio che questo prezioso metallo sia scomparso dalla circolazione spirituale
come da quella monetaria. Nel Vangelo si rinviene l’ammonimento che, «nel giorno
del giudizio, gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno
detta» (Mt., 12, 36). E anche Martin Heidegger, uno dei più forti pensatori
dell’esistenzialismo tedesco, si richiama alla parola, allorché distingue fra la
vita autentica, quella cioè di chi vive nella contemplazione della morte, e la
vita non autentica, che è quella di chi volge gli occhi da un’altra parte, non
osando pensare alla sua fine: nel descrivere questo secondo tipo di vita, non
degna d’essere vissuta, il filosofo ricorre a una parola francese, di non facile
traduzione nella nostra lingua, il «bavardage». In sostanza, «bavarder» vuol
dire ciarlare, ma l’idea precisamente è quella che si legge nel Vangelo: parlare
ozioso. Per pensare si deve essere in due e le parole servono a far pensare;
oziose, dunque, sono le parole che non riescono a far pensare, a produrre delle
idee, le quali, per essere tali, devono consentire di scoprire qualcosa di nuovo
nel mondo. Quelle provocate dal bavardage sono, pertanto, pseudo-idee: esse non
fanno procedere d’un passo la conoscenza; dopo un’ora di ciarle, infatti, le
persone si lasciano più vuote di prima.
Le parole oziose, pur non
facendo pensare, non impediscono di pensare. Occorre chiedersi, però, se ci
siano parole che impediscono di pensare; se l’abuso della parola possa arrivare
al punto di cavarne il risultato contrario a quello per cui è stata creata; se,
insomma, la parola strumento di libertà possa stravolgersi in parola strumento
di servitù. Che la parola sia strumento di libertà, muovendo dalla libertà di
chi parla e sollecitando la libertà di chi ascolta, è espresso dal verbo latino
«suadere», che in italiano si rafforza e diventa persuadere, parole che evocano
la «suavitas». Non è, dunque, un caso che al fine d’ottenere l’effetto
persuasivo occorra soavità: la scelta e il tono delle parole, là dove si voglia
sollecitare e non sopprimere la libertà dell’altro, giovano più di quanto non si
creda. Il mezzo del persuadere è suggerire; offrire cioè un’idea, che l’altro
possa far propria se gli piace o respingere se non gli piace; ma quest’idea
dev’essere offerta in modo così discreto che neppure s’adombri un’offesa alla
libertà dell’altro, il quale la possa far sua come s’egli stesso l’avesse
pensata. L’uomo non pensa che il pensiero proprio; se il proprio coincide con
l’altrui, ciò non può avvenire se non in quanto l’altrui sia liberamente
accettato. Se non pensare, l’uomo può agire in virtù del pensiero altrui.
Così avviene quando il
costringere prende il posto del persuadere. Il problema è, allora, se si possa
costringere con le parole. L’esperienza della nostra realtà contemporanea è lì a
dimostrare che si può abusare delle parole; e questo è uno dei suoi aspetti più
sconcertanti e pericolosi. Nulla è più lontano dal persuadere che il discorso di
uno dei quei venditori sulle piazze, ai quali si dà il nome di ciarlatani. La
differenza fra il discorso del ciarlatano e un discorso persuasivo è la stessa
che corre fra il rumore e l’accordo. Arthur Schopenhauer, per sostenere che «la
vista è un senso attivo e l’udito un senso passivo», ha scritto che «i suoni
agiscono disturbando e agitando il nostro spirito (…) distraggono tutti i
pensieri, sconvolgono momentaneamente la forza del nostro pensiero».
L’osservazione, evidentemente sbagliata per il suono, è giusta comunque per il
rumore, che quando raggiunge la misura del fracasso impedisce di pensare. La
ciarlataneria, rispetto al passato, ha oggi assunto nuove forme: i Dulcamara non
s’incontrano più neppure sui mercati di campagna e quella che un tempo si
chiamava «réclame» si è via via meglio truccata sotto il nome di «propaganda»,
la cui tecnica è oggi fondata sulla ripetizione.
L’essenza del ciarlatano,
infatti, non è più il rumore, ma il ronzio, che di quello è di gran lunga
peggiore: qui non si tratta più di suggerimento, ma di suggestione. La
propaganda, portando un attentato alla libertà dell’uomo è pur sempre un male.
Piccolo, magari, se riguarda la scelta di una merce, ma intollerabile quando
riguarda la scelta delle forme e delle norme della struttura sociale, essenziali
alla nostra vita, perché, come diceva Heidegger, il nostro «Sein» è «Mit-sein»,
il nostro essere è essere insieme. E questo esige una regola, un regime o meglio
sarebbe dire un reggimento, che risulti dall’accordo di tutti quanti
costituiscono l’insieme. L’accordo di tutti presuppone la libertà di ciascuno. E
questo vuol dire democrazia, la quale esigendo che ognuno pensi con la propria
testa, favorisce sì l’eloquenza e la persuasione, ma rifiuta la propaganda,
poiché essa offende la libertà. In linea d’abuso della parola, il bavardage, la
ciarla, il pettegolezzo non costituiscono il danno più grave: il ciarliero è
meno nocivo del ciarlatano, poiché il primo, che si limita a non pensare, rovina
sé stesso, mentre il secondo rovina gli altri, ai quali impedisce di pensare. E
fino a quando non si sentirà l’esigenza di liberarsi degli imbonitori da fiera,
lasciando finalmente spazio soltanto a indicazioni sobrie e decorose, rispettose
della dignità dei contendenti e della libertà dei cittadini, la democrazia non
potrà essere che un’illusione.
Otello Lupacchini.
Giusfilosofo e magistrato in pensione
Il sistema da cambiare.
Errori giudiziari, vite distrutte e 50 euro di risarcimenti ogni minuto.
Viviana Lanza su Il
Riformista il 17 Aprile 2022.
Il dilemma sulla giustizia, la
riforma da approvare, il sistema da cambiare, i privilegi da azzerare, i diritti
da tutelare. In questo periodo si fa un gran parlare di giustizia, diritti e
magistratura. Si discute di referendum, di riforma della giustizia, di interessi
di casta (quella dei magistrati), di aspetti da modificare o da conservare. E
intanto, ogni minuto che passa, dalle casse dell’Erario escono 50,28 euro per
risarcire chi ha subìto una custodia cautelare da innocente. «Non è poco, vero?
Ma allora perché invece di pagare e basta non si cercano soluzioni concrete ed
efficaci per ridurre il problema all’origine?», si legge sulla pagina
dell’associazione Errorigiudiziari.com, l’associazione fondata da Benedetto
Lattanzi e Valentino Maimone che da oltre vent’anni si occupano di raccogliere
dati e storie su casi di malagiustizia.
Come non concordare con questa
loro osservazione… Perché non si cercano soluzioni? E perché di errori e vittime
di ingiustizie si parla così poco, quasi per nulla? Nel dibattito sulla
giustizia, infatti, tra i temi centrali non c’è quello relativo agli errori
giudiziari. Come se le migliaia di vite distrutte da indagini frettolose o
sbagliate, da accuse poi rivelatesi infondate, da misure cautelari applicate
senza che ve fosse effettivo bisogno non fossero un macigno per la nostra
giustizia. Già di per sé la custodia cautelare preventiva è una condanna
anticipata che contiene il seme dell’ingiustizia, perché tra i presupposti su
cui si fonda c’è quello del rischio di reiterazione del reato. Vuol dire che si
fonda su un sospetto che a sua volta si basa su un altro sospetto. Perché
immaginare che una persona indagata possa reiterare il reato di cui è sospettata
equivale a dare per scontato che quel reato sia stato commesso e quindi che può
essere commesso di nuovo. E questo – è evidente – va contro la presunzione di
innocenza prevista dalla nostra Costituzione, perché una persona indagata non è
detto che sia colpevole.
La statistica giudiziaria ci
dice che non lo è nell’oltre il 40% dei casi. Basterebbe poi ricordare
quante ingiuste detenzioni ci sono ogni anno per capire le proporzioni del
fenomeno e i motivi per cui dovrebbe essere un tema tutt’altro che da ignorare
nelle riflessioni su giustizia e riforma. Secondo le statistiche elaborate
da Errorigiudiziari.com sulla base di dati ministeriali, negli ultimi trentuno
anni le persone innocenti, risarcite o indennizzate in quanto vittime
di ingiuste detenzioni o di errori giudiziari, sono state in Italia 30.231.
«Tanti da riempire fino all’ultimo strapuntino lo stadio di Torino», sottolinea
l’associazione Errorigiudiziari.com per rendere meglio l’idea di ciò di cui si
parla. Dal 1992 al 2020 la media annua di cittadini che sono finiti in carcere
da innocenti oppure che sono stati processati e condannati da innocenti è di
1.015 casi. Per niente pochi. Volendo puntare la lente su Napoli e provincia
bisogna calcolare che le statistiche locali si aggirano attorno al 10% del dato
nazionale. Negli ultimi anni la media delle sole vittime di ingiuste detenzioni
a Napoli non è scesa al di sotto dei 100 casi.
Più numerose che in altre
città italiane. Ora, è vero che Napoli e il suo distretto giudiziario fanno
riferimento ad aree ad alto tasso criminale ed è quindi vero che paragonare i
processi di Napoli con quelli di Firenze per esempio non ha senso perché si
tratta di processi con una complessità e un numero di imputati tato diversi da
non poter essere equiparati, ma è anche vero che un innocente in carcere è
uguale in qualsiasi parte del mondo e che un innocente in carcere è un peso che
la magistratura spesso si scrolla troppo facilmente di dosso. Un peso che invece
finisce per essere un macigno sulle spalle delle vittime, le quali patiscono
tutte le conseguenze delle loro vite stravolte da arresti o processi ingiusti, e
un fardello per la comunità, che si trova a pagare il costo sociale ed economico
di queste conseguenze. Secondo recenti statistiche, nell’ultimo anno i casi di
ingiusta detenzione sono stati 565 nel nostro Paese per una spesa complessiva e
già liquidata in indennizzi pari a 24.506.190 euro.
Un numero che appare in calo,
se confrontato con quelli degli anni precedenti, ma che va letto anche tenendo
conto degli effetti della pandemia che hanno rallentato un po’ tutta la macchina
giudiziaria, incluso il lavoro delle Corti d’appello incaricate di definire le
istanze di riparazione per ingiusta detenzione. Per quanto riguarda, invece, gli
errori giudiziari, e quindi i casi di processi che si sono definiti con condanne
poi annullate in seguito a una revisione che ha stabilito l’infondatezza delle
accuse su cui si basavano, nell’ultimo anno si sono contati sette casi, nove in
meno rispetto all’anno precedente. Un numero che finalmente inverte la tendenza
degli ultimi anni quando la media degli errori giudiziari non era mai al di
sotto dei dieci casi annui. E di fronte a tutti questi numeri, vale ricordare
che le valutazioni di professionalità positiva dei magistrati si attestano
ancora attorno al 99,2%. Un record.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Errori giudiziari,
un’ecatombe intollerabile in uno Stato di Diritto.
C’è una media annuale di mille
indennizzi per ingiusta detenzione, ma sarebbero più del doppio considerando chi
per legge non ne ha diritto. Mimmo Gangemi su Il Dubbio il 31 marzo 2022.
“Ci sarà pure un giudice a
Berlino”. La frase, attribuita a Bertolt Brecht, è l’accorata speranza di un
uomo qualunque che confida in una giustizia imparziale. Lui, un mugnaio, la
trovò, in Federico II il Grande, re di Prussia. E la trovò nel XVIII secolo. Nel
XXI troppo spesso non succede. E imperversa l’errore giudiziario. Che è
argomento tabù, con la valenza del reato di lesa maestà nei confronti di chi –
pochi e tuttavia incidenti sull’opinione pubblica – presume d’essere alle
dirette dipendenze del Padreterno, si crede investito della missione di
anticipare in terra il giudizio divino.
Numerose le Procure nelle
quali sono incrostate sacche di resistenza, con personaggi per nulla
intenzionati a schiodarsi dalla destra del Padre, che pure tira calci per non
averceli al fianco, e ossessionati dalla smania malaticcia di ottenere
risultati, meglio se eclatanti, su nomi di rilievo, in grado di smuovere
carriere che altrimenti stenterebbero. L’errore giudiziario merita
approfondimenti. Occorre ripristinare la verità completa, correggendo i numeri,
fin qui calcolati per difetto.
I dati
Uno studio del Corriere della
Sera ha determinato che dal 1992 al 2016 in Italia si sono verificati 24 mila
rimborsi per ingiusta detenzione e che la cifra corrisposta fu di 648 milioni di
euro, con la maggiore incidenza in Calabria. Il dato si è mantenuto pressoché
costante, come si evince dalle relazioni annuali del ministero della Giustizia
al Parlamento. E la media annuale di 1.000 indennizzi riparatori, comunque
allarmante, porta a ritenere che 1.000 siano stati anche gli arresti
ingiustificati. Sbagliato. Perché è lontana da quella reale che, a occhio ma non
tanto, si attesta almeno al doppio, essendoci i respingimenti e le mancate
richieste, pur a fronte di assoluzioni piene.
Non hanno infatti diritto al
risarcimento quanti, in seguito riconosciuti estranei ai delitti contestati,
nella fase istruttoria si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e quanti
avevano solide premesse di colpevolezza, indizi a sfavore da aver indotto gli
inquirenti alla valutazione scorretta, con quest’ultimo che è un elemento
soggettivo, in teoria applicabile a chiunque. Ed ecco che i 1.000 diventano
2.000, 2.500. Ecco che i 28 mila si trasformano in 60 mila, 70 mila. È
tollerabile una simile ecatombe in una democrazia, in uno Stato di diritto? No.
Eppure, nonostante Francesco Carnelutti, insigne giurista e accademico, per il
quale “La sentenza di assoluzione è la confessione di un errore giudiziario”,
mai compaiono colpe da contestare, provvedimenti sanzionatori, nemmeno un
buffetto, un vago rimprovero, un distinguo, e la dice lunga che la Consulta
abbia bocciato il referendum sulla responsabilità diretta dei magistrati.
E chi incorre nell’obbrobrio
sistematico di incarcerare innocenti a bizzeffe fischietta indifferente, tanto
la coscienza è un optional, tanto gli applausi dell’ignavia e della morbosità
scrosciano ugualmente, tanto le stellette guadagnate su meriti fasulli non
verranno restituite. Naturalmente, perfezione pretenderebbe che l’errore
giudiziario non si verificasse mai – e questo è umanamente e obiettivamente
impossibile. Ma fin dove esso è fisiologico? Qual è il confine entro cui si
mantengono applicate le garanzie costituzionali? Da che punto in poi si
trasforma in una stortura del sistema?
Beh, se l’incidenza del
carcere su estranei al delitto assume proporzioni vistose, se i malcapitati
finiscono con il sommergere per numero i colpevoli, o se i colpevoli non ci sono
affatto, se le anomalie riguardano molte delle grandi e strombazzate inchieste
con arresti a raffica, allora la dea bendata, con la spada in una mano e la
bilancia nell’altra, quella benda se l’è tolta per poter strizzare complice
l’occhio, allora si è in presenza di un crollo, o di una devianza voluta, della
capacità investigativa e di una pericolosa sospensione dei diritti umani, allora
si è di fronte a una giustizia arruffona, frettolosa, sommaria, cinica, allora
ci si accosta a una deriva autoritaria, a una sorta di regime legalizzato che
puzza di Stato di polizia, allora occorre riflettere sulle perplessità di Sabino
Cassese, grande giurista e accademico, già ministro del governo Ciampi e giudice
della Corte Costituzionale – “se ci sono tanti innocenti (riconosciuti tali nei
processi, ndr) questo è veramente l’esercizio di un potere autoritario e
arbitrario”; “noi vogliamo che i procuratori siano magistrati; se si comportano
da Robin Hood, non sono più magistrati” – allora tornano di cruda attualità le
parole di Gaetano Salvemini: “se ti accusano d’aver stuprato la statua della
Madonnina appollaiata sul Duomo di Milano, intanto devi riparare all’estero, poi
si vede”.
E non può valere l’assunto che
in guerra qualsiasi mezzo sia lecito e che gli agnelli debbano farsi una ragione
d’essere finiti in bocca al lupo.
Errori
giudiziari ma anche "Far parti uguali tra diseguali". Carcere, assoluzione e
nuova imputazione, la storia dell’eroe perseguitato dai giudici perché vive
accanto ai “ribelli”.
Domenico Ciruzzi su
Il Riformista il
29 Marzo 2022.
«La Legge è il
Potere dei senza potere», si diceva una volta. Sempre più spesso da qualche
tempo l’ignavia del giudicante, e quindi di chi rappresenta la legge nella sua
attuazione, fa gravi danni non solo al singolo ma alla speranza dei tanti poveri
che potrebbero intraprendere eroicamente la dritta via. L’ignavia del
Giudicante (ovviamente non tutti, ma purtroppo neanche pochissimi) può
danneggiare gravemente anche il faticoso, prezioso e spesso straordinario lavoro
del volontariato che tanto si spende per supplire alle carenze ataviche dello
Stato nei quartieri più degradati.
Non si tratta
solo di errori giudiziari, dunque, ma degli effetti nefasti che tale ignavia può
produrre in danno della collettività più indifesa ed innocente. Alla vigilia
di riforme della Giustizia, divenute improvvisamente necessarie ed inderogabili
solo per incassare denari dalla Comunità Europea, ecco un esempio di ignavia
tratto da un processo come tanti, neanche raccontato dai media. Nei quartieri
più poveri e degradati, grazie all’azione incessante di parrocchie e volontari,
vivono piccoli eroi contemporanei accanto a tantissimi “ribelli”. Eroi che
crescono fianco a fianco di furfanti e disperati, spacciatori e potenziali
killer in quartieri abbandonati dallo Stato come in una riserva di espunti
predestinati. Sovente i nostri pochissimi eroi ed i tantissimi “ribelli” abitano
negli stessi palazzoni che affacciano direttamente sui reclusori, presagio di
una predestinazione che disintegra senza ipocrisia la chimera del libero
arbitrio. In tali contesti delle periferie metropolitane più degradate, dove
fino a due decenni fa perfino la Chiesa era assente, costoro, come rare stelle
in un cielo plumbeo, riescono eroicamente a prendere le distanze da tutto ciò
che è già loro “addosso” fin dalla nascita riuscendo a distinguersi talvolta
anche nella gestualità e nell’estetica, pur costretti a convivere con tutto ciò
che è la diversa “normalità” dell’intero quartiere.
Questi piccoli
eroi riescono miracolosamente a trovare perfino un lavoro stabile con regolare
contratto, mediando faticosamente con tutto il resto attorno che inizia a
guardarli con sussiego se non addirittura con sospetto. Una bella mattina,
proprio il giorno dopo che in tv si discute delle grandi trasformazioni della
criminalità organizzata mimetizzatasi ormai nei trust e nei capitali
internazionali, un blitz di arresti per camorra e piccolo spaccio di
stupefacenti deflagra sul quartiere, coinvolgendo anche il nostro piccolo eroe
ed azzerando così ogni segno di diversità attraverso una sbrigativa omologazione
giudiziaria contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare che lo deporta dal
balcone di casa direttamente all’interno del reclusorio sottostante, avverando
così ogni sinistra profezia. La prassi attuale è che – di regola e salvo
lodevoli eccezioni – nelle aule dei tribunali penali, la tragica povertà di
lingua e di contesti degradati, invece di provocare indulgenza e commozione,
sovente amplifica crudelmente l’entità di pene da infliggere a corpi incatenati
senza valutarne la storia ed il tasso di libero arbitrio che ne ha determinato
le condotte. Ed è sotto l’egida de “La legge è uguale per tutti” che ogni giorno
si compie l’ingiustizia più grande secondo Don Milani: «Far parti uguali tra
diseguali».
Se questa è la
tragica tendenza culturale che avanza nei tribunali, ancor più difficile sarà in
tale clima operare le giuste distinzioni riuscendo ad individuare immediatamente
l’innocenza del nostro piccolo eroe. Ed invero, soltanto dopo due anni di
terribile reclusione, il nostro eroe viene assolto. Ometto ogni considerazione
sull’essere imprigionati da innocenti, perché non è questo il senso di ciò che
intendo evidenziare. Il nostro piccolo eroe cambia abitazione, si trasferisce
nel quartiere accanto, allontanandosi dalle case dei coimputati tra cui vi erano
inevitabilmente anche parenti e conoscenti, e riprende subito a lavorare. Dopo
un anno, un nuovo blitz, fortunatamente meno cruento perché non vi sono arresti:
associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione di marchi di borse
di gran moda, questa volta fortunatamente senza aggravanti camorristiche. Il
nostro eroe immediatamente si presenta dinanzi all’autorità giudiziaria,
dichiarando la sua estraneità ai fatti e fornendo tutte le spiegazioni del caso.
Spiegazioni che
dovrebbero risultare ancor più convincenti considerato che, già nel corso del
precedente processo ed a seguito di indagini lunghe ed invasive, era emersa la
sua assoluta onestà ed estraneità da ambienti criminali. Nel corso dell’indagine
preliminare, questa volta dinanzi ad un giudice che dovrebbe essere imparziale
perché terzo rispetto all’indagine del pm, insiste nel difendersi rendendo
ulteriori dichiarazioni ed esibendo orgogliosamente, come reliquie – ma
evidentemente non percepite come tali – le numerose buste paga e certificazioni
lavorative che si susseguono nel tempo senza soluzione di continuità. Al giudice
si era chiesta con insistenza ancora più attenzione, pur sempre dovuta, giacché
la posizione dell’eroe era sacra, perché sacra è la busta paga del suo lavoro in
quei contesti di rovine. Contro di lui tecnicamente da un punto di vista
indiziario, c’è lo zero assoluto, e si può affermare con certezza assoluta che
il ragazzo – se rinviato a giudizio – sarà sicuramente assolto per non aver
commesso il fatto. Tra 6 o 7 anni, ovviamente. Ma l’ignavia trionfa: il giudice
rinvia tutti a giudizio, senza alcuna distinzione.
In tal caso, non
è in evidenza la pena dell’inutilissimo processo. È in evidenza invece uno
stuolo di adolescenti borderline che, anche da tale vicenda fallimentare del
nostro eroe, capiranno che non c’è speranza, che è tutto uguale, che il
capitombolo dal balcone al carcere è ineluttabile. Ed inizieranno ad armarsi. Ma
quand’è che in primis la politica e le istituzioni, e poi anche le tante
meritorie associazioni di volontariato si interrogheranno più a fondo sui guasti
provocati anche dall’ignavia di alcuni giudicanti? Domenico Ciruzzi
Le domande di
risarcimento. Ti sbattono in carcere da innocente e non ti risarciscono perché
la colpa è tua: non hai parlato durante l’interrogatorio.
Tiziana Maiolo su
Il Riformista il
29 Marzo 2022.
Quanti sono ogni
anno i cittadini italiani arrestati ingiustamente? Più del doppio di quello che
ci dice il ministero e che vengono risarciti dallo Stato. Senza che mai alcuna
toga paghi per i propri errori. Ci vorrebbe una scossa, come quella del
referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, e anche una riforma del
codice di procedura penale, sul risarcimento per ingiusta detenzione. Una scossa
che dia la sveglia allo stanco rituale per cui ogni anno in primavera per un
giorno qualche quotidiano (non tutti, quest’anno pochissimi) ci racconta il
carcere degli innocenti, con il numero delle ingiuste detenzioni e le cifre
esorbitanti che lo Stato ha versato per mettere una pezza, almeno sul piano
economico, sugli errori delle sue toghe.
Sui processi
sbagliati, sugli innocenti prima sbattuti in galera e poi assolti. Per la
cronaca, se quest’anno abbiamo saputo che nel 2021 lo Stato ha dovuto sborsare
ben 25 milioni di euro per errori giudiziari e detenzioni ingiuste, lo dobbiamo
soltanto a un’interrogazione del deputato Enrico Costa e alla risposta in aula
alla Camera della sottosegretaria all’economia Alessandra Sartore. Nel silenzio
del Ministero di giustizia, che avrebbe il dovere ogni anno di fornire al
Parlamento tutti i dati sull’amministrazione della giustizia entro il 31
gennaio. Ma il tema delle toghe che sbagliano, non sempre in buona fede, è molto
spinoso, negli uffici di via Arenula dove ha sede il ministero di Marta
Cartabia. Perché il luogo è affollato di magistrati, soprattutto nelle posizioni
apicali. Sono la gran parte dei famosi 200 fuori ruolo, cioè distaccati dai
tribunali in organi amministrativi. Così ogni anno il rituale si svolge in
primavera. E la stessa sottosegretaria del Ministero all’economia, che poi è
quello destinato ad aprire i cordoni della borsa, si è lamentata non poco,
nell’aula di Montecitorio, per essere stata costretta, il 9 febbraio, a
sollecitare ai colleghi della giustizia i dati del 2021, che sono infine
arrivati il 22 febbraio. Lentezza o resistenza rispetto a una ferita aperta che
la magistratura non vuole neppure vedere?
La contraddizione
è del resto palese. Se anche nell’anno della pandemia in cui si è arrestato di
meno, anche su sollecitazione dello stesso procuratore generale Cesare Salvi,
ancora seicento persone (contro le mille degli anni precedenti) sono finite in
galera da innocenti, come mai il Csm “assolve” sempre il 99% dei magistrati
colpiti da azioni disciplinari? È dunque il fato a mettere erroneamente le
manette ai polsi di un numero così impressionante di persone che poi verranno
assolte? In particolare nei distretti come quello di Catanzaro dove i blitz di
300 persone vengono poi sconfessati dai giudici? Un vulnus esiste però anche
nella legge, e qui occorre chiamare il causa il Parlamento. A volte noi
osservatori ci domandiamo se in questa legislatura esistano solo il
deputato Enrico Costa e pochi altri a occuparsi di giustizia. Un’occhiata
andrebbe data per esempio all’articolo 314 del codice di procedura penale,
laddove sancisce che “chiunque è stato prosciolto con sentenza irrevocabile…ha
diritto a un’equa riparazione, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi
causa per dolo o colpa grave”.
Questo principio,
che comunque andrebbe meglio precisato con un’opportuna riforma, è stato
interpretato liberamente nel modo più ampio dai magistrati. Prima di tutto ha
consentito alle corti d’appello di bocciare le richieste di riparazione a tutti
coloro che, magari nel primo interrogatorio, quando erano ancora sconvolti per
l’arresto, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande. Un
diritto, appunto. Non un’astuzia (che sarebbe masochistica, oltre a tutto) per
dirottare il pubblico ministero nelle indagini. Ma non solo. Ci sono stati casi
di persone accusate di reati di terrorismo, come Giulio Petrilli, che aveva
subito una lunghissima carcerazione e che due anni fa organizzò anche una
manifestazione di protesta e una petizione all’Unione europea, che si sono visti
negare l’erogazione del risarcimento per motivi ideologici.
Una sorta di
giudizio morale sulle sue frequentazioni giovanili. O più di recente il caso
di Francesco Belsito, ex tesoriere della Lega ed ex sottosegretario, che dopo
sei mesi di ingiusto carcere preventivo e un enorme danno finanziario, si è
visto respingere la richiesta di risarcimento dalla corte d’appello di
Genova perché le sue dichiarazioni negli interrogatori sarebbero state
“caratterizzate da notevole opacità”. Questi casi sono tantissimi, abbiamo
calcolato che almeno i due terzi delle domande vengono rigettate con questo tipo
di argomentazioni. Quindi occorre più che raddoppiare i dati del ministero.
Una luce è però
spuntata alla fine di questo tunnel, fatto di argomentazioni capziose e non
disinteressate. Perché ogni magistrato ha il timore che qualche seria riforma
della giustizia lo porti a rispondere a qualcuno -che non sia il Csm dei 99
“perdoni” su 100- delle sue azioni, del suo lavoro, delle sue capacità
professionali. Stiamo parlando di quella sentenza numero 1684 della quarta
sezione penale della cassazione (v. Il Riformista, 23-3-2022) che ha considerato
il silenzio dell’ indagato non ostativo alla riparazione per ingiusta
detenzione, proprio sulla base del decreto legislativo sulla presunzione
d’innocenza. Giurisprudenza destinata a fare scuola o a essere scacciata come un
fastidioso moscerino?
Tiziana Maiolo.
Politica e giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella
XI, XII e XIII legislatura.
Quelle ingiuste detenzioni
che non basta risarcire con un assegno.
La riparazione economica non
compensa la perdita del lavoro, degli amici, della credibilità, della fiducia.
Riccardo Radi su Il Dubbio il 21 agosto 2022.
È bene chiarire
preliminarmente che quanto si afferma è certificato dai dati della relazione che
prende in considerazione soltanto i procedimenti penali conclusi ( con sentenza
sia definitiva che non definitiva) nello stesso anno di emissione della misura (
i cosiddetti procedimenti “cautelati”).
Il campione complessivo è
costituito da 32.805 casi.
Interessa rilevare, per i fini
propri di questa riflessione, che il 5,4% dei procedimenti in questione si è
concluso con assoluzione non definitiva, l’ 1,5% con assoluzione definitiva e il
2% con sentenze di proscioglimento a vario titolo. La percentuale complessiva di
questi ammonta all’ 8,9% ( era il 9,1% nel 2020, il 10% nel 2019 e il 10,2% nel
2018).
C’è poi un secondo insieme ed
è quello costituito dai procedimenti conclusi con condanna ( definitiva e non
definitiva) a pena sospesa. Nel 2021 il loro totale è stato del 14,4% ( era il
14,5% nel 2020, il 14,8% nel 2019 e il 14,1% nel 2018).
Si può dunque affermare che,
relativamente all’anno 2021, nell’ 8,9% dei casi la sentenza ha escluso la
fondatezza dell’accusa o ha comunque riconosciuto la presenza di una causa
estintiva) e nel 14,4% dei casi le caratteristiche del fatto- reato e della
personalità dell’autore hanno consentito una prognosi favorevole tale da
escludere la commissione futura di nuovi reati.
È chiaro che questa seconda
tipologia di esiti ha bisogno talvolta della pienezza del giudizio perché ne
emergano i presupposti ma il buon senso suggerisce che il più delle volte il
quadro è completo già al momento della domanda di misura cautelare. Il che è
come dire che in un numero rilevante di procedimenti conclusi con condanna a
pena sospesa ben si sarebbe potuto fare a meno di qualsiasi misura, tanto più
tenendo conto del disposto dell’art. 275, comma 2- bis, cod. proc. pen., a norma
del quale «non può essere applicata la misura della custodia cautelare in
carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la
sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena».
Non è quindi azzardato
affermare che, complessivamente ed alla luce dei fatti, in 2 casi su 10 il
potere cautelare è stato esercitato in contesti che avrebbero suggerito ben
maggiore prudenza valutativa di quella dimostrata.
Questi numeri sono vite
sconvolte dove la maggior parte di queste persone viene arrestata in piena
notte, condotta in carcere senza troppe spiegazioni, proiettata in prima pagina
o sui titoli dei giornali, per poi vedersi dichiarare «ingiusta» la privazione
della libertà.
La riparazione per ingiusta
detenzione non basta, non può bastare. Prima che la vicenda processuale sia
conclusa, dopo diversi anni, la vittima spesso ha perso il lavoro, gli amici,
qualche volta perfino la famiglia, sempre la credibilità e la fiducia altrui.
Quale somma potrebbe mai
risarcire un’esperienza capace di incidere così pesantemente nella mente e nel
corpo, fino a causare conseguenze difficilmente eliminabili? Chi è stato in
carcere da innocente racconta di essere stato soggetto a crisi di panico, notti
insonni e difficoltà relazionali anche a distanza di anni.
Una riflessione appare
necessaria: di fronte a tali situazioni che colpiscono le famiglie, l’attività
lavorativa, la credibilità di soggetti che entrano nel sistema carcerario o la
cui libertà personale viene ingiustamente limitata, può essere ammissibile che a
pagare per gli errori del magistrato, in sede di valutazione dei presupposti per
l’applicazione delle misure detentive, sia sempre e soltanto lo Stato (cioè, in
ultima analisi, i cittadini stessi) ?
Se lo Stato riconosce che c’è
stata un’ingiustizia, è corretto che affronti e valuti che cosa non ha
funzionato: se qualcuno ha sbagliato, se l’errore è stato inevitabile, se c’è
stata negligenza o superficialità, se chi ha sbagliato deve essere chiamato a
una valutazione disciplinare.
I magistrati oggi non
rispondono degli errori commessi. Troppo spesso, infatti, accade che le ragioni
che hanno determinato errori, anche gravi, non siano rilevate, come
occorrerebbe, sul piano disciplinare o restino prive di conseguenze in sede di
decisione sugli avanzamenti di carriera.
Il tema sotteso a questa
riflessione è la necessità di abbandonare la cultura della comoda
deresponsabilizzazione a favore di un più diretto e penetrante controllo
sull’operato del magistrato, che – non va dimenticato – in questa materia
applica misure che incidono sui più importanti diritti costituzionali delle
persone.
Nelle scorse settimane era
stato presentato alla Camera un progetto di legge che pare destinato a
riproporsi nella prossima legislatura e che prevede di introdurre sulla
disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e
della procedura per la loro applicabilità, tra gli illeciti disciplinari il
fatto di aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la
richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all’adozione
dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata
disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e
315 del codice di procedura penale.
Il tutto per sfatare
l’aforisma di Borges: «Per aver paura dei magistrati non bisogna essere
necessariamente colpevoli». Riccardo Radi
Errori giudiziari e
ingiuste detenzioni: soldi (e vite) buttati.
Il deputato Costa (Azione):
«Lo Stato ha speso 25 milioni di euro in risarcimenti e i dati vengono forniti
con regolare ritardo». Valentina Stella su Il Dubbio il 27 marzo 2022.
Nel 2021 lo Stato ha speso per
riparazione da errore giudiziario 1.271.914,90 euro, relativamente a sette
ordinanze di Corti d’appello; mentre quelli relativi alla riparazione per
ingiusta detenzione sono stati ben 24.506.190,41 euro e riguardano 565 ordinanze
di Corti d’appello. In totale più di 25 milioni.
Lo ha comunicato ieri
nell’Aula della Camera la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Alessandra Sartore, rispondendo ad una interpellanza urgente
dell’onorevole di Azione Enrico Costa. Tuttavia la questione che forse fa più
discutere è un’altra: sempre la sottosegretaria Sartore ha puntualizzato che
«per l’anno 2021, si evidenzia che il Ministero della Giustizia ha chiesto i
dati al Ministero dell’Economia e delle finanze in data 9 febbraio 2022 e gli
stessi sono stati forniti in data 16 febbraio 2022». In pratica, il Ministero
della Giustizia avrebbe dovuto rendere noti i numeri sull’esito dei processi con
arresti, sulle ingiuste detenzioni, sulle azioni disciplinari a chi ha sbagliato
attraverso una Relazione al Parlamento da presentare entro il 31 gennaio di
quest’anno, come prevede la legge, ma incredibilmente solo il 9 febbraio, quindi
quando i termini erano già scaduti, si è preoccupato di chiedere i dati al Mef.
Per il vicesegretario
di Azione, ciò dimostra «il totale disinteresse da parte del Ministero della
Giustizia rispetto a un tema che è di civiltà giuridica. Se una persona è stata
arrestata e poi assolta, è giusto che si chiarisca perché ciò è accaduto. Il
problema nel nostro Paese è che quando accadono queste vicende, lo Stato si
volta dall’altro lato senza comprendere le vere ragioni, senza verificare le
motivazioni dietro quegli errori e senza sanzionare chi sbaglia». Costa poi si è
soffermato anche sulla riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario. Ieri vi
avevamo raccontato che il suo emendamento per la responsabilità civile diretta
dei magistrati avrebbe profili di incostituzionalità e quindi sarebbe da
bandire.
Ma lui non ci sta e
in Aula attacca: «Allora, colgo l’occasione per chiedere al Governo, che è stato
così attento ai profili e alle sfumature di costituzionalità, se sia coerente
con il nostro assetto costituzionale, di fronte ai numeri che ci sono stati dati
(565 persone arrestate ingiustamente e lo Stato che paga 24.206.000 euro per
indennizzi), che nessuno paghi, che paghi solo lo Stato, che non ci sia un
magistrato che subisca un’azione disciplinare, visto che il Governo è attento
alle sfumature sugli emendamenti parlamentari. E chiedo ancora al Governo: è
coerente con la Costituzione che il 99 per cento delle valutazioni di
professionalità abbia un esito positivo? È coerente con questi numeri, che sono
stati appena resi, un 99 per cento di magistrati che sono bravi, bravissimi? È
coerente con la Costituzione un correntismo strabordante, in cui c’è una
giustizia domestica, in cui i magistrati si giudicano fra di loro e nessuno
sanziona nessuno? È coerente con la Costituzione un sistema che, in dodici anni,
dal 2010 al 2022, ha visto otto condanne – otto! – per responsabilità civile, di
fronte a 664 cause intentate e a 154 sentenze definitive? 664 cause e otto
condanne! Nell’ultimo anno, 25 sentenze definitive, zero condanne! Io lo chiedo
al Governo: è coerente con la Costituzione?».
E conclude: «L’auspicio è che
nel quadro della riforma al Csm venga finalmente approvata la mia proposta di
sanzione disciplinare – una norma di civiltà giuridica – per chi ha concorso,
con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione
della misura della custodia cautelare, all’adozione dei provvedimenti di
restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la
riparazione per ingiusta detenzione».
Ingiusta detenzione, tutti
gli alibi dello Stato per ridurre o non riconoscere un indennizzo.
Viviana
Lanza Libero Quotidiano il 13 Marzo 2022.
Avvalersi della facoltà di non
rispondere è un diritto riconosciuto dalla legge ma può diventare un boomerang
se poi, a processo finito e ad errore giudiziario accertato o ingiusta
detenzione subita, si prova a chiedere un risarcimento allo Stato. Perché?
Perché lo Stato può dirti che appellandoti a quel tuo diritto hai contributo a
far cadere nell’errore gli inquirenti. Sembra assurdo, eppure è una delle
motivazioni a cui si ricorre per ridurre o negare il risarcimento a chi,
ingiustamente detenuto, chiede un indennizzo per il danno patito.
L’associazione Errorigiudiziari.com, fondata dai giornalisti Benedetto
Lattanzi e Valentino Maimone che da oltre vent’anni raccolgono dati su casi di
ingiusta detenzione ed errori giudiziari, ha messo insieme storie,
testimonianze, provvedimenti svolgendo un’analisi delle decisioni più
frequentemente adottate dalle Corti d’appello e dalla Cassazione. E si scopre
che una “colpa lieve” che non dà diritto a un pieno risarcimento può essere
l’essersi avvalso della facoltà di non rispondere al momento
dell’interrogatorio, l’avere frequentazioni poco raccomandabili oppure il fatto
di non possedere una memoria di ferro per ricordare, con minuziosa precisione,
date e orari che interessano alla tesi accusatoria. Della serie, non basta dire
che si è innocenti. Perché si potrebbe essere accusati di «non essere pienamente
collaborativi» e quindi avere diritto a un risarcimento decurtato. Ma come si
può collaborare se non si conosce quel dato fatto, se non si è commesso quel
tale reato? Ah, saperlo!
Anche essere già stato in
carcere in passato o avere precedenti penali, oppure avere una personalità
ritenuta «negativa» può essere una colpa lieve che contribuisce a far ridurre la
percentuale dell’indennizzo o a non averlo proprio. Addirittura, bisogna stare
attenti all’avvocato che si sceglie come difensore appena si viene arrestati,
perché al momento di richiedere un indennizzo per ingiusta detenzione si
potrebbe vedere l’importo del proprio indennizzo tagliato del 25% perché secondo
lo Stato, che comunque non avrebbe dovuto arrestarti, ti sei fatto difendere da
un avvocato poco preparato. Sembra assurdo ma è la realtà. Ed è una realtà che
si confronta con grandi numeri. Basti pensare che, facendo una media dei casi
dal 1992 al 2020, nel nostro Paese si stimano 1.015 vittime di malagiustizia
all’anno (più di cento solo a Napoli) e si spendono in media due milioni e mezzo
di euro in risarcimenti ogni anno. E dire che circa il 70% delle richieste di
risarcimento non viene accolto, il che vuol idre che le dimensioni del fenomeno
sono ben più ampie.
Ci sarebbero circa 20mila casi
di ingiusta detenzione non dichiarati negli ultimi anni, perché spesso chi
subisce un arresto o un processo ingiusto poi non ha la forza economica o
psicologica per ingaggiare una nuova battaglia giudiziaria per
il risarcimento. Dunque, a fronte dei dati ufficiali sottoposti all’attenzione
ministeriale secondo cui ammonterebbero a circa 30 mila le vittime di ingiusta
detenzione negli ultimi trent’anni, ci sono dei dati reali che danno al fenomeno
una proporzione ben più ampia. Inoltre, secondo i dati diffusi
da Errorigiudiziari.com, su 544 cause contro lo Stato per responsabilità civile
dei magistrati presentate tra il 2020 e il 2021, solo 129 sono andate a sentenza
finora e di queste solo 8 si sono concluse con una condanna.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
C’è un giudice a Trapani,
rubò provola e pancetta per fame: assolta.
L'ammontare complessivo del
furto di alimenti non superava 10 euro. Ma il pm di Trapani aveva chiesto una
condanna a quattro mesi di carcere. su Il Dubbio il 20 febbraio 2022.
Il giudice del Tribunale di
Trapani Francesco Giarrusso ha assolto una donna di 69 anni di Trapani che era
finita nel 2020 sotto processo per aver rubato alcuni generi alimentari da un
supermercato della città. Come scrive il Giornale di Sicilia nelle pagine
provinciali di Trapani, la signora, due anni addietro, aveva conservato nella
sua borsa mozzarella, provola e pancetta, alimenti dal valore non superiore a 10
euro. A scoprirla erano stati gli addetti alla sicurezza che l’avevano
denunciata.
L’imputata non era in aula, a
seguire l’udienza. Era presente la figlia. Il giudice, alla fine, ha accolto la
tesi dell’avvocato Josemaria Ingrassia. Nella sua arringa difensiva, il legale
ha chiesto l’assoluzione, affermando che la sua assistita, con la fedina penale
«immacolata» aveva rubato non perché fosse abituata a compiere furti ma solo per
fame. Il pubblico ministero Marta Martinelli aveva chiesto la condanna a 4 mesi
di reclusione.
Da lastampa.it il 20 febbraio
2022.
Il giudice del Tribunale di
Trapani Francesco Giarrusso ha assolto una donna di 69 anni di Trapani che era
finita nel 2020 sotto processo per aver rubato alcuni generi alimentari da un
supermercato della città. Come scrive il Giornale di Sicilia nelle pagine
provinciali di Trapani, la signora, due anni addietro, aveva conservato nella
sua borsa mozzarella, provola e pancetta, alimenti dal valore non superiore a 10
euro. A scoprirla erano stati gli addetti alla sicurezza che l'avevano
denunciata.
L'imputata non era in aula, a
seguire l'udienza. Era presente la figlia. Il giudice, alla fine, ha accolto la
tesi dell'avvocato Josemaria Ingrassia. Nella sua arringa difensiva, il legale
ha chiesto l'assoluzione, affermando che la sua assistita, con la fedina penale
"immacolata" aveva rubato non perché fosse abituata a compiere furti ma solo per
fame. Il pubblico ministero Marta Martinelli aveva chiesto la condanna a 4 mesi
di reclusione.
M.Ser. per "la Stampa" l'11
febbraio 2022.
La piccola rivincita di Renato
Vallanzasca contro lo Stato è stata confermata anche dalla corte d'Appello. Che,
anzi, ha condannato il ministero dell'Interno a rimborsargli le spese legali. Il
conto è di 12 mila euro, che si sommano alle 5 mila 800 già sborsate dopo il
primo grado, per un totale di 17 mila 800 euro.
Il bel René e la moglie
Antonella D'Agostino erano stati trascinati in Tribunale dall'avvocatura
generale per conto del ministero che, dal 1978, cerca di farsi risarcire dall'ex
bandito della Comasina, condannato al carcere a vita, per l'omicidio dell'agente
Bruno Lucchesi dopo l'evasione dal carcere di Spoleto.
Un debito di 425 mila euro mai
saldato. Quando, nel 2009, Vallanzasca ha ceduto i diritti della sua storia (ne
sono nati due libri e il film Gli angeli del male), la moglie Antonella ha
incassato dalla Cosmo Production 278 mila euro. Denaro su cui lo Stato avrebbe
voluto mettere le mani, sostenendo che quei soldi fossero in realtà dell'ex re
della mala. Niente da fare: dopo la sconfitta in primo grado anche l'Appello ha
respinto ricorso e condannato il ministero a pagare le spese legali.
Misure cautelari, ogni anno
un terzo bocciate in modificate dal Riesame.
Viviana Lanza su Il Riformista
il 6 Febbraio 2022.
Il Riesame è il primo banco di
prova di un’inchiesta in campo penale. Misure cautelari personali e reali,
decise dai gip su richiesta dei pubblici ministeri, vengono poi valutate in sede
di Riesame. Analizzando gli esiti delle decisioni di questo Tribunale, in
composizione collegiale, con un presidente e due giudici a latere, si può fare
una sorta di screening della tenuta delle indagini.
Considerando che in
ogni bilancio giudiziario, da alcuni anni a questa parte, si evidenzia la
sproporzione tra numero di indagini che vengono avviate e numero di procedimenti
che giungono a definizione, con un netto sbilanciamento a favore dei primi
decisamente più numerosi, e considerato che da tempo è sotto i riflettori il
tema dello bilanciamento del sistema giudiziario e mediatico tradizionalmente a
favore dell’accusa, osservare il trend delle inchieste che arrivano al vaglio
del Riesame o Tribunale delle Libertà come dir si voglia, analizzare gli esiti
delle pronunce, può essere utile a inquadrare meglio lo stato generale di salute
della nostra giudiziaria. Ebbene, nel 2021 sono state vagliate dal Tribunale del
Riesame di Napoli 5.945 misure cautelari.
Di queste 3.589 hanno avuto
conferma, le altre hanno ottenuto sorti varie. Dal bilancio relativo all’ultimo
anno di attività giudiziaria emerge infatti che 470 sono state completamente
annullate, 615 sono state parzialmente riformate, 25 sono state dichiarate
inefficaci, 1.007 sono state dichiarate inammissibili. Tra riunioni con altre
misure e altre modalità si classificano le restanti decisioni adottate
dal Riesame nell’ultimo anno. Sono state, inoltre, 2.397 le istanze di appello
di parte su misure cautelari personali, nessuna da parte del pm..
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Tre innocenti al giorno
finiscono in carcere. I pm si autoassolvono ma i loro errori costano 40 milioni
ogni anno.
Massimo Malpica il 5 Febbraio 2022 su Il Giornale.
Nel suo discorso di
insediamento Mattarella ha puntato il dito anche "sulle decisioni arbitrarie o
imprevedibili in contrasto con la certezza del diritto". Da Zamparini a Melis:
ecco i casi più eclatanti di malagiustizia.
«I cittadini devono poter
nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l'Ordine
giudiziario. Neppure devono avvertire timore per il rischio di decisioni
arbitrarie o imprevedibili che, in contrasto con la certezza del diritto,
incidono sulla vita delle persone. Va sempre avvertita la grande delicatezza
della necessaria responsabilità che la Repubblica affida ai magistrati».
Parole del vecchio/nuovo
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo discorso di
insediamento non ha risparmiato critiche alla giustizia, dedicando un passaggio
importante agli errori giudiziari, a quelle «decisioni arbitrarie o
imprevedibili» che, purtroppo, sono ancora numerose ogni anno. Così l'appello di
Mattarella è un registro dei desiderata, non la proiezione della realtà, se solo
nel biennio 2019/2020 le ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione sono
state 1.750, con un esborso per lo Stato di oltre 80 milioni di euro. E a fronte
di questa messe di provvedimenti ingiusti che lo Stato ha riconosciuto come
tali, sono state promosse solo 45 azioni disciplinari contro i magistrati: di
queste 7 si sono concluse con l'assoluzione, 13 con il non doversi procedere
(per esempio perché il magistrato incolpato ha lasciato la toga) e 25 erano
ancora in corso al momento dell'ultima relazione al Parlamento del ministero
della Giustizia. Finora, insomma, per 1.750 errori conclamati, 283 dei quali non
più impugnabili, non c'è stata una sola censura, un solo ammonimento: per
trovarne tocca risalire al 2018, anno in cui a fronte di 509 indennizzi per
ingiusta detenzione riconosciuti sono stati sottoposti ad azione disciplinare 16
magistrati, quattro dei quali censurati.
Malagiustizia e scarsa
incisività dell'azione disciplinare, insomma, che giustificano, quando meno,
l'opportunità del richiamo del capo dello Stato. E in fondo per capire come gli
errori giudiziari non siano microscopiche macchioline in un sistema altrimenti
perfetto basta scorrere le cronache. Anche quelle recenti, se appena a inizio
settimana Pietro Grasso, ex presidente del Senato e già procuratore nazionale
Antimafia, ha ricordato su Repubblica lo scomparso Maurizio Zamparini, ex
presidente del Palermo, sostenendo che l'imprenditore era diventato «un
obiettivo di chi aveva deciso che dovesse lasciare» il capoluogo siciliano, e
che quell'obiettivo era stato «raggiunto anche attraverso l'azione della
magistratura» che «credo ha proseguito Grasso abbia risentito dell'atmosfera che
si respirava in città e che era portatrice della volontà di fargli lasciare il
club». Obiettivo riuscito alla fine del 2018, con conseguenze disastrose anche
per la squadra, fallita poco dopo e costretta a ripartire dalla serie D. Ma di
storie ce ne sono tante, così tante che ad alcune tra le più eclatanti Stefano
Zurlo ha dedicato «Il libro nero delle ingiuste detenzioni», uscito lo scorso
autunno per Baldini e Castoldi, raccontando nove odissee giudiziarie di vittime
della malagiustizia, scelte tra quelle delle 30mila persone che, come ricorda il
deputato di Azione Enrico Costa, tra 1991 e 2020 sono finite in cella per poi
vedersi assolvere o prosciogliere. Ecco dunque il caso di Pietro Paolo Melis,
allevatore del Nuorese, arrestato nel 1997 da incensurato per un sequestro che
non aveva commesso, condannato a 30 anni a causa di una intercettazione coperta
da «un rilevante e continuo rumore di fondo» sciattamente ed erroneamente
attribuita a lui dai giudici, e tornato libero solo 18 anni, sei mesi e cinque
giorni più tardi, il 15 luglio 2016, quando di anni ne aveva 56. O quello di
Angelo Massaro, finito dietro le sbarre dal 15 maggio 1996 al 23 febbraio 2017
perché sette giorni dopo la sparizione di un suo amico e sodale viene
intercettato mentre dice alla moglie una frase in dialetto: lui dice di aver
detto «muerse» (pesante), riferendosi a una pala meccanica, per gli inquirenti
ha detto invece «muerte», riferendosi appunto alla morte dello scomparso. Quanto
basta, insieme alle dichiarazioni de relato di un pentito, per condannarlo e
buttare via la chiave fino a quando a salvarlo arriva la revisione del processo,
e una nuova sentenza che, nel 2017, gli restituisce la libertà. Non quei 21 anni
rubati. Massimo Malpica
Mille innocenti in cella
ogni anno: «Ora le toghe paghino i loro errori».
Dopo il monito di Mattarella
sulla giustizia, i fondatori dell’Associazione Errori giudiziari rispolverano il
tema della responsabilità civile dei magistrati: «Dignità è anche riuscire a
ridurre i mille innocenti arrestati ingiustamente e risarciti ogni anno, sono 3
al giorno, uno ogni otto ore». Il Dubbio il 5 Febbraio 2022.
Se il monito di
Mattarella sulle riforme ha sollevato un gran rumore attorno alla Giustizia, di
certo più tiepido è stato il favore con cui si è accolto il richiamo, nel suo
discorso di insediamento, al sovraffollamento nelle carceri e alla tutela della
dignità. «Mattarella ha pronunciato 18 volte la parola dignità: ci sarebbe
piaciuto che ci fosse una diciannovesima volta riferita agli innocenti. Dignità
è anche riuscire a ridurre i mille innocenti arrestati ingiustamente e risarciti
ogni anno, sono 3 al giorno, uno ogni otto ore. Dignità per un cittadino
innocente è anche che quel numero venga ridotto», sottolineano Valentino Maimone
e Benedetto Lattanzi, giornalisti e fondatori dell’Associazione Errori
giudiziari, che pure si uniscono agli applausi con cui sono state accolte le
parole del Presidente.
«È stato un intervento più
vigoroso del solito – concordano i due giornalisti – che ci convince e ci trova
assolutamente d’accordo, in particolare il passaggio sulla riforma del Csm che,
al di là del discorso delle correnti, speriamo sia effettivamente fatta: ora la
palla passa al legislatore, si può applaudire Mattarella cento volte ma se poi
non lavori come devi tutto resta sulla carta». «Ci aspettiamo che all’interno
della riforma del Csm sia introdotta la responsabilità dei magistrati. Oggi la
valutazione dei magistrati supera il 99% dei giudizi positivi, e così perde ogni
efficacia e ogni validità. Inserendo nella riforma del Csm una concreta
responsabilità professionale dei magistrati per quanto riguarda il tema degli
errori giudiziari e delle vittime di ingiusta detenzione sarebbe un aspetto
importante», ribadiscono i fondatori dell’Associazione, estensori di quel
“rapporto degli orrori” sui numeri della malagiustizia pubblicato nell’aprile
scorso insieme ad Enrico Costa, deputato e responsabile Giustizia di
Azione. Parliamo di quasi trentamila persone ingiustamente dietro le sbarre dal
1992 al 31 dicembre 2020. Quasi mille ogni anno, uno sproposito, così come i
soldi che lo Stato ha dovuto sborsare per riparare i propri errori: 870milioni.
Con indennizzi per 46 milioni solo nel 2020.
Il rapporto: 30mila innocenti
in carcere in 30 anni
Dal 1991 al 31 dicembre 2020 i
casi di errore giudiziario sono stati 29.659, errori che sono costati agli
italiani, tra indennizzi e risarcimenti, 869.754.850 euro, ovvero più di 28
milioni e 990 mila euro l’anno. Partendo da una doverosa distinzione tra vittime
di ingiusta detenzione e vittime di errore giudiziario, Benedetto Lattanzi e
Valentino Maimone hanno snocciolato i casi città per città. La parte più corposa
delle ingiustizie riguarda proprio coloro che finiti in carcere o ai domiciliari
si sono visti poi riconoscere innocenti all’esito dei processi.
In 28 anni è toccato a 29.452
persone, 1015 se si considera la media del singolo anno. A loro lo Stato ha
versato un totale di 794 milioni e 771 mila euro in indennizzi, poco più di
27.405.915 euro l’anno. Solo nel 2020 sono state 750 le persone che hanno
subito una custodia cautelare poi rivelatasi ingiusta, per una spesa di
36.958.648,64 euro. Numeri più bassi rispetto al 2019 ( 250 casi in meno), ciò
anche a causa del Covid, con il conseguente rallentamento dell’attività
giudiziaria, comprese le istanze di riparazione per ingiusta detenzione.
Gli errori giudiziari veri e
propri sono invece 207 in tutto, per un totale di 74.983.300,01 euro di
risarcimenti, 2 milioni e mezzo circa l’anno. Una cifra altissima, che comprende
i casi più eclatanti, ovvero quelli che hanno visto innocenti scontare pene per
reati mai compiuti prima di riuscire a far valere la verità. Ci sono,
ovvero, casi come quello di Giuseppe Gullotta, condannato per la strage di
Alcamo e che ha passato ingiustamente 22 anni in carcere, o Angelo Massaro,
anche lui rimasto in cella per un ventennio per un omicidiomai commesso. Nel
solo 2020 sono stati 16 i casi di errore giudiziario. Numeri che portano la
spesa complessiva del 2020 a 46 milioni.
Le città che hanno speso di
più in risarcimenti sono Reggio Calabria ( 7.907.008 euro), Catanzaro (
5.584.529 euro) e Palermo ( 4.399.761 euro), mentre le città con più casi di
indennizzo sono Napoli ( 101 casi, per i quali ha speso 3.105.219 euro), Reggio
Calabria ( 90 casi) e Roma ( 77 casi). Nella Capitale i risarcimenti ammontano a
3.566.075 euro, mentre Milano, con 39 casi di indennizzo, ha speso 1.327.207
euro. Il distretto di Napoli è rimasto tra le prime tre posizioni per 9 anni
consecutivi. E per ben sei volte su nove è stato al primo posto, detenendo il
record di casi raggiunti in un anno: 211 nel 2013.
Giu.Sca. per "il Messaggero"
il 28 gennaio 2022.
«Un giorno in carcere da
innocente vale per lo Stato 235 euro di risarcimento». Valentino Maimone, 55
anni, giornalista e fondatore dell'associazione Errorigiudiziari.com (assieme al
collega Benedetto Lattanzi) è tra i massimi esperti in Italia di ingiuste
detenzioni. Tradotto, si tratta di persone finite in carcere da innocenti.
Uomini e donne che si sono
ritrovati rinchiusi in una cella o ai domiciliari salvo poi essere assolti da
ogni imputazione.
«Abbiamo un database che
aggiorniamo costantemente, adesso abbiamo in tutto 840 casi»
Quanti casi di ingiuste
detenzioni si registrano ogni anno in Italia?
«Negli ultimi 30 anni la media
è di mille all'anno. Abbiamo superato quota 30mila».
Quali sono le principali
città?
«La prima è Napoli, poi Reggio
Calabria, terza è Roma. Napoli è nei primi tre posti da nove anni consecutivi.
La Calabria, da sola, assorbe un terzo di tutti gli indennizzi che ogni anno
vengono versati a chi è stato vittima di ingiusta detenzione»
La cifra media che paga lo
Stato qual è?
«Per un giorno in custodia
cautelare in carcere solo 235 euro al giorno. Per i domiciliari la metà. Ad ogni
modo c'è un limite nel risarcimento, non si possono superare i 516mila euro, il
vecchio miliardo in lire»
Come fare per ottenere il
risarcimento?
«Entro due anni
dall'assoluzione è necessario presentare la domanda per istanza di riparazione
per ingiusta detenzione. Quasi l'80% delle richieste di risarcimento vengono
respinte, ne passano in media un 20-25%».
Quanto spende lo Stato ogni
anno per risarcire?
«Ventinove milioni di euro in
media. Il totale è 890 milioni di euro negli ultimi 30 anni»
Cosa accade agli inquirenti
che sbagliano le inchieste mandando in carcere persone che si rivelano essere
innocenti. Pagano per i loro errori?
«In Italia esiste una legge
sulla responsabilità civile dei magistrati, è la legge Vassalli. Questa legge
prevede che non ci si possa rivalere direttamente sui magistrati. In pratica si
fa una causa allo Stato e in seconda battuta, in caso di risarcimento, lo Stato
si rifà sul magistrato. Devo dire che, negli ultimi 15 anni, le toghe che alla
fine hanno pagato per i loro errori si contano sulle dita di una mano».
«Tra assoluzioni e
prescrizioni numeri sconvolgenti: siamo oltre il 60%».
Cristiana Valentini, avvocato
e professore, commenta i numeri della giustizia emersi dalla Relazione del Primo
Presidente di Cassazione Pietro Curzio all'inaugurazione dell'anno giudiziario.
Valentina Stella Il Dubbio il 28 gennaio 2022.
L’avvocato Cristiana
Valentini, ordinario di procedura penale presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche e Sociali dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, ha
scritto per “Archivio penale” un articolo intitolato “Riforme, statistiche e
altri demoni”, frutto di una ricerca dell’Università, condotta insieme al
professore di statistica, Simone Di Zio. Sono stati mossi dalla convinzione che
senza conoscenza dei dati offerti dal mondo reale non è possibile alcun reale
cambiamento. A maggior ragione quando si parla di giustizia, tanto è vero che la
ministra Cartabia, durante la sua relazione al Parlamento, ha annunciato
l’istituzione del Dipartimento del ministero che si occuperà della transizione
digitale e della statistica.
Stiamo vivendo un periodo di
riforme nel campo della giustizia. Eppure molti dati riguardanti la sua
amministrazione sono sconosciuti.
Credo che la giustizia penale
sia stata per troppo tempo un campo oscuro, in cui molte cose, troppe, navigano
al riparo della formula del segreto, declinato in varie misture. Lo Stato ha il
dovere di agire in modo trasparente: nel campo del diritto amministrativo, le
discipline dell’accesso agli atti hanno portato doverosa luce negli incunaboli
dell’apparato; nel settore specifico del processo penale, poi, la Corte europea
ripete che (perfino) le indagini devono essere trasparenti. Epperò in questo
Paese la trasparenza sembra per molti versi ancora un sogno ingenuo e non è cosa
che dovrebbe accadere in uno Stato di diritto. Ecco, la prima forma di
trasparenza dovrebbe iniziare dalle statistiche sul processo penale. Una vera
democrazia non dovrebbe tollerare che l’attività dei suoi organi sia scarsamente
decifrabile e ben poco pubblica.
Quindi ben venga il nuovo
dipartimento annunciato dalla Guardasigilli?
Certo. Ma è fondamentale che
ci sia piena e totale trasparenza sul metodo usato e sulla totalità dei dati
raccolti.
Nel suo articolo lei analizza
anche le relazioni dell’anno giudiziario in Cassazione. Rispetto alle ultime:
per il Primo Presidente Curzio circa il 50% dei processi di primo si conclude
con l’assoluzione, mentre per il Procuratore Generale Salvi solo il 21%.
Ho letto i dati a cui lei fa
riferimento. Per quanto questo tipo di analisi sia cosa delicata, posso dire, in
via di prima approssimazione, che, anche sulla scorta degli studi da noi
condotti sulla base dei dati ufficiali della Direzione Generale di statistica e
analisi organizzativa del Ministero, sono corretti i numeri sui proscioglimenti
indicati dal Primo Presidente. E sono numeri sconvolgenti. Se lei aggiunge a
quel 50,50% di esiti assolutori da parte del giudice monocratico adito a
citazione diretta, i numeri delle prescrizioni, si arriva sicuramente – lo dico
a spanne – attorno al 60%, forse di più. Ripeto, mi sembrano numeri
sconvolgenti, che sarebbero degni della più grande attenzione, e invece non è
stato così da parte di nessuna delle recenti riforme. Si è preferito
“manganellare” il giudizio d’appello, che – purtroppo per l’efficienza delle
riforme in questione – si colloca a valle della maggior parte delle declaratorie
di prescrizione.
Questi dati ci dicono forse,
come lei ha scritto, che “l’azione penale viene troppo spesso esercitata in
assenza dei corretti requisiti”. Anche Curzio ha bacchettato pm e gup in tal
senso.
Qui devo scomodare una
molteplicità di concetti noti: il processo penale è una pena in sé, un tormento
autentico per l’imputato; sottoporre un innocente ad un processo che potrebbe
essere evitato semplicemente con indagini più accurate o anche semplicemente
condotte nel rispetto dell’art. 358 c.p.p.(cioè anche a favore dell’indagato) è
un’abitudine radicalmente contrastante con la presunzione d’innocenza, oltre ad
essere uno scempio etico. È la famosa “azione penale apparente” da cui ci mise
inutilmente in guardia anni fa la Corte costituzionale: fenomeno gravissimo, che
conosce molte sfaccettature, che giungono fino ai casi – frequentissimi nella
prassi, come ben sanno i difensori – di azione penale esercitata sulla scorta
della mera querela e poco altro. D’altra parte, quando osserviamo il fenomeno
nella prospettiva della vittima del reato, il risultato è simile: la Cedu
insegna da tempo che la vittima ha diritto ad indagini complete e di qualità,
perché si arrivi non ad un responsabile purchessia, ma all’effettivo
responsabile. Infine, un pensiero che potrebbe apparire brutale, ma è solo
schietto: la giustizia è un bene prezioso e non va sprecato; sprecarlo significa
assumerci le conseguenze che oggi sono sotto gli occhi di tutti, ovvero una
giustizia sommersa dai numeri e troppo spesso priva di qualità.
Una commissione ministeriale
sta lavorando ai decreti attuativi della riforma del processo penale. Il suo
articolo “ha eletto ad oggetto d’analisi la gestione delle indagini preliminari
e dell’alternativa tra agire e archiviare”. Che consigli ha da dare a chi dovrà
riformare questa parte?
Un suggerimento che mi sento
di fare a cuor leggero, e che dovrebbero senz’altro seguire, è l’abbandono della
circolare Pignatone come modello per la disciplina dell’iscrizione della notizia
di reato e del modello 45.
Intende gli atti non
costituenti notizia di reato, che riposano nel “limbo” della non sicura
definibilità?
Esatto. È un terreno
delicatissimo e il modello Pignatone riporta il nostro codice a forme di
autogestione della notizia di reato da parte delle Procure che ricordano molto
la struttura del codice Rocco, prima della riforma urgente realizzata dopo la
caduta del regime fascista. Quel modello trasforma la notizia di reato in una
creatura gestibile ad libitum dalle Procure e nella più totale mancanza di
trasparenza: Tizio viene perseguito e va a giudizio, Caio, invece, viene
“salvato” grazie al modello 45. Immagini di trovarsi a difendere una persona cui
vengono addossate responsabilità spettanti in realtà ad altro soggetto, la cui
posizione è stata semplicemente cestinata con un tratto di penna e senza
controllo giudiziale. Un incubo che esiste già oggi e che s’intende allargare a
dismisura. Stento davvero a comprendere come sia possibile, in questo momento
storico, fornire alle Procure poteri del genere, che riescono ad eclissare senza
rumore persino notizie di reato provenienti dagli organi di polizia giudiziaria.
Forse, poi, esistono margini anche per eliminare un altro buco nero del nostro
codice, ovvero la stentata disciplina delle investigazioni difensive, che allo
stato consente al pubblico ministero di ignorare bellamente le indagini della
difesa, anzi persino di ostacolarle.
A proposito di Pignatone,
qualche giorno fa ha scritto un articolo in cui ha detto che la giustizia è
lenta a causa dei troppi gradi di giudizio, dei troppi avvocati e del divieto
della riforma in peggio.
Sono discorsi già fatti, mi
stupisce che si continui a proporre riforme simili ad onta della loro
inconsistenza pratica e dell’insostenibilità scientifica. La storia dei troppi
avvocati mi fa sinceramente sorridere: mica parliamo di processo civile dove
l’azione è esercitata dagli avvocati? Il lavoro agli avvocati, qui, sono le
Procure a fornirlo. Forse sotto simili assunti si sottende che gli avvocati
“inducono” i loro assistiti ad impugnare; insomma, non sono discorsi da farsi.
Piuttosto direi che sono i magistrati ad essere in numero nettamente inferiore
rispetto al necessario. Quanto al tema del divieto di riforma in peius, mi
sembra costituzionalmente disdicevole ed evoca nuovamente un istituto caro al
legislatore fascista; senza dire che avrebbe la stessa inesistente efficacia
deflattiva dell’art. 96 c.p.c., privo di effetti apprezzabili, come ben sanno i
civilisti. Quanto all’argomento dei troppi gradi di giudizio, mi limiterò a dire
che prima di sfiorare – anche solo sfiorare, ripeto – un tema del genere,
andrebbe assicurata una reale qualità nell’amministrazione della giustizia;
vogliamo parlare dei numeri degli errori giudiziari? Aggiungo invece questo:
sono anni che si scarica la responsabilità dei ritardi del processo penale sulle
povere Corti d’appello. Anche qui, però, i dati statistici dimostrano che i veri
problemi stanno altrove. Ma su questo tornerò nella prossima tranche della
nostra ricerca.
Indagini in fumo. Crisi
magistratura e caos processi, il bilancio nero della magistratura: “Uno su tre
va in prescrizione”.
Viviana Lanza su Il Riformista il 21 Gennaio 2022.
La crisi di credibilità della
magistratura (dopo, e non solo con, il caso Palamara), la riforma strutturale
mancata, il numero elevatissimo di processi, il numero ridottissimo delle forze
in campo, le lacune, le sproporzioni, il coraggio delle scelte che in alcuni è
mancato, l’impegno di chi nonostante tutto ha provato a fare la propria parte. E
poi, i processi prescritti (uno su tre in appello, il 6% in primo grado) e gli
effetti della pandemia sull’andamento della giustizia e dei reati.
L’annuale bilancio in
previsione dell’anno giudiziario ripropone i temi di sempre, meglio sarebbe dire
le criticità di sempre. «A fronte di un risultato positivo del settore civile e
lavoro deve rilevarsi ancora una volta la situazione sempre più drammatica in
cui versa il settore penale ordinario della Corte che ha subìto maggiormente le
difficoltà di celebrazione dei processi determinate dalla pandemia», dichiara il
presidente della Corte d’appello Giuseppe De Carolis di Prossedi, illustrando i
dati dell’ultimo anno di attività nel distretto di Napoli: 10.170 processi
definiti (più del 2020 in ogni caso) ma con una sopravvenienza di 12.255 (la più
alta d’Italia) e una pendenza passata da 55.409 a 57.293. «Provate a fare 57mila
processi in secondo grado in due anni con 39 giudici – afferma –. Già sappiamo
che la gran parte di questi processi diventeranno improcedibili». Il riferimento
è ai paletti sui tempi del processo d’appello posti dalla riforma Cartabia. «Con
il Pnrr l’Italia si è impegnata con l’Unione europea a ridurre entro il 30
giugno 2026 il cosiddetto disposition time del 25% per il penale e del 40% per
il civile, nonché a ridurre l’arretrato civile del 90% rispetto ai valori del 31
dicembre 2019. Il disposition time – spiega – è la misura della durata media dei
procedimenti utilizzata in contesto europeo». A Napoli questo parametro è 1.660
nel settore penale, 768 in quello civile.
«Paradossalmente può essere un
vantaggio perché si abbatte l’arretrato, ma in realtà non si fa giustizia, si
eliminano solo le carte». E a proposito di tempi del processo, la prescrizione
riguarda un processo su tre in Appello, il 6% di quelli definiti in primo grado.
«Se lavoriamo sulla qualità, se facciamo i maxi processi alla camorra, è
difficile fare anche i numeri come si chiede con il disposition time e le
prescrizioni sono inevitabili, pur essendo una cosa molto triste – commenta De
Carolis – perché così si finisce per avere una giustizia solo formale. Si
mettono a posto le carte, a discapito dell’effettività della giustizia». Quanto
al nodo risorse, «abbiamo – spiega il presidente – una situazione di totale
sproporzione tra le forze in campo». «Abbiamo un alto numero di pm, 107 solo a
Napoli e circa 200 in tutto il distretto, e circa 240 giudici penali in organico
mentre dovrebbero essere almeno il doppio, altrimenti non si sta dietro al
lavoro della Procura che rischia di essere vanificato – sottolinea De Carolis -.
In secondo grado poi abbiamo
in pieno organico una cinquantina di giudici, ma essendo in sotto organico si
arriva ad appena 39. Per cui tutte le sentenze che fanno i giudici penali del
distretto vanno a finire sulle spalle di 39 magistrati divisi in 13 collegi. È
come se versassimo ogni anno damigiane in un bicchierino». A ciò si aggiunga la
crisi di credibilità della magistratura, una questione morale che dura da molti
anni. «Non basta aver mandato via Palamara per ritenere risolti tutti i problemi
della categoria – afferma il procuratore generale Luigi Riello -. C’è un
cedimento valoriale che riguarda pochi magistrati, ma non pochissimi. Non
illudiamoci». E aggiunge: «Il circuito di governo autonomo non si esaurisce nel
Csm, al di là del suo funzionamento buono o cattivo, delle sue cadute o non
cadute di stile, ma deve coinvolgere i capi degli uffici.
Nel corso del 2021 ho fatto sì
che due magistrati del distretto fossero colpiti da provvedimento cautelare di
trasferimento d’ufficio. Dobbiamo metterci in gioco in maniera piena: se c’è
qualcosa di negativo bisogna scriverlo e assumersi la responsabilità, non
possiamo lamentarci di ciò che accade se noi a capo degli uffici per primi non
ci assumiamo le nostre responsabilità. Chi non ha il coraggio di scrivere le
cose negative su colleghi quando purtroppo con amarezza bisogna farlo, non
faccia domanda, si faccia da parte e se ne vada».
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Dal "Corriere della Sera" il
17 gennaio 2022.
Golfo dei Poeti, La Spezia.
Succede che una famiglia, marito e moglie, fra i tanti problemi ne abbia uno che
non li fa dormire: lo sciacquone del wc dei vicini. Troppo rumoroso.
La loro camera da letto
confina con un nuovo bagno realizzato dai quattro fratelli che abitano
nell'appartamento adiacente. La coppia si rivolge al Tribunale di La Spezia per
eliminare lo scarico e chiede un risarcimento del danno per le notti insonni. Ma
niente da fare: causa bocciata.
La coppia è però tenace e
ricorre in appello a Genova. Viene disposta una perizia nella quale tecnici
sottoscrivono che effettivamente siamo di fronte a un caso di «superamento della
normale tollerabilità e di spregiudicato uso del bene comune, posto che la
cassetta del wc era stata installata nel muro divisorio di cm 22». Il che
condizionerebbe la vita dei due.
Codice alla mano significa
«lesione del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di
vita quotidiana, diritti costituzionalmente garantiti e tutelati dall'articolo 8
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo».
Conclusione: sciacquone da
ricollocare e risarcimento di 500 euro all'anno a decorrere dal 2003, anno in
cui è stato piazzato il nuovo scarico. Ma i fratelli non ci stanno e si
rivolgono alla Cassazione, che però respinge il ricorso: tre decibel di troppo
«rispetto agli standard previsti dalla normativa specifica».
La Corte Suprema ha
riconosciuto così il «pregiudizio al diritto al riposo» e confermato la condanna
dei quattro «rumorosi» fratelli.
Giustizia, se l'abuso del
diritto viene eretto a sistema: le leggi "sgradite" e il pessimo vizio della
sinistra.
Iuri Maria Prado su Libero Quotidiano il 18 gennaio 2022.
Si dice, non del tutto a
torto, che esiste un garantismo classista per cui ci si indigna quando
l'ingiustizia molesta la gente "perbene", mentre se il malcapitato è un
poveraccio, tanto più se immigrato, ci vuole il randello e altro che presunzione
di innocenza e diritti della difesa. Il rilievo avrebbe un senso se non fosse
fatto dai responsabili di un pregiudizio opposto, e cioè quello per cui il
privilegio economico e sociale costituisce un titolo sufficiente a "meritare"
una giustizia cattiva: che è un atteggiamento identicamente classista.
Ma non basta. Perché ad
opporsi al primo pregiudizio (che tanto per intenderci chiameremo di destra) non
c'è soltanto quello di segno contrario per cui è giusto che "anche i ricchi
piangano", ma un impedimento sistematico: e cioè la completa estraneità, anzi
l'avversione, ai criteri dello Stato di diritto. È da lì, da sinistra, che viene
a tradizione delle sentenze “costituzionalmente orientate”, in buona sostanza le
decisioni con cui ci si mette sotto i tacchi la legge che non piace, ola si
rivolta come un calzino, per l’affermazione di una giustizia più confacente alle
rimasticature ideologiche con cui si pretende di modellare la società per via
giudiziaria.
È da lì, da sinistra, che
viene l’idea di degradare a faccenda trascurabile, a cavillo, la principale
garanzia in qualsiasi sistema di diritto: e cioè il diritto individuale di
protestare la propria innocenza contro la pretesa punitiva dello Stato
reclamando che esso rispetti anche l’ultima virgola della propria legalità. Lo
Stato di diritto sta esattamente in questo: nel rispetto della punteggiatura. E
se da destra può venire una punteggiatura sbagliata (è comunque una colpa), da
sinistra viene la licenza del testo arbitrario e rimaneggiabile a capriccio,
vale a dire l’abuso eretto a sistema. C’è dunque a destra e a manca il
garantismo farlocco. Ma uno avrebbe qualche possibilità di emendarsi. L’altro
no.
Zaleuco sulla scia di
Licurgo Dalla Locride il primo nomoteta.
Un libro del magistrato
Condemi ripercorre la storia dell'inventore del diritto. LUIGI MARIANO GUZZO su
Il Quotidiano del Sud il 16 Gennaio 2022.
“I magistrati non siano
ostinati, non giudichino per fare oltraggio, e nel dare le sentenze non abbiano
presente né l’amicizia né l’inimicizia, ma la giustizia. In tal guisa daranno
giudizi giustissimi e si mostreranno degni del loro posto”. Parole, queste, per
davvero attuali, specie ai nostri giorni, in cui assistiamo ad una crisi, anche
etica, della magistratura. Si tratta di una sentenza normativa da far risalire
intorno al settimo secolo avanti Cristo, attribuita a Zaleuco, il “primo
legislatore del mondo occidentale”, come leggiamo in una targa marmorea affissa
all’ingresso del Palazzo di Giustizia di Locri.
La recente pubblicazione
“Gerace e Zaleuco. Da alba della civiltà a patrimonio dell’umanità” (Academ
Editore, 2021) di Luigi Condemi di Fragastò, magistrato della Corte dei Conti di
Roma e docente universitario, ha il grande il merito di far riemergere
dall’oblio dei tempi contemporanei la figura di Zaleuco, legislatore e giudice,
contestualizzandola nei territori della Locride, tra Gerace e Locri Epizefiri,
dove il “nomoteta” (cioè, colui che stabilisce la legge, il legislatore) sarebbe
nato, avrebbe compiuto gli studi giuridici e avrebbe operato. Con questo libro
di Condemi, l’Academ Editore, sotto l’intuizione e la direzione dei giornalisti
Roberto Messina e Carmelo Lentino, inaugura una collana di studi giuridici
dedicata ai grandi protagonisti del diritto.
La vita di Zaleuco rimane
sospesa tra la storia e la leggenda. Come sottolinea Condemi, la stessa
indicazione di “primo legislatore” non è del tutto corretta se pensiamo a
Licurgo, vissuto tra il dodicesimo e il decimo secolo prima di Cristo. A parte
ciò, non vi è dubbio che le leggi di Zaleuco – delle quali ad oggi non ci
rimane, purtroppo, un corpo organico – abbiano inciso notevolmente
nell’elaborazione giuridica della Magna Graecia. Peraltro, si tratta di leggi
“scritte” e non consegnate, quindi, alla indeterminatezza della tradizione
orale. Inoltre, la prescrizione del comportamento è spesso accompagnata, in caso
di violazione, dalla previsione di una sanzione. In tal modo, queste leggi sono
molto efficaci e, soprattutto, sottratte alla discrezionalità dei giudici. “Le
sue leggi furono particolarmente apprezzate, tanto che vennero copiate da
Caronda, legislatore di Katane (Catania), che le diffuse in altre polis della
Magna Grecia (Reggio Calabria, Turi), oltre che in Atene, dove rimasero in
vigore per ben duecento anni”, scrive Condemi nel suo libro.
La concezione del diritto che
ritroviamo in Zaleuco è ovviamente di origine sacrale, in quanto si ritiene che
le leggi siano state dettate direttamente da Minerva. Ciò comporta anche
un’attitudine a considerare il corpo normativo come immutabile, a meno di non
adottare la procedura del “laccio al collo”: il cittadino che chiede la modifica
di una legge deve presentarsi davanti all’Assemblea dei Mille con un cappio al
collo, con la conseguenza che, nel caso in cui la variazione non sia accettata,
il proponente finisce soffocato: “colui che proponga al Senato la riforma o la
sostituzione di una legge vigente deve tenere un ‘laccio al collo’ pronto a
strozzarlo se la proposta non venga approvata”, leggiamo in una delle regole di
Zaleuco, arrivata fino a noi e riportata nel libro di Condemi. Questa procedura
– tramandataci da Demostene – ci può apparire, con gli occhi di oggi,
particolarmente brutale (e certamente lo è!), ma sta comunque a significare la
tendenza a mantenere il diritto pressoché immutato e immutabile, “permanente”.
Infatti, i locresi erano convinti che dalla stabilità del diritto dipendesse la
stabilità politica. Un insegnamento, quest’ultimo, di grande ispirazione ai
nostri giorni, in cui, al contrario, assistiamo in Italia ad un’attività di
iperlegificazione, con una continua sedimentazione di leggi su leggi, a fronte
del principio della certezza del diritto. Ciò è ben messo in evidenza nella
introduzione dell’avvocato Vincenzo Fulvio Attisani, il quale scrive: “Le aule
di Giustizia sono quotidianamente testimoni di un Diritto oggi a tratti
farraginoso, istericamente complesso, frammentato in miriadi di disposizioni
normative, spesso disarmonicamente sparse qua e là tra migliaia di leggi. Locri
Epizefiri fu invece antesignana di un indirizzo culturale ben differente, in cui
la “Norma”, divenendo via via più complessa per adeguarsi a una società in
crescita, veniva comunque organizzata e compendiata, sì da essere agevolmente
conosciuta e riconosciuta da tutti”.
Inoltre, l’attualità delle
leggi di Zaleuco è data anche dal fatto che il diritto si configura come limite
al potere politico, allorché – leggiamo – “nessuno deve stimarsi superiore ad
esse [le leggi]”. Tant’è che, “il decoro e l’utile è posto nel credersi
inferiore e nello seguire il comando”. Certo siamo ben lontani da una piena
eguaglianza davanti alla legge: nelle città greche rimane affermata la
distinzione tra cittadini liberi e schiavi, nonché l’esclusione delle donne
dalla vita pubblica. Così come, in fin dei conti, alla base della produzione
normativa penale di Zaleuco vi è la “regola del taglione”: “dev’essere cavato un
occhio a chi ne cavò un altro” (vale a dire: occhio per occhio, dente per
dente!). Ma nelle tesi di Zaleuco pare comunque riecheggiare una sorta di
ispirazione che – utilizzando le nostre categorie giuridiche – potremmo definire
giusnaturalistica, per la quale la legge diventa un argine all’arbitrarietà del
potere politico. D’altra parte, Zaleuco è giudice imparziale, al punto – secondo
quanto ci è stato tramandato – da decidere di far cavare l’occhio al figlio,
colpevole di adulterio: la scena è mirabilmente rappresentata nell’affresco di
Perin del Vaga “La Giustizia di Zaleuco” (1521), oggi esposto a Gli Uffizi. Ma,
secondo un’ulteriore versione della storia, Zaleuco si fa cavare lui stesso
l’occhio per non accecare del tutto il figlio (un occhio per lui e un occhio per
il figlio).
Insomma, il libro di Condemi
ci permette di riscoprire la figura di Zaleuco, che tanto, davvero tanto, ha da
dire alla civiltà giuridica contemporanea. E la Calabria può così ritenersi
culla, tra le altre, del diritto occidentale.
Il giudice che collezionava
strumenti di tortura. E ci nascondeva le mazzette…Una
storia di giustizia tormentata scritta da un giudice. Ogni riferimento a fatti
reali è puramente casuale, così come a fatti di cronaca accaduti. Roberto
Oliveri del Castillo su Il Dubbio l'8 gennaio 2022.
Il Tribunale di Belvirate era
non era veramente un tribunale. Sembrava più un museo, visto che in passato era
stato un carcere in epoca austroungarica, con le sue segrete sotterranee
collegate al vicino castello veneziano, eretto su un più antico fortilizio
bizantino, posto a protezione del lato est del territorio imperiale, a guardia
dall’arrivo dei mongoli. Da queste parti li hanno attesi per secoli, a volte
sembrava che stessero arrivando, si intravvedevano polveroni all’orizzonte,
cavalieri e carri, soprattutto all’imbrunire, giusto per mettere in allarme le
sentinelle del castello sul poggio ad est, poi più niente per giorni e giorni,
per mesi lo sguardo perso nell’attesa.
Non era veramente un
tribunale, incastonato com’era tra l’antico Duomo gotico trecentesco, di fronte
al piazzale, e il palazzo della Curia, risalente al XVI secolo, a destra, eretto
ai tempi della controriforma, con annesso museo medioevale. Alle spalle del
tribunale si apriva poi l’ampio piazzale che conduceva al castello con le sue
massicce torri quadrate. E infine, a ridosso dell’intero complesso, i vicoli del
quartiere ebraico, con ben due sinagoghe, testimonianza di una delle più floride
e ricche comunità dell’est. Chiudevano il piazzale a sinistra il palazzo della
Dogana, e il vecchio monastero di San Giovanni, che secondo la leggenda non solo
sarebbe passato di qua, ma avrebbe anche scritto proprio da queste parti ampi
stralci della sua Apocalisse, forse sentendo la presenza del Maligno.
Ma non era veramente un
tribunale anche perché i capi degli uffici facevano i magistrati “a tempo
perso”, come un Presidente del Consiglio di qualche anno fa, sorpreso con alcune
dame di compagnia nella villa di famiglia, a cui confidava che il ponderoso peso
del governo era per lui, in realtà, un ameno passatempo. E facevano i magistrati
“a tempo perso” perché la loro occupazione principale era occuparsi delle loro
aziende. Sia il Procuratore Malerba sia il Presidente Adduce avevano chi una
azienda agricola, chi un resort a quattro stelle con annessa spa, e quindi erano
molto più interessati alle vicende delle loro imprese piuttosto che allo stato
dei rispettivi uffici giudiziari.
Quando arrivai qui, qualche
anno fa, trasferito dal Tribunale di Valdifiori nelle serre calabresi come
seconda sede, fui ricevuto da entrambi, e mi dissero che potevo fare domanda
tranquillamente, perché “si stava bene”. Questo mi doveva mettere in allarme:
che voleva dire, infatti, che “si stava bene”? Si riferiva alla vita? Al lavoro?
Al rapporto con gli avvocati? Può esistere un luogo di lavoro di giudice dove
“si sta bene”? O invece questo lavoro è per definizione un lavoro dove “si sta
male”, alle prese com’è con i mali della vita, decisioni, anche la più banale,
sempre impegnativa e difficile perché riguarda la vita degli altri? Invece non
ci feci caso, e ammaliato dalla bellezza del posto, ad un passo dalle montagne
innevate dell’est, estrema propaggine verso i sempre attesi barbari, decisi di
stabilirmi proprio qui, tra i vicoli del quartiere ebraico. Non immaginavo che
barbari erano già arrivati, e si erano già da tempo impossessati della città.
Qui lavorava da sempre il
giudice Bretella. Questo non era il suo vero nome, ma il suo soprannome, poiché
aveva una vera passione per le bretelle, che ostentava in vari colori e
fantasie. Ne aveva, si diceva, centinaia. Era costui un vecchietto magro e
leggermente ricurvo, naso aquilino, su cui poggiavano degli occhialetti tondi a
molla, molto retrò, capelli bianchi tirati all’indietro, il volto scavato
incorniciava degli occhietti piccoli e di un celeste slavato. Vestito sempre con
completi stile anni ’30 del 1900, a passeggio sempre con l’inseparabile bastone
col pomello argentato, abitava con l’anziana governante, ed era conosciuto da
tutti in città, oltre che per le doti di fine giurista, proprio per la sua
passione per il collezionismo. Quelle che erano note e palesi erano due:
bretelle e francobolli.
La sua bella casa, un attico
in un palazzetto dell’ottocento nel centro moderno, limitrofo alla centralissima
piazza della Repubblica, aveva una stanza adibita ad esposizione, con mobili
alle pareti dalle ante trasparenti dove alloggiavano infiniti album di
francobolli divisi e sistemati per provenienza geografica, mentre le bretelle
erano in un luogo più riservato, prossimo alla capiente cabina-armadio. Una
volta che lo andai a trovare, mi mostrò orgoglioso l’intera collezione delle une
e degli altri. Per i francobolli era in grado di precisare provenienza ed epoca
di alcuni pezzi pregiati, il cui costo, a me non appassionato del settore, mi
parve esorbitante.
In giro, però, si parlava di
un’altra passione che lo rendeva strano: collezionava strumenti di tortura,
trovati in giro per il mondo, e che secondo qualcuno erano collocati in alcuni
scantinati del palazzo, adibiti a esposizione in un luogo che poteva essere
considerata una camera degli orrori della storia giudiziaria. Una volta, visti i
buoni rapporti di colleganza, gli chiesi di vederla, ma lui negò di possedere
una siffatta collezione. Eppure qualcuno parlava della “Sedia di Giuda”, o della
“Sedia delle streghe”, degli “Strappaseni”, della “Vergine di ferro”, e di tutta
una serie di diavolerie usate dall’Inquisizione per strappare confessioni.
“Dicerie”, mi disse, chi mai collezionerebbe roba del genere? Se vuoi un giorno
ti mostrerò invece la mia collezione di pistole moderne, ne ho varie decine, e
alcune di cui vado molto fiero, soprattutto alcuni modelli della seconda guerra
mondiale, tra cui una Luger cal.9 appartenuta ad un ufficiale nazista, e una
Walter PPK simile a quella usata da James Bond nei romanzi di Fleming”. “Si mi
piacerebbe molto”, risposi convinto, le pistole erano una mia passione fin da
quando frequentavo il poligono di tiro, quando ero giù in Calabria, anche se non
fino al punto da collezionarle.
Un giorno, tuttavia, successe
l’imprevisto. Alcuni pentiti, che da mesi stavano rivelando una serie di
particolari su alcune assoluzioni sospette dei giudici del Tribunale di
Belvirate, avevano tirato in ballo il giudice Bretella e alcuni suoi
provvedimenti. Ebbene, le osservazioni, le intercettazioni e le rivelazioni di
alcuni pentiti avevano condotto gli inquirenti a sospettare che quei
provvedimenti di assoluzione fossero stati oggetto di compravendita da parte del
giudice. Il suo arresto, in virtù di inequivocabili riprese dove si notavano gli
scambi e i passaggi di buste negli stessi uffici giudiziari, e in particolare
nella stanza del giudice incriminato, fu un vero terremoto, anche se qualcuno
ricordava che alcuni pentiti di camorra già nei primi anni 2000 avevano parlato
di scambi di favori, ma non erano stati ritenuti credibili. L’ambiente era
scosso, avvocati e magistrati si trincerarono dietro le solite dichiarazioni di
circostanza circa “la necessità da parte dei cittadini di continuare a mantenere
la fiducia nelle istituzioni così gravemente colpite, e considerare il lavoro
onesto e indefesso di tanti professionisti, magistrati, avvocati e cancellieri,
che ogni giorno fanno il loro lavoro con onestà e dedizione”.
Sarà indubbiamente così, ma al
Tribunale di Belvirate quello che era successo non sembrava proprio
un’eccezione. Qualche anno addietro, infatti, erano stati arrestati, sempre per
corruzione, alcuni magistrati della Procura, che in combutta con un giudice per
le indagini preliminari, arrestavano cittadini innocenti per poi chiedere denaro
per la revoca degli arresti in carcere. Gli inquirenti, anche qui grazie a
pentiti e intercettazioni, avevano scoperto che i magistrati corrotti avevano un
vero e proprio tariffario delle scarcerazioni, che dipendeva dal tipo di misura
cautelare e dalle possibilità economiche del malcapitato, per lo più un
imprenditore o un facoltoso professionista.Un’altra modalità estorsiva
escogitata dal gruppetto di malavitosi in toga era far giungere tramite un
avvocato compiacente alla vittima una copia informale di una ordinanza di
custodia cautelare, dicendo “vedi, domani devi essere arrestato. Se paghi
10.000,00 euro questa la stracciamo”. E questi fatti erano andati avanti per
anni, nella assoluta, colpevole inconsapevolezza dei capi degli uffici.
A Belvirate, quindi, secondo
me, c’erano parecchi magistrati collezionisti, ma non collezionisti di bretelle,
francobolli, di armi, di orologi o quant’altro, no: collezionisti di soldi, che
infatti erano poi stati trovati nelle loro abitazioni, stipati nei luoghi più
impensati, in notevole quantità. Al giudice Bretella, ad esempio, molti pacchi
di banconote erano state trovati all’interno degli strumenti di tortura, quasi
come se il denaro, lo sterco del diavolo, e gli strumenti fossero accomunati
nella diabolicità della tentazione alla quale il giudice aveva ceduto, e nella
sua nemesi punitoria. Mi sembrava quasi di vedere in questo accostamento quello
che Kafka descriveva nella sua colonia penale, ovvero come l’erpice che scrive
la pena sulla pelle del condannato, fino a determinarne la morte, così qui il
denaro nascosto negli strumenti di tortura finiva con l’anticipare per il suo
possessore l’infausto esito detentivo e la sua moderna gogna mediatica,
provocato dal suo illecito procacciamento e per il mercimonio della funzione
giudiziaria di cui Bretella si era macchiato.
Si erano al contempo aperte
delle indagini ministeriali, per verificare come era potuto accadere che questi
fatti gravissimi avvenissero senza che alcuno denunciasse alcunché. Anche io fui
sentito da un funzionario, forse si riteneva non necessario che ad istruire la
pratica fosse un magistrato. Devo dire che mi feci un po’ prendere dal
nervosismo, e fui molto brusco con il povero incaricato. Quando mi fu chiesto se
avevo sentito dire qualcosa su queste vicende, sbottai “Ma mi scusi, lei dice
sul serio? Lei mi chiede se avessi sentore di ciò che accadeva? Certo che avevo
sentore, e che avrei dovuto fare? Denunciare le voci? Il sentito dire? Per
essere denunciato per qualunque e pagare anche cospicui risarcimenti? O non
siete voi, qui al Ministero, ad avere in tutti questi anni ignorato tutto ciò
che accadeva all’ombra del Castello, tra capi degli uffici promossi nonostante
aziende e interessi economici rilevanti, a volte condotte da prestanomi; non li
avete nominati voi? E come dovevano interessarsi degli uffici se avevano da
badare ai loro interessi imprenditoriali? Costoro, affaristi senza scrupoli,
hanno prosperato nell’ignavia e nel disinteresse dei magistrati cd. “perbene”,
che sentivano la puzza, ma si giravano dall’altra parte. Ma come avete fatto?
Con tutti i procedimenti che si aprivano in tre o quattro procure competenti per
territorio, le indagini e i rinvii a giudizio che puntualmente si leggevano
anche sui giornali, a fare finta che non accadesse niente, quando la giustizia,
una giustizia con la g minuscola e mortificata, era oggetto di mercimonio e
corruttela? Dove eravate, voi che avete consentito per vent’anni a questi
cialtroni di spadroneggiare? Non li avete messi voi nel posto che hanno
oltraggiato con le loro condotte? Lo sapete che parenti e sodali sono tutti ben
inseriti nelle amministrazioni locali? Che loro congiunti figurano nelle
municipalizzate e in tutto il territorio del circondario del tribunale? E non
potreste accertarlo da soli di chi si tratta, facendo partire accertamenti e
indagini a tappeto acquisendo per prima cosa informazioni sui processi pendenti,
in modo almeno da allontanarli dagli uffici pubblici trasformati in studi
professionali con parenti e amici? E ve lo dovrei dire io? Addio, non ho altro
tempo da perdere …Vi auguro buona fortuna con le vostre indagini!”.
Alla fine, se non me ne fossi
andato sbattendo la porta, avrei potuto avanzare una proposta, avrei suggerito
di sopprimerlo questo Tribunale, e fargli riprendere le sue antiche funzioni di
museo, magari allocando in un ala dello stesso palazzo l’esibizione degli
strumenti di tortura sequestrati al giudice Bretella, e nello stesso tempo
cominciare a scegliere come capi degli uffici magistrati normali, con una storia
di dedizione al lavoro, piuttosto che capi degli uffici, “a tempo perso”, scelti
solo perché amici delle persone giuste, che in quel momento hanno il potere di
decidere.
Attendiamo tutta una vita i
barbari, abbiamo la guardia alta verso il nemico all’orizzonte, e spesso non ci
accorgiamo che questo è già penetrato nella nostra cittadella, ce l’abbiamo
affianco, davanti, ci andiamo a pranzo o a cena, ci scherziamo prendendo il
caffè in ufficio, mentre questi, silenzioso come un topo in un sotterraneo, rode
le fondamenta dell’edificio dei nostri valori e del nostro lavoro, fino a farlo
crollare, seppellendoci tutti. Ogni riferimento a fatti reali è puramente
casuale, così come eventuali riferimenti a fatti di cronaca effettivamente
accaduti.
Roberto Oliveri del Castillo,
Magistrato della corte d’appello di Bari, ex gip a Trani
La polvere sotto il
tappeto. Alice nel paese delle meraviglie è lo specchio della giustizia
italiana: sono la stessa cosa.
Otello Lupacchini su Il
Riformista il 9 Gennaio 2022.
Giudicare è compito
necessario, non potendo una società lasciare senza conseguenze comportamenti
incompatibili con la sua ordinata sopravvivenza; ma anche impossibile, non
potendosi mai avere la certezza di riuscire a conseguire la verità, là dove è
proprio su questa che si fonda la rettitudine della convivenza civile. È da tale
contraddizione che nasce l’esigenza del «processo», quale metodo meno imperfetto
per pronunciare una decisione giusta che si sia pronti ad accettare pro
veritate. Varcata la soglia del tribunale, tuttavia, si entra in un mondo di
apparenze che spesso coprono l’inganno o, anche, l’autoinganno: le leggi, i
magistrati e i burocrati possono simulare e far prevalere la menzogna. Gli
sfondi culturali sono ormai jeux de mode: il pubblico chiede del feuilleton,
biascicamenti gergali, filosofemi da Luna Park, effusioni umide et similia;
tutto beve, purché sia nero, stupido, sanguinolento.
Sembrerà magari audace che
ricordi, dunque, due situazioni esulanti dal repertorio consueto delle immagini
distorte o delle satire dell’amministrazione della giustizia, dove il processo è
guardato «dal basso», con gli occhi delle vittime impaurite, o «dall’alto», con
quelli dello spettatore divertito o sdegnato. Vale a dire, i comportamenti di
Alice e di Josef K., i quali esprimono la superiorità e il disprezzo di chi,
indipendentemente dal ruolo provvisoriamente assunto, la prima come avvocato
difensore e il secondo quale imputato, credendo si trattasse di processi veri,
constatando, tuttavia, ben presto, la sgangherata sovversione di ogni regola
processuale e logica, ha il potere di annientarli. Josef K. abbandona sdegnato
la strana udienza nella quale si è fatto coinvolgere, una domenica mattina, in
un quartiere proletario della città: «Pezzenti (Lumpen). Teneteveli i vostri
verbali!». Gesto teatrale che sembra consapevolmente ricalcato su quello di
Alice, quando questa tronca l’assurdo processo al Fante di Cuori gettando in
aria le carte da gioco che popolano Wonderland ed esclamando: «Chi vi bada? …
Non siete altro che un mazzo di carte!». Poco importa se quest’ultimo episodio
costituisca o meno, in termini narrativi, il modello, se non certo dell’intero
romanzo kafkiano, almeno di qualche suo episodio.
Esso offre, infatti, il destro
per proporre un istruttivo giro nell’universo letterario di Lewis Carroll, dove
ci s’imbatte in alcuni processi che si prestano a essere considerati, oggi più
che mai, quando la crisi senza fine dell’amministrazione della giustizia cade
sotto gli occhi di tutti, in una prospettiva assai meno superficiale di semplici
manifestazioni letterarie dello stupore, dell’ilarità e della diffidenza che il
funzionamento delle istituzioni giudiziarie ha sempre e dovunque suscitato tra i
profani, nella consapevolezza, esatta da Friedrich Nietzsche, che al mondo si
può solo alludere indirettamente tramite simboli e metafore. Il primo lo
troviamo in Alice in Wonderland, nel «racconto in forma di coda» che il Topo fa
ad Alice, per giustificare la propria avversione per i cani, ma anche per i
gatti. Un cane di nome Fury incontra per caso un topo e, «non avendo niente da
fare», lo invita a partecipare con lui ad un processo, precisando che egli vi
assumerà il ruolo di accusatore e il topo quello dell’accusato. Quest’ultimo
obietta impaurito: che processo potrà mai essere senza giudice né giuria? «“Son
giudice e giuria!” fu del can la follia: “son io tutta la legge e ti condanno a
morte”», risponde il cane.
Il secondo, che si celebra
presso la «corte» dei reali di Cuori, lo si trova nell’undicesimo e nel
dodicesimo capitolo dello stesso libro. Imputato è il Fante, accusato di aver
rubato dei dolci preparati dalla Regina, la quale è a un tempo parte lesa,
coadiutrice del giudice e componente, con il Re stesso, dell’ufficio della
pubblica accusa. La giuria è composta da dodici animaletti di varia specie,
disorientati e ottusi. Araldo, usciere, cancelliere e in genere maestro di
cerimonie è il Coniglio Bianco. Di avvocati difensori, nel testo non vi è
traccia. Dopo la solenne lettura del capo d’imputazione, il re invita subito la
giuria a pronunciare il verdetto, ma il Coniglio Bianco gli fa presente la
necessità di assumere prima di tutto le prove. Vengono allora sentiti, in veste
di testimoni, il Cappellaio Matto, la cuoca della Duchessa e, finalmente, Alice.
Esaurita, senza alcun esito apprezzabile, l’escussione dei testimoni, il Re
torna a sollecitare il verdetto della giuria; ma è ancora una volta il Coniglio
Bianco a impedirlo, segnalando al Re un documento decisivo, che si suppone
provenga dall’imputato, quantunque non rechi traccia della sua calligrafia.
Il documento, letto con la
consueta solennità dal Coniglio Bianco, risulta contenere una poesia nonsense,
come tale incomprensibile; ma ciò non impedisce al Re di esultare, fregandosi le
mani. È a questo punto che si accende una vivace disputa ermeneutica fra il Re e
la Regina da una parte e dall’altra Alice, erettasi a tutrice del senso comune e
indirettamente a difensore del Fante, la quale ribadisce la futilità della prova
raccolta, mentre gli altri insistono nel ravvisare nel documento
un’inconfutabile dimostrazione di colpevolezza dell’imputato. Il Re tronca la
discussione, invitando per la terza volta la giuria a pronunciare il verdetto.
Questo ennesimo sovvertimento delle regole processuali eccede la sopportazione
di Alice, che, contestando drammaticamente la serietà e la realtà stessa della
corte, pone fine repentinamente sia al processo sia al sogno in cui esso
s’inserisce.
Anche il terzo processo
carrolliano si colloca in una dimensione onirica, nel sesto «sussulto» di The
Hunting of the Snark: un Barrister, facente parte di un equipaggio salpato per
dare la caccia allo Snark, mostro la cui identità e il cui aspetto non saranno
mai rivelati, a un certo punto si addormenta e sogna di trovarsi «in una corte
ombrosa», dove proprio lo Snark (in toga e parrucca) è apparentemente impegnato
nella difesa di un maiale. Nessuno enuncia chiaramente il capo d’imputazione: si
arguisce l’accusa mossa all’imputato solo dopo che il mostro «inimmaginabile» e
perciò non ritraibile parla già da tre ore. Eloquente e puntiglioso, lo Snark
indica la legge su cui si fonda l’accusa; allega la marginale partecipazione del
suo assistito al delitto; ne sostiene la perfetta solvibilità; si richiama alla
prova di un alibi, tanto più ridicola in quanto al maiale parrebbe contestarsi
il reato di allontanamento dalla stiva; si rimette alla clemenza della giuria
indicando al giudice come riferirsi alle sue annotazioni «per sintetizzare il
caso». Poiché, tuttavia, il giudice ammette candidamente di non aver mai
sintetizzato prima le risultanze di una causa, a ciò provvede ancora lo Snark,
che opera una sintesi così perfetta da ricomprendere anche quanto mai detto dai
testimoni. Quando tocca ai giurati pronunciare il verdetto, anch’essi declinano
il compito, essendosi imbrogliati, a loro dire, nel sillabare le parole;
tuttavia, osano sperare che sia sempre lo Snark ad assolvere quel dovere.
Sebbene esausto per la fatica, il mostro provvede all’incombente e quando
pronuncia «Colpevole!», dalla giuria si leva un lungo gemito e qualcuno cade
addirittura svenuto.
Essendo il giudice troppo
emozionato per pronunciare la sentenza, è necessario provveda anche a questo lo
Snark e se quando commina la pena i giurati non nascondono la loro gioia il
giudice resta invece dubbioso. Ma ecco che compare il carceriere, per
comunicare, in lacrime, che il maiale è ormai morto da alcuni anni, sicché la
sentenza non potrà essere eseguita. Alla notizia, il giudice s’allontana
disgustato, mentre lo Snark, riassunto l’originario ruolo di difensore, riprende
imperterrito la sua arringa, sui cui echi roboanti il Barrister si sveglia. Nei
tre processi carrolliani, le caratteristiche del due process of law, del «giusto
processo», sono ignorate, calpestate e derise quanto lo sono la logica, il senso
comune, le regole del linguaggio, sicché, all’esito della lettura, si è più
angosciati che divertiti: il Topo è tratto a giudizio senza nessun’altra
giustificazione che la noia e il capriccio del suo accusatore, che in più si
arroga la funzione di giudice e di giuria e gli preannuncia una condanna a
morte; il Fante di Cuori, accusato di furto, si ritrova a dover fronteggiare,
senza avvocato difensore, un giudice prevenuto e subordinato alla parte lesa,
una giuria di animali stupidi e ignoranti e una serie di elementi probatori
tanto più temibili e schiaccianti quanto meno sono razionali; il maiale
patrocinato dallo Snark, se la morte non lo avesse già sottratto a ogni
problema, subirebbe una condanna durissima, per un reato incerto e risibile, ad
opera del suo stesso avvocato inopinatamente investito di funzioni giudicanti.
Nihil sub sole novi.
Otello Lupacchini.
Giusfilosofo e magistrato in pensione
La polvere sotto il
tappeto. Quel magistrato inquisitore degno erede di Torquemada.
Otello Lupacchini su Il
Riformista il 12 Gennaio 2022.
Ancora sul finire degli anni
Ottanta del secolo scorso, vigente il codice Rocco, dunque non senza una qualche
ipocrisia, risuonava l’avvertimento che il processo penale è e deve restare, in
ogni tempo e in ogni luogo, un «sistema di garanzie», senza cedimenti che ne
possano alterare o snaturare l’essenza: solo il rigoroso rispetto dei principi
fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione e dalle Convenzioni
internazionali, entrate a far parte del nostro Ordinamento, può assicurare un
processo penale degno di un Paese civile, moderno e democratico.
La riforma del rito penale,
entrata in vigore nel 1989, fu salutata come una svolta epocale nella
realizzazione di un meccanismo processuale penale realmente «accusatorio»,
all’altezza delle impellenti aspettative del cosiddetto fronte garantista. Pia
illusione. Il sistema accusatorio, fondato sulla formazione delle prove nel
contraddittorio, non esiste ormai più, tendendo queste a formarsi nel corso
delle indagini preliminari condotte dal pubblico ministero. E con esso si avvia
irrimediabilmente verso il definitivo tramonto l’esperienza del «giusto
processo», sebbene assurto ad autonomo valore costituzionale, con buona pace
della riforma cosiddetta Cartabia, volta com’era, almeno nelle intenzioni, poi
purtroppo in larga misura tradite, a incidere profondamente sulla prescrizione,
sul rinvio a giudizio, sulle priorità in materia d’esercizio dell’azione penale,
sul rinnovato vigore del principio costituzionale della presunzione di non
colpevolezza, dall’iscrizione della persona indagata sino al vaglio della
Cassazione.
La marcia à rebours verso il
progressivo abbandono della strada dell’ipocrisia del processo penale come
«sistema di garanzie», era iniziata, peraltro, già con l’epifania, tra le
fattispecie premiali, della collaborazione processuale, apparsa, sul piano dei
risultati pratici, strumento efficace per smantellare le organizzazioni
terroristiche, ma, sul piano degli orientamenti politico-criminali e degli
effetti di ripercussione sul sistema punitivo e nel suo complesso, anche tale da
suscitare le maggiori perplessità, non fosse che per la sua inevitabile e grave
ripercussione sulla dialettica processuale. Per un verso, infatti, la
collaborazione processuale si era ben presto trasformata in un paradigma
normativo sostanzialmente obbligatorio, essendo la mancata cooperazione
sanzionata non solo dalla persistenza degli effetti punitivi eccezionali
stabiliti per i reati commessi per finalità di terrorismo, ma, in termini
processuali, dal regime e dalla pratica della custodia cautelare, ricalcato
sulla falsariga della collaborazione e dalla sua entità.
Mentre, per altro verso,
il «pentito», che pagava in anticipo il prezzo del premio, per la riscossione
doveva attendere, tuttavia, la valutazione di un giudice diverso, con un duplice
ordine di conseguenze: la posizione del pubblico ministero non poteva che essere
caratterizzata dall’assenza di conflittualità con l’imputato collaboratore e,
per contrappeso, dall’aumento di conflittualità con l’imputato raggiunto dalla
chiamata di correo; il giudice del dibattimento, dal canto suo, o assecondava il
polarizzarsi del contraddittorio nel senso promosso dal pubblico ministero
ovvero assumeva il compito di attuare contro quella logica la più genuina
funzione del contraddittorio, rischiando, dunque, per questo di essere
trascinato in un rapporto conflittuale con l’imputato collaboratore; in entrambi
i casi ne sarebbe restata compromessa la propria funzione di «terzietà».
Nell’impossibilità o incapacità di risolvere altrimenti la vicenda terroristica,
il legislatore aveva anche finito per delegare il relativo compito ai giudici,
dotandoli dei poteri necessari, spesso estranei alla funzione giusdicente.
Un ruolo vicario penetrato, da
allora, nell’istituzione come messaggio e come costume, ben oltre i limiti a
esso assegnati: non v’è quasi più processo di una qualche importanza dove non
compaia il collaboratore di turno o dove la sua presenza non sia sollecitata
nello svolgimento delle indagini, e la mancanza di cooperazione sia
stigmatizzata come «omertosa» e, talvolta, addirittura «sanzionata» sul piano
della custodia cautelare o del trattamento penitenziario, con buona pace dei
diritti costituzionali e convenzionali. Nell’originaria formulazione, peraltro,
la cooperazione aveva una sua logica: i terroristi negano il sistema politico
nel modo in cui un cataro negava l’ecclesiastico; l’opposizione assume figure
fobiche, da guerra teologale: i settari oppongono un dogmatismo visionario
all’onnivoro pragmatismo, talvolta cinico, dell’istituto ecclesiastico. Su un
cataro-terrorista può darsi abbia, dunque, senso l’esorcismo allestito
dalla legge 29 maggio 1982, con quell’abiura imposta dall’art. 1: chiesa e setta
contendono sulle anime; genuina o simulata, la confessione serve ai dominanti;
equivale a un autodafé la «piena confessione» richiesta dagli artt. 2 e 3. Per
quanto perversa, questa logica, saltò, comunque, quando gli ambiti operativi e
le finalità della collaborazione processuale furono estesi a situazioni dove non
vi erano da promuovere soltanto processi disgregativi già in atto per
fronteggiare l’emergenza terroristico-eversiva, quanto piuttosto di fare i conti
con fenomeni di marca diversa, i cui protagonisti e i cui gregari non hanno
progetti politici implicanti l’abbandono di ideologie da ripudiare, ma faide da
compiere, prezzi da riscuotere o, peggio, ordini da eseguire.
Ecco, in proposito, cosa
scrisse il Giudice istruttore di Palermo, nel 1986, sui motivi che avrebbero
indotto Tommaso Buscetta alla scelta di collaborazione: «Egli, mafioso di
vecchio stampo, si era reso conto che i principi ispiratori di Cosa nostra erano
stati ormai irrimediabilmente travolti dalla bieca ferocia dei suoi nemici, che
avevano trasformato l’organizzazione in un’associazione criminale della peggior
specie in cui egli non si riconosceva più. Non aveva, pertanto, più senso
prestare ossequio alle regole di un’organizzazione in cui egli non credeva, non
aveva più senso tenere fede alla legge dell’omertà. Egli doveva operare per la
distruzione della “nuova mafia”, doveva vendicarsi dei tanti lutti subiti, ma la
soverchiante superiorità dei suoi nemici non gli lasciava molte speranze; non
gli restava altra via che rivolgersi alla Giustizia dello Stato per consumare la
sua vendetta e per salvare la sua vita». Insomma, sul terreno della criminalità
comune, sono venute a mancare le alternative politico-teologali ed esistono
limiti obiettivi al narrabile: il business ignora l’anima e le abiure vi suonano
male; l’autodafé scade, magari non sempre, ma comunque assai spesso, a farsa
dialettale, guastando l’effetto scenico complementare al lavorio istruttorio.
Inutile che l’inquirente cerchi mirabilia in materie sordidamente banali,
essendo improbabile ve ne siano.
Tutti sanno che esiste una
connection altolocata, notoria, visibile, penalmente inafferrabile: qualunque
sia la fonte da cui colano, delitto incluso, denaro e potenza psicagogica
influiscono sugli alambicchi dei poteri costituiti, venendo utili, ad esempio,
nelle partite elettorali. Là dove si voglia colpire i nodi perversi, è
necessario, dunque, individuare i punti in cui li alimenta il metabolismo
collettivo. Mosse simili esigono, comunque, una perfetta analisi del groviglio,
fantasia intellettuale, norme idonee, mani pulite e abili, ossia complesse
condizioni tecniche, più una costosa volontà politica. Ma è proprio qui che,
purtroppo, spesso casca l’asino. I filosofi hanno sempre cercato di stabilire la
certezza della conoscenza, il «punto d’appoggio» archimedico di tutta l’umana
conoscenza. E il pensatore che meglio ha rappresentato l’anelito a questa prima
certezza filosofica, anche se paradossalmente espresso all’inizio sotto forma di
dubbio totale su tutto ciò che ci circonda, è Cartesio. Per questo filosofo,
infatti, almeno una volta nella vita si dovrebbero mettere in discussione tutte
le conoscenze che ci sono state trasmesse, facendo passare tutte le informazioni
attraverso il provvidenziale setaccio della critica sistematica, con l’obiettivo
non già di approdare allo scetticismo, bensì il contrario: cercare di arrivare a
un punto indiscutibile, a partire dal quale possano conseguire tutte le
conoscenze future.
E il dubito, ergo sum dovrebbe
essere l’abito mentale del magistrato. Eppure, mi sono recentemente imbattuto in
un documento veicolante il testo di un interrogatorio approdato, qualche tempo
fa, solo Dio sa come, nella redazione di un giornale on-line, presentato con un
titolo nel quale si esalta l’«astuzia» dell’inquisitore per smascherare un falso
aspirante collaboratore, di cui stigmatizza la «farsa». Questo l’anatema,
tutt’altro che cartesiano, dell’inquisitore, degno erede, al netto dell’evidente
scarto culturale rispetto a taluni di essi, dei vari Robert le Bougre, Tomas de
Torquemada, Joseph Goebbels, Andrej Višinskij e altri consimili: «Noi oggi le
abbiamo fatto domande su omicidi dove abbiamo la prova di come sono andati i
fatti, non i gravi indizi di colpevolezza, la prova, per questo sono salito qua
oggi. Non siamo qui per parlare di cose nuove o inedite, noi stiamo parlando di
cose acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale e siamo pronti a
chiedere la condanna, ci sono persone che hanno spiegato per filo e per segno
come stanno le cose. E lei qui capo crimine, sta a fare le pulci a ogni frase
che dice (il pubblico ministero Tizio) o a ogni frase che dice (il pubblico
ministero Caio).
Ma stiamo scherzando?! Ma qua
c’è gente, c’è l’ultimo della ’ndrangheta, l’ultimo dei garzoni di ’ndrangheta
che si siede qui dove è seduto lei. Sa quanta gente abbiamo sentito qua? Che
parlano come l’Ave Maria! E lei qua è da stamattina che stiamo facendo il
braccio di ferro… Si comporta non da capo crimine, ma da spettatore». Al di là
dell’attendibilità del narrante e della credibilità della narrazione, tutte da
accertare, naturalmente, ma brutalmente liquidate opponendo l’autorità di
precedenti giudicati, dove è noto a chiunque sia minimamente educato al diritto
che la «verità legale» ben possa divergere dalla «verità naturale», sorge
spontanea la domanda se e quale «verità» cercasse di attingere dal suo
interlocutore l’astuto inquisitore.
Otello Lupacchini.
Giusfilosofo e magistrato in pensione
La polvere sotto il
tappeto. L’astuto inquisitore e l’ignoranza delle regole minime…Otello
Lupacchini su Il Riformista il 30 Gennaio 2022.
Tempi bui, giornate tristi,
fiori, campane a morto. I notiziari sono bollettini di guerra: la conta delle
vittime non ha fine. Per dirla con Bertolt Brecht (Lob der Dialektik,
1932): «Das Unrecht geht heute einher mit sicherem Schritt», l’ingiustizia,
insomma, oggi cammina con passo sicuro. Ogni parola è ormai un rumore inutile:
meglio sarebbe il silenzio, per chi sia inetto all’entertainment e, vagolando
magari dalla filologia romanza ai labirinti medievali, da François
Rabelais a Franz Kafka, da Hans Kelsen a Carl Schmitt, arroti una lingua
distante dalle dolcezze colloquiali dei tanto affabili poligrafi, se non
analfabeti comunque più spesso semianalfabeti, che spopolano nell’odierno
panorama (pseudo)culturale.
Parafrasando il
professor Francesco Muzioli, caduti tutti gli steccati e tutti i muri nella
confusione postmoderna, non ci sono più distinzioni di settore e neppure uno
straccio di competenza specifica, ed è possibile transitare liberamente, senza
passaporto di sorta, attraverso i confini che un tempo separavano la letteratura
dalla logica filosofica o dalla teoria politica economica, essendo ridotto
qualunque argomentare in amabile intrattenimento, tipo «conversazione», essendo
tutti quanti, siano essi letterati e filosofi, letterati-filosofi, giuristi
semianalfabeti o, addirittura, analfabeti tout court, nient’altro che
«scrittori», da valutare non secondo metodi e tradizioni proprie, ma vagliati
già da sé davanti all’unico giudice insindacabile che è il Mercato.
Vi sono, per fortuna, ancora
dei limiti all’indecenza, che impongono ai «competenti», di far sentire la
propria voce, per quanto sia loro consentito ed essa possa risultare, più che
sgradevole, sgradita, di fronte allo scempio che vien fatto del diritto e del
processo, a opera di taluni «menanti» dall’inadeguata professionalità, la cui
impreparazione giuridica favorisce una «informazione spettacolo», tendente a
presentare i fatti in forma personalistica e sensazionalistica, con grave
adulterazione, dunque, del valore di taluni atti o di taluni momenti
dell’accertamento giurisdizionale, bisognoso, invece, di un’accorta mediazione
tecnica. È, infatti, il professor Glauco Giostra a segnalare che, «una profonda
consapevolezza dell’effettivo significato processuale dell’attività giudiziaria
permetterebbe al giornalista di affrancarsi dalla sua fonte, nel senso che gli
consentirebbe di non esserne il passivo megafono, ma di valutare, apprezzare e
correlare ad altre conoscenze in suo possesso le notizie che gli vengono non
disinteressatamente fornite».
Il mio pensiero, in proposito,
corre, e non è la prima volta, avendovi fatto cenno in una mia precedente
riflessione, a quel verbale d’interrogatorio che, secondo il «menante» venutone,
solo dio sa come, in possesso, avrebbe condotto a emersione l’«astuzia»
dell’inquisitore, impegnato nella partita capitale la cui posta era lo
smascheramento di un asseritamente falso aspirante allo status di collaboratore
di giustizia. Quel «menante», forse proprio perché gravemente carente di
preparazione specialistica o, magari, soltanto per sensazionalistica
superficialità, non ha sottoposto alla doverosa critica il discorso
dell’«astuto» inquisitore. Se lo avesse fatto, avrebbe colto l’assurdità del
negare in radice, oltretutto affatto aprioristicamente, sia l’attendibilità
dell’aspirante collaboratore sia la credibilità di quanto da costui narrato,
adducendo l’autorità di precedenti «giudicati».
La «logica», absit iniuria
verbis, sottesa a questa «astuzia» è la stessa che indusse altro alumbrado a
manifestare, in un verbale di coordinamento delle indagini redatto presso
la Dna di Palermo il 22 aprile del 2009, «la sua contrarietà alla richiesta di
piano provvisorio di protezione (nei confronti di Gaspare Spatuzza, «aiutante
boia di Brancaccio», n.d.r.) sia perché essa attribuirebbe alla dichiarazione di
Spatuzza una connotazione di attendibilità che ancora non hanno (sic!), sia
perché le dichiarazioni di Spatuzza, sebbene non ancora completamente
riscontrate, potrebbero rimettere in discussione le ricostruzioni e le
responsabilità delle stragi, oramai consacrate in sentenze irrevocabili, sia
perché l’attribuzione, allo stato, di una connotazione di attendibilità alle
dichiarazioni di Spatuzza potrebbe indurre l’opinione pubblica a ritenere che la
ricostruzione dei fatti e le responsabilità di essi, accertate con sentenze
irrevocabili, siano state affidate alle dichiarazioni di falsi pentiti protetti
dallo Stato, e potrebbe, per tale ultima ragione, gettare discredito
sulle Istituzioni dello Stato, sul sistema di protezione dei collaboratori di
giustizia e sugli stessi collaboratori di giustizia».
Eppure, sia detto per inciso,
proprio grazie alle asseverazioni di Gaspare Spatuzza fu possibile acclarare
come le indagini dei pubblici ministeri che, coordinati dal procuratore capo
di Caltanissetta, nei primi anni Novanta del secolo scorso, seguivano le
indagini del gruppo investigativo «Falcone/Borsellino» guidato da Arnaldo La
Barbera, fossero inquinate dalle false dichiarazioni, fra gli altri, del
«superpentito» Vincenzo Scarantino, indottrinato per allontanare la verità sulla
strage di via D’Amelio. Il medesimo «menante», a dimostrazione dell’«astuzia»
dell’inquisitore, ne riporta la seguente proposizione rivolta all’aspirante
collaboratore: «Noi oggi le abbiamo fatto domande su omicidi dove abbiamo la
prova di come sono andati i fatti, non i gravi indizi di colpevolezza, la prova,
per questo sono salito qua oggi».
Mossa sommamente incauta, in
quanto evidenzia i limiti tecnico-giuridici dell’astuto inquisitore: non è
paradosso l’idea che ci troviamo difronte a un problema d’igiene linguistica,
circolando troppe parole equivocamente adoperabili. Secondo i grandi maestri
della retorica, da Aristotele a Ermagora di
Temmo, a Cicerone, a Quintiliano, tra gli strumenti per la formazione del
giudizio di fatto la distinzione fondamentale era quella tra le «probationes
inartificiales», che si presentavano al giudice così com’erano, senza alcuna
elaborazione da parte del retore, quali le testimonianze e i documenti, e le
«probationes artificiales», costruite o «inventate» dal retore, secondo lo
schema argomentativo identificabile con quello della prova presuntiva o
indiziaria di cui parlano gli articoli 2727 e 2729 del codice civile, nonché
l’articolo 192 comma 2 del codice di procedura penale.
Quando il fatto «principale»,
oggetto della controversia o dell’accusa non può essere provato «direttamente»,
con inspectio ocularis, testimonianze, confessioni o altro, si individuano come
oggetto fatti diversi, «secondari», cioè indizi, dai quali, in concorso tra
loro, possa inferirsi il fatto principale, in applicazione di una «regola
d’esperienza», che può avere natura logica o scientifica, ma corrispondente, più
spesso, semplicemente a un criterio di normalità, secondo l’id quod plerumque
accidit. Se sia più efficace, in sede di valutazione da parte del giudice, la
prova «diretta» o la prova «indiziaria», è problema diversamente risolto a
seconda della più moderna concezione «dimostrativa» della prova o di quella
«persuasiva» dei retori classici: nel primo caso, la prova indiziaria vale di
regola meno di quella diretta; nel secondo caso, era vero il contrario: «Apud
bonum iudicem argumenta plus quam testes valent», diceva Cicerone (De republica,
I. 38).
Per giustificare questa
affermazione apparentemente paradossale, senza affrontare qui il tema fin troppo
impegnativo delle due diverse concezioni di «verità» sottese alla
contrapposizione di opinioni sulla prevalenza della prova «diretta» o
della prova «indiziaria», basti evidenziare che l’argumentum è un prodotto
finito elaborato e perfezionato dall’arte del retore e da lui tradotto in un
linguaggio conosciuto dal giudice; là dove, invece, la prova «diretta», ivi
compresa la stessa «inspectio ocularis», è un materiale grezzo, o tutt’al più un
semilavorato, che si presenta al giudice con tutte le sue asperità e tutti i
suoi difetti, potendo il narrante mentire, ricordare male, esprimersi
confusamente; il documento essere di difficile lettura o interpretazione; il
giudice fraintendere ciò che vede con i suoi occhi; e, quindi, essere, in
definitiva, più ingannevole. Come, allora, ognun vede, la mossa astuta riposa su
un’analisi a dir poco corriva, eccessivamente approssimativa, sbagliata del
fenomeno probatorio.
Da altra proposizione
dell’astuto inquisitore («Non siamo qui per parlare di cose nuove o inedite, noi
stiamo parlando di cose acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale e
siamo pronti a chiedere la condanna, ci sono persone che hanno spiegato per filo
e per segno come stanno le cose»), emerge, peraltro, che quella che costui
sbandiera è una prova narrativa, che cola da «persone che hanno spiegato per
filo e per segno come stanno le cose», in contrasto con altra prova narrativa,
che cola dall’aspirante collaboratore di giustizia. In simile contesto, dove si
contrappongono due prove «dirette», parlare a vanvera di «prova» e di «gravi
indizi», evocando la formula dell’articolo 273 comma 1 del codice di procedura
penale, segnala l’ignoranza delle minime regole semantiche e logico-giuridiche
di chi si crede fin troppo furbo.
Otello Lupacchini.
Giusfilosofo e magistrato in pensione
Filippo Facci per “Libero
quotidiano” il 10 gennaio 2022.
Se si trattasse solo di dare
una notizia, sarebbe questa: le accuse dei pubblici ministeri, nei processi
italiani, vengono sconfessate nel 36 per cento dei casi, i quali salgono
approssimativamente al 50 per cento se comprendiamo le prescrizioni. Il problema
è che pioverebbero smentite e repliche non tutte in cattiva fede, visto che
ciascuno si appella a dati diversi e spesso visti da un'angolatura ancor più
diversa.
Il punto è che parlando del
disastro della giustizia italiana - da mesi, da anni - ci sono tre domande a cui
nessuno sembrava saper rispondere, o alle quali ciascun soggetto dava una
risposta troppo difforme da quelle altrui perché suonasse credibile.
Le domande erano: che cosa
può o vuole fare, seriamente, l'annunciata riforma del Ministro Cartabia?;
soprattutto, quali sono, di preciso, le lagnanze della Commissione Europea
(Cedu) sulle disfunzioni della nostra Giustizia?; perché, infine, i dati sui
tempi, sui proscioglimenti e sulle disfunzioni della giustizia italiana non
quadrano mai coi dati opposti dalla magistratura, come per esempio ha ribadito
il Procuratore Generale Giovanni Salvi nella sua Relazione annuale sulla
giustizia medesima?
Bene, ora una risposta un po'
più seria ce l'abbiamo, anche se siamo costretti a condensarla nei limiti di un
articolo senza che tuttavia non cambia percezione finale, che è una sola: è
impressionante.
Dobbiamo la possibilità di
rispondere a uno studio - impressionante a sua volta: per accuratezza e
complessità - pubblicato sull'ultimo numero di Archivio Penale e curato dalla
nota giurista Cristiana Valentini, ordinario di procedura penale, la quale
dimostra quanto mal riposto fosse l'ottimismo del Procuratore Generale Giovanni
Salvi quando disse che «le assoluzioni depurate degli esiti non di merito sono
in realtà inferiori al 20 per cento del totale».
Il procuratore rispondeva a
quanti rilevavano una distonia tra l'esercizio dell'azione penale e i suoi esiti
dibattimentali, cioè processuali: «Questa discussione si basa in realtà su di
una non corretta informazione, derivante dalla imperfezione della raccolta e
dell'analisi del dato, causata da una storica sottovalutazione dell'aspetto
conoscitivo del sistema giudiziario».
E su questo aveva senz'altro
ragione. Il problema è che è lo studio di Cristiana Valentini ha preso in esame
ogni procedimento penale sin dalla «scaturigine» (la notizia di reato e la sua
gestione) e fino al suo epilogo.
I dati di Salvi (i dati in
generale) per esempio non tengono mai conto anche delle denunce iscritte a
"modello 46", ossia le notizie da fonte anonima (soffermandosi perlopiù sulle
notizie di reato iscritte a "modello 21", registro noti) e tantomeno le notizie
iscritte nel registro "modello 45", ossia gli atti non costituenti notizia di
reato, che non compaiono in nessuna statistica ministeriale (la Valentini ha
dovuto procurarseli per conto proprio) e che per l'anno 2019, l'ultimo
disponibile, ammontavano a oltre 1.198.000.
Ora: al modello 45 - questo lo
aggiungiamo noi - il cittadino mediamente istruito sa che un pm tenda a
ricorrere quando ritiene appunto che non esista notizia di reato, come nel caso
di denunce presentate da pazzi con manie di persecuzione, insomma, è una forma
di archiviazione: ma un qualsiasi avvocato praticone sa che non è vero, come
spiego Antonio Di Pietro nel 1997 credendosi al riparo da orecchie indiscrete:
spiegò che il modello 44 e 45 servivano provvisoriamente a guadagnare tempo
visto che i tempi delle indagini preliminari in teoria duravano solo sei mesi.
La Valentini traduce così:
«Una minima esperienza empirica in possesso di qualsivoglia avvocato insegna che
a registro degli atti non costituenti notizia di reato finisce ben altro dei
deliri immaginifici del soggetto psichiatrico di turno».
In sostanza i "modelli 45"
testimoniano che la cifra reale della discrezionalità (incontrollata) dei
pubblici ministeri è molto più alta di quanto si sospetti. $ un mare magnum di
apparenti «non notizie di reato» che non prevedono limiti di tempo, pronte da
ripescare a piacimento, magari a carico di «finti» ignoti che quest' ultimi, di
fatto indagati o persone offese, secondo una logica fuori legge, consente vere e
proprie «istruttorie occulte».
$ anche una specialità
siciliana- aggiungiamo noi anche questo - a cui ricorsero per esempio nella
fallita inchiesta «sistemi criminali» o in un'altra dove gli indagati vennero
celato sotto le sigle «XXXXX» e «YYYYY», e che si ossequia criteri selettivi
misteriosi quanto incontrollabili dove l'unico a fungere da nocchiero è il
pubblico ministero.
Ecco, di queste notizie di
reato nascoste, iscritte a "modello 45", non è a conoscenza neppure la
volenterosa Commissione Lattanzi messa in piedi dal ministro Cartabia, per
capirci. Ma sono bel altri, ed esulano dai limiti di questo articolo, gli esempi
di come i pubblici ministeri possano ampliare i loro poteri discrezionali e
incontrollabili in modo che sfugga all'occhio ma soprattutto alla statistica,
nascosto nelle pieghe oscure del sistema.
Se a tutto questo aggiungiamo
i controversi e confusi numeri (comunque bassissimi) di ricorso ai riti
alternativi da parte dei pm, dei quali mancano dati completi relativamente alle
richieste di rinvio a giudizio e ai proscioglienti, giungiamo infine alla
risposta che più si temeva, ossia quella sul che cosa possa effettivamente fare
la ministra Marta Cartabia assieme a Giorgio Lattanzi (ottimo ex presidente
della Corte costituzionale) in tema di riforma della Giustizia.
La risposta è niente.
L'imprinting dato alla sua Commissione in fondo non è diverso da quello affidato
al peggior ministro Guardasigilli della storia italiana, Alfonso Bonafede:
assicurare una ragionevole durata del processo e recuperare una miglior
efficienza ed efficacia dell'amministrazione della giustizia. Parole.
Le ingiuste
detenzioni nodo irrisolto della giustizia. “Ancora troppi casi come quello di
Enzo Tortora”, parla l’avvocato Giovanni Palumbo.
Viviana Lanza su
Il Riformista l'11
Gennaio 2022.
«Mi domando cara
Silvia che cosa posso insegnarti dalle mura di Regina Coeli. Fra le mura della
16 bis dove fa un caldo atroce. Siamo in sei disperati e fuori si vede il cielo.
Che posso insegnarti, mi chiedo, perché a te, devi saperlo, è a te che il mio
cuore più spesso vola…». Era l’estate del 1983, Enzo Tortora aveva da poco
iniziato il terribile calvario giudiziario che lo portò in cella da innocente.
Silvia, sua figlia, è morta ieri a Roma. Aveva 59 anni, come suo padre quando
morì. E come suo padre, era una giornalista che aveva scelto di raccontare la
verità dei fatti e si è spesa in nome del garantismo.
La notizia della
sua morte ha aggiunto dolore e amarezza al ricordo di una delle pagine più
dolorose della storia giudiziaria napoletana, oltre che nazionale. Enzo
Tortora fu ingiustamente detenuto e processato. «Mai più» si disse dopo lo
scandalo giudiziario che lo travolse. E invece cosa è cambiato in questi quasi
quarant’anni? Napoli continua ad essere la capitale delle ingiuste detenzioni, e
sebbene sia un distretto giudiziario molto ampio con numeri ben superiori a
quelli di altri distretti è pur vero che detiene questo triste primato da quasi
dieci anni.
Le ingiuste
detenzioni sono state 101 nel 2020, a febbraio si conosceranno i casi del 2021 e
ai dati ufficiali bisognerà aggiungere un centinaio o più di innocenti
invisibili che non hanno avuto accesso al risarcimento per l’ingiusta detenzione
per un “cavillo” (è accaduto che il risarcimento, per esempio, sia stato negato
a chi da indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, perché pur
avvalendosi di un proprio diritto avrebbe contribuito all’errore degli
inquirenti che lo avevano messo in carcere per accuse poi rivelatesi infondate)
oppure per una scelta personale (sono molti quelli che dopo anni di processo
vissuti da innocenti ingiustamente detenuti non hanno più né la forza economica
né quella mentale di intraprendere un nuovo percorso giudiziario seppure per
vedersi riconosciuto un proprio diritto, cioè quello al risarcimento per il
danno subìto dalla detenzione ingiusta).
L’ingiusta
detenzione è una delle più dolorose piaghe del nostro sistema giustizia. «Il mio
compito- scriveva Tortora dopo il suo arresto del 17 giugno 1983, in una delle
tante lettere inviate alla compagna Francesca Scapelliti – è uno: far sapere. E
non gridare solo la mia innocenza, ma battermi perché queste inciviltà
procedurali, questi processi che onorano, per paradosso, il fascismo vengano a
cessare. Perché un uomo sia rispettato, sentito, prima di essere ammanettato
come un animale e gettato in carcere. Su delazioni di pazzi criminali». Il
processo a Enzo Tortora si svolse a Napoli negli anni del post-terremoto, dei
magistrati che si giocavano la carriera anche sulle indagini sulla camorra e dei
primi collaboratori di giustizia. Il processo seguiva il vecchio codice penale e
ai pentiti Gianni Melluso, Giovanni Pandico e Pasquale Barra i pubblici
ministeri dell’epoca diedero credito al punto da mandare in galera un innocente.
Tortora fu ritenuto coinvolto in un giro di droga che riguardava uomini della
Nco di Raffaele Cutolo. Tutto falso. L’avvocato Giovanni Palumbo era all’epoca
un giovane penalista e affiancava suo padre, l’avvocato Tommaso Palumbo, nella
difesa di due imputati che secondo la fantasiosa ricostruzione dei pentiti
avrebbero fornito droga al famoso giornalista. «Ricordo ogni udienza, era chiaro
sin dal primo momento che ai pentiti si era dato troppo spazio creando
confusione tra falsità e verità ma ci vollero anni per dimostrarlo».
Le parole
di Tortora rivolte ai giudici prima che andassero in camera di consiglio («Devo
concludere dicendo: ho fiducia. Io sono innocente, lo grido da tre anni, lo
gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io
spero, dal profondo del cuore che lo siate anche voi») sono il momento che
l’avvocato Palumbo ricorda con maggiore commozione. E di fronte ai dati, ancora
oggi impietosi, sugli innocenti in cella commenta: «Non ci sarà nessuna riforma
veramente efficace finché nel nostro sistema non sarà attuata una vera svolta
culturale e abbandonata del tutto quella mentalità di tipo inquisitorio che
ancora resiste».
Viviana Lanza.
Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è
giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed
economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del
quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il
Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
La malagiustizia. Innocenti
in carcere: un detenuto su tre vittima di ingiusta detenzione.
Viviana Lanza su Il
Riformista il 7 Gennaio 2022.
Le statistiche dicono che
in Campania, e il dato è in linea con quello nazionale, un detenuto su tre è
innocente. Le chiamano ingiuste detenzioni, sono quanto di peggio possa capitare
ad una persona che, per un caso o per un errore di un pm o un investigatore, si
ritrova ad essere rinchiuso in una cella, con persone sconosciute, per giorni,
settimane, mesi. Persino anni quando ci si imbatte in pubblici ministeri
convinti della propria tesi di partenza e per niente disposti a tornare sui
propri passi. Ci sono ricostruzioni accusatorie che vengono portate avanti
nonostante le lacune e le contraddizioni che emergono nel corso di accertamenti
successivi, nonostante le alternative e i chiarimenti forniti dalla difesa,
nonostante una pronuncia diversa da parte di un giudice.
Il tutto, nei tempi dilatati
della giustizia, con l’incertezza di non sapere mai se ci vorranno mesi oppure
anni per arrivare a ristabilire la verità. Spesso si dice che la custodia
preventiva è una sorta di anticipazione sulla condanna, ma quando la condanna
non c’è perché non ci deve essere, perché si stabilisce che la persona arrestata
e messa sotto accusa è innocente, quella carcerazione preventiva diventa
soltanto tortura. E non possono certo i soldi del risarcimento (riconosciuto
dopo un percorso giudiziario altrettanto lungo e niente affatto scontato, perché
lo Stato può anche negarlo) cancellare come un colpo di spugna i danni di
una detenzione ingiusta. C’è chi perde il lavoro quando finisce coinvolto in
un’inchiesta e non lo ritrova quando, dopo anni di processo, viene assolto. C’è
perde anche gli affetti. Ci sono famiglie e vite rovinate da arresti e accuse
che non hanno ragion d’essere, che magari sono solo il frutto di un
convincimento sbagliato di un pm o di testimonianze che alla fine vengono
ritrattate o di indizi che non poggiano su alcuna prova. Negli ultimi
trent’anni, in Italia, si sono contati quasi 30 mila errori giudiziari, con
risarcimenti per quasi 900 milioni di euro.
Napoli e la Campania hanno
registrato negli ultimi dieci anni numeri da record. Nel solo distretto di
Napoli, che comunque è tra i più grandi distretti giudiziari del Paese, si
stimano più di cento casi all’anno. Nel 2012 si registrava un caso di ingiusta
detenzione al giorno, poi il ricorso alle manette facili, seppure a fasi
alterne, è stato ridimensionato ma non a sufficienza perché risulti sempre
applicato il principio in base al quale la reclusione preventiva in carcere deve
essere l’extrema ratio. Nel 2020 si sono registrati 101 casi di innocenti
ingiustamente arrestati, ma se si considera che questi accertati sono soltanto
il 30% delle cause di risarcimento per ingiusta detenzione proposte è chiaro che
il fenomeno ha proporzioni ben più ampie. A fine mese il ministero della
Giustizia dovrebbe rendere noti i dati più aggiornati del 2021. Nel discorso di
Natale, la ministra Marta Cartabia ha affrontato anche il tema degli errori
giudiziari, delle lettere per i risarcimenti che arrivano al Ministero, “dietro
ogni lettera ci sono sempre singole persone, vite in carne ed ossa”.
Bisognerebbe ricordarlo sempre, in ogni istante. E tutti.
La ministra ha ricordato, tra
quelle che l’hanno più colpita, la storia del professor Francesco Addeo, oggi
80enne, nel 2001 scienziato di fama internazionale finito al centro di
un’inchiesta penale e persino in carcere per quattro mesi e ai domiciliari per
altri due a seguito di dichiarazioni di due imprenditori che nel corso del
processo non si sono rivelate fondate. Di qui la sua assoluzione ma un danno
nell’anima che resta indelebile. E storie come questa si ripetono a centinaia
ogni anno. L’associazione Errorigiudiziari.com da venticinque anni raccoglie
dati e storie di vittime di malagiustizia. Puntando la lente su Napoli si scopre
l’incubo di un 35enne, sposato con una figlia di tre anni, che un pomeriggio di
maggio di quattro anni fa viene convocato dai carabinieri per una generica
comunicazione di servizio e si ritrova in manette, dopo che gli viene notificata
un’ordinanza di custodia cautelare, per accuse gravi come rapina aggravata e
violenza sessuale. Gli viene concessa una telefonata alla moglie e viene portato
a Poggioreale. La vittima dice di aver riconosciuto in lui l’autore
dell’aggressione subita mesi prima. E tanto basta.
Il 35enne resta in cella per
tre giorni e ne trascorre altri 141 agli arresti domiciliari. In primo grado
viene condannato a otto anni di reclusione, in appello la sentenza viene
ribaltata e il 35enne viene assolto. L’assoluzione diventa definitiva ma ci
vorranno due anni di calvario giudiziario. Ora il 35enne è in attesa che venga
accolta la sua richiesta di risarcimento per l’ingiusta detenzione sofferta.
Iter più o meno simili hanno segnato le storie di altre vittime della giustizia,
dal camionista scambiato per narcotrafficante all’imprenditore mandato in
carcere come presunto killer e tenuto in cella per ottocento giorni e in
sospeso, legato al filo esile della giustizia, per oltre quattro anni in attesa
che nel processo si accertasse il grave errore dovuto a un’intercettazione male
interpretata dagli investigatori. Si può finire in carcere davvero per poco. Più
lungo e difficile il percorso per uscirne, anche se si è innocenti.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Il bilancio dell'anno giudiziario 2021.
Io, avvocato a Napoli, vi racconto i paradossi di una giustizia che non c’è.
Gennaro De Falco su Il Riformista il 31 Dicembre 2021.
Ieri ho chiuso l’anno giudiziario 2021 con la prima udienza per fatti del 2010
di un processo che ancora non si sa neppure chi deciderà e che per ragioni
prettamente biologiche concluderanno, se avranno fortuna, i miei nipoti se per
sventura dovessero fare il mio stesso lavoro (e poi dicono che i processi si
prescrivono per colpa degli avvocati) . Se e quando il processo dovesse finire,
gli imputati saranno ampiamente morti per vecchiaia. Dirà il mio eventuale
lettore: «Ma come può essere possibile? Sarà un caso?». Ed io non potrò che
dirgli: «Sbagli mio caro, è quasi la regola e non solo a Napoli ti assicuro».
Sfogliando l’agenda vedo un altro processo su cui pure ci sarebbe tantissimo da
scrivere. L’imputato risponde di aver venduto ben 27 Cd contraffatti nel 2004 –
sì, nel 2004 avete letto bene! -. Diciotto anni per stabilire se e quale pena
dovrà essere inflitta all’ormai canuto imputato che tanti anni fa si è imbattuto
in questo ormai altrettanto canuto difensore che ancora aspetta la definizione
di tante vicende anche molto più assurde di quelle che ho appena accennato. Ad
esempio, aspetto ancora la fissazione, o meglio il pervenimento in Cassazione,
di un altro processo per fatti del 2003 (diciannove anni fa) in cui tre dei
quattro imputati sono stati assolti da gravissime imputazioni associative.
Il pm ha ritenuto di impugnare la sentenza
assolutoria (confondendo nei suoi motivi di appello anche la sede dove operava e
indicando un Tribunale per un altro). Il processo è quindi arrivato in appello
dove si è ibernato per circa dieci anni e poi la Corte di appello, alla fine di
tutto, ha confermato la decisione assolutoria del Tribunale dichiarando, e
vorrei pure vedere, la prescrizione dei reati minori per l’unico tapino
condannato che ancora aspetta da 19 anni di conoscere la sua sorte. Il tutto
mentre i tre assolti sono stati per 19 anni senza dormire la notte, in attesa
che la loro assoluzione venisse confermata anche in appello. Ma, nel frattempo,
uno con un carico pendente di questo tipo come fa a trovare lavoro, come campa?
E non continuo questo elenco disperato non perché non abbia da scrivere ancora.
Se potessi, potrei riempire l’intero giornale con storie anche peggiori di
queste, solo che alla fine sarei tanto noioso e ripetitivo che nessuno
leggerebbe. Non diversa è la sorte delle denunce e, soprattutto, delle querele
dove la disperazione di noi avvocati raggiunge, se possibile, ulteriori vette di
dolorosa impotenza.
Ormai, forse anche per il palese ingolfamento
degli uffici quasi tutte le denunce, anche per fatti davvero gravissimi e con
rilevanti conseguenze economiche, vengono archiviate con motivazioni davvero
sconcertanti e solo il clamore della stampa riesce, in qualche rarissimo caso, a
farle fortunosamente rivivere. Tempo fa depositai una denuncia per
maltrattamenti ed altro in favore di una donna marocchina cui il marito, di
stretta osservanza islamica, tra l’altro voleva imporre di non uscire di casa e
di indossare il velo, e solo una vivacissima campagna di stampa che stava per
provocare una mezza crisi diplomatica ha spinto il pm a revocare la sua
richiesta.
In quella denuncia la donna, che logicamente non
ha un euro, chiese anche di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato ma
ad oggi non le hanno neppure risposto. E io, nel frattempo, ho dovuto anticipare
spese vive e lavoro che non so se e quando mi verranno rimborsati. Io, che ho un
animo missionario e posso permettermelo, l’ho difesa ugualmente e continuerò a
farlo ma chi non dispone di queste possibilità o magari vuole solo essere pagato
per il lavoro che fa? Come può sostenere questa situazione e poi è giusto che
accada? È vero, per questa vicenda sono stato a cena con diversi ambasciatori
che mi hanno anche applaudito e premiato, che un eminentissimo Monsignore mi ha
degnato della sua benedizione e che mi hanno anche accompagnato in albergo in
una splendida limousine con targa diplomatica, che qualche giorno dopo mi hanno
anche invitato alla cena degli ambasciatori ma a me tutto ciò appare
assolutamente surreale.
Lo smarrimento si acuisce quando si vedono invece
processi per fatti del 2020 che vanno speditissimi e in cui si contesta
l’appropriazione indebita di «2 mazzole, 2 scalpelli, 2 metri da misura, 2
tenaglie, un martello da carpentiere, tre lenze ed una livella» che l’imputato
non ha restituito agli operai di cui si era servito. In questi termini mi pare
evidente che l’istituzione giudiziaria nel suo complesso sia un mero costo per
la collettività senza alcuna utilità apprezzabile. Gennaro De Falco
Investe un cinghiale in
strada: “Ora paga”. L’incredibile processo a Terni.
Il Dubbio il 06 gennaio 2022.
Pubblichiamo il racconto esilarante di un avvocato su un automobilista citato in
giudizio perché ritenuto "corresponsabile" dell'animale selvatico per danni alla
circolazione
C’è nella tradizione tedesca
una storia condensabile nella famosa frase: “Ci sarà pure un Giudice a
Berlino!”, che si dice sia citata anche da Bertolt Brecht, il quale non l’ha
invece scritta da nessuna parte. Si tratta, comunque, delle vicissitudini del
mugnaio Arnold il quale traeva la sua unica fonte di reddito dall’uso di un
mulino ad acqua a Sans-Souci, nei pressi di Postdam, finché un nobile
proprietario del terreno a monte, non aveva deciso di deviare per suo diletto le
acque del ruscello che avevano così cessato di alimentare il frantoio a valle.
Ridotto in miseria, il povero Arnold aveva provato a reagire al sopruso
affrontando senza alcun successo numerosissimi gradi di giudizio, finché non
aveva trovato “un giudice a Berlino”, che gli aveva dato al postutto piena
ragione.
Personalmente non so se ci sia
ancora “un giudice a Berlino”, ma so che non ce n’è uno qui, nel circondario di
Terni, per Tizio, come risulterà evidente dalla storia “vera” che vado a
raccontare. Tutto è iniziato in una sera di maggio del 2020, quando Tizio stava
percorrendo l’affascinante Valnerina alla guida della propria vettura e, giunto
nei pressi del piccolo ma intrigante paese di Ferentillo, si è trovato di fronte
un bel cinghialone che gli ha attraversato all’improvviso la strada, rendendo
inevitabile l’urto. La bestia, di notevole stazza e possanza, non moriva però
sul colpo, ma caracollava in avanti per un centinaio di metri, fino ad urtare
l’auto di Caio che stava sopraggiungendo nell’opposto senso di marcia. Così
descritto brevemente il fatto, la risposta alla domanda “chi paga?” è una sola:
paga la Regione che risponde dei danni causati alla circolazione stradale dai
cinghiali, quale proprietaria della fauna selvatica, proprio come avviene per il
privato il cui animale d’affezione provochi danni alla circolazione stradale,
sfuggendo al controllo del padrone. Tutto molto semplice, quindi, ma
evidentemente fin troppo elementare se l’avvocato di Caio – credendosi erede del
genio italico – si è andato inventando la strampalata tesi che il danno alla
vettura del suo assistito non l’aveva provocato il cinghiale, da cui era stata
materialmente colpita, ma Tizio che dopo aver urtato con la sua auto l’animale,
lo aveva fatto letteralmente volare – e non caracollare – per 100 metri,
scaraventandolo addosso a quella di Caio. Tant’è che lo citava in giudizio –
quale artefice, appunto, del “cinghiale volante”-, al posto della Regione, unica
responsabile per legge e per nomofilachia – e non per capriccio ermeneutico -,
del sinistro causato dall’animale di sua proprietà.
Ebbene, raccontata in giro
questa storia, gli addetti ai lavori si sono messi le mani nei capelli, i meno
esperti di infortunistica stradale hanno riso di gusto e i bambini, amanti per
loro natura delle favole, hanno battuto le manine immaginando lo sventurato
cinghialotto che volava grugnendo per 100 metri ed atterrava senza paracadute e
con le orecchie al vento sull’auto di Caio. Il bello – si fa per dire! – è
che non ha invece riso un Giudice di Pace di Terni, che si è al contrario
invaghita del dissennato ghiribizzo ed ha battuto le mani proprio all’idea di
poter accollare a Tizio la responsabilità dei danni causati da quel cinghiale
maldestro, che invece di morire sul colpo – come ogni animale di buoni costumi e
di sano rigore morale dovrebbe fare! -, era andato ad impattare con la vettura
di Caio. Di tal che, a prescindere dalle cennate considerazioni giuridiche che
non paiono appassionare i due operatori del diritto, il brocardo di fondo
sarebbe, ad summam: “Se adeguatamente sollecitato, un cinghiale di 80 chili, può
volare per 100 metri”. A ciò si aggiunga – e l’addendum non è certo di poco
momento -, che il Giudice ritiene di poter valutare una corresponsabilità di
Tizio ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile, quando unica legittimata ad
eccepire tale eventuale concorso – quale esimente totale o parziale della
propria responsabilità -, sarebbe stata semmai la Regione, la quale non è però
parte in causa. Cosicché, incredibile dictu, si arriverebbe a sentenziare un
concorso di colpa di Tizio con il povero cinghiale – privo, ahinoi, di difesa
processuale! – nella causazione del danno, con conseguente “meritata” lesione
anche dei diritti di Caio – in quanto maldestro artefice dell’autolesionistico
inguacchio -, il quale vedrebbe limitata del 50% la sua pretesa risarcitoria!
E allora, cari amici, se
doveste mai imbattervi – viaggiando nel territorio ternano – in un cinghiale che
dopo avervi attraversato la strada sbucando all’improvviso dalla boscaglia, non
dovesse morire subito lì, sotto le ruote della vostra auto, ma proseguire
caracollando – o persino volando – la sua corsa fino a causare danni in giro
anche a centinaia di metri di distanza, fate una novena a Sant’Antonio a che gli
eventuali danneggiati siano assistiti da un avvocato meno “estroso e geniale”
del Nostro e raccomandatevi a tutti gli altri Santi del calendario, affinché la
potenziale causa non venga affidata al prefato Giudice di Pace.
Sandro Tomassini, Avvocato del
Foro di Terni
·
La durata delle indagini.
Indagine: spingere la
selvaggina (e la verità) nella rete.
Paolo Fallai su Il Corriere
della Sera il 19 luglio 2022.
Indagine è una parola che si è
conquistata nel tempo uno spettro talmente ampio di significati da aver bisogno
spesso di un aggettivo qualificativo per evitare equivoci. Eppure, nasce con una
origine che non si presta a nessun fraintendimento, anzi oltre a spiegarla
magnificamente la illumina eliminando ogni zona d’ombra. Una tecnica
precisa. Indagine è una parola latina composta da indu (variazione antica
di in- per indicare «in, dentro») e il verbo agere, «spingere». Il risultato
indicava una azione tipica della caccia: spingere la selvaggina verso le reti
per poterla comodamente catturare. Premessa che rende molto più chiara
l’indagine che faremo sui moderni significati, che non hanno perso del tutto la
specificità della caccia. Niente è lasciato al caso. Il dizionario di Tullio De
Mauro riporta come primo significato «ricerca sistematica per conoscere,
scoprire qualcosa». Non una ricerca qualsiasi ma una «attività diligente e
sistematica volta alla scoperta della verità intorno a fatti determinati»
(Treccani). Andiamo molto oltre una semplice ricerca, identificando il frutto di
coscienziosi e seri accertamenti. La rosa dei campi. Per i motivi che abbiamo
visto l’indagine si è prestata a costruire un fiorire di locuzioni che ne
spiegassero la particolare natura. Tra le più conosciute l’indagine di mercato,
una ricerca di statistica economica che studia i prodotti, i gusti dei
consumatori e la distribuzione, per incrementare le vendite. Ma l’indagine può
essere nutrizionale (sui comportamenti alimentari di un determinato soggetto), o
più in generale statistica, linguistica, filologica, storica, sociologica. E
così via. Due esempi particolari. Esistono due tipi di indagine che per la loro
stessa natura ci aiutano a comprendere la serietà e la profondità di questa
ricerca. La prima è l’indagine pilota, una rilevazione preliminare che si svolge
su un campione ristretto ma rappresentativo, per consentire di raccogliere tutte
le informazioni utili a svolgere un’indagine completa. Il secondo esempio è
ancora più esplicito: chiamiamo indagine conoscitiva una speciale attività di
ricerca e raccolta dati che viene disposta dalle commissioni parlamentari per
acquisire informazioni e dati utili al lavoro del parlamento. Il plurale apre un
altro scenario. «Le» indagini ci accompagnano a scoprire un mondo intero di
investigazioni giudiziarie e degli organi di polizia. «Le» indagini hanno
l’obiettivo di fare luce su episodi di reato, crimini compiuti o sospetti. «Le»
indagini preliminari sono appunto le attività svolte dalla polizia giudiziaria
in base a un’informazione di reato, allo scopo di determinare l’eventuale
esercizio dell’azione penale. Questa attività viene coordinata da un pubblico
ministero e verificata da un giudice, il «giudice delle indagini preliminari»
(GIP). L’obiettivo non cambia. Anche in questo ambito giudiziario il significato
profondo dell’indagine non cambia: ci troviamo di fronte alla ricerca scrupolosa
della verità, a maggior ragione se si tratta di episodi criminosi con delle
vittime e dei presunti colpevoli. In fondo perfino l’immagine iniziale acquista
nuova luce: l’indagine non è altro che un insieme di accertamenti capace di
spingere i colpevoli nella rete della giustizia. Noir, fantasy, storici. Non può
stupire che l’indagine sia uno dei pilastri centrali di ogni opera letteraria,
dalla narrativa alla saggistica. E sarebbe davvero riduttivo pensare che
riguardi solo i noir, o i «gialli» (la letteratura d’inchiesta è sempre
colorata, ma questa è tutta un’altra storia). Ogni saggio che si rispetti è
frutto di una accurata indagine. Ogni tesi di laurea è un’indagine. Ogni
articolo serio, ogni inchiesta giornalistica, dovrebbe esserlo. Ma tutta la
letteratura, dalle fiabe ai poemi omerici, non è che l’insieme dell’indagine sul
significato della vita, che accompagna la civiltà umana. Almeno per gli uomini
civili. Per gli incivili non c’è speranza.
Troppo lavoro, così i
fascicoli giudiziari finiscono nella spazzatura: il caso a Napoli.
Viviana Lanza su Il
Riformista il 14 Aprile 2022.
L’ultima inchiesta, in ordine
di tempo, della Procura di Napoli contiene un dettaglio che, se confermato, è
l’ennesima spia di come disfunzioni e ritardi generino affanni, ansie, persino
comportanti esasperati o illeciti. Tra le righe di questa inchiesta viene fuori,
infatti, che una funzionaria giudiziaria pro tempore della quarta sezione
della Corte d’appello di Napoli avrebbe, tra febbraio e marzo 2021, distrutto,
soppresso e occultato atti giudiziari, interi fascicoli di processi
penali ancora in corso o già conclusi. In almeno cinquanta circostanze pezzi di
vita processuale di persone, anche ignare della soppressione delle carte che le
riguardavano, sono spartiti.
Nelle stanze della Torre del
palazzo di Giustizia al centro direzionale quei fascicoli erano diventati
arretrati da smaltire, in qualunque modo. La funzionaria è agli arresti
domiciliari da ieri, insieme a un assistente giudiziario della Corte d’appello
di Napoli. La funzionaria deve difendersi dalle accuse di soppressione e
distruzione di atti; l’assistente giudiziario dai reati di corruzione, accesso
abusivo a un sistema informatico e truffa in danno dell’amministrazione perché
sospettato di aver rivelato notizie e informazioni ritenute non ostensibili, in
alcuni casi anche in cambio di somme di denaro tra cinquanta e cento euro. Ma è
soprattutto la storia della funzionaria a colpire e ad accedere un faro sulla
situazione in cui versa la nostra giustizia e in cui si trova chi per essa
lavora.
Dalle intercettazioni al cuore
dell’inchiesta, gli stessi inquirenti sottolineano come la funzionaria avesse
manifestato a terzi «preoccupazione sia per la mole di lavoro in capo al suo
ufficio – a suo dire eccessivamente elevata – sia per la circostanza che alcuni
fascicoli risulterebbero smarriti», peraltro «…con il silenzio di altri
appartenenti all’amministrazione giudiziaria». In un passaggio emerge
addirittura il disappunto di un addetto alle pulizie che, di fronte alla mole di
carte da buttare che riempiono il cestino nell’ufficio della funzionaria, si
lamenta. Dentro ci sono fascicoli, buste, cartelle, documenti che
sistematicamente la funzionaria è accusata di aver fatto sparire gettandoli nel
contenitore della raccolta differenziata della carta. Non in cambio di soldi, ma
– almeno questo è il sospetto – per smaltire il troppo lavoro. Se così fosse il
fatto sarebbe comunque grave, perché tra quelle carte distrutte ci sono pezzi di
storia giudiziaria che hanno richiesto poi tempo per essere ricostruiti e forse
riguardano innocenti ingiustamente finiti sotto processo. Ma sarebbe un fatto
grave anche sotto un altro profilo: la giustizia è troppo in affanno.
La Corte di appello di
Napoli è un ufficio grande, che accoglie i processi di primo grado che arrivano
dai vari tribunali del distretto e parliamo di distretti altrettanto grandi,
basti pensare a Napoli, Torre Annunziata, Napoli Nord, Santa Maria Capua Vetere.
Questo significa che in Appello confluiscono migliaia di processi, da quelli con
un solo imputato ai maxiprocessi di criminalità organizzata con decine di
posizioni da valutare. Atti e fascicoli non si contano. Dalle immagini video
catturate dai finanzieri durante la fase delle indagini saltano agli occhi le
stanze piene di documenti. Anche la stanza dove lavorava la funzionaria da ieri
agli arresti domiciliari era sommersa dalle carte. Lei, intercettata, si
lamentava che in ufficio erano in pochi. Non è una novità, le carenze di
organico nel personale amministrativo del Palazzo di Giustizia di Napoli sono da
anni segnalate al Ministero che però ancora non ha trovato il modo di risolvere
il problema, con la conseguenza che pure a voler compiere i più ardui e leciti
sforzi organizzativi gli arretrati si sono accumulati di anno in anno, fino a
raggiungere i 50mila processi arretrati. Troppi, evidentemente. Per tutti.
percorsi della giustizia tradizionale.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Termini di durata delle
indagini preliminari, possibili proroghe e rimedi in caso di inerzia del
pubblico ministero.
Beatrice Alba su dirittoconsenso.it il 25 giugno 2021.
Introduzione
Il libro V del codice di
procedura penale si occupa delle indagini preliminari e dell’udienza
preliminare. Ai sensi dell’art. 326 c.p.p., “il pubblico ministero e la polizia
giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini
necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale”.
Da questa norma è possibile
ricavare lo scopo delle indagini preliminari: esse
sono finalizzate unicamente ad acquisire elementi di prova al fine di mettere il
pubblico ministero nella condizione di decidere se esercitare o meno l’azione
penale.
Gli atti di indagine
preliminare sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere
conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini.
Il codice fissa la durata
massima delle indagini preliminari. Questa previsione risponde a due esigenze:
quella di ridurre i tempi
delle indagini, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo ex
art. 111 Cost., in modo contenere i costi dell’amministrazione della giustizia e
rendere più proficua la successiva attività di acquisizione dibattimentale della
prova; e
quella di garantire
l’osservanza del principio di obbligatorietà dell’azione penale, fissando il
momento nel quale sarà necessario attivare i rimedi per sopperire all’inerzia
del pubblico ministero.
Durata delle indagini
preliminari
La durata delle indagini
preliminari è di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è
attribuito il reato viene iscritto nel registro delle notizie di reato, a pena
di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del
termine.
Il termine è, invece, di un
anno se si procede per uno dei gravi delitti indicati nell’art. 407 comma 2
lett. a) c.p.p..
Se è necessaria la querela,
l’istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui
queste pervengono al pubblico ministero.
Se è necessaria
l’autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della
richiesta a quella in cui l’autorizzazione perviene al pubblico ministero.
La Corte Costituzionale si è
occupata della questione relativa al contrasto del limite cronologico fissato
per le indagini preliminari con il principio dell’obbligatorietà dell’azione
penale sancito dall’art. 112 Cost. Pensiamo all’ipotesi in cui alla vigilia
della scadenza dell’ultimo termine prorogato per le indagini preliminari emerga
la necessità di ulteriori indagini. In questo caso delle due l’una: o il P.M.
rinuncia ad effettuarle oppure risulteranno inutilizzabili (anche se da esse
emerga la necessità di esperire l’azione penale) a causa del decorso del termine
per le indagini preliminari.
La Corte Costituzionale con
l’ordinanza n. 436/1991 ha escluso l’illegittimità della normativa che fissa la
durata massima delle indagini preliminari e prevede l’inutilizzabilità degli
atti compiuti dopo la scadenza dei termini sulla base di plurime considerazioni.
Tra queste, la più importante è data dal rilievo che l’impossibilità di compiere
altre indagini preliminari per scadenza dei termini e la conseguente eventuale
impossibilità di esercitare l’azione penale alla stregua delle indagini compiute
non preclude in un secondo momento l’esercizio dell’azione penale posto che,
dopo l’emanazione del decreto di archiviazione, il pubblico ministero può,
adducendo la necessità di nuove investigazioni, chiedere la riapertura delle
indagini ex art. 414 c.p.p., effettuare le nuove indagini e, se del caso,
esercitare l’azione penale.
Proroga dei termini di durata
delle indagini preliminari
La ricezione di una richiesta
di proroga delle indagini è spesso la prima informazione per l’indagato
dell’esistenza di un’indagine penale nei suoi confronti. L’avviso di garanzia,
infatti, spetta solo in caso di arresto, perquisizione e sequestro.
Il termine di sei mesi o di un
anno può essere prolungato nel caso in cui il pubblico ministero ne richieda al
giudice la proroga per giusta causa. Con tale dizione il legislatore ha voluto
riferirsi a ragioni oggettive riconducibili alla natura del procedimento e non a
ragioni di ordine generale, strutturali, personali od organizzative.
La richiesta contiene
l’indicazione della notizia di reato, senza che siano necessarie indicazioni
temporali e spaziali del fatto né delle norme che si intendono violate in
concreto, e l’esposizione dei motivi che giustificano la proroga, i quali
costituiscono l’oggetto del contraddittorio. I motivi addotti dal P.M. per
giustificare la sua richiesta sono quindi il vero oggetto del contraddittorio.
Non è possibile, invece, avere notizie sull’origine del procedimento penale né
sugli elementi raccolti.
Ai sensi dell’art. 393 c.p.p.
è possibile avanzare istanza di proroga anche nel caso in cui il P.M. o la
persona offesa ne facciano richiesta per eseguire l’incidente probatorio. In
questo caso il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per
il tempo indispensabile all’assunzione della prova quando risulta che la
richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata
anteriormente.
La proroga non può avere
durata superiore a sei mesi. Una volta ottenuta la prima, le seguenti richieste
di proroga necessitano di una motivazione più stringente, in quanto possono
essere chieste solo nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di
oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
La proroga può essere concessa
più di una volta, ma i termini delle indagini preliminari non possono comunque
superare i diciotto mesi, o i due anni se le indagini riguardano i delitti
indicati nell’art. 407 comma 2 c.p.p..
Per i reati contemplati dagli
artt. 572, 589 c. 2, 589-bis, 590 c. 3, 590-bis, 612-bis c.p., la proroga può
essere concessa solo una volta.
La richiesta di proroga deve
essere notificata, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 406 comma 5 bis), a
cura del giudice alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal
reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione,
abbia dichiarato di voler esserne informata. La finalità della notifica è quella
di consentire agli interessati di presentare memorie entro cinque giorni dalla
notifica. Si instaura così un contraddittorio di tipo cartolare, caratterizzato
dalla limitata conoscenza che le parti possono vantare circa gli atti di
indagine.
Il giudice deve decidere circa
la concessione o meno della proroga entro dieci giorni dal termine per la
presentazione delle memorie.
Nell’ipotesi in cui il giudice
conceda la proroga provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio senza
l’intervento del pubblico ministero e dei difensori. L’ordinanza non è
impugnabile.
In caso contrario, ovvero
qualora ritenga che la proroga non debba essere concessa, fissa la data
dell’udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico
ministero, alla persona offesa dal reato che ne abbia fatto richiesta e alla
persona sottoposta alle indagini. Nella stessa ordinanza che respinge la
richiesta di proroga il giudice, se il termine per le indagini preliminari è
scaduto, ne stabilisce uno non superiore a dieci giorni per consentire al
pubblico ministero di formulare la richiesta di archiviazione o di rinvio a
giudizio.
Gli atti di indagine compiuti
dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del
provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di
provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine
originariamente previsto per le indagini.
Inerzia del P.M.
Il comma 3 dell’art. 407
c.p.p. stabilisce l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la
scadenza.
Il comma successivo, inserito
dalla legge 103/2017, impone al P.M. di esercitare l’azione penale o richiedere
l’archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata.
L’unico rimedio all’inerzia
protratta dal pubblico ministero è quello dell’avocazione delle indagini da
parte del procuratore generale della Corte d’appello. Il potere di avocazione
combina il principio costituzionale della buona amministrazione dell’ufficio e
della ragionevole durata del processo (art. 111 c. 2 Cost.) con quello di
indipendenza del pubblico ministero (art. 107 c. 4 Cost.).
L’avocazione è una funzione
del procuratore generale presso la Corte d’appello che avoca a sé, ovvero
autoassume, un procedimento gestito da un procuratore della repubblica. I casi
di avocazione sono espressamente previsti dalla legge. In breve, consistono
nelle ipotesi in cui il P.M. abbia omesso di compiere un’attività doverosa
oppure il procedimento penale rischi una paralisi per inerzia dello stesso.
Informazioni
Bibliografia G. Lozzi, Lezioni
di procedura penale, Giappichelli, 2017
Beatrice Alba. Ciao, sono
Beatrice. Classe 1997, sono nata in uno dei borghi più belli d’Italia, Cefalù, e
vivo nella città dei gianduiotti. Mi piace dire che probabilmente nelle mie vene
scorre l’inchiostro perché amo la scrittura, la carta e le parole. Mi piacciono
anche i romanzi, il cioccolato e il diritto. Ho una laurea magistrale in
Giurisprudenza che ho conseguito nel 2021 discutendo una tesi dedicata al
viaggio della Corte Costituzionale turca tra la libertà di espressione e
l’indipendenza della magistratura. Il lavoro di ricerca per la redazione
dell’elaborato mi ha portato a viaggiare, a conoscere da vicino la realtà turca,
dalla quale sono rimasta affascinata. Ho iniziato a collaborare con
DirittoConsenso nel 2020 perché amo spiegare il “legalese” ai non esperti del
settore.
Il bilancio della Procura
partenopea. Quanto durano le indagini: oltre settemila giorni di inchieste e
vite sospese.
Viviana Lanza su Il Riformista il 12 Marzo 2022.
Quanto può durare un’indagine?
Non si contano le volte in cui si è sentito parlare di «ragionevole durata del
procedimento», una definizione che racchiude in poche parole il senso di una
giustizia, ma anche quello di una giustizia che non c’è. Perché è proprio sui
tempi della giustizia che il nostro Paese, e Napoli in particolare (considerando
la mole di processi e di indagini che ci sono ogni anno in questo distretto
giudiziario), detengono un triste primato. Si può arrivare ad attendere anni per
una sentenza, e mica parliamo necessariamente di un verdetto definitivo,
l’attesa è lunga, lunghissima, anche per una semplice sentenza di primo grado.
Ci sono processi a Napoli che durano da dieci anni.
Ma cosa accade durante la fase
delle indagini? Per quanto tempo si resta sospesi all’esito dell’attività
investigativa di un pubblico ministero? Anche questo è un settore della
giustizia dove per anni lungaggini e faldoni su faldoni hanno reso i tempi
dilatati e le attese estenuanti. Essere indagato vuol dire vivere sospeso in una
bolla di incertezze, ancor di più se si è totalmente estranei ai fatti per i
quali si è indagati. La nuova disciplina legale dell’avocazione ha comportato la
necessità di rafforzare il monitoraggio della durata delle indagini e il
controllo del rischio di stasi non giustificate. Già, le stasi non giustificate.
Quei faldoni lasciati negli armadietti in attesa di indizi o chissà. A Napoli
un’indagine, per i reati più vari, può durare dai 73 ai 7.208 giorni, calcolando
il periodo compreso tra la data di iscrizione del procedimento alla conclusione
del pubblico ministero. I tempi variano anche a seconda della richiesta con cui
il pubblico ministero conclude le indagini preliminari: azione penale o
archiviazione. La Procura di Napoli, nel suo bilancio sociale, ha calcolato la
durata delle indagini nell’ultimo anno.
Certo, a seconda della
tipologia di reato cambia anche la durata delle indagini. È facile intuire che
ci sono reati per i quali le indagini sono più elaborate per via del numero di
persone coinvolte o delle ipotesi di reato che gli inquirenti contestano. Ad
ogni modo facciamo un esempio. Prendiamo come riferimento il reato di
associazione a delinquere semplice e un’indagine a carico di persone note (nel
2021, per questo particolare reato, ne sono state definite quasi 883):
l’inchiesta è durata in media 646 giorni quando la Procura ha concluso con una
richiesta di rinvio a giudizio, 1.089,12 giorni nel caso di un’archiviazione nel
merito, 2.887,32 giorni nel caso di un’archiviazione per prescrizione. Altro
esempio. Prendiamo in considerazione un reato di pubblica amministrazione come
l’abuso di ufficio. Nel 2021 i tempi che hanno scandito la durata e l’esito
delle indagini, facendo la media dei 557 casi definiti nell’anno, sono stati
questi: 470 giorni per concludere l’inchiesta con una richiesta di rinvio a
giudizio, 535 per archiviarla nel merito, stabilendo quindi che non vi sono
prove a carico dell’iniziale ipotesi accusatoria, e ben 7.208 giorni per
archiviare per prescrizione.
Significa che per tutto questo
tempo un cittadino, destinato ad uscire dall’indagine senza accuse visto che
l’esito sarà un’archiviazione, resta in attesa. Un’attesa che spesso genera
drammi, traumi, gogne mediatiche e giudiziarie, stronca carriere, spezza
famiglie, costringe a scelte che non si sarebbero mai fatte. Tenendo la lente
su Napoli e sulla Procura partenopea, parliamo di un numero di indagini molto
elevato. Nel 2021, solo a modello 21 e quindi per indagini a carico di persone
note (escludendo quindi le indagini a carico di ignoti), si sono registrati
2.875 procedimenti sopraggiunti, 2.427 procedimenti iscritti, 2.979 definiti e,
a fronte di una pendenza di 2.473 fascicoli, il 2021 si è chiuso con una
pendenza di 1.743 procedimenti. Si tratta di migliaia di vite sospese.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
·
I Consulenti.
Procure e tribunali, medici
legali in fuga: tariffe ferme da 20 anni e onorari in ritardo. «Così i giovani
scappano».
Gianni Santucci su Il Corriere della Sera il 29 Maggio 2022.
Un’autopsia viene pagata 67,66
euro come nel 2002. L’ambito penale è abbandonato da quasi tutti i
professionisti: «Così si crea una disaffezione dei giovani per il lavoro al
servizio del pubblico». Cristina Cattaneo, antropologa e patologa forense:
«Servono riforme».
Un ladro ucciso mentre prova
ad entrare in un appartamento. Anno 2014. Caso complesso. Gli accertamenti
medico-legali (come quasi sempre accade) sono decisivi: autopsia, sopralluoghi,
approfondita consulenza tecnica per il pubblico ministero (e intorno, una forte
attenzione dell’opinione pubblica). Tralasciando la vicenda giudiziaria, è
interessante oggi sapere come, e quanto, è stato liquidato il lavoro di quel
professionista: 1.400 euro (ovviamente lordi), ma soprattutto pagati nel 2021.
Basterebbe questo esempio per rendersi conto di quanto sia profonda la crisi che
sta allontanando dalle Procure e dai Tribunali tutti i professionisti di maggior
livello di cui la giustizia ha invece un bisogno sempre più massiccio. Pagati
con onorari «indecorosi». In più: pagati in ritardo, anche macroscopico. E, non
di rado, coi compensi tagliati al momento della liquidazione. Nei mesi scorsi
il Corriere si è occupato di informatici forensi, ingegneri, criminologi. Stessi
problemi. L’ambito della medicina legale può avere però ricadute sociali ancora
più pesanti. Basta valutare l’aspetto che ha minor rilevanza mediatica, ma che
tocca invece un numero enorme di persone: e cioè tutte le controversie su
contributi pubblici per invalidità o inabilità, gli infortuni sul lavoro. Se i
professionisti chiamati a fare accertamenti su queste controversie sono
superficiali, da una parte si può sprecare denaro pubblico, dall’altra si può
rovinare una persona che avrebbe pieno diritto a un aiuto e non lo ottiene. «La
medicina legale in questi ambiti ha riflessi sociali enormi», riflette Carlo
Bernabei, professionista che ha lavorato a lungo per studi legali e uffici
giudiziari soprattutto a Milano, Como, Varese e Genova, su delitti, colpe
mediche e risarcimenti.
Il listino dei compensi
Tornando all’ambito penale,
bisogna partire dal listino dei compensi, fermo al 2002: per l’autopsia, 67,66
euro; per l’autopsia su «cadavere esumato», 96,58 euro; per una consulenza
tecnica con «accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti
patogeni», da 38,03, a 290,77 euro. Quando i lavori si prolungano (e si
prolungano sempre, come è intuitivo) i pagamenti passano «a vacazione» (una
vacazione equivale a due ore e viene liquidata con 8,15 euro (tariffa che Milano
ha raddoppiato). «Anche per questo l’ambito penale è abbandonato da quasi tutti
i professionisti. Chiediamo che siano rivisti gli onorari, non per diventare
ricchi, ma per poter continuare a lavorare al servizio della giustizia con un
compenso decoroso», continua Bernabei. E Riccardo Zoja, direttore dell’Istituto
di medicina legale della Statale e fino a pochi mesi fa presidente della Società
italiana di medicina legale, analizza: «Nell’ambito della giustizia cercano
tutti di fare miracoli ma le procedure burocratiche sono lentissime. Le
tempistiche della retribuzione sono migliorate leggermente, ma arrivano oggi
pagamenti del 2017: non è sostenibile. Oltre ai ritardi c’è anche il fatto che
gli onorari sono fermi dal 2002. Una retribuzione iniqua rispetto all’impegno
della prestazione. In questo contesto si crea una disaffezione dei giovani per
il lavoro al servizio del pubblico. E anche i medici legali esperti svolgono per
il pubblico le prestazioni solo su casi interessanti, ma devono compensare con
quote crescenti di lavoro nel privato».
L’effetto sui processi
Non serve sottolineare che in
casi di omicidio o lesioni gravi la qualità del lavoro dei periti medico-legali
può fare la differenza tra un assassino in carcere o libero, tra una vittima che
ottiene giustizia o no. «Da libero professionista — aggiunge Bernabei — è però
diventato di fatto impossibile lavorare per la Procura o il giudice: tutte le
verifiche accessorie legate a un’autopsia (dagli esami tossicologici, ai tecnici
di laboratorio) le anticipa di tasca propria il professionista, e le paga
subito. A fronte di un compenso che arriverà dopo anni». C’è qualche eccezione,
ad esempio il Tribunale di Monza. Ma Milano e il resto d’Italia stanno iniziando
a vedere ricadute sempre più marcate. Riflette Cristina Cattaneo, medico e
antropologo, professore di medicina legale alla Statale e direttore del Labanof,
laboratorio di antropologia e odontologia forense: «La medicina legale italiana,
quella delle autopsie, ha bisogno di riforme serie, come hanno fatto i francesi
15 anni fa, e di accreditamento. Bisogna riconquistare la fiducia della società,
tra cui anche le Procure, relativamente al fatto che sia fondamentale per
tutelare giustizia e società. Ma paradossalmente le richieste di autopsie da
parte della giustizia, e anche dei servizi di salute pubblica, sono sempre meno:
non certo perché sono diminuiti i crimini, ma perché c’è l’idea che la medicina
forense non sia in grado di produrre risultati tangibili in termini di giustizia
e salute pubblica, e dunque su quelle si risparmia».
I risparmi gli accertamenti
legali
Che peso può avere, in un
sistema democratico, se la giustizia risparmia sugli accertamenti e che provoca
un’emorragia continua di professionalità? È un tema sul quale insiste anche
Zoja: «Sono diminuite drasticamente le richieste di autopsie, non se ne fanno
quasi più. C’è una scarsa fiducia nell’utilità di analisi approfondite, ma anche
un tema economico, che pesa nella decisione di non farne molte. In questo modo
però si ha un minor controllo della situazione sociale ed epidemiologica».
L’albo dei consulenti
certificati
In alcuni ambiti Milano ha
un’organizzazione avanzata, come ad esempio sulle colpe professionali, con una
Sezione dedicata in Tribunale e anche un albo di consulenti «certificati», per i
quali una commissione ha verificato la competenza. Il problema però è sempre lo
stesso, e cioè che poi questi medici accettino il lavoro al servizio del
pubblico. Proprio sulle colpe mediche rischia di generarsi (in parte è già così)
una delle distorsioni più gravi: se una persona con pochi mezzi ha avuto un
gravissimo danno dopo un intervento sbagliato e denuncia l’ospedale, dalla sua
parte avrà spesso solo il perito del magistrato, e se questo è di livello non
adeguato, nel processo sarà sempre in difficoltà. Perché di fronte si troverà i
periti di più alto livello sul mercato, pagati dalla parte. E dunque, questo è
il tema chiave che investe il senso stesso della giustizia, le due parti non
saranno ad armi pari di fronte al giudice. È anche per questo che si sono
moltiplicate società che si fanno pubblicità e si offrono di assistere vittime
di potenziali errori medici. Propongono di assistere la vittima: se perde, la
società non avrà compensi; se vince, incasserà una percentuale sul risarcimento.
È un sistema molto criticato nell’ambiente, ma che in realtà rappresenta un
correttivo rispetto a uno squilibrio.
·
Incompatibilità ambientale: questa sconosciuta.
Io son io e voi non siete un
cazzo!
Presso la Sezione Penale del
Tribunale di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, al ruolo A bis, si tiene il
processo n. 238/19 R.G.N.R, n. 1399/19 R.G.T. tenuto dalla D,ssa Annalisa
Palamara a carico di Latino Giandomenico difeso dall’Avv. Antonino Napoli.
L’Avv. Antonino Napoli ha
pensato di citare come testimone al processo il dr. Antonio Giangrande, di
Avetrana, del versante orientale della provincia di Taranto, ai confini con
Lecce, noto saggista e presidente nazionale dell’associazione antiracket ed
antiusura denominata “Associazione Contro Tutte Le Mafie”.
Il citato dr. Antonio
Giangrande non conosce fatti, atti e parti del processo in corso. In udienza si
scopre che è un artifizio per far rendere dichiarazioni incriminanti su un
articolo pubblicato dall’imputato contenete un’inchiesta del dr Antonio
Giangrande. Dossier contenete altri articoli in cui si parla di incompatibilità
ambientale dei magistrati. Nello stesso foro praticano magistrati e loro
familiari, in qualità di togati ed avvocati. L’indicazione erronea del nome di
uno di questi ha sortito una richiesta di rettifica, effettuata. Ciononostante
vi fosse prova di mancanza di dolo, è partita la querela. In questo caso si è
guardato il dito e non la luna.
L’avv. Antonino Napoli cita
con atto
di citazione testi il dr Antonio Giangrande a presenziare per l'udienza del 28
giugno 2021 ore 12 e ss con Racc. A.R. del 04/06/2021 ricevuta il 09/06/2021.
Avviso
congruo inviato 24 giorni prima e ricevuto 19 prima l’udienza.
Il Dr
Antonio Giangrande in data 23 giugno 2021 con fax personale all’avvocato
Antonino Napoli ed al Tribunale giustifica l’impedimento a presenziare in
udienza per i postumi del Long Covid, residui di una lunga degenza in ospedale
per un’infezione grave ai polmoni e ad altri organi .
Il Dr
Antonio Giangrande per maggiore sicurezza fa inviare dal suo Avvocato di fiducia
del Foro di Taranto, Mirko Giangrande, al Tribunale di Palmi e all’avvocato
Antonino Napoli la stessa giustifica.
Mandato speciale rilasciato per quel singolo atto. Oltretutto non essendo
imputato.
Giustifica accettata dal Tribunale.
Dopodichè l’avv. Antonino Napoli rinnova la citazione testi al Dr Antonio
Giangrande per l’udienza di lunedì 14 marzo 2022, ore 13:00.
Citazione testi che il dr Antonio Giangrande, teste, non ha mai ricevuto, perché
inviata dall’avv. Antonino Napoli con pec nel week end, ossia sabato 12 marzo
2022, ore 13:53 all’indirizzo dell’avvocato Mirko Giangrande, non legittimato a
riceverla.
Avv.
Mirko Giangrande che, intanto, aveva sospeso la professione, in quanto aveva
vinto il concorso ed operava come addetto all’Ufficio del Processo presso il
Tribunale Penale di Parma.
Avv.
Mirko Giangrande che, nel momento in cui ha ricevuto l’errata citazione, nella
stessa data la contesta presso il mittente, rilevando la sua nullità.
Da
notare:
Destinatario non legittimato a ricevere la notifica, né egli è dovuto a
comunicare la stessa al vero destinatario, che ad onor del vero nel week end ed
a circa mille chilometri era irrintracciabile.
Termini non congrui tra la notifica e l’udienza: due giorni prima, anzi 47 ore
prima, contenuti tra festivi e pre festivi. Come dire: si notifica con un
fischio. Oltretutto non congrui per organizzare la trasferta di quasi mille
chilometri per un covidizzato, i cui postumi sono difficoltà respiratorie e
prostatite.
Si
pensava fosse finita così, invece…
In
data 30 maggio 2022 il dr Antonio Giangrande riceve una chiamata sul cellulare
personale: erano i carabinieri di Avetrana, che sollecitavano la notifica di un
atto.
Da
autore di inchieste, ci si aspettava, come tutti i migliori saggisti o
giornalisti, un procedimento per diffamazione a mezzo stampa.
Invece
in caserma veniva presentato un accompagnamento coattivo teste emesso con
ordinanza del giudice Annalisa Palamara del 14 marzo 2022, che avallava la
versione dell’avvocato Antonino Napoli di regolare notifica nello stesso giorno
dell’udienza citata e mai notificata, nonostante all’avvocato Antonino Napoli ed
al Tribunale si fosse prodotta prova contraria per pec della mancata notifica da
parte dell’avv. Mirko Giangrande.
In
questo caso la nuova notifica è avvenuta il 30 maggio 2022 per l’udienza del 13
giugno 2022.
Nota
bene: 14 giorni prima. In questo caso: Termini congrui.
Al
giudice Annalisa Palamara bastava far rinnovare, nei termini congrui ed al
legittimo destinatario, la citazione all’avvocato Antonino Napoli, ove assumesse
l’onere dell’errore precedente, invece l’accompagnamento coattivo sa di
punizione oltraggiosa. Essere considerato reticente è offensivo.
Da
esercente la professione forense come praticante avvocato con patrocinio il dr
Antonio Giangrande sa cosa significa accompagnamento coattivo e quanto sia
umiliante e degradante.
Da
presidente antimafia, inoltre, ci si aspettava la scorta, non gli accompagnatori
coattivi per testimoniare su cose e su persone di cui nulla si è a conoscenza.
Quasi
mille chilometri per andare in capo al mondo senza vie di collegamento degne di
un paese civile, tanto da alleviare la trasferta: né autobus, né treni, salvo
lunghe ed estenuanti attese per cambi e coincidenze.
Laddove il Maresciallo Vincenzo Caliandro, luogotenente della caserma dei
carabinieri di Avetrana, mi avesse invitato a firmare una liberatoria, affinchè
si esentasse l’arma dei Carabinieri ad accompagnarmi dietro l’impegno del buon
esito della trasferta, la sollecitazione sarebbe stata declinata in quanto lungo
il tragitto di centinaia di chilometri tutto può succedere per impedire la
presenza in udienza ed ove non si fornisse prova certa e legittima di
impedimento, potrebbe prospettarsi l’incriminazione
di reato di
rifiuto di uffici legalmente dovuti previsto nell’art. 366 c.p.
. In
ogni caso ai sensi dell’art. 255 cpc in caso di ulteriore mancata comparizione
il giudice dispone l'accompagnamento coattivo alla stessa udienza o ad altra
successiva e lo condanna ad una sanzione pecuniaria non inferiore a 200 euro e
non superiore a 1.000 euro.
Ergo:
Un
accompagnamento coattivo infondato oltraggioso ed offensivo.
Un’auto obbligatoria per il teste ed un’auto dei carabinieri al seguito come
accompagnamento coattivo, come capopattuglia il brigadiere Biagio Blaiotta, per
controllare che l’auto che precede arrivi al Tribunale di Palmi. (In verità è
avvenuto il contrario. I carabinieri a precedere tutto spiano e l’auto del
testimone costretta a seguire alla stessa velocità!)
Un
onere umano ed economico incalcolabile ed uno spreco enorme, per il privato e
per il pubblico, oltretutto con il presente caro-carburante.
Si scongiura la denuncia
querela presso l’autorità giudiziaria competente e l’esposto presso le autorità
amministrative e giudiziarie di controllo, contro i responsabili del falso e
dell’abuso, perché il giudice Palamara con buon senso chiede scusa, riconoscendo
l’errore del suo ufficio.
Roma: Figlia Giudice
monocratico, padre Pubblico Ministero.
Giulia Cavallone, 36 anni,
giovane magistrato del Tribunale capitolino e figlia dell'attuale procuratore
generale della Corte di appello di Roma, Roberto Cavallone (che da pm aveva
seguito l'indagine bis sulla morte di Simonetta Cesaroni a via Poma).
[…] Estratto dell’articolo di Erika Chilelli per “il Messaggero” l'1 luglio
2022.
La donna, che si era occupata
come giudice monocratico del processo a carico di 8 carabinieri accusati, a
vario titolo, di avere messo in atto depistaggi dopo la morte di Stefano Cucchi,
si è spenta il 17 aprile del 2020 appunto a soli 36 anni dopo aver lottato a
lungo con la malattia che non le aveva dato scampo. (…) Estratto dell’articolo
di Carlotta Lombardo su Il Corriere della Sera l'1 Luglio 2022.
Estratto dell’articolo di
Erika Chilelli per “il Messaggero” l'1 luglio 2022.
Scambia un melanoma per una
verruca durante un controllo di routine. Una dermatologa, Carla V., è stata
condannata dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Perugia a 8
mesi di reclusione con l'accusa di omicidio colposo per aver causato la morte di
Giulia Cavallone, 36 anni, giovane magistrato del Tribunale capitolino e figlia
dell'attuale procuratore generale della Corte di appello di Roma, Roberto
Cavallone (che da pm aveva seguito l'indagine bis sulla morte di Simonetta
Cesaroni a via Poma). […]
È il 4 novembre del 2013, la
vittima, insospettita da un neo comparso su un polpaccio, prenota una visita
presso lo studio privato della dermatologa, dalla quale si reca ancora una volta
il 18 giugno del 2014. Nel corso di entrambe le visite, la dottoressa la
tranquillizza, dicendole che si tratta di una verruca seborroica, «nonostante la
presenza di elementi di sospetto», si legge ne capo di imputazione. Inoltre,
«ometteva di ricorrere a un esame strumentale più approfondito della lesione e,
comunque, di avviare con urgenza la paziente alla competenza di un esperto».
Dunque, non viene prelevato
nessun campione dalla lesione, al fine di esaminarlo istologicamente. A luglio
del 2014, otto mesi dopo la prima visita, però, alla vittima viene fatta una
diagnosi del tutto inaspettata presso l'Ospedale San Camillo. I medici asportano
d'urgenza la lesione sospetta e concludono che non si tratta di una verruca,
come stabilito dalla collega, bensì di un melanoma modulare maligno ulcerato.
Una risposta che, però, è
arrivata troppo tardi: il melanoma è al quarto stadio. L'asportazione del
tessuto, un intervento successivo e le cure con i farmaci non hanno impedito la
sua evoluzione. Le metastasi si diffondono nel corpo della donna arrivando a
colpire cervello, polmoni, cuore, fegato e intestino: non c'è più niente da
fare. Il giudice muore il 17 aprile del 2020. Un epilogo, che, come emerso nel
corso dell'udienza preliminare davanti al giudice di Perugia si poteva evitare
con un'asportazione tempestiva della lesione. […]
Giudice morta a 36 anni per
un tumore, otto mesi alla dermatologa: «Non ha riconosciuto il melanoma».
Carlotta Lombardo
su Il Corriere della Sera l'1 Luglio 2022.
La macchia che aveva Giulia
Cavallone scambiata per una verruca seborroica. Rongioletti, primario al San
Raffaele: «Condanna eccessiva, ma doveva asportare e fare l’istologico». Cos’è
un melanoma.
Otto mesi di reclusione per
omicidio colposo alla dermatologa accusata di avere definito come «verruca
seborroica» un neo sul polpaccio e che in realtà era un «melanoma nodulare
maligno ulcerato» da cui è partita la forma tumorale che ha causato la
morte del giudice al tribunale di Roma Giulia Cavallone, 36 anni. È quanto
deciso oggi dal gup di Perugia. La donna, che si era occupata come giudice
monocratico del processo a carico di 8 carabinieri accusati, a vario titolo, di
avere messo in atto depistaggi dopo la morte di Stefano Cucchi, si è spenta il
17 aprile del 2020 appunto a soli 36 anni dopo aver lottato a lungo con la
malattia che non le aveva dato scampo.
La diagnosi sbagliata
La famiglia sta portando
avanti questa battaglia già iniziata dalla Cavallone quando era ancora in
vita per impedire che quanto accaduto «non abbia a ripetersi in
futuro». L’errata valutazione di quel neo — secondo il capo d’imputazione — non
è stata risolta dall’asportazione di un’ampia zona di derma nell’area
interessata dalla formazione cancerosa, e poi da «un intervento linfoadenectomia
inguinale ed iliaco-otturatoria sinistra». Nulla hanno potuto neanche le cure
con «farmaci immunomodulanti e a bersaglio molecolare». Perché così è arrivata
la fine con «metastasi cerebrali, polmonari, cardiache, epatiche,
gastrointestinali e linfonodali». Non aver diagnosticato correttamente il
melanoma alla Cavallone è stato per la giudice un errore fatale. «Purtroppo può
succedere perché sia il melanoma che la verruca seborroica si presentano come
due macchie scure — spiega Franco Rongioletti, 64 anni, primario di dermatologia
clinica dell’Ospedale San Raffaele e ordinario di dermatologia all’Università
Vita-salute San Raffaele —. Nel 90% dei casi si distinguono soprattutto se il
dermatologo usa il dermatoscopio che ingrandisce la lesione e permette di vedere
anche in profondità ma rimangono comunque dei casi dove la distinzione non è
semplice. La cosa migliore rimane sempre quella di asportare e fare l’esame
istologico che non dà margini di errore».
«Una condanna eccessiva»
Sulla decisione del gup umbro
hanno espresso «soddisfazione» gli avvocati di parte civile, Stefano Maccioni e
Nicola Di Mario. «Attendiamo di leggere le motivazioni per un più attento esame
— hanno detto —. È stata riconosciuta una condotta colposa della dermatologa e
il nesso di causalità tra questa e il decesso della dottoressa Giulia
Cavallone». I difensori dell’imputata, avvocati Alberto Biffani e Myriam Caroleo
Grimaldi, precisano invece che «la nostra assistita aveva inviato la paziente a
un chirurgo oncologo per l’asportazione della lesione. Attenderemo il deposito
delle motivazioni per comprendere il ragionamento seguito dal GUP e proporre
appello».
Sulla condanna, si esprime
ancora il professor Rongioletti. «Una pena eccessiva perché ha fatto un errore
che può succedere. Anche a me è capitato di vedere delle lesioni che mi
sembravano delle verruche seborroiche solo che ho fatto l’asportazione e l’esame
istologico mi ha fatto capire che si trattava di un melanoma. Ecco, la
dermatologa sotto processo avrebbe dovuto procedere anche lei così». Il primario
di dermatologia dell’ospedale San Raffaele di Milano tiene però a chiarire che
«la paziente è morta di melanoma e non per un neo». «Un chiarimento doveroso
perché parliamo di due cose completamente diverse — spiega — . Il neo è una
lesione benigna, un tumore benigno dei melanociti mentre il melanoma è una
lesione maligna, un tumore dei melanociti maligno che può portare alla morte. Se
si toglie un neo non si muore mai. Ancora oggi, quando per prevenzione consiglio
l’asportazione di nei dalle caratteristiche brutte mi sento dire dai pazienti
che non lo vogliono fare perché “togliendo i nei si può morire”. Niente di più
falso. Si può morire invece quando si toglie un melanoma troppo tardi ma se lo
si toglie nella fase iniziale e superficiale la guarigione è praticamente del
100%».
Ogni anno 100.000 nuovi casi
di melanoma nel mondo
Ogni anno nel mondo sono più
di 100.000 i nuovi casi di melanoma. Secondo i dati Airtum , l’Associazione
Italiana Registri Tumori, la sua incidenza nel nostro Paese è raddoppiata negli
ultimi dieci anni e nel 2020 sono stati diagnosticati circa 14.900 nuovi casi di
cui 8.100 nei maschi e 6.700 nelle donne. Prevenire la formazione di un melanoma
e intervenire per tempo è possibile, effettuando innanzitutto la cosiddetta
«mappatura» dei nei, meglio con un video-dermatoscopio, e regolando
l’esposizione della pelle al sole. Spiega Rongioletti: «Noi dermatologi
consigliamo la mappatura una volta l’anno però ci possono essere delle
eccezioni, come quando vediamo dei pazienti con nevi displastici o atipici
caratterizzati da un colore diverso, bordi irregolari o note di
asimmetria (caratteristiche che possono simulare un melanoma), oppure pazienti
con molti nei. Il numero critico è tra i 50 e i 100 nei, allora è meglio fare la
mappatura ogni sei mesi». Relazione tra neo e melanoma? «Nel 70% dei casi il
melanoma nasce già melanoma, solo che quando è di un millimetro è difficile
riconoscerlo. Il 30% invece nasce da un nevo, o neo, preesistente. In questo
caso quindi un neo può essere un precursore del melanoma». Altri consigli?
«L’esposizione solare è uno dei fattori di rischio per lo sviluppo del melanoma.
Non bisognerebbe esporsi nelle ore in cui ci sono gli ultravioletti più dannosi,
dalle 11, 12 del mattino alle 16, 17 del pomeriggio. Bisogna comunque usare
sempre una protezione con fattore di protezione 50+ (30 è il minimo).
Soprattutto se le persone sono bionde, o rosse, con la pelle e gli occhi chiari,
di tipo anglosassone. Un ulteriore fattore di rischio è il melanoma familiare,
se qualcuno cioè dei parenti stretti ha avuto dei melanomi, il controllo deve
essere almeno annuale. L’aumento del numero dei casi di melanoma è in aumento
progressivo e si pensa che sia legato proprio al fatto che le persone tendono a
esporsi sempre più al sole rispetto a qualche anno fa».
LE COMPATIBILITA’ ELETTIVE.
IO SON IO E TU NON SEI UN CAZZO.
QUANDO IL DNA GIUDICANTE E’
QUESTIONE DI FAMIGLIA.
Come la legislazione si
conforma alla volontà ed agli interessi dei magistrati.
Un’inchiesta svolta in virtù
del diritto di critica storica e tratta dai saggi di Antonio Giangrande
“Impunitopoli. Legulei ed impunità” e “Tutto su Messina. Quello che non si osa
dire”.
Marito giudice e moglie
avvocato nello stesso tribunale: consentito o no?
Si chiede Massimiliano Annetta il 25 gennaio 2017 su “Il Dubbio”. Ha destato
notevole scalpore la strana vicenda che si sta consumando tra Firenze e Genova e
che vede protagonisti due medici, marito e moglie in via di separazione, e un
sostituto procuratore della Repubblica, il tutto sullo sfondo di un procedimento
penale per il reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo il medico, il pm che
per due volte aveva chiesto per lui l’archiviazione, ma poi, improvvisamente,
aveva cambiato idea e chiesto addirittura gli arresti domiciliari – sia l’amante
della moglie. Il tutto sarebbe corredato da filmati degni di una spy story.
Ebbene, devo confessare che
questa vicenda non mi interessa troppo. Innanzitutto per una ragione etica, ché
io sono garantista con tutti; i processi sui giornali non mi piacciono e, fatto
salvo il sacrosanto diritto del pubblico ministero di difendersi, saranno i
magistrati genovesi (competenti a giudicare i loro colleghi toscani) e il Csm a
valutare i fatti. Ma pure per una ragione estetica, ché l’intera vicenda mi
ricorda certe commediacce sexy degli anni settanta e, a differenza di Quentin
Tarantino, non sono un cultore di quel genere cinematografico.
Ben più interessante, e
foriero di sorprese, trovo, di contro, l’intero tema della incompatibilità di
sede dei magistrati per i loro rapporti di parentela o affinità. La prima
particolarità sta nel fatto che l’intera materia è regolata dall’articolo 18
dell’ordinamento giudiziario, che la prevede solo per i rapporti con esercenti
la professione forense, insomma gli avvocati. Ne discende che, per chi non veste
la toga, di incompatibilità non ne sono previste, e quindi può capitare, anzi
capita, ad esempio, che il pm d’assalto e il cronista sempre ben informato sulle
sue inchieste intrattengano rapporti di cordialità non solo professionale. Ma
tant’è.
Senonché, pure per i rapporti
fra avvocati e magistrati la normativa è quantomeno lacunosa, poiché l’articolo
18 del regio decreto 30.1.1941 n. 12, che regola la materia, nella sua
formulazione originale prevedeva l’incompatibilità di sede solo per “i
magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali […]
nei quali i loro parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado sono
iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore”. Insomma, in
origine, e per decenni, si riteneva ben più condizionante un nipote di una
moglie, e del resto non c’è da sorprendersi, la norma ha settantasei anni e li
dimostra tutti; infatti, all’epoca dell’emanazione della disciplina
dell’ordinamento giudiziario le donne non erano ammesse al concorso in
magistratura ed era molto limitato pure l’esercizio da parte loro della
professione forense.
Vabbe’, vien da dire, ci avrà
pensato il Csm a valorizzare la positiva evoluzione del ruolo della donna nella
società, ed in particolare, per quanto interessa, nel campo della magistratura e
in quello dell’avvocatura. E qui cominciano le soprese, perché il Cxm con la
circolare 6750 del 1985 che pur disciplinava ex novo la materia di cui
all’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario, ribadiva che dovesse essere
“escluso che il rapporto di coniugio possa dar luogo a un’incompatibilità ai
sensi dell’art. 18, atteso che la disciplina di tale rapporto non può ricavarsi
analogicamente da quella degli affini”. Insomma, per l’organo di governo
autonomo (e non di autogoverno come si suol dire, il che fa tutta la differenza
del mondo) della magistratura, un cognato è un problema, una moglie no,
nonostante nel 1985 di donne magistrato e avvocato fortunatamente ce ne fossero
eccome. Ma si sa, la cosiddetta giurisprudenza creativa, magari in malam partem,
va bene per i reati degli altri, molto meno per le incompatibilità proprie.
Della questione però si avvede
il legislatore, che, finalmente dopo ben sessantacinque anni, con il decreto
legislativo 109 del 2006, si accorge che la situazione non è più quella del ‘41
e prevede tra le cause di incompatibilità pure il coniuge e il convivente che
esercitano la professione di avvocato. Insomma, ora il divieto c’è, anzi no.
Perché a leggere la circolare del Csm 12940 del 2007, successivamente modificata
nel 2009, si prende atto della modifica normativa, ma ci si guarda bene dal
definire quello previsto dal novellato articolo 18 come un divieto tout court,
bensì lo si interpreta come una incompatibilità da accertare in concreto, caso
per caso, e solo laddove sussista una lesione all’immagine di corretto e
imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato e,
in generale, dell’ufficio di appartenenza. In definitiva la norma c’è, ma la si
sottopone, immancabilmente, al giudizio dei propri pari. E se, ché i costumi
sociali nel frattempo si sono evoluti, non c’è “coniugio o convivenza”, ma ben
nota frequentazione sentimentale? Silenzio di tomba: come detto, l’addictio in
malam partem la si riserva agli altri. Del resto, che il Csm sia particolarmente
indulgente con i magistrati lo ha ricordato qualche giorno fa pure il primo
presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio che, dinanzi al Plenum di
Palazzo dei Marescialli, ha voluto evidenziare come “il 99% dei magistrati”
abbia “una valutazione positiva (in riferimento al sistema di valutazione delle
toghe, ndr). Questa percentuale non ha riscontro in nessuna organizzazione
istituzionale complessa”.
Insomma, può capitare, e
capita, ad esempio, che l’imputato si ritrovi, a patrocinare la parte civile nel
suo processo, il fidanzato o la fidanzata del pm requirente.
E ancora, sempre ad esempio,
può capitare, e capita, che l’imputato che debba affrontare un processo si
imbatta nella bacheca malandrina di un qualche social network che gli fa
apprendere che il magistrato requirente che ne chiede la condanna o quello
giudicante che lo giudicherà intrattengano amichevoli frequentazioni con
l’avvocato Tizio o con l’avvocata Caia. Innovative forme di pubblicità verrebbe
da dire.
Quel che è certo, a giudicare
dalle rivendicazioni del sindacato dei magistrati, è che le sempre evocate
“autonomia e indipendenza” vengono, evidentemente, messe in pericolo dal tetto
dell’età pensionabile fissato a settant’anni anziché a settantacinque, ma non da
una disciplina, che dovrebbe essere tesa preservare l’immagine di corretto ed
imparziale esercizio della funzione giurisdizionale, che fa acqua da tutte le
parti.
Al fin della licenza, resto
persuaso che quel tale che diceva che i magistrati sono “geneticamente
modificati” dicesse una inesattezza. No, non sono geneticamente modificati,
semmai sono “corporativamente modificati”, secondo l’acuta definizione del mio
amico Valerio Spigarelli. E questo è un peccato perché in magistratura c’è un
sacco di gente che non solo è stimabile, ma è anche piena di senso civico, di
coraggio e di serietà e che è la prima ad essere lesa da certe vicende più o
meno boccaccesche. Ma c’è una seconda parte lesa, alla quale noi avvocati – ma,
a ben vedere, noi cittadini – teniamo ancora di più, che è la credibilità della
giurisdizione, che deve essere limpida, altrimenti sovviene la sgradevole
sensazione di nuotare in uno stagno.
Saltando di palo in frasca,
come si suo dire, mi imbatto in questa notizia.
Evidentemente quello che vale per gli avvocati non
vale per gli stessi magistrati.
VIETATO SPIARE L'AMORE TRA GIUDICI.
I CASI DI INCOMPATIBILITA' FINO AL 1967 (prima di quell' anno, i magistrati
erano soltanto uomini): Tra padre e figli (o tra fratelli o tra zio o nonno e
nipote) entrambi magistrati nello stesso collegio giudicante o nel collegio d'
impugnazione; oppure uno magistrato e uno avvocato nello stesso circondario,
scrive Giovanni Marino il 25 maggio 1996 su "La Repubblica". Dopo IL 1967 (cioè
dopo la legge che permetteva l'ingresso in magistratura delle donne):
Incompatibilità estesa anche: Tra marito e moglie, uno magistrato e uno avvocato
nello stesso circondario Tra marito e moglie entrambi magistrati, se nello
stesso collegio giudicante o nel collegio d' impugnazione Tra marito Pm e moglie
Gip (o viceversa) nello stesso circondario Magistrati conviventi e operanti
nello stesso circondario.
Giudici e avvocati compagni di vita. Il
Csm apre una pratica a Torino. Palazzo dei
Marescialli, contestata la compatibilità ambientale, scrive Raphael Zanotti il
18/09/2010 su “La Stampa”. L’amore non ha diritto di cittadinanza nelle aride
lande della Giustizia e dei codici deontologici. Non è previsto, non è
contemplato. Quando lo si scopre, si cerca di annichilirlo, azzerarlo. Si può
essere buoni magistrati se si ama l’avvocato dall’altra parte della barricata?
Si può difendere al meglio il proprio assistito se si deve battagliare con il
giudice con cui, il mattino dopo, ci si alza per fare colazione? L’uomo è
fragile, la legge no. Tra gli uomini e le donne di giustizia, l’amore è vietato.
Lo si cancella con due parole e un articolo di legge: incompatibilità
ambientale. Oppure, il più delle volte, lo si tiene nascosto, riservato. Perché
tra quelle aule austere, tra i corridoi e gli scartafacci, è come in qualsiasi
altro posto: l’amore sboccia, cresce, s’interrompe. È la vita che preme contro
le regole che gli uomini si sono dati per riuscire a essere più equi, per non
doversi affidare a eroi e asceti. Ma per quanto discreto, disinteressato e
onesto, l’amore - a volte - viene scoperto. E allora la legge interviene,
implacabile. E gli amanti tremano. Per uno che viene sorpreso, altri nove
restano nell’ombra. Tutti sanno di essere di fronte a una grande ipocrisia.
Perché nei tribunali ci sono sempre stati amori clandestini, che vivono di
complicità. Oppure ufficiali e stabili da così tanto da sentirsi al sicuro. Il
giudice torinese Sandra Casacci e l’avvocato Renzo Capelletto vivono la loro
storia sentimentale da 31 anni. Una vita. L’hanno sempre fatto alla luce del
sole. Il nuovo Consiglio Superiore della Magistratura, targato Michele Vietti,
che solo per un caso è torinese e avvocato anch’egli, ha appena aperto la sua
prima pratica disciplinare. L’ha aperta nei confronti del giudice Casacci per
incompatibilità ambientale. Il suo compagno, Capelletto, è amareggiato: «Mi
spiace per Sandra - racconta - Stiamo insieme da tanto, non ci siamo mai
nascosti. Sono stato anche presidente degli avvocati di Torino e nessuno ha mai
potuto dire che ci siano stati contatti tra la mia attività di avvocato e la sua
di giudice. Il vero problema è che Sandra, dopo una vita di lavoro, sta per
diventare capo del suo ufficio e forse questo dà fastidio a qualcuno». Il Csm ha
aperto un’altra pratica contro un giudice torinese. Questa volta si tratta di
Fabrizia Pironti, legata per anni sentimentalmente all’avvocato Fulvio Gianaria,
uno dei legali più conosciuti e stimati del foro torinese. «Della mia vita
privata preferirei non parlare - dice l’avvocato - ma una cosa la dico: in tutto
questo tempo non ho mai partecipato a un processo che avesse come giudice la
dottoressa Pironti. E così i miei colleghi di studio. È la differenza tra la
sostanza e il formalismo». La pratica aperta dal Csm mette il dito in una piaga.
Nei tribunali italiani non ci sono solo coppie formate da giudici e avvocati, ma
anche giudici e giudici sono incompatibili in certi ambiti. Oppure parenti,
affini. La legge dice, fino al secondo grado. «Abbiamo aperto questa pratica
perché ci è arrivata una segnalazione - si limita a dire il vicepresidente del
Csm, Vietti - È una pratica nuova, verificheremo». Il 4 ottobre, a Palazzo dei
Marescialli, è stato convocato il procuratore generale del Piemonte Marcello
Maddalena che dovrà spiegare se esiste una situazione di incompatibilità dei
suoi due giudici. E, nel caso esista da tempo, perché non è stata risolta prima.
Dovrà spiegare, insomma, come mai l’amore ha trovato spazio tra le aule austere
e i faldoni dei suoi uffici giudiziari.
TRA MOGLIE E MARITO NON METTERE L’EXPO
- PER GIUSTIFICARE IL SILURAMENTO DI ROBLEDO DAL POOL ANTITANGENTI, BRUTI
LIBERATI HA SEGNALATO AL CSM CHE LA NOVELLA MOGLIE DEL PM LAVORA ALL’UFFICIO
LEGALE DI EXPO: “C’ERA INCOMPATIBILITÀ”. Per Robledo la storia della moglie
sarebbe solo un “pretesto” di Bruti Liberati per dare legittimità alla propria
rimozione, bocciata il 28 ottobre dal Consiglio Giudiziario come “esautoramento
usato per risolvere in modo improprio l’esistenza di un conflitto”…, scrive
Luigi Ferrarella per “il Corriere della Sera” il 6 novembre 2014. L’ex capo del
pool antitangenti Alfredo Robledo, che indagava sugli appalti collegati a Expo
2015, ha la moglie avvocato amministrativista che lavora all’ufficio legale di
Expo 2015: è quanto il procuratore Edmondo Bruti Liberati ha segnalato ieri al
Csm e al Consiglio Giudiziario, alla vigilia dell’odierna assemblea dei pm da
lui convocata per «voltare pagina» e «rilanciare l’orgoglio di appartenere alla
Procura». Lo fa inviando anche una lettera di risposta richiesta al commissario
di Expo 2015 Giuseppe Sala, e aggiungendo che la potenziale incompatibilità nel
pool antitangenti tra il pm e la coniuge non esiste invece ora nel nuovo pool
(«esecuzione delle pene») al quale il procuratore rivendica di aver trasferito
Robledo il 3 ottobre. Ma questi ribatte che la storia della moglie sarebbe solo
un «pretesto» di Bruti per dare una rinfrescata di legittimità alla propria
rimozione, bocciata il 28 ottobre dal Consiglio Giudiziario come «esautoramento
usato per risolvere in modo improprio l’esistenza di un conflitto»: ad avviso di
Robledo, infatti, non c’è mai stata alcuna possibile incompatibilità neppure
quando la moglie faceva l’amministrativista perché — spiega — operava in una
nicchia estranea alle indagini, e comunque ora proprio per evitare «pretesti» si
è cancellata dall’Ordine degli Avvocati. L’ordinamento giudiziario, per
prevenire incompatibilità nel lavoro, impone ai magistrati di segnalare entro 60
giorni (e ai capi di vigilare) relazioni sentimentali con altri magistrati o
avvocati del distretto. Robledo non lo fa nei 60 giorni dopo le nozze il 10
luglio 2014 con l’avvocato amministrativista Corinna Di Marino. A Bruti che ne
chiede conto, risponde che non ravvisa alcuna incompatibilità. Bruti chiede
allora il 23 ottobre «dettagli» sul tipo di lavoro della moglie, e il 31 ottobre
Robledo, pur «ribadendo l’insussistenza di incompatibilità», aggiunge che la
moglie, avvocato dal 2009, ha svolto la professione forense «esclusivamente nel
campo del diritto amministrativo sino a giugno 2013», quando ha smesso e ha
chiuso in luglio la partita Iva. Ma «al solo di fine di non lasciare spazio a
qualsiasi ulteriore incertezza o pretesto, si è anche cancellata dall’Albo degli
Avvocati il 27 ottobre 2014». Intanto Bruti ha interpellato il commissario di
Expo, Sala, che il 3 novembre spiega che l’avvocato «nel settembre 2013» rispose
a un bando online di Expo «per una posizione di specialista legale
amministrativa», fece la preselezione con altri candidati, la superò, svolse i
colloqui e infine ebbe il punteggio più alto. Mentre in Expo raccontano che è
una professionista stimata e chi l’ha selezionata non sapeva fosse legata a un
pm, la lettera di Sala prosegue indicando in 60.000 euro lordi l’anno lo
stipendio della moglie di Robledo con contratto co.co.pro. sino a fine 2015 per
la stipula dei «contratti commerciali» del Padiglione Italia in Expo. In linea
con quanto Robledo scrive sul fatto che la moglie, «in seguito al superamento di
concorso pubblico nel settembre 2013, svolge attività di mera consulenza legale
interna presso Expo 2015 nella materia specifica della valorizzazione ed
esposizione di prodotti tipici d’eccellenza nella filiera agroalimentare ed
enogastronomica italiana».
Procuratore Napoli, il figlio legale
ostacolo per Cafiero de Raho, scrive Mercoledì 7
Giugno 2017 Il Mattino. Il suo curriculum è eccellente, così come le sue doti
professionali sono riconosciute al Csm da tutti. Ma sulla via che potrebbe
portare il capo della procura di Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho alla
nomina a procuratore di Napoli c'è un ostacolo che non si sa ancora se possa
essere aggirato: un figlio che fa l'avvocato penalista proprio nel capoluogo
campano. Una situazione che potrebbe determinare - se effettivamente De Raho
venisse preferito al suo diretto concorrente, l'ex capo di gabinetto del
ministro della Giustizia, Giovanni Melillo - quella che tecnicamente viene
chiamata «incompatibilità parentale», e che è causa di trasferimento ad altra
sede per i magistrati. Per questo al Csm c'è chi chiede di affrontare subito
questo nodo, prima ancora che, la prossima settimana, la Commissione Direttivi
entri nel vivo della discussione sul candidato da proporre al plenum. Anche per
Melillo - che con De Raho si contende pure la nomina a procuratore nazionale
antimafia - la strada non è in discesa: su di lui restano i dubbi di una parte
dei consiglieri di Area (gruppo di riferimento dello stesso magistrato e ago
della bilancia in questa difficile partita), che giudicano poco opportuno
affidare la guida della procura di Napoli, alle prese con inchieste delicate con
implicazioni politiche, come quella su Consip, a chi sino a poco tempo fa ha
ricoperto un ruolo di diretta collaborazione con il ministro Orlando. Per quanto
riguarda De Raho, il problema del figlio avvocato, Francesco, si era già posto
in passato, quando il magistrato era procuratore aggiunto a Napoli. E nel 2009,
dopo una lunga istruttoria, il Csm aveva escluso che vi fosse un'incompatibilità
ambientale e funzionale. Non c'è «il pericolo di interferenze», stabilirono
allora i consiglieri, accertato che Francesco non aveva mai trattato la materia
specialistica del padre (all'epoca alla guida della sezione sulle misure di
prevenzione della Dda), non aveva con lui nessun rapporto di natura
professionale, e che, esercitando a Napoli, non avrebbe potuto occuparsi nemmeno
in futuro di criminalità casertana, materia di competenza del genitore. Allora
però De Raho era un procuratore aggiunto e dunque coordinava un settore
limitato. Per questo il ragionamento seguito all'epoca non potrebbe essere
riproposto ora per il ruolo di capo dell'ufficio. E il fatto che tra il
magistrato e il figlio non ci siano più rapporti dal 1997, ribadito dal capo
della procura di Reggio nell'audizione di dieci giorni fa al Csm, potrebbe non
essere decisivo. Anzi, nel 2009, i consiglieri ritennero questo elemento «privo
di rilevanza» perché «l'intensità della frequentazione tra i congiunti non è
presa in considerazione dalla legge e può mutare nel tempo in maniera del tutto
imprevista». La più facile soluzione del rebus sarebbe destinare De Raho al
vertice della procura nazionale antimafia e Melillo alla guida di quella
campana. Ma un piano del genere richiederebbe l'unità di Area, che ancora non
c'è.
Lo strano intreccio di magistrati e la
professione dei figli avvocati, scrive il 14 Maggio
2014 "Libero Quotidiano”. Nei tribunali non si applica la legge dei codici
(salvo eccezioni), mentre si applica la tecnica delle “raccomandazioni” e non si
può escludere “a pagamento”. Oggi vige anche una giustizia “casareccia”, ovvero
trovare l’avvocato figlio del magistrato. E’ il caso dell’imprenditore/avvocato
D.rio D’Isa, figlio del magistrato di cassazione C.dio D’Isa, l’avvocato cura
gli interessi Gabriele Terenzio e figlio Luigi, accusati di associazione per
delinquere di stampo camorristico, gli inquisiti hanno un ricorso per cassazione
e lo stesso avvocato D.rio D’Isa fa incontrare gli inquisiti con suo padre, il
giudice di Cassazione C.dio D’Isa, evidentemente per trovare una soluzione
ottimale agli inquisiti. Inutile stupirsi la giustizia viene amministrata con
questi “sistemi.”. Mi sono trovato nelle medesima situazione: un semplicissimo
procedimento civile durato 17 anni solo il primo grado, dopo il decimo anno uno
dei magistrati che per oltre cinque anni ha tenuto udienze “farsa”, con la sua
signora parla con un mio famigliare (ignari del procedimento in atto) e
raccontano che il tal avvocato (patrocinante il convenuto nel procedimento lungo
17 anni) era un loro amico e procurava lavoro legale al loro figliolo – avvocato
in Roma-, da una piccola indagine accertavo che molti legali del foro iniziale
di appartenenza del magistrato, per i ricorsi da presentare in Cassazione,
Consiglio di Stato, Corte dei Conti di 2° grado, Tar Lazio, ecc. si avvalevano
dell’avvocato figlio del magistrato, di conseguenza gli stessi avvocati avevano
una corsia preferenziale presso l’ufficio del magistrato per allungare i
processi e le parcelle, e comunque per fare pastette giudiziarie a danno di una
delle parti in causa, ipoteticamente lautamente compensate, non si può escludere
che il magistrato influenzasse altri colleghi per favorire clienti di avvocati
“AMICI”. Inoltre, lo stesso Avv. D.rio D’Isa è un imprenditore – come riferisce
il Vostro quotidiano Libero- e se così fosse sarebbe incompatibile l’esercizio
della professione legale. Ed il consiglio forense dovrebbe prendere
provvedimenti disciplinari nei confronti dell’Avv. D.rio D’Isa. Spesso le
sentenze della Cassazione fanno giurisprudenza!!!!!!
Parentopoli al tribunale di Lecce, il
presidente verso l'allontanamento. Il figlio di
Alfredo Lamorgese, avvocato iscritto a Bari, segue in Salento 37 cause civili,
ma in base alla legge sono ammesse, in via eccezionale, deroghe
all'incompatibilità parentale solo per piccole situazioni. Sul caso è
intervenuto il Csm per il trasferimento d'ufficio, scrive Chiara Spagnolo 12
giugno 2012 su "La Repubblica". Il padre presidente del Tribunale di Lecce, il
figlio avvocato, formalmente iscritto all’albo di Bari, ma con 37 cause civili
in itinere davanti allo stesso Tribunale del capoluogo salentino. È la saga dei
Lamorgese, famiglia di giudici e avvocati, che potrebbe costare il trasferimento
al presidente Alfredo, dopo che la prima commissione del Csm ha aperto
all’unanimità la procedura per "incompatibilità parentale". A Palazzo dei
Marescialli è stata esaminata la copiosa documentazione inoltrata dal Consiglio
giudiziario di Lecce, che, qualche settimana fa, ha rilevato la sussistenza
delle cause di incompatibilità attribuite all’attuale presidente del Tribunale.
Le verifiche effettuate dall’ordine degli avvocati hanno permesso di appurare
che Andrea Lamorgese risulta nominato come legale in 193 procedimenti pendenti
davanti agli uffici giudiziari salentini e che la sua appartenenza al Foro di
Bari, probabilmente, non basta a far venire meno le cause di incompatibilità
previste dall’ordinamento giudiziario. La legge prevede, infatti, che i
magistrati non possano esercitare funzioni direttive in un Tribunale in cui un
familiare svolga l’attività forense. La deroga a tale norma si può ottenere solo
quando l'attività difensiva del congiunto sia "sporadica e poco significativa"
anche dal punto di vista della qualità. Per ottenere la deroga, tuttavia, i
legami parentali tra giudici e avvocati devono essere portati all’attenzione del
Csm, cosa che Lamorgese non avrebbe fatto all’atto della sua nomina a presidente
del Tribunale, avvenuta nel 2009. A distanza di soli tre anni quella leggerezza
rischia di costargli cara, ovvero un trasferimento prematuro rispetto agli otto
anni previsti per il suo incarico, perché l’accertamento sull’attività svolta
dal figlio ha permesso di scoprire come l’esercizio della funzione legale di
Andrea a Lecce non fosse né sporadica né poco significativa. Diversamente per
quanto riscontrato rispetto alla figlia e alla nuora, anche loro avvocati, le
cui professioni non sarebbero però incompatibili con l’attività del presidente,
dal momento che la prima non esercita la professione e la seconda si occupa di
giustizia amministrativa. Il prossimo passo del Consiglio superiore della
magistratura sarà la convocazione di Lamorgese a Roma, che sarà ascoltato il
prossimo 25 giugno per chiarire la propria posizione. All’esito dell’ascolto, e
dell’esame di eventuali documenti prodotti, la prima commissione deciderà se
chiedere al plenum il trasferimento o archiviare il caso.
Lecce, trasferito il presidente del
tribunale. "Il figlio fa l'avvocato, incompatibile".
La decisione presa all'unanimità dal Csm: Alfredo Lamorgese non può esercitare
nello stesso distretto dove lavora il suo congiunto. Il magistrato verso la
pensione anticipata, scrive Chiara Spagnolo il 13 febbraio 2013 su "La
Repubblica". Finisce con la parola trasferimento l’esperienza di Alfredo
Lamorgese alla guida del Tribunale di Lecce. Il plenum del Csm è stato
perentorio: impossibile sedere sulla poltrona di vertice degli uffici giudicanti
salentini se il figlio avvocato, formalmente iscritto all’albo di Bari, in
realtà esercita la sua professione anche a Lecce. Trasferimento d’ufficio per
incompatibilità ambientale era stato chiesto dalla Prima commissione e così
sarà, in seguito alla decisione presa ieri all’unanimità a Palazzo dei
Marescialli. Prima che la Terza commissione scelga per Lamorgese una nuova
destinazione, tuttavia, il giudice potrebbe presentare domanda di pensionamento,
così come è stato comunicato ad alcuni membri del Csm, che avevano consigliato
di chiudere immediatamente la lunga esperienza professionale onde evitare l’onta
di una decisione calata dall’alto. La vicenda tiene banco da mesi nei palazzi
del barocco, da quando il Consiglio giudiziario di Lecce ha inoltrato al
Consiglio superiore una copiosa documentazione che ha determinato l’apertura
della pratica per incompatibilità “parentale”. Le verifiche effettuate
dall’ordine degli avvocati hanno permesso infatti di appurare che Andrea
Lamorgese risulta nominato come legale in 193 procedimenti pendenti davanti agli
uffici giudiziari salentini e che la sua appartenenza al Foro di Bari,
probabilmente, non basta a far venire meno le cause di incompatibilità previste
dall’ordinamento giudiziario. La legge prevede che i magistrati non possano
esercitare funzioni direttive in un Tribunale in cui un familiare svolga
l’attività forense. La deroga a tale norma si può ottenere solo quando
l'attività difensiva del congiunto sia "sporadica e poco significativa" anche
dal punto di vista della qualità e deve essere tempestivamente comunicata
all’organo di autogoverno della magistratura. Stando a quanto verificato dal
Csm, tuttavia, il presidente non avrebbe comunicato alcuna causa di
incompatibilità all’atto della sua nomina, avvenuta nel 2009, né negli anni
successivi. E a poco è servito il tentativo di difendersi che in realtà le cause
in cui il figlio è stato protagonista come avvocato sono in numero di gran lunga
inferiore rispetto alle 193 contestate, perché l’accertamento sull’attività
svolta dal figlio ha permesso di scoprire come l’esercizio della funzione legale
di Andrea a Lecce non fosse né sporadica né poco significativa. Al punto che,
secondo il Consiglio superiore, uno dei due Lamorgese avrebbe dovuto lasciare.
Brindisi, giudici contro il procuratore,
scrive il 27 giugno 2008 Sonia Gioia su "La Repubblica". Il procuratore Giuseppe
Giannuzzi, oggetto di un pronunciamento di incompatibilità parentale da parte
del Consiglio superiore della magistratura, che lo costringe ad abbandonare il
ruolo rivestito nella procura brindisina, non potrà mai più dirigere un'altra
procura. E' questo, a quanto pare, quello che stabilisce la legge. Sebbene a
Giannuzzi resti la chance del ricorso al tribunale amministrativo contro il
provvedimento adottato dall' organo di autogoverno dei magistrati.
Incompatibilità sorta sulla base di un procedimento penale nel quale un figlio
del magistrato, Riccardo Giannuzzi, avvocato iscritto all'albo forense di Lecce,
assunse la difesa di alcuni indagati sulla base di una richiesta al gip
controfirmata dallo stesso procuratore capo. Giannuzzi junior, raggiunto
telefonicamente, si esime da qualsiasi commento: "Non parlo per una questione di
correttezza nei confronti di mio padre. Senza il suo consenso non sarebbe giusto
rilasciare alcuna dichiarazione". Ma la famiglia, coinvolta in una vicenda senza
precedenti, almeno nella procura brindisina, è comprensibilmente provata. Sono
stati i magistrati della città messapica i primi a far emergere il caso della
presunta incompatibilità parentale. Gli stessi giudici difesi a spada tratta da
Giannuzzi quando gli strali del gip Clementina Forleo, autrice della denuncia
contro i pm Alberto Santacatterina e Antonio Negro, si sono abbattuti sulla
procura di Brindisi. A settembre scorso la sezione locale dell'associazione
nazionale magistrati si riunì per discutere il caso, dopo che da tempo, nei
corridoi del palazzo al civico 3 di via Lanzellotti, si mormorava
insistentemente e non senza insofferenza. L'avvocato Giannuzzi, per quanto
iscritto all'albo salentino dal 1999, figurava in qualità di difensore in
diversi processi celebrati nel tribunale brindisino. Fino all' ultimo caso,
esploso a seguito di un blitz per droga. Il legale assunse la difesa di uno
degli indagati, arrestato a seguito dell'operazione, sulla base di una richiesta
al gip controfirmata da Giuseppe Giannuzzi. A seguito della vicenda, i giudici
tanto della procura quanto del tribunale, riuniti in consesso, insorsero
siglando a maggioranza una delibera in cui si legge: "L' evidente caso di
incompatibilità parentale mina il prestigio di cui la magistratura brindisina ha
sempre goduto". Parole pesanti, che il procuratore capo Giuseppe Giannuzzi, di
stanza a Brindisi dal settembre 2004, non ha mai voluto commentare. Adesso, il
pronunciamento del Csm: padre e figlio non possono convivere professionalmente
nello stesso distretto giudiziario. Diciotto i voti a favore, sei i favorevoli a
Giannuzzi, fra cui quello del presidente Nicola Mancino. La decisione è stata
adottata sebbene l'avvocato Riccardo Giannuzzi abbia, a seguito del putiferio
venutosi a creare, rinunciato a tutti i mandati che potevano vedere in qualche
modo coinvolto il procuratore capo della Repubblica di Brindisi. La prima
commissione del Csm si era già espressa all' unanimità a favore del
trasferimento, sempre alla luce del fatto che Giannuzzi junior esercita la
professione forense anche nel capoluogo messapico. Le conseguenze del
procedimento, a quanto pare, non sortiranno effetti in tempi brevi: la decisione
del plenum del Csm infatti, dopo la notifica potrà essere impugnata dal
procuratore capo. La prassi prevede che a indicare le nuove, possibili sedi di
destinazione sia ora la terza commissione del Consiglio superiore della
magistratura. La scelta toccherà direttamente al giudice, che se non dovesse
esprimersi, sarà trasferito d' ufficio. Ma in nessuna sede in cui Giuseppe
Giannuzzi verrà destinato, lo prevede il regolamento, mai più potrà rivestire il
ruolo di procuratore capo. A meno che non presenti ricorso al Tar e lo vinca.
Tribunale di Messina, le relazioni
pericolose emerse dallo screening di un gruppo di giovani avvocati,
scrive l'1 settembre 2016 "100 Nove". Nello “screening” effettuato in relazione
al Tribunale di Messina, un gruppo di giovani avvocati emergono una serie di
rapporti in chiaroscuro tra magistrati, prima sposati e poi divorziati, che si
trovano ad operare nello stesso tribunale; magistrati che si ritrovano cognati
avvocati a discutere le stesse cause. E altro, dopo l’esplosione del caso Simona
Marra. Un dettagliato elenco di tutte le anomalie nei rapporti tra avvocati e
magistrati nel distretto giudiziario di Messina. Lo ha predisposto un gruppo di
giovani avvocati che ha passato al setaccio le situazioni “controverse” nei
tribunali della provincia, dopo l’esplosione del “caso Simona Merra”, il pm di
Trani titolare del fascicolo sull’incidente ferroviario del 12 luglio tra Bari e
Barletta dove hanno perso la vita 23 persone, sorpresa da uno scatto fotografico
a farsi baciare il piede dall’avvocato Leonardo De Cesare, legale di Vito
Picaretta, capostazione di Andria che è il principale indagato della strage.
Nello “screening” del Tribunale di Messina, conosciuto in passato come “rito
peloritano”, emergono una serie di rapporti in chiaroscuro tra magistrati, prima
sposati e poi divorziati, che si trovano ad operare nello stesso tribunale;
magistrati che si ritrovano cognati avvocati a discutere le stesse cause;
magistrati togati che, tra i 64 incaricati alla commissione tributaria, si
ritrovano nella rotazione ad avere parenti diretti in commissione; magistrati
invitati la sera a cena da avvocati, con i quali hanno fascicoli aperti. Una
situazione anomala, tollerata per una sorta di quieto vivere, che preoccupa ora
i giovani avvocati promotori dello screening: si stanno interrogando se inviare
in forma anonima il documento solo ai giornali e al Consiglio giudiziario, o
solo alla sezione disciplinare del Csm e alla procura generale della Cassazione:
temono rappresaglie professionali, da parte dei magistrati e consiglieri
dell’Ordine. Sulla questione delle incompatibilità, si è aperto un vivace
dibattito anche a livello nazionale. Se da una parte il vicepresidente del
Csm Giovanni Legnini chiede ai magistrati di assumere un maggiore senso di
sobrietà e finirla con la giustizia-spettacolo, dall’altra, la stessa categoria
dei magistrati, dilaniata dalle correnti, si è spaccata sul caso “Simona Marra”
con posizioni divergenti tra Magistratura Indipendente, Magistratura
Democratica, Unicost, Area, la corrente di sinistra, e Autonomia & Indipendenza,
il gruppo che fa capo al presidente nazionale dell’Associazione nazionale
magistrati, Piercamillo Davigo, che ha raccolto un buon numero di adesioni in
provincia di Messina, dove esponente di punta è il procuratore
aggiunto, Sebastiano Ardita.
Giustizia alla cosentina: tutte le
“parentele pericolose” tra giudici, pm e avvocati,
scrive Iacchite il 22 luglio 2016. Diciassette magistrati del panorama
giudiziario di Cosenza e provincia risultano imparentati con altrettanti
avvocati dei fori cosentini. Una situazione impressionante, che corre da anni
sulle bocche di tutti i cosentini che hanno a che fare con questo tipo di
“giustizia”. Il dossier Lupacchini, già dieci anni fa, faceva emergere in tutta
la sua gravità questo clima generale di “incompatibilità ambientale” ma non è
cambiato nulla, anzi. La legge, del resto, non è per niente chiara e col passare
del tempo è diventata anche più elastica. Per cui diventa abbastanza facile
eludere il comma incriminato e cioè che il trasferimento diventa
ineludibile “quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio
della Amministrazione”. Si tratta, dunque, di un potere caratterizzato da
un’ampia discrezionalità. E così, dopo un decennio, siamo in grado di darvi una
lettura aggiornata di tutto questo immenso “giro” di parentele, difficilmente
perseguibili da una legge non chiara e che comunque quantomeno condiziona
indagini e sentenze. E coinvolge sia il settore penale che quello civile. Anzi,
il civile, che è molto più lontano dai riflettori dei media, è ricettacolo di
interessi, se possibile, ancora più inconfessabili. Cerchiamo di capirne di più,
allora, attraverso questo (quasi) inestricabile reticolo di relazioni familiari.
LE PARENTELE PERICOLOSE
Partiamo dai magistrati che lavorano nel Tribunale
di Cosenza.
Il pubblico ministero Giuseppe Casciaro (chè tanto
da qualcuno dovevamo pur cominciare) è sposato con l’avvocato Alessia Strano,
che fa parte di una stimata famiglia di legali, che coinvolge anche il suocero
Luciano Strano e i cognati Amedeo e Simona.
Il giudice Alfredo Cosenza è sposato con
l’avvocato Serena Paolini ed è, di conseguenza, cognato dell’avvocato Enzo
Paolini, che non ha certo bisogno di presentazioni.
Il gip Giusy Ferrucci, dal canto suo, è sposata
con l’avvocato Francesco Chimenti.
Paola Lucente è stata giudice del Tribunale penale
di Cosenza e adesso è in servizio alla Corte d’Appello di Catanzaro e mantiene
il ruolo di giudice di sorveglianza e della commissione tributaria cosentina. Di
recente, il suo nome è spuntato fuori anche in alcune dichiarazioni di pentiti
che la coinvolgono in situazioni imbarazzanti riguardanti il suo ruolo di
magistrato di sorveglianza.
Anche la dottoressa Lucente ha un marito avvocato:
si chiama Massimo Cundari.
Del giudice Lucia Angela Marletta scriviamo ormai
da tempo. Anche suo marito, Maximiliano Granata, teoricamente è un avvocato ma
ormai è attivo quasi esclusivamente nel settore della depurazione e, come si sa,
in quel campo gli interventi della procura di Cosenza, in tema di sequestri e
dissequestri, sono assai frequenti. Quindi, è ancora peggio di essere “maritata”
con un semplice avvocato.
Se passiamo al civile, la situazione non cambia di
una virgola.
La dottoressa Stefania Antico è sposata con
l’avvocato Oscar Basile.
La dottoressa Filomena De Sanzo, che proviene
dall’ormai defunto tribunale di Rossano, si porta in dote anche lei un marito
avvocato, Fabio Salcina.
La dottoressa Francesca Goggiamani è in servizio
nel settore Fallimenti ed esecuzioni immobiliari ed è sposato con
l’avvocato Fabrizio Falvo, che fino a qualche anno fa è stato anche consigliere
comunale di Cosenza.
GIUDICI COSENTINI IN ALTRA SEDE
Passando ai magistrati cosentini che adesso
operano in altri tribunali della provincia o della regione, il giudice penale
del Tribunale di Paola Antonietta Dodaro convive con l’avvocato Achille
Morcavallo, esponente di una famiglia da sempre fucina di legali di spessore.
Il giudice penale del Tribunale di Castrovillari,
nonché giudice della commissione tributaria di Cosenza, Loredana De Franco, è
sposata con l’avvocato Lorenzo Catizone. Anche lui, come Granata, non fa
l’avvocato di professione ma in compenso fa parte da anni dello staff di Mario
Oliverio. Che non ha bisogno di presentazioni. Catizone, inoltre, è cugino di
due noti avvocati del foro cosentino: Francesco e Rossana Cribari.
Il neoprocuratore di Castrovillari Eugenio
Facciolla si trascina molto più spesso rispetto al passato la figura ingombrante
del fratello Marco, avvocato. In più, lo stesso Facciolla è cognato
dell’avvocato Pasquale Vaccaro.
Sempre a Castrovillari, c’è un altro giudice
cosentino, Francesca Marrazzo, che ha lavorato per molti anni anche al Tribunale
di Cosenza. E che è la sorella dell’avvocato Roberta Marrazzo.
La dottoressa Gabriella Portale invece è in
servizio alla Corte d’Appello di Catanzaro (sezione lavoro) ed è giudice della
commissione tributaria di Cosenza. Suo marito è l’avvocato Gabriele Garofalo.
Il dottor Biagio Politano, giudice della Corte
d’Appello di Catanzaro già proveniente dal Tribunale di Cosenza e giudice della
commissione tributaria di Cosenza, ha una sorella tra gli avvocati. Si
chiama Teresa.
Non avevamo certo dimenticato la
dottoressa Manuela Morrone, oggi in servizio nel settore civile del Tribunale di
Cosenza dopo aver lavorato anche nel penale. Tutti sanno che è la figlia
di Ennio Morrone e tutti sappiamo quanto bisogno ha avuto ed ha tuttora di una
buona parola per le sue vicissitudini giudiziarie, sia nel penale, sia nel
civile.
Morrone non è un avvocato ma riteniamo, per tutte
le cause che lo vedono protagonista, che lo sia diventato quasi honoris causa.
Poiché non ci facciamo mancare veramente nulla,
abbiamo parentele importanti anche per giudici onorari e giudici di pace.
La dottoressa Erminia Ceci è sposata con
l’avvocato Alessandro De Salvo e il dottor Formoso ha tre avvocati in famiglia:
suo padre e le sue due sorelle.
Tra i giudici di pace, infine, la
dottoressa Napolitano è la moglie dell’avvocato Mario Migliano.
CHE COSA SIGNIFICA
Mentre le “conseguenze” delle reti personali nel
settore penale sono molto chiare e riguardano reati di una certa gravità, le
migliori matasse si chiudono nel settore civile, come accennavamo. Numerosi
avvocati, familiari di magistrati, sono nominati tutori dai giudici tutelari del
Tribunale di Cosenza, per esempio gli avvocati De Salvo e Politano, ma anche
curatori fallimentari oppure avvocati nelle cause dei tutori e della curatela
del fallimento in questione. Alcuni avvocati, per evitare incompatibilità, fanno
condurre le cause ad altri avvocati a loro vicini. Cosa succede quando uno degli
avvocati che cura gli interessi del familiare di un giudice ha una causa con un
altro avvocato imparentato con un altro giudice? Lasciamo ai lettori ogni tipo
di risposta. Un discorso a parte meritano le nomine dei periti del tribunale.
Parliamo di una schiera pressoché infinita di consulenti tecnici d’ufficio,
medici, ingegneri, commercialisti, geologi e chi più ne ha più ne metta. Pare
che alcuni, quelli maggiormente inseriti nella massoneria, facciano collezione
di nomine e di soldini. Questo è il quadro generale, diretto, tra l’altro da un
procuratore in perfetta linea con i suoi predecessori: coprire tutto il marcio e
continuare a far pascere i soliti noti. Questa è la giustizia “alla cosentina”.
E nessuno si lamenta. Almeno ufficialmente.
Sarebbe interessante, però,
sapere di quanti paradossi sono costellata i distretti giudiziari italiani.
Art. 19 dell’Ordinamento
Giudiziario. (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con
magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede).
I magistrati che hanno tra loro vincoli di
parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non
possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso
ufficio giudiziario.
La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di
sede è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma,
per quanto compatibili.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di
parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non
possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati
in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in
un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei
due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede
centrale.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di
parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di
convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle
corti e nei tribunali.
I magistrati preposti alla direzione di uffici
giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di
incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti
organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile
e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla
base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili,
se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità
entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al
medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed
i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della
Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un
magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della
Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i
minorenni.
I magistrati non possono appartenere ad uno stesso
ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in
primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La
ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri
di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.
Si sa che chi comanda detta legge e non vale la
forza della legge, ma la legge del più forte.
I magistrati son marziani. A chi può venire in
mente che al loro tavolo, a cena, lor signori, genitori e figli, disquisiscano
dei fatti di causa approntati nel distretto giudiziario comune, o addirittura a
decidere su requisitorie o giudizi appellati parentali?
A me non interessa solo l'aspetto
dell'incompatibilità. A me interessa la propensione del DNA, di alcune persone
rispetto ad altre, a giudicare o ad accusare, avendo scritto io anche:
Concorsopoli.
«Ciao Melitta, hai saputo? Mio marito è stato
nominato all'unanimità presidente della Corte d'Appello di Messina. Sono molto
contenta, dillo anche a Franco (Tomasello, rettore dell'Università) e ricordagli
del concorso di mio figlio. Ciao, ciao». Chi parla al telefono è la moglie del
presidente della Corte d'appello di Messina, Nicolò Fazio, chi risponde è
Melitta Grasso, moglie del rettore e dirigente dell'Università, il cui telefono
è intercettato dalla Guardia di Finanza perché coinvolta in una storia di
tangenti per appalti di milioni di euro per la vigilanza del Policlinico
messinese. Ma non è la sola intercettazione. Ce ne sono tante altre, anche di
magistrati messinesi, come quella del procuratore aggiunto Giuseppe Siciliano
che raccomanda il proprio figlio. Inutile dire che tutti e due i figli, quello
del presidente della Corte d'appello e quello del procuratore aggiunto, hanno
vinto i concorsi banditi dall'ateneo. Posti unici, blindati, senza altri
concorrenti. Francesco Siciliano è diventato così ricercatore in diritto
amministrativo insieme a Vittoria Berlingò (i posti erano due e due i
concorrenti), figlia del preside della facoltà di Giurisprudenza, mentre
Francesco Siciliano è diventato ricercatore di diritto privato. Senza nessun
problema perché non c'erano altri candidati, anche perché molti aspiranti, come
ha accertato l'indagine, vengono minacciati perché non si presentino. Le
intercettazioni sono adesso al vaglio della procura di Reggio Calabria che, per
competenza, ha avviato un'inchiesta sulle raccomandazioni dei due magistrati
messinesi, che si sarebbero dati da fare con il rettore Franco Tomasello per
fare vincere i concorsi ai propri figli. Altri guai dunque per l'ateneo che,
come ha raccontato «Repubblica» nei giorni scorsi, è stato investito da una
bufera giudiziaria che ha travolto proprio il rettore, Franco Tomasello, che è
stato rinviato a giudizio e sarà processato il 5 marzo prossimo insieme ad altri
23 tra docenti, ricercatori e funzionari a vario titolo imputati di concussione,
abuso d' ufficio in concorso, falso, tentata truffa, maltrattamenti e peculato.
In ballo, alcuni concorsi truccati e le pressioni fatte ad alcuni candidati a
non presentarsi alle prove di associato. E in una altra indagine parallela è
coinvolta anche la moglie del rettore, Melitta Grasso, dirigente universitaria,
accusata di aver favorito, in cambio di «mazzette», una società che si era
aggiudicata l'appalto, per quasi due milioni di euro, della vigilanza
Policlinico di Messina. Un appalto che adesso costa appena 300 mila euro.
L'inchiesta sull'ateneo messinese dunque è tutt'altro che conclusa ed ogni
giorno che passa si scoprono altri imbrogli. Agli atti dell'inchiesta, avviata
dopo la denuncia di un docente che non accettò di far svolgere concorsi
truccati, ci sono molte intercettazioni della moglie del rettore. Convinta di
non essere ascoltata, durante una perquisizione della Guardia di Finanza Melitta
Grasso dice ad un suo collaboratore («Alberto») di fare sparire dall'ufficio
documenti compromettenti. In una interrogazione del Pd al Senato, si chiede al
ministro della Pubblica istruzione Mariastella Gelmini «se intende costituirsi
parte civile a tutela dell'immagine degli atenei e inoltre se intenda sospendere
cautelativamente il rettore di Messina». (Repubblica — 20 novembre 2008 pagina
20, sezione: cronaca).
L'INCHIESTA DI M. SCHINELLA SULLA
PARENTOPOLI DI MESSINA: LE CATTEDRE DI FAMIGLIA. TUTTI I NOMI DI TUTTE LE
FACOLTA'! Scrive il 18 novembre 2008
"Stampalibera.it". Identico cognome. Identico luogo di nascita. Il 50% dei 1500
docenti dell’Ateneo di Messina, uno ogni 20 iscritti, ha almeno un omonimo. Ed è
accomunato ai colleghi dallo stesso luogo di nascita, la città di Messina. Il
dato statistico, rapportato alla esigua popolazione della città, è l’indizio che
la parentopoli nell’Università peloritana non teme confronti neanche con gli
altri Atenei siciliani. Un indizio che diventa prova non appena si va oltre le
omonimie. Altro che Palermo. Del “dovere morale di sistemare mio figlio”, come
dice Battesimo Macrì, ordinario e preside di Medicina Veterinaria impegnato a
fine 2006 a far vincere a tutti i costi un posto di associato al figlio
Francesco, che benchè già ricercatore è considerato dalla commissione “carente
di preparazione di base, in possesso di superficiale conoscenza della materia,
di scarsa capacità espositiva e sensibilità didattica”, all’Università di
Messina nel reclutamento dei docenti ma anche degli amministrativi, si è fatto
un larghissimo uso. L’Ateneo da luogo del sapere si è trasformato in azienda in
cui sistemare i familiari. E se molti hanno scalato i gradini accademici con
sacrifici e dopo anni di gavetta, i numeri sono impietosi: sono legati da
parentela 27 dei 75 docenti di Giurisprudenza. A Palermo sono 21 su 132. A
Medicina e Chirurgia i rapporti di parentela diretta uniscono 90 dei 531. A
Palermo, per rimanere al confronto, 58 su 440. A Medicina Veterinaria, dei 63
docenti 23 sono legati da un rapporto che non va oltre a quello che intercorre
tra nonno e nipote. Gruppi familiari si sono impadroniti di intere facoltà. E
quando i rampolli da piazzare sono stati troppi o i posti pochi sono stati
dirottati su altre. Chi a Messina ha fatto carriera universitaria ha avuto la
fortuna di nascere nella famiglia giusta: Navarra, Carini, Vermiglio, Saitta,
Galletti, Tommasini, Falzea, Dugo, Tigano, Teti, Resta, Guarnieri, Basile,
Trimarchi, Germanà. O ha avuto un padre ordinario: decine sono i cattedratici
che non sono riusciti ad insediare l’intera famiglia ma prima di abbandonare si
sono assicurati un erede. Un risultato frutto di valutazioni comparative che di
comparativo hanno avuto poco: tra la fine del 2006 e l’inizio 2007, l’Università
ha bandito74 concorsi per ricercatore. Nel 60% di questi la valutazione ha avuto
un solo candidato, il vincitore. Gli altri si sono ritirati anzitempo. «Che il
fenomeno fosse imponente lo sospettavo. Ma il problema più grosso è che i figli
di qualcuno hanno comunque, anche se i concorsi fossero regolari, molte più
opportunità dei figli di nessuno», dice Andrea Romano, preside di Scienze
politiche, una delle facoltà meno colpita. Adesso l’Università ha pronto un
codice etico: lo ha preparato Antonio Ruggeri, docente di Diritto costituzionale
e prorettore. Prevede che il figlio del cattedratico, se vuole seguire le orme
del padre nella stessa disciplina debba emigrare in altri atenei. Ironia della
sorte, la chiamata nello stesso dipartimento, alla cattedra di procedura penale,
del figlio trentenne di Ruggeri, Stefano, associato (l’idoneità l’aveva
conseguita all’Università privata Kore di Enna), la cui madre, Carmela Russo, è
ordinario nella stessa facolta di Istituzione di diritto romano, determinò nel
corso del Consiglio di facoltà del 21 dicembre 2007, una mezza sollevazione. Il
segno che in una delle Facoltà più prestigiose dell’Ateneo il livello di guardia
fosse stato superato, lo sintetizzò Sara Domianello, ordinario di diritto
Ecclesiastico: «Da questo momento mi rifiuterò di esprimere un giudizio su
conferimenti di incarichi a persone legate a colleghi da vincoli di parentela od
affinità fino al quarto grado», affermò nello stupore generale la docente.
Centonove, è andato a caccia dei vincoli di parentela.
GIURISPRUDENZA – La Domianello, allieva del
preside, Salvatore Berlingò, ha presieduto la commissione che ha attribuito
l’idoneità di associato a Marta Tigano, figlia di Aldo Tigano, ordinario di
diritto amministrativo. Che si ritrova come collaboratrice la figlia di
Berlingò, Vittoria, ricercatrice di diritto amministrativo. E nel corpo docente
vanta 2 nipoti, Francesco Martines, e Valeria Tigano, entrambi ricercatori.
Nello stesso dipartimento gomito a gomito lavorano Giuseppe Giuffrida, ordinario
di diritto agrario, e la figlia Marianna, ordinario anch’ella, della stessa
disciplina del padre. All’Istituto di diritto privato impera Raffaele Tommasini,
ordinario di Lavoro e Civile, un numero di incarichi compendiato in un elenco
che riempirebbe un’intera pagina, che si avvale nel proprio dipartimento della
figlia Alessandra. E del genero, Antonino Astone, associato. L’altra figlia
Maria, è associato, sempre della stessa disciplina, alla facoltà di Economia.
L’altro genero, Orazio Pellegrino, è ricercatore a Ingegneria. Nello stesso
settore, diritto privato, in cui opera anche Francesca Panuccio, associata
figlia di Vincenzo, una vita da ordinario, muove i primi passi da cattedratico,
Francesco Rende, figlio di Ciraolo Clorinda, associato nella stessa disciplina,
e di Mario Rende, assistente ad Economia. Vincenzo Michele Trimarchi, era stato
anche giudice della Corte costituzionale, il figlio Mario, è ordinario di
privato, (la moglie di questi, Renata Altavilla, è associato nello stesso
dipartimento), il nipote Francesco è ordinario a Medicina.
MEDICINA E CHIRURGIA – Trecentoventi dei 540
docenti della Facoltà, secondo il Ministero dell’Università, sono di troppo ma
l’Ateneo di Messina fa finta di nulla e continua a bandire concorsi (7
nell’ultima tornata) per ricercatori, associati e ordinari. Che vanno quasi
sempre ai soliti figli di cattedratico. Come quello del 2005 per ricercatore di
Chirurgia, andato a Giuseppinella Melita, figlia di Paolo, ordinario. O a Rocco
Caminiti, figlio di un ordinario in pensione. La dinastia dei Galletti regna
all’Otorinolaringoiatria: Cosimo Galletti è stato il capostipite, il figlio
Franco, ordinario, e Bruno, associato, i suoi eredi. L’ultimo figlio Claudio si
è spostato ad Anestesiologia, dove è ricercatore. Massimo, invece, è divenuto
associato di diritto privato a Giurisprudenza. Al defunto chirurgo Salvatore
Navarra, è succeduto in sala operatoria uno dei 3 figli, Giuseppe, diventato
ordinario giovanissimo. Pietro, è ordinario ad Economia (e prorettore). Michele
è associato a Scienze. La Dermatologia porta il nome di Guarnieri: Biagio è
ordinario, i figli Claudio e Fabrizio, ricercatori. Diana Teti, patologo, e
Giuseppe Teti, microbiologo, entrambi ordinari, hanno raccolto lʼeredità del
padre, Mario, ordinario di microbiologia in pensione. Diana si è sposata con
Matteo Venza, ordinario a Scienze. Un’unione che ha dato a Medicina altri due
ricercatori: Mario e Isabella Venza. L’oculista Giuseppe Ferreri, ordinario,
lavora fianco a fianco della figlia Felicia, ricercatrice. Cosi come Gaetano
Barresi, ordinario, con la figlia, Valeria, ricercatrice. Ci lavoravano fino
alla scorsa settimana Giuseppe Romeo, ordinario di Chirurgia pediatrica, e il
figlio Carmelo, ordinario delle stessa disciplina. Corrado Messina, ordinario di
Neurologia ha una figlia Maria Francesca, ricercatrice in altro settore.
Maurizio Monaco, ordinario, figlio dell’ex Prefetto di Messina, ha il figlio
Francesco ricercatore. Hanno avuto un padre o la madre, ordinario o associato
nella stessa o in disciplina affine, solo per fare degli esempi, Eugenio
Cucinotta, Antonio D’Aquino, Marcello Longo, Massimo Marullo, Filippo De Luca,
Antonino Germanò, Ignazio Barberi, Giorgio Ascenti, Michele Colonna, Impallomeni
Carlo, Giuseppe Santoro, Antonella Terranova.
MEDICINA VETERINARIA – Giovanni Germanà, ordinario
di Fisiologia, ha lasciato il segno. Nello stesso settore è associato il figlio
Antonino e la nipote Germana. Un’altra nipote, Maria Beatrice Levanti, è
ricercatrice, sempre nello stesso settore. Luigi Chiofalo era ordinario di
Zootecnia, Vincenzo, il figlio, attuale preside di Facoltà ne ha preso il posto,
Biagina, l’altra figlia è ricercatrice, così come il marito, Luigi Liotta: tutti
nello stesso settore. Ma a Veterinaria nello stesso settore, Sanità pubblica,
operano Antonio Pugliese, ordinario e la figlia Michela che si è aggiudicata un
posto di ricercatrice in un concorso in cui era unica candidata, per le
pressioni, secondo la Procura di Messina, del padre su concorrenti più titolati.
E Battesimo Macrì, e il figlio ricercatore, Francesco, la cui ascesa è stata
interrotta dalla magistratura. Sono figli di cattedratici ormai in pensione una
schiera di docenti: Anna Maria Passantino, associato, figlia di Michele; Bianca
Orlandella, ricercatrice, figlia di Vittorio; Antonio Panebianco, diventato
ordinario senza salire per gli scalini intermedi; Antonio Ajello e Adriana
Ferlazzo, (moglie di Alberto Calatroni, ordinario a Medicina) sorelle entrambe
ordinario, figlie di Aldo, ordinario, invece, di Pediatria. Pippo Cucinotta,
ordinario di Chirurgia, infacoltà non ha parenti, ma da Claudia Interlandi,
associato dello stessa disciplina ha avuto 2 figli.
SCIENZEMATEMATICHE E FISICHE – La fisica e la
matematica a Messina parla Carini. Giovanni, il capostipite, era ordinario di
Fisica Matematica. E ha sdoppiato i geni scientifici: il figlio Giuseppe, è
ordinario di Fisica; la figlia Luisa, associato di Matematica è moglie di
Giuseppe Magazzù, ordinario a Medicina. Il primo ha 2 figli, Manuela, già
ricercatrice di Matematica all’Università della Calabria. L’altro figlio
Giovanni è assegnista di ricerca. I fratelli Dugo, Giacomo e Giovanni, sono
entrambi ordinari. Giovanni, nello stesso Dipartimento a Farmacia ha una figlia,
Paola, associato, moglie di Luigi Mondello, ordinario nello stesso dipartimento
del suocero. Laura, figlia di Giovanni, ha già ottenuto un dottorato di ricerca
e si prepara a seguire le orme del padre. Come Giuseppe Gattuso, ricercatore di
chimica, figlio di Mario, ordinario della stessa disciplina, di Marisa Ziino,
ordinario a Scienze. E Armando Ciancio, figlio di Vincenzo, ordinario di
Matematica e delegato del rettore, che si è aggiudicato un recente concorso di
ricercatore dello stesso settore del padre, bandito, però, dalla Facoltà di
Medicina. Ed è in attesa di chiamata. Nella facoltà di Scienze operano come
associati, Enza Marilena Crupi, il padre era ordinario nella stessa facoltà.
Cosi come lo era il padre dell’ordinario Viviana Bruni, Augusto, docente per
decenni di Microbiologia. E il padre di Ulderico Wanderling, associato, figlio
di Franco, ordinario. Di cui è nipote Rita Giordano, associato sempre di Fisica.
La figlia di Rita De Pasquale, ordinario a Farmacia e prorettore, Chiara Costa,
figlia anche di Giovanni, ordinario di farmacologia, si è aggiudicata un posto
da ricercatrice a Medicina. Carlo Caccamo, ordinario, ha potenziato il corredo
genetico sposandosi con Maria Caltabiano, ordinario a Lettere: la figlia Daniela
è ricercatrice di biologia a Medicina.
ECONOMIA – Lavorano nella stessa Facoltà, ma in
dipartimenti diversi, Antonino Accordino, ordinario, e la figlia Patrizia,
ricercatrice. E’ figlia d’arte anche Maria Teresa Calapso, ordinario di
Matematica: il padre Pasquale Calapso, era ordinario di matematica seppure a
Scienze. Così come Paolo Cubiotti, ordinario di analisi matematica, cui ha
trasferito i geni scientifici il padre Gaetano, ex ordinario di Fisica. E
Filippo Grasso, associato, figlio dell’ordinario a Fisica, Vincenzo.
LETTERE – L’attuale preside, Vincenzo Fera, ha una
figlia Maria Teresa, che ha intrapreso la carriera medica ed è associato. L’ex
preside Gianvito Resta ha passato il testimone alla figlia Caterina, ordinario
nella facoltà del padre. L’altra figlia, Maria Letizia è associato a Medicina.
L’ordinario Angelo Sindoni, prorettore, ha una figlia, Maria Grazia, uscita di
recente vincitrice di un concorso per ricercatrice. Lavora, invece, a Scienze
politiche, nello stesso dipartimento del padre, Mario Centorrino, ordinario ed
ex prorettore, Marco, benchè il posto di ricercatore lo avesse bandito la
facoltà di Lettere.
TRAVERSALITA’ – Francesco Basile, ordinario, è
stato preside di Scienze. Non si può dire che i suoi figli nel mondo accademico
non abbiano fatto strada: Maurizio, ordinario a Medicina, Massimo, ordinario di
diritto a Scienze politiche, Fabio, ordinario a Ingegneria. La figlia di
quest’ultimo, Rosa, ha appena vinto un concorso di ricercatrice in diritto
costituzionale a Giurisprudenza. Dopo il ritiro degli altri candidati è rimasta
da sola. A presiedere la commissione Antonio Saitta, ordinario, ex sindaco di
Messina, appartenente ad una delle famiglie che all’Ateneo ha dato molto. E’
figlio di Emilio, che fu ordinario a Medicina. E nipote di Nazzareno, ordinario
a Giurisprudenza, il cui figlio Fabio è docente a Catanzaro, e di Gaetano,
ordinario a Ingegneria. Sono solo cugini tra di loro ma i Vermiglio si sono
fatto valere: uno, Mario Vermiglio, è vincitore di un concorso di ordinario a
Medicina, sempre a Medicina c’è Giuseppe, associato di Fisica, la moglie Maria
Giulia Tripepi, è associato dello stesso settore. Franco è invece ordinario ad
Economia. L’eredità di Diego Cuzzocrea, ordinario di Chirurgia, ed ex rettore
dell’Università, l’hanno raccolta, Salvatore, associato a Medicina e Francesca,
ricercatrice a Scienze della Formazione. Del precedente rettore Guglielmo Stagno
D’alcontres, ordinario di Chimica, sono nipoti Francesco, deputato nazionale,
ordinario di Chirurgia plastica a Messina e Alberto, ordinario di diritto
commerciale a Palermo. MICHELE SCHINELLA – CENTONOVE 07-11-08
Se il rettore non può firmare. I casi in cui il
Magnifico deve ricorrere al vicario. Da Gaetano Silvestri a Franco Tomasello. Il
concorso ad un posto di ricercatore in diritto amministrativo si è celebrato nel
giugno del 2008. Francesco Martines, figlio di Maria Chiara Aversa, ordinario
alla facoltà di Scienze, delegato del rettore per la ricerca, nipote di Aldo
Tigano, ordinario di diritto amministrativo, e genero del rettore Franco
Tomasello, di cui ha sposato la figlia, si è aggiudicato il posto. Ed è rimasto
in attesa della chiamata della facoltà di Scienze politiche. A firmare il
decreto di approvazione degli atti del concorso non è stato il suocero, come
succede in tutti gli altri casi: per prassi consolidata, infatti, lo fa il
rettore vicario. Non è la prima volta che il rettore vicario debba intervenire
per firmare gli atti di un concorso vinto da un parente stretto di Tomasello. Lo
fece già per il figlio Dario, vincitore nel 2005, del concorso di associato alla
Facoltà di Lettere. E non è il primo rettore vicario dell’Università di Messina.
Toccò anche al predecessore. Durante il rettorato di Gaetano Silvestri, la
moglie di quest’ultimo, Marcella Fortino, divenne docente ordinario. Insegna a
Scienze politiche. (M.S.)
Concorsi truccati: «Io raccomandata pentita, mi
sono riscattata...», scrive Nino Luca il 18 novembre 2008 su "Il Corriere della
Sera". «Non ci dormivo la notte. I finanziamenti "ad hoc " sono la prassi
accettata da tutti». Raccomandazioni all'università: il mondo del web reagisce.
Raccomandazioni all'università: il mondo del web reagisce. «Un posto, un solo
candidato: il figlio del professore». Sommersi dalle email. Dare spazio alle
denunce oppure spiegare il meccanismo cioè come si fa a truccare un concorso
nelle università italiane? Citare a caso qualcuna tra le centinaia di
segnalazioni che ci sono arrivate da Milano, Roma, Avellino, Bari o scegliere
solo alcuni casi emblematici? La storia che abbiamo raccontato venerdì, del
concorso da ricercatore a Messina, «Un posto, un solo candidato: il figlio del
professore», ha scatenato il web. Dalle centinaia e centinaia di e-mail ricevute
è chiaro che si tratta di un fenomeno che colpisce tutti gli atenei italiani, da
nord a sud. Molte di queste email contengono delle vere e proprie notizie di
reato e innumerevoli casi di disonestà che scatta in maniera meccanica laddove
la legge lascia margini di discrezionalità all'individuo. E quindi «taroccare»
diventa quasi una prassi. Molti, impauriti da possibili ritorsioni, ci chiedono
di non pubblicare i loro nomi ma fanno nomi, precisando anche i fatti e
circostanziandoli. E sono tantissimi anche gli italiani, fuggiti all'estero, che
ci hanno scritto. Quindi, dopo le opportune verifiche, organizzeremo meglio
questo «urlo di denuncia» e magari lo faremo attraverso una pubblicazione. Ma
adesso non troviamo di meglio che pubblicare un'autodenuncia che è anche un
augurio. Perché, come in tanti ci hanno scritto, la «parola "cultura" dovrebbe
necessariamente essere associata ad un vivere corretto e civile».
LA LETTERA - Ecco il testo di Lucia (nome di
fantasia): «Io ottenni una borsa di studio dottorale messa in palio
dall'università di ... che fu finanziata dall'ente pubblico presso il quale
lavoravo, ergo: era la mia borsa di dottorato. Volevo fare il dottorato da
quando mi ero iscritta all'università; non sono né figlia né nipote di, ma ero
l'assistente di... In attesa nel concorso trovai un posto come consulente presso
un ente pubblico, nel quale mi occupavo della stessa materia della mia tesi, e
il mio Professore «arrangiò» il finanziamento. Mi presentai al concorso. Mi
sedetti coi 7 partecipanti; si fecero gli scritti a porte aperte e gli orali a
porte chiuse. Vinsi, ovviamente, la borsa. Sono pronta a difendere quanto le sto
per dire sotto giuramento: mi creda quando le dico che non ci dormivo la notte,
mentre questa prassi (di raccomandazione o finanziamenti ad hoc) era del tutto
accettata, e non criticata, dai dottorandi che ne usufruivano».
I DUBBI - «Io invece - prosegue Lucia - mi
chiedevo in continuazione: sono un dottorando perché sono veramente dotata in
questo campo o perché sono l'assistente di con la borsa finanziata da? Le
sembrerà banale e invece è un punto chiave: quel che i dottorandi si sentono
dire è infatti che, in virtù della mancanza di risorse, «vanno create le
occasioni» per poterli mandare avanti. Mi domandavo: mi mandano avanti perché
sono brava, o sono brava perché mi mandano avanti? Inutile dirle infatti che io
ricerca, negli 8 mesi che resistetti, non ne feci mai. Feci solo, e tanta,
assistenza. Senza mai sentire NESSUNO lamentarsene oltre misura. Torturata -
letteralmente - da una profonda insicurezza circa le mie reali capacità e la mia
volontà di sostenere un compromesso che mi sembrava, di fatto, una truffa
venduta come «l'aver creato l'occasione», mi iscrissi di nascosto ad un secondo
concorso al Politecnico di Milano. Mi alzai alle 4 del mattino per presentarmi
al concorso senza sapere nulla né della commissione né dei partecipanti, e vinsi
la seconda borsa in palio; inutile dire che si fecero scritti e orali a porte
aperte. Ricordo il messaggio che spedii a mia sorella con le lacrime agli occhi:
"Una vittoria mia, ma una vittoria di tutta l'università italiana".
IL RISCATTO - Di lì a poche settimane mi chiamò
per una intervista di lavoro un politecnico olandese per un posto di assistente
alla ricerca, sulla base del mio mero curriculum vitae, e mi fu offerto il
posto. Me ne andai, e non mi sono mai voltata indietro. Mi «licenziai»
dall'Università di... con una lettera congiunta a tutto il dipartimento in cui
spiegavo le mie ragioni ed il mio grande senso di autostima ritrovato. Nessuno
dei dottorandi, mi rispose; dal mio professore e dal preside fui presa,
verbalmente, ma letteralmente, a calci, e fui accusata di aver tradito la loro
fiducia e di aver osato non presentare prima le mie rimostranze di fronte a quel
che io definii «il sistema». Ma questa è un'altra storia, che riguarda me e la
mia coscienza, e di cui sono alla fine, tutto sommato, orgogliosa.
IL CAMBIAMENTO - Sono passati tanti anni e quel
che vorrei dirle in sostanza è questo: il cambiamento vero partirà dalla volontà
e dal senso di dignità dei singoli di non accettare il compromesso cui le
università italiane chiamano la nostra coscienza. Essere un buon ricercatore
significa avere gli standard per lavorare non in quell'ateneo o quel
dipartimento, ma nel mondo. La conoscenza appartiene al mondo; e quindi, a cosa
serve avere il posticino messo in palio da papà, senza poi il rispetto della
comunità scientifica internazionale, che è l'unico vero giudice dell'operato di
un ricercatore? Mi rendo conto che è molto banale quanto le scrivo. Ma è tutto
quel di cui mi sento di far da tramite e testimone, nel mio immensamente
piccolo. Cordialmente, Lucia».
Eppure è risaputo come si svolgono i concorsi in
magistratura.
Negli altri Paesi non è permesso, non so
in Italia...Woodcock mi vuole mandare in prigione, può fare il Pm in un processo
contro l’editore del giornale che ha querelato? Piero
Sansonetti su Il Riformista il 20 Ottobre 2021. Scusate se ogni tanto parlo di
cose nostre. In evidente conflitto di interessi. È solo che proprio in questi
giorni mi sono occupato di un processo, anzi due, che il mio editore, Alfredo
Romeo, sta affrontando a Napoli. Non da solo, insieme ad altre 50 persone.
Diciamo pure una robusta associazione a delinquere. I processi sono due perché
sono stati divisi dalla Procura. Uno è solo per Romeo e per l’architetto Russo,
l’altro per Romeo, l’architetto e altri 50. Il primo è con giudizio immediato,
il secondo con rito tradizionale. Il reato è esattamente lo stesso: tangenti. Le
stesse identiche e ipotetiche tangenti. Gli imputati hanno proposto di
unificare, perché a loro sembrava logico, ma il tribunale ha detto di no. Da
quando ‘sta cosa è iniziata sono stati cambiati già 14 giudici. Gran giostra.
Decine e decine di magistrati impegnati. Del resto – dicono- la partita è
grossa. La parte principale del reato è il regalo di un myrtillocactus (non
sapete cos’è? Ve lo dico io: una pianta, francamente bruttina, tutta
attorcigliata, che vale dai 50 ai 100 euro); e poi c’è uno sconto consistente
sul biglietto di ingresso a un centro benessere. e altre mandrakate simili. La
somma di tutte le tangenti pagate da questa banda di 50 farabutti raggiungerebbe
quasi i 1000 euro (800 per la precisione: circa 17 euro per imputato); i
vantaggi ottenuti pare però che siano inesistenti. Gli imputati si difendono.
Alcuni, compreso Romeo, dicono di non saperne niente. Altri sostengono che non
credevano che regalando a una signora un myrtillocactus si commettessero – tutti
insieme – i reati di truffa, associazione a delinquere, abuso d’ufficio,
traffico di influenze, corruzione, peculato, violenza privata e così via.
Riflettevo su tutto questo leggendo sui giornali che pare che siano state pagate
tangenti significative anche per l’acquisto da parte del governo italiano di
alcuni milioni di mascherine anti covid. Ci sono due tronconi di questa
inchiesta. In uno dei due tronconi è coinvolto l’ex commissario
anticovid Domenico Arcuri, nominato dall’allora premier Giuseppe
Conte. Nell’altro Troncone è coinvolto invece l’ormai celebre Luca Di
Donna, avvocato compagno di ufficio di Giuseppe Conte. Nel primo caso sarebbe
stata pagata una commissione di circa 72 milioni di euro per queste mascherine.
Che però erano mascherine fasulle. Non funzionavano e spargevano il contagio. Il
governo le ha comprate lo stesso, e qualcuno ha messo a posto i conti di
famiglia, credo, con questi 72 milioni (sai quanti mirtilli cactus si possono
comprare con 72 milioni? Circa 900 mila. Il problema è che poi non sai dove
metterli 900 mila mirtilli cactus…). Nel secondo caso sembra che agli
imprenditori che fornivano le mascherine sia stata chiesta una commissione
dell’8 per cento. E più o meno questa tangente avrebbe fruttato sempre una
settantina di milioni. L’imprenditore rifiutò e l’affare saltò. Io sono sicuro
che Romeo è innocente. Tendo a pensare che anche per i due casi Arcuri sia
ingiusto condannare e mettere alla gogna prima che esca fuori qualcosa di
concreto. Per ora c’è solo la certezza che le mascherine acquistate erano
farlocche, e che un imprenditore umbro denuncia che a lui è stata chiesta una
commissione dell’8 per cento. Tutto qui, eh. Non voglio trarre nessuna
conclusione, per carità. Solo che mi veniva in mente questo paragone tra 800
euro e 72 milioni di euro. Siccome i giornali spesso hanno fatto molto chiasso
sugli 800 euro. Prendete Il Fatto: oh, quanti articoli su Romeo! Su Arcuri- Di
Donna-Conte un po’ meno. Vabbé, ognuno poi fa come gli pare. Oltretutto penso
che sia molto difficile indagare su Conte se è vero quello che io vado dicendo
da molto tempo, e cioè che Conte non esiste. C’è comunque l’assoluzione con la
formula: l’imputato non sussiste. P.S. Magari avrò scritto anche perché ho il
dente avvelenato. Il deus ex machina del processo per il myrtillocactus è il
celebre Pm John Henry Woodcock. Il quale, ho saputo l’altro giorno, mi ha
querelato e vuole mandarmi in prigione per diffamazione. Perché? Il solito: l’ho
criticato. E Woodcock ha fatto causa al Riformista. Ai magistrati non piace mai
essere criticati. Piuttosto, una domanda: ma visto che il Riformista appartiene
a Romeo, può Woodcock fare il Pm in un processo nel quale l’imputato è il
proprietario del giornale che lui querela? Negli Stati Uniti, in Francia,
in Germania, in Spagna, in Bulgaria e in diversi paesi asiatici e africani
questo non è permesso. Non so in Italia.
Piero Sansonetti. Giornalista professionista dal
1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di cui è stato vicedirettore e poi
condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004 al 2009, poi di Calabria Ora dal
2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per poi approdare alla direzione de Il
Riformista tornato in edicola il 29 ottobre 2019.
La norma nel codice
disciplinare dei magistrati. No ai rapporti tra toghe e condannati: il divieto
che rinnega la Costituzione.
Massimo Donini su Il
Riformista il 19 Ottobre 2021. L’articolo 3, comma 1, lettera b) del codice
disciplinare dei magistrati (D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109) vieta al
magistrato di «frequentare persona …. che a questi consta… aver subito condanna
per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni… ovvero
l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone».
L’illecito è equiparato espressamente a quello di frequentare un delinquente
abituale o professionale. Ora dobbiamo chiederci quale sia il valore della
verità processuale di una sentenza di condanna, che vale nel mondo del diritto,
ma non in quello dei rapporti tra le persone o per il giudizio “storico” sui
fatti. E qual è comunque il suo valore morale, se conduce a impedire quei
rapporti perfino a chi pronunci “di mestiere” condanne a una pena che deve
tendere alla rieducazione del condannato e non alla sua emarginazione sociale?
Il magistrato non è il rappresentante di una moralità superiore – è quasi
ironico il doverlo ricordare oggi, anche se lo abbiamo sempre pensato – ma deve
solo rispettare disciplinatamente e con onore i pubblici uffici (art. 54 Cost.).
Ebbene, come può la sua condotta non apparire portatrice di un’ipocrisia
legalistica se si deve allontanare dall’umanità delle relazioni e non è neppure
ammesso a provare, se rinviato al Csm per una violazione disciplinare, che aveva
il diritto fondamentale di frequentare un condannato, perché nessuna ragione
antigiuridica di pubblico interesse era sottesa a quelle relazioni? Certo,
esistono doveri di stato che toccano a determinate persone in ragione della
peculiare funzione, per come devono “apparire” e non solo essere, e che non
riguardano altri. Ma qui si tratta di presunzioni assolute di non
frequentabilità e di divieti che neppure ammettono prove contrarie e che sono
assistite da diritti scriminanti. Non si può sanzionare la sola apparenza
antievangelica di frequentare i pubblicani. In uno “storico” incontro svoltosi
qualche anno fa a Scandicci, nel 2016, per la Formazione dei magistrati,
dedicato alla giustizia riparativa, alcuni organizzatori ebbero la malaugurata
idea di invitare a relazionare al pubblico due ex terroristi rossi, condannati
all’ergastolo e poi rimessi in libertà dopo aver scontato interamente la pena, e
avere anche attivato percorsi di mediazione e condotte riparatorie a favore di
vittime vicarie, sostitutive di quelle reali, ma per offese di analogo
significato subìte. Il giorno precedente l’incontro si sollevò una reazione da
parte di giornalisti, politici, opinion makers della giustizia, alti magistrati,
contrariati per questa iniziativa che metteva “in cattedra” autori di gravi o
efferati delitti, per lo più imperdonabili. La “testimonianza” degli ex
terroristi saltò e le lezioni si limitarono a quelle svolte da professori e
magistrati. Ora sono trascorsi alcuni anni, e la Scuola Superiore della
magistratura ospita iniziative anche internazionali in tema di giustizia
riparativa, anche con limitate esperienze testimoniali di autori di reato. Forse
proprio da quella esperienza di esclusione ha preso avvio un percorso
selezionato di ascolto. Per i normali relatori, peraltro, che svolgano anche
un’ora di didattica alla Scuola, è stato introdotto l’obbligo di presentare una
autocertificazione dalla quale risulti che sono incensurati o se abbiano carichi
pendenti. Tutto questo non solo è umiliante, ma profondamente contrario allo
spirito dell’art. 27, co. 3, Cost., perché fa intendere che la condanna penale o
anche l’essere indagato rende “infetta” la persona, inadatta all’insegnamento a
questo pubblico. E come potrà quel magistrato, cioè ogni magistrato, rispettare
la lettera, e non solo lo spirito dell’art. 27, co. 3, Cost., se è egli stesso
diseducato da queste regole o prassi ordinamentali e persino “disciplinari”?
Oggi la recente legge delega n. 134/2021, la c.d. riforma Cartabia, prevede
l’introduzione di una “riforma organica della giustizia riparativa”, dove in
ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena sia
possibile accedere a forme di mediazione volte ad assicurare la ricostituzione
del rapporto fra autore e vittima e a promuovere programmi strutturati a
quell’obiettivo, «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o
alla sua gravità». (art. 1, co. 18, lett. c). Questo importante supporto statale
alla mediazione penale, debitamente finanziato, rimarrà peraltro una vicenda
parallela a quella processuale, dove altre numerosissime forme di “riparazione
dell’offesa” già esistono, ma producono specifici e concreti benefici. Invece,
l’esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa di tipo mediatorio
potrà, eventualmente, essere valutato nel procedimento penale o nell’esecuzione
(art. 1, co. 18, lett. e). Un obiettivo molto spirituale, dunque, direi
evangelico e senza vera contropartita utilitaristica, domina questi istituti,
che si affiancano al diritto penale più duro di contrasto alla criminalità. In
questa antinomia di logiche, che andranno a coesistere nel sistema, una novità
specificamente rieducativa è data dalla previsione standardizzata per i
condannati a pena che si mantenga entro i quattro anni di detenzione in concreto
(anche per delitti gravi in astratto), di limitare detta pena a forme
extracarcerarie, se utili alla rieducazione, e in particolare alle pene
sostitutive di semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità,
pena pecuniaria (art. 1, co. 17). Dunque, riassumendo: programmi umanistici
senza utilitarismo per recuperare il rapporto tra autore e vittima, rieducazione
extracarceraria per pene detentive entro i quattro anni, inclusione e non
esclusione. Ma al contempo, per i gestori di questi programmi, divieto di
frequentare condannati ad almeno tre anni di reclusione, rifiuto o permanente
difficoltà di ascoltare a lezione di formazione testimonianze
di docenti-testimoni spiccatamente “qualificati dal reato”, divieto per i
relatori della loro formazione di presentarsi senza autocertificare un pedigree
specchiato di mancanza di precedenti e carichi pendenti. La domanda è ovvia:
quale “cultura” ci aspettiamo che abbiano questi magistrati quando devono
applicare le norme rieducatrici? Da dove prenderanno i basamenti professionali
della loro visione del mondo, del loro giudizio, e della discrezionalità che
esso richiede? Siamo tutti abituati ad antinomie giuridiche e conflitti di
coscienza anche dentro alle istituzioni. Però viene il momento in cui queste
contraddizioni esplodono e devono produrre prima un malessere, poi una
resistenza, e infine una decisione di libertà e di coerenza. Le più recenti
riforme, per quanto interessate anche alla difesa sociale, stanno introducendo
una cura per la persona umana che è ora richiesta in misura maggiore anche al
magistrato: è questo il primo dovere disciplinare della sua etica del lavoro.
Altrimenti la persona da non frequentare, per un gioco di specchi, potrebbe
diventare proprio lui. Massimo Donini
Art. 29. Modifiche agli
articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
1. Gli articoli 18 e 19
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12
del 1941, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
(Il presente articolo prima
modificato dall’ art. 7, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51, è stato, poi, così sostituto
dall’art. 29 D.Lgs. 23.02.2006, n. 109, con decorrenza dal 19.06.2006. Si
riporta di seguito il testo previgente: “(Incompatibilità di sede per parentela
o affinità con professionisti) - I magistrati giudicanti e requirenti delle
corti di appello e dei tribunali ordinari, non possono appartenere ad uffici
giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli
affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di
procuratore, né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od
affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o
di procuratore.”.)
"Art. 18
(Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti
la professione forense). - I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di
appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi
nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il
coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.
La ricorrenza
in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti
criteri:
a) rilevanza della professione
forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di
appartenenza del magistrato,
tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore
della professione forense e di eventuali forme di esercizio non
individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
b) dimensione del predetto
ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
c) materia trattata sia dal
magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del
diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza,
ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto
civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il
magistrato, dalla organizzazione tabellare;
d) funzione specialistica
dell'ufficio giudiziario.
Ricorre sempre una situazione
di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica
sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati
con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione
distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna
attività o viceversa.
I magistrati preposti
alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di
incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense
presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i
Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore
di attività civile e penale.
Il rapporto di parentela o
affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione
forense, e' valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei
criteri di cui al secondo comma.
Art. 19 (Incompatibilità di
sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria della stessa sede).
(Il presente articolo è stato
così sostituto dall’art. 29 D.Lgs. 23.02.2006, n. 109, con decorrenza dal
19.06.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: “(Incompatibilità per
vincoli di parentela o di affinità fra magistrati della stessa sede) - I
magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo
grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello
stesso ufficio giudiziario. Questa disposizione non si applica quando, a
giudizio del Ministro di grazia e giustizia, per il numero dei componenti il
collegio o l’ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al
regolare andamento del servizio. Tuttavia non possono far parte come giudici
dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali ordinari i parenti
e gli affini sino al quarto grado incluso.”.)
I magistrati che hanno tra
loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di
convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o
dello stesso ufficio giudiziario.
La ricorrenza in concreto
dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui
all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.
I magistrati che hanno tra
loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di
convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa
Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte
organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica,
salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e
l'altro in sede centrale.
I magistrati che hanno tra
loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di
coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio
giudicante nelle corti e nei tribunali.
I magistrati
preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa
sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per
caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per
ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di
incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18,
secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente
dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado,
o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio,
tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici
addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di
appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato
addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica
del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.
I magistrati
non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti
fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto
dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18,
secondo comma, per quanto compatibili.".
Quasi 200 giudici hanno
interessi nelle strutture a cui affidano i minori.
Luca Rinaldi il 3 Agosto 2015
su L'inchiesta. Sono poco più di un migliaio e si trovano all’interno dei 29
tribunali minorili di tutta Italia così come nelle Corti d’Appello minorili.
Sono i giudici onorari minorili, e di fatto hanno il pallino in mano quando si
tratta di affidamenti in casa-famiglia oppure a centri per la protezione dei
minori. Una figura prevista dall’ordinamento ma che continua a risultare anomala
nonostante il peso determinante nelle decisioni nell’ambito dei procedimenti che
riguardano i minori e gli affidamenti: nel settore infatti il giudizio di un
giudice onorario minorile è pari a quello di un magistrato di carriera. Quando
si decide nelle corti infatti giudicano due togati e due onorari, mentre in
Corte d’Appello sono tre i togati e due gli onorari. A definire il ruolo del
giudice onorario minorile ci pensa una del 1934 e una riforma del 1956, ripresa
nelle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura: l’aspirante giudice
oltre che ad avere la cittadinanza italiana e una condotta incensurabile, «deve,
inoltre, essere “cittadino benemerito dell’assistenza sociale” e “cultore di
biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia”». Il tema
non fa rumore, ma tra queste circa mille persone che ricoprono incarichi lungo
tutto lo stivale, c’è qualcosa che non funziona come dovrebbe. Il centro di
alcune distorsioni del sistema rimane proprio all’interno delle circolari del
Csm che ogni tre anni mette a bando posti per giudici onorari: all’articolo 7
della circolare si definiscono le incompatibilità, e si scrive espressamente che
“Non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti
dallo svolgimento di attività private, libere o impiegatizie, sempre che non si
ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse
possano incidere sull’indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori
di imparzialità”. Al comma 6 dello stesso articolo addirittura si prevede una
causa certa di incompatibilità: all’atto dell’incarico il giudice onorario
minorile deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell’incarico,
cariche rappresentative di strutture comunitarie, e in caso già rivesta tali
cariche deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni. Insomma, a meno che non
ci siano pareri motivati che possano incidere su indipendenza e imparzialità del
giudizio, solo un atto motivato, che spesso non arriva, può mettere ostacoli
sulla nomina del giudice onorario. Sulle maglie larghe dell’articolo 7 è
depositata anche una interrogazione parlamentare dallo scorso 17 febbraio del
senatore Luigi Manconi al Ministero della giustizia, che al momento rimane senza
risposta, mentre ai primi di maggio l’onorevole Francesca Businarolo del
Movimento 5 Stelle, ha depositato una proposta di legge per l’istituzione di una
apposita commissione d’inchiesta. Tuttavia tra questi 1.082 (tanti risultano
all’ultimo censimento) circa 200 sarebbero incompatibili con la carica, dunque
il 20% sul totale. Questi sono i dati contenuti in un dossier che l’associazione
Finalmente Liberi Onlus presenterà nei prossimi mesi al Consiglio Superiore
della Magistratura per mettere mano al problema. In particolare segnalano
dall’associazione, che i duecento nomi che fanno parte della lista e ogni giorno
decidono su affidamenti a casa famiglia e centri per la protezione dei minori,
dipendono dalle strutture stesse. Tra questi 1.082 (tanti risultano all’ultimo
censimento) circa 200 sarebbero incompatibili con la carica, dunque il 20% sul
totale. A vario titolo c’è chi ha contribuito a fondarle, chi ne è azionista e
chi fa parte dei Consigli di Amministrazione. Dunque il tema è centrato: a
giudicare dove debbano andare i minori e soprattutto se debbano raggiungere
strutture al di fuori della famiglia sono gli stessi che hanno interessi nelle
strutture stesse. L’incompatibilità, che dovrebbe essere già valutata come
condizione precedente al conflitto di interessi, in questo caso sembra evidente,
ma difficilmente vengono effettuati gli approfondimenti “caso per caso”
richiesti dalle circolari del Csm. «Stiamo cercando un appoggio
istituzionale forte – spiega a Linkiesta l’avvocato Cristina Franceschini
di Finalmente Liberi Onlus – per poter sottoporre al Consiglio Superiore della
Magistratura la lista dei giudici onorari minorili incompatibili. Presentarlo
come semplice associazione rischia di far finire il tutto dentro un cassetto,
avendo invece una sponda dalle istituzioni o dalla politica potrebbe far finire
il tema in agenda al Csm meglio e più velocemente». Nel dossier, al momento
ancora in via di definizione ma prossimo alla chiusura, «troviamo anche giudici
che lavorano ai servizi sociali in comune e che hanno interessi in casa
famiglia», fanno sapere da Finalmente Liberi Onlsu, «ma anche chi intesta
automobili di lusso alle stesse strutture». Così tra una Jaguar e una sentenza
capita anche che un centro d’affido ricevesse rette da 400 euro al giorno, per
un totale di 150 mila euro l’anno in tre anni per un solo minore.
Un business non indifferente se si conta che i minori portati via alle famiglie,
stimati dalle ultime indagini del Ministero per il Lavoro e per le Politiche
Sociali, sono circa 30mila. Sicuramente non è un ambito in cui ragionare in
termini meramente economici e non tutte le case famiglia ragionano in termini di
profitto, tuttavia, anche alla luce della recente sentenza su quanto accaduto in
oltre trent’anni al Forteto di Firenze, una riflessione in più va fatta. In
particolare sulla trasparenza con cui si gestiscono gli istituti e su chi e come
decide di dirottare i minori all’interno delle strutture. Un altro caso è quello
dell’ex giudice onorario minorile Fabio Tofi, psicologo e direttore della casa
famiglia “Il monello Mare” di Santa Marinella, a Roma. Violenze, abusi sessuali,
aggressioni fisiche e verbali, percosse, minacce, somministrazioni di cibo
scaduto, di sedativi e tranquillanti senza alcuna prescrizione medica: queste
sono le accuse che la procura di Roma ha mosso allo stesso Tofi e altri quattro
collaboratori che sono poi sfociate nell’arresto dello scorso 13 maggio. Tofi
dal 1997 al 2009 (periodo in cui la struttura era già funzionante) è stato
giudice onorario presso il Tribunale dei minori di Roma e psicologo presso i
Servizi Sociale del Comune di Marinella dal 1993 al 1996. Non sono però solo le
nomine e la compatibilità degli incarichi a destare più di un interrogativo nel
mondo degli affidamenti, ma sono anche le procedure che a detta di più di un
esperto andrebbero riviste. «Sarebbe sufficiente constatare come le perizie
psicologiche fatte ai genitori prima di togliere il minore e durante
l’allontanamento non vengano replicate anche agli operatori delle strutture.
I controlli – dice ancora Franceschini – nei confronti di questi dovrebbero
essere stringenti e con cadenza regolare, e invece non lo sono». Franceschini
(Finalmente Liberi Onlus): «All’interno degli stessi tribunali minorili andrebbe
istituito un organismo di coordinamento tra il giudice e i servizi sociali, e da
parte degli avvocati che seguono le famiglie a cui sono stati sottratti i minori
sarebbe consigliabile meno scrivania e più accompagnamento dei genitori nel
percorso tra servizi sociali, tribunali e casa famiglia». Così come l’ascolto
del minore nel corso dei procedimenti spesso avviene in modo poco chiaro: i
minori dopo i 12 anni devono essere ascoltati dal giudice, nella maggioranza dei
casi però questo ascolto avviene in una stanza in cui oltre al minore e al
giudice è presente anche un emissario della comunità. «Evidentemente in queste
condizioni non è possibile lasciare libertà d’espressione al minore, e molte
volte gli avvocati sono invitati a rimanere fuori dall’aula. Non di rado infatti
arrivano sul nostro tavolo verbali confezionati». Per questo motivo in tanti
denunciano al raggiungimento del diciottesimo anno di età una volta fuori dalle
strutture, come accaduto nella vicenda del Forteto. Tuttavia, spiega
Franceschini, all’interno degli stessi tribunali minorili andrebbe istituito
un organismo di coordinamento tra il giudice e i servizi sociali, e da parte
degli avvocati che seguono le famiglie a cui sono stati sottratti i minori
sarebbe consigliabile meno scrivania e più accompagnamento dei genitori nel
percorso tra servizi sociali, tribunali e casa famiglia. Dopo l’estate
il dossier sui giudici onorari minorili arriverà comunque sul tavolo di più di
un politico e del Garante per l’Infanzia, il cui mandato è al momento
in scadenza. L’occasione per aprire uno squarcio su un tema taciuto e
sconosciuto ai più inizia a vedersi, per non sentire più in un tribunale, «io
sono il giudice, io dirigo la comunità, e decido io a chi va il minore».
Csm, arriva la stretta sui
procuratori: regole rigide sugli incarichi e le indagini.
Liana Milella su La Repubblica
il 10 dicembre 2020. Oggi il Consiglio vara il decalogo di comportamento per i
vertici delle procure. Ogni incarico dovrà essere documentato e soprattutto
motivato. Decalogo (obbligatorio) del Csm per i procuratori della Repubblica.
Sono i potenti titolari dell'azione penale a cui adesso l'organo di governo
autonomo della magistratura toglie decisamente un po' di discrezionalità
dettando rigide regole di comportamento su ogni aspetto dell'organizzazione
dell'ufficio e la conduzione delle indagini. Ci ha lavorato tutta la settima
commissione del Consiglio (Pepe, Donati, Basile, D'Amato, Suriano, Ciambellini)
e tra gli estensori figurano anche Micciché e Dal Moro. Tutte le correnti
insomma. E dovrebbe finire anche con un voto all'unanimità, anche se Nino Di
Matteo propone delle modifiche che si riserva di illustrare e motivare durante
la discussione. Ma in cosa consiste la riforma? Detto in due parole, per
capirci, potremmo chiamarla il vademecum di cosa può fare, e cosa non può fare,
un procuratore della Repubblica nel suo ufficio. Più brutalmente: il Csm
stabilisce come deve comportarsi il capo di una procura, automaticamente
delimitando i suoi compiti, e quindi anche i suoi poteri. Sicuramente aggrava la
sua rendicontazione burocratica. Ma lo obbliga anche, con i suoi vice, a fare
indagini e non solo a guidare i colleghi. Perché, "seppure compatibilmente con
le dimensioni dell'ufficio e dei compiti di direzione e coordinamento nonché dei
carichi di lavoro", anche i capi e i vice capi non potranno essere sganciati dal
lavoro ordinario. Per loro ci sarà "un'obbligatoria riserva di lavoro
giudiziario". Una mossa, quella del Csm, che anticipa sui tempi il
Guardasigilli Alfonso Bonafede che, sullo stesso tema, ha scritto un capitolo
nella sua legge sulla riforma del processo penale che marcia con tempi biblici
alla Camera, i cui scopi però sono già sunteggiati, e quindi ritenuti
strategici, nel piano dell'Italia per guadagnare e spendere i 196 miliardi di
euro del recovery fund. Ma partiamo da un parterre di giudizi. Ecco quello
di Giuseppe Marra, il consigliere "davighiano" di Autonomia e indipendenza. "È
un testo molto importante perché, in estrema sintesi, detta regole più
stringenti per l'attività dirigenziale dei procuratori, che non potranno più
fare, senza motivazione adeguate, il bello e il cattivo tempo nei loro uffici,
anche se la legge gli riconosce la titolarità dell'azione penale". Un parere che
non è affatto diverso la quello di Antonio D'Amato, componente della settimana
commissione, toga di Magistratura indipendente, componente della commissione,
alle prese con piccoli aggiusti del testo: "Abbiamo voluto ancorare le scelte
del procuratore a criteri di trasparenza e conseguente motivazione, allorquando
individua i suoi collaboratori fra i sostituti per affidargli degli incarichi.
In questo modo si è voluto scongiurare il rischio delle cosiddette medagliette
costruite su sostituti “vicini” allo stesso procuratore per favorirli nel
percorso professionale, trattandosi di medagliette utili in sede di successiva
valutazione per possibili incarichi direttivi o semidirettivi". Due giudizi che
confermano quanto il decalogo sarà impegnativo e destinato a cambiare la vita
degli uffici. Ma leggiamo cosa c'è scritto nella relazione che accompagna il
testo, definito come una "rivisitazione e parziale riformulazione" di quello del
novembre 2017 che, a sua volta, integrava i precedenti del 2007 e del 2009,
tutti figli della riforma dell'ordinamento giudiziario del governo Berlusconi,
allora Guardasigilli il leghista Roberto Castelli, poi diventato legge con il
successore, l'ex Dc Clemente Mastella. Il Csm ci rimette mano perché "sono in
gioco attribuzioni che concorrono ad assicurare il rispetto delle garanzie
costituzionali". Cosa cambia e cosa dovranno fare da domani i procuratori in
base al vademecum che si risolve in oltre 60 pagine di nuove regole? La mossa
del Csm impone ai capi degli uffici una totale e maggiore trasparenza in tutte
le scelte, da quella dei procuratori aggiunti, a quella di indicare uno
piuttosto che un altro pubblico ministero per seguire un'indagine, nonché anche
per costituire i singoli gruppi di lavoro. Il capo dovrà ricorrere al cosiddetto
"interpello", cioè sentire democraticamente tutti prima di costituire un gruppo.
E qualora dovesse fare una scelta anomala, una deroga rispetto alle regole in
vigore, dovrà motivarlo per iscritto e dettagliatamente al Csm. Dovrà spiegare,
insomma, perché ha privilegiato un collega piuttosto che un altro. Una regola
che, evidentemente, limita l'autonomia del procuratore in ogni sua mossa. Come
non bastasse questo procuratore, nonché i suoi vice, dovranno anche lavorare
alle indagini, cioè non basterà fare "il capo", bisognerò anche fare
concretamente delle indagini. Tutto questo perché, come scrive la settima
commissione, "l'organizzazione degli uffici di Procura deve essere finalizzata a
garantire l'esercizio imparziale dell'azione penale, la speditezza del
procedimento e del processo, l'effettività? dell'azione penale, l'esplicazione
piena dei diritti di difesa dell'indagato e la pari dignità? dei magistrati che
cooperano all'esercizio della giurisdizione: beni giuridici costituzionalmente
rilevanti la cui effettiva tutela si realizza immancabilmente attraverso un uso
imparziale e consapevole della leva organizzativa che deve essere utilizzata
secondo criteri trasparenti e verificabili". Per essere espliciti, il Csm vuole
vederci chiaro sul perché un procuratore si batte per un procuratore aggiunto -
che comunque viene scelto dal Csm - o affida una certa indagine, perché se è
vero che "la responsabilità? delle scelte organizzative compete al procuratore",
è altrettanto vero che "la verifica della rispondenza delle opzioni in concreto
adottate alle ragioni di quella attribuzione e? compito irrinunciabile del
governo autonomo". Per tutte queste ragioni il Csm chiede ai procuratori di
presentare "documenti chiari, trasparenti, articolati" rispetto alle assemblee
interne e soprattutto che le assemblee stesse si svolgano veramente, visto che
da alcuni verbali mandati a Roma sembra trapelare invece che prese d'atto e
accettazioni sarebbero giunte solo a cose fatte. La regola aurea per scegliere i
magistrati sarò l'interpello, una sorta di consultazione interna su "chi vuole
fare cosa". Ugualmente il capo dell'ufficio non sarà più il sovrano unico delle
assegnazioni dei singoli pm alle Direzioni antimafia, i gruppi che lavorano
sulla criminalità organizzata. Anche in questo caso, scrive il Csm, il
procuratore che "rinnova o non rinnova" un incarico dovrà "motivarlo
espressamente" e "comunicarlo a tutti i magistrati dell'ufficio" che, se
bocciati ed esclusi, potranno presentare le loro contro deduzioni. Ovviamente di
tutto questo dovrà essere informato il Consiglio giudiziario, la longa manus del
Csm in sede locale, che potrà esprimere il proprio parere. Infine il
procuratore, nell'organizzare l'ufficio, dovrà guardare anche oltre le sue
stanze, verso quelle dei tribunali dove i suoi processi poi andranno in
udienza.
Csm, la pm fa le valigie:
"Non può lavorare insieme al marito, è incompatibile".
Maria Elena Vincenzi su La
Repubblica il 28 agosto 2021. Dopo un anno e mezzo, il Consiglio superiore di
magistratura ribalta il suo iniziale verdetto e dichiara l'incompatibilità tra
due procuratori aggiunti sposati. Nunzia D'Elia trasloca presso la Corte
d'Appello. Poco più di un anno fa, per il Csm, il fatto che marito e moglie
lavorassero nello stesso ufficio non rappresentava un profilo di
incompatibilità. Ma quello che per l'organo di autogoverno della magistratura
valeva nel 2020 oggi non vale più. Così, accade a Roma, nel più grande tribunale
d'Europa, che uno dei due coniugi oggi sia costretto a fare le valigie. E in
quelle valigie chiudere i successi di questi anni. Dalla sparatoria in cui
rimase paralizzato Manuel Bortuzzo all'omicidio Cerciello, passando per quello
di Luca Sacchi. Dalle inchieste su Ama, Flambus e sugli alberi che con il
maltempo cadono nelle strade di Roma perché non viene fatta la manutenzione alla
strana morte di Maddalena Urbani prima e, da ultimo, di Libero De Rienzo.
Riavvolgiamo il nastro. A Roma, tra i nove procuratori aggiunti (al momento ce
ne sono 8, uno è da nominare) c'è una coppia. Nunzia D'Elia e Stefano Pesci sono
sposati da anni. Lo erano anche quando facevano entrambi i sostituti in quella
stessa procura e quando lei, qualche anno fa, è rientrata dal Latina per fare
l'aggiunto. Stando alle circolari vigenti sul regime delle incompatibilità, la
nomina del marito in quello stesso ruolo poteva sollevare qualche dubbio, ma
palazzo dei Marescialli ha deciso comunque di conferire al dottor Pesci lo
stesso incarico semi-direttivo. Era il 13 febbraio del 2020. Al Csm erano a
conoscenza della situazione che, per altro, era stata sollevata, ma hanno deciso
di procedere chiarendo che un'eventuale incompatibilità andava valutata in
concreto. Così, il 2 marzo, Stefano Pesci ha preso possesso. Un anno dopo, il
Consiglio, una volta ricevuta dichiarazione di eventuale incompatibilità inviata
dai diretti interessati (seppur già esistente e già valutata in sede di nomina),
ha deciso di riprendere in mano la questione. I due magistrati sono stati
sentiti personalmente. Il capo della procura Michele Prestipino, invece, non è
stato convocato. "Preciso - ha scritto in una nota il numero uno dei pm romani -
che il procuratore aggiunto dottoressa D'Elia coordina i gruppi "Reati causati
da responsabilità professionale", "Reati in materia di
infortuni-alimenti-incolumità pubblica", e "Reati in materia di ecologia e
tutela dell'ambiente" dal 20/7/2016 e il procuratore aggiunto dottor Stefano
Pesci coordina la struttura Sdas1 dal 6/3/2020 e il gruppo "Reati tributari" dal
26/5/2020 e durante tale periodo non si sono manifestate situazioni di possibile
incompatibilità. Anche in precedenza la dottoressa D'Elia e il dottor Pesci
hanno prestato servizio entrambi presso questo Ufficio, l'una quale procuratore
aggiunto e l'altro quale sostituto, non facendo registrare alcuna situazione di
incompatibilità potenziale né tantomeno concreta". D'accordo col procuratore
anche il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, il "Csm
locale" che ha escluso ripercussioni sulla vita dell'ufficio. Ma da piazza
Indipendenza non hanno sentito ragioni. Sarà per il riassetto degli equilibri
tra le correnti, sarà per un certo rigorismo dopo la bufera del caso Palamara,
ma dopo appena un anno dalla decisione di segno opposto, la Prima Commissione ha
ribaltato il tavolo e deciso che Pesci e D'Elia siano incompatibili. E che uno
dei due deve lasciare l'incarico. Per questo, dopo sei anni di inchieste
importanti, Nunzia D'Eliha lasciato in questi giorni la procura di Roma per
andare in procura generale presso la Corte d'Appello. Qualcuno ha detto che si
tratta di una scelta d'amore. Di scelta sicuramente non si può parlare.
La circolare del Csm nasce
dalle modifiche volute dall'ex ministro Roberto Castelli. Altre ai vincoli di
parentela, matrimonio e affini riconosce le convivenze. Coppie di fatto
"incompatibili" tra le toghe. Il divieto anche tra investigatori e pm. Entro il
31 dicembre i magistrati dovranno autodenunciarsi al Consiglio superiore. La
verde Balducci: "E' un provvedimento contrario alla privacy".
Claudia Fusani su La
Repubblica il 25 maggio 2007. Invece di arrivare diritti, arrivano doveri. E
limitazioni. Succede alle coppie di fatto, se hanno la toga, di magistrato o di
avvocato, a cui il Consiglio superiore della magistratura ha fatto pervenire
l'ultima novità: la convivenza fa scattare la incompatibilità. O meglio, "la
stabile coabitazione determinata da rapporti sentimentali", fa s� che un
magistrato e un avvocato, o due magistrati, o uno dei due se divide lo stesso
tetto con ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non possono lavorare nello
stesso ufficio. Anche Palazzo dei Marescialli, quindi, deve confrontarsi con la
realtà delle convivenze. Che sono talmente "riconosciute" da diventare per legge
causa di incompatibilità. Mercoledì la Prima Commissione dell'organo di
autogoverno della magistratura ha deliberato sul più generale capitolo delle
incompatibilità. Un passaggio necessario per adeguare il regolamento alla nuova
legge su illeciti disciplinari e trasferimenti voluta dall'ex ministro della
Giustizia Roberto Castelli. La circolare contiene alcune importanti novità. La
prima è che se finora, per legge, l'incompatibilità professionale scattava solo
per parenti, coniugi e affini (a parte alcune circolari che prevedevano anche
qualche caso di convivenza), adesso, per legge, l'impossibilità di lavorare
nello stesso ufficio scatta anche per i conviventi. Si legge al punto 5 della
circolare: "La convivenza è rilevante laddove si sostanzi in un rapporto di
stabile coabitazione". In una prima versione era anche scritto "assimilabile a
quello matrimoniale". Nelle versione definitiva è passata una definizione più
soft: la coabitazione deve cioè "essere determinata da rapporti sentimentali".
Critica il deputato dei verdi Paola Balducci, avvocato penalista e membro della
Commissione Giustizia: "Da una parte - osserva ironica - mi compiaccio nel
constatare che la convivenza è un dato di fatto cos� rilevante da provocare
una incompatibilità per legge. Dall'altra - continua - lo Stato, e neppure il
Csm - si deve preoccupare di definire il tipo di convivenza tra due persone. E'
inopportuno e va contro i principi della privacy. Cosa succede adesso? Entro il
31 dicembre 2007 magistrati e avvocati che vivono sotto lo stesso tetto senza
essere sposati devono specificare la tipologia della loro coabitazione?".
Infine, aggiunge Balducci, "per quello che riguarda la terzietà di giudizio, a
me avvocato non interessa sapere il tipo di rapporto tra i due conviventi. Basta
il fatto che convivano, anche solo per dividere le spese, per farmi dubitare
sulla imparzialità di giudizio". La seconda novità della circolare riguarda
poliziotti e agenti di polizia giudiziaria. Al punto 42, infatti, viene
introdotto un terzo tipo di incompatibilità. Non solo quando il rapporto di
parentela, affinità, coniugio e convivenza è tra magistrati, o tra magistrati e
avvocati, ma anche quando riguarda "magistrati addetti agli uffici di procura e
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria". In sintesi tra inquirente e
investigatore. Entro il 31 dicembre di quest'anno ci deve essere l'autodenuncia,
su apposito modulo informatico. Il regime delle incompatibilità per i magistrati
è regolato da due articoli (18 e 19) dell'Ordinamento giudiziario che è stato
modificato dall'ex Guardasigilli. Il codice di procedura penale, invece, regola
i casi di astensione e ricusazione del giudice. L'incompatibilità è totale
quando la sede giudiziaria è piccola. In quelle più grandi scatta ogni volta che
le funzioni - giudice, pm, avvocato o investigatore - rischiano di incrociarsi.
Convocati a Roma i
presidenti del tribunale e dell’Ordine degli avvocati. Famiglie in toga: Indaga
Csm Stretta sulle incompatibilità. Segnalati 23 casi di parentele nello stesso
distretto tra giudici, pm e legali.
Tratto da “la Repubblica”
3.04.2008 di a.z.. L’INCOMPATIBILITA viene risolta a colpi di astensione. Ma
quando cominciano ad essere troppi i giudici che chiedono di spogliarsi di
processi in cui sono coinvolti, come altra parte, mariti, mogli o figli, allora
l’impasse comincia a diventare difficile da superare. Sarà anche per questo che
il Consiglio superiore della magistratura ha rimesso all’ordine del giorno
l’annosa questione della “parentopoli” al Palazzo di giustizia di Palermo che, a
quanto sembra, in Italia è uno di quelli che conta il più alto numero di coppie
incompatibili tra giudici, magistrati e avvocati. Sono ben 23 i magistrati in
servizio a Palermo sui quali la prima commissione dell’organo di autogoverno
della magistratura ha deciso di svolgere accertamenti, mettendo in calendario le
prime audizioni: quelle del presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo
Enrico Sanseverino, convocato per il 14 aprile. E del presidente del tribunale
Giovanni Puglisi, peraltro toccato personalmente dalla questione visto che le
sue figlie, una avvocato e una al tribunale dei minorenni, lavorano nello stesso
distretto così come una nipote, anche lei giudice a Palermo. Il caso della
famiglia Puglisi era già stato esaminato dal Csm e archiviato in base alle
vecchie norme dell’ordinamento giudiziario ma adesso gli articoli 18 e 19
stabiliscono regole più severe sull’incompatibilità di funzioni nello stesso
distretto giudiziario. Il presidente del tribunale, per la verità, ha sempre
minimizzato la questione ritenendo i casi superabili ma adesso il Consiglio
superiore della magistratura intende valutare se sia il caso di chiedere il
cambio di mansioni per qualcuno dei magistrati coinvolti. “Situazioni critiche
sotto il profilo dell’incompatibilità parentale”, le definisce il Csm. A Palermo
i casi a rischio di cambio di funzioni sono quelli di tre coppie di coniugi in
cui uno lavora nella magistratura inquirente, l’altro nella giudicante: è così
per il pm della Dda Lia Sava, moglie del giudice Antonio Tricoli, è così per il
sostituto procuratore Sergio De Montis sposato con il giudice delle indagini
preliminari Rachele Monfredi, ed è così per il pm Domenico Gozzo, anche lui
sposato con un gip, Antonella Consiglio. Tra i nomi finiti sotto la lente di
ingrandimento del Csm anche quelli del presidente di sezione del tribunale
Antonio Prestipino, sposato con il sostituto procuratore generale Rosalia Cammà,
e delle sorelle Antonina e Vincenza Sabatino, la prima presidente di sezione ad
Agrigento, la seconda sostituto in Procura generale. Nell’elenco all’attenzione
del Csm anche i nomi di altri magistrati sposati o in grado di stretta parentela
con avvocati del foro di Palermo: il pm Emanuele Ravaglioli, il presidente
Salvatore Virga, i giudici Maisano, Scaduti, Soffientini, Laudani e
Piraino. a.z.
L’assurdo caso caso del Gup “contestato”
per “colpa” del padre avvocato che difese il Cav. Il
magistrato sarà chiamato a valutare in sede di udienza preliminare la posizione
dei fratelli del senatore di Forza Italia Luigi Cesaro, che potrebbero finire
a processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Valentina Stella su Il
Dubbio il 14 maggio 2021. La Camera penale di Napoli è intervenuta sulla
polemica che ha coinvolto in questi giorni la giudice Ambra Cerabona. Il
magistrato sarà chiamata a valutare in sede di udienza preliminare la posizione
dei fratelli del senatore di Forza Italia Luigi Cesaro, che potrebbero finire
a processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Repubblica fa
notare che la Cerabona è la «figlia di uno storico legale di Berlusconi a
Napoli: Michele Cerabona, difensore dell’ex premier in tanti procedimenti e oggi
membro laico al Consiglio Superiore della magistratura, nominato ovviamente in
quota Forza Italia. Un profilo di inopportunità su cui, si apprende solo ieri
addirittura dall’udienza, era arrivato anche un esposto negli uffici giudiziari
[…] Come se la giustizia italiana non incrociasse, in questa triste stagione,
sufficienti profili di disagio e di auspicabile autocritica, ecco un nuovo
potenziale caso di imbarazzo». Il ragionamento sarebbe grossomodo questo:
siccome il padre del giudice ha difeso Silvio Berlusconi e poiché è stato eletto
al C.S.M. su proposta di Forza Italia, la figlia non sarebbe compatibile a
giudicare il processo citato poiché in esso sono imputati i fratelli di un
senatore di FI. La giudice avrebbe chiesto di potersi astenere ma la richiesta è
stata respinta. «A noi un sospetto così articolato – scrive la giunta dei
penalisti napoletani, presieduta dall’avvocato Marco Campora – appare
incomprensibile stante l’assoluta lontananza ed evanescenza del collegamento,
laddove mai è stato neppure ipotizzato che la Dott.ssa Cerabona abbia una sia
pur minima conoscenza e/o rapporto con i fratelli Cesaro. Ed allora, i dubbi
insinuanti avanzati nell’occasione sembrano risolversi nel tentativo di
condizionare l’attività del giudicante, di comprimere la sua autonomia ed
indipendenza di giudizio; di indurlo a dovere fornire la prova positiva (ed
intrinsecamente diabolica) di non essere sospetto. Prova che può essere fornita
in un solo modo: condannando o rinviando a giudizio gli imputati. Non si può
continuare a ragionare così, minando dalle fondamenta i capisaldi che regolano
l’esercizio della funzione giurisdizionale. Tutti i giudici sono, sino a prova
contraria, autonomi ed indipendenti. Questa è la regola su cui si fonda il
nostro ordinamento, eliminata la quale l’intero sistema è inesorabilmente
destinato a crollare». E poi la critica all’esposto anonimo: «Sinora, le parti
di quel processo – le uniche a ciò legittimate – non hanno inteso avanzare
alcuna istanza di ricusazione, evidentemente ritenendo la Dott.ssa Cerabona del
tutto idonea a svolgere la funzione di giudicante nel processo. L’irruzione
nelle aule di giustizia di esposti anonimi è invece operazione degradante, vile
e molto pericolosa, atteso che l’esposto anonimo è per sua natura un mezzo
utilizzato unicamente per depistare, sviare, colpire chi si ritiene nemico. Su
questo occorre essere chiari: l’esposto anonimo non ha alcun diritto di
cittadinanza in un ordinamento democratico (dunque a tutti i livelli: politico,
giudiziario, poliziesco …) e va sempre trattato per quello che è: una gravissima
calunnia anonima che ha sempre la finalità di colpire qualcuno, di mestare nel
torbido, di avvelenare la democrazia e le istituzioni». E il finale contro il
complottismo: «L’unica colpa – l’unico elemento di sospetto avanzato – della
dott.ssa Cerabona è quella di essere figlia di un noto e stimatissimo avvocato.
Ora, si può anche stabilire per legge che un giudice, nel luogo in cui esercita
la funzione, non debba avere rapporti familiari, affettivi, sentimentali e
amicali con soggetti che operano nel medesimo settore (fuor di metafora: con
altri giudici, pubblici ministeri, avvocati e cronisti giudiziari). È operazione
difficilmente praticabile, ed infatti così – per fortuna – non è. In tutti i
Tribunali italiani vi sono giudici sposati tra di loro, con pubblici ministeri e
con avvocati. Giudici figli di giudici, di pubblici ministeri o di avvocati.
Giudici fratelli di giudici, pubblici ministeri ed avvocati. Giudici amanti di
giudici, pubblici ministeri ed avvocati. È fisiologico, normale e non foriero
di alcun sospetto. Ed allora, smettiamola con questo complottismo a senso unico
che dimostra la scarsa cultura democratica di alcuni settori del nostro Paese».
Alone di ingiustificato sospetto.
Processo ai fratelli Cesaro, “Basta complottismo”. I penalisti si schierano con
Cerabona. Viviana Lanza su Il Riformista il 13 Maggio
2021. «Smettiamola con questo complottismo a senso unico che dimostra la scarsa
cultura democratica di alcuni settori del nostro Paese», tuona l’avvocato Marco
Campora, presidente della Camera penale di Napoli firmando un documento con cui
i penalisti prendono posizione di fronte al caso sollevato dall’edizione
partenopea del quotidiano Repubblica: a giudicare il processo in cui sono
coinvolti, tra gli altri, i fratelli Cesaro (Luigi Cesaro è senatore di Forza
Italia) sarà il giudice Ambra Cerabona (figlia dell’avvocato Michele, attuale
componente del Consiglio superiore della magistratura e in passato difensore del
leader di Forza Italia Silvio Berlusconi). «Non si tratta di esprimere
solidarietà al giudice Cerabona, che non ne ha bisogno, essendosi attenuta al
completo rispetto delle norme codicististiche e avendo dimostrato anche grande
saggezza e prudenza – spiega Campora facendo riferimento alla notizia che la
giudice avrebbe presentato una richiesta di astensione non accolta dalla
presidente del Tribunale – Il tema che riteniamo rilevante è un altro e attiene
proprio all’alone di ingiustificato sospetto che si è creato nei confronti del
gup Cerabona per l’unica ragione di essere figlia di Michele Cerabona che in
passato ha difeso anche l’ex presidente del Consiglio e di Forza Italia Silvio
Berlusconi». Un esposto anonimo avrebbe innescato il sospetto che, in quanto
figlia dell’ex difensore di Berlusconi, il giudice Cerabona non sarebbe
compatibile a giudicare il processo Cesaro. «A noi – aggiunge il presidente dei
penalisti napoletani – un sospetto così articolato appare incomprensibile». «I
dubbi insinuati – osserva Campora – sembrano risolversi nel tentativo di
condizionare l’attività del giudicante, di comprimere la sua autonomia e
indipendenza di giudizio, di indurlo a dovere fornire la prova positiva (e
intrinsecamente diabolica) di non essere sospetto. Prova che può essere fornita
in un solo modo: condannando o rinviando a giudizio gli imputati». «Non si può
continuare a ragionare così, minando dalle fondamenta i capisaldi che regolano
l’esercizio della funzione giurisdizionale», aggiunge Campora. E poi c’è
un’altra considerazione dei penalisti napoletani: «Appare opportuno evidenziare
che i veri o presunti rapporti personali divengono, per taluni, forieri di
sospetto in ambito giudiziario solo quando è coinvolto un avvocato. In tutti
i Tribunali italiani vi sono giudici sposati tra loro, con pm e con avvocati.
Giudici figli di giudici, di pm o di avvocati. Giudici fratelli di giudici, pm e
avvocati. Giudici amanti di giudici, pm e avvocati. È fisiologico, normale e non
foriero di alcun sospetto. E allora – conclude il leader dei penalisti
partenopei – smettiamola con questo complottismo».
Viviana Lanza. Napoletana, laureata in Economia e
con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal
2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca
nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli
per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie
di stampa (TMNews, Askanews).
"ECCO QUANDO SI PUO' VIOLARE L' ALCOVA".
Franco Coppola il 25 maggio 1996 su La Repubblica. Un
pubblico ministero e una giudice delle indagini preliminari (o una pm e un gip)
che non sono marito e moglie ma che convivono possono esercitare nello stesso
tribunale? Giriamo la domanda a due magistrati, Edmondo Bruti Liberati,
sostituto procuratore generale a Milano, segretario generale dell'Associazione
nazionale magistrati, ex membro del Consiglio superiore della magistratura,
esponente storico di "Magistratura democratica", e Stefano Erbani, dell'ufficio
studi dello stesso Csm. Spiega Erbani: "La legge del ' 41 sull' ordinamento
giudiziario prevedeva i casi di parentela sia tra magistrati e avvocati della
stessa città, sia tra magistrati dello stesso collegio giudicante. Nel primo
caso, c'era il trasferimento d' ufficio del magistrato, nel secondo era il
dirigente dell'ufficio ad evitare di far operare i due interessati nello stesso
settore. Naturalmente, se uno lavorava al penale e l'altro al civile, il
problema non esisteva. Se poi, uno dei due, ad esempio, era un giudice
istruttore che si era occupato di un certo caso e l'altro faceva parte del
tribunale a cui il caso veniva successivamente affidato era prevista
l'astensione del secondo e, in caso di mancata astensione, la ricusazione da
parte dei difensori". Insomma, più o meno quello che succede ora, dopo le due
sentenze della corte costituzionale che vietano al giudice del tribunale della
libertà e al gip di far poi parte di collegi giudicanti che debbano esaminare la
posizione dello stesso imputato. "Esattamente". E per quanto riguarda il caso di
marito e moglie? "Fino al ' 67 non esistevano donne magistrato, quindi il caso
era limitato al marito magistrato e alla moglie avvocato. Anche in quel caso
scattava l'incompatibilità e quindi il trasferimento del marito. Dopo è potuto
accadere che ci fossero un marito e una moglie magistrati. Un caso non previsto
dalla normativa, ma che per analogia porterebbe alle stesse conseguenze che ho
già illustrato: trasferimento d' ufficio o astensione o ricusazione". E se il pm
e la gip (o la pm e il gip) fossero non marito e moglie ma conviventi? Risponde
Bruti Liberati: "Non credo sia mai accaduto: comunque, bisogna distinguere: se
si tratta di una convivenza notoria, si crea un problema di opportunità e, se
non è uno degli interessati a chiedere il trasferimento, provvederà il Csm. Se
invece - ad esempio, in seguito all' esposto di un avvocato - fosse una cosa
tutta da accertare, il Csm dovrebbe intromettersi nella vita privata di due
magistrati e credo che questo non sia accettabile". Aggiunge Erbani: "Il Csm è
un organo amministrativo che ha anche poteri di indagine. Certo, sarebbe una
cosa molto delicata e tutta da valutare". "A Milano", conclude Bruti Liberati,
"ricordo che si ricorreva ad un trucco tra gli avvocati che avevano parenti tra
i giudici. Si iscrivevano al foro di Monza, ma di fatto esercitavano a Milano.
Così, formalmente erano a posto".
Lo strano intreccio di magistrati e la professione
dei figli avvocati, scrive il 14 Maggio 2014 "Libero Quotidiano”. Nei tribunali
non si applica la legge dei codici (salvo eccezioni), mentre si applica la
tecnica delle “raccomandazioni” e non si può escludere “a pagamento”. Oggi vige
anche una giustizia “casareccia”, ovvero trovare l’avvocato figlio del
magistrato. E’ il caso dell’imprenditore/avvocato D.rio D’Isa, figlio del
magistrato di cassazione C.dio D’Isa, l’avvocato cura gli interessi Gabriele
Terenzio e figlio Luigi, accusati di associazione per delinquere di stampo
camorristico, gli inquisiti hanno un ricorso per cassazione e lo stesso avvocato
D.rio D’Isa fa incontrare gli inquisiti con suo padre, il giudice di Cassazione
C.dio D’Isa, evidentemente per trovare una soluzione ottimale agli inquisiti.
Inutile stupirsi la giustizia viene amministrata con questi “sistemi.”. Mi sono
trovato nelle medesima situazione: un semplicissimo procedimento civile durato
17 anni solo il primo grado, dopo il decimo anno uno dei magistrati che per
oltre cinque anni ha tenuto udienze “farsa”, con la sua signora parla con un mio
famigliare (ignari del procedimento in atto) e raccontano che il tal avvocato
(patrocinante il convenuto nel procedimento lungo 17 anni) era un loro amico e
procurava lavoro legale al loro figliolo – avvocato in Roma-, da una piccola
indagine accertavo che molti legali del foro iniziale di appartenenza del
magistrato, per i ricorsi da presentare in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte
dei Conti di 2° grado, Tar Lazio, ecc. si avvalevano dell’avvocato figlio del
magistrato, di conseguenza gli stessi avvocati avevano una corsia preferenziale
presso l’ufficio del magistrato per allungare i processi e le parcelle, e
comunque per fare pastette giudiziarie a danno di una delle parti in causa,
ipoteticamente lautamente compensate, non si può escludere che il magistrato
influenzasse altri colleghi per favorire clienti di avvocati “AMICI”. Inoltre,
lo stesso Avv. D.rio D’Isa è un imprenditore – come riferisce il Vostro
quotidiano Libero- e se così fosse sarebbe incompatibile l’esercizio della
professione legale. Ed il consiglio forense dovrebbe prendere provvedimenti
disciplinari nei confronti dell’Avv. D.rio D’Isa. Spesso le sentenze della
Cassazione fanno giurisprudenza!!!!!!
Parentopoli al tribunale di Lecce, il presidente
verso l'allontanamento. Il figlio di Alfredo Lamorgese, avvocato iscritto a
Bari, segue in Salento 37 cause civili, ma in base alla legge sono ammesse, in
via eccezionale, deroghe all'incompatibilità parentale solo per piccole
situazioni. Sul caso è intervenuto il Csm per il trasferimento d'ufficio, scrive
Chiara Spagnolo 12 giugno 2012 su "La Repubblica". Il padre presidente del
Tribunale di Lecce, il figlio avvocato, formalmente iscritto all’albo di Bari,
ma con 37 cause civili in itinere davanti allo stesso Tribunale del capoluogo
salentino. È la saga dei Lamorgese, famiglia di giudici e avvocati, che potrebbe
costare il trasferimento al presidente Alfredo, dopo che la prima commissione
del Csm ha aperto all’unanimità la procedura per "incompatibilità parentale". A
Palazzo dei Marescialli è stata esaminata la copiosa documentazione inoltrata
dal Consiglio giudiziario di Lecce, che, qualche settimana fa, ha rilevato la
sussistenza delle cause di incompatibilità attribuite all’attuale presidente del
Tribunale. Le verifiche effettuate dall’ordine degli avvocati hanno permesso di
appurare che Andrea Lamorgese risulta nominato come legale in 193 procedimenti
pendenti davanti agli uffici giudiziari salentini e che la sua appartenenza al
Foro di Bari, probabilmente, non basta a far venire meno le cause di
incompatibilità previste dall’ordinamento giudiziario. La legge prevede,
infatti, che i magistrati non possano esercitare funzioni direttive in un
Tribunale in cui un familiare svolga l’attività forense. La deroga a tale norma
si può ottenere solo quando l'attività difensiva del congiunto sia "sporadica e
poco significativa" anche dal punto di vista della qualità. Per ottenere la
deroga, tuttavia, i legami parentali tra giudici e avvocati devono essere
portati all’attenzione del Csm, cosa che Lamorgese non avrebbe fatto all’atto
della sua nomina a presidente del Tribunale, avvenuta nel 2009. A distanza di
soli tre anni quella leggerezza rischia di costargli cara, ovvero un
trasferimento prematuro rispetto agli otto anni previsti per il suo incarico,
perché l’accertamento sull’attività svolta dal figlio ha permesso di scoprire
come l’esercizio della funzione legale di Andrea a Lecce non fosse né sporadica
né poco significativa. Diversamente per quanto riscontrato rispetto alla figlia
e alla nuora, anche loro avvocati, le cui professioni non sarebbero però
incompatibili con l’attività del presidente, dal momento che la prima non
esercita la professione e la seconda si occupa di giustizia amministrativa. Il
prossimo passo del Consiglio superiore della magistratura sarà la convocazione
di Lamorgese a Roma, che sarà ascoltato il prossimo 25 giugno per chiarire la
propria posizione. All’esito dell’ascolto, e dell’esame di eventuali documenti
prodotti, la prima commissione deciderà se chiedere al plenum il trasferimento o
archiviare il caso.
Lecce, trasferito il presidente del tribunale. "Il
figlio fa l'avvocato, incompatibile". La decisione presa all'unanimità dal Csm:
Alfredo Lamorgese non può esercitare nello stesso distretto dove lavora il suo
congiunto. Il magistrato verso la pensione anticipata, scrive Chiara Spagnolo il
13 febbraio 2013 su "La Repubblica". Finisce con la parola trasferimento
l’esperienza di Alfredo Lamorgese alla guida del Tribunale di Lecce. Il plenum
del Csm è stato perentorio: impossibile sedere sulla poltrona di vertice degli
uffici giudicanti salentini se il figlio avvocato, formalmente iscritto all’albo
di Bari, in realtà esercita la sua professione anche a Lecce. Trasferimento
d’ufficio per incompatibilità ambientale era stato chiesto dalla Prima
commissione e così sarà, in seguito alla decisione presa ieri all’unanimità a
Palazzo dei Marescialli. Prima che la Terza commissione scelga per Lamorgese una
nuova destinazione, tuttavia, il giudice potrebbe presentare domanda di
pensionamento, così come è stato comunicato ad alcuni membri del Csm, che
avevano consigliato di chiudere immediatamente la lunga esperienza professionale
onde evitare l’onta di una decisione calata dall’alto. La vicenda tiene banco da
mesi nei palazzi del barocco, da quando il Consiglio giudiziario di Lecce ha
inoltrato al Consiglio superiore una copiosa documentazione che ha determinato
l’apertura della pratica per incompatibilità “parentale”. Le verifiche
effettuate dall’ordine degli avvocati hanno permesso infatti di appurare che
Andrea Lamorgese risulta nominato come legale in 193 procedimenti pendenti
davanti agli uffici giudiziari salentini e che la sua appartenenza al Foro di
Bari, probabilmente, non basta a far venire meno le cause di incompatibilità
previste dall’ordinamento giudiziario. La legge prevede che i magistrati non
possano esercitare funzioni direttive in un Tribunale in cui un familiare svolga
l’attività forense. La deroga a tale norma si può ottenere solo quando
l'attività difensiva del congiunto sia "sporadica e poco significativa" anche
dal punto di vista della qualità e deve essere tempestivamente comunicata
all’organo di autogoverno della magistratura. Stando a quanto verificato dal
Csm, tuttavia, il presidente non avrebbe comunicato alcuna causa di
incompatibilità all’atto della sua nomina, avvenuta nel 2009, né negli anni
successivi. E a poco è servito il tentativo di difendersi che in realtà le cause
in cui il figlio è stato protagonista come avvocato sono in numero di gran lunga
inferiore rispetto alle 193 contestate, perché l’accertamento sull’attività
svolta dal figlio ha permesso di scoprire come l’esercizio della funzione legale
di Andrea a Lecce non fosse né sporadica né poco significativa. Al punto che,
secondo il Consiglio superiore, uno dei due Lamorgese avrebbe dovuto lasciare.
Brindisi, giudici contro il procuratore, scrive il
27 giugno 2008 Sonia Gioia su "La Repubblica". Il procuratore Giuseppe
Giannuzzi, oggetto di un pronunciamento di incompatibilità parentale da parte
del Consiglio superiore della magistratura, che lo costringe ad abbandonare il
ruolo rivestito nella procura brindisina, non potrà mai più dirigere un'altra
procura. E' questo, a quanto pare, quello che stabilisce la legge. Sebbene a
Giannuzzi resti la chance del ricorso al tribunale amministrativo contro il
provvedimento adottato dall' organo di autogoverno dei magistrati.
Incompatibilità sorta sulla base di un procedimento penale nel quale un figlio
del magistrato, Riccardo Giannuzzi, avvocato iscritto all'albo forense di Lecce,
assunse la difesa di alcuni indagati sulla base di una richiesta al gip
controfirmata dallo stesso procuratore capo. Giannuzzi junior, raggiunto
telefonicamente, si esime da qualsiasi commento: "Non parlo per una questione di
correttezza nei confronti di mio padre. Senza il suo consenso non sarebbe giusto
rilasciare alcuna dichiarazione". Ma la famiglia, coinvolta in una vicenda senza
precedenti, almeno nella procura brindisina, è comprensibilmente provata. Sono
stati i magistrati della città messapica i primi a far emergere il caso della
presunta incompatibilità parentale. Gli stessi giudici difesi a spada tratta da
Giannuzzi quando gli strali del gip Clementina Forleo, autrice della denuncia
contro i pm Alberto Santacatterina e Antonio Negro, si sono abbattuti sulla
procura di Brindisi. A settembre scorso la sezione locale dell'associazione
nazionale magistrati si riunì per discutere il caso, dopo che da tempo, nei
corridoi del palazzo al civico 3 di via Lanzellotti, si mormorava
insistentemente e non senza insofferenza. L'avvocato Giannuzzi, per quanto
iscritto all'albo salentino dal 1999, figurava in qualità di difensore in
diversi processi celebrati nel tribunale brindisino. Fino all' ultimo caso,
esploso a seguito di un blitz per droga. Il legale assunse la difesa di uno
degli indagati, arrestato a seguito dell'operazione, sulla base di una richiesta
al gip controfirmata da Giuseppe Giannuzzi. A seguito della vicenda, i giudici
tanto della procura quanto del tribunale, riuniti in consesso, insorsero
siglando a maggioranza una delibera in cui si legge: "L' evidente caso di
incompatibilità parentale mina il prestigio di cui la magistratura brindisina ha
sempre goduto". Parole pesanti, che il procuratore capo Giuseppe Giannuzzi, di
stanza a Brindisi dal settembre 2004, non ha mai voluto commentare. Adesso, il
pronunciamento del Csm: padre e figlio non possono convivere professionalmente
nello stesso distretto giudiziario. Diciotto i voti a favore, sei i favorevoli a
Giannuzzi, fra cui quello del presidente Nicola Mancino. La decisione è stata
adottata sebbene l'avvocato Riccardo Giannuzzi abbia, a seguito del putiferio
venutosi a creare, rinunciato a tutti i mandati che potevano vedere in qualche
modo coinvolto il procuratore capo della Repubblica di Brindisi. La prima
commissione del Csm si era già espressa all' unanimità a favore del
trasferimento, sempre alla luce del fatto che Giannuzzi junior esercita la
professione forense anche nel capoluogo messapico. Le conseguenze del
procedimento, a quanto pare, non sortiranno effetti in tempi brevi: la decisione
del plenum del Csm infatti, dopo la notifica potrà essere impugnata dal
procuratore capo. La prassi prevede che a indicare le nuove, possibili sedi di
destinazione sia ora la terza commissione del Consiglio superiore della
magistratura. La scelta toccherà direttamente al giudice, che se non dovesse
esprimersi, sarà trasferito d' ufficio. Ma in nessuna sede in cui Giuseppe
Giannuzzi verrà destinato, lo prevede il regolamento, mai più potrà rivestire il
ruolo di procuratore capo. A meno che non presenti ricorso al Tar e lo vinca.
Tribunale di Messina, le relazioni pericolose
emerse dallo screening di un gruppo di giovani avvocati, scrive l'1 settembre
2016 "100 Nove". Nello “screening” effettuato in relazione al Tribunale di
Messina, un gruppo di giovani avvocati emergono una serie di rapporti in
chiaroscuro tra magistrati, prima sposati e poi divorziati, che si trovano ad
operare nello stesso tribunale; magistrati che si ritrovano cognati avvocati a
discutere le stesse cause. E altro, dopo l’esplosione del caso Simona Marra. Un
dettagliato elenco di tutte le anomalie nei rapporti tra avvocati e magistrati
nel distretto giudiziario di Messina. Lo ha predisposto un gruppo di giovani
avvocati che ha passato al setaccio le situazioni “controverse” nei tribunali
della provincia, dopo l’esplosione del “caso Simona Merra”, il pm di Trani
titolare del fascicolo sull’incidente ferroviario del 12 luglio tra Bari e
Barletta dove hanno perso la vita 23 persone, sorpresa da uno scatto fotografico
a farsi baciare il piede dall’avvocato Leonardo De Cesare, legale di Vito
Picaretta, capostazione di Andria che è il principale indagato della strage.
Nello “screening” del Tribunale di Messina, conosciuto in passato come “rito
peloritano”, emergono una serie di rapporti in chiaroscuro tra magistrati, prima
sposati e poi divorziati, che si trovano ad operare nello stesso tribunale;
magistrati che si ritrovano cognati avvocati a discutere le stesse cause;
magistrati togati che, tra i 64 incaricati alla commissione tributaria, si
ritrovano nella rotazione ad avere parenti diretti in commissione; magistrati
invitati la sera a cena da avvocati, con i quali hanno fascicoli aperti. Una
situazione anomala, tollerata per una sorta di quieto vivere, che preoccupa ora
i giovani avvocati promotori dello screening: si stanno interrogando se inviare
in forma anonima il documento solo ai giornali e al Consiglio giudiziario, o
solo alla sezione disciplinare del Csm e alla procura generale della Cassazione:
temono rappresaglie professionali, da parte dei magistrati e consiglieri
dell’Ordine. Sulla questione delle incompatibilità, si è aperto un vivace
dibattito anche a livello nazionale. Se da una parte il vicepresidente del
Csm Giovanni Legnini chiede ai magistrati di assumere un maggiore senso di
sobrietà e finirla con la giustizia-spettacolo, dall’altra, la stessa categoria
dei magistrati, dilaniata dalle correnti, si è spaccata sul caso “Simona Marra”
con posizioni divergenti tra Magistratura Indipendente, Magistratura
Democratica, Unicost, Area, la corrente di sinistra, e Autonomia & Indipendenza,
il gruppo che fa capo al presidente nazionale dell’Associazione nazionale
magistrati, Piercamillo Davigo, che ha raccolto un buon numero di adesioni in
provincia di Messina, dove esponente di punta è il procuratore
aggiunto, Sebastiano Ardita.
Tribunale di Messina, le relazioni pericolose
emerse dallo screening di un gruppo di giovani avvocati, scrive l'1 settembre
2016 "100 Nove". Nello “screening” effettuato in relazione al Tribunale di
Messina, un gruppo di giovani avvocati emergono una serie di rapporti in
chiaroscuro tra magistrati, prima sposati e poi divorziati, che si trovano ad
operare nello stesso tribunale; magistrati che si ritrovano cognati avvocati a
discutere le stesse cause. E altro, dopo l’esplosione del caso Simona Marra. Un
dettagliato elenco di tutte le anomalie nei rapporti tra avvocati e magistrati
nel distretto giudiziario di Messina. Lo ha predisposto un gruppo di giovani
avvocati che ha passato al setaccio le situazioni “controverse” nei tribunali
della provincia, dopo l’esplosione del “caso Simona Merra”, il pm di Trani
titolare del fascicolo sull’incidente ferroviario del 12 luglio tra Bari e
Barletta dove hanno perso la vita 23 persone, sorpresa da uno scatto fotografico
a farsi baciare il piede dall’avvocato Leonardo De Cesare, legale di Vito
Picaretta, capostazione di Andria che è il principale indagato della strage.
Nello “screening” del Tribunale di Messina, conosciuto in passato come “rito
peloritano”, emergono una serie di rapporti in chiaroscuro tra magistrati, prima
sposati e poi divorziati, che si trovano ad operare nello stesso tribunale;
magistrati che si ritrovano cognati avvocati a discutere le stesse cause;
magistrati togati che, tra i 64 incaricati alla commissione tributaria, si
ritrovano nella rotazione ad avere parenti diretti in commissione; magistrati
invitati la sera a cena da avvocati, con i quali hanno fascicoli aperti. Una
situazione anomala, tollerata per una sorta di quieto vivere, che preoccupa ora
i giovani avvocati promotori dello screening: si stanno interrogando se inviare
in forma anonima il documento solo ai giornali e al Consiglio giudiziario, o
solo alla sezione disciplinare del Csm e alla procura generale della Cassazione:
temono rappresaglie professionali, da parte dei magistrati e consiglieri
dell’Ordine. Sulla questione delle incompatibilità, si è aperto un vivace
dibattito anche a livello nazionale. Se da una parte il vicepresidente del
Csm Giovanni Legnini chiede ai magistrati di assumere un maggiore senso di
sobrietà e finirla con la giustizia-spettacolo, dall’altra, la stessa categoria
dei magistrati, dilaniata dalle correnti, si è spaccata sul caso “Simona Marra”
con posizioni divergenti tra Magistratura Indipendente, Magistratura
Democratica, Unicost, Area, la corrente di sinistra, e Autonomia & Indipendenza,
il gruppo che fa capo al presidente nazionale dell’Associazione nazionale
magistrati, Piercamillo Davigo, che ha raccolto un buon numero di adesioni in
provincia di Messina, dove esponente di punta è il procuratore
aggiunto, Sebastiano Ardita.
Giustizia alla cosentina: tutte le “parentele
pericolose” tra giudici, pm e avvocati, scrive Iacchite il 22 luglio 2016.
Diciassette magistrati del panorama giudiziario di Cosenza e provincia risultano
imparentati con altrettanti avvocati dei fori cosentini. Una situazione
impressionante, che corre da anni sulle bocche di tutti i cosentini che hanno a
che fare con questo tipo di “giustizia”. Il dossier Lupacchini, già dieci anni
fa, faceva emergere in tutta la sua gravità questo clima generale
di “incompatibilità ambientale” ma non è cambiato nulla, anzi. La legge, del
resto, non è per niente chiara e col passare del tempo è diventata anche più
elastica. Per cui diventa abbastanza facile eludere il comma incriminato e cioè
che il trasferimento diventa ineludibile “quando la permanenza del dipendente
nella sede nuoccia al prestigio della Amministrazione”. Si tratta, dunque, di un
potere caratterizzato da un’ampia discrezionalità. E così, dopo un decennio,
siamo in grado di darvi una lettura aggiornata di tutto questo immenso “giro” di
parentele, difficilmente perseguibili da una legge non chiara e che comunque
quantomeno condiziona indagini e sentenze. E coinvolge sia il settore penale che
quello civile. Anzi, il civile, che è molto più lontano dai riflettori dei
media, è ricettacolo di interessi, se possibile, ancora più inconfessabili.
Cerchiamo di capirne di più, allora, attraverso questo (quasi) inestricabile
reticolo di relazioni familiari.
LE PARENTELE PERICOLOSE
Partiamo dai magistrati che lavorano nel Tribunale
di Cosenza.
Il pubblico ministero Giuseppe Casciaro (chè tanto
da qualcuno dovevamo pur cominciare) è sposato con l’avvocato Alessia Strano,
che fa parte di una stimata famiglia di legali, che coinvolge anche il suocero
Luciano Strano e i cognati Amedeo e Simona.
Il giudice Alfredo Cosenza è sposato con
l’avvocato Serena Paolini ed è, di conseguenza, cognato dell’avvocato Enzo
Paolini, che non ha certo bisogno di presentazioni.
Il gip Giusy Ferrucci, dal canto suo, è sposata
con l’avvocato Francesco Chimenti.
Paola Lucente è stata giudice del Tribunale penale
di Cosenza e adesso è in servizio alla Corte d’Appello di Catanzaro e mantiene
il ruolo di giudice di sorveglianza e della commissione tributaria cosentina. Di
recente, il suo nome è spuntato fuori anche in alcune dichiarazioni di pentiti
che la coinvolgono in situazioni imbarazzanti riguardanti il suo ruolo di
magistrato di sorveglianza.
Anche la dottoressa Lucente ha un marito avvocato:
si chiama Massimo Cundari.
Del giudice Lucia Angela Marletta scriviamo ormai
da tempo. Anche suo marito, Maximiliano Granata, teoricamente è un avvocato ma
ormai è attivo quasi esclusivamente nel settore della depurazione e, come si sa,
in quel campo gli interventi della procura di Cosenza, in tema di sequestri e
dissequestri, sono assai frequenti. Quindi, è ancora peggio di essere “maritata”
con un semplice avvocato.
Se passiamo al civile, la situazione non cambia di
una virgola.
La dottoressa Stefania Antico è sposata con
l’avvocato Oscar Basile.
La dottoressa Filomena De Sanzo, che proviene
dall’ormai defunto tribunale di Rossano, si porta in dote anche lei un marito
avvocato, Fabio Salcina.
La dottoressa Francesca Goggiamani è in servizio
nel settore Fallimenti ed esecuzioni immobiliari ed è sposato con
l’avvocato Fabrizio Falvo, che fino a qualche anno fa è stato anche consigliere
comunale di Cosenza.
GIUDICI COSENTINI IN ALTRA SEDE
Passando ai magistrati cosentini che adesso
operano in altri tribunali della provincia o della regione, il giudice penale
del Tribunale di Paola Antonietta Dodaro convive con l’avvocato Achille
Morcavallo, esponente di una famiglia da sempre fucina di legali di spessore.
Il giudice penale del Tribunale di Castrovillari,
nonché giudice della commissione tributaria di Cosenza, Loredana De Franco, è
sposata con l’avvocato Lorenzo Catizone. Anche lui, come Granata, non fa
l’avvocato di professione ma in compenso fa parte da anni dello staff di Mario
Oliverio. Che non ha bisogno di presentazioni. Catizone, inoltre, è cugino di
due noti avvocati del foro cosentino: Francesco e Rossana Cribari.
Il neoprocuratore di Castrovillari Eugenio
Facciolla si trascina molto più spesso rispetto al passato la figura ingombrante
del fratello Marco, avvocato. In più, lo stesso Facciolla è cognato
dell’avvocato Pasquale Vaccaro.
Sempre a Castrovillari, c’è un altro giudice
cosentino, Francesca Marrazzo, che ha lavorato per molti anni anche al Tribunale
di Cosenza. E che è la sorella dell’avvocato Roberta Marrazzo.
La dottoressa Gabriella Portale invece è in
servizio alla Corte d’Appello di Catanzaro (sezione lavoro) ed è giudice della
commissione tributaria di Cosenza. Suo marito è l’avvocato Gabriele Garofalo.
Il dottor Biagio Politano, giudice della Corte
d’Appello di Catanzaro già proveniente dal Tribunale di Cosenza e giudice della
commissione tributaria di Cosenza, ha una sorella tra gli avvocati. Si
chiama Teresa.
Non avevamo certo dimenticato la
dottoressa Manuela Morrone, oggi in servizio nel settore civile del Tribunale di
Cosenza dopo aver lavorato anche nel penale. Tutti sanno che è la figlia
di Ennio Morrone e tutti sappiamo quanto bisogno ha avuto ed ha tuttora di una
buona parola per le sue vicissitudini giudiziarie, sia nel penale, sia nel
civile.
Morrone non è un avvocato ma riteniamo, per tutte
le cause che lo vedono protagonista, che lo sia diventato quasi honoris causa.
Poiché non ci facciamo mancare veramente nulla,
abbiamo parentele importanti anche per giudici onorari e giudici di pace.
La dottoressa Erminia Ceci è sposata con
l’avvocato Alessandro De Salvo e il dottor Formoso ha tre avvocati in famiglia:
suo padre e le sue due sorelle.
Tra i giudici di pace, infine, la
dottoressa Napolitano è la moglie dell’avvocato Mario Migliano.
CHE COSA SIGNIFICA
Mentre le “conseguenze” delle reti personali nel
settore penale sono molto chiare e riguardano reati di una certa gravità, le
migliori matasse si chiudono nel settore civile, come accennavamo. Numerosi
avvocati, familiari di magistrati, sono nominati tutori dai giudici tutelari del
Tribunale di Cosenza, per esempio gli avvocati De Salvo e Politano, ma anche
curatori fallimentari oppure avvocati nelle cause dei tutori e della curatela
del fallimento in questione. Alcuni avvocati, per evitare incompatibilità, fanno
condurre le cause ad altri avvocati a loro vicini. Cosa succede quando uno degli
avvocati che cura gli interessi del familiare di un giudice ha una causa con un
altro avvocato imparentato con un altro giudice? Lasciamo ai lettori ogni tipo
di risposta. Un discorso a parte meritano le nomine dei periti del tribunale.
Parliamo di una schiera pressoché infinita di consulenti tecnici d’ufficio,
medici, ingegneri, commercialisti, geologi e chi più ne ha più ne metta. Pare
che alcuni, quelli maggiormente inseriti nella massoneria, facciano collezione
di nomine e di soldini. Questo è il quadro generale, diretto, tra l’altro da un
procuratore in perfetta linea con i suoi predecessori: coprire tutto il marcio e
continuare a far pascere i soliti noti. Questa è la giustizia “alla cosentina”.
E nessuno si lamenta. Almeno ufficialmente.
Sarebbe interessante, però, sapere di quanti
paradossi sono costellata i distretti giudiziari italiani.
Art. 19 dell’Ordinamento
Giudiziario. (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con
magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede).
I magistrati che hanno tra loro vincoli di
parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non
possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso
ufficio giudiziario.
La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di
sede è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma,
per quanto compatibili.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di
parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non
possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati
in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in
un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei
due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede
centrale.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di
parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di
convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle
corti e nei tribunali.
I magistrati preposti alla direzione di uffici
giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di
incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti
organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile
e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla
base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili,
se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità
entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al
medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed
i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della
Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un
magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della
Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i
minorenni.
I magistrati non possono appartenere ad uno stesso
ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in
primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La
ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri
di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.
Si sa che chi comanda detta legge e non vale la
forza della legge, ma la legge del più forte.
I magistrati son marziani. A chi può venire in
mente che al loro tavolo, a cena, lor signori, genitori e figli, disquisiscano
dei fatti di causa approntati nel distretto giudiziario comune, o addirittura a
decidere su requisitorie o giudizi appellati parentali?
A me non interessa solo l'aspetto
dell'incompatibilità. A me interessa la propensione del DNA, di alcune persone
rispetto ad altre, a giudicare o ad accusare, avendo scritto io anche:
Concorsopoli.
«Ciao Melitta, hai saputo? Mio marito è stato
nominato all'unanimità presidente della Corte d'Appello di Messina. Sono molto
contenta, dillo anche a Franco (Tomasello, rettore dell'Università) e ricordagli
del concorso di mio figlio. Ciao, ciao». Chi parla al telefono è la moglie del
presidente della Corte d'appello di Messina, Nicolò Fazio, chi risponde è
Melitta Grasso, moglie del rettore e dirigente dell'Università, il cui telefono
è intercettato dalla Guardia di Finanza perché coinvolta in una storia di
tangenti per appalti di milioni di euro per la vigilanza del Policlinico
messinese. Ma non è la sola intercettazione. Ce ne sono tante altre, anche di
magistrati messinesi, come quella del procuratore aggiunto Giuseppe Siciliano
che raccomanda il proprio figlio. Inutile dire che tutti e due i figli, quello
del presidente della Corte d'appello e quello del procuratore aggiunto, hanno
vinto i concorsi banditi dall'ateneo. Posti unici, blindati, senza altri
concorrenti. Francesco Siciliano è diventato così ricercatore in diritto
amministrativo insieme a Vittoria Berlingò (i posti erano due e due i
concorrenti), figlia del preside della facoltà di Giurisprudenza, mentre
Francesco Siciliano è diventato ricercatore di diritto privato. Senza nessun
problema perché non c'erano altri candidati, anche perché molti aspiranti, come
ha accertato l'indagine, vengono minacciati perché non si presentino. Le
intercettazioni sono adesso al vaglio della procura di Reggio Calabria che, per
competenza, ha avviato un'inchiesta sulle raccomandazioni dei due magistrati
messinesi, che si sarebbero dati da fare con il rettore Franco Tomasello per
fare vincere i concorsi ai propri figli. Altri guai dunque per l'ateneo che,
come ha raccontato «Repubblica» nei giorni scorsi, è stato investito da una
bufera giudiziaria che ha travolto proprio il rettore, Franco Tomasello, che è
stato rinviato a giudizio e sarà processato il 5 marzo prossimo insieme ad altri
23 tra docenti, ricercatori e funzionari a vario titolo imputati di concussione,
abuso d' ufficio in concorso, falso, tentata truffa, maltrattamenti e peculato.
In ballo, alcuni concorsi truccati e le pressioni fatte ad alcuni candidati a
non presentarsi alle prove di associato. E in una altra indagine parallela è
coinvolta anche la moglie del rettore, Melitta Grasso, dirigente universitaria,
accusata di aver favorito, in cambio di «mazzette», una società che si era
aggiudicata l'appalto, per quasi due milioni di euro, della vigilanza
Policlinico di Messina. Un appalto che adesso costa appena 300 mila euro.
L'inchiesta sull'ateneo messinese dunque è tutt'altro che conclusa ed ogni
giorno che passa si scoprono altri imbrogli. Agli atti dell'inchiesta, avviata
dopo la denuncia di un docente che non accettò di far svolgere concorsi
truccati, ci sono molte intercettazioni della moglie del rettore. Convinta di
non essere ascoltata, durante una perquisizione della Guardia di Finanza Melitta
Grasso dice ad un suo collaboratore («Alberto») di fare sparire dall'ufficio
documenti compromettenti. In una interrogazione del Pd al Senato, si chiede al
ministro della Pubblica istruzione Mariastella Gelmini «se intende costituirsi
parte civile a tutela dell'immagine degli atenei e inoltre se intenda sospendere
cautelativamente il rettore di Messina». (Repubblica — 20 novembre 2008 pagina
20, sezione: cronaca).
Padre giudice e figlia avvocato: c'è
incompatibilità? Annamaria Villafrate il 25 nov 2020
su studiocataldi.it. Per il Tar Lazio, un magistrato può ricoprire il ruolo
direttivo presso un Tar monosezione se la figlia avvocato rinuncia a praticare
il diritto amministrativo. Il magistrato può assumere l'incarico direttivo
presso il TAR mono-sezione se la figlia che esercita la professione forense si
impegna ad astenersi dal compiere attività giudiziali e stragiudiziali in
diritto amministrativo. L'art. 18 dell'ordinamento giudiziario dispone che
l'incompatibilità deve essere valutata caso per caso e il CPGA può farlo grazie
al proprio potere discrezionale. Questo in sostanza quanto emerge
dalla sentenza n. 11551/2020 del Tar Lazio (sotto allegata) che si è trovato a
dover decidere la seguente e ingarbugliata vicenda. Un magistrato
amministrativo ricorre al Tar, impugnando alcuni atti relativi alla sua nomina,
di cui chiede l'annullamento per eccesso di potere e violazione di legge. Il
magistrato espone di aver presentato domanda per il conferimento di un incarico
direttivo. La commissione incaricata dello scrutinio ha respinto la proposta di
una relatrice "di rilevare la ricorrenza della causa di incompatibilità prevista
dall'art. 18 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
applicabile ai magistrati amministrativi ai sensi dell'art. 28 della legge 27
aprile 1982, n. 186, posto che la figlia del ricorrente esercita la professione
forense presso la sede marchigiana." Rigettata detta questione la Commissione
propone la nomina del Magistrato al Plenum, ma la dottoressa incaricata di
redigere la relazione di accompagnamento alla proposta solleva nuovamente il
problema dell'incompatibilità a causa della professione svolta dalla figlia, la
quale ha dichiarato di impegnarsi per il futuro a non svolgere nessun tipo di
attività presso il TAR, fatta eccezione per le attuali pendenze, in numero di
cinque o sei ricorsi con un mandato congiunto con altro difensore e di tre come
unico avvocato". La Commissione però nomina il Magistrato, accogliendone la
richiesta in merito alla presidenza della III sezione esterna del Tar Lazio.
Le censure del magistrato amministrativo. Il
Magistrato però censura gli atti di nomina per le seguenti ragioni. Prima di
tutto ricorda che la figlia ha dichiarato che, contrariamente a quanto rilevato
in Commissione, avrebbe dismesso il mandato in relazione alle 9 cause
amministrative pendenti in caso di nomina del padre. In secondo luogo denuncia
"eccesso di potere: disparità di trattamento; difetto di istruttoria;
motivazione carente o comunque insufficiente; manifesta ingiustizia", perché, in
occasione di precedenti delibere applicative dell'art. 18 ord. Giud., il CPGA ha
escluso la ricorrenza della incompatibilità, proprio in ragione dell'impegno del
parente del magistrato ad astenersi da ogni attività di fronte al giudice
amministrativo di primo grado." Denuncia poi il mancato espletamento da parte
del Plenum di una completa istruttoria sulle circostanze rilevanti ai fini della
incompatibilità e il fatto che lo stesso non è tenuto ad applicare in modo
automatico le cause di incompatibilità previste dall'ordinamento giudiziario,
dovendo tenere conto della specificità della magistratura amministrativa. Rileva
inoltre come nel caso di specie la rinuncia a svolgere la professione forense di
fronte all'ufficio giudiziario a cui è preposto il magistrato esclude
l'incompatibilità, stante l'insussistenza di un conflitto di interessi.
L'Avvocatura di Stato per i convenuti evidenzia come la circolare del Consiglio
di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA) del 12 ottobre 2006 metta in
evidenza come tra i fattori preponderanti per valutare l'incompatibilità del
magistrato c'è quello della dimensione del Foro.
Il CPGA tenga conto della rinuncia della figlia.
Dopo aver analizzato e deciso le questioni preliminari il Tar, passando al
merito della questione, chiarisce che: "in sede di apprezzamento di profili di
incompatibilità parentale del magistrato, il CPGA applica direttamente gli artt.
18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, perché ciò è previsto dall'art. 28 della
legge n. 186 del 1982" naturalmente purché compatibili con la specificità della
giurisdizione amministrativa, ricordando altresì come "la incompatibilità trova
la sua essenza nel pregiudizio che, in difetto di essa, potrebbe essere arrecato
al requisito costituzionale dell'imparzialità della magistratura." Occorre però,
come sottolineato dalla circolare del CSM n. 6750 del 19 luglio 1985,
un "concreto accertamento" della incompatibilità, principio che ha segnato la
strada per la formulazione dell'attuale art. 18 dell'ordinamento giudiziario da
cui emerge l'opzione del legislatore per "un meccanismo di bilanciamento degli
interessi confliggenti, tale da costituire il vero e proprio principio
informatore della materia." Analizzando l'art. 18 dell'ordinamento giudiziario,
attorno al quale ruota la soluzione della vicenda, il Tar precisa che: "E'
perciò l'art. 18, comma 4, ord. giud. a disciplinare il profilo di
incompatibilità che rileva nella presente causa." Da questa norma si può trarre
infatti il principio secondo cui salvo fattispecie eccezionali e tassativamente
indicate, il rilievo di una causa di incompatibilità esige "un riscontro caso
per caso delle singole situazioni implicanti la impossibilità di svolgimento di
attività incompatibili in base alla legge" (Cons. Stato, sez. IV , n. 1818 del
2008). Ora, il ricorrente ritiene che la sua nomina in un Tar mono-sezionale sia
ostacolata proprio dalla formulazione dell'art. 18 dell'ordinamento giudiziario,
poiché solo in presenza di più sezioni l'incompatibilità da rigida può diventare
più flessibile. Vero però che nelle intenzioni del legislatore la pluralità
delle sezioni non è dirimente, se non accompagnata da una pluralità di materie,
solo a queste condizioni l'incompatibilità assoluta viene meno." Dell'art. 18
ord. giud., in altri termini, non è direttamente applicabile la porzione
prescrittiva, la cui lettera si riferisce inequivocabilmente alla sola
giurisdizione ordinaria, attinente alla pluralità di sezioni civili e penali."
La prassi della CPGA tuttavia tende sempre e comunque a valutare caso per caso e
concretamente la sussistenza dell'incompatibilità, anche se il magistrato viene
assegnato a un ufficio mono-sezionale. Occorre però evidenziare che nel caso di
specie, come in altri precedenti, l'impegno assunto dal professionista di
astenersi da ogni attività in grado di interferire con la giurisdizione
amministrativa esclude la sussistenza di una causa di incompatibilità
ambientale, almeno quando l' avvocato non eserciti in uno studio associato e
quando non siano percepibili circostanze eccezionali di segno contrario." Alla
luce delle suddette considerazioni e di altre successive il Tar dispone quindi
che il CPGA avvii un nuovo procedimento, e che nel pronunciarsi sui profili di
incompatibilità ambientale segnalati si attenga al seguente principio di
diritto: "l'impegno del parente del magistrato (quand'anche preposto, o da
preporre, alla presidenza di un TAR mono-sezionale) ad astenersi da ogni
attività anche stragiudiziale, nel campo del diritto amministrativo, in linea di
massima e ove provenga da un professionista che esercita l' attività in forma
individuale, rimuove lo stato di incompatibilità ambientale, salvo casi
eccezionali."
·
Il
Diritto di Difesa vale meno…
Antonio Giangrande: Il nostro
cavallo di battaglia è l’istituzione del difensore civico giudiziario che possa
operare con i poteri giudiziari, contro gli abusi e le omissioni dei magistrati
e degli avvocati e degli apparati ministeriali a tutela dei cittadini. Sposiamo
la causa e divulghiamo l’iniziativa concreta.
Il giudice zittisce l’imputato per non offendere i carabinieri:
avvocati in sciopero.
Francesca Sabella su
Il Riformista il 25 Novembre 2022
In un’aula di
giustizia del Tribunale di Nola, un acceso scambio di battute tra avvocato e
giudice è proseguito fra relazioni ed esposti, che hanno portato a prese di
posizione delle organizzazioni di appartenenza e addirittura alla proclamazione
di uno sciopero da parte della camera penale per il 5 dicembre.
E’ accaduto nel
corso di un processo per minacce con l’uso di armi con un unico imputato. La
tensione è esplosa tra il difensore di quest’ultimo, Paola Caruso, iscritta al
Foro di Nola, e il giudice onorario Rossana Ferraro, che peraltro è anche
avvocato iscritto al Foro di Santa Maria Capua Vetere, nell’udienza del 14
novembre scorso, durante l’esame dell’imputato, quando quest’ultimo ha iniziato
a parlare, su domanda del legale, della perquisizione effettuata a casa sua dai
carabinieri che cercavano (e non hanno trovato) l’arma usata.
Il giudice, come
emerge dalla relazione di servizio, ha stoppato l’imputato, e con ordinanza
istruttoria ha disposto che non si parlasse della perquisizione, essendo
circostanza che esulava dal capo di imputazione, ma anche per evitare
affermazioni “sconvenienti” e “offensive” verso l’Arma, memore di quanto
accaduto in un’udienza precedente, quella del 13 giugno, in cui il giudice
riferisce – stando alla relazione di servizio – che l’imputato aveva già offeso
i carabinieri a proposito della perquisizione, tanto che nell’udienza del 14
novembre – annota il giudice – l’imputato chiede poi scusa.
Lo stop imposto dal
giudice all’imputato fa infuriare l’avvocato Caruso, che secondo quanto
riportato nella nota della Camera Penale di Nola (affissa e pubblicata in tutti
i palazzi di giustizia italiani e inviata alle sedi istituzionali), “tenta di
spiegare le ragioni della rilevanza delle argomentazioni, ma viene zittito dal
giudice che, con toni concitati e fare dispotico, non ha permesso di concludere
una serena interlocuzione”.
Francesca Sabella.
Nata a Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole ha
deciso, non senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro.
Giornalista pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi
protagonisti.
Sotto processo a vita.
Storie di ordinario “sequestro”.
La ragionevole durata, prevista dalla Costituzione e dalla Cedu, e regolata
dalla Legge Pinto, è spesso disattesa. Vittime illustri e semplici cittadini
accomunati da una stessa sorte. Il caso record di Giuseppe Gulotta: in carcere
per 22 anni. Valentina Stella su Il Dubbio il 31 ottobre 2022.
Il tema della ragionevole
durata del processo è oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l’art.
111, comma 2, Costituzione secondo cui la «La legge assicura la ragionevole
durata » e l’art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad
un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad
un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge». Inoltre secondo la
Legge Pinto il termine di durata ragionevole del processo si considera
rispettato se il processo non eccede la durata di: tre anni in primo grado, due
anni in secondo grado, un anno nel giudizio di legittimità. O comunque se il
giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei
anni.
Eppure nel nostro Paese
esistono diverse storie di persone che per veder concluso l’iter giudiziario che
le coinvolgeva hanno dovuto aspettare anni ed anni, trasformandole in dei veri e
propri “sequestrati dalla giustizia”. Tanto è vero che la Corte europea dei
Diritti dell’Uomo si è ripetutamente pronunciata nei confronti dell’Italia sul
rispetto del diritto alla ragionevole durata del processo. Una delle più note e
recenti sentenze riguarda la “Causa Verrascina e altri c. Italia” del 28 aprile
di quest’anno.
Il signor Antonio Verrascina è
stato sottoposto a giudizio per 18 anni e 8 mesi. L’inizio del procedimento fu
al Tribunale di Modena nel 1997. Si concluse in Cassazione nel luglio 2017. La
sua causa era stata riunita ad altre: pensate che per il signor Salvatore
Giardina primo grado e appello sono durati 24 anni e 2 mesi. Il processo era
iniziato al Tribunale di Mistretta nel 1991 e si era concluso alla Corte di
Appello di Messina nel maggio 2016. Ma di casi ce ne sono molti altri, pur senza
essere arrivati all’attenzione della Cedu. A gennaio di quest’anno la Corte
d’Appello di Catania ha assolto l’ex presidente della Regione
Siciliana, Raffaele Lombardo, dalle accuse di concorso esterno in associazione
mafiosa e corruzione elettorale.
Alla lettura della sentenza
l’ex Fondatore e leader del Movimento per le Autonomie si era detto «molto
felice e sollevato per l’assoluzione. Sono stati 12 anni da incubo, la sentenza
mi ripaga di tante sofferenze. La mia è una vicenda umana e giudiziaria
incredibile». Per uno dei politici più influenti della Sicilia è stata una vera
e propria odissea giudiziaria: una condanna, un’assoluzione, un annullamento
dell’assoluzione con rinvio. Tre sentenze, tutte diverse l’una dall’altra. E
quest’anno la quarta sentenza: ancora una assoluzione. Nel dicembre 2020 la
Corte di Cassazione aveva confermato l’assoluzione dell’ex ministro Calogero
Mannino nel processo stralcio sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. L’uomo
era accusato di violenza o minaccia a Corpo politico dello Stato.
L’indagine era partita nel
2012. Nel 2015 viene assolto, sentenza confermata in appello. Nonostante una
“doppia assolutoria” i procuratori generale di Palermo andarono in Cassazione,
la quale diede loro torto. L’uomo per 8 anni è stato prigioniero di una accanita
(in)giustizia. Come non dimenticare il calvario di Pierdomenico Garrone, ex
presidente di Enoteca del Piemonte e di Enoteca d’Italia, la cui vita è rimasta
sospesa per 16 anni.
Lo scorso anno si è visto
confermare l’assoluzione già rimediata in primo grado quattro anni prima. Un
processo e un’inchiesta lunghissimi, senza esser mai stato sentito dai pm che lo
accusavano di aver fatto carte false sfruttando il suo ruolo. Tutto era partito
nel 2005 con un blitz della Guardia di Finanza nelle sue proprietà. Da quel
momento la sua vita cambiò radicalmente, a partire dalle dimissioni da
presidente di Enoteca Piemonte ed Enoteca d’Italia.
Invece Rocco Femia, di
professione professore, ex sindaco di Marina di Gioiosa, è rimasto ostaggio
della giustizia per 11 anni. Undici anni trascorsi tra carceri e tribunali. Ma
era innocente, non faceva parte di una cosca di ‘ndrangheta. Lo ha
definitivamente deciso quest’anno la Cassazione. «Sono passati 11 anni per avere
giustizia, anni in cui ho gridato la mia innocenza, dopo una vita distrutta, una
famiglia che ha sofferto come non auguro a nessuno e una comunità che ha dovuto
subire tutto questo. Ho dovuto aspettare tanto per vedere nei fatti che ciò che
dicevo era vero. Erano gli altri, quelli che rappresentavano la giustizia, ad
infangarmi. Ma c’è sempre un giudice a Berlino» aveva detto alla collega Simona
Musco.
Ma poi c’è la storia di Ciccio
Addeo, riportata alla luce dalla nostra firma Alessandro Barbano ma in questo
caso sull’Huffington post: «La mattina del 23 marzo 2001, in cui entrò
a Poggioreale, era ancora un luminare all’apice della sua carriera. Cinquantotto
anni, capo del Cnr di Avellino, ordinario di agraria alla Federico II,
presidente del consorzio per la mozzarella di bufala, direttore di centri di
ricerca sperimentale a Lodi e in Corsica, Addeo era considerato uno de massimi
esperti in Europa in materia lattiero-casearia». Le accuse? Associazione per
delinquere, falso in atto pubblico, truffa aggravata.
Il chimico veniva accusato di
aver falsamente garantito la genuinità del burro sofisticato, che dall’Italia si
immetteva nel mercato francese. Rimase in carcere quattro mesi, altri quattro ai
domiciliari. Dopo sette anni la sentenza di primo grado che lo assolse da quasi
tutti i reati. Rinunciò alla prescrizione, altri sette anni per la sentenza di
secondo grado, che ricopiò integralmente quella del primo, e altri due per
quella di Cassazione, che annullò i due giudizi, “dimostrando il gravissimo
travisamento delle prove di cui si erano macchiati, rinviando gli atti alla
Corte d’appello per un definitivo pronunciamento di assoluzione”. Che arrivò a
febbraio 2021, a venti anni esatti di distanza dall’inizio della vicenda.
Un’altra storia drammatica è
quella che vi abbiamo raccontato qualche giorno fa e che riguarda Vincenzo
Nespoli, ex sindaco di Afragola e senatore del Pdl dal 2008 al 2013. Ad inizio
ottobre la Cassazione ha annullato con rinvio per la seconda volta la sentenza
di condanna della Corte d’Appello di Napoli nei confronti dell’ex sindaco,
accusato di bancarotta in relazione al fallimento di una società di vigilanza
di Afragola. Processo da rifare, dunque, mentre la carriera politica di Nespoli,
nel frattempo, è naufragata. «Un processo di 15 anni confisca il bene più
importante per un uomo, la progettualità – ha commentato il suo
avvocato Vittorio Manes -. Travolge destini politici, fortune imprenditoriali,
rapporti familiari e sociali». Prima assolto, poi condannato, poi un nuovo
processo d’appello con condanna e infine l’assoluzione in Cassazione.
Si è concluso quest’anno un
incubo per un pensionato residente nella Bassa Reggiana, accusato oltre 11 anni
fa di violenza sessuale per presunte molestie alla nipotina, che all’epoca aveva
7-8 anni. L’anziano aveva scontato anche dei periodi in carcere e agli arresti
domiciliari. Sempre quest’anno e sempre dopo 11 anni l’ex sindaco di
Pagani, Alberico Gambino, è stato assolto pienamente nel processo “Criniera”, il
cui impianto accusatorio si fondava su intrecci tra imprenditori, classe
politica – l’amministrazione retta dall’allora sindaco – e il clan a Pagani.
«Credo che vada fatta una riflessione precisa, visto questo processo così lungo
e due anni – tra domiciliari e carcere – di custodia cautelare, quando Gambino
non era responsabile di niente. La necessità di un’indagine è una necessità
istituzionale, però la vita di un politico è stata fortemente danneggiata e
certe verità obbligano dopo 11 anni una persona a urlare al mondo la propria
innocenza», aveva detto il suo legale Giovanni Annunziata.
Invece ci sono voluti 9 anni
per vedere confermata in appello l’assoluzione di primo grado per l’ex ministro
delle politiche agricole Nunzia De Girolamo e per altri cinque imputati.
L’ipotesi accusatoria era quella di concussione, consumata e tentata,
nell’ambito di una inchiesta partita nel 2013 e relativa all’esistenza di quello
che gli inquirenti all’epoca definirono “un direttorio politico-partitico”che
avrebbe influenzato la gestione dell’Asl sannita. Un mese fa un cinquantenne è
stato assolto dopo 10 anni e quattro gradi di giudizio dalla Corte di appello di
Perugia “perché il fatto non sussiste” dalla pesantissima accusa di aver
violentato le figlie.
A questi casi possiamo
aggiungere altri ancora più sconvolgenti, ossia quando la giustizia arriva dopo
la revisione del processo. Ricordate Hashi Omar Hassan, condannato e poi assolto
per l’omicidio Alpi – Hrovatin e ucciso da una bomba lo scorso luglio
a Mogadiscio? Hassan fu assolto in primo grado, condannato in secondo grado e
in Cassazione per aver fatto parte del commando che uccise i giornalisti
italiani, ma un successivo ricorso portò all’assoluzione dopo oltre 16 anni di
reclusione. Lo Stato Italiano lo ha risarcito con 3 milioni.
E cosa vogliamo dire nel caso
di Angelo Massaro? Ha trascorso in carcere da innocente 21 dei suoi 54 anni, dal
1996 al 2017, accusato dell’omicidio del suo miglior amico. Tutto a causa di
un’intercettazione telefonica trascritta male e interpretata peggio. Ma a
battere ogni record Giuseppe Gulotta che ha trascorso 22 anni, ossia 8030
giorni, in carcere da innocente. Il suo è forse il più grande errore giudiziario
della storia italiana.
L’odissea
dell’innocente che patteggiò per paura: assolta dopo 6 anni.
Dopo 3 mesi di carcere, davanti allo spettro di un lungo processo per
favoreggiamento in omicidio, la donna si arrende, poi il presunto omicida viene
assolto e arriva la revisione della sentenza. Avv. RICCARDO RADI su Il Dubbio il
24 ottobre 2022.
L’intervento che
segue è un ampio estratto dell’articolo pubblicato dall’avvocato Riccardo Radi
sul blog “Terzultima fermata” (terzultimafermatablog8460979 35.wordpress.com/),
lo spazio on line curato dallo stesso Radi insieme con Vincenzo Giglio.
Storia di una
innocente che si dichiara colpevole pur di non avere più nulla a che fare con la
giustizia. Giustizia che non le ha creduto quando lei, l’innocente, raccontava
il vero e che l’ha imprigionata fino a “convincerla” a dire il falso. D’altra
parte, anche un ex ministro della Giustizia dichiarò alla stampa che “gli
innocenti non finiscono in carcere”.
Nella storia che
racconto ci sono due innocenti che finiscono in carcere nello stesso
procedimento per delle accuse infamanti: il primo, accusato dell’omicidio di una
ragazza, si farà 30 mesi di carcerazione preventiva, e la seconda 3 mesi per
favoreggiamento. In tanti “credono” che gli assolti siano persone che la fanno
franca, noi raccontiamo di innocenti che sono stati stritolati dal
sistema giustizia.
Nelle aule dei
Tribunali accade anche che una persona che patteggia la pena, quindi si dichiara
colpevole, venga successivamente assolta perché il fatto non sussiste! Infatti,
parleremo di un caso che nella prassi giudiziaria raramente accade: la revisione
di una sentenza di patteggiamento.
La vicenda ha per
protagonista la signora V.G., una tranquilla badante moldava che viene chiamata
dalla polizia per testimoniare in merito alla presenza nella sua abitazione di
un indagato per omicidio. La signora V.G. ricorda chiaramente la circostanza e
riferisce in maniera dettagliata orari e riferimenti precisi relativi al fatto
che effettivamente il signor A.C. fosse il giorno 1° dicembre del 2008, dalle
ore 10.30 alle ore 16.00, presso la sua abitazione per svolgere un lavoro di
riparazione e per fermarsi poi a mangiare. La Procura della Repubblica di
Roma non le crede, e per ben tre volte la convoca, e sempre più insistentemente
la mette alle strette. Gli inquirenti acquisiscono i tabulati telefonici delle
utenze dell’indagato e della V.G., e raccolgono le dichiarazioni delle altre due
persone che avrebbero dovuto parzialmente riscontrare l’alibi.
Dalla lettura dei
verbali delle testimoni risultano parziali differenze nell’indicazione degli
orari, differenze che però sembrano scaturire dalla non perfetta conoscenza
della lingua italiana. Sia la V.G. che le altre due donne ascoltate non sono
italiane, ma non vengono esaminate in presenza di un interprete perché tutte
dichiarano di parlare e comprendere la lingua italiana. Errore fatale!
L’incalzare delle domande, l’uso di un linguaggio tecnico e il riferimento a
orari scanditi da minuti rendono le dichiarazioni delle tre donne poco lineari e
poco concordanti tra loro. Si arriva alla svolta: la mattina dell’8 ottobre
2010, alle 5.00, la Polizia giudiziaria suona al campanello e notifica una
ordinanza di custodia cautelare per il presunto omicida e per la signora
moldava, accusata di favoreggiamento, ed entrambi vengono trasferiti in carcere.
In sede di interrogatorio di garanzia si dichiarano innocenti, ma non
vengono creduti, in virtù del fatto che i tabulati telefonici dimostrerebbero
che l’omicida si sarebbe trattenuto solo per una ora nell’abitazione. Quindi
avrebbe avuto tutto il tempo per spostarsi e uccidere la giovanissima vittima e
di conseguenza la moldava avrebbe mentito.
Il Tribunale
della Libertà conferma l’ordinanza e la signora V.G dopo 3 mesi di carcerazione
preventiva viene scarcerata per scadenza termini. La Procura della Repubblica
procede alla richiesta di rinvio a giudizio e all’udienza preliminare il
presunto omicida è in stato di detenzione carceraria e la V.G libera con
l’accusa di favoreggiamento. La prospettiva è quella che il processo si svolga
in Corte di Assise, ma dopo tre mesi di carcerazione la prospettiva di subire un
processo lungo e costoso e le ristrettezze economiche, in seguito dell’arresto,
per aver perso il lavoro sono tutti buoni motivi per lasciarsi alle spalle la
triste storia. Davanti al Giudice dell’udienza preliminare di Roma si patteggia
una pena di nove mesi di reclusione, pena sospesa.
La signora VG,
però, non rinuncia a testimoniare nel processo per l’omicidio e grazie al suo
atto di coraggio civico e alle sorprendenti circostanze che in realtà l’attento
esame dei tabulati telefonici confermano l’alibi dell’omicida: la vittima
sarebbe morta per cause naturali. Si i arriva così alla svolta. L’imputato AC
viene assolto perché il fatto non sussiste dopo 2 anni 5 mesi e 7 giorni di
carcerazione preventiva. Per questo orrore giudiziario si riesce a ottenere il
24 gennaio 2017 dalla Corte di appello di Roma il risarcimento di 260mila euro,
ma questa è un’altra storia.
Illustrata la
vicenda ora è necessario entriamo nel particolare della posizione della signora
V. G. La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la
sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di
quest’ultime, alla luce della regola di giudizio posta, per il rito alternativo.
Le nuove prove devono consistere in elementi tali da dimostrare che
l’interessato deve essere prosciolto secondo il parametro di giudizio dell’art.
129 c.p.p., così come applicabile nel patteggiamento. Tale differenza rispetto
ai parametri utilizzati nella revisione delle sentenze “ordinarie” trova la sua
spiegazione nella peculiarità della pronuncia emessa ai sensi dell’art. 444
c.p.p., in cui il controllo giudiziale è appunto limitato ad escludere la
sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Questa regola è
stata ribadita dalla Cassazione – sezione sesta penale – con sentenza n. 25308
del 9 giugno 2015. Per i giudici di piazza Cavour, l’estensione del
rimedio straordinario alla sentenza di patteggiamento, ad opera della L. n. 234
del 2003, risulta notevolmente più contratta rispetto alla revisione
ordinaria. Infatti nel caso delle pronunce ex art. 444 c.p.p., il giudice viene
chiamato a stabilire se le prove sopravvenute alla sentenza definitiva e quelle
scoperte successivamente siano tali da dimostrare “da sole” la necessità di un
proscioglimento oppure se siano autonomamente in grado di gettare una nuova luce
e di fornire una chiave di letture radicalmente alternativa degli atti del
procedimento concluso con il patteggiamento, atti che di per sé non erano tali
da reclamare l’adozione di una pronuncia ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
In caso
contrario, – conclude la Corte – “la revisione cesserebbe di essere un mezzo di
impugnazione straordinaria e diverrebbe, in relazione al patteggiamento,
strumento a disposizione del patteggiante per revocare in dubbio una decisione
da lui stessa richiesta e riaprire integralmente la fase dell’accertamento dei
fatti e della responsabilità” (così, Sez. 6, 24 maggio 2011, n. 31374; Sez. 3
sent. 13032/14 e 23050/13; sez. 4 sent. 26000/13).
Ed ancora più
recentemente, la Cassazione sezione 2 sentenza numero 24365 del 23 giugno 2022,
ha chiarito: “è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di
patteggiamento per inconciliabilità con l’accertamento compiuto in giudizio nei
confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente ma è,
tuttavia, necessario che l’inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a
fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione”.
Principio
ribadito tra le tante da (Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188 –
02; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Rv. 262731 – 01); – in ogni caso, «in tema
di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi
sull’inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a),
cod. proc. pen., il giudizio sull’ammissibilità o meno della domanda di revoca
della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e
comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il
giudice limitarsi a verificare esclusivamente l’irrevocabilità della decisione
che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale
sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna» (Sez. 2, n. 29373 del
18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002 – 01). Nel caso in esame c’è una sentenza
definitiva di assoluzione per l’omicidio che rende inconciliabile la sentenza di
patteggiamento. In base a questo presupposto viene redatta la richiesta di
revisione alla Corte di appello di Perugia che, in data 22 aprile 2016, ha
revocato la sentenza emessa in data 15 luglio 2011 dal Gup di Roma ed ha assolto
la Signora V.G. perché il fatto non sussiste!
Finalmente, dopo
circa 6 anni dall’arresto si arriva a mettere un punto sulla triste storia che
ha segnato in maniera indelebile la Signora VG, la quale ancora oggi non riesce
a parlare della sua odissea. Pochi giorni fa mi ha riferito di avere ancora gli
incubi e di sognare di risvegliarsi in carcere e provare l’umiliazione di non
essere creduta.
Un giudice
emette sentenza senza aver mai ascoltato la difesa. Per il Csm è solo una
marachella.
Per il Csm questa incredibile vicenda non rappresenta la condotta
più grave che un giudice possa assumere, anzi, è una delle meno gravi. Gian
Domenico Caiazza su Il Dubbio il 25 settembre 2022.
Giudice condanna a 11 anni
senza ascoltare l’imputato, il Csm gli dà un buffetto sulla guancia.
Gian Domenico Caiazza su Il Riformista il 25 Settembre 2022
Forse qualcuno
ricorderà la incredibile vicenda accaduta tempo fa al Tribunale di Asti. Si
celebrava un delicato processo di violenza sessuale (di un padre sulla figlia,
con la madre accusata di non averlo impedito). Giunti alla conclusione della
istruttoria dibattimentale, discute il pm, che chiede una pena molto dura;
discutono i due difensori della madre, e si rinvia ad altra udienza per la
discussione del difensore del padre, imputato principale. Discussione che però
non avverrà mai perché alla udienza successiva il Tribunale legge solennemente
il dispositivo di condanna degli imputati ad 11 anni di reclusione. Gli
sbalorditi astanti, compreso lo stesso pm, fanno garbatamente presente al
Presidente che il difensore del secondo (e principale) imputato non aveva mai
discusso. Il Presidente si dice dispiaciuto dell’incidente, accartoccia il
foglio contenente il dispositivo appena pronunciato, e dà la parola al secondo
difensore. Il quale ovviamente si rifiuta, eccependo l’abnormità di quanto
accaduto.
Il Tribunale
deposita egualmente la sentenza, che ovviamente non potrà che essere annullata
dalla Corte di Appello. Insorge la Camera penale del Piemonte occidentale, con
modalità giudicate da Anm e Procuratore Generale, come dire, esagerate: con il
risultato di spostare il focus dalla gravissima, incredibile condotta di quel
Collegio giudicante, al tono ed ai modi della protesta. La vicenda fu segnalata
al Csm, che – apprendiamo oggi da dettagliate notizie di stampa – dopo la
bellezza di oltre due anni e mezzo, ha concluso con la sanzione della censura,
per di più – e qui siamo al mistero più profondo – nei riguardi del solo
Presidente; prosciolte le due giudici a latere.
Non sono ancora
depositate, a quanto pare, le motivazioni della bizzarra (è un eufemismo)
decisione, ma c’è davvero poco da approfondire. La censura è poco più di una
tirata di orecchie, ed è ovvio che la entità della sanzione irrogata fotografa
impietosamente la considerazione che il Csm nutre delle questioni di principio
messe in discussione in quella incredibile vicenda. Nel dare notizia di questo
stupefacente esito, l’articolo viene così titolato: «Sanzionato il giudice che
ha letto la sentenza di condanna prima dell’arringa del difensore»; un titolo
che la dice lunga su quanto sia indietro questo nostro Paese in termini di
comprensione dei principi fondamentali che regolano il processo penale.
Qui non si tratta
di “aver letto la sentenza di condanna prima dell’arringa”; quanto invece del
fatto che tre giudici abbiano potuto ritirarsi in camera di consiglio, discutere
tra di loro della fondatezza della ipotesi accusatoria o invece di quella
difensiva, e deciso la irrogazione della pena di 11 anni di reclusione (undici
anni, dico) senza avere mai ascoltato il difensore (unico difensore, per di più)
dell’imputato principale. Il fatto non può ovviamente avere spiegazioni
alternative all’unica sensata: la totale indifferenza di quel giudice collegiale
alle argomentazioni in difesa di quell’imputato.
Converrete con me
che un giudice che ritenga di pronunziare sentenza nei confronti di un imputato
senza aver ascoltato e vagliato la sua difesa, nega in radice la propria stessa
funzione. Il giudice non è uno sciamano, chiamato ad interpretare il giudizio
divino, ma è un signore il cui compito è esattamente quello di formulare un
giudizio solo all’esito della compiuta espressione delle posizioni contrapposte
tra accusa e difesa. Insomma, non è che si debbano spendere ulteriori argomenti:
si tratta di un fatto di inconcepibile gravità. Che però è stato punito con la
pena della censura, un buffetto sulla guancia. La conseguenza che dobbiamo
trarne è che, per il Consiglio superiore della magistratura, questa non è la
condotta più grave che un giudice possa assumere, anzi, è una delle meno gravi.
Talmente poco grave, da rendere addirittura misteriosamente possibile il
proscioglimento dei due a latere, pur avendo essi partecipato alla camera di
consiglio e deliberato la condanna: come a dire, una marachella del solo
Presidente. È già gravissimo che un fatto di questa enorme gravità possa essere
accaduto in un Tribunale della Repubblica; ma è addirittura desolante ed ancora
più allarmante che il supremo organo di autogoverno della magistratura possa
averlo giudicato alla stregua di un banale incidente professionale. C’è qualcuno
che sappia darci una spiegazione, e soprattutto che senta il bisogno, prima
ancora che il dovere, di farlo?
Intercettato
colloquio tra legale e assistito: finisce tutto nel fascicolo.
Indignazione
nel Foro: i penalisti baresi proclamano una giornata di astensione dalle udienze
per il prossimo 14 ottobre. Giovanni M. Jacobazzi su Il Dubbio il 25 settembre
2022.
«Il momento del
colloquio tra il difensore ed il suo assistito rappresenta quanto di più sacro
ci sia nell’evoluzione del rapporto fiduciario». A dirlo è l’avvocato Guglielmo
Starace, presidente della Camera penale di Bari, commentando con il Dubbio un
increscioso episodio accaduto al collega Nicolò Nono Dachille.
Tutto ha inizio a
febbraio del 2017 durante una perquisizione da parte della Guardia di Finanza
presso una ditta gestita da una cittadina cinese a Casamassima e difesa da Nono
Dachille. La donna è accusata di contraffazione e ricettazione e ha il telefono
intercettato. I finanzieri, in particolare, ipotizzano sia responsabile di un
traffico di calzature sportive griffate con il marchio contraffatto. All’arrivo
dei militari, la donna decide di avvertire subito l’avvocato Nono Dachille,
informandolo di quanto sta accadendo. Terminata l’ispezione, conclusasi con il
sequestro di circa 2000 calzature, l’avvocato chiama a sua volta la propria
assistita, facendosi raccontare nei dettagli come si erano svolte le operazioni.
La telefonata si conclude con un “non ti preoccupare, non succede niente”, e con
l’avvertimento dell’avvocato Nono Dachille che probabilmente i finanzieri
“torneranno con una interprete”.
L’avvocato, poi,
si fa mandare una foto tramite whatsapp delle scarpe sequestrate dai finanzieri.
Questa seconda conversazione, a differenza della prima, viene integralmente
trascritta dagli operanti e finisce nel fascicolo che la scorsa settimana il pm
ha depositato alle parti. «Il fatto che abbiano messo in grassetto le mie frasi
evidenzia la volontà di mettermi in cattiva luce agli occhi del pm, pur in
assenza di qualsiasi rafforzamento dell’ipotetico proposito criminoso già
compiuto», sono state le parole dell’avvocato Nono Dachille.
L’accaduto, come
era prevedile ha suscito grande indignazione nel foro, con la decisione dei
penalisti baresi di indire una giornata di astensione dalle udienze per il
prossimo 14 ottobre. Inoltre, per quella data è stata convocata una assemblea
aperta alla società civile e alle Istituzioni presso il Palazzo di Giustizia
barese per sensibilizzare l’opinione pubblica. “Non c’è alcuna giustificazione
per quanto accaduto, il colloquio non poteva assumere alcuna rilevanza
investigativa”, si legge nella delibera dei penalisti con cui è stata proclamata
l’astensione.
«Il cittadino che
si affida al professionista deve essere libero di potersi fidare e affidare»,
prosegue allora l’avvocato Starace. «Sapere di non poter essere liberi di
parlare riservatamente mina non soltanto il rapporto tra cittadino e
professionista, ma anche quello tra cittadino e Istituzione. È interesse della
collettività pretendere la garanzia di riservatezza delle comunicazioni».
Il tema delle
conversazioni fra indagato e difensore intercettate dagli organi di polizia e
poi finite nel fascicolo processuale è annoso. Nessuna disposizione pare essere
in grado di mettere un freno a questa “pratica”, da sempre vietata espressamente
dal codice. In questo caso le violazioni sono molteplici. Da un lato i
finanzieri che prima hanno ascoltato e poi trascritto integralmente la
telefonata, evidenziando peraltro in grassetto le frasi dell’avvocato,
dall’altro il pm che ha deciso di inserire questa trascrizione nel fascicolo poi
depositato alle parti. Nessun commento, al momento, dagli uffici giudiziari
baresi.
Diritti, difensori e
magistrati. Avvocati sempre più ai margini e magistrati sempre sotto i
riflettori: diritti e tutele sono di troppo…Gennaro
De Falco su Il Riformista il 26 Agosto 2022
Anni fa, quando già mi facevo
molte domande sugli equilibri di potere nel nostro Paese e sull’avvocatura,
rimasi davvero colpito da uno speciale sulla famiglia pubblicato
dal Foglio sulla famiglia Agnelli o meglio sugli eredi dell’avvocato e sulle
loro vite. Si trattava di un servizio talmente interessante che ho conservato
per anni ed anni e che mi ha incuriosito e fatto riflettere davvero molto.
Ebbene nella sterminata genealogia dei discendenti di Gianni Agnelli c’era di
tutto, dentisti, stilisti, registi, artisti vari ma nessuno degli eredi
dell’avvocato era o si è mai fatto chiamare avvocato come lui.
Mi chiesi: ma come mai? Come è
possibile che in ben altri tempi per l’avvocatura nessuno abbia scelto questa
strada anche solo per curare i suoi affari o per tradizione familiare? È vero
Gianni Agnelli non ha mai esercitato ma per tutti era l’avvocato. A dire il vero
io la risposta a questa domanda non la conosco o forse non c’è, magari è solo un
caso oppure magari hanno visto giusto e lungo e compreso esattamente
l’evoluzione della dinamica sociale che ancora non si era profilata del tutto.
Io sono convinto che in un modo o nell’altro la profezia di circa cento anni fa
che vide nel cosiddetto “pericolo giallo”, ovverosia nella Cina il futuro del
mondo si stia avverando. Che c’entra la Cina con l’avvocatura e la sua decadenza
mi chiederete, invece secondo me c’entra e c’entra tantissimo.
In Occidente il cuore della
società è sempre stato l’individuo e quindi, sia pur con delle oscillazioni,
l’avvocato è l’ambasciatore naturale del cittadino nei confronti
dello Stato mentre il giudice è sempre stato solo la parola della legge, il
giudice non parlava mai ascoltava e taceva. Ed infatti, nella storia
dell’Occidente sono rimasti solo gli avvocati non i giudici. Tutti
ricordano Cicerone ma nessuno sa chi fosse il giudice che lo ascoltava, anzi per
la verità un giudice è rimasto nella storia e si chiamava Ponzio Pilato, altri
non ne ricordo o almeno non ne conosco. Mentre da noi l’eroe è o meglio era
l’avvocato, in Cina l’eroe è il giudice, vale a dire il potere. Del resto,
questa rivoluzione copernicana che è avvenuta e sta avvenendo la racconta con
ogni possibile eloquenza il nome delle strade delle nostre città. Sino a pochi
anni fa le strade delle città, soprattutto nei pressi dei tribunali, erano tutte
dedicate agli avvocati, soprattutto penalisti.
Ora non è più così, ora sono
dedicate solo e soltanto ai giudici. Faccio un esempio evidente: il
nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli si trova a Piazza Falcone e Borsellino ma
questa piazza ha assunto questo nome da poco, prima si chiamava Piazza Enrico
Cenni, vale a dire un giurista che lasciò la magistratura per darsi
all’avvocatura, in pratica volle morire avvocato. Quasi tutti i tribunali
d’Italia sono dedicati a Falcone e Borsellino, voglio anche aggiungere
meritatamente, ma ci sono tantissimi avvocati che hanno fatto la stessa fine,
meno clamorosa ma l’hanno fatta lo stesso, e non per difendere, come pure
sarebbe legittimo, giusto e doveroso il loro cliente ma per eseguire deliberati
dei tribunali. Qui non si tratta di fare una gara all’ultima lapide che potrebbe
apparire e certamente sarebbe di pessimo gusto, ma di comprendere la realtà
nelle sue trasformazioni.
A Napoli diversi anni fa
l’avvocato Antonio Metafora venne ucciso per aver eseguito lo sfratto di un
garage ma non mi risulta che gli abbiano mai dedicato nessuna strada e come lui
tanti ed ovunque. A Torino fu ucciso dalle Br Carlo
Casalegno, nel 2015 a Milano uccisero un avvocato addirittura in tribunale. È
vero, sono stati sempre o quasi omicidi singoli e mai stragi, questo è vero, ma
perché gli avvocati uccisi non avevano nessuno che li difendesse o che almeno
provasse a farlo. Se volessi potrei riempire le pagine con i loro nomi che
nessuno conosce ed ancor meno ricorda, ma questo è un aspetto del problema,
certamente il più tragico ed ingiusto ma soltanto un aspetto.
Il nocciolo è la palese
dissimetria che si è creata nella scala di valori della nostra società che si
sta sempre più cinesizzando nelle forme e nei contenuti, ormai anche da noi il
protagonista è sempre e comunque il magistrato e quasi mai l’avvocato, i cui
servizi e la cui esistenza stessa vengono sistematicamente compressi, ostacolati
e negati in ogni modo. E così il legislatore fa passare per razionalizzazione
del sistema il vero e proprio sradicamento dell’avvocatura dal corpo sociale del
Paese rendendo l’esercizio della professione sempre più difficile e costoso.
Insomma, nel mondo di oggi individuo, diritti e tutele sono di troppo. Gennaro
De Falco
A rischio il
patrocinio per i meno abbienti. Lo Stato non paga, a rischio il patrocinio a
spese dello… Stato.
Viviana Lanza su Il Riformista il 23 Ottobre 2022
È sempre una
questione di tempi. Anche quando si parla di patrocinio a spese dello Stato. E
i penalisti di Napoli sono sul piede di guerra. Costretti ad aspettare anni per
vedersi riconosciuto dallo Stato l’onorario per il lavoro svolto, hanno deciso
di proclamare lo stato di agitazione.
La decisione è
stata adottata dalla giunta della Camera penale di Napoli, presieduta
dall’avvocato Marco Campora, dopo le numerosissime segnalazioni arrivate dai
penalisti del foro partenopeo e degli altri fori del Distretto campano per
segnalare l’incresciosa condizione in cui versano il Tribunale e la Corte di
Appello di Napoli in relazione alla liquidazione e all’effettivo versamento
degli onorari relativi al patrocinio a spese dello Stato. «Il tema – si legge
nella delibera della giunta – non è purtroppo nuovo ed è stato più volte oggetto
di serrato confronto con tutti gli organismi e i soggetti competenti. Tuttavia,
la situazione non risulta significativamente modificata (è il caso del
Tribunale) o addirittura risulta peggiorata rispetto agli ultimi anni (come in
Corte di Appello, dove è stato ideato un meccanismo farraginoso ed illogico che
sta esponenzialmente allungando i tempi di liquidazione o ancora peggio presso
il Tribunale di Sorveglianza, dove l’istituto in questione sembra essere stato
di fatto abolito)».
Di qui la
protesta dei penalisti. È bene ricordare che il patrocinio a spese dello Stato
per i cittadini non abbienti rappresenta uno dei capisaldi del giusto
processo ed è uno dei pochi strumenti idonei ad assicurare la democrazia
all’interno del processo penale; senza di esso si rischierebbe una giustizia per
ricchi e una giustizia per poveri, un doppio binario che per certi versi in
qualche caso già esiste e che verrebbe irrimediabilmente accentuato. Gli
avvocati protestano non solo per il quantum delle liquidazioni che, confrontato
con la media europea e con quella di tutti i Tribunali italiani, «appare del
tutto inadeguato e talvolta addirittura irridente», ma protestano soprattutto
per i tempi dei pagamenti.
«Nel Tribunale di
Napoli l’effettiva corresponsione delle somme avviene a distanza di almeno tre
anni dall’emissione del decreto di liquidazione (e talvolta anche a distanza di
tempi ancora più lunghi, visti i ritardi nella emissione dei decreti di
liquidazione da parte di taluni magistrati o nella lavorazione dei fascicoli da
parte di talune cancellerie) – spiegano i penalisti -. In Corte di Appello, a
seguito di “sciagurate” modifiche organizzative, trascorre addirittura almeno un
anno o più esclusivamente solo perché venga emesso il decreto di liquidazione, e
cioè un provvedimento per la cui redazione non occorrono più di cinque minuti.
In Sorveglianza addirittura avviene sovente che anche le istanze di ammissione
al beneficio, presentate dagli Avvocati nell’interesse dei loro assistiti,
giacciono negli uffici, prive di riscontro, anche per un anno o più, comportando
una ancor più grave dilatazione dei termini per poi ambire ad ottenere i
pagamenti».
«Sono tempi
scandalosi – si legge nel documento firmato dalla giunta del
presidente Campora -, non suscettibili di alcuna giustificazione (anche perché
in tutta Italia i tempi sono straordinariamente più celeri rispetto a quelli
del Distretto partenopeo) e che danno luogo, di fatto, sia pur quasi certamente
come conseguenza non voluta, ad una continua, costante ed ininterrotta
violazione dei diritti minimi in danno delle fasce più deboli della popolazione.
Né vale a giustificare tale tempistica la solita ed abusata doglianza in punto
di carenza di personale poiché come detto, a fronte di una pianta organica che
negli ultimi tempi è stata sensibilmente implementata, i tempi delle
liquidazioni sono addirittura aumentati».
Viviana Lanza.
Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è
giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed
economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del
quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il
Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Il Convegno della Camera
Penale di Napoli. Diritto alla difesa, i penalisti: subito riforma per
assicurarlo a chi non può pagare un avvocato.
Riccardo Rossi su Il
Riformista l'8 Luglio 2022
Intervenire al convegno
su “Gratuito patrocinio: il tradimento del patto etico
tra Stato e Avvocato” della Camera Penale di Napoli ha rappresentato l’occasione
per fare il punto su talune contraddizioni che attengono all’applicazione in
Italia degli istituti del patrocinio a spese dello Stato e della difesa
d’ufficio che costituiscono violazioni dei principi del giusto processo e di
uguaglianza tra i cittadini indagati dinanzi alla legge.
L’Associazione dei Difensori
d’Ufficio, sia nella sezione napoletana che a livello nazionale, è
particolarmente sensibile a questo argomento, perché per quanto siano certamente
diversi gli istituti della difesa d’ufficio e del patrocinio a spese dello
Stato, essi sono molto più correlati di quanto si possa pensare. In generale, il
primo momento di contatto ideale tra la difesa d’ufficio e il patrocinio a spese
dello Stato avviene quando l’indagato, ricevuto il primo atto notificatogli
dall’Autorità Giudiziaria nel corso del procedimento penale, non abbia
effettuato la nomina del difensore di fiducia, poiché in tale evenienza – in
ragione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale – gli verrà
assegnato un difensore d’ufficio. Nel 30-40 % di questi casi, infatti, il
difensore designato per legge si sentirà ripetere “avvocato, non ho i soldi per
pagarla”, avviando in questo modo le pratiche affinché l’assistito possa
accedere al c.d. “gratuito patrocinio”.
Può però accadere che il
difensore nominato d’ufficio non riesca in alcun modo a contattare l’indagato,
il quale – pur avvisato e sollecitato – decida di disinteressarsi del processo.
In tal caso, l’avvocato d’ufficio dovrà attivare una procedura di recupero del
credito professionale – con messa in mora, decreto ingiuntivo, precetto,
pignoramento mobiliare o immobiliare – che ritarderà di anni l’effettiva
corresponsione dell’onorario per l’attività difensiva svolta. Il “tradimento del
patto etico tra Stato ed Avvocato” si realizza, dunque, per tutta una serie di
prassi diffuse tra gli uffici giudiziari e previsioni normative che esprimono
null’altro che la volontà del legislatore. Ciò perché, al termine di questo
complesso procedimento, l’art. 116 del T.U. sulle Spese di Giustizia ci dice che
nel momento in cui la persona assistita risulti incapiente si applicano le
liquidazioni del gratuito patrocinio. È qui che si realizza un corto circuito
nel coordinamento con la disciplina della difesa d’ufficio: ed invero, in
quest’ultima ipotesi, il difensore designato per legge non ha accettato
spontaneamente ed a monte di assistere l’indagato/imputato “a spese dello
Stato”, ma si ritrova a subirne comunque la disciplina economica sfavorevole.
Vi è poi da evidenziare anche
l’ostracismo espresso negli anni da quella parte aristocratica della classe
forense. In tal modo, sono stati chiusi gli occhi davanti ad un incremento –
dal 1995 al 2019 – del 1230% delle ammissioni al patrocinio a spese dello Stato.
Numeri elevatissimi davanti ai quali non si possono chiudere gli occhi, poiché
la giustizia sostanziale si fonda su questi numeri. Oltre a impegnarsi al fine
di promuovere la riforma proposta dagli Avvocati Raffaele De Cicco e Alessandro
Amodio che consenta di equiparare le tempistiche delle liquidazioni dei
difensori a quelli degli ausiliari dei magistrati è stata evidenziata
dall’On. Del Mastro l’assurdità di prevedere, per ciascun tribunale d’Italia, un
diverso protocollo d’intesa per le liquidazioni, che portano – per la stessa
attività – a vedere le liquidazioni tra, ad esempio, Bari e Napoli decisamente
diverse. L’effettività della difesa, soprattutto per i non abbienti, non può
prescindere dal giusto e tempestivo compenso dei professionisti protagonisti del
processo. Riccardo Rossi
Condizionatori rotti nel
tribunale di Napoli. Magistrati e avvocati: «Così non si può lavorare».
L'Anm del distretto
di Napoli e le Camere penali denunciano la "situazione invivibile" a cui sono
sottoposti da giorni. Il Dubbio il 7 giugno 2022.
Condizioni di lavoro
«insostenibili» negli edifici del Palazzo di Giustizia di Napoli a causa del
guasto ai condizionatori. A denunciarlo è la Giunta esecutiva sezionale dell’Anm
del Distretto di Napoli, presieduta da Pina D’Inverno, secondo cui «il guasto ai
condizionatori negli edifici del Nuovo Palazzo di Giustizia del Centro
direzionale “Alessandro Criscuolo” sta rendendo insostenibili, complici le
altissime temperature del periodo, le condizioni di lavoro di tutti gli addetti
al servizio giustizia, non solo magistrati ed amministrativi, ma anche avvocati,
parti, testimoni impegnati nelle quotidiane attività d’udienza».
«Tenuto conto della
comunicazione pervenute di recente, secondo cui il guasto al sistema di
condizionamento non si risolverà che entro l’11-12 giugno 2022 – prosegue la
nota – la Ges dell’Anm del Distretto di Napoli s’impegna, sin d’ora, a
denunziare pubblicamente e nell’interesse di tutti gli utenti del Nuovo Palazzo
di Giustizia, con il coinvolgimento degli organi di stampa e dell’Asl
competente, la difficile situazione venutasi a creare».
Ad denunciare la «situazione
di straordinaria difficoltà» è anche la Giunta della Camera penale di Napoli,
che condivide in pieno il documento dell’Anm. E sottolinea che le
caratteristiche strutturali del Palazzo di Giustizia napoletano rende l’assenza
dell’aria condizionata «invivibili, determinando un gravissimo disagio (se non
una vera e propria sofferenza fisica) per tutti gli operatori e per l’utenza».
«Risulta assai grave e poco dignitoso – prosegue la nota – che in un Tribunale –
frequentatissimo e sede di centinaia di processi al giorno – occorrano settimane
per riparare un guasto». I penalisti sottolineano che il Tribunale dovrebbe
essere un luogo di accoglienza, e «invece si è trasformato in un luogo di
incuria e disinteresse nei confronti delle centinaia di cittadini che
quotidianamente si relazionano, a diverso titolo, con la giustizia».
«Il senso di sfiducia –
conclude la nota -, e talvolta di frontale disapprovazione, che un numero sempre
più crescente di cittadini nutre nei confronti delle modalità attraverso cui
viene amministrata la giustizia ha certamente ragioni serie, profonde e
stratificatesi negli anni ma è anche figlio del disastro strutturale ed
organizzativo in cui versano molti tribunali italiani».
«Nel Tribunale di Taranto
stanze come fornaci»: protestano i lavoratori.
I sindacati denunciano:
climatizzatori rotti e bagni fuori servizio. Redazione online su La Gazzetta del
Mezzogiorno il 07 Giugno 2022.
I dipendenti del Tribunale a
Taranto protestano per i disagi causati dai climatizzatori rotti a fronte di
temperature elevatissime che trasformano le stanze degli uffici in una sorta di
fornaci. E’ quanto denunciano i sindacati FP Cgil, Uilpa, Usb, Flp e Unsa, che
hanno organizzato, insieme alle Rsu, per giovedì 9 giugno, dalle 9 alle 12,
un’assemblea nell’androne di Palazzo di Giustizia.
«Ad oggi - sottolineano - le
temperature esterne già compromettono la capacità di lavorare in un clima
adeguato alla normativa sulla sicurezza (7 gradi di differenza dalla temperatura
esterna). Ancora una volta, non funziona alcuno strumento di refrigerazione e
ciò determina vere e proprie temperature tropicali all’interno delle stanze,
assolutamente inadeguate non solo per lavorare, ama anche solo per sostare».
Evidentemente, attaccano le
organizzazioni sindacali, «per i lavoratori della giustizia non valgono le
stesse regole valide per gli altri lavoratori. I loro doveri sono immediatamente
esigibili, ma non anche i loro diritti, come quello basilare a lavorare in
condizioni conformi alla normativa e dignitose. Questo vale anche per tanti
operatori della Giustizia che frequentano il Palazzo di Giustizia (avvocati e
cittadini), anch’essi costretti a vivere in condizioni inaccettabili».
A rendere «ancora più
inaccettabile il tutto - concludono i sindacati - è la condizione di fatiscenza
dei servizi igienici per lavoratori ed utenti. Infatti, nonostante giungano
rassicurazioni circa lavori per il potenziamento degli stessi, di fatto
aumentano i “fuori servizio” degli attuali e quei poco funzionanti sono pervasi
da odori nauseabondi».
«Altro che dai giudici: i
pm vanno separati dalla polizia giudiziaria…».
Intervista al consigliere
laico del Csm, eletto in Parlamento con la Lega. «Grave danno d'immagine per la
magistratura la vicenda dell'hotel Champagne. E Gratteri era il candidato
migliore per la Dna». Giovanni M. Jacobazzi su Il Dubbio il 15 giugno 2022.
«Penso che sia giunto il
momento per una seria riflessione sui rapporti e sui legami che si creano fra
pubblici ministeri e polizia giudiziaria. È un argomento troppo spesso
sottovalutato ma che invece avrebbe bisogno di un serio approfondimento». A
dirlo è l’avvocato Stefano Cavanna, attuale componente del Consiglio superiore
della magistratura. Prima di essere eletto nel 2018 al Csm in quota Lega,
Cavanna svolgeva la professione forense a Genova, occupandosi principalmente di
diritto societario, commerciale e del brokeraggio assicurativo.
Consigliere Cavanna, perché è
importante affrontare il tema dei legami che si instaurano fra pm e pg?
Guardi, da molto tempo ci si
concentra quasi esclusivamente sui rapporti fra pm e giudice. Si dice spesso che
la comune appartenenza allo stesso ordine giudiziario determini un possibile
condizionamento reciproco. E dunque il pm, pur essendo parte del processo come
l’avvocato, non verrebbe messo dal giudice sullo stesso piano. Io personalmente
ritengo che le criticità ci siano fra pm e pg. È storia degli ultimi anni: si
creano dei legami fra pm e pg che vanno avanti per tutta la carriera di
entrambi.
Cerchiamo di spiegare bene.
Senza ovviamente fare
riferimento a casi specifici, ci sono pm che hanno una polizia giudiziaria di
riferimento. Possono essere carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato,
non fa differenza. Sono rapporti che si consolidano nel tempo. Un procuratore,
ad esempio, può fare domanda di trasferimento per ricoprire lo stesso incarico
in un’altra città. E anche il comandante del reparto di pg può essere trasferito
e raggiungere la città dove il magistrato con cui lavorava è diventato
procuratore. È innegabile che si possano allora creare dinamiche molto
particolari.
Sarebbero le “cordate” di cui
parla il dottor Nino Di Matteo nel suo libro?
Il termine “cordate” rende
bene il concetto.
Comunque, per la cronaca,
anche il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, il consigliere di
Cassazione Giuseppe Santalucia, in una recente intervista ha fatto cenno alle
“cordate” che si creano al di fuori delle correnti.
Ripeto, io credo che il vero
punto sensibile sia quello.
Parliamo di referendum sulla
giustizia. Un flop annunciato?
Avevo delle perplessità sui
quesiti proposti, come quello sulla separazione delle funzioni.
Io credo al contrario che si
debbano incentivare i passaggi tra una funzione e l’altra. Si potrebbe pensare
un meccanismo che preveda, dopo un determinato periodo, un cambio di funzioni.
Una “rotazione”?
Sì. La rotazione degli
incarichi è apprezzabile anche in chiave anti “cordate”. Da pm a giudice. Senza
pg.
Le nomine al Csm sono da
sempre terreno di scontro. Cosa può dire?
Eh già. I cv dei candidati si
equivalgono tutti. Sono sempre eccellenti. Diventa così molto difficile fare una
scelta. Io alcune volte mi astengo perché ho forti dubbi sul modo in cui sono
state attribuite queste valutazioni eccelse.
Qui entrano in gioco le
correnti della magistratura e la loro capacità di condizionamento…
Senza girarci tanto intorno,
le correnti sono diventate dei centri di potere. Sono ormai delle associazioni
dove ci si aiuta e si viene incontro alle esigenze dell’amico collega.
Come ci sente ad essere un
componente del Csm?
Indubbiamente il consigliere
laico parte penalizzato. Il togato sa come muoversi, conosce l’ambiente, ci sono
i suoi colleghi. I magistrati poi non solo al Csm ma anche al ministero della
Giustizia. Ed hanno un grande peso.
La consiliatura sta finendo.
Ha qualche rammarico?
Premesso che i problemi della
magistratura non si risolvono dall’oggi al domani, a me sarebbe piaciuto girare
per gli uffici giudiziari per capire le varie realtà sui territori. Però è
arrivato il Covid ed ha bloccato tutto.
Lei va spesso in minoranza in
Plenum. Penso alla nomina di Carlo Renoldi al Dap, a quella di Giovanni Melillo
a nuovo capo della Dna, all’archiviazione della pratica di incompatibilità
ambientale per la giudice di Cassazione Donatella Ferranti.
Resto convinto delle mie
scelte. Renoldi per le sue opinioni sul carcere era una figura divisiva, le
costanti interlocuzioni di Ferranti con Luca Palamara hanno fatto tornare alla
mente le vicende dell’hotel Champagne che determinarono un grave danno
all’immagine della magistratura, e Nicola Gratteri, il procuratore di Catanzaro,
era il candidato migliore quell’incarico. Non ho cambiato idea su nessuna di
queste pratiche e resto fermamente convinto delle scelte fatte.
La legge ha rotto il
giocattolo. Giornalisti nel panico: la presunzione di innocenza ha fatto sparire
le fughe di notizie.
Alberto Cisterna su Il Riformista il 7 Giugno 2022.
È pieno di orfani e vedove
inconsolabili il cimitero delle fughe di notizie. Le norme sulla presunzione di
innocenza stanno facendo strage di un certo giornalismo di cui francamente non
si avvertiva alcuna necessità e che, sotto l’ombrello della libertà di stampa,
ha consumato anche innumerevoli misfatti negli ultimi decenni. Un modello
vincente di magistratura e un assetto in modalità combat della carta stampata
sono stati i pilastri per la costruzione di un potere separato e distinto da
quelli da cui pur legittimamente provengono. Terzo e quarto potere, troppo
volte, hanno dato vita a un ibrido pericoloso, tentacolare, sottratto a
qualunque controllo ed esentato (dai medesimi magistrati) da ogni
responsabilità. Un’alleanza insana che ha portato vantaggi enormi a entrambi i
protagonisti dell’incestuoso connubio.
Basterebbe scrutare le
redazioni di importanti quotidiani o settimanali per accorgersi quali vantaggi e
quali carriere sono stati assicurati a giornalisti che hanno avuto quale
esclusivo merito, o quasi, quello di avere buoni agganci nei piani alti della
giustizia inquirente. Né è da pensare che editori, sempre in mezzo a pasticci
giudiziari, non abbiano avuto un occhio benevolo verso questa modalità
dell’informazione. Fare scoop giudiziari al tempo stesso comportava la creazione
di interlocuzioni privilegiate con i mastini delle procure della Repubblica,
rapporti che alla bisogna potevano rivelarsi – come dire – preziosi agli occhi
di direttori compiacenti ed editori in fibrillazione. Senza contare che, qua e
là, qualche benefit ulteriore non è mancato per qualche cronista approfittando
degli attacchi di collera di qualche boss, della solita notizia riservata
portata dai soliti servizi, di qualche intercettazione “addomesticata” per far
apparire vulnerabile e minacciato il cronista di turno, del verbo di qualche
pentito più disponibile.
Un mondo opaco, con poche luci
che si è praticamente alimentato a spese della vita e della dignità di migliaia
di cittadini additati come mostri e sbattuti in prima pagina. Senza che mai una
volta un’indagine, guarda caso, scoprisse un colpevole. Persino di fronte
all’evidenza si sono coperte nefandezze e seppellite conclamate violazioni del
segreto istruttorio, senza che (si badi bene) sia mai esistita alcuna congiura o
alcun complotto come pensano ancora le più sprovvedute tra le vittime. Il
sistema si autoproteggeva spontaneamente nella convinzione che le fughe di
notizie fossero un male necessario da far pagare al malcapitato di turno in nome
del supremo interesse della corporazione a poter agire a mani libere e con il
maggiore consenso sociale possibile. Poi la legge sulla presunzione di
innocenza ha rotto il giocattolo e la riforma Cartabia – prevedendo un apposito
illecito disciplinare per chi viola il dovere di comunicare con la stampa solo
con apposite conferenze – hanno praticamente innalzato una diga che sta
prosciugando il lago salmastro e melmoso di un certo giornalismo.
Non passa giorno senza che si
elemosinino interviste, dichiarazioni, attestati, si lancino moniti contro la
folle compromissione della libertà di stampa che il nuovo corso starebbe
imprimendo al mondo della giustizia e della informazione. Si prefigurano
sciagure inenarrabili, con una pubblica opinione resa sorda e cieca dal silenzio
dei magistrati sulle indagini in corso. Si dirà: ma le norme non impediranno i
soliti commerci di file e verbali consegnati a mano o con accorgimenti
telematici da narcos. È vero, ma il rischio che il procuratore incappi in
qualche impiccio disciplinare è ora enorme e l’aria è cambiata anche tra le
toghe, in gran parte stufe del fango arrivato loro addosso per la spregiudicata
ambizione di pochi. Si dirà: ma allora sarà la polizia giudiziaria ad alimentare
il mercato nero degli scoop. Anche questo è un errore. Quasi mai, a dir poco, le
carte ai giornalisti sono arrivate da poliziotti e carabinieri. Una maggiore
esposizione alle indagini, verifiche gerarchiche al proprio interno e uno stile
diverso, a dire il vero, hanno quasi sempre tenuto fuori la polizia giudiziaria
da questo circuito.
Tranne, è pur vero, i pochi
casi di cooptazione e integrazione operativa tra pubblici ministeri,
giornalisti e poliziotti che costituiscono uno dei più pericolosi vulnus con cui
la democrazia di questo paese si sia dovuta confrontare e sul quale ancora
scarsa è l’attenzione della politica. Debellare questi grumi opachi sarebbe di
fondamentale importanza per dare trasparenza alla giustizia penale italiana,
soprattutto impedendo che procuratori, in nome del “fare squadra”, si portino
dietro come salmerie uomini di polizia di propria fiducia e ai propri esclusivi
ordini. La questione coinvolge, in primo luogo, le responsabilità del ministero
dell’Interno che dovrebbe impedire alle singole forze di polizia di cedere alle
richieste dei procuratori e, anche questa volta, una bella norma disciplinare
per i magistrati varrebbe più di molte leggi e circolari.
La legge sulla tutela della
presunzione di innocenza e le sue imminenti ricadute disciplinari stanno
sconvolgendo un mondo la cui reazione non si sta facendo attendere e che non
mancherà nei giorni a venire. Certo qualcuno dovrebbe spiegare perché chiudere i
rubinetti delle fughe di notizie e serrare i ranghi delle corride mediatiche
leda o metta in pericolo l’autonomia del pubblico ministero o dell’intera
magistratura italiana. Non dovrebbe essere esattamente l’opposto, viene da
chiedersi.
Ma intanto, come è noto, la
gallina che canta…Alberto Cisterna
Procura e
organi di stampa, come cambia la disciplina dei rapporti: tutte le regole nel
dettaglio.
Libero Quotidiano il 31 maggio 2022
Aggiornata la
disciplina dei rapporti degli Uffici di Procura con gli organi di stampa. La
normativa in esame, nel recepire le disposizioni della direttiva 2016/343 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2016 in materia di presunzione
di innocenza, regolamenta nel dettaglio le modalità con cui possono essere
riferite agli organi di stampa le informazioni relative ai procedimenti penali e
agli atti di indagine compiuti.
Nel dettaglio:
-la diffusione
di informazioni sui procedimenti penali può avvenire esclusivamente tramite
comunicati ufficiali, oppure nei casi di particolare rilevanza pubblica dei
fatti, tramite conferenza stampa
-la diffusione
delle medesime informazioni è consentita solo quando è strettamente necessaria
per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni
di interesse pubblico
-la comunicazione
può avvenire a mezzo comunicato stampa o conferenza stampa ad opera del
Procuratore della Repubblica, in tale ipotesi, solo la conferenza stampa deve
essere preceduta da un provvedimento motivato in cui viene dato atto delle
specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la divulgazione delle
informazioni
-la Polizia
Giudiziaria può fornire informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali
ha partecipato, compresi gli arresti in flagranza, con entrambi i mezzi, ma
sempre previa autorizzazione motivata del Procuratore della Repubblica
-le comunicazioni
in qualunque forma vengano effettuate, devono sempre essere corrette,
imparziali, rispettose della dignità della persona e devono chiarire la fase in
cui il procedimento pende e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona
sottoposta alle indagini e dell’imputato a non essere indicati colpevoli fino a
quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale
passati in giudicato
-resta fermo il
divieto di diffondere immagini o fotografie di persone in manette, di pubblicare
l’immagine e le generalità dei minori e vanno adottate tutte le misure utili ad
evitare l’ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive
della dignità e della riservatezza delle persone offese.
Il pm dispone, il gip
“esegue”: uno studio dice che è lo standard.
Ecco i risultati dell'approfondimento fatto a Brescia dalla Camera penale in
collaborazione con i vertici di procura e Tribunale. Ma negli altri uffici
giudiziari il dato rimane un mistero: impossibile calcolare il grado di
appiattimento del giudice sulle richieste di misura cautelare. L'Ucpi: ora si
cambi. Giovanni M. Jacobazzi su Il Dubbio il 28 maggio 2022.
«Purtroppo quanto affermato
dal presidente delle Camere penali, il collega Gian Domenico Caiazza è la triste
realtà: è praticamente impossibile avere il dato relativo alle percentuali di
accoglimento delle richieste dei pm di applicazione delle varie misure cautelari
da parte dei gip». Ad affermarlo è l’avvocato Andrea Cavaliere, presidente della
Camera penale di Brescia, che la scorsa settimana ha affrontato il tema della
“cultura del dato” nel corso di una tavola rotonda alla presenza anche dei
vertici degli uffici giudiziari della città lombarda.
Durante l’incontro sono stati
resi noti i risultati di una ricerca condotta, come è stato sottolineato, in
modo empirico e senza alcuna pretesa di scientificità da parte dei penalisti e
finalizzata ad avere una indicazione di massima della situazione relativa al
numero di richieste di misura cautelare avanzate e poi accolte a Brescia nel
corso del 2021. La ricerca ha evidenziato quello che tutti sospettavano: l’alta
percentuale di ordinanze di accoglimento dei gip rispetto alle richieste dei pm,
pari quasi al novanta per cento.
«Questo dato deve essere
valutato con estrema attenzione – puntualizza però Cavaliere – perché i sistemi
informatici, al momento, non consentono di distinguere le ordinanze di convalida
degli arresti in flagranza dalle ordinanze che decidono su richieste di
applicazione di misura cautelare». In altri termini, prosegue il penalista
bresciano, «il dato non è sufficientemente attendibile per essere oggetto di una
seria discussione e, tra l’altro, può essere interpretato in modi diametralmente
opposti: da un lato l’avvocatura potrebbe evidenziare un pericoloso
“appiattimento” del gip sulle posizioni del pm, ma dall’altro la stessa Procura
potrebbe replicare – forse senza troppa convinzione – che l’alta percentuale di
accoglimenti è la prova della serietà del lavoro dei pm e del fatto che le
richieste di applicazione delle misure cautelari vengono avanzate solo quando
sono effettivamente necessarie».
Circa la disponibilità di
informazioni, invece, il «caso Brescia» è la classica eccezione che conferma la
regola esposta nell’intervento del presidente dell’Upi Caiazza. «A Brescia –
puntualizza Cavaliere – solo in virtù di una disponibilità particolare del
procuratore della Repubblica, del coordinatore dell’Ufficio gip nonché del
presidente del Tribunale e soprattutto del presidente della Corte d’appello
Claudio Castelli, questi dati sono stati resi ostensibili a noi avvocati: nella
maggior parte degli altri Uffici giudiziari italiani ciò non avviene. Come
mai?».
La difficoltà di accedere a
queste informazioni era stata stigmatizza dei penalisti, che tramite il loro
Osservatorio stanno cercando in tutti i modi da anni di conoscere quante volte
vengono accolte dal gip le misure cautelari e i sequestri richiesti dal pm. Ad
oggi, infatti, il dato non è disponibile né al ministero della Giustizia né al
Consiglio superiore della magistratura, in quanto non oggetto di apposito
censimento. Tale circostanza non può non riportare l’attenzione di tutti gli
operatori del diritto sull’annoso e mai risolto problema di ottenere questo
genere di informazioni statistiche dai sistemi informatici delle Procure.
Spesso, come da più parti
evidenziato, anche per un evidente atteggiamento di chiusura degli uffici
giudiziari ad aderire a richieste di accesso presentate da soggetti esterni.
«Il mio augurio – aggiunge
Cavaliere – è che tale situazione sia destinata finalmente a migliorare alla
luce delle importanti affermazioni che la ministra della Giustizia Marta
Cartabia ha esposto al Parlamento in occasione della sua relazione annuale lo
scorso gennaio, parlando dell’importanza di sviluppare proprio la cultura del
dato. Credo sia importante potere accedere direttamente alle stime di tutti i
servizi connessi all’amministrazione della giustizia, anche a quelli raccolti
dai vari uffici giudiziari», conclude quindi il presidente della Camera penale
di Brescia, ricordando comunque che «la fruibilità dei dati dovrà sempre
avvenire nel pieno rispetto, ovviamente, delle esigenze della riservatezza delle
indagini e della tutela delle norme sulla privacy».
Insulti agli
avvocati, il paradosso Facebook: per chi denuncia scatta la censura.
La
piattaforma ha deciso di cancellare il post nel quale si riportava la notizia
perché viola gli standard interni. Valentina Stella su su Il Dubbio l'1 giugno
2022.
Oggi vi abbiamo
dato una notizia arrivata da Viterbo: alcuni leoni da tastiera avevano rivolto
nel 2019, commentando su Facebook post di TusciaWeb e Tgcom24, messaggi del tipo
«Spero che stuprino le mogli degli avvocati –Avvocati di merda papponi – Dico a
giudici e avvocati vi auguro di cuore che possa capitare ai vostri cari di fare
la fine delle migliaia di ragazze violentate.. e perché no uccise…ve lo auguro
proprio» a tre legali della Camera penale locale, colpevoli, a loro dire, di
aver assistito due giovani ex militanti di CasaPound arrestati per lo stupro ai
danni di una 37enne.
Vi abbiamo
raccontato che il presidente dei penalisti viterbesi ha presentato una denuncia
alla Procura ipotizzando il reato di diffamazione aggravata ma il pm ha
richiesto l’archiviazione con la seguente motivazione «Si ritiene che il
contenuto dei commenti costituisca manifestazione del tutto legittima
dell’esercizio di critica». La Camera penale si è opposta: udienza 8 giugno
dinanzi al gip.
Ma sapete qual è
il paradosso? Abbiamo diffuso su Facebook il link alla notizia, inserendo nel
sommario le minacce degli hater per attirare i nostri lettori su un tema
particolarmente sensibile per l’avvocatura. E sapete cosa ha fatto la
piattaforma social gestita da Meta? Ha cancellato il nostro post perché
violerebbe gli standard interni.
Tre sono le
considerazioni da fare:
Facebook ha un
algoritmo alquanto ottuso perché non riesce a distinguere l’offesa vera e
propria da una notizia giornalistica;
Lo stesso
Facebook ha lasciato visibili per giorni quegli stessi commenti che abbiamo
riportato noi, mentre a noi ci ha censurati dopo 4 ore;
Non sarebbe il
caso di interrogarci sulla relatività degli standard? Per una Procura quelle
parole ricadrebbero nel diritto di critica, per il social network sono da
censurare.
Insulti e
minacce ai legali, ma per il pm non c’è reato.
Haters contro tre
penalisti che difeso due giovani accusati di stupro. La procura: è libertà di
critica. Ma la Camera penale di Viterbo dice no all’archiviazione. Valentina
Stella su Il Dubbio l'1 giugno 2022.
«Spero che
stuprino le mogli degli avvocati – Voi dovete finire in carcere insieme a loro
finché non morite – Vorrei vedere se si tratta della figlia del giudice e del
avocato!!! Fate solo schifo e questo ti porta a fare giustizia da soli – Quando
è evidente che gli avvocati fanno largo abuso di droghe…in galera anche voi –
Questi avvocati vanno condannati sono tutti venduti – Avvocati di merda papponi
– Dico a giudici e avvocati vi auguro di cuore che possa capitare ai vostri cari
di fare la fine delle migliaia di ragazze violentate..e perché no uccise…ve lo
auguro proprio»: questi allucinanti e gravemente minacciosi messaggi, che vi
abbiamo riportato nell’originale italiano stentato, sono solo una minima parte
di quelli apparsi nel 2019 tra i commenti delle pagine Facebook delle testate
TusciaWeb e Tgcom24.
Gli odiatori
social avevano nel mirino tre avvocati di Viterbo – Domenico Gorziglia, Marco
Valerio Mazzatosta, Giovani Labate – colpevoli, a loro dire, di assistere due
giovani ex militanti di CasaPound arrestati nell’aprile del 2019 per lo stupro
ai danni di una 37enne, avvenuto in un pub del capoluogo laziale. I due,
usufruendo del rito abbreviato, sono stati condannati in via definitiva uno a 2
anni e 10 mesi, l’altro a 3 anni. Ma non è questo il punto. La questione
riguarda l’immagine falsata che molte persone hanno del ruolo dell’avvocato.
L’assimilazione tra l’avvocato e il suo assistito è una delle tante distorsioni
che intaccano il ruolo del difensore nella società. Eppure come aveva scritto
Ettore Randazzo in ”L’avvocato e la verità” (Sellerio Editore Palermo), «solo i
nemici della democrazia e della libertà possono temere l’avvocatura». Sempre di
più in questi anni stiamo assistendo a vari tipi di attacchi verso coloro che
esercitano un diritto costituzionalmente garantito.
Dinanzi a questo
scenario, cosa fare? Per i fatti di Viterbo, prontamente il presidente della
Camera penale viterbese, Roberto Alabiso, presentò una denuncia querela,
ipotizzando il reato di diffamazione aggravata presso la Procura della
Repubblica, «a tutela della immagine personale e professionale non solo dei
colleghi interessati al procedimento penale sopra accennato, ma anche e
soprattutto per dare forza e dignità alla professione forense che nonostante il
dettato costituzionale continua ad essere percepita come una sorta di
“complicità” con gli assistiti» . L’avvocato Alabiso, nel suo esposto, aveva
anche ricordato che la Cassazione con sentenza n.40083 del 6/9/2018 ha stabilito
che «il profilo social dell’utente è luogo virtuale e la pubblicazione di
commenti offensivi sulla bacheca Facebook costituisce una forma diffamatoria di
comunicazione con più persone».
Nonostante tutto
questo, nel maggio 2020 la Procura di Viterbo ha fatto richiesta di
archiviazione: «Si ritiene che il contenuto dei commenti costituisca
manifestazione del tutto legittima dell’esercizio di critica, espressa, seppur
con linguaggio e con toni aspri e polemici, a tratti utilizzando termini con
accezioni indubitabilmente offensive, senza trasmodare nella immotivata
aggressione ad hominem, potendo, le medesime critiche, dirsi ampiamente
ricomprese entro i limiti di operatività della scriminante del diritto di
critica».Quindi augurare stupri e morti ai parenti degli avvocati rientra del
diritto di critica? Permetteteci di sollevare qualche dubbio, crediamo
legittimo. Il presidente Alabiso, comunque, non demorde e presenta opposizione
alla richiesta di archiviazione, scrivendo, tra l’altro, che «la sensazione
sgradevole che si prova leggendo le motivazioni della richiesta di archiviazione
è che la pm procedente si sia “adagiata” sul malcostume imperante tra giovani e
meno giovani, di utilizzare espressioni fuori da ogni decente consesso civile».
Inoltre,
sottolinea il penalista, «consentire a chi ha indirizzato ingiurie, minacce e
quant’altro, di superare indenne una situazione che, invece, andrebbe certamente
sanzionata ed evidenziata come rimarchevole, volgare ed inaccettabile
costituisce a parere di chi scrive una ulteriore beffa per tutti coloro i quali,
come previsto dalla nostra Costituzione, si adoperano per il rispetto delle
leggi, che non significa salvare chi ha commesso reati, ma al contrario vuol
dire che ciascuno di noi merita un’adeguata difesa dal punto di vista tecnico,
senza alcun coinvolgimento personale».
Come andrà a
finire lo si capirà l’8 giugno: l’avvocato del foro di Civitavecchia, Andrea
Miroli, sosterrà le ragioni della Camera penale di Viterbo per opporsi
all’archiviazione. A decidere sarà il gip che potrebbe ricordarsi che questi
attacchi ormai non riguardano solo gli avvocati ma anche gli stessi giudici,
sempre più spesso finiti nel mirino quando scarcerano, derubricano o assolvono.
Si tratta di una battaglia di civiltà che dovrebbe vedere uniti avvocatura e
magistratura.
L’imputato è al funerale
del padre, ma per il tribunale non è legittimo impedimento.
L'incredibile caso a Vercelli.
Rifiutata la richiesta, l'uomo ha impugnato la sentenza di condanna in appello e
in Cassazione. Che però ha dato ragione al tribunale. Gennaro Grimolizzi su Il
Dubbio il 27 maggio 2022.
Udienza penale e funerale di
uno stretto congiunto possono essere compatibili. Il caso riguarda una persona
sotto processo a Vercelli, che ha chiesto di partecipare ai funerali del padre e
presentato, tramite il suo avvocato, istanza di legittimo impedimento. Di fronte
alle norme, però, neppure una dolorosa vicenda personale può rendere meno rigidi
i giudici. È l’amara constatazione alla quale si giunge prendendo in
considerazione quanto accaduto in Piemonte. Il Tribunale di Vercelli è andato
avanti spedito senza tener conto dell’istanza di legittimo impedimento
dell’imputato, che però ha impugnato la sentenza di condanna davanti alla Corte
di appello di Torino per poi giungere pure in Cassazione. Quest’ultima ha
confermato quanto stabilito dal Tribunale, ma ha rivisto il trattamento
sanzionatorio.
I giudici di secondo grado
hanno preso in considerazione le due diverse esigenze dell’imputato, vale a dire
l’orario di celebrazione del processo e quello dei funerali del padre, e hanno
considerato l’impedimento non assoluto, riconoscendo comunque che lo stato
emotivo dell’imputato può essere stato condizionato. Un’analisi fredda, scandita
dall’incrocio dei dati – l’ora dell’udienza e quella di un evento tanto triste
quanto intimo -, con la considerazione della «correttezza della decisione del
Tribunale, sebbene indicativa di una modesta sensibilità dei componenti del
collegio, che avrebbero potuto acconsentire ad un rinvio del processo». La
difesa non ha mollato e ha chiesto l’intervento della Corte di Cassazione,
ponendo l’accento sul coinvolgimento emotivo della persona imputata, in procinto
di essere ascoltata in udienza (decisiva per le sorti del processo) e in uno
stato emotivo alterato, considerata la concomitanza del funerale del padre. Poco
più di una settimana fa la sentenza della Suprema Corte (la numero 19678 del 19
maggio). I legali del condannato hanno insistito sulla contraddittorietà della
motivazione della Corte d’appello, che nel sottolineare la non assolutezza del
dedotto impedimento ha, comunque, condiviso la tesi della mancanza di lucidità
del ricorrente tale da giustificare una richiesta di rinvio del suo esame.
Qual è stata la strada seguita
dalla Cassazione per giungere alle sue conclusioni? I giudici di Piazza Cavour
hanno preliminarmente evidenziato che nell’atto di appello la difesa aveva
impugnato la sentenza di primo grado anche in merito al rigetto della richiesta
di differimento del processo, avanzata dal ricorrente per l’udienza del giorno
in cui doveva celebrarsi il funerale del padre. In Corte d’appello il
ragionamento dei giudici si è basato sugli orari. È stata affermata la natura
non assoluta dell’impedimento, dato che il funerale del padre dell’imputato si
sarebbe celebrato a Garbagnate Milanese nel primo pomeriggio (alle 14.30),
mentre il processo ha avuto inizio davanti al Tribunale di Vercelli alle 9.43 e
si è concluso alle 11.08 con la lettura del dispositivo.
I giudici di secondo grado
hanno evidenziato che «l’imputato avrebbe avuto modo di presenziare tanto
all’udienza (eventualmente chiedendo un rinvio per rendere l’esame
dibattimentale ove fosse stato in condizioni emotive tali da non riuscire a
difendersi adeguatamente), quanto al funerale del proprio padre, previsto per le
ore 14,30 del pomeriggio», confermando la correttezza della decisione del
Tribunale. Se l’impedimento non è assoluto, dunque, il processo si celebra e in
udienza si deve andare. Inoltre, è stato sostenuto che «il difensore non aveva
dedotto un impedimento assoluto ed effettivo dell’imputato, poiché l’udienza e
il funerale non si sovrapponevano tra loro». Il carattere non assoluto
dell’impossibilità dell’imputato di essere presente in udienza era collegato non
alla natura dell’impegno quanto alla sua compatibilità con la presenza in
udienza, che deriva da una verifica operata “a posteriori”. La valutazione,
invece, si sarebbe dovuta basare – con l’utilizzazione anche del criterio della
“probabilità” di cui al capoverso dell’articolo 420-ter del Codice di Procedura
penale – prima della sua celebrazione.
Dunque, il desiderio di
portare l’ultimo saluto ad uno stretto congiunto non rappresenta un legittimo
impedimento (assoluto) e si scontra con la freddezza delle norme, delle sentenze
e della irremovibilità dei giudici. Viene in mente il titolo di un recente
libro del professor Gerardo Villanacci: “Giustizia cinica”.
«Non vi sopporto,
avvocati!», l’agente fa lo show in aula. La Camera penale capitolina indice
un’astensione: «Episodio assurdo che si somma a un mare di disagi».
Valentina Stella su Il Dubbio il 28 aprile 2022.
«Vattene immediatamente fuori,
io già non sopporto gli avvocati, pensa i detenuti!». Così si è rivolto ad un
recluso, due giorni fa, al Tribunale di Sorveglianza di Roma, un agente della
polizia penitenziaria, addetto alla gestione delle presenze di parti e avvocati
durante le udienze. Il contesto fisico è quello di un corridoio a zig zag con
legali e assistiti ammassati mentre sono in attesa di accedere all’aula. Il
detenuto stava lamentando la lunga attesa, raccontano gli avvocati presenti,
quando l’agente «allontanava e aggrediva verbalmente tutti i presenti con frase
ingiuriose, minacciose e gratuitamente aggressive», e liquidava gli avvocati
«con gesti della mano del tipo ‘ ciao’ per poi rinchiudersi nell’aula di
udienza. Alle legittime rimostranze degli avvocati, beffeggiava i difensori
dichiarando che lui ‘ aveva alle spalle già 37 anni di galera’ e non temeva
nessuno».
La vicenda è stata fortemente
stigmatizzata dal direttivo della Camera penale di Roma, che ha chiesto la
rimozione dell’agente da quel ruolo, ha inviato una segnalazione al
Provveditorato regionale per eventuali provvedimenti e ha indetto per il 26
maggio una giornata di astensione dalle udienze, con una manifestazione da
tenersi insieme a tutte le Camere penali del Distretto. Come ci dice il
presidente dei penalisti romani Vincenzo Comi, «quando un operatore addetto alla
vigilanza prende a male parole gli avvocati e gli interessati con modi da
sceriffo metropolitano e nessuno interviene, vuol dire che la misura è colma.
Quello che è accaduto presso il tribunale di Sorveglianza è intollerabile, e se
aggiungiamo le disfunzioni, le mancanze di personale, i ritardi nella gestione e
trattazione dei procedimenti che riguardano persone private della libertà
personale, non ci resta che adottare ogni forma di protesta a difesa dei diritti
dei cittadini».
Aggiunge l’avvocato Maria
Brucale, presente al verificarsi dell’episodio e responsabile della commissione
Tribunale di Sorveglianza della Camera penale capitolina: «Nonostante il massimo
impegno profuso dalla presidente del Tribunale di Sorveglianza, la dottoressa
Vertaldi, sempre pronta a sostenere noi avvocati e a mettere in campo tutti gli
sforzi per farci lavorare al meglio per i nostri assistiti, le risorse umane e
materiali sono assolutamente carenti. A ciò si aggiungono problemi
organizzativi, a cominciare dalle troppe udienze concentrate nello stesso giorno
in spazi inadeguati e da tempi di definizione dei procedimenti patologici e
incoerenti con la natura del giudizio di sorveglianza, teso al recupero e alla
fruizione dell’offerta trattamentale delle persone ristrette».
Notificazione al difensore
valida solo quando è chiaro che l’imputato “fugge” dal processo: la sentenza.
È ispirata a
un principio garantista, la pronuncia con cui le sezioni unite della Cassazione,
lo scorso 14 aprile, hanno sancito in quali casi il tentativo compiuto tramite
posta è equiparabile alla procedura con ufficiale giudiziario, e può dunque
legittimare l’invio dell’atto al legale. Alessandro Parrotta su Il Dubbio il 28
aprile 2022.
È stata depositata lo scorso
14 aprile la sentenza a sezioni unite n. 14573/2022 con la quale il Supremo
consesso è stato chiamato, a seguito di ordinanza di rimessione della Sesta
penale della Cassazione, a pronunciarsi su una questione tanto tecnica quanto
assai delicata. I temi oggetto della decisione toccano fondamentalmente due
momenti, espressione del più generale e supremo diritto di difesa: la
notificazione di un provvedimento a una persona imputata in un procedimento
penale (nella specie, un decreto di citazione a giudizio) e – come conseguenza –
il diritto dell’imputato ad essere messo nelle condizioni di poter partecipare
concretamente ed attivamente allo stesso, con tutte le tutele e garanzie offerte
dal nostro ordinamento.
In particolare, la questione
portata all’attenzione delle sezioni unite concerne la legittimità o meno
della “notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art.
161, comma 4, c.p.p., nel caso in cui l’addetto al servizio postale incaricato
della notificazione abbia in precedenza attestato l’irreperibilità del
destinatario nel domicilio dichiarato o eletto” e, più nel dettaglio, il
rapporto tra il citato articolo e l’art. 170, comma 3 del codice di rito.
Le sezioni unite concordano
sull’esistenza di due orientamenti interpretativi: il primo, basato sulla non
perfetta sovrapponibilità della notificazione a mezzo postale e di quella a
mezzo ufficiale giudiziario, che ritiene affetta da nullità assoluta la
notificazione sostitutiva al difensore (art. 161, comma 4, c.p.p.) quando
“accertata dall’addetto al servizio postale l’irreperibilità del destinatario
nel domicilio dichiarato o eletto, non si sia attivata la notifica con le
modalità ordinarie ai sensi dell’art. 170, comma 3, c.p.p.”; il secondo, che,
onde evitare paradossi applicativi, ritiene riconducibile alla nozione di
irreperibilità del destinatario, legittimando così la notificazione sostituiva
al difensore, anche solo una mera “temporanea assenza dell’imputato al momento
dell’accesso dell’ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello
specifico luogo” (Cass. pen., sez. I, n. 23880/2021).
In questa seconda ipotesi,
dunque, l’operatività dell’art. 170, comma 3, c.p.p. sarebbe circoscritta ai
soli casi di prima notificazione all’imputato non detenuto, ossia a tutti quei
casi in cui, mancando una dichiarazione o elezione di domicilio, vani i
tentativi effettuati per eseguire la prima notifica, si perviene all’adozione di
un decreto di irreperibilità.
Con la pronuncia in esame è
stata adottata una posizione intermedia, tesa, da un lato, a non vanificare il
procedimento di notificazione quando siano state rispettate le formalità
previste dall’ordinamento, dall’altro, a garantire l’effettività della
conoscenza del processo in capo all’imputato, anche alla luce dei moniti
provenienti dalla giurisprudenza della Corte Edu nonché dalla novella del 2014
(l. 67/2014) in materia di procedimento in assenza.
La Corte, dunque, ritenuta la
piena equiparabilità tra la notificazione di atti giudiziari a mezzo posta e
quella compiuta personalmente a mezzo ufficiale giudiziario, ha concluso
esprimendo che “nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi
dell’art. 161, commi 1, 2 e 3, c.p.p. il tentativo di notificazione col mezzo
della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi dell’articolo 170 c.p.p. e
non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza
necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta
impossibile e/o dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui
all’art. 161, comma 4, prima parte”.
In tali ipotesi le sezioni
unite ritengono sufficiente, ai fini della regolarità, la notificazione
sostituiva al difensore tranne che, come previsto nell’ultimo capoverso del
comma 4 dell’art. 161 c.p.p., per caso fortuito o forza maggiore l’imputato non
ha potuto comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto.
Questo arresto ha annullato
tanto la sentenza della Corte distrettuale quanto quella del Giudice di prime
cure ritenendo, sulla scorta di alcuni indici sintomatici, che:
1) l’imputato non avesse avuto
effettiva conoscenza dell’instaurando procedimento (nella fattispecie, non
avendo mai avuto per tutto il decorso processuale un reale contatto con il
proprio difensore);
2) conseguentemente, la sua
assenza non poteva ricondursi ad una scelta volontaria di rinunciare ad
esercitare un proprio diritto ovvero di sottrarsi alla conoscenza dello stesso
bensì ad un difetto circa la regolare costituzione del rapporto processuale.
Merita sottolineare, quindi,
come questo importante principio sicuramente e condivisibilmente garantista si
pone in linea di esatta continuità con quanto già previsto dalla cosiddetta
riforma Cartabia, ratificandone in sostanza gli esiti: all’art. 1, comma 7,
lett. a), infatti, si evidenzia la necessità di prevedere “che il processo possa
svolgersi in assenza dell’imputato solo quando esistono elementi idonei a dare
certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo” mentre
alla successiva lett. b) “che ai fini della notificazione dell’atto introduttivo
del processo, l’autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria”.
Anche l’Autorità giudiziaria,
pertanto, è aderente alla più attuale riforma: che possa questo esser da spunto
per giungere ad un punto condiviso e non lesivo dei diritti dell’imputato.
*Avvocato, direttore Ispeg –
Istituto per gli studi politici, economici e giuridici
«Lei è maleducata!».
Avvocata insultata in aula perché in ritardo.
La professionista di Messina è
stata presa di mira dal giudice perché aveva un altro procedimento e si è
collegata con sette minuti di ritardo all'udienza da remoto. Gennaro Grimolizzi
su Il Dubbio il 13 maggio 2022.
L’avvocato che arriva con un
leggero ritardo in udienza da remoto, giustificando il tutto perché impegnato in
un altro procedimento, è da considerarsi “maleducato”. Non si tratta di una
nuova norma di comportamento stilata da qualche magistrato, ma del rimprovero e
dell’assunto al quale è giunto il presidente della sesta sezione della
Commissione tributaria provinciale di Napoli.
La storia viene raccontata
dalla diretta interessata, l’avvocata Daniela Agnello del Foro di Messina, con
studio a Milano e nella città dello Stretto, penalista apprezzata anche per la
rilevante giurisprudenza ottenuta in materia di giochi con le sentenze della
Corte di giustizia dell’Unione Europea. Agnello è delusa e amareggiata per sé
stessa e per l’intera categoria professionale alla quale appartiene, costretta
ad affrontare un momento storico delicato in cui guardare al futuro con
ottimismo non sempre è facile.
Tutto è accaduto lo scorso 6
maggio. L’udienza davanti ai giudici tributari contrappone una multinazionale e
l’Agenzia dei Monopoli. L’ora di inizio dell’udienza sulla carta è fissato alle
9. Il collegamento a distanza, come riporta il verbale, risulta «perfettamente
riuscito alle ore 9.43» con la presenza di entrambe le parti. Nella difesa della
multinazionale, oltre alla avvocata Agnello, anche la collega Vittoria Varzi.
Quest’ultima chiede «il rinvio per un tentativo di conciliazione con l’ufficio»,
considerata la momentanea assenza di Agnello. La Commissione tributaria
provinciale non accoglie la richiesta di rinvio, ma alle 9.50 (sette minuti dopo
l’inizio dell’udienza) interviene l’avvocata Agnello, che presenta una ulteriore
richiesta – la riunione in trattazione di tre fascicoli -, rigettata a sua volta
dalla Ctp. È in questa occasione che Agnello fa mettere a verbale la sua
doglianza, evidenziando il suo disappunto verso la condotta del presidente della
Sesta sezione che l’ha appena definita «maleducata e scorretta» per il ritardo
risibile del suo arrivo in udienza con l’attivazione del collegamento da remoto.
«Non posso nascondere – dice
al Dubbio Daniela Agnello – la mia amarezza per l’episodio che mi ha riguardato.
Quanto accaduto manifesta offesa in pubblica udienza, insolenza, inadeguato
rispetto della classe forense. Nel momento in cui ho attivato il collegamento da
remoto ho subito riscontrato un atteggiamento ostile del presidente della
Commissione tributaria provinciale. È stata concessa la parola al difensore, ma
il presidente ha inveito nervosamente nei miei confronti, definendomi per più
volte “scorretta e maleducata” per non essermi resa prontamente ed
immediatamente disponibile sin dal momento dell’insediamento della Commissione.
Il presidente, visibilmente agitato, ha reiterato le frasi offensive,
continuando a definirmi “maleducata”. La vicenda è accaduta innanzi alla
presenza degli altri giudici componenti la Commissione provinciale, del
segretario di Cancelleria, dei funzionari dell’Agenzia dei Monopoli nonché
colleghi difensori impegnati nella medesima controversia».
La professionista ha segnalato
il caso al Coa di appartenenza, Messina, interessando pure l’Ordine degli
avvocati di Napoli, la Commissione tributaria partenopea e la Camera degli
avvocati tributaristi. «La vicenda – commenta Daniela Agnello – riassume la
condizione in cui talvolta si trovano gli avvocati nell’esercizio della loro
funzione. Una posizione ritenuta secondaria, subordinata e sulla quale risulta
prevaricante lo strapotere attribuito alle altre parti processuali. Una vicenda
di inaudita gravità che offende la dignità professionale dell’avvocato, spesso,
troppo spesso, svilita e mortificata. L’auspicio è che si possa raggiungere in
tutte le sedi giudiziarie un reale equilibrio, ma soprattutto un eguale rispetto
per tutti i protagonisti della giurisdizione, nella reciproca stima dei ruoli,
consentendo a ciascun attore della dinamica processuale di esercitare i propri
diritti e poteri, le specifiche prerogative con equilibrio e moderazione,
nell’interesse superiore della giustizia».
Avvocata insultata dal
giudice, i Coa si mobilitano.
La legale Daniela Agnello
venne definita “scorretta e maleducata” dal presidente di sezione della Ctp di
Napoli. Gennaro Grimolizzi su Il Dubbio l'11 giugno 2022.
Il caso dell’avvocata Daniela
Agnello approda a Salerno: verrà affrontato per competenza dal Consiglio
giudiziario presso la Corte di Appello e dal Consiglio dell’Ordine degli
avvocati. Il 6 maggio scorso, nel corso di una udienza davanti alla Commissione
tributaria provinciale di Napoli, il presidente della sesta sezione ha definito
la penalista “scorretta e maleducata” per il leggero ritardo con cui si è
collegata da remoto per discutere una causa tra una multinazionale (difesa da
Agnello) e l’Agenzia dei Monopoli. Una condotta, quella del giudice tributario,
che non poteva passare inosservata.
La professionista, che ha
studio a Milano e a Messina, ha chiesto l’astensione del presidente e
l’intervento del Coa di appartenenza. È bene ricordare che il collegamento a
distanza, come riporta il verbale, risulta «perfettamente riuscito alle ore
9.43» con la presenza di entrambe le parti e con orario dell’udienza fissato
alle 9. Oltre alla avvocata Agnello, apprezzata in tutta Italia per la rilevante
giurisprudenza ottenuta in materia di giochi con le sentenze della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, la sua collega Vittoria Varzi. Quest’ultima ha
chiesto in udienza «il rinvio per un tentativo di conciliazione con l’ufficio»,
considerata la momentanea assenza dell’avvocata Agnello. La Commissione
tributaria provinciale però non ha accolto la richiesta di rinvio. Alle 9.50
(sette minuti dopo l’inizio dell’udienza) interviene Agnello, che presenta una
ulteriore richiesta (la riunione in trattazione di tre fascicoli), rigettata
dalla Commissione tributaria provinciale, chiedendo di far mettere a verbale le
parole nel frattempo pronunciate dal presidente di sezione, circostanza, tra
l’altro, non contestata nel medesimo verbale di udienza.
Nel mandare gli atti a Salerno
il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Messina, presieduto da Domenico
Santoro, evidenzia che costituisce «una lesione della dignità e del decoro della
funzione difensiva svolta l’additare un avvocato, impegnato nello svolgimento
del mandato professionale, quale maleducato e scorretto sol perché sopraggiunto
tardivamente in udienza (malgrado un pur dedotto e contestuale impegno
professionale)». Gli avvocati della città dello Stretto, inoltre, hanno
manifestato «piena solidarietà alla collega Agnello per il disdicevole
episodio». Sull’evolversi della vicenda interviene la diretta interessata. «Sono
fortemente amareggiata – dice al Dubbio – per quanto accaduto. L’episodio
sconveniente e offensivo poteva trovare un epilogo con delle formali scuse,
pubbliche e private. Il provvedimento adottato dal Consiglio dell’Ordine di
Messina con cui sono stati trasmessi gli atti al Consiglio giudiziario della
Corte di Appello competente, per le valutazioni in merito al comportamento
tenuto dal presidente del collegio in pubblica udienza, era inevitabile».
La mente ritorna al 6 maggio
scorso. «Rammento – prosegue l’avvocata Agnello – che quel giorno mi sono
collegata con la Commissione con sette minuti di ritardo, ma nella piena
consapevolezza di non creare intralcio alla regolare trattazione del
procedimento per la presenza del co-difensore. Quando ho attivato il
collegamento da remoto, ho riscontrato sin da subito un atteggiamento ostile da
parte del presidente di cui non ho precedenti ricordi di conoscenza. Prima di
chiedere l’astensione dalle mie cause, ho chiesto se si volesse scusare
pubblicamente, ma lui ha mantenuto l’atteggiamento ostile e offensivo al mio
indirizzo e per l’intera categoria». Sicuramente l’amarezza è tanta per il
nervosismo che alcune volte serpeggia in udienza e che intacca l’autorevolezza e
la delicata funzione del difensore.
«Il Coa – conclude Agnello –
ha ritenuto l’episodio lesivo della dignità e del decoro della funzione
difensiva. Auspico, a questo punto, che in sede disciplinare si possano adottare
i provvedimenti più idonei per rammentare all’intero mondo giudiziario
l’importanza della funzione e del ruolo degli avvocati. Troppo spesso dobbiamo
constatare la mancanza di rispetto nella dinamica processuale e un forte
dislivello tra le due categorie professionali con il rischio di determinare
inevitabilmente effetti negativi anche sull’espletamento del mandato difensivo e
nel quotidiano perseguimento dei principi di equità e di giustizia. Nelle aule
dei Tribunali italiani si devono esercitare i diritti di difesa garantiti dalla
Costituzione della Repubblica nel pieno rispetto delle funzioni, con piena e
incondizionata stima dei ruoli, consentendo a ciascun attore della dinamica
processuale di esercitare i propri incarichi con determinazione, passione e
professionalità».
«Così il tribunale ci ha
negato il diritto di difesa in presenza».
La denuncia di due legali di
Roma che più volte hanno presentato istanza per trattare l'udienza in presenza,
ottenendo sempre un rifiuto. Valentina Stella su Il Dubbio il 17 maggio 2022.
«Riteniamo profondamente
lesivo del diritto di difesa il fatto che non ci sia stato concesso di discutere
una causa civile in presenza»: è quanto lamentano al Dubbio gli avvocati Roberto
Di Napoli e Alessandro Martini del Foro di Roma. Siamo al Tribunale capitolino,
sedicesima (ex terza) sezione civile. Il 29 marzo il Gop fissa l’udienza per il
16 maggio «in modalità esclusivamente cartolare, senza la presenza delle parti»,
adducendo nella premessa del provvedimento anche il riferimento al dl 18/2020,
approvato durante la pandemia, che lascia discrezionalità ai capi di uffici per
la trattazione delle udienze.
Il 4 aprile, la difesa,
«ritenendo che la complessità e delicatezza della controversia rendessero
necessario esporre alcune circostanze che non si prestano a essere sintetizzate
nella nota di trattazione scritta e che, comunque, sia preferibile che l’udienza
si svolga nel contraddittorio simultaneo», chiedeva che l’udienza fosse fissata
in presenza. Il Gop rigettava l’istanza «attese le esigenze di ruolo». Gli
avvocati Di Napoli e Martini presentano nuova istanza per ribadire la necessità
dell’udienza in presenza, altresì «in considerazione del valore della causa
(434.431,92 euro)», e per chiedere che essa fosse assegnata al giudice togato e
non a quello onorario. Nulla da fare: il Gop respinge. I due legali non
demordono e scrivono a presidente di sezione e presidente del Tribunale di
Roima, rammentando: «La difesa continua a ritenere che la trattazione
dell’udienza in presenza debba costituire la “regola” rispetto a quanto previsto
dalla normativa emergenziale».
In essa, hanno sottolineato,
«il legislatore, nel contemperare l’esigenza di salvaguardia della salute dal
pericolo di infezione da covid-19 col diritto di difesa, ex art. 24 Cost. e 6
Cedu, pur prevedendo che il giudice possa disporre che l’udienza che non
richieda la presenza delle parti o testimoni si svolga con trattazione scritta,
ha previsto, tuttavia, che le parti possano richiedere che l’udienza si svolga
in presenza. È stato più volte osservato che il diritto ad una udienza orale è
una importante garanzia che può essere considerata una specificazione del
“diritto ad un tribunale” consacrato dall’articolo 6 della Cedu”. Inoltre
l’esercizio del diritto della parte o dei suoi difensori a partecipare
personalmente all’udienza non può essere impedito da esigenze organizzative
dell’Ufficio. Si ricorda, peraltro, che, come riconosciuto anche dai giudici di
legittimità, l’art. 111 Cost. tutela il diritto al contraddittorio, insito nel
diritto di difesa, a sua volta riconosciuto dall’art. 24 Cost». Sta di fatto che
il presidente del Tribunale non ha risposto per ora ai due avvocati, mentre il
presidente di sezione ha replicato che «in considerazione della carenza di
organico non può provvedere diversamente. Le modalità di trattazione
dell’udienza attengono alla discrezionalità del giudice».
I due avvocati sono molto
amareggiati: «Se rientra nella discrezionalità del giudice fissare o meno
l’udienza in presenza pur dinanzi ad una tempestiva istanza formulata dal
difensore, come previsto dall’art. 221 l. 77/2020, c’è, allora, il pericolo che
gli avvocati siano privati del contraddittorio “simultaneo”. Che, in alcuni
casi, è fondamentale, soprattutto quando sia finanche imposto di limitare le
note scritte alle sole istanze e conclusioni senza nemmeno poter replicare. La
legge delega per la riforma del processo civile (l. 206/2021) prevede che il
giudice potrà disporre l’udienza con trattazione scritta ma sempre che non vi
sia opposizione di una delle parti. Come sarà interpretata l’eventuale
opposizione all’udienza con trattazione scritta? Continuerà ad essere ritenuta
“non vincolante” o soggetta all’apprezzamento del giudice?». Intanto ieri
l’udienza è stata rinviata al 12 settembre.
Legali interrotti, captati,
indagati: «Certe toghe ci confondono coi nostri clienti».
Armetta, presidente del Coa di Palermo: «Dagli ultimi casi emerge una mancanza
di rispetto per il nostro ruolo». Il report del Cnf porta l’allarme all’Unione
Europea. Gennaro Grimolizzi su Il Dubbio l'11 aprile 2022.
Esiste un timore per il ruolo
e la funzione svolta dagli avvocati? Questo timore si trasforma in compressione
del diritto di difesa? La risposta, se si pensa ai casi verificatisi da qualche
anno a questa parte, è affermativa. A dimostrarlo è la Relazione del Cnf sullo
Stato di diritto e l’indipendenza degli avvocati e degli Ordini
forensi, presentata pochi giorni fa alla Commissione europea. Il documento ha
consentito, come rilevato da Francesca Sorbi, capo delegazione presso
il Ccbe (Consiglio dell’avvocatura europea), di fare il punto sulle condizioni
in cui versa e opera l’avvocatura italiana, partendo dalla pari dignità che
hanno i protagonisti della giurisdizione. A questi, senza distinzioni, sono
riconosciute autonomia e indipendenza.
NELLA RELAZIONE DEL CNF ALLA
UE ANCHE I CASI DI DIFENSORI INTERCETTATI
Sulla realizzazione del
diritto di difesa, tenendo conto della segretezza e riservatezza delle
conversazioni e l’interferenza dei giudici, sono stati portati a conoscenza
di Bruxelles alcuni casi. Il primo ha riguardato un penalista del Foro di
Roma, sottoposto a intercettazioni per più di due anni, dopo l’avvio di
un’indagine sulla presunta partecipazione ad una associazione per delinquere con
i suoi assistiti. Una “prassi disfunzionale”, ha rilevato il Cnf, tendente ad
affermare un «metodo d’indagine che non rispetta le prerogative della difesa, né
la presunzione di innocenza».
Un tema di grande attualità è
quello dell’interferenza dei giudici che può implicare l’interruzione della
funzione di difesa. I vertici di via del Governo Vecchio, nel conferire con la
Commissione europea, hanno rilevato in alcuni casi una «deriva inquisitoria
nella fase centrale dell’udienza con l’emergere di comportamenti che connotano
un eccesso dell’uso del potere discrezionale del Giudice, se non un abuso di
potere, consistenti nel limitare i diritti della difesa in fase di esame e
contro esame, impedendo, ad esempio, di porre domande o escludendo
arbitrariamente la loro rilevanza». Tra le vicende segnalate quella degli
avvocati Borzone e Capra.
Durante un’udienza, un giudice
ha interrotto senza troppi convenevoli il controesame dei testi, ostacolando, di
fatto, l’attività difensiva. A Lecce, invece, un altro avvocato ha deciso di
rinunciare al proprio mandato, poiché si è trovato in palese disaccordo con la
condotta del giudice, e ha ritenuto «negato il corretto esercizio delle proprie
funzioni nel corso di un procedimento». Il 2022 ha fatto registrare altri casi
in cui il diritto difesa è stato messo a dura prova. In un processo penale gli
avvocati del Foro di Milano Enrico Visciano e Alfredo Partexano, nel corso della
loro arringa, hanno fatto i conti con un atteggiamento singolare del giudice che
ha cercato di abbandonare l’aula di udienza.
«Durante le arringhe presso il
Tribunale di Monza – spiegano i due legali –, ci siamo imbattuti in molteplici
interruzioni, nonostante i richiami di noi difensori rispetto all’impossibilità
assoluta di interrompere un’arringa finale quale momento sacramentale del
rito. Anche l’imputato, non dimentichiamolo mai, ha dei diritti. Le interruzioni
sono state poste in essere sia dal difensore di parte civile sia dal giudice,
che abbiamo richiamato affinché tornasse al proprio posto con i faldoni in mano
nel momento in cui decise di allontanarsi dall’aula. Solo con le nostre proteste
rivolte al giudice siamo riusciti a concludere le arringhe».
La sentenza emessa al termine
del processo ha, poi, riservato una sorpresa. L’assistita di Visciano e
Partexano è stata condannata a quattro anni di reclusione, ma a meravigliare gli
avvocati sono state le parole scritte dal giudice. Le conclusioni alle quali è
giunto sono singolari: gli avvocati che non si dissociano dalle dichiarazioni
del proprio assistito e che le fanno proprie nelle arringhe, seppur con «toni
solo apparentemente più pacati ed urbani », rischiano quanto la persona difesa.
Un assunto che stride con la “sacralità” del ruolo del difensore.
E ORA SCATTANO INDAGINI SUGLI
AVVOCATI CHE CHIEDONO IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Nelle ultime settimane grande
clamore ha destato il “caso Murano”. L’avvocato Antonio Murano del Foro di
Potenza è stato indagato e sottoposto a controlli nel suo studio legale di
Rionero in Vulture, dopo essersi assentato in una udienza penale per motivi di
salute, certificati da un medico. Con la trasmissione del verbale di udienza in
Procura il professionista ha ricevuto la visita fiscale in casa. Il medico si è
presentato accompagnato dai carabinieri. Sono state sottoposte ad interrogatorio
diverse persone, compresi i familiari del penalista, e il suo studio legale ha
subito un controllo per visionare l’impianto di videosorveglianza e acquisire le
registrazioni.
ARMETTA: «A MAGGIOR RAGIONE
URGE LA RIFORMA SUI CONSIGLI GIUDIZIARI»
«Mi piacerebbe – commenta
Antonello Armetta, presidente del Coa di Palermo – se più che di paura o timore
si parlasse del dovuto rispetto per gli avvocati. I fatti di Potenza non fanno
che confermare come, tra alcuni componenti del complesso sistema giustizia,
l’avvocato goda della stessa considerazione di cui gode il suo assistito, quasi
a voler immaginare una sovrapposizione tra i medesimi, che è figlia di una
assoluta mancanza di cultura giuridica. Tale approccio dovrebbe far riflettere
molto sulla stessa capacità di alcuni di indagare e giudicare».
Per questo motivo, secondo
Armetta, «non ci si stupisce della ritrosia ad ammettere il diritto di voto
degli avvocati nei Consigli giudiziari, che l’avvocatura deve pretendere senza
se e senza ma». «L’amministrazione della giustizia – conclude il presidente del
Coa palermitano – impone un controllo che solo gli avvocati possono garantire.
Risponde al superiore interesse pubblico gravemente compromesso dai recenti
fatti di cronaca, che hanno intaccato la credibilità dell’intero sistema
giustizia. La resistenza cui assistiamo non fa che confermare l’assoluta
necessità di una operazione trasparenza ineludibile e urgente».
Placanica: «Per i pm il
sistema giustizia è chiuso e noi siamo intrusi».
Parla l’avvocato penalista:
«Il magistrato ha una concezione autoritaria della giustizia, che però porta a
distorsioni. L’unico modo per evitarle è un efficace ed effettivo sistema di
controllo». Simona Musco su Il Dubbio l'11 aprile 2022.
«La diffidenza della
magistratura nei confronti degli avvocati non è altro che un meccanismo di
autoprotezione: il magistrato si sente come il buon padre di famiglia e
l’avvocato deve essere tenuto fuori, perché lui sì che viene inteso come
soggetto che ha un interesse “partigiano”». A dirlo è Cesare Placanica, ex
presidente della Camera penale di Roma, che al Dubbio spiega il perché di una
insofferenza sempre più palese.
I casi di Potenza e Brescia
rappresentano una degenerazione del rapporto tra magistratura e avvocatura.
Ritiene che ci sia una sorta di timore, da parte delle toghe, nei vostri
confronti?
Credo sia doveroso, intanto,
distinguere il “bestiario” da quello che accade normalmente. I casi di Potenza e
Brescia sono patologici e il dato patologico va isolato e va affrontato,
evitando un approccio massimalista al problema, non serio e neanche corretto. Al
tribunale di Roma, faccio un esempio, non ho mai visto trasformare il
certificato medico in notitia criminis. Ma lo dico come dato obiettivo anche
rispetto all’autorevolezza della classe forense, che non è al punto di essere
messa in discussione, da questo punto di vista. Il discorso è, in realtà, molto
più serio e profondo quando riguarda non il dato patologico, ma l’approccio alla
gestione della giustizia.
In che senso?
Faccio un esempio: chiunque
voglia occuparsi di capire un problema del sistema giustizia deve per prima cosa
ancorarsi ai dati. Noi avvocati abbiamo da anni, sulla scorta della nostra
esperienza, la sensazione che l’udienza preliminare sia completamente fallita,
perché nessun giudice, anche per motivi tecnici, fa effettivamente da filtro. E
abbiamo anche la sensazione di un fallimento rispetto a quello che era la
funzione di controllo vera e propria del gip rispetto al pubblico ministero.
Faccio questo lavoro da 31 anni e non credo ci sia la dovuta diffidenza
nell’approccio del gip rispetto all’ufficio del pubblico ministero. Piuttosto
c’è l’opposto, un approccio “confidente”.
Per “diffidenza” intende un
approccio critico al materiale probatorio?
Sì. Il giudice deve
riscontrare che l’impostazione e l’idea accusatoria siano effettivamente
fondate, soprattutto nella fase dell’applicazione della misura cautelare. Anche
rispetto ai Tribunali della Libertà di tutta Italia abbiamo la sensazione che il
vaglio non sia così approfondito come dovrebbe essere. Noi abbiamo un sistema
che in nessun modo accetta il rischio di un colpevole condannato e che invece,
fisiologicamente, accetta il rischio di un colpevole mandato assolto. Può
sembrare anche non bello: chi non ha sensibilità democratica e liberale ripudia
questo concetto.
Quando quel famoso magistrato
dice che si tratta di colpevoli che la fanno franca è perché lui, per sua
sensibilità culturale e giuridica, non accetta la possibilità del colpevole che,
per insufficienza del materiale probatorio, venga assolto. Invece il sistema
questo lo pretende. Quello che un sistema democratico non può accettare è
l’opposto: il bicchiere deve essere visto sempre mezzo pieno e mai mezzo vuoto.
Questo approccio critico, dicevamo, non c’è. E tornando al discorso originario,
per capire se questa sensazione sia una follia o anche soltanto una cattiva
impressione dovuta alla prospettiva in cui si pone l’avvocato, esattamente
opposta a quella del pm, basterebbe cominciare ad analizzare i dati statistici.
E dire quante misure cautelari siano accolte e quante rigettate. Sarebbe
interessante. Perché se viene rigettata la metà delle richieste allora, forse,
avrebbe ragione il pubblico ministero. Ma se ne viene accolto il 99% allora
forse abbiamo ragione noi a dire che non c’è un vero vaglio.
E i dati cosa dicono?
Vengono, con dolo, tenuti
nascosti. Eppure non sono di chi amministra la giustizia, perché il sistema
giustizia è gestito dalla politica, nel senso più alto e più nobile del termine,
e i protagonisti del sistema giustizia, con funzioni diverse e con pari dignità,
sono tutti essenziali allo scopo finale di un processo, che è quello di
accertare il più possibile come siano andati dei fatti, scongiurando soprattutto
il pericolo di condannare un innocente.
Da cosa dipende questa
diffidenza rispetto alla classe forense?
È un meccanismo di
autoprotezione, una visione filosofica autoritaria e autocratica della gestione
della giustizia. Il magistrato si sente come il buon padre di famiglia e non ce
l’ha con l’imputato, perché non farebbe nulla contro di lui. Il cittadino è
oggetto della giustizia. E per quanto quella dell’avvocato sia una funzione
pubblica, che non fa parte del sistema autoritario, deve essere tenuto fuori dal
sistema giustizia, perché lui sì che viene inteso come soggetto che ha un
interesse “partigiano”. Quindi il pm “imperatore” gestisce tutto autonomamente,
perché si percepisce come imparziale, caratteristica che non attribuisce al
soggetto con il quale dovrebbe interloquire. Questa concezione autoritaria è
smentita dalla storia, perché inevitabilmente porta verso distorsioni. E l’unica
cosa che non consente le distorsioni è un efficace e vero sistema di controllo.
Le degenerazioni del caso di Palamara sono dovute proprio a questo: dalla
mancanza effettiva di controllo, che può avvenire solo con la trasparenza.
A tal proposito, una forma di
“controllo” potrebbe essere rappresentata dal diritto di voto agli avvocati nei
Consigli giudiziari, soluzione molto criticata dai magistrati. Secondo lei
perché?
È l’unico modo per evitare una
deriva che è sistematica di ogni sistema chiuso. Il potere si autoalimenta, non
accetta il contraddittorio, tutto quello che è al di fuori è sbagliato e ha
necessità proprio di una chiusura. E il controllo, perché sia effettivo ed
efficace, pretende trasparenza. Il che vuol dire che io devo stare lì dentro,
devo vedere e devo poter decidere. Altrimenti è un soliloquio. Ed è per questo
l’idea che non piace.
Un altro esempio di diffidenza
ha riguardato la sentenza della Consulta sulla segretezza della corrispondenza
tra detenuti al 41 bis e difensori: per alcuni magistrati significava
autorizzare la consegna di veri e propri pizzini tramite l’avvocato.
Come dissi a Travaglio, quella
considerazione è stata vergognosamente offensiva. Intanto perché appena si
scopre che un avvocato si presta a cose del genere deve essere ovviamente
radiato dall’ordine e processato, e l’avvocatura deve costituirsi parte civile.
Ma siamo sempre nell’ambito del patologico. La Consulta si è posta il problema e
ha detto che è una facoltà connaturata al diritto di difesa, che c’è in ogni
Stato democratico, quindi ha un rango primario rispetto ad un’eventuale
possibile patologia di fondo.
Dopodiché la Corte ha detto
chiaramente che una riflessione su questo dato si potrebbe fare se fosse
patrimonio acquisito alla nostra conoscenza l’esistenza di una ricorrente
trasgressione, da parte della classe forense, del divieto di legge di non
portare notizie di mafia dal boss detenuto ai suoi consociati. Siccome questo
dato empirico non esiste e non esiste una prassi – e nemmeno un’apprezzabile
casistica -, come hanno detto i giudici, né è ipotizzabile, questa riflessione
non può essere fatta. Fermo restando che se si arrivasse a fare il dibattito
bisognerebbe capire cosa sacrificare rispetto a un’esigenza di polizia. È così
brutale, disarmante e miserabile il ragionamento che è stato fatto da non poter
essere preso in considerazione. Ma questo è il sintomo della volontà di minare
una gestione che sia effettivamente democratica della giustizia.
Quale potrebbe essere la
soluzione?
Intanto vorrei dire che
l’avvocato nel Consiglio giudiziario non ha interesse a starci. L’interesse è
della collettività, che vuole garanzie sul fatto che un potere incredibile ed
eccezionale come quello di somministrare giustizia abbia un serio controllo. E
quindi non è un problema dell’avvocato, ma del cittadino. Quello che si deve
fare, poi, è parlarne. Far capire alle persone di cosa si tratta, demistificando
gli argomenti che vengono scientificamente introdotti, fuorvianti e irrilevanti
rispetto al tema di cui si parla, sempre agitando le paure e banalizzando
patologie che esistono ed esisteranno sempre. Ma nessuno sogna di togliere le
pistole alla polizia perché ogni tanto qualcuno perde la testa.
Quando il pm si pone (ma
non si sente) fuori dalla giurisdizione. I casi di Potenza e Brescia denotano il
germe di un intollerabile pregiudizio nei confronti della funzione difensiva.
Pasquale Annicchiarico, Presidente della Camera Penale di Brindisi, su Il Dubbio
il 12 aprile 2022.
In questi ultimi tempi si sono
verificati episodi nelle aule dei tribunali che hanno destato non poche
perplessità tra noi avvocati a seguito di alcune decisioni assunte da pubblici
ministeri insofferenti tanto ad istanze difensive, quanto a provvedimenti del
giudicante.
Come riportato nei giorni
scorsi da articoli di cronaca, a Potenza un avvocato che aveva presentato
un’istanza di rinvio per impedimento dettato da motivi di salute si è visto
raggiunto da carabinieri con medico al seguito affinché venissero accertate le
sue condizioni, con successiva ulteriore “visita” in studio per l’acquisizione
di eventuali filmati dal sistema di videosorveglianza. Il tutto, su iniziativa
del pubblico ministero, nonostante il tribunale avesse accolto la richiesta di
differimento senza disporre alcun tipo di accertamento. A Brescia, sempre a
seguito di un’istanza di rinvio di un avvocato che adduceva quale legittimo
impedimento la tumulazione della salma della madre, il pubblico ministero ha
disposto che venisse verificato se quanto dedotto dal legale corrispondesse al
vero, inviandosi anche in questo caso le forze dell’ordine per gli accertamenti
del caso.
I contorni di queste vicende –
su cui è già intervenuta tempestivamente la Giunta dell’Ucpi – saranno chiariti
nelle sedi opportune, in cui ognuno potrà fornire le giustificazioni che
ritiene. Ma indipendentemente da quanto verrà accertato nel merito, quel che
sconcerta ed appare ingiustificabile è come – pur in presenza di rinvii
improduttivi di effetti processuali pregiudizievoli per la contestuale
sospensione dei termini di prescrizione – ci si sia determinati a perseguire
intenti inquisitori così invasivi, che denotano plasticamente in tutta la loro
ampiezza il germe neppure tanto velato di un intollerabile pregiudizio nei
confronti della funzione difensiva.
Non mi risulta che avvocati
abbiano mai stigmatizzato o anche solo sindacato i ritardi conseguenti ad
impedimenti di pubblici ministeri per motivi di salute o eventi luttuosi (o
anche di altro genere, mai neppure esplorati), che comportano allontanamenti dal
lavoro d’ufficio o da attività di udienza. Ma – come sempre – ognuno si porta
dietro il suo stile di vita. Allorché però – soprattutto quando in gioco è il
tema della separazione delle carriere – si rivendica a gran voce la “cultura
della giurisdizione”, sia consentito ricordare, a chi si pone in quel modo nei
confronti di una categoria cui va riconosciuta pari dignità e rispetto, come la
cultura del sospetto sia ontologicamente e palesemente incompatibile con quella
della giurisdizione.
Check point in tribunale, i
penalisti calabresi: «Trattati come pericolo pubblico».
Divieto di parcheggio all’aula
bunker di Lamezia, controlli e sospetti nei confronti dei legali. La denuncia
delle Camere penali calabresi: «Pari dignità in discussione». Valentina Stella
su Il Dubbio il 7 aprile 2022.
«In difesa del prestigio
dell’avvocatura e per la rimozione di ogni ostacolo alla pari dignità tra tutti
gli attori della giurisdizione», è il titolo di un documento licenziato dalle
Camere penali calabresi – Catanzaro, Crotone, Lamezie Terme, Vibo Valentia – per
stigmatizzare quanto sta avvenendo negli ultimi giorni durante i processi contro
la criminalità organizzata, a partire da Rinascita Scott e Imponimento.
«Da qualche giorno – scrivono
i penalisti – agli avvocati impegnati nei processi presso l’aula bunker di
Lamezia Terme è inibito, per presunte e non meglio esplicitate ragioni di
sicurezza, parcheggiare le auto nello sconfinato piazzale dell’edificio
giudiziario». Chi abbia emesso il provvedimento non è dato sapere. Bocche cucite
da parte degli agenti e militari chiamati a garantire la sicurezza. Comunque
fino a qualche giorno fa, «l’avvocatura, e non solo, vi accede(va) previo
controllo da parte dei militari dell’esercito – un vero e proprio check-point –
i quali registrano e annotano targa e documenti, previa verifica anche della
effettività dell’impegno professionale. Inoltre, prima di accedere alla sede
giudiziaria i difensori sono sottoposti ad ulteriori controlli, attraverso la
verifica dell’identità personale (nuova annotazione del nome e numero di tessera
professionale sul registro tenuto dalle guardie giurate della vigilanza privata)
e al passaggio dal metal detector ogni qual volta si entra ed esce dall’aula».
Poiché, però, criticano i
penalisti, «l’avvocato rappresenta all’evidenza un “pericolo” per l’ordine
pubblico e l’incolumità personale – di chi, lo si può solo intuire», è apparso
«necessario implementare i presidi di sicurezza al fine di neutralizzare la
fonte di rischio, vietando l’utilizzo agli avvocati del predetto “piazzale”, già
distante circa 300 mt. dall’aula». Sia inteso, precisano, «qui non si tratta di
rivendicare un diritto corporativo al posto auto (ora relegato in un luogo
distante circa 800 mt.); è in gioco, invece, il doveroso e reciproco rispetto
che tutti gli attori della giurisdizione dovrebbero reciprocamente riconoscersi
come terreno minimo comune sul quale edificare e garantire il buon andamento
della vita giudiziaria». Inoltre «presso il Tribunale e la Corte D’appello di
Catanzaro è stato introdotto, da pochi giorni, per i soli avvocati (non anche
per magistrati, personale di cancelleria, addetti all’ufficio del processo,
guardie giurate, carabinieri, fonici, etc) il controllo di borse e valigette sul
nastro trasportatore del metal detector. Sicché, all’evidenza, l’avvocato è
considerato come “fonte di pericolo per la sicurezza pubblica”. Nella casistica
delle circostanze, dei luoghi comuni o di quant’altro possa svilire e attaccare
il ruolo difensivo, questa mancava».
Il problema, secondo le Camere
Penali, è che «dilaga la cultura del sospetto, l’utopia securitaria rappresenta
l’ennesimo e ingiustificato attacco nei confronti dell’avvocatura, degno di un
regime illiberale, in cui il difensore è avvertito come un nemico del popolo e,
come tale, merita di essere avversato». La questione è stata sollevata
nell’udienza del 1 aprile dall’avvocato Michele Andreano, che ha anche ricordato
che «anche il bar è stato chiuso e quindi neanche una bottiglietta d’acqua si
può prendere in questa maestosa Aula, ma siamo costretti anche, come dire, a
portarci i viveri e le bevande». Sembrerebbe perché qualcuno tema che gli
imputati a piede libero possano parlare tra loro davanti ad una tazza di caffè.
A lui, durante l’udienza, si
sono poi associati altri colleghi, tra cui l’avvocato Vincenzo Comi (che è anche
presidente della Camera Penale di Roma) difensore di uno degli imputati, che ci
dice: «Si tratta di una vera e propria anomalia, soprattutto in un momento così
delicato per l’organizzazione dei processi e per il rispetto delle prerogative
difensive. Cosa sia accaduto negli ultimi giorni di così grave da inibire a noi
avvocati l’utilizzo del parcheggio non è dato sapere. Durante l’udienza ho
chiesto che della questione venisse investito il presidente del Coa, il
presidente della Corte di Appello e quello dei penalisti del capoluogo. È come
se magistrati e cancellieri entrano dalla porta principale mentre noi avvocati
da quella di servizio. Questo non è tollerabile». Per tutto questo le camere
penali firmatarie del documento chiedono «che il presidente della Corte e il
procuratore generale del distretto di Corte D’Appello di Catanzaro, ognuno nelle
rispettive competenze, revochino, con effetto immediato, i provvedimenti che
hanno determinato il trattamento discriminatorio riservato all’avvocatura».
Brescia, il pm manda i
carabinieri per verificare se la mamma dell’avvocato è davvero morta.
Il legale del foro
di Varese aveva chiesto il rinvio delle udienze previste per il 20 dicembre per
assistere alla cremazione. Valentina Stella su Il Dubbio l'1 aprile 2022.
Dopo l’incredibile
vicenda dell’avvocato di Potenza Antonio Murano (il professionista ha richiesto
il differimento dell’udienza per motivi di salute, ma il magistrato ha deciso di
mandargli a casa i carabinieri e un medico), oggi vi raccontiamo un’altra storia
forse ancora più surreale che arriva da Brescia. La Procura non si sarebbe
fermata neanche dinanzi al cadavere della madre dell’avvocato.
Il protagonista, suo malgrado,
di questo increscioso episodio, è il legale Corrado Viazzo del foro di Varese,
che ci racconta cosa è successo. È anche tutto riassunto in una richiesta di
sanzione disciplinare nei confronti del pubblico ministero, antagonista della
narrazione, al Procuratore Generale di Cassazione Giovanni Salvi che il legale
ha inviato subito dopo i fatti. «Dopo 30 anni di carriera forense (70 se
consideriamo l’anzianità del mio studio) ho dovuto agire così per una questione
che fa torto all’integrità e probità della magistratura». Al momento da piazza
Cavour nessuna risposta. Ma vediamo nel dettaglio.
Sua madre muore
improvvisamente mercoledì 15 dicembre 2021. Il funerale viene celebrato due
giorni dopo mentre la cremazione viene fissata per il lunedì 20 dicembre,
inizialmente senza un orario definito. Pertanto il venerdì l’avvocato Viazzo
chiede il rinvio di tutte le udienze previste per il 20, compresa una dinanzi al
Tribunale di Brescia. La mattina del 20, mentre era “in preparazione spirituale
alla cremazione” riceve una telefonata da chi gestisce il centro per le
cremazioni. Gli dicono che si sono presentati i Carabinieri «per accertare – su
ordine della Procura di Brescia – l’identità della salma e chi fosse il figlio.
Ovviamente vado nel panico, visto il momento, perché non capisco cosa stia
accadendo».
In pratica l’avvocato Viazzo
viene a sapere, da un suo collega nominato d’ufficio, che un pm aveva inviato i
militari dell’Arma «per le verifiche del caso (cioè se mia mamma fosse morta o
viva, immagino, e a che ora fosse fissata l’operazione di cremazione). Sulla
base di questo, chiedeva il rigetto dell’impedimento e la trasmissione degli
atti al mio Consiglio dell’Ordine, cosa che il giudice faceva di buon grado».
Commenta così il legale: «Il pm può dubitare di tutto, anche se di fronte alla
morte dovrebbe esserci un limite. Può pure chiedere il rigetto del legittimo
impedimento perché la cremazione non è impedimento assoluto. Certo però non può
inviare i carabinieri a identificare una salma, perché un avvocato ha chiesto il
rinvio di un processo dove era prevista l’audizione di un solo teste del pm, che
oltretutto per la terza o quarta volta di seguito non si è neppure presentato».
Inoltre «è stata gravemente offesa la pietas verso mia mamma e il mio stesso
sentimento religioso. Se proprio questo pm dubitava della morte, poteva fare
accertamenti presso l’impresa funeraria, oppure chiamare telefonicamente il
centro cremazioni. Inviare una pattuglia è stato un gesto di oltraggio verso la
defunta (io credo nella vita dopo la morte), oltre che un discredito assoluto
verso la mia persona».
E aggiunge: «Immagino che il
pm si difenderà dicendo che l’ora della cremazione era serale, e quindi ben
potevo andare a Brescia. Osservazioni prive di senso, sia perché l’ora a me è
stata comunicata solo alle 12:55, sia perché – quanto alla mia partecipazione al
rito – non avevo nessun obbligo di preavvisare, ma solo di presentarmi in tempo.
Mica stavo andando ad un ricevimento di gala». L’avvocato, davvero afflitto e
sconcertato per quanto accaduto, ci confessa che alla fine «sono rimasto
talmente amareggiato che alla cremazione non ci sono andato, per timore di
trovare carabinieri o finanzieri. Mi pare che un comportamento così grave ed
oltraggioso della memoria di una defunta vada sanzionato, non tanto per me o mia
mamma, ma per il decoro della categoria dei magistrati».
Lo strano caso di Potenza.
GIULIA MERLO
su Il Domani l'01 aprile 2022.
Questo è un nuovo numero di In
contraddittorio, la newsletter di Domani sulla giustizia.
Ogni settimana, tutte le
notizie giuridiche degli ultimi giorni, il dibattito tra magistrati e avvocati,
le novità legislative e l’analisi delle riforme.
Per iscriverti gratuitamente
alla newsletter in arrivo ogni venerdì pomeriggio clicca qui, e segui tutti
i contenuti di In contraddittorio.
Cari lettori,
il dibattito sulla riforma
dell’ordinamento giudiziario prosegue nel suo consueto e difficile iter, che
potrebbe concludersi con un accordo politico entro lunedì. Per cambiare focus
dopo molti numeri dedicati a questo, la newsletter di questa settimana sceglie
di occuparsi in particolare di un caso che ha coinvolto il foro di Potenza e che
ha visto coinvolti un avvocato e un pm. Trovate i dettagli nella mia
ricostruzione, ma certamente la vicenda non è ancora chiusa.
Sul fronte dei contributi,
invece, questa settimana vengono ospitati due commenti sul tema del conflitto
ucraino, ma sul fronte delle sue implicazioni costituzionali. La giurista
Vitalba Azzollini affronta il tema del conflitto per capire se e come il nostro
paese può entrare in guerra.
Sempre su questo tema, il
filosofo Pasquale Pugliese si interroga sulla liceità dell’invio di armi in
Ucraina alla luce dell’articolo 11 della Costituzione.
LO STRANO CASO DI POTENZA
La storia è talmente
singolare da far supporre che ci sia ancora qualcosa di non emerso. Eppure, per
ora ha provocato scompiglio nel foro di Potenza e uno scontro molto duro tra
avvocati e la procura guidata da Francesco Curcio. Il caso è già arrivato al
procuratore generale di Cassazione e anche alla ministra della Giustizia, con
una interrogazione del senatore di Italia Viva, Giuseppe Cucca.
Riassumendo i fatti: un
penalista chiede il rinvio di una udienza per legittimo impedimento, presentando
un certificato medico. Il giudice la accoglie, la procura invece gli manda i
carabinieri a casa per un’ispezione, sente i suoi familiari, poi convoca il
medico. Ora sono entrambi indagati.
Le reazioni sono state molte:
tutto il foro e i vertici nazionali hanno condannato l’iniziativa del
procuratore. Mentre il procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio, ha scritto
una nota in cui spiega che «non si è proceduto ad indagini in ragione della mera
allegazione del certificato medico», ma sulla base «sia del vernale riassuntivo
di udienza del tribunale» e «soprattutto sulla base si ulteriori e diverse
circostanze di fatto concernenti la certificazione medica di cui si parla, che
hanno reso doverosi gli accertamenti in corso».
La presidente del Cnf, Maria
Masi, ha chiesto al procuratore generale di Cassazione, Giovanni Salvi, di
occuparsi del caso e lui ha risposto positivamente, aggiungendo però una frase
di auspicio che il «Consiglio Distrettuale di Disciplina di Potenza stia agendo
con la medesima tempestività ai necessari, paralleli accertamenti».
All’esito di una assemblea
degli iscritti indetta dall’Ordine degli avvocati di Potenza, sono stati
proclamati 8 giorni di sciopero.
Tuttavia, è ancora in corso un
ulteriore giallo: circolano infatti due verbali di udienza, che divergono in
modo evidente. Il primo, redatto a mano e in forma riassuntiva, dà conto dei
fatti come raccontati dall’avvocato. Il secondo, redatto in stenotipia durante
l’udienza fa luce sulle ragioni per le quali il pm sarebbe intervenuto: a fargli
sospettare che il certificato medico fosse falso, è stato il fatto che pochi
giorni prima l’avvocato aveva fatto istanza di rinvio per legittimo impedimento,
adducendo altra udienza concomitante in diverso foro, il pm chiede di fornire
documentazione della convocazione d’udienza ma l’avvocato non risponde più.
Salvo poi depositare richiesta di rinvio con certificato medico.
I dettagli sono molti, ho
provato a ricostruirli in questo articolo.
LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO
Non sembra accennare a
risolversi l’impasse intorno alla riforma dell’ordinamento giudiziario.
Tuttavia, dopo numerosi incontri tra la ministra e la maggioranza e un nuovo
slittamento dell’approdo in aula – ora fissato al 19 aprile – il tempo sembra
essere finito.
La ministra ha fissato un
nuovo incontro per il prossimo lunedì, prevedendo che non venga aggiornato fino
a che non si sarà trovato l’accordo.
Infatti, il presidente della
commissione Giustizia, Mario Perantoni, ha stabilito che martedì si inizierà
necessariamente a votare il testo, visto chesono arrivati anche i pareri del
governo sulle proposte emendative presentate dai gruppi. «L'approdo in aula è
previsto per il 19 e non sono pensabili ulteriori rinvii».
Il punto più critico rimane il
sistema elettorale del Csm: il centrodestra e Italia Viva non demordono sul
sorteggio, il ministero invece lo ritiene incostituzionale. Sono al vaglio
soluzioni di mediazione, come il sorteggio dei collegi, invece che dei
candidati. L’ipotesi, però, non convince i partiti. Con il risultato che tutto
rimane rinviato a lunedì.
QUI MILANO: L’ATTACCO A DE
PASQUALE
Non c’è pace per la procura di
Milano, oggi gestita dal facente funzioni Riccardo Targetti, in attesa che il
Csm nomini il nuovo procuratore capo. Il terremoto che è stato il caso Amara è
ancora fresco e gli attriti in procura rimangono forti, come ha dimostrato una
assemblea tra sostituti e aggiunti convocata da Targetti.
In quella sede è emersa la
necessità di riequilibrare i carichi di lavoro, soprattutto visti i bassi numeri
di fascicoli gestiti dal terzo dipartimento, quello dei reati economici
transnazionali guidato dall'aggiunto Fabio De Pasquale.
Per questo Targetti ha emesso
un provvedimento provvisorio che durerà fino al 25 giugno, in cui si vuole porre
rimedio alla «importante anomalia riguardo al III Dipartimento» (quello
dell’indagine Eni-Nigeria), costituito dall’ex procuratore capo Francesco Greco,
in merito alla «significativa sproporzione nelle assegnazioni di fascicoli».
In un triennio il pool di De
Pasquale ha avuto sopravvenienze di 82 fascicoli, mentre gli altri dipartimenti
hanno numeri che superano il migliaio, come i circa 7mila del pool “fasce
deboli”.
L’assemblea ha avuto momenti
di forte contrasto: De Pasquale avrebbe mostrato un documento con le firme di 22
pm per il riassetto degli incarichi, sostenendo che era fuori ruolo che alcuni
procuratori criticassero il lavoro dei colleghi in quel modo e sollevando
possibili profili formali e disciplinari.
In ogni caso, ora il III
Dipartimento dovrà farsi carico delle truffe assicurative e i fascicoli della
"materia ordinaria", come calunnie, diffamazioni e appropriazioni indebite.
Il III Dipartimento, però, è
da anni un tema scottante e, come si legge nei verbali allegati al provvedimento
di Targetti, alcuni magistrati hanno parlato di «creazione del dipartimento che
ha creato un vulnus».
In particolare, la pm
Giancarla Serafini ha parlato di «malcontento di sostituti», che è «alimentato
dal fatto che ci sono pm che si possono permettere di fare indagini importanti
perchè non gravati da una massa enorme di fascicoli» e che «vedono con assoluto
fastidio il privilegio di chi invece le indagini si può permettere di farle».
In ogni caso, De Pasquale e
gli altri 5 pm del Dipartimento hanno scritto una lettera in cui dicono che «in
un'ottica di solidarietà d'ufficio e sino alla definizione dei nuovi criteri
organizzativi, la disponibilità ad un aumento delle assegnazioni
dell'ordinario».
CALANO I REDDITI DEGLI
AVVOCATI
L’ordine degli avvocati di
Milano ha svolto insieme all’Università Cattolica un sondaggio per valutare
l’impatto del covid sui redditi degli avvocati milanesi.
Su un campione di 810 avvocati
che hanno risposto, «il 56% ha visto ridursi il proprio reddito personale» e
circa la metà di questi ha avuto «un calo tra il 10 e il 50%».
Tra i numeri contenuti nel
documento ci sono quelli sull'impatto dell’emergenza sanitaria sulla
professione: tra i 447 titolari di studio o soci di società tra avvocati, il 68%
dichiara di aver subito un calo di fatturato e, tra questi, oltre due terzi
dichiara un calo tra il 10 e il 50%. Qui per leggere il bilancio di
sostenibilità pubblicato.
GLI ORGANI DI AUTOGOVERNO
MERCOLEDÌ 31 MARZO SI È SVOLTO
PRESSO LA LUISS GUIDO CARLI UN CONVEGNO DAL TITOLO “LA CORTE DEI CONTI AL
SERVIZIO DEL PAESE PER UNA RIPRESA ECONOMICA EQUA ED EFFICIENTE”, IN RICORDO DEL
PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE DEI CONTI, LUIGI GIAMPAOLINO. A ORGANIZZARLA, IL
CENTRO DI RICERCA SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, “VITTORIO BACHELET” E
L’ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI.
Particolarmente significativo
è stato il dibattito della prima tavola rotonda, dal titolo “Gli organi di
autogoverno delle magistrature”, a cui hanno preso parte i rappresentanti di
tutti gli organi di autogoverno: il presidente della Corte di Cassazione Pietro
Curzio, il Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, il Presidente
della Corte dei conti Guido Carlino, il Procuratore Generale Militare presso la
Corte Suprema di Cassazione Maurizio Block, il Presidente del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria Antonio Leone, l’Avvocato generale
aggiunto dello Stato Leonello Mariani, il Professor Aristide Police e il
Professor Raffaele Bifulco.
Per rivederla, questo è il
link di Radio Radicale.
L’AVVOCATURA SUL CSM
Alla luce del dibattito
piuttosto acceso sulla legittimità del voto agli avvocati nei consigli
giudiziari per valutare la professionalità dei magistrati, il Consiglio
nazionale forense ha organizzato un convegno dal titolo “La riforma
dell’ordinamento giudiziario e il ruolo dell’avvocatura”.
Interessante è stato il
confronto tra la presidente del Cnf, Maria Masi, e il presidente
dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia.
Anche in questo caso, è
possibile rivedere il convegno a questo link.
CAOS IN OCF, AGGIORNAMENTI
In attesa dell’assemblea
dell’8 aprile, in cui si voterà il nuovo ufficio di coordinamento e si discuterà
la situazione politica interna all’Organismo congressuale forense, sono arrivate
le dimissioni del tesoriere.
L’avvocato Alessandro Vaccaro,
infatti, si è dimesso anche dall’assemblea di Ocf e non più solo dall’ufficio di
coordinamento. A suo carico pesa ancora però il mancato chiarimento
sulle ragioni dei bonifici dal conto dell’Organismo al suo personale, che poi
venivano da lui ri-bonificate.
Intanto, l’attività di
controllo sui conti continuano e, secondo indiscrezioni, sarebbero state trovate
anomalie anche nelle causali dei bonifici e dei pagamenti contestati a Vaccaro e
nelle spese effettuate dall’ufficio di coordinamento.
Per chiarimenti confermati e
più puntuali, però, bisognerà aspettare la relazione del comitato che sta
analizzando i bilanci.
REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA
E’ stato fissato il giorno in
cui si voterà per i referendum sulla giustizia: il 12 giugno, in concomitanza
con il primo turno delle elezioni amministrative.
I quesiti riguardano la
giustizia e riguardano il sistema elettorale del Csm, la valutazione delle
toghe, abrogazione della legge Severino, modifica delle misure cautelari,
separazione delle funzioni in magistratura.
Qui un piccolo schema
riassuntivo, per capire i contenuti dei referendum e come si intersecano con la
riforma dell’ordinamento giudiziario.
ll dato politico, però,
riguarda il fatto che la Lega, proponente i referendum, di troverà
contemporaneamente seduta al tavolo per riformare in via parlamentare il ddl
sull’ordinamento giudiziario e impegnata in campagna elettorale per sostenerne
una modifica in via referendaria.
GIULIA MERLO. Mi occupo di
giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla
Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato.
Le esigenze difensive
intralciano sempre il processo. E quelle del giudice?
Gian Domenico Caiazza, Presidente UCPI – Unione Camere Penali Italiane, su Il
Corriere del Giorno l'1 Aprile 2022.
La cosa che pochi sanno è che
in Italia tra le cause più diffuse del rinvio, e dunque della lentezza dei
processi vi è l’impedimento del giudice, non quello del difensore. Non sia mai
che si metta il naso nelle carriere del giudice. Intanto, andiamo ad indagare
sul certificato dell’avvocato di Potenza, o sulla effettiva dipartita della
mamma di quell’avvocato di Brescia.
Fa notizia che un avvocato
risulti indagato, in quel di Potenza, per avere osato chiedere il rinvio di una
udienza in quanto malato, come da allegato certificato medico. Sull’abbrivio di
questa notizia, il giorno dopo ne salta fuori un’altra: a Brescia il difensore
chiede un rinvio perché gli è morta la madre, e il Tribunale manda i Carabinieri
a verificare se la signora sia davvero nella bara. Chi dovesse stupirsi di
simili notizie, sappia che si tratta invece di comportamenti abituali nelle aule
di giustizia. Intorno alle ragioni di impedimento del difensore vige da anni, in
ogni parte di Italia, una diffusa presunzione falsità, o almeno di insidiosa
pretestuosità. Forse è un riflesso legato alle antiche conseguenze di tali
richieste di rinvio delle udienze, quando cioè ancora esse determinavano il
proficuo maturare della prescrizione del reato contestato all’imputato.
Ma non è più così sin dal
2005, quando l’art. 159 del Codice penale fu modificato prevedendo, tra le cause
di sospensione del corso della prescrizione, i rinvii del processo
determinati “per ragione di impedimento delle parti e dei difensori, ovvero su
richiesta dell’imputato e del suo difensore” Ma come! direte voi: e tutta quella
storia raccontata, ancora oggi, dai pifferai del populismo giustizialista,
secondo la quale gli avvocati, soprattutto quelli di imputati ben paganti,
inventano mille diavolerie per far maturare la prescrizione? Beh, peggio per voi
che vi bevete le balle di Travaglio e compagnia.
Ma torniamo a noi. Sarà per
questo, o per la radicata idea manzoniana dell’azzeccagarbugli, sta di fatto che
di regola il giudice pensa che il difensore stia ordendo un inganno, sicché sono
all’ordine del giorno poco edificanti storie come quelle di Potenza e Brescia.
Il difensore è, di default, un sabotatore del processo, un potenziale intralcio
al sereno corso della giustizia: questa è l’idea dell’avvocato assolutamente
prevalente nel nostro Paese. Ma la cosa che pochi sanno è che in Italia tra le
cause più diffuse del rinvio, e dunque della lentezza dei processi vi è
l’impedimento del giudice, non quello del difensore. Dalla indagine statistica
dell’Istituto Eurispes, commissionata dalle Camere Penali Italiane e riferite
all’anno 2019, risulta che i rinvii dovuti alla “assenza del giudice
titolare” sono il 3,3%; cui devono aggiungersi i rinvii dovuti a “precarietà del
collegio” (0,3%), per assenza del P.M. titolare (0,2%), per un totale del 3,8%;
contro il 2,1% dei rinvii per impedimento del difensore.
Con l’aggravante che questi
ultimi, come si è detto, fermano il decorso dei termini di prescrizione,
mentre i rinvii dovuti ad assenza di Giudici e PM no. Ovviamente nessuno sindaca
le ragioni degli impedimenti dei giudici, che devono ritenersi giustificati e
legittimi ex se, tanto quanto sono sospetti di strategie fraudolente quelli
degli avvocati. Il quadro, poi, si è oggi ulteriormente aggravato, da quando i
giudici medesimi hanno in via interpretativa scardinato la sacrosanta regola
processuale che impone la ripetizione della istruttoria dibattimentale se in
corso di processo cambia il giudice. Con una sentenza emblematica del potere del
tutto fuori controllo che i giudici italiani si sono assegnati nell’interpretare
le norme anche contro la evidenza della loro testualità, le sezioni unite hanno
sancito di fatto l’abrogazione di quel principio, dando così corpo ad una antica
loro ossessione che il legislatore non aveva voluto recepire. Il risultato è che
ormai assistiamo ad un bailamme di giudici che cambiano in corso di causa ad
ogni piè sospinto.
La motivazione formale
starebbe nella tutela della ragionevole durata del processo, ma la sostanza è
ben altra, ed è a tutto tondo di autoprotezione corporativa. Infatti, basterà
chiedersi: ma perché il giudice cambia in corso di causa? La risposta è ovvia:
cambia per ragioni di carriera. Vuole cambiare funzione, o Foro, o anche
semplicemente sezione, e questo è del tutto legittimo; ma vuole poterlo fare
senza vincoli ed intralci, e questo lo è molto meno. Questo profilo della
questione non è minimamente indagato dalle severe Sezioni Unite.
Il problema delle conseguenze
del cambio del giudice -che pregiudica il sacrosanto diritto dell’imputato ad
essere giudicato dal medesimo giudice che ha assunto la prova – è stato dunque
affrontato del tutto a prescindere da una indagine sulle cause di quel cambio.
Non sia mai che si metta il naso nelle carriere del giudice. Non sia mai che si
pretenda che questi attenda almeno di esaurire il ruolo delle proprie udienze
prima di trasferirsi. State alla larga dai fatti nostri. Intanto, andiamo ad
indagare sul certificato dell’avvocato di Potenza, o sulla effettiva dipartita
della mamma di quell’avvocato di Brescia. Giusto, no?
Potenza. Gli avvocati
contro l’arroganza della Procura: 8 giorni di astensione da tutte le udienze
penali, civili, amministrative e tributarie.
Redazione CdG 1947 su Il
Corriere del Giorno l'1 Aprile 2022.
La Giunta nazionale dell'
Unione Camere Penali Italiane pur esprimendo apprezzamento per le petizioni di
principio rivendicate dal Procuratore Curcio, ritiene ora più che mai
indispensabile un accertamento chiaro, definitivo ed inequivoco di quanto
accaduto, perché occorre con certezza sapere se sia mai potuto accadere che un
avvocato possa essere indagato per avere semplicemente certificato la propria
malattia, ciò costituendo una inaudita aggressione alla dignità ed ai diritti
fondamentali del difensore; o quale sia altrimenti, senza residui equivoci,
quella alternativa e diversa spiegazione che finalmente vorremmo comprendere
L’Assemblea dell’Ordine degli
avvocati di Potenza convocata d’urgenza per prendere posizione sul caso su cui
la Procura generale della Corte di Cassazione ha avviato accertamenti in sede
pre-disciplinare e sul quale sono state già presentate alcune interpellanze
parlamentari, ha proclamato oggi l’astensione da tutte le udienze penali civili
amministrative e tributarie per il massimo dei giorni ( otto) previsti dal
regolamento . Stigmatizzato lo sgarbo istituzionale del Procuratore Capo che è
intervenuto sulla stampa con un lungo comunicato pieno di inesattezze, ancora
prima di incontrare il consiglio dell’ordine e la camera penale.
Anche l’ Unione Nazionale
delle Camere Penali, ha emesso ieri sera una nota abbastanza dura. “Abbiamo
atteso con pazienza condividendo ed apprezzando le prese di posizione della
avvocatura potentina, a partire da quella espressa dalla Camera Penale della
Basilicata, che la Procura della Repubblica di Potenza fornisse una spiegazione
del clamoroso atto investigativo svolto nei confronti di un avvocato che,
impedito a comparire per ragioni di salute, aveva fatto depositare in udienza il
relativo certificato medico. Ciò in quanto l’accesso della Polizia Giudiziaria,
lo stesso giorno, prima presso l’abitazione del Collega con medico al seguito, e
poi nello studio, nonostante il Tribunale avesse in udienza respinto la
richiesta di visita fiscale avanzata dal P.M. e ritenuto legittimo l’impedimento
del difensore, recava in sé le stimmate di un atto di tale inaudita gravità e di
grossolana illegalità da indurci ad immaginare ragioni investigative diverse da
quelle apparenti“.
“Senonché la lunga nota
diramata ieri dal Procuratore dott. Francesco Curcio – continua la nota – pur
fondata su lunghe premesse volte a ritenere inconcepibile, e del tutto estranea
ai convincimenti ed al costume giudiziario di quell’Ufficio, una reazione
ritorsiva quale quella denunziata dalla avvocatura, fornisce una spiegazione
contraddittoria, oscura nella rappresentazione dei fatti ed alla fine
semplicemente incomprensibile. Ciò sollecita questa Giunta a rivolgersi al
Procuratore Generale ed al Presidente del Tribunale di Potenza, perché rendano
edotti tutti noi di quanto effettivamente accaduto. Ed infatti, secondo il
Procuratore dott. Curcio: L’iniziativa investigativa, non abbiamo compreso se
relativa ad una indagine in qualche modo precedente ed autonoma rispetto ai
fatti accaduti in aula, sarebbe comunque stata alimentata dalla trasmissione
“urgente” del verbale di udienza da parte del Tribunale“.
“Dunque il Tribunale da un
lato avrebbe ritenuto legittimo l’impedimento, respingendo la richiesta del PM
di disporre visita fiscale, e dall’altro avrebbe ritenuto sussistere in quei
fatti una qualche notizia criminis, tale da imporne una urgente segnalazione al
Procuratore della Repubblica; La Polizia Giudiziaria, recatasi – per ragioni che
continuiamo a non comprendere – prima nell’abitazione e poi nello studio del
Collega, avrebbe portato con sé un medico “di propria iniziativa”, dunque non su
disposizione della Procura.È agevole constatare la assoluta incongruenza della
articolata spiegazione che il Procuratore della Repubblica ha inteso dare
pubblicamente” continua l’ Unione delle Camere Penali.
“Con essa, nell’intento di
respingere la fondatezza delle proteste dell’avvocatura, non solo finisce per
confermarla, ma anzi ne aggrava il quadro, prospettando da un lato una condotta
inspiegabilmente contraddittoria del Tribunale, e dall’altra una iniziativa del
tutto abusiva della Polizia Giudiziaria.La Giunta UCPI, pur esprimendo
apprezzamento per le petizioni di principio rivendicate dal Procuratore Curcio,
ritiene ora più che mai indispensabile un accertamento chiaro, definitivo ed
inequivoco di quanto accaduto, perché occorre con certezza sapere se sia mai
potuto accadere che un avvocato possa essere indagato per avere semplicemente
certificato la propria malattia, ciò costituendo una inaudita aggressione alla
dignità ed ai diritti fondamentali del difensore; o quale sia altrimenti, senza
residui equivoci, quella alternativa e diversa spiegazione che finalmente
vorremmo comprendere” conclude l’ UCPI.
Sulla vicenda è intervenuto
l’avvocato e responsabile regionale del Dipartimento Giustizia di Italia Viva
Basilicata, Antonio Di Lena: “Oggi in qualità di avvocato e di dirigente
politico ho preso parte all’Assemblea dell’Ordine che si è svolta a Potenza a
seguito della grave vicenda a cui è stato sottoposto l’avvocato Antonio Murano
da parte della Procura di Potenza” che ha aggiunto “Va immediatamente fatta luce
su quello che appare un clamoroso atto investigativo svolto nei confronti di un
avvocato di Potenza che appare, così come già dichiarato dalla Camera penali
nazionali di inaudita gravità. Per questo di rende indispensabile un
accertamento chiaro, definitivo ed inequivoco di quanto accaduto anche a seguito
di notizie di stampa secondo cui ci sarebbero dei verbali modificati
successivamente. “Per questo ritengo doveroso stigmatizzare questa mancanza di
rispetto del ruolo difensivo e mi associo – conclude – alla richiesta
dell’Ordine di fare piena luce sulla vicenda affinché non vengano mai più
compromesse le garanzia difensive con la delibera di astensione da tutte le
attività per il periodo massimo consentito e cioè dal 14 al 26 aprile prossimi”.
Redazione CdG 1947
Quel caso dell'avvocato di
Potenza che scuote il Parlamento.
Francesco Boezi il 29 Marzo 2022 su Il Giornale.
Il senatore d'Italia Viva
Giuseppe Cucca presenta un'interrogazione su una perquisizione dello studio di
un avvocato che non poteva partecipare ad un'udienza per motivi di salute.
Un'interrogazione parlamentare
presentata dal senatore Giuseppe Cucca, un esponente d'Italia Viva che da sempre
si occupa di temi legati alla Giustizia, sul caso di un avvocato di Potenza il
cui studio, secondo quanto si legge dal testo presentato dal renziano, è stato
perquisito per ordine del pm, nonostante il legale avesse dribblato un'udienza
per meri motivi di salute.
Ma non viene rimarcato
soltanto il "dettaglio" della perquisizione. Il senatore Giuseppe Cucca, come
ripercorso dall'Ansa, ci ha tenuto a ricostruire il quadro: "Ho presentato
un'interrogazione urgente alla Ministra Cartabia - ha premesso - per chiedere
conto di un grave fatto avvenuto a Potenza dove un avvocato ha richiesto il
differimento di un'udienza per ragioni di salute, accordato da il tribunale".
Poi viene spiegato quello che
sarebbe stato predisposto dal Pubblico ministero: "Il pm peró ha deciso di
mandargli a casa i carabinieri e un medico, indagarlo e disporre una
perquisizione dello studio del professionista che aveva redatto il certificato".
Atti che il parlamentare del
partito guidato da Matteo Renzi ritiene dunque privi di una reale base in grado
di motivarli. Peraltro il tutto viene condito da un dettaglio giuridico in grado
di spiegare, per Cucca, l'incomprensibilità di quanto sarebbe stato deciso dal
Pm: "Non si comprendono le ragioni di un tale dispiego di forze e personale per
un mero rinvio dell'udienza rispetto ad un procedimento penale non prossimo alla
prescrizione, i cui termini sarebbero rimasti, in ogni caso, sospesi proprio in
virtù del differimento per motivi di salute del difensore". In buona sostanza,
l'assenza dell'avvocato non avrebbe avuto alcuna rilevanza rispetto ai termini
di prescrizione.
Il senatore, che è anche il
vice del gruppo d'Iv a Palazzo Madama, ha dunque voluto chiedere spiegazioni al
ministro Marta Cartabia: "Per questo chiedo alla Ministra di adoperarsi affinché
tali fatti siano chiariti e non si ripetano", ha chiosato.
Quanto avvenuto nel capoluogo
lucano è stato commentato anche dal segretario generale dell'Associazione
Nazionale Forense Giampaolo Di Marco: "La denuncia dell'avvocato Antonio Murano,
del Foro di Potenza, che, dopo avere chiesto il rinvio di un'udienza alla quale
non poteva presenziare per motivi di salute, istanza accolta dal collegio del
Tribunale, ha ricevuto una visita fiscale a casa, all'esito della quale ha
scoperto di essere indagato, mentre il medico è stato a lungo interrogato in
caserma, è, nella migliore delle ipotesi, un eccesso delle prerogative del
magistrato", ha fatto presente il rappresentante dell'ente associativo, così
come rimarcato dalla fonte sopra citata.
Legale a giudizio: notizia
alla stampa, poi a lui, of course.
I pm chiedono il procedimento
immediato per Antonio Murano, l’avvocato di Potenza finito sotto inchiesta dopo
essersi assentato in udienza per malattia. Nella nota con cui la Procura
riferisce lo sviluppo, dice che “la legge è uguale per tutti”. E uguale per
tutti è anche la circostanza di doverne essere informati dai giornali. Gennaro
Grimolizzi su Il Dubbio l'1 luglio 2022.
È ancora alta la tensione tra
la Procura di Potenza e l’avvocatura del capoluogo lucano sul caso Murano.
Qualche giorno fa è stato
disposto da parte del Gip del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura,
il giudizio immediato per gli avvocati Antonio e Pasquale Murano e per altre
quattro persone, coinvolte nella vicenda dei certificati medici e dei rinvii
delle udienze penali. La Camera penale distrettuale di Basilicata ora passa al
contrattacco. E lo fa sollevando una serie di questioni che riguardano le
notizie date in anteprima alla stampa e il trattamento riservato al legale.
A lasciare sconcertati i
penalisti lucani è stato l’intero modus procedendi. Per questo motivo è stata
indetta una conferenza stampa nella mattinata di oggi per porre all’attenzione
alcuni aspetti della vicenda.
Nello scorso marzo, dopo
essersi assentato in udienza presentando un certificato medico, l’avvocato
Antonio Murano ha ricevuto la visita fiscale ed è stato sottoposto ad alcuni
controlli da parte dei carabinieri nel suo studio.
«La notizia giornalistica –
evidenzia Sergio Lapenna, presidente della Camera penale distrettuale di
Basilicata – relativa al giudizio immediato disposto nei confronti degli
avvocati Murano e alla nota del Procuratore della Repubblica, Francesco Curcio,
con la quale si è resa nota questa circostanza e si è sottolineata l’intenzione
dell’ufficio di dare sempre concretezza al principio per cui la legge è uguale
per tutti, ci induce a precisare una serie di aspetti. Ciò anche in conseguenza
della decisione che ha indotto l’avvocatura potentina a proclamare un’astensione
dalle udienze lo scorso mese di aprile».
Lapenna lamenta la classica
fuga di notizie, con la conseguenza, per i diretti interessati, di apprendere
prima dalla stampa le questioni che li riguardano. «Spiace sottolineare – dice
Lapenna – che, a differenza di quanto dovrebbe sempre avvenire nelle vicende di
giustizia, il provvedimento che ha disposto il giudizio immediato a carico dei
colleghi Murano è stato anticipato dalla Procura di Potenza agli organi di
stampa, addirittura prima che lo stesso fosse notificato agli interessati, senza
tener conto degli indirizzi voluti dal legislatore il quale, con un recente
provvedimento di legge, ha previsto che tutti gli uffici di Procura si
rapportino agli organi di stampa con misura e sobrietà nel rispetto della più
generale presunzione d’innocenza di tutti i cittadini indagati. Quanto al
contesto della vicenda, senza entrare nel merito dei fatti che saranno accertati
nelle sedi competenti, non si può fare a meno di sottolineare che la censura
espressa dall’avvocatura sull’indirizzo dell’attività investigativa ha
riguardato il “metodo” con il quale si è proceduto».
Cosa impensierisce la Camera
penale di Basilicata? «In particolare – prosegue il presidente Lapenna – abbiamo
lamentato la scelta di un modus procedendi invasivo, quale la visita presso il
domicilio dell’avvocato Antonio Murano, senza il rispetto delle garanzie
difensive codicistiche. Infatti, tale azione non è stata preceduta né da un
avviso di garanzia né da qualsiasi atto prodromico che potesse in qualche modo
legittimarlo. Parimenti, la visita presso lo studio del professionista da parte
dei carabinieri per visionare le registrazioni videofilmate non è stata
preceduta né dall’avviso prescritto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Potenza né da un atto di garanzia previsto per tutti i casi in cui è considerata
la partecipazione dell’indagato».
Parità di trattamento per
tutti, ma anche oculatezza in riferimento a certi metodi utilizzati.
«L’avvocatura – conclude il presidente della Camera penale – concorda sul
principio che la legge debba essere uguale per tutti e che per ogni imputato
vige la presunzione di innocenza, fino a sentenza passata in giudicato, ma
sottolinea che le regole e le garanzie difensive vadano anch’esse rispettate per
tutti gli indagati ed imputati, a prescindere se siano avvocati o meno».
Continuano le follie della
procura di Potenza. L’avvocato è malato, il pm lo fa perquisire e non contento
poi lo indaga.
Redazione CdG 1947 su Il Corriere del Giorno il 29 Marzo 2022.
La vicenda assurda è capitata
ad un legale di Potenza che richiesto il differimento dell’udienza per motivi di
salute. Il magistrato ha deciso di mandargli a casa i Carabinieri ed un medico.
Sulla vicenda sono intervenuti annunciando due parlamentari alla Camera ed al
Senato con interrogazioni rivolte al Ministro di Giustizia. Rivolta
dell'avvocatura italiana contro il magistrato della Procura di Potenza
Nel Palazzo di Giustizia di
Potenza la “follia” ed arroganza giudiziaria sembrano non avere limiti. In
occasione di un’udienza penale tenutasi lo scorso 24 marzo dinnanzi al Tribunale
Penale, l’ avvocato Antonio Murano con studio a Rionero in Vulture (PZ) con
motivi di salute certificati, la sera prima era stato colpito da una fortissima
colica al punto da richiedere l’intervento del medico, è stato impossibilitato,
a raggiungere il Palazzo di giustizia del capoluogo lucano ed ha richiesto
verbalmente, per il tramite di un collega, il differimento dell’udienza.
L’ assenza peraltro
giustificata dell’avvocato è stata recepita da parte del Collegio B, presieduto
dal giudice Federico Sergi, che dopo aver ricevuto non solo via Pec, ma anche in
originale attraverso l’imputato l’attestazione medica, ha accolto l’istanza del
legale che peraltro non avrebbe causato problemi allo svolgimento del processo
dal momento che il legittimo impedimento del difensore interrompe
automaticamente il decorso della prescrizione . A questo punto, però, è successo
qualcosa che non può e non deve passare inosservata.
Il Collegio giudicante ha
rigettato ben due richieste del pm Giuseppe Borriello, che tendeva a verificare
le condizioni dell’avvocato assente per motivi di salute. Ma non solo. Infatti
il magistrato lucano ha presentato al Tribunale anche un’istanza in merito alla
contestata trasmissione del certificato alla Procura della Repubblica. Rigettata
come la prima. Non contento il pubblico ministero, ha deciso di mandare i
Carabinieri a casa dell’avvocato senza alcun provvedimento giudiziario, il quale
ha scoperto essere addirittura stato iscritto nel registro degli indagati della
Procura lucana con l’accusa di “false dichiarazioni o attestazioni in atti
destinati all’Autorità giudiziaria”, reato punito dal codice con una pena che
prevede 6 anni di prigione.
“Dopo qualche ora nel primo
pomeriggio intorno alle 14, l’inaspettato arrivo nella mia dimora di un medico.
Si è presentato accompagnato dai Carabinieri per effettuare una visita disposta
dalla Procura di Potenza” racconta l’avvocato Murano, che ha ritenuto opportuno
informare anche il Consiglio nazionale forense, le Camere penali ed il Csm.
“Pur non essendo questi visitatori muniti di alcun provvedimento giudiziario, e
pur in assenza delle obbligatorie informazioni previste dagli articoli 369 e
369-bis del Codice di procedura penale, animato da uno spirito collaborativo e
non avendo alcunché da occultare non mi sono opposto. Ho consentito quindi al
medico di verificare il mio status“.
L’avvocato Murano, noto
penalista con quasi quarant’anni di carriera, apprezzato in Basilicata e fuori
regione, non nasconde la propria amarezza. “Ho pensato che si trattasse di una
esagerazione, immaginando che qualcuno avesse potuto dubitare della genuinità
del certificato attestante la mia malattia, anche se non mi pare che sia mai
stata disposta un’ispezione medica su un avvocato, né in tantissimi anni di
onorata professione mi è mai capitato di sentire un episodio simile” commenta il
legale.
“Ad ogni modo, consentita la
visita alla quale mi sarei potuto lecitamente opporre e concessa al medico
inviato dalla Procura la facoltà di verificare le mie condizioni, ho sperato che
la faccenda fosse chiusa”. Ma invece non è andata così. Le cose si sono
complicate ulteriormente coinvolgendo persino alcuni parenti stretti del legale.
“Con stupore ho appreso di essere addirittura indagato, non so per cosa, e
nell’ambito di tali indagini sono stati disposti gli interrogatori di mia madre,
che ha più di ottant’anni, mio fratello e mio figlio Pasquale, che svolge con me
la professione forense” spiega l’ avvocato Murano.
Non contento il magistrato
Borriello ha coinvolto anche il medico, il dr. Donato Labella stimato
professionista “colpevole, è proprio il caso di dirlo – aggiunge
l’avvocato Murano – di avermi visitato e redatto il certificato che è stato
trattenuto per circa tre ore nella caserma dei Carabinieri di Rionero in
Vulture, in provincia di Potenza, attinto da decreto di perquisizione locale e
personale e decreto di sequestro del telefonino, vedendosi privato del
dispositivo contenente le applicazioni relative all’identità digitale,
necessarie, tra le altre cose, a firmare le guarigioni da Covid-19 e disporre la
fine della quarantena dei suoi pazienti”.
Ma non è finita. Alle otto di
sera un’altra pattuglia di Carabinieri si è recata nello studio di Murano per
acquisire le immagini della video sorveglianza. Acquisizione che non produceva
alcunchè non essendo le telecamere funzionanti con registrazione.
L’avvocato Murano, scosso da quanto accaduto, ha scritto una lettera a tutti i
vertici degli uffici giudiziari lucani, al presidente della Corte d’appello e
procuratore generale inclusi, alla Procura di Catanzaro ed al Consiglio
superiore della magistratura.
Una giornata lunghissima e da
dimenticare quella del 24 marzo scorso per l’avvocato Murano. Con l’aggiunta di
ulteriori anomalie e forzature. Come racconta il quotidiano IL DUBBIO emanazione
del Consiglio Nazionale Forense: “In prima serata – spiega l
‘avvocato Murano -, verso le 20, i Carabinieri si sono recati, in mia assenza,
presso il mio studio legale di Rionero in Vulture. Con tatto e discrezione, non
posso negarlo, hanno chiesto di acquisire le registrazioni della
videosorveglianza. Anche in tale occasione la richiesta appare anomala, in
quanto non mi è stato notificato alcun avviso di garanzia che legittimasse atti
invasivi della privacy e, quindi, pur sussistendo i presupposti per opporsi,
veniva consentito l’accesso, che non dava alcun esito in quanto il sistema non
era funzionante. Tutto si è verificato senza che io abbia ricevuto, ad oggi,
un’informazione di garanzia o qualunque altro provvedimento, a fronte di azioni
fortemente invasive del campo professionale e privato. Né si comprende la
ragione di un simile sospetto che ha portato all’immediata iscrizione della
notitia criminis con cotanto dispiego di forze, posto che il procedimento penale
oggetto di rinvio non è prossimo alla prescrizione, i cui termini sarebbero
rimasti, in ogni caso, sospesi, visto il differimento per motivi di salute del
difensore“.
Quanto accaduto qualche giorno
fa nel Tribunale di Potenza e nella città di Rionero, un tempo rientrante nel
circondario del Tribunale di Melfi, soppresso nel 2013, non ha precedenti sia
per la storia dell’avvocatura che in quella della magistratura. “Ritengo –
commenta l’avvocato Murano – quanto accaduto di una abissale gravità a maggior
ragione se si tiene conto che il Collegio aveva ritenuto inopportuno qualsiasi
accertamento, rigettando la relativa richiesta. È il momento, da parte di tutti
gli organismi forensi e dell’intera avvocatura, di intraprendere ogni iniziativa
volta a dare risalto con decisione all’accaduto al fine di affermare con forza
il decoro ed il prestigio della classe forense, denigrato ed umiliato da episodi
come quelli che mi hanno interessato, evitando, con fermezza, che possano
incrinare i rapporti di stima tra magistratura e avvocatura, con azioni
ingiustificatamente dirompenti, la cui eco rischierebbe di proscrivere anche le
più banali facoltà difensorie nell’alveo della paura di vedersi colpiti da
simili episodi“.
Interrogazioni parlamentari
Sulla vicenda sono intervenuti
annunciando due interrogazioni parlamentari al Ministro di Giustizia presentate
dall’ Onorevole Carmelo Miceli (PD) avvocato siciliano e membro della
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati , e dal Senatore Giuseppe Luigi
Salvatore Cucca (PSI-IV) avvocato sardo e membro della Commissione Giustizia del
Senato della Repubblica .
“Quanto accaduto nel Tribunale
di Potenza mi ha lasciato davvero senza parole. Mi sto abituando a tutto, ma
trattare così un avvocato non può che farmi preoccupare. Stiamo vivendo un
momento di grandi tensioni per quanto riguarda i rapporti tra avvocatura e
magistratura. I magistrati devono rispettare la legge e non sentirsi al di
sopra” dice il senatore Cucca che con la sua interrogazione mira a chiarire
tutti i contorni della vicenda. “Voglio sapere se la ministra Cartabia è a
conoscenza dei fatti e quali sono i suoi intendimenti in merito. Inoltre, voglio
conoscere le iniziative che la ministra ritiene di adottare per prevenire il
ripetersi di vicende come quelle accadute presso il Tribunale di Potenza. È
emerso da quanto si apprende che il potere requirente ha tentato di interferire,
travalicando i propri poteri e le proprie competenze, su decisioni già assunte
dall’organo giudicante. Occorre evitare che, tramite azioni sproporzionate e
ingiustificate, si possano incrinare i rapporti di leale collaborazione che
devono sussistere tra magistratura e ordine forense” aggiunge il senatore Cucca.
L ’iniziativa intrapresa dal senatore di Italia Viva, ha l’obiettivo di far
svolgere un’ispezione nel Tribunale di Potenza ed una segnalazione del caso al
Procuratore generale della Corte di Cassazione. “Spero che quanto accaduto
all’avvocato Murano ottenga la massima attenzione da parte del Consiglio
nazionale forense” conclude Cucca.
Le reazioni degli avvocati
Il Consiglio dell’ ordine
degli Avvocati di Potenza ha immediatamente convocato per venerdì un’ assemblea
per discutere sull’accaduto e decidere sulle azioni da intraprendere. Ed anche
la Camera Penale di Potenza sta vagliando le opportune iniziative da
intraprendere.
Immediatamente è scattata la
puntale solidarietà dei colleghi. Sono intervenute diverse associazioni forensi.
“Non è concepibile in uno stato di diritto che si possa soltanto immaginare
quanto è accaduto” ha commentato l’ avvocato Nino La
Lumia del Movimento forense. L’ OCF- organismo congressuale forense attraverso
il coordinatore Giovanni Malinconico, scrive in una nota : “Davanti a vicende
come questa si resta attoniti. Il capriccio intimidatorio di un pm, perché di
questo si tratta, oltre a suonare come un inaccettabile schiaffo all’intera
classe forense, incide in modo gravissimo sul diritto di difesa a danno della
parte assistita dal Collega e della stessa Giustizia. L’OCF, oltre a portare la
propria solidarietà al Collega Murano e al COA di Potenza, segnalerà la vicenda
al Ministro della Giustizia Cartabia, affinché disponga quanto prima
un’ispezione presso la Procura di Potenza e assuma tutti i conseguenti
provvedimenti”.
Quanto avvenuto nel capoluogo
lucano è stato commentato anche da Giampaolo Di Marco segretario generale
dell’Associazione Nazionale Forense : “La denuncia dell’avvocato Antonio Murano,
del Foro di Potenza, che, dopo avere chiesto il rinvio di un’udienza alla quale
non poteva presenziare per motivi di salute, istanza accolta dal collegio del
Tribunale, ha ricevuto una visita fiscale a casa, all’esito della quale ha
scoperto di essere indagato, mentre il medico è stato a lungo interrogato in
caserma, è, nella migliore delle ipotesi, un eccesso delle prerogative del
magistrato“.
La Camera penale distrettuale
di Basilicata in una nota ha scritto che “l’attività posta in essere dalla
Procura costituisce un anomalo utilizzo degli strumenti investigativi a
disposizione dell’organo dell’accusa” sottolineando che l’accesso alla casa
dell’avvocato con un medico di un altro comune e allo studio del legale,
effettuato senza “alcun avviso o atto formale“, “non può che essere ritenuto
grave, con gravi violazioni delle norme procedurali, inderogabili“. Secondo
la Camera penale distrettuale, “tali fatti minano la serenità dello svolgimento
della delicata funzione giurisdizionale nella quale l’Avvocatura è parte
essenziale a tutela dei diritti di ogni cittadino, sia imputato-indagato sia
parte offesa”. L’incontro fissato con il Procuratore della Repubblica di
Potenza Francesco Curcio, fissato lunedì prossimo, dovrebbe servire ad avere
“gli opportuni chiarimenti anche volti a ridisegnare i rapporti tra la
Magistratura inquirente e l’Avvocatura“. Redazione CdG 1947
Potenza. Il giallo dei
verbali fra Procura e Tribunale sul “caso Murano”...
Redazione CdG 1947 su Il
Corriere del Giorno l'1 Aprile 2022.
Cosa dirà il procuratore
Curcio lunedì al presidente dell' Ordine degli Avvocati di Potenza, Avv.
Maurizio Napolitano e quello della Camera Penale Distrettuale Avv. Sergio
Lapenna ? Ma sarebbe ancora più interessante sapere cosa spiegherà alla Procura
Generale della Cassazione ed agli ispettori del Ministero di Giustizia quasi
certamente in arrivo a seguito delle due interrogazioni parlamentari presentate
sull' accaduto ? Dirà anche a loro che è sempre colpa dei giornalisti...???
Questa mattina si svolgerà l’
assemblea dell’ avvocatura di Potenza per decidere le iniziative da
intraprendere sul “caso Murano” creato dalla Procura di Potenza, che ha iscritto
nel registro degli indagati l’ avvocato penalista di Rionero in Vulture, colpito
da una colica renale che gli ha impedito di essere presente in un’udienza
dinnanzi al collegio penale presieduto dal Giudice Federico Sergi del Tribunale
di Potenza. Ma in questa vicenda c’è qualcosa di molto strano che ci auguriamo
che gli Ispettori del Ministero di Giustizia, la Procura Generale della
Cassazione ma anche la Procura di Catanzaro facciano luce e chiarezza. Noi siamo
semplici giornalisti, il nostro lavoro è dare notizie, non alterare la
verità (“con grave pregiudizio” come sostiene il Procuratore di Potenza Curcio
). Qualcuno dovrebbe ricordare o imparare che dire la verità non è mai
diffamazione ! O forse noi giornalisti dobbiamo imparare dai magistrati a fare
il nostro lavoro ? In alcuni casi, ci sia consentito di dirlo, potrebbe accadere
facilmente il contrario !
Eccovi quindi di seguito la
ricostruzione documentale che il nostro giornale ha effettuato documentalmente
(come nostro stile di lavoro) su quanto accaduto nel Tribunale di Potenza, e
questa volta per qualche magistrato sarà difficile querelarci…e provare a
smentirci. Come dicevano i nostri padri latini “verba volant, scripta manent”.
Domani l’ assemblea dell’
ordine degli Avvocati di Potenza deciderà quali azioni intraprendere dopo la
nota stampa diramata ieri dal procuratore di Potenza Francesco Curcio, che
riportiamo integralmente di seguito, il quale sostiene ed evidenzia che sulla
base del verbale riassuntivo sintetico (trascritto a mano dal cancelliere
d’udienza Silvia Lauciello) in udienza del Tribunale da cui si legge “Il
Tribunale dispone a cura della cancelleria la trasmissione del certificato
medico e dell’istanza di rinvio dell’ avv. Murano alla segreteria del dr.
Borriello, con urgenza“, era assolutamente doveroso per la procura del capoluogo
lucano disporre gli accertamenti in corso. Una teoria che fa acqua da tutte le
parti, come i documenti acquisiti in esclusiva dal CORRIERE DEL
GIORNO dimostrano. In questo caso lasciatecelo dire, la toppa è più profonda e
larga del buco…che qualcuno vorrebbe coprire e ribaltare.
Come sempre il nostro giornale
pubblica gli atti integrali
A conferma della nostra
correttezza professionale e deontologia giornalistica che è ben diversa e più
elevata di quella di qualcun altro…ecco di seguito copia originaledel
verbale redatto con due ore di ritardo dal cancelliere dopo il termine dell’
udienza.
Dalla lettura del comunicato
stampa della procura, ed un’attenta disamina dalle trascrizioni dell’udienza,
più di qualcosa non quadra nelle giustificazioni addotte dal procuratore di
Potenza. Infatti da un altro verbale, cioè quello fonoregistrato, più
attendibile e realistico, emerge una realtà ben diversa da quella trascritta dal
cancelliere 1 h e 19 minuti dopo la chiusura dell’udienza ed utilizzata dalla
Procura di Potenza per giustificare il proprio comportamento che sembra poco in
linea con quanto contenuto nel codice di procedura penale. Infatti a pagina 7 di
10 del verbale fonoregistrato si legge quanto segue:
“P.M. E’ il Pubblico Ministero
che chiede trasmissione all’Ufficio di Procura della richiesta del certificato
medico del difensore“. Quindi basta leggere con attenzione la risposta reale del
giudice dr. Sergi per verificare che è ben diversa da quella trascritta dal
cancelliere, ed utilizzata dalla Procura per avviare le proprie indagini
imbarazzanti culminate con il sequestro del telefono ad un medico che ha in cura
pazienti colpiti dal Covid !
Questo è quanto è accaduto in
realtà, come si apprende dalla fonoregistrazione:
“PRESIDENTE. Ne può acquisire
copia. E’ agli atti. Sono estensibili a chiunque. La può acquisire e il
fascicolo del dibattimento è pubblico“. Ed alla pagina successiva (pag. 8 di 10)
si legge: “Rinvio quindi al 19 maggio prossimo 11. 30“.
Anche in questo caso forniamo
in lettura ai nostri lettori ( e non solo…) gli atti integrali:
Quindi se l’udienza è stata
rinviata, vuol dire che il certificato medico è stato accolto dal giudice e
l’impedimento ritenuto legittimo. Ma la cosa più grave è che il giudice non ha
mai disposto proprio nulla ! Quindi legittimo chiedersi, quale sarebbe il reato
ipotizzato dal pm Giuseppe Borriello della procura di Potenza per cui ha
indagato l’ avv. Murano ? Ma c’è qualcosa di ancora più grave. Dalla
registrazione risulta che il verbale viene chiuso alle 10:41, mentre da quello
dattiloscritto dal cancelliere risulta chiuso alle 12, cioè 1 ora e 19 minuti
dopo!
Il nostro lavoro è quello di
fare delle domande. Cosa è successo in quel tempo ? Come ha fatto il cancelliere
d’udienza a scrivere il contrario di quanto emerge dalle registrazioni ?
Qualcuno gli ha fatto da promemoria…? Chissà se il dr. Curcio ed il suo
sostituto Borriello vorranno cortesemente spiegarcelo, o meglio spiegarlo ai
nostri lettori ? In definitiva siamo tutti cittadini e contribuenti che con con
le proprie tasse contribuiamo a pagare i lauti stipendi anche alla magistratura
!
Cosa dirà il procuratore
Curcio lunedì al presidente dell’ Ordine degli Avvocati di Potenza,
Avv. Maurizio Napolitano e quello della Camera Penale Distrettuale Avv. Sergio
Lapenna ? Ma sarebbe ancora più interessante sapere cosa spiegherà alla Procura
Generale della Cassazione ed agli ispettori del Ministero di Giustizia quasi
certamente in arrivo a seguito delle due interrogazioni parlamentari presentate
sull’ accaduto ? Dirà anche a loro che è sempre colpa dei giornalisti…???
Attendiamo delle risposte (e non delle squallide querele)
Redazione CdG 1947
Avv. Maurizio Napolitano, Avv.
Sergio Lapenna, avvocato Antonio Murano, Camera Penale Distrettuale
Basilicata, caso Murano, giudice Federico Sergi, Ministero di Giustizia, Ordine
degli Avvocati di Potenza, pm Giuseppe Borriello, Procura di Catanzaro, Procura
di Potenza, Procura Generale della Cassazione, Silvia Lauciello, Tribunale di
Potenza
L'Associazione nazionale
forense: «Eccesso di prerogativa da parte del magistrato». L'Aiga: «Intervenga
il ministro della Giustizia».
La Gazzetta del Mezzogiorno il
29 Marzo 2022.
L’Aiga (Associazione Italiana
Giovani Avvocati) esprime «forte preoccupazione» per quanto accaduto
all’avvocato potentino Antonio Murano, «finito sotto inchiesta dopo aver
presentato un certificato medico per legittimo impedimento a presenziare ad
un’udienza penale», ed auspica «un immediato intervento del Ministero della
Giustizia, previa ispezione, volto ad adottare i più opportuni provvedimenti».
La denuncia dell'avvocato Murano «che, dopo avere chiesto il rinvio di
un’udienza alla quale non poteva presenziare per motivi di salute, istanza
accolta dal collegio del Tribunale, ha ricevuto una visita fiscale a casa,
all’esito della quale ha scoperto di essere indagato, mentre il medico è stato a
lungo interrogato in caserma, è, nella migliore delle ipotesi, un eccesso delle
prerogative del magistrato» secondo il segretario generale dell’Associazione
nazionale forense, Giampaolo Di Marco. Per quest'ultimo «al netto della
legittimità, fatti come questi minano quel necessario equilibrio che sempre deve
sussistere fra le parti processuali e fra avvocatura e magistratura. Altro
aspetto, e altra valenza - ha aggiunto Di Marco - ha invece l’ispezione dello
studio legale del collega Murano che a quanto si apprende sarebbe stata eseguita
senza la comunicazione preventiva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Potenza, misura prevista dall’articolo 103 del codice di procedura penale. Siamo
certi che su ogni aspetto di illegittimità verrà fatta piena luce dagli
organismi che sono stati investiti della vicenda».
Sulla questione (indagato
dalla procura di Potenza) l'avvocato Murano ha informato, tra gli altri, il
Consiglio nazionale forense, le Camere penali ed il Csm. La sua assenza
giustificata riguarda un'udienza penale prevista lo scorso 24 marzo al tribunale
di Potenza. Il differimento dall'udienza, il legale potentino lo ha richiesto
verbalmente, per il tramite di un collega.
La vicenda dell’avvocato del
foro di Potenza malato e indagato «ha profondamente scosso ed allarmato
l’Avvocatura tutta, per le modalità che, allo stato, appaiono abnormi": lo ha
detto la Camera penale distrettuale di Basilicata.
In una nota, la Cpd ha
spiegato che «l'attività posta in essere dalla Procura costituisce un anomalo
utilizzo degli strumenti investigativi a disposizione dell’organo dell’accusa" e
ha sottolineato che l’accesso alla casa dell’avvocato con un medico di un altro
comune e allo studio del legale, senza «alcun avviso o atto formale», «non può
che essere ritenuto grave», con "gravi violazioni delle norme procedurali,
inderogabili». Secondo la Camera penale distrettuale, «tali fatti minano la
serenità dello svolgimento della delicata funzione giurisdizionale nella quale
l’Avvocatura è parte essenziale a tutela dei diritti di ogni cittadino, sia
imputato-indagato sia parte offesa». L’incontro fissato con il Procuratore della
Repubblica, lunedì prossimo, dovrebbe servire, secondo la Cpd, ad avere «gli
opportuni chiarimenti anche volti a ridisegnare i rapporti tra la Magistratura
inquirente e l’Avvocatura».
Il procuratore Curcio e il
caso Murano: «Inchiesta avviata non per malattia».
LEO AMATO su Il Quotidiano del
Sud il 31 marzo 2022.
Mai avviate indagini su
avvocati «per il solo fatto che avessero chiesto un rinvio di udienza per un
impedimento a comparire allegando certificati di malattia o altro». Quanto
piuttosto sulla scorta di «ulteriori e diverse circostanze di fatto», che al
momento non possono essere rivelate, «per evidenti ragioni di riservatezza e
di tutela sia degli indagati che delle indagini».
Ha replicato così, ieri, il
procuratore capo di Potenza sul caso dell’avvocato Antonio Murano. Vale a dire
la denuncia del legale rionerese contro gli inquirenti potentini, che la scorsa
settimana lo avrebbero messo sotto inchiesta, a suo dire, solo per aver chiesto
e ottenuto il rinvio di un processo, tutto sommato banale, a carico di un suo
assistito, un carabiniere forestale accusato di peculato. Rinvio motivato da una
sua indisposizione fisica dimostrata da un certificato del suo medico curante,
sulla cui autenticità gli inquirenti parrebbero nutrire più di qualche dubbio.
Non per niente hanno iscritto
sul registro degli indagati anche il medico in questione, in concorso col
legale, per “false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità
giudiziaria”: un reato punito con pene tra 2 e 6 anni di reclusione.
Curcio è intervenuto
all’indomani dell’annuncio di un’interrogazione parlamentare al riguardo del
senatore di Italia viva, Giuseppe Luigi Cucca, seguito dal deputato del Partito
democratico Carmelo Miceli. Sempre nella giornata di martedì, però, si era fatta
sentire anche la Camera penale distrettuale della Basilicata, stigmatizzando,
tra l’altro, l’accesso dei carabinieri nello studio professionale dell’avvocato
Murano, per provare ad acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza, «in
assenza delle dovute comunicazioni anche al consiglio dell’Ordine di
appartenenza». Mentre, a Roma, il Consiglio nazionale forense ha deciso di
investire della vicenda il procuratore generale presso la Corte di Cassazione,
competente per le azioni disciplinari nei confronti dei magistrati, contestando
agli inquirenti potentini di aver «operato in spregio alla dignità, al decoro e
al prestigio della classe forense».
Il procuratore, riferendosi
alle cronache che diverse testate – anche nazionali – hanno dedicato alla
vicenda, ha provato a sgombrare il campo dall’idea di una contrapposizione tra
il suo ufficio e l’avvocatura potentina. «Gli avvocati impediti per ragioni di
salute o per altri gravi motivi – ha dichiarato – hanno il sacrosanto diritto
di ottenere un rinvio delle udienze». D’altro canto lo stesso Curcio ha voluto
precisare che «in coerenza con tale principio, nel caso in questione, non si è
proceduto ad indagini in ragione della mera allegazione del certificato medico
da parte dell’avvocato Murano richiedente il rinvio». Bensì «sulla base sia
del verbale riassuntivo di udienza del Tribunale, in cui si disponeva la
trasmissione “con urgenza” a questo ufficio, di copia del predetto verbale e
del certificato medico in questione che, soprattutto, sulla base di ulteriori e
diverse circostanze di fatto concernenti la certificazione medica di cui si
parla – non evidenziate dagli articoli di stampa in questione – che hanno
reso doverosi gli accertamenti in corso».
«Naturalmente per l’avvocato
Murano (come per qualsiasi altro cittadino indagato) vale la presunzione
d’innocenza». Ha aggiunto il procuratore. «Gli accertamenti in corso (si ripete
doverosi e non fondati sulla semplice certificazione medica prodotta da parte
del legale) come qualsiasi indagine penale, non sono la “verità”, ma sono
attività esclusivamente finalizzate a verificare se vi siano i presupposti
per esercitare l’azione penale seguendo tutte le garanzie e le procedure
previste dalla legge».
Curcio si è poi soffermato su
altri aspetti della vicenda per come rappresentati nei giorni scorsi in base a
quanto riferito dallo stesso Murano. Come l’accesso nella sua abitazione di un
medico accompagnato dai carabinieri, per verificare le sue condizioni di salute,
e poi nel suo studio legale. Oltre alla presunta perquisizione subita dal medico
curante dell’avvocato, che – sempre a suo dire – sarebbe stato «trattenuto per
circa tre ore in caserma», e poi si sarebbe visto sequestrare il telefonino.
Stesso dispositivo in cui il medico aveva installato «le applicazioni relative
all’identità digitale, necessarie, tra le altre cose, a firmare le guarigioni e
a disporre la fine della quarantena dei suoi pazienti».
«Contrariamente a quanto si è
potuto leggere su alcuni organi di stampa – ha dichiarato Curcio – questo
ufficio non ha disposto (né è stata effettuata) alcuna perquisizione,
alcun sequestro ovvero alcuna attività invasiva nei confronti dell’avvocato
Murano, le cui prerogative di avvocato difensore previste dalla legge non sono
state in alcun modo violate. Alcun documento o atto difensivo, alcuna
conversazione di natura professionale o solo lontanamente tale è stata
acquisita o captata».
«L’avvocato Murano, esperto
penalista, piuttosto, mostrando disponibilità e lealtà, ha consentito a che gli
organi delegati alle indagini potessero verificare le sue condizioni di
salute». Ha aggiunto ancora il procuratore. «E tuttavia, va precisato, tali
organi non avevano ricevuto alcun mandato da questo ufficio (né lo stesso è
stato esercitato arbitrariamente) di procedere a visite coatte
dell’indagato: ove l’avvocato avesse inteso non consentire allo svolgimento
della verifica, se ne sarebbe semplicemente preso atto procedendosi a diversa
ed ulteriore attività investigativa. Né, inoltre, corrisponde al vero, come pure
si è avuto modo di leggere, che altro co-indagato nel medesimo procedimento sia
stato “trattenuto” in caserma per tre ore. Quasi a volere sottolineare un
eccesso di potere da parte degli inquirenti.
Semplicemente tale
co-indagato, si è recato presso la caserma dei carabinieri, come qualsiasi
cittadino cui vengono notificati degli atti giudiziari e nei cui confronti deve
redigersi un verbale, per il tempo necessario per formare e firmare il
verbale e riceverne copia, avendo piena libertà di entrare ed uscire dalla
caserma, come infatti è successo in questo caso, e, comunque, ferma restando la
piena facoltà dell’interessato di rifiutarsi di firmare e di ricevere la copia
degli atti stessi e di tornarsene a casa propria immediatamente, come,
peraltro, non di rado avviene».
«Invero – ha concluso Curcio –
il principio di presunzione d’innocenza, di cui questo ufficio è convinto
custode, non si può tradurre nella omissione di un doveroso accertamento dei
fatti che deve essere svolto nel rispetto della legge, senza la pretesa
dell’infallibilità, ma anche senza distinzioni riguardanti il ruolo sociale e
professionale di chi a tali accertamenti deve essere sottoposto». Domani sulla
vicenda è attesa anche la presa di posizione dell’avvocatura potentina tutta,
dopo che il consiglio dell’Ordine ha convocato un’assemblea straordinaria ad hoc
degli iscritti per «l’adozione dei provvedimenti conseguenziali».
Non è escluso, tuttavia, che
i legali decidano di attendere la prossima settimana per valutare meglio il da
farsi, dato l’incontro già fissato per lunedì tra il procuratore e i presidenti
di Ordine degli avvocati di Potenza, Maurizio Napolitano, e Camera penale
distrettuale, Sergio Lapenna, per un chiarimento di persona sull’accaduto.
L’avvocato è malato, il pm
lo fa perquisire e poi lo indaga.
L’incredibile vicenda di un
legale di Potenza: il professionista ha richiesto il differimento dell’udienza
per motivi di salute, ma il magistrato ha deciso di mandargli a casa i
carabinieri e un medico. Gennaro Grimolizzi su Il Dubbio il 29 marzo 2022.
L’assenza giustificata in
udienza dell’avvocato scatena l’ira del pubblico ministero, che manda i
carabinieri a casa del professionista. È successo al Tribunale di Potenza. In
occasione di un’udienza penale prevista lo scorso 24 marzo, l’avvocato Antonio
Murano è stato impossibilitato, per motivi di salute certificati dal medico, a
raggiungere il Palazzo di giustizia del capoluogo lucano e ha richiesto
verbalmente, per il tramite di un collega, il differimento dell’udienza.
Nulla da eccepire da parte del
Collegio B, presieduto dal giudice Federico Sergi, che ha accolto l’istanza del
legale. A questo punto, però, si verifica l’imprevedibile. Il Collegio
giudicante riceve, rigettandole, due richieste del pm Giuseppe Borriello. La
prima volta a verificare le condizioni dell’avvocato assente per motivi di
salute; la seconda riguardante la trasmissione del certificato alla Procura
delle Repubblica. La vicenda prende una piega a dir poco incredibile.
«Dopo qualche ora – racconta
l’avvocato Murano, che ha voluto informare, tra gli altri, il Consiglio
nazionale forense, le Camere penali ed il Csm – nel primo pomeriggio, intorno
alle 14, l’inaspettato arrivo nella mia dimora di un medico. Si è presentato
accompagnato dai carabinieri per effettuare una visita disposta dalla Procura di
Potenza. Pur non essendo questi visitatori muniti di alcun provvedimento
giudiziario, e pur in assenza delle obbligatorie informazioni previste dagli
articoli 369 e 369-bis del Codice di procedura penale, animato da uno spirito
collaborativo e non avendo alcunché da occultare non mi sono opposto. Ho
consentito quindi al medico di verificare il mio status».
L’avvocato Murano, penalista
apprezzato in Basilicata e fuori regione, con quasi quarant’anni di carriera,
non nasconde la propria amarezza. «Ho pensato – dice – che si trattasse di una
esagerazione, immaginando che qualcuno avesse potuto dubitare della genuinità
del certificato attestante la mia malattia, anche se non mi pare che sia mai
stata disposta un’ispezione medica su un avvocato, né in tantissimi anni di
onorata professione mi è mai capitato di sentire un episodio simile. Ad ogni
modo, consentita la visita alla quale mi sarei potuto lecitamente opporre e
concessa al medico inviato dalla Procura la facoltà di verificare le mie
condizioni, ho sperato che la faccenda fosse chiusa». Non è andata invece così.
Anzi, le cose si sono complicate ulteriormente con il coinvolgimento di alcuni
parenti stretti del legale.
«Con stupore – spiega – ho
appreso di essere addirittura indagato, non so per cosa, e nell’ambito di tali
indagini sono stati disposti gli interrogatori di mia madre, cha ha più di
ottant’anni, mio fratello e mio figlio Pasquale, che svolge con me la
professione forense». Coinvolto anche il medico, Donato Labella. «Si tratta –
aggiunge l’avvocato Murano – di uno stimato professionista, colpevole, è proprio
il caso di dirlo, di avermi visitato e redatto il certificato. È stato
trattenuto per circa tre ore nella caserma dei carabinieri di Rionero in
Vulture, in provincia di Potenza, attinto da decreto di perquisizione locale e
personale e decreto di sequestro del telefonino, vedendosi privato del
dispositivo contenente le applicazioni relative all’identità digitale,
necessarie, tra le altre cose, a firmare le guarigioni da Covid-19 e disporre la
fine della quarantena dei suoi pazienti».
Una giornata lunghissima e da
dimenticare quella del 24 marzo scorso per l’avvocato Murano. Con l’aggiunta di
ulteriori anomalie e forzature. «In prima serata – spiega -, verso le 20, i
carabinieri si sono recati, in mia assenza, presso il mio studio legale di
Rionero in Vulture. Con tatto e discrezione, non posso negarlo, hanno chiesto di
acquisire le registrazioni della videosorveglianza. Anche in tale occasione la
richiesta appare anomala, in quanto non mi è stato notificato alcun avviso di
garanzia che legittimasse atti invasivi della privacy e, quindi, pur sussistendo
i presupposti per opporsi, veniva consentito l’accesso, che non dava alcun esito
in quanto il sistema non era funzionante. Tutto si è verificato senza che io
abbia ricevuto, ad oggi, un’informazione di garanzia o qualunque altro
provvedimento, a fronte di azioni fortemente invasive del campo professionale e
privato. Né si comprende la ragione di un simile sospetto che ha portato
all’immediata iscrizione della notitia criminis con cotanto dispiego di forze,
posto che il procedimento penale oggetto di rinvio non è prossimo alla
prescrizione, i cui termini sarebbero rimasti, in ogni caso, sospesi, visto il
differimento per motivi di salute del difensore».
Forse, quanto accaduto qualche
giorno fa nel Tribunale di Potenza e nella città di Rionero, un tempo rientrante
nel circondario del Tribunale di Melfi, soppresso nel 2013, non ha precedenti
sia per la storia dell’avvocatura sia per quella della magistratura. «Ritengo –
commenta l’avvocato Murano – quanto accaduto di una abissale gravità a maggior
ragione se si tiene conto che il Collegio aveva ritenuto inopportuno qualsiasi
accertamento, rigettando la relativa richiesta. È il momento, da parte di tutti
gli organismi forensi e dell’intera avvocatura, di intraprendere ogni iniziativa
volta a dare risalto con decisione all’accaduto al fine di affermare con forza
il decoro ed il prestigio della classe forense, denigrato ed umiliato da episodi
come quelli che mi hanno interessato, evitando, con fermezza, che possano
incrinare i rapporti di stima tra magistratura e avvocatura, con azioni
ingiustificatamente dirompenti, la cui eco rischierebbe di proscrivere anche le
più banali facoltà difensorie nell’alveo della paura di vedersi colpiti da
simili episodi».
Il legale del Foro di Potenza
spera che quanto accaduto possa rientrare presto nei binari dell’equilibrio e
della sobrietà dei comportamenti per tutti i protagonisti della giurisdizione.
«Nel reciproco rispetto dei ruoli – conclude – è auspicabile che ciascun
interprete eserciti i propri poteri e le specifiche prerogative con equilibrio e
moderazione, al di là di ogni tensione. Il Tribunale è l’ambiente di lavoro
degli avvocati e dei magistrati. È compito di tutti, quindi, agire nel prudente
principio della cordialità e del vicendevole rispetto, che dovrebbe costituire
la regola fondamentale dei rapporti tra le parti, nel supremo interesse della
giustizia».
Avvocato indagato a
Potenza, il procuratore: «Accertamenti doverosi, ma nessuna perquisizione».
Il Dubbio
l'1 aprile 2022.
La Procura in una nota afferma
di non aver «disposto (né è stata effettuata) alcuna perquisizione, alcun
sequestro, ovvero alcuna attività invasiva nei confronti dell'avvocato Murano,
le cui prerogative di avvocato difensore non sono state in alcun modo violate».
Sono «doverosi» gli
accertamenti in corso sulla certificazione medica presentata
dall’avvocato Antonio Murano, del Foro di Potenza, per chiedere il rinvio di
un’udienza: è questo uno dei passaggi di un comunicato diffuso stamani dal
Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio.
Secondo Curcio, le «recenti
notizie di stampa danno conto» della vicenda «in modo inesatto, con particolare
risalto e grave pregiudizio. Bisogna immediatamente dire che questo Ufficio – ha
scritto il Procuratore – intrattiene rapporti cordiali e improntati al reciproco
rispetto con il Foro di questo Tribunale. Mai questo Ufficio, da quando è da me
diretto (cioè da quattro anni) ha avviato indagini su avvocati per il solo fatto
che avessero chiesto un rinvio di un’udienza per un impedimento a comparire
allegando certificati di malattia o altro».
In particolare, per la vicenda
dell’avvocato Murano, Curcio ha evidenziato che «non si è proceduto a indagini
in ragione della mera allegazione del certificato medico», ma «sulla base sia
del verbale riassuntivo di udienza del Tribunale, in cui si disponeva la
trasmissione “con urgenza” a questo Ufficio di copia dello stesso certificato,
che, soprattutto, sulla base di ulteriori e diverse circostanze di fatto
concernenti la qualificazione medica di cui si parla – non evidenziate dagli
articoli di stampa – che hanno reso doverosi gli accertamenti». Inoltre, Curcio
ha «precisato» che la Procura non ha «disposto (né è stata effettuata) alcuna
perquisizione, alcun sequestro, ovvero alcuna attività invasiva nei confronti
dell’avvocato Murano, le cui prerogative di avvocato difensore non sono state in
alcun modo violate»
Avvocato malato sotto
indagine, il Cnf scrive al Pg Salvi.
La presidente Masi sul caso
del legale di Potenza preso di mira dai pm: «Perplessità sull’operato di una
Procura in spregio alla dignità della classe forense». Gennaro Grimolizzi su Il
Dubbio il 31 marzo 2022.
La vicenda dell’avvocato del
Foro di Potenza, Antonio Murano, ha assunto rilevanza nazionale ed è approdata
in Parlamento. La presidente del Cnf, Maria Masi, ha scritto al Procuratore
generale presso la Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, affinché venga acquisito
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza «ogni elemento
utile a consentire la ricostruzione dei fatti e, qualora riscontri elementi di
rilevanza disciplinare, procedere all’esercizio della relativa azione».
«Ferme restando – evidenzia la
presidente del Cnf – le autonome e indipendenti valutazioni del Collegio
giudicante circa la fondatezza dell’impedimento a comparire addotto dal collega
e ferme restando le autonome valutazioni dell’Ufficio del Pubblico ministero
circa la fondatezza della notizia criminis e la conseguente iscrizione del
collega nel registro delle persone indagate, su cui non mi permetto di entrare
nel merito, desta perplessità, e qualche timore, che un Ufficio di Procura,
evidentemente eccedendo nelle proprie prerogative, abbia operato in spregio alla
dignità, al decoro e al prestigio della classe forense. Gli avvocati tutti,
anche per previsione deontologica, debbono avere massimo rispetto per la
magistratura, sia inquirente che requirente. La magistratura, del pari».
Il senatore Giuseppe Luigi
Cucca di Italia Viva ha preparato un’interrogazione orale con carattere
d’urgenza indirizzata alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Lo scorso
24 marzo l’avvocato Murano è stato impossibilitato a partecipare ad un’udienza
penale per motivi di salute certificati dal medico. In quella occasione ottenne
dal presidente del collegio giudicante il differimento ad altra data. Il
pubblico ministero Giuseppe Borriello ha chiesto però la verifica delle
condizioni di salute del legale, assente in udienza, e la trasmissione del
certificato medico alla Procura delle Repubblica. Entrambe le richieste sono
state respinte dal giudice. Murano ha ricevuto lo stesso la visita dei
carabinieri, disposta dal pm, che hanno accompagnato un medico nella dimora del
professionista per verificare il suo effettivo stato di salute. Qualche ora
dopo, i militari dell’Arma hanno ascoltato anche l’anziana madre dell’avvocato,
il figlio (anch’egli togato del Foro potentino) e il fratello.
Ma le verifiche non si sono
fermate qui. Hanno coinvolto pure il medico. Inoltre, i carabinieri si sono
recati, in assenza dell’avvocato Murano, presso il suo studio legale per
acquisire le registrazioni della videosorveglianza. Una richiesta anomala e
invasiva della privacy. «Quanto accaduto nel Tribunale di Potenza – dice al
Dubbio il senatore Cucca – mi ha lasciato senza parole. Mi sto abituando a
tutto, ma trattare così un avvocato non può che farmi preoccupare. Stiamo
vivendo un momento di grandi tensioni per quanto riguarda i rapporti tra
avvocatura e magistratura». L’interrogazione presentata da Cucca, che è anche
avvocato, mira a chiarire tutti i contorni della vicenda. «Voglio sapere –
spiega – se la ministra Cartabia è a conoscenza dei fatti e quali sono i suoi
intendimenti in merito. Inoltre, voglio conoscere le iniziative che la ministra
ritiene di adottare per prevenire il ripetersi di vicende come quelle accadute
presso il Tribunale di Potenza. È emerso da quanto si apprende che il potere
requirente ha tentato di interferire, travalicando i propri poteri e le proprie
competenze, su decisioni già assunte dall’organo giudicante».
Il Coa di Potenza ha convocato
l’assemblea straordinaria degli iscritti il 1 aprile, con sospensione delle
udienze dalle 10 alle 14, sul caso Murano per decidere quali iniziative
intraprendere. Il presidente nazionale del Movimento Forense, Antonino La Lumia,
esprime preoccupazione: «Non è concepibile, in uno stato di diritto, che si
possa verificare, ma anche soltanto immaginare, quanto accaduto. Sono stati
messi in un angolo e inammissibilmente calpestati i principi fondamentali del
giusto processo e delle garanzie connesse al diritto di difesa, ledendo, nel
contempo, l’immagine, la reputazione e la funzione stessa dell’avvocatura. Per
tali ragioni, la nostra associazione, esprimendo solidarietà e vicinanza al
collega potentino e preso atto dell’immediata convocazione del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Potenza per discutere di tale grave situazione,
chiede che le massime istituzioni forensi adottino i provvedimenti più opportuni
a tutela dell’intera categoria, stigmatizzando ogni possibile condotta, che,
come nel caso di specie, determini la compromissione dei diritti
costituzionalmente garantiti».
La Camera penale di
Basilicata rileva che «quanto accaduto ha profondamente scosso ed allarmato
l’avvocatura tutta, per le modalità che, allo stato, appaiono abnormi». «Al di
là del caso specifico – aggiunge il presidente Sergio Lapenna -, tale modus
agendi e lo strepitus fori che ne è seguito, ancora una volta tratteggia la
figura dell’avvocato ed il suo ruolo di difensore quale elemento di disturbo e
intralcio all’attività giudiziaria». Ieri il Procuratore distrettuale di
Potenza, Francesco Curcio, ha chiarito che «non si è proceduto ad indagini in
ragione della mera allegazione del certificato medico da parte dell’avvocato
Murano, richiedente il rinvio, ma sulla base sia del verbale riassuntivo in
udienza del Tribunale, in cui si disponeva la trasmissione “con urgenza” a
questo Ufficio, di copia del predetto verbale e del certificato medico in
questione che, soprattutto, sulla base di ulteriori e diverse circostanze di
fatto concernenti la certificazione medica di cui si parla, che hanno reso
doverosi gli accertamenti in corso». «Circostanze di fatto» che la Procura non
rivela per «evidenti ragioni di riservatezza» e per tutelare le indagini e gli
indagati.
Il pg Salvi risponde alla
presidente Masi: “Già in corso accertamenti disciplinari”.
La lettera con cui il
procuratore generale della Cassazione replica alla richiesta della presidente
Cnf in merito al caso dell'avvocato Murano. Il Dubbio l'1 aprile 2022.
Pubblichiamo di seguito la
lettera inviata alla Presidente del Cnf Maria Masi dal Procuratore generale
presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi in relazione
all’indagine sull’avvocato del Foro di Potenza Antonio Murano, indagine avviata
dalla Procura di Potenza dopo che il professionista aveva chiesto, e si era
visto riconosciuto dal Tribunale, il legittimo impedimento a presenziare in
udienza.
Egregia Presidente Masi,
ho ricevuto la Sua lettera
datata 29 marzo ma in realtà spedita il giorno successivo. Purtroppo ne ho letto
il contenuto questa mattina sul vostro quotidiano, prima ancora che fosse
possibile una diretta interlocuzione con il Consiglio Nazionale. Rispondo quindi
alla S.V., inviando contestualmente a Il Dubbio copia di questa nota, per
completezza di informazione, certo che questa sia anche la vostra volontà. Il
mio ufficio è stato informato già la mattina di ieri 30 marzo con una relazione
del Procuratore generale e del Procuratore della Repubblica. Sono quindi stati
avviati immediati accertamenti in sede predisciplinare, che saranno rigorosi e
al tempo stesso rispettosi delle prerogative dell’organo inquirente, come
peraltro la stessa Sua nota suggerisce. Sono certo che il Consiglio distrettuale
di disciplina forense stia agendo con la medesima tempestività ai necessari,
paralleli accertamenti.
I più cordiali saluti,
Il teatro
dell'assurdo. L’avvocato sta male, blitz in casa della Procura: “E’ indagato per
falso, interroghiamo tutta la sua famiglia”.
Paolo Comi su
Il Riformista il
29 Marzo 2022.
Per i giudici era
malato grave e non poteva essere presente in udienza. Per il pm, invece, la
malattia era immaginaria ed il certificato medico un tarocco. La “sorprendente”
vicenda, anche se nel meraviglioso mondo della giustizia italiana ormai è sempre
più difficile trovare qualcosa di cui stupirsi, è capitata lo scorso 24 marzo al
Tribunale penale di Potenza. L’avvocato Antonio Murano, con studio a Rionero in
Vulture, quella mattina aveva un processo davanti al collegio presieduto dal
giudice Federico Sergi. La sera prima, però, Murano viene colpito da una
fortissima colica al punto da richiedere l’intervento del medico.
Murano, non
essendo in condizioni di presentarsi in aula per difendere il suo assistito,
avvisa quindi un collega di sostituirlo, invitandolo anche a chiedere ai giudici
un rinvio per legittimo impedimento. l giudici, sentite le giustificazioni del
collega, accolgono la richiesta di Murano che non avrebbe causato problemi allo
svolgimento del processo dal momento che il legittimo impedimento del difensore
interrompe automaticamente il decorso della prescrizione. Murano, purtroppo, non
aveva fatto i conti con il pm Giuseppe Borriello che aveva chiesto al collegio
una verifica, non accolta, sulle sue condizioni di salute.
Alle 14 si
presentava presso la casa dell’avvocato Murano un medico scortato da una
pattuglia di carabinieri. Alla richiesta di spiegazioni, il medico rispondeva di
dover effettuare una visita su mandato della Procura di Potenza. Murano, non
avendo nulla da nascondere, accettava di farsi visitare. Quando pensava che
fosse finita lì, con l’attestazione del non positivo stato di
salute, Murano scopre di essere addirittura stato iscritto nel registro degli
indagati della Procura lucana con l’accusa di “false dichiarazioni o
attestazioni in atti destinati all’Autorità giudiziaria”, un reato punito con 6
anni di prigione. Come se non bastasse, la Procura di Potenza aveva disposto gli
interrogatori a tappeto di tutti i suoi familiari, dal figlio al fratello,
iniziando dall’anziana madre ultraottantenne.
Per non farsi
mancare nulla, al medico curante che aveva redatto il certificato medico per
l’indisposizione, veniva prima perquisito lo studio e poi, una volta tradotto
nella caserma dei carabinieri, sequestrato il telefonino all’interno del quale
erano contenute le app per certificare la fine della quarantena per i
pazienti Covid. Ma l’incredibile giornata era ancora lunga. Alle otto di sera,
infatti, un’altra pattuglia di carabinieri si recava nello studio di Murano per
acquisire le immagini della video sorveglianza. Acquisizione che non aveva
successo essendo le telecamere non funzionanti. L’avvocato Murano, scosso da
quanto accaduto, il giorno dopo scriveva allora una lettera a tutti i vertici
degli uffici giudiziari lucani, presidente della Corte d’appello e procuratore
generale inclusi, ed al Consiglio superiore della magistratura.
«Il tribunale è
l’ambiente di lavoro degli avvocati e dei magistrati: è compito di tutti agire
nel principio di cordialità e reciproco rispetto che dovrebbe costituire la
regola nel supremo interesse della giustizia», ha ricordato Murano.
Immediatamente è scattata la solidarietà dei colleghi. «Non è concepibile in uno
stato di diritto che si possa soltanto immaginare quanto è accaduto», ha detto
l’avvocato Nino La Lumia del Movimento forense. Paolo Comi
Caso Murano, cala il gelo
tra procura e avvocati: «Stop a tutte le udienze».
Il Foro di Potenza proclama
l'astensione dal 13 al 24 aprile. Il racconto del legale: "Perquisito e indagato
senza garanzie". Gennaro Grimolizzi su Il Dubbio il 6 aprile 2022.
Lo scontro tra l’avvocatura
potentina e la Procura di Potenza è ormai conclamato. Nella storia del Foro
potentino non si registrano astensioni così lunghe, come quella decisa
dall’assemblea straordinaria degli iscritti qualche giorno fa. Lo stop a tutte
le udienze (penali, civili, amministrative e tributarie) è previsto dal 13 al 24
aprile. Lunedì gli avvocati Maurizio Napolitano e Sergio Lapenna,
rispettivamente presidente del Coa di Potenza e presidente della Camera penale
distrettuale della Basilicata, hanno incontrato il Procuratore Francesco Curcio.
«Un confronto cordiale anche se ognuno è rimasto sulle proprie posizioni», hanno
fatto sapere i due legali.
Sulla vicenda interviene il
diretto interessato: Antonio Murano. L’avvocato indagato e sottoposto a
controlli nel suo studio legale di Rionero in Vulture, dopo essersi assentato in
una udienza penale per motivi di salute, certificati da un medico, parla di
«preoccupanti evoluzioni della triste vicenda» che lo sta riguardando. Lo fa
ripercorrendo i momenti in cui è stato raggiunto dal medico fiscale in compagnia
dei carabinieri per svolgere una visita disposta dalla Procura di Potenza. Un
atto, definito dal professionista, «invasivo di natura medica», dal quale è
derivata una «ispezione corporale». Tutto «senza ricevere i necessari prodromici
avvisi di garanzia». Il resto della vicenda è ormai noto. O meglio l’ulteriore
piega che ha preso il pomeriggio del 24 marzo scorso, con le sue «forzature e
violazioni di legge», come le definisce Murano, dopo che nella mattinata si era
tenuta la controversa udienza penale davanti al Collegio “B”, presieduto dal
giudice Federico Sergi.
Al termine degli interrogatori
di diverse persone, compresi i familiari dell’avvocato, nella serata i
carabinieri raggiungevano lo studio legale per visionare l’impianto di
videosorveglianza e acquisire le registrazioni. Qui un’altra forzatura,
denunciata da Murano: ancora una volta le operazioni si svolgevano «senza alcuna
garanzia procedimentale e senza la presenza personale del Pm e senza aver
preventivamente avvertito il Consiglio dell’Ordine, in violazione dell’articolo
103 del Codice di procedura penale». Ricordiamo che il medico certificante,
Donato Labella, ha subito una perquisizione ed il sequestro del cellulare. Ora
l’avvocato Murano risulta essere indagato. «Solo in data 28 marzo – dice -, in
occasione della notifica di un accertamento tecnico irripetibile sul telefono
sequestrato al medico, ho appreso formalmente di essere stato iscritto nel
registro degli indagati». Il procedimento a suo carico vede impegnati ben due
Sostituti procuratori (Antonella Mariniello e Giampaolo Robustella) ai quali si
aggiunge il Procuratore Francesco Curcio.
«Il reato contestatomi –
aggiunge il legale -, peraltro senza descrizione della condotta, è quello
previsto dall’articolo 374 bis del Codice penale, che al secondo comma prevede
la reclusione fino a sei anni e si applica inequivocabilmente alle false
certificazioni che riguardano specificamente imputati, condannati o persone
sottoposte a prevenzione e non ai difensori di questi ultimi. Senza volermi
addentrare in valutazioni di esclusiva competenza della Procura e nel rispetto
delle sue prerogative, mi limito ad osservare che esistono gli articoli 480 e
481 del Codice penale, applicabili ed applicati in casi analoghi, con pene
decisamente inferiori. Qualsiasi operatore del diritto comprenderà che dalla
qualificazione giuridica, operata dai Pm, discendono differenti ed accresciuti
poteri investigativi. Trovo singolare una simile contestazione, idonea a
consentire lo svolgimento di atti di indagine maggiormente invasivi».
A tutto questo baillame si
aggiunge, poi, la questione del verbale di udienza nella sua duplice versione. È
lo stesso Murano a riflettere sulla grande confusione generata dalla redazione
dei due verbali del 24 marzo: uno con il resoconto fonoregistrato, che trova
riscontro nei file audio depositati in Tribunale; l’altro redatto in forma
sintetica ai sensi dell’articolo 480 del Codice di procedura penale. «Questa
gravissima difformità – afferma il penalista – costituisce una circostanza
profondamente inquietante, che getta, purtroppo, ulteriori ombre sinistre
sull’intera vicenda». L’avvocato riflette pure sulla presa di posizione del
Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio, assunta con il caso
già scoppiato. «Con comunicato – evidenzia – il dottor Curcio ha proclamato
rapporti di cordialità e rispetto intercorrenti tra la Procura ed il Foro di
Potenza, ritenendo però opportuno diramare il predetto comunicato alla stampa,
prima ancora di procedere all’interlocuzione formale richiesta da istituzioni ed
associazioni forensi. La suddetta nota, tra l’altro, non chiarisce affatto la
vicenda. Anzi, liquida clamorosamente la visita medica che ho ricevuto, in
dispregio alle garanzie difensive, chiosando che avrei potuto non acconsentirvi.
Si confonde, peraltro, sul soggetto che l’ha disposta nel momento in cui si
afferma che la Pg ed il medico non avevano ricevuto alcun mandato dalla Procura,
insinuando il dubbio che abbiano agito autonomamente e smentendo le
dichiarazioni verbali fornite dagli stessi operatori. Parimenti dicasi per
l’accesso presso lo studio legale e la richiesta di acquisizione delle
registrazioni della videosorveglianza».
I carabinieri non si sono
mossi spontaneamente. «Checché se ne dica ed a qualunque norma del codice di
rito le si voglia ancorare – conclude Murano -, le suddette attività di indagine
sono state disposte dalla Procura e avrebbero richiesto la notifica dei
prodromici avvisi di garanzia, rafforzati per gli atti riguardanti lo studio
legale. Ed è quantomeno singolare che un Procuratore dell’abilità e
dell’esperienza del dottor Curcio intenda banalizzare tale omissione dietro la
laconica affermazione che “l’avvocato Murano esperto penalista” avrebbe potuto
non consentirla. Siamo di fronte ad elementari principi del Codice di procedura
penale, che non prevedono diverse applicazioni commisurate all’esperienza
penalistica dell’indagato».
Quelle “Sentenze
memorabili” che hanno scritto la storia.
La carriera di Conte, che
indossa la toga da cinquantasette anni, è costellata non solo da successi nelle
aule giudiziarie, ma si caratterizza per il suo infaticabile impegno culturale.
Gennaro Grimolizzi Il Dubbio il 17 marzo 2022.
Conoscere la storia attraverso
alcuni processi. L’avvocato Augusto Conte nel suo ultimo libro, “Sentenze
memorabili” Edizioni Il Grifo, pagg. 207, euro 18), conduce il lettore in un
viaggio che dura diversi secoli e che ha come protagonisti, tra gli
altri, Dante, Galileo Galilei, Gioacchino Murat, fino ad arrivare ad un
“principe del Foro” come Alfredo De Marsico. La carriera di Conte, che indossa
la toga da cinquantasette anni, è costellata non solo da successi nelle aule
giudiziarie, ma si caratterizza per il suo infaticabile impegno culturale.
Prolifico scrittore, Conte è autore di decine di testi rivolti agli operatori
del diritto e dedicati alla storia dell’avvocatura. Un impegno ed una passione
che lo rendono un raffinato uomo di cultura. L’ultimo lavoro editoriale riguarda
le sentenze pronunciate in occasione di fatti che, direttamente o
indirettamente, hanno segnato il corso della storia.
«Gli accadimenti umani – dice
al Dubbio l’avvocato Conte -, nell’avvicendarsi delle società, normalmente
costituiscono oggetto di studio di storici, di sociologi, di filosofi, di
teologi e più raramente di giuristi, e ancora più sporadicamente vengono
utilizzate per le strutturazioni storiche le pronunce giurisdizionali che
determinano i destini degli uomini e delle società, a volte deviandoli. Con
questa mia ultima ricerca ho inteso innanzitutto soddisfare una esigenza storica
sulla giurisdizione. Ho voluto fornire elementi utili agli storici, ai
sociologi, ai filosofi, ai teologi, per ricomporre e ristrutturare eventi
attraverso i provvedimenti giudiziari, specie nel campo penale, che non solo
segnano la vita delle persone cui sono destinate, mutandone il corso, ma
incidono sui mutamenti della società».
Alcune sentenze hanno
consentito al legislatore di affrontare particolari fenomeni sociali.
«Ordinariamente – spiega l’autore di “Sentenze memorabili” – la legislazione,
più che prevenire, segue il divenire dei mutamenti sociali, specialmente quando
si presentano fenomeni che sconvolgono la società. Diverse volte, in tutti i
tempi, il legislatore ha dovuto fare ricorso alla legislazione di emergenza per
contenere la diffusione e la perpetuazione di accadimenti. Si pensi alla Legge
Pica del 1863 per contenere il fenomeno di quello che fu definito
“brigantaggio”, alle “Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa” e alle “Misure a favore di chi si dissocia dal
terrorismo”».
«Anche le decisioni
giurisprudenziali hanno stimolato il legislatore, che si muove molto lentamente,
a introdurre leggi. Come stiamo verificando in questi ultimi tempi, la Corte
Costituzionale, interessata in via incidentale su problematiche sollevate nel
corso di giudizi ordinari che interessano la salute, la vita, i diritti dei
cittadini, per evitare di travalicare dai suoi compiti con l’emanazione di
sentenze “additive”, su temi delicati, ha più volte dato impulso al Parlamento
di legiferare, non ottenendo sollecite risposte per il freno costituito dai
variegati schieramenti politici».
«Un processo non può
restituire la verità, ma fornire una ricostruzione, «umanamente accettabile», in
grado di appagare il senso del giusto nella collettività. Si pensi a quanto
affrontato da Galileo Galilei. «Molte decisioni adottate a conclusione di
processi – commenta Conte – non solo condizionano, non solo intralciano il corso
degli eventi, ma ritardano l’evoluzione storica. Emblematica è, per stare al
campo della scienza, la condanna di Galileo Galilei, che, oltre a ritardare
l’evolversi della scienza, fornisce una verità deliberata rivelatasi poi
fallace. Nel campo socio- politico le sentenze del Tribunale Speciale fascista
soffocarono le libertà democratiche di pensiero e di esercizio delle ideologie
che si opponevano al regime, frenando le aspirazioni, personali e sociali, al
cambiamento».
Tra i casi giudiziari
contenuti in “Sentenze memorabili” anche quello che ha riguardato Alfredo De
Marsico, ministro della Giustizia e aderente all’ordine del giorno di Dino
Grandi che portò alla caduta del fascismo. De Marsico fu professore di Diritto e
Procedura penale. Dopo la Seconda guerra mondiale ricoprì per molti anni la
carica di presidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli. «Il “Processo di
Verona” – evidenzia Augusto Conte – non colpì né l’uomo, né l’avvocato-
professore. Venne pronunciata una sentenza che si può con fatica definire
politica, che condannò a morte i traditori dell’idea fascista. Il processo e la
sentenza furono imposti dagli ex alleati tedeschi e favoriti da fascisti delusi
perché tenuti a margine durante il regime, perché facinorosi e contrari
all’armonia che il fascismo voleva creare. Sottrattosi con la latitanza alla
condanna, dopo avere subito l’epurazione, De Marsico riprese la cattedra di
Diritto Penale alla Sapienza di Roma, fu eletto consecutivamente per dieci anni
presidente dell’Ordine di Napoli, ma soprattutto ritornò a discutere nel Foro,
regalandoci la sua oratoria, non enfatica o ridondante, ma essenziale e
avvincente, alla quale l’impronta del classicismo forense veniva raffinata e
filtrata da contenuti giuridici e scientifici».
Qui i ricordi di Conte
affiorano con limpida emozione: «Ho avuto modo più volte di constatare di
persona la caratura umana e professionale di De Marsico. Nel 1976, nel corso di
un processo presso la Corte di Assise di Appello di Lecce, nel quale difendevamo
imputati con distinti capo di imputazione, trascorsi una giornata
indimenticabile in compagnia del maestro. Mi confidò che stava riordinando i
pensieri sulla notte del Gran Consiglio, mentre a me sembrava di essere a
colloquio con la storia».
La polvere sotto il
tappeto. Il triste declino degli avvocati: considerati correi, processati e
persino condannati.
Otello Lupacchini su Il Riformista l'8 Marzo 2022.
Sono lontani i tempi in cui,
analizzando il processo penale nel suo momento tecnicamente più
delicato, Francesco Carnelutti coglieva un risultato di una certa importanza per
la civiltà, quale la «riabilitazione degli avvocati» (Le miserie del Processo
Penale, Torino 1947, pp. 37 ss.). Recenti vicende, sulle quali tornerò in
seguito, e a prescindere dal coinvolgimento di noti avvocati in procedimenti
penali nella veste di imputati per rapporti, considerati, almeno nella
prospettiva dell’accusa, poco o nulla ortodossi, ribadiscono nei fatti come
quella dell’avvocato sia una delle figure più discusse nel quadro sociale. A
partire dalla seconda metà del secolo scorso, salvo rare e lodevoli eccezioni,
la letteratura giuridica è progressivamente e, alla fine, irrimediabilmente
scaduta ad ars poetica da tirapiedi.
Ciò è ascrivibile, innanzi
tutto, alla deriva della «scienza della legge», già magistralmente descritta nei
primi decenni del Cinquecento, là dove si sostituisca all’«autorità» dei dottori
quella dei precedenti giurisprudenziali, dal Francesco Guicciardini dei
Ricordi (BUR, 1984, C-208, p. 178): se nella decisione di una causa è «da uno
canto qualche viva ragione», dall’altro l’autorità di un precedente «più si
attende nel giudicare»; questo implica che l’operatore impieghi il tempo che,
invece, «sarebbe a mettere in speculare» proprio nella ricerca dei precedenti:
«così quello tempo, si consuma in leggere (almagesti giurisprudenziali) con
stracchezza di animo e di corpo, in un modo che l’ha più similitudine a una
fatica di facchini che di dotti». Ed è ascrivibile, altresì, alla proliferazione
di retori ai quali, per dirla con Tito Castricio, «è consentito usare argomenti
falsi, audaci, inventati, subdoli capziosi, purché siano verosimili e possano,
con qualche astuzia, influenzare gli animi da commuovere degli uomini», e
reputano «turpe» se in una «cattiva causa» lasciano qualcosa trascurato e
indifeso (Aulo Gellio, Noctes Atticae, 1, 4).
Comprensibile, dunque, perché
oggi sembrino suonare ai più come moneta falsa i rilievi di Francesco
Carnelutti per il quale «un uomo, per essere giudice, dovrebbe essere più di un
uomo», e perché appaiano altresì ormai jou de mode ai più le spiegazioni in
proposito del grande giurista, tanto che, in nome del mito dell’efficienza, è
stato sostanzialmente abbandonato il «correttivo» ispirato dall’insufficienza
del giudice, vale a dire il collegio giudiziario quale «rimedio» suggerito
dall’esperienza, troppo spesso sostituito da quella contradictio in adiecto che
è il «tribunale monocratico», là dove, peraltro, non si tiene più in alcun conto
la parzialità dell’uomo, che è invece il punto di partenza per capire. Vale,
comunque, la pena di ripercorrere, sia pure in via di rapidissima sintesi, il
limpido argomentare del grande penalprocessualista, risalente a quando era
ancora vigente, nella versione originaria, l’arcigno codice di rito penale
fascista. Proprio per la sua parzialità, egli sostiene, nessun uomo arriva ad
afferrare la verità, essendo quella che ciascuno ritiene la verità null’altro
che un aspetto di essa, «qualcosa come una faccetta di un diamante
meraviglioso». Se, dunque, «La verità è come la luce o come il silenzio, i quali
comprendono tutti i colori e tutti i suoni, dove, tuttavia, la fisica ha
dimostrato che il nostro occhio non vede o il nostro orecchio non ode che un
breve segmento della gamma dei colori o dei suoni», ciò spiega il modo di dire
«il giudice stabilisce chi abbia ragione». Come la verità, la ragione è infatti
una sola, ma nel processo ciascuna delle parti dice le sue ragioni, quelle per
le quali vengono chieste, a seconda di chi ne sia rispettivamente il portatore,
tanto la condanna quanto l’assoluzione.
Se ragionare significa porre
delle premesse e trarne delle conclusioni, l’accusatore e il difensore sono due
ragionatori, ma il loro è un ragionare in modo diverso da quello del giudice;
essi ragionano «a rime obbligate», poiché ognuno deve cercare le premesse per
arrivare a una conclusione obbligata. Le parzialità del difensore e del suo
avversario, che si contrappongono dialetticamente, sono il prezzo da pagare per
ottenere l’imparzialità del giudice, «che è poi il miracolo dell’uomo, in
quanto, riuscendo a non essere parte, supera sé stesso». Tutto ciò potrebbe
sembrare assurdo, ma è proprio qui la chiave del processo: guai se il giudice,
in presenza di prove apparentemente lampanti della colpevolezza o
dell’innocenza, condannasse o assolvesse senza continuare nell’indagine fino ad
averne esaurito tutte le risorse. Ovvio che, per fare questo, il giudice debba
essere aiutato, non potendo riuscirci da solo, e il suo «aiutante naturale» è il
difensore, il quale, tuttavia, avendo l’interesse di cercare le ragioni utili a
dimostrare l’innocenza dell’accusato, è sì un aiutante prezioso per il giudice,
ma anche un aiutante pericoloso, a causa della sua parzialità, così che, per
renderlo innocuo, gli viene contrapposto quel ragionatore altrettanto parziale
in senso inverso, che è il pubblico ministero, il quale meglio sarebbe, dunque,
chiamare accusatore.
È certo uno «scandalo» quello
delle due verità, della difesa e dell’accusa, ma il giudice ne ha bisogno,
affinché scandaloso non sia il suo giudizio.
Neppure nei momenti più
convulsi della storia, si è mai proposta, per esempio, la soppressione dei
medici o degli ingegneri, ma quella degli avvocati sì; e, talvolta, come nei
periodi più bui dell’Inquisizione, si è riusciti anche a sopprimerli, sebbene,
fortunatamente, siano poi subito risorti. Eppure, ancora oggi, è tragicamente
sin troppo facile incontrare sostenitori della massima secondo cui «plerumque
propter enormitatem delicti licitum est iura transgredi», così «in puniendo»
come «etiam in procedendo», là dove, naturalmente, i crimini atroci che
legittimerebbero la violazione del principio di legalità della pena e anche
delle regole processuali non sono più, come un tempo, le eresie o i traffici col
demonio, ma il terrorismo, la mafia, e la corruzione. In fondo, il sistema
inquisitorio tende a riprodursi: ingerisce idee, restituisce formule, fabbrica
le proprie creature, tutte uguali, omuncoli nella provetta di un mago: come
l’Inquisizione con la «I» maiuscola anche l’odierna inquisizione con la «i»
minuscola dispone di reggicoda, turiferari, consolatori, prefiche, necrofori,
scomunicatori, apologeti, dottori, falsari, pedagoghi, libellisti, araldi,
agiografi, esegeti, casuisti, cortigiani, cicisbei, mezzani, bottegai, sensali,
barattieri, plagiari, aguzzini, legislatori, spie, censori, sbirri, carcerieri,
flagellatori, carnefici.
Per fortuna, anche fosse dieci
volte più numeroso, questo smisurato esercito lavora sempre in perdita, come i
giocatori che puntano il pari, il dispari e lo zero. Alcuni casi clinici la
dicono più lunga di pur raffinatissime costruzioni teoriche. Un’ulteriore
premessa è, comunque, d’obbligo. Sebbene l’art. 24 comma
2 della Costituzione riconosca solennemente che «La difesa è diritto inviolabile
in ogni stato e grado del procedimento», vi è chi, non dandosene per inteso,
alimenta campagne denigratorie contro gli avvocati, adiuvante, peraltro, un
difetto della macchina processuale, che anche per questo funziona male: a
differenza del difensore, il pubblico ministero è concepito come ragionatore
imparziale, sebbene, nove volte su dieci, la logica delle cose lo trascini a
essere l’antagonista del difensore. Anni or sono, si diede il caso di un
avvocato che svolgeva con coraggio il proprio mestiere, per ciò oggetto di
critiche, di sospetti, di pedinamenti, in indagini sempre archiviate, avendo
assistito per anni quelli che tutti consideravano i peggiori: dal fattore di
Arcore, Vittorio Mangano a Giovanni Pullarà, dal Papa della mafia, Michele
Greco, a Bernardo Provenzano; secondo la vulgata popolare era un «avvocato di
mafia» o l’«avvocato del diavolo», come lo definì un noto giornalista, in un
memorabile articolo apparso su un importante quotidiano nazionale.
Più di recente, a prescindere
dal caso del difensore le cui conversazioni con l’assistito, indagato, ma
archiviato, non solo sono state proditoriamente intercettate, ma anche
illecitamente trascritte e poi depositate dal procuratore generale
della Cassazione agli atti di un procedimento disciplinare a carico di un terzo,
in barba all’exclusionary rule di cui all’art. 103 comma 7 del codice di
procedura penale, senza che la Sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura vi abbia trovato nulla da eccepire, mi è capitato
d’imbattermi nelle vicissitudini di due avvocati milanesi, posti di fronte
all’interrogativo, come possa un avvocato, nell’esercizio del ministero della
difesa, dissociarsi dal proprio assistito nei confronti del quale sta
profondendo ogni sforzo al fine di difenderlo al meglio. Tutto nasceva da un
complesso contenzioso civile, con risvolti penali a carico dell’assistito.
A tacere caritatevolmente del
garbo del giudice penale di primo grado, il quale dopo aver manifestato a più
riprese il fastidio durante tutto il corso delle arringhe difensive, sino
all’abbandono, bofonchiando, dell’aula di udienza, mentre l’esposizione era
ancora in corso, è da rimarcarne, invece, la decisione di trasmettere gli atti
alla procura della Repubblica per valutazioni circa l’esercizio dell’azione
penale nei confronti dei difensori, rei di non essersi dissociati dalle
dichiarazioni del proprio cliente, in virtù del principio, Dio sa da dove
esatto, che gli avvocati che non si dissociano dalle dichiarazioni del proprio
assistito e che le fanno proprie nelle arringhe difensive, seppur con «toni solo
apparentemente più pacati ed urbani», concorrono nel reato della persona che
difendono. Il fatto che si giunti a tanto è esemplare dell’insofferenza di certa
magistratura per «quei Cirenei della società», sono ancora parole di Francesco
Carnelutti, che «portano la croce per un altro e questa è la loro nobiltà».
Otello Lupacchini,
Giusfilosofo e magistrato in pensione
«Un giudice “estraneo” in
Camera di Consiglio: il Csm non ci vuole dire che fine ha fatto l’esposto».
La denuncia dell'avvocato Murolo: «La sentenza di condanna del mio assistito
potrebbe essere nulla, ma la procura generale ci nega gli atti che ci servono
per dimostrarlo». Simona Musco su Il Dubbio il 9 marzo 2022.
Non per tutti i magistrati il
diritto alla privacy vale allo stesso modo. A sostenerlo è l’avvocato Giancarlo
Murolo, del foro di Reggio Calabria, alle prese con la decisione della procura
generale della Cassazione – confermata dal Tar del Lazio – di non rendere noto
l’esito di un procedimento disciplinare a carico di quattro magistrati reggini
per ragioni di riservatezza. Una decisione importantissima, per il legale, dal
momento che la stessa potrebbe essere utile a stabilire la nullità della
sentenza di condanna a carico di un suo assistito, Rocco Ripepi, coinvolto
nell’operazione antimafia “Gambling”. Processo che ora pende davanti alla
Cassazione e la cui udienza è prevista per il 4 aprile. Ma all’appuntamento la
difesa sarà costretta probabilmente ad arrivare senza un documento fondamentale,
quello che potrebbe provare la necessità di azzerare il lavoro dei giudici di
merito.
La vicenda affonda le sue
radici nel 2019, quando Ripepi, in attesa della decisione della Corte d’Appello
di Reggio Calabria, vede entrare in camera di consiglio un magistrato estraneo
al collegio giudicante, ma anzi impegnato in precedenza come giudice del Riesame
nel definire la posizione cautelare di un coimputato. Una “visita” durata circa
un’ora e mezza, con la conseguente «violazione della segretezza della camera di
consiglio», denuncia Murolo. «Il collegio – si legge nel ricorso al Consiglio di
Stato – alle ore 12.30 circa» si era «ritirato in camera di consiglio,
avvertendo che intorno alle 19 circa si sarebbe data lettura del dispositivo.
Alle ore 19.45 circa, i ricorrenti con altri coimputati ed i loro familiari, in
attesa dentro e fuori la sede della locale Corte d’Appello, hanno notato
l’ingresso» di un giudice del Riesame, «il quale raggiungeva la stanza ove il
collegio stava deliberando la sentenza. Questi si allontanava dalla predetta
stanza intorno alle ore 21,10 circa, quindi dopo quasi un’ora e mezza di
permanenza in camera di consiglio. Il Ripepi, pertanto, notando tale
straordinaria circostanza, portava a conoscenza del Presidente della Corte
d’Appello tali fatti, chiedendo che venisse accertata la causa della presenza
indebita del quarto giudice».
Da qui un esposto
disciplinare, in seguito al quale Murolo non è riuscito più ad avere
informazioni, se non che lo stesso esposto è arrivato sulla scrivania di Palazzo
dei Marescialli e che il procedimento è stato definito. Impossibile, però,
sapere come: nessuna informazione, a parte questa, è stata ritenuta ostensibile
da parte della procura generale. Da qui la richiesta di accesso agli atti,
avanzata a marzo dello scorso anno, respinta dalla procura generale e dal Tar,
che ha condiviso l’assunto secondo cui «gli atti del procedimento disciplinare
nei confronti dei magistrati ordinari non sono atti amministrativi», bensì
«giurisdizionali», per accedere ai quali è necessario procedere in sede civile
contro i magistrati.
Un controsenso, dal momento
che quegli atti servono alla difesa per contestare la sentenza davanti al
giudice di legittimità, mentre per qualsiasi azione civile il processo dovrebbe
essersi già concluso. Ripepi, infatti, «ha interesse ad ottenere gli atti
richiesti per tutelare la propria posizione processuale, nell’ambito del
processo, ancora pendente – spiega Murolo -. Lo stesso lo potrà fare solo
esibendo tali atti, non essendo in grado di poter ottenere aliter alcuna prova
confortante l’eccepita nullità della sentenza d’appello, conseguente la
violazione del dovere di segretezza della camera di consiglio».
L’errore, secondo il legale,
starebbe nel considerare la decisione disciplinare come un atto giurisdizionale.
Da nessuna parte, infatti, «si attribuisce al procedimento disciplinare la
qualifica di “giurisdizionale”», se non nel generico riferimento all’osservanza
delle regole del codice di procedura penale per l’attività di indagine. Ma ciò
non basta, contesta il legale: «Rimane pur sempre nell’alveo degli atti
amministrativi, atti, quindi, accessibili a chiunque abbia un interesse
qualificato».
Secondo Murolo, nulla, nel
procedimento disciplinare, è assimilabile ad un vero e proprio processo, non
solo per via della composizione mista dei “giudici”, ma anche perché a poter
promuovere l’azione disciplinare è anche il ministero della Giustizia, che tutto
è fuorché un membro della giurisdizione. E se così fosse, in ogni caso, la
Costituzione dovrebbe attribuire al Csm il ruolo di “giudice speciale”, cosa che
invece non fa. «Il rifiuto da parte della procura generale, pertanto, è da
ritenersi ingiustificato, tenuto conto che il diritto alla riservatezza deve
cedere il passo al superiore diritto alla difesa del denunciante, anche in virtù
del principio del giusto processo», prosegue il legale. Che non manca di
evidenziare le differenze con il caso Palamara: «La tanto decantata riservatezza
e la ostinata affermazione di principio della “non ostensibilità” delle
decisioni del Consiglio superiore della magistratura sui procedimenti
disciplinari a carico di magistrati» sono state «allegramente messe da parte in
occasione della vicenda del dottor Luca Palamara. Probabilmente, al fine di
rendere pubblica la rigidità dei giudizi e delle determinazioni (adottate solo
in questo caso, viste le notorie statistiche circa la scarsità delle punizioni
inflitte ai magistrati) prese per tutti coloro che hanno spalleggiato Palamara,
il Consiglio superiore della magistratura ha reso pubbliche le sanzioni
disciplinari, consentendo a tutta la stampa nazionale e alle reti televisive,
nessuna esclusa, di pubblicare, di informare l’intera collettività e di
diffondere, senza alcuna remora sul tanto celebrato diritto alla riservatezza, i
nomi dei soggetti destinatari e persino l’entità delle predette sanzioni».
Come è possibile, si chiede
dunque il legale, «che la non ostensibilità degli atti disciplinari dei
procedimenti a carico dei suddetti magistrati sia venuta meno?». A dire chi ha
ragione, ora, sarà Palazzo Spada, che dovrà pronunciarsi il 10 marzo.
Esposto “sparito”, il Csm
si smarca: non è mai arrivato al Consiglio.
Dopo la denuncia dell'avvocato
Murolo dell'esposto contro il "giudice intruso", Palazzo dei Marescialli fa
sapere che non è mai arrivato al Csm e per cui non è possibile parlare di un
volontario ostruzionismo nei confronti della difesa. Simona Musco su Il Dubbio
il 10 marzo 2022.
Tutto ciò che non arriva a
Palazzo dei Marescialli “muore” negli uffici della procura generale e averne
notizia è impossibile, «perché si tratta di atti segreti». Anche nel caso in cui
quegli atti potrebbero rappresentare “un’arma” per la difesa che lamenta una
violazione dei diritti del proprio assistito, perché nessuno, nemmeno lo stesso
Csm, può intromettersi nella fase predisciplinare. A chiarirlo fonti interne al
Consiglio superiore della magistratura, tirato in ballo a seguito della denuncia
fatta sulle colonne di questo giornale dall’avvocato Giancarlo Murolo, del foro
di Reggio Calabria, che ha chiesto di conoscere l’esito di un esposto,
presentato più di due anni fa, nel quale si lamentava la presenza, in Camera di
consiglio, di un magistrato estraneo al collegio giudicante e impegnato in
precedenza come giudice del Riesame nel definire la posizione cautelare di un
coimputato del suo assistito, Rocco Ripepi, imputato nel processo “Gambling”.
Ma quell’esposto, spiega ora
il Csm, non è mai arrivato a Palazzo dei Marescialli, per cui non è possibile
parlare di un volontario ostruzionismo nei confronti della difesa. «Gli atti che
compongono il cosiddetto fascicolo predisciplinare, quello che si apre presso la
procura generale quale soggetto chiamato ad esercitare eventualmente l’azione
disciplinare a carico di un magistrato – spiega la fonte -, non sono conosciuto
o accessibile né al Consiglio superiore della magistratura, né al soggetto che
ha presentato l’esposto e nemmeno al magistrato oggetto della lamentela». Ripepi
aveva presentato il suo esposto due anni fa al presidente della Corte d’appello
di Reggio Calabria, che dopo una preliminare istruzione ha inviato tutte le
carte alla procura generale. L’uomo aveva denunciato la presenza in Camera di
consiglio di un magistrato esterno al collegio, una “visita” durata circa un’ora
e mezza, con la conseguente «violazione della segretezza della camera di
consiglio», ha sottolineato l’avvocato. Che da quel momento non ha saputo più
nulla: gli atti, aveva risposto a sua richiesta la procura generale, non erano
ostensibili e tutto ciò che era dato sapere è che «i procedimenti originati
dall’esposto sono stati definiti».
Ma quegli atti, ha spiegato
Murolo, sono necessari alla difesa, in quanto «prova confortante l’eccepita
nullità della sentenza d’appello». Da qui il ricorso al Tar – davanti al quale
Murolo ha citato il ministero della Giustizia e la procura generale -, secondo
cui, però, «gli atti del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati
ordinari non sono atti amministrativi» ma «giurisdizionali» e pertanto «rispetto
ad essi non valgono le esigenze di ordine generale a fondamento dell’accesso nei
confronti dell’attività di pubblico interesse dell’amministrazione, consistenti
nel “favorire la partecipazione e (…) assicurarne l’imparzialità e la
trasparenza”». A dirimere la questione ci penserà domani il Consiglio di Stato,
che dovrà decidere definitivamente se quella prova ritenuta fondamentale dalla
difesa sia accessibile o meno. E ciò a pochi giorni dall’udienza in Cassazione,
fissata il 4 aprile. Intanto, però, è possibile fare chiarezza su tutto ciò che
accade prima che un fascicolo si “incardini” a Palazzo dei Marescialli. Dal
momento in cui la procura riceve la notizia di illecito disciplinare, che
consente di fare delle sommarie indagini preliminari per capire se esercitare o
meno l’azione, questo pezzo di procedimento rimane segreto. E se la decisione
del pg è quella di chiudere tutto senza passare la palla al Csm, nessuno,
nemmeno la parte che ha lamentato un eventuale danno, verrà mai a sapere che
fine abbia fatto il proprio esposto. La sentenza del Tar Lazio, spiega la fonte,
«non è affatto nuova: esistono diversi precedenti». E ciò perché «la procura
generale lavora nell’interesse dell’amministrazione della giustizia, in questo
caso nell’interesse di un controllo dell’attività di quei magistrati oggetto
dell’esposto. Ma si tratta di procedimenti interni, perciò inaccessibili».
Segreti, un po’ come le
inchieste fino alla chiusura delle indagini preliminari. L’obiezione è
automatica: in quel caso, chi si è eventualmente rivolto all’autorità
giudiziaria ha diritto ad essere informato e c’è un giudice a vagliare il tutto.
Ma ciò non vale per le “indagini” che la procura generale svolge sui magistrati:
«Una cosa è l’indagine penale, una cosa l’indagine disciplinare, un fatto
interno all’ordinamento della categoria interessata. Tant’è che neanche il
Consiglio ha accesso agli atti». Come indaga, dunque, la procura generale? Una
delle possibilità è che il pg deleghi ai capi delle Corti interessate il compito
di sentire i magistrati e riferire poi alla procura generale, cosa che nel caso
specifico sarebbe avvenuta preventivamente.
Probabile, dunque, che
l’esposto di Murolo sia stato archiviato. Ma cosa fare nel caso in cui una
violazione della segretezza della Camera di consiglio si sia effettivamente
verificata? «Il privato che si sente eventualmente leso può percorrere la strada
della legge Vassalli, cioè della responsabilità civile, o tentare la via della
giustizia penale». Murolo però non si arrende: «La legge non prevede che gli
atti non siano ostensibili – ribadisce -, si tratta di una costruzione
giurisprudenziale. Al di là del fatto che mi era stato comunicato che il
procedimento era in corso, per noi sono fondamentali gli atti, non solo il
provvedimento finale: ne va del diritto alla difesa».
«Io, avvocato segnalato da
una gip, solo perché ho preteso rispetto…».
Il legale è stato segnalato da
una giudice agli organi disciplinari dopo una discussione con un carabiniere in
corridoio. «Non ho potuto dire la mia: da parte sua un atteggiamento astioso».
Damiano Aliprandi su Il Dubbio il 3 marzo 2022.
«La giudice ha interrotto
l’udienza e mi ha accusato di avere apostrofato “con irripetibili insulti” il
giovane carabiniere (definito con tono materno “un ragazzo per bene, che fa il
suo lavoro”). Ma non è vero. Non mi ha concesso il diritto di replica e ha preso
in considerazione solamente il resoconto dell’appuntato pieno di inesattezze da
inviare ai competenti Organi disciplinari, che avrebbero provveduto al mio
caso». È l’avvocato Paolo Di Fresco del foro di Milano a denunciare l’accaduto.
Una vicenda che lo ha costretto a segnalare il comportamento del giudice
all’ordine degli avvocati e alla camera penale.
I fatti
Andiamo con ordine. Giovedì
scorso, alle 11.30, assieme a molti altri colleghi, l’avvocato Di Fresco
attendeva nel corridoio dell’Ufficio gip, in attesa che la giudice “chiamasse”
il suo processo, fissato per le 11.10. Ad un certo punto un carabiniere di
piantone ha ordinato ai presenti di tacere e sgombrare il corridoio. In
particolare a Di Fresco e altri due colleghi, veniva intimato di togliersi di
mezzo. «Dovete levarvi di qui», avrebbe detto loro. A quel punto, l’avvocato Di
Fresco racconta di aver risposto al giovane appuntato in modo netto, invitandolo
a serbare un atteggiamento più rispettoso nei confronti degli avvocati impegnati
nelle loro attività. «A quel punto – prosegue Di Fresco nel racconto
dell’accaduto -, il carabiniere mi si avvicinava con fare minaccioso ma io non
raccoglievo la provocazione e testualmente lo invitavo a lasciar perdere e
andarsene (“Lasci perdere e veda di andarsene”)».
Un quarto d’ora più tardi, lo
stesso appuntato gli ha chiesto di seguirlo nella stanza del giudice cui si
doveva l’ordine di far allontanare gli avvocati dal corridoio. Ed ecco che si
arriva al punto, quello che l’avvocato Di Fresco vede come un comportamento
irrispettoso per l’intera categoria. «La stessa – racconta nei dettagli
l’avvocato Di Fresco -, interrotta l’udienza, mi accusava di avere apostrofato
“con irripetibili insulti” il giovane carabiniere (definito con tono materno “un
ragazzo per bene, che fa il suo lavoro”) e, convocato il suo vicino di stanza e
presunto testimone del confronto tra me e l’appuntato, imbastiva una sorta di
giudizio direttissimo nei miei confronti. Chiusa la porta e interrogato
l’appuntato (senza concedermi alcun diritto di replica), dettava al cancelliere
un resoconto pieno di inesattezze da inviare ai competenti Organi disciplinari,
che avrebbero provveduto al mio caso». Sorpreso da quel modo di procedere,
l’avvocato Di Fresco ha chiesto di poter contattare un consigliere dell’Ordine o
un rappresentante della Camera Penale, ma la giudice avrebbe tagliato corto
dicendo che non si trattava di un processo, ma di una mera segnalazione per il
suo comportamento irriguardoso nei confronti delle Istituzioni. Riuscendo a
strappare almeno una battuta in sua difesa, l’avvocato racconta di aver ribadito
di non avere offeso l’appuntato, ma di avere soltanto protestato di fronte a un
atteggiamento che riteneva irrispettoso nei confronti degli avvocati presenti.
Il precedente: “Dalla giudice
un atteggiamento astioso nei confronti di quegli avvocati”
Prosegue l’avvocato del foro
di Milano: «Insistevo inoltre nel dire – e di ciò pretendevo si desse atto in
quella parodia di verbale che, schiumando di rabbia, la giudice aveva dettato al
cancelliere – che il Tribunale è anche degli avvocati, i quali non sono ospiti
da tollerare a stento nel Palazzo di Giustizia». Conclusa la verbalizzazione,
gli era infine consentito di lasciare la stanza e tornare alle sue attività.
Questi, in sintesi, i fatti che l’avvocato di Fresco ha ritenuto opportuno
segnalare all’ordine e alla camera penale. Aggiunge anche un altro particolare.
A detta sua, o meglio si tratta di una impressione, la giudice avrebbe colto
l’occasione per dare seguito a un piccolo, personale, regolamento di
conti. Infatti, nel luglio 2021, nel corso dell’udienza preliminare di un
processo da lei presieduto, l’avvocato aveva vibratamente protestato contro la
sua decisione di limitare gli interventi dei difensori, costringendoli a
discutere non più di 5 minuti a testa nell’interesse di imputati (tra cui il suo
assistito) che non avevano avuto modo di far sentire la loro voce nei lunghi
mesi di custodia cautelare a cui erano stati sottoposti. «So dai colleghi che la
mia netta presa di posizione aveva suscitato già allora una sua reazione sopra
le righe», rivela sempre Di Fresco. La segnalazione dell’avvocato conclude con
una nota polemica: «I fatti odierni parrebbero, dunque, confermare l’esistenza
di un atteggiamento astioso della giudice nei confronti di quegli avvocati che
non sono disposti a baciare la pantofola del Giudice sovrano».
Procura di Bergamo,
presunte intimidazioni a un praticante avvocato: spuntano le telefonate.
Nuovi dettagli
sulla vicenda già oggetto di due esposti al Csm. Le trascrizioni delle
conversazioni finiscono nel nuovo fascicolo. Valentina Stella su Il Dubbio il 24
febbraio 2022.
Ricordate il caso che vi
abbiamo raccontato nel 2020 riguardante due esposti al Csm per presunte
intimidazioni ad un praticante avvocato da parte di un sostituto Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e di un Tenente colonnello della
Guardia di Finanza? Ricapitoliamo.
La vicenda in sintesi
I due avrebbero convocato con
un pretesto il giovane praticante E.F., lo avrebbero chiuso in una stanzetta,
intimidito con urla e minacce, obbligato a spegnere il cellulare, gli avrebbero
negato il diritto di appellarsi al segreto professionale e lo avrebbero
torchiato per tre ore e mezza per estorcergli informazioni su un importante
cliente dello studio, Gianfranco Cerea, che aveva concluso una procedura di
voluntary disclosure per un rimpatrio di capitali dall’estero. Aggiungiamo che
la Procura aveva sottoposto ad intercettazione l’auto del praticante e la sua
utenza. Secondo la Procura esistevano a carico di Cerea gravi indizi di
esibizione di atti falsi: non sarebbe stato un collezionista ma un vero mercante
d’arte. Qualche settimana fa Cerea è stato condannato in primo grado a tre anni
di carcere per false dichiarazioni nella voluntary disclosure. Ma non è questo
il punto, bensì un altro: durante il dibattimento sarebbe stato confermato
quanto scritto nei due precedenti esposti riportati da questo giornale.
Qual era il problema?
Gli esposti riportavano la
versione del ragazzo ma gli avvocati avevano chiesto di acquisire le
trascrizioni delle telefonate intercettate per provare quanto riferito dal
praticante. Solo che, a loro dire, la documentazione inviata dalla Guardia di
Finanza alla Procura, affinché fornisse spiegazioni per l’istruttoria aperta dal
Csm, risultava «inspiegabilmente priva delle chiamate intercettate sull’utenza
telefonica in uso al dottor Ferrara il cui contenuto è particolarmente
importante ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare in
oggetto». Adesso quelle telefonate sono note.
Il nuovo fascicolo al Csm
Lo si evince da un nuovo
esposto, presentato da Cerea stesso questa volta, e indirizzato alla Ministra
della Giustizia Marta Cartabia, al Ministro dell’Economia Daniele Franco, alla
sezione disciplinare del Csm e al suo vice presidente David Ermini. Abbiamo
avuto modo di visionarlo e vi leggiamo che “la vicenda riportata da Il Dubbio ha
suscitato in me – scrive Cerea – comprensibile disagio. […] La presente
iniziativa nasce perché il dibattimento che si è svolto davanti al Tribunale di
Bergamo – con l’acquisizione delle trascrizioni di undici telefonate del dottor
E.F. ha confermato quanto evidenziato negli esposti del 2020″, presentati dagli
ex avvocati che seguivano la procedura di voluntary disclosure.
Le telefonate trascritte
Prima dell’interrogatorio il
dominus raccomanda a Ferrara di opporre il segreto professionale. Terminato
l’incontro con pm e finanzieri, Ferrara chiama in evidente stato di prostrazione
una collega di studio. Piange e confessa: «Mi sono sentito morire Francesca tre
ore e mezza come se fossi un delinquente – ma il Pubblico Ministero che mi
commenta si sta approcciando con disinvoltura alla professione legale. Ma che
vergogna – ma erano cinque contro uno. Mi hanno fatto sentire un delinquente.
Adesso capisco quale sia il metodo Di Pietro. Con il Comandante gliel’ho detto
mi sta inducendo a dire cose che non ho detto, che non sto pensando … mi sta
inducendo a rispondere cose che … che vuole che scriva … vuole scrivere lei».
Poi chiama l’avvocato di studio Stufano: « tre ore e mezza davanti al Pubblico
Ministero. La prima cosa che mi hanno detto c’è qui il pubblico ministero –
tanto a fare terrorismo psicologico – quindi se dichiara il falso è false
dichiarazioni al PM”. Replica Stufano: «Ho chiamato … alla tenenza, mi ha
risposto uno, mi fa no, non glielo posso passare dico: scusi, sono l’avvocato …
ma che cazzo è in stato di sequestro? Abbia pazienza! … ma è sequestro di
persona!». Poi un’altra telefonata alla collega in cui riferisce la
conversazione con Stufano: «Dice che il loro comportamento è stato scorretto,
illegale, illecito, che ci sono gli estremi di un abuso … quindi poter procedere
con un esposto dacché … anche il segreto professionale loro mi hanno costretto a
violarlo». Secondo Cerea, come si legge nel nuovo esposto, «le telefonate appena
richiamate sono state oggetto di un accurato depistaggio degli inquirenti volto,
da un lato, a nascondere al Csm ed alla Procura Generale di Brescia l’esistenza
di queste telefonate e, dall’altro, a confondere le acque riportando nei
brogliacci una serie di particolari pacificamente falsi. Particolarmente
significativa, a riprova dell’evidente depistaggio, una nota nella quale viene
prospettato – cosa francamente ridicola – che queste telefonate non sarebbero
state trascritte perché ritenute ininfluenti dagli operanti della GdF». Come se
non bastasse, «all’udienza del 29 ottobre 2021 presso il Tribunale di Bergamo
E.F, nel corso del suo esame dibattimentale, ha confermato di avere subìto le
illecite pressioni di cui agli esposti presentati». Abbiamo chiesto all’avvocato
E.F. un commento ma ha declinato il nostro invito.
La richiesta
Pertanto Cerea chiede al Csm
di «valutare l’operato della Procura della Repubblica di Bergamo anche alla luce
delle dichiarazioni rese dal procuratore Capo alla giornalista de Il Dubbio che
ne aveva dato conto nell’articolo apparso il 17.11.2020 (“questa procura, che
ribadisce piena fiducia nel corretto operato del magistrato e dell’ufficiale
della Guardia di Finanza, per quanto di sua specifica competenza, provvederà ad
analizzare approfonditamente i contenuti di questo esposto, riferendo a chi di
competenza e valutando la condotta di tutti i soggetti coinvolti nella
vicenda”)». Ovviamente, se il Procuratore di Bergamo volesse commentare la
vicenda noi siamo qui, come l’altra volta, in cui riportammo la difesa del suo
sostituto , che aveva negato categoricamente la ricostruzione riportata nei
primi due esposti.
E il giudice disse:
“L’avvocato che non si dissocia dal proprio cliente ne è complice”.
L'incredibile
vicenda di due legali del Foro di Milano: il giudice chiede di inquisirli per
presunta “collusione morale” con l’assistita. Gennaro Grimolizzi su Il Dubbio il
24 febbraio 2022.
Come può un avvocato,
nell’esercizio del ministero della difesa, dissociarsi dal proprio assistito nei
confronti del quale sta profondendo ogni sforzo al fine di difenderlo al meglio?
Questo interrogativo sta
arrovellando Enrico Visciano e Alfredo Partexano del Foro di Milano, i quali
hanno deciso di raccontare una vicenda che li ha riguardati come
professionisti. Tutto nasce da un complesso contenzioso civile, sorto alcuni
anni fa, riguardante il pagamento di una quietanza assicurativa a seguito di un
incidente stradale mortale. Dal civile si sono poi avuti dei risvolti penali,
con un procedimento per calunnia davanti al Tribunale di Monza, nonostante una
archiviazione originaria, nei confronti dell’assistita di Visciano e Partexano.
Nelle fasi conclusive del
processo, con gli interventi dei difensori, il primo colpo di scena: il giudice,
a un certo punto, nel corso dell’arringa difensiva, si incammina verso l’uscita
per abbandonare l’aula di udienza. «Durante le arringhe davanti al Tribunale di
Monza – dicono al Dubbio gli avvocati Visciano e Partexano – ci siamo imbattuti
in molteplici interruzioni, nonostante i richiami di noi difensori rispetto
all’impossibilità assoluta di interrompere un’arringa finale quale momento
sacramentale del rito. Anche l’imputato, non dimentichiamolo mai, ha dei
diritti. Le interruzioni erano messe in atto sia dal difensore di parte civile
sia dal giudice, che richiamammo affinché tornasse al proprio posto, nel momento
in cui decise di allontanarsi dall’aula con i faldoni in mano. Solo con le
nostre proteste rivolte al giudice siamo riusciti a concludere le arringhe».
Con la sentenza, l’altro colpo
di scena. L’assistita di Visciano e Partexano viene condannata a quattro anni di
reclusione, ma a lasciare di sasso gli avvocati sono le parole usate dal
magistrato in sentenza. Un passaggio che amareggia i due legali anche per la
considerazione complessiva dell’avvocatura. «La lettura della sentenza di
condanna – evidenziano –, in particolare a pagina 21, portava noi difensori a
sentirci colpiti non solo nell’intimo della nostra professionalità ma anche come
categoria. Si era deciso di trasferire atti e causa alla Procura anche per le
difese, vale a dire nei nostri diretti confronti, per la sola colpa di non
esserci dissociati dalle dichiarazioni della nostra cliente».
Dunque, a detta del giudice,
gli avvocati che non si dissociano dalle dichiarazioni del proprio assistito e
che le fanno proprie nelle arringhe, seppur con «toni solo apparentemente più
pacati ed urbani», rischiano quanto la persona difesa. Un’assimilazione
singolare. Un assunto che ha lasciato molto perplessi Visciano e Partexano,
senza però scoraggiarli. Anzi. Uno sprone ad andare fino in fondo e presentare
appello.
A Milano, il terzo colpo di
scena. «Il nostro stupore – commentano – fu ancora maggiore nel leggere l’atto
del Procuratore generale che citava il passaggio della sentenza del Tribunale di
Monza, rimarcandolo alla prima riga della propria requisitoria e delle proprie
conclusioni scritte, come se fosse l’aspetto più importante del processo».
Una sottolineatura che ha
indotto Visciano e Partexano a richiedere la trattazione orale della causa.
«Abbiamo deciso – aggiungono – di far risaltare il passaggio a gran voce durante
le arringhe in appello e fare menzione del fatto che eravamo stati troppo
eleganti nel non dare la necessaria importanza a un così grave fatto. Era giunto
il momento di approfondire e sottolineare come i rapporti tra magistratura e
avvocatura siano da considerarsi assai compromessi, se davvero può esistere un
protocollo secondo cui ogni difensore, all’atto di iniziare la propria arringa,
quale momento sacramentale nel rito, è costretto ad alzarsi in piedi, alzare la
mano e dissociarsi dall’innocenza del proprio assistito».
A questo punto Enrico Visciano
si infervora e descrive i momenti della sua arringa in Corte d’Appello. «Mentre
parlavo – afferma – ho voluto battere la mano sulla toga, dalla parte della
spalla destra, facendo rimbalzare verso l’alto i cordoni dorati per ben tre
volte. Un gesto ben preciso, atto ad indicare l’inviolabilità della toga, di ciò
che è molto di più di un mero e semplice servizio. Svolgiamo un ruolo,
costituzionalmente garantito, che non può risultar oggetto, da parte di nessuno,
di scherno, di interruzioni, di dissacrazioni, di ipotesi di reato nel momento
stesso della necessità difensiva del cliente, senza dimenticare la storia
personale dei protagonisti coinvolti. Per questo motivo mi rivolsi in udienza al
Procuratore generale, chiedendogli di guardarmi negli occhi e di rispondermi, se
poteva, proprio lì, davanti a tutti gli astanti, sulla tipologia di reato che
avremmo potuto commettere noi avvocati o sul già ricordato trasferimento degli
atti alla Procura della Repubblica disposto nei nostri confronti da parte del
giudice Colella. Trasferimento rimarcato anche da parte dello stesso Procuratore
generale».
Quanto successo pone l’accento
sullo svilimento al quale può andare incontro alcune volte il ruolo del
difensore. In questo contesto si inserisce il tema del pericolo di
spersonalizzazione della difesa sul quale tante volte si sono soffermati
importanti esponenti dell’avvocatura. Le parole del presidente del Coa di Milano
Vinicio Nardo (si veda Il Dubbio del 12 gennaio 2022) sono un riferimento
significativo: «L’avvocato deve seguire le sorti del cliente. Deve essere la
fotocopia del cliente, non del magistrato. Il magistrato è un funzionario di
Stato e risponde allo Stato. L’avvocato è un libero professionista e risponde al
cliente».
Per la cronaca è opportuno
segnalare che la Corte d’Appello ha comunque assolto la cliente di Visciano e
Partexano. I giudici hanno accolto le domande sulla prescrizione e revocato le
statuizioni civili, ossia il danno pari quasi a 80mila euro concesso alla parte
civile in primo grado. «Il che – concludono i legali – non ci pare poco, dopo
una condanna in primo grado a quattro anni di reclusione».
L’avversario. Quella strana
pretesa avvocatesca di costruire la giustizia.
Iuri Maria Prado su L'Inkiesta
l'8 Febbraio 2022.
Il suo compito è solo la
difesa del cliente, fatta proprio perché esiste un soggetto (lo Stato) che si
impanca a giudicarlo. L’idea di collaborare è aliena alla sua missione e porta a
derive pericolose.
C’è in alcuni giuristi la
pretesa, e in alcuni magistrati la concessione, che gli avvocati in qualche modo
“partecipino” alla giustizia da rendere in aula. Pretesa e concessione riposanti
sull’idea, cioè, che l’avvocato contribuisca, e debba contribuire, a scrivere la
giustizia di cui è destinatario il proprio assistito.
È un’idea profondamente
sbagliata e dannosissima. L’avvocato deve difendere il proprio assistito perché
questi è accusato, non perché è accusato malamente o infondatamente: e, in
quella difesa, l’avvocato non deve in nessun modo lavorare con, ma in ogni modo
contro, chi eleva l’accusa. Il magistrato, per il sol fatto di essere impancato
ad accusare e giudicare, è, o almeno dovrebbe essere considerato, un avversario
dell’avvocato: necessario, da rispettare, ma avversario. E che non dismette
questa sua caratteristica nemmeno, e anzi tanto meno, quando dice una giustizia
confacente agli interessi di chi è processato.
L’avvocato stimolato a essere
“coautore” di giustizia, e a compiacersene, come purtroppo spesso accade, per
quanto magari in buona fede rinnega in realtà la propria funzione, che è
tutt’altra: rappresentare e difendere la controparte individuale – non il
discepolo timorato, non il resipiscente incurvo, non il consegnato in postura
penitenziale, insomma non la vittima in attesa di giudizio – del potere
pubblico.
La sentenza “giusta” che
ostentasse in calce la finzione della firma del difensore sarebbe la sentenza
più detestabile, la meno affidabile, e la più contraria all’idea stessa di una
decisione resa secondo diritto.
Chi poi sapesse e volesse
indagare tra le motivazioni profonde di quella pretesa avvocatesca, e cioè di
non esser solo voce del proprio cliente, ma della stessa giustizia di cui questi
destinatario, ne scoprirebbe il subdolo profilo sopraffattorio: quello che in
realtà si carica di potere in quel ruolo incongruo e usurpato, rivolgendosi a
“fare stato” sul proprio assistito. Una specie di agente di giustizia.
Presunzione d’innocenza,
questa sconosciuta. La legge non basta…Sono
passati due mesi dalla nuova norma ma gran parte dei giornali e delle procure
continuano a sbattere “il mostro in prima pagina”. Ecco cosa è successo a
Bari...di Valentina Stella su Il Dubbio il 4 febbraio 2022.
In questi giorni siamo tornati
a scrivere in merito alla nuova norma sulla presunzione di innocenza in vigore
dal 14 dicembre. Ci siamo chiesti se realmente sia cambiato qualcosa nella
comunicazione delle Procure e delle forze di polizia giudiziaria. Le risposte
sono state molteplici: se per un verso ci sono stati dei mutamenti, dall’altro
verso è difficile talvolta stabilire se si stia eludendo la norma. Ad esempio la
norma prevede di non dare alle inchieste nomi lesivi della presunzione di
innocenza. Ma se un nome viene dato, e però all’interno del comunicato non ci
sono i riferimenti degli indagati, si è contra legem?
Discutendo con magistrati,
avvocati, giornalisti abbiamo anche capito che la nuova norma non è la panacea
di tutti i mali, come vedremo appunto in questo pezzo, prendendo in esame un
aspetto che è stato criticato da molti, persino dai magistrati. Dopo il
monitoraggio di un copioso numero di comunicati della Guardia di Finanza, oggi
vogliamo cimentarci, infatti, in un altro esercizio: prendere una notizia
pubblicata sui maggiori siti di informazione e vedere se la presunzione di
innocenza dell’indagato è rispettata. Badiamo bene: se è rispettata come
principio culturale, perché purtroppo la nuova legge non interviene nel caso che
stiamo per discutere. Lo spunto ce lo offre una nota agenzia della redazione di
Bari: «Abusi in ambulanza su una studentessa, arrestato – Ai domiciliari un
paramedico volontario», questo il titolo. All’interno dell’articolo vengono
pubblicati stralci dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip.
Precisiamo che non c’è un comunicato ufficiale della Procura né della polizia
giudiziaria. Ne deriva che l’ordinanza di custodia cautelare, atto pubblico, può
essere finita nelle mani del giornalista o tramite l’avvocato difensore
dell’indagato – ipotesi improbabile – , o tramite cancellieri, agenti della Pg,
magistrati della procura, avvocato di parte civile.
Per l’avvocato Giuseppe
Belcastro, co-responsabile, insieme a Luca Brezigar, dell’Osservatorio
Informazione Giudiziaria dell’Unione Camere Penali, «è sicuramente una criticità
il fatto che la nuova norma non abbia anche previsto espressamente il divieto di
pubblicazione dell’ordinanza di custodia cautelare. Se da un lato è giusto
informare i cittadini quando qualcuno viene privato della libertà personale,
tuttavia la pubblicazione degli stralci o dell’intera ordinanza del gip
rappresenta una lesione del diritto alla riservatezza, all’onore e alla
presunzione di innocenza dell’indagato». Il motivo è cristallino, ma non per
molti: «vengono resi pubblici dei dettagli lesivi della immagine dell’indagato
che però potrebbero essere smentiti in fase processuale o anche già in fase di
indagine. Andando oltre il dato dell’arresto e della motivazione si rischia
sempre di creare il ‘mostro’ da prima pagina. E se poi viene assolto?». Non
sappiamo perché nei vari articoli usciti non sia stato interpellato l’avvocato
difensore dell’uomo ai domiciliari. Questa omissione, secondo l’avvocato
Belcastro, «rende quanto meno parziale la narrazione dei fatti, tenendo però a
mente che il difensore deve comunque sempre attentamente valutare se e come
intervenire sui media. Il dovere della stampa è fare una cronaca della vicenda,
non fornire una visione parziale della stessa».
Ma addentriamoci
nell’articolo. Il pezzo inizia e prosegue usando molte volte termini ipotetici:
l’uomo «avrebbe abusato dentro un’ambulanza di una studentessa universitaria
approfittando della fatto che la ragazza si era sentita male per aver bevuto
troppo ad una festa. Un paramedico volontario, Gaetano Notaro di 36 anni, è agli
arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata». E ancora: la «presunta
violenza sarebbe avvenuta», «la presunta vittima ha deciso di denunciare circa
due settimane dopo il fatto, rivolgendosi ad un centro antiviolenza». Secondo
l’analisi dell’avvocato Belcastro «fino ad un certo punto l’articolo è stato
continente, utilizzando verbi e aggettivi appropriati per un contesto probatorio
che deve essere ancora definito. Tuttavia, proseguendo con il racconto e
aggiungendo ulteriori dettagli estrapolati dall’ordinanza del gip («La ragazza,
scrive il giudice, “ha descritto i particolari dell’abuso subito, descrivendone
lucidamente ogni dettaglio, anche i più umilianti” e non ci sono elementi per
“ipotizzare che siano frutto di intenti calunniosi”», ndr) si è andati oltre.Non
dobbiamo scordare che queste valutazioni del gip saranno verosimilmente oggetto
di ricorso al Tribunale del Riesame e persino della Corte di Cassazione.
Insomma, se un gup non archivierà, si andrà a processo e solo lì emergerà la
verità processuale. Il processo è un fatto complesso e delicato: occorre anche
saper attendere». Questo è solo un esempio di come la strada da fare sia ancora
molta, perché «trovare in edicola le ordinanze di custodia cautelare non
significa salvaguardare il giusto processo», ha detto in un recente convegno sul
tema Luca Brezigar. Se avete segnalazioni da farci sia su casi come questi o
direttamente lesivi della nuova norma scriveteci pure.
«Così aiuti la
mafia!», l’anatema multiuso che tappa la bocca ai garantisti.
La polemica di
Gratteri sulla presunzione d’innocenza («le mafie potrebbero approfittarne») è
solo l’ultimo esempio. Costretti ad arretrare, i giustizialisti duri e puri
sfoderano sempre più spesso l’arma della disperazione: accusano l’avversario di
voler favorire le cosche. Anche se, come nel caso del deputato Enrico Costa,
volevano solo affermare lo Stato di diritto. Errico Novi su Il Dubbio l'8
febbraio 2022.
Ormai non si
ragiona più. Promuovi una legge contro la sputtanopoli giudiziaria? «Fai gli
interessi della mafia!». Cerchi di far notare timidamente che la riforma
dell’ergastolo ostativo dovrebbe aderire alle indicazioni della Consulta,
anziché cercare di ribaltarle? «Fai gli interessi della mafia!». E, ovviamente:
provi a chiedere di riagganciare le misure di prevenzione antimafia allo Stato
di diritto, in modo che, almeno, se si è riconosciuti innocenti nel processo
penale non si debba per forza essere spogliati di tutti i beni, dalle aziende
alla abitazione? «Fai gli interessi della mafia!».
Ormai è così: non
se ne esce. E la polemica scatenata da Nicola Gratteri contro le recenti norme
in materia di presunzione d’innocenza («le mafie potrebbero approfittarne», ha
detto ieri in un’intervista al Fatto quotidiano) ne sono la conferma: è davvero
difficile cogliere il nesso reale fra le tutele previste in quel provvedimento e
i presunti favori alle cosche temuti dal procuratore di Catanzaro. Davvero non
si capisce perché, in indagini nelle quali la virtù teologale sarebbe casomai il
riserbo e non certo la ridondanza, vedersi limitati nel riferire ai giornalisti
ogni dettaglio costituirebbe, per gli inquirenti, un danno.
Non a caso Enrico
Costa, tra i maggiori protagonisti dell’iniziativa che nell’autunno scorso ha
consentito di recepire la direttiva “garantista” dell’Ue, ha risposto per le
rime: «Ad essere scontenti saranno coloro che fino ad oggi hanno campato sul
marketing giudiziario, scientificamente studiato da certe Procure per far
conoscere e apprezzare un prodotto parziale, non verificato, non definitivo:
l’accusa. Un prodotto presentato all’opinione pubblica come oro colato. Una
forma di condizionamento anche del giudice, raggiunto da una gragnuola di
frammenti di informazione proveniente solo da una parte».
Gratteri ha
trovato pane per i suoi denti. Resta però l’efficacia del refrain, la paralisi
dialettica che è in grado di indurre: come si fa a uscire dall’angolo, se
insinuano che propendi per una certa norma perché segretamente vuoi fare un
assist ai criminali? Non ne esci. E se ben ci pensate, proprio con una tecnica
del genere lo stesso Gratteri riuscì l’estate scorsa a far scivolare la riforma
del processo penale verso il definitivo avvitamento sull’improcedibilità. Anche
il quel caso disse che si sarebbero persi un sacco di processi alla malavita: ne
è venuto il regime differenziato che ora fa ammattire gli uffici giudiziari,
tanto è piena di eccezioni la norma base.
Ma certo,
chiunque debba intestarsi quell’istituto preferirà farsi dare dell’incompetente,
piuttosto che lasciarsi inchiodare dal inesorabile mood: «Fai gli interessi
della mafia!»
Enrico Costa a Gratteri:
«La legge sulla presunzione d’innocenza colpisce chi ha campato di “marketing
giudiziario”».
Gratteri, in una intervista al Fatto, fa delle affermazioni
pesantissime contro la nuova norma di derivazione europea per la quale Enrico
Costa si è battuto. Valentina Stella Il Dubbio il 07 febbraio 2022.
Scontro a distanza tra il
Procuratore Nicola Gratteri e il deputato di Azione Enrico Costa. Pomo della
discordia: la nuova legge sulla presunzione di innocenza. Stamattina, dalle
solite pagine del Fatto Quotidiano, che da mesi sta mandando avanti una campagna
di delegittimazione della nuova norma, Gratteri, in una intervista, fa delle
affermazioni pesantissime contro la nuova norma di derivazione europea: « Le
mafie potrebbero approfittare della recente legge sulla presunzione di innocenza
che limita la comunicazione istituzionale sulle indagini giudiziarie mettendo di
fatto un bavaglio ai magistrati».
Gratteri fa emergere il solito
malinteso tra indagini e sentenza definitiva
E poi, facendo emergere il
solito – chiamiamolo così – malinteso per cui le indagini corrispondono a
verità e sentenza definitiva, prosegue: «La rilevanza sociale del diritto
all’informazione e del diritto alla verità delle vittime di gravi reati rischia
di essere offuscata da un sistema che impedisce di spiegare ai cittadini
l’importanza dell’azione giudiziaria nei territori controllati dalle mafie,
rendendo molto più difficile creare quel clima di fiducia che consente alle
vittime di rompere il velo dell’omertà».
Tuttavia, la preoccupazione
più grande del Procuratore di Catanzaro è un’altra e non ci si riesce a
credere: «Il mio timore è anche un altro: sembra quasi che non parlandone, la
‘ndrangheta e Cosa Nostra non esistano. Ma non è così, e io ho molta paura che
di questo “silenzio stampa” le mafie ne approfitteranno, perché le mafie da
sempre proliferano nel silenzio. Se la ‘ndrangheta oggi è la mafia più potente è
perché per anni non se ne è parlato».
Costa: «Da brividi
l’insinuazione che la legge provochi un assist alla criminalità organizzata
Vorrà accusare Enrico Costa di
associazione mafiosa? Proprio il responsabile giustizia di Azione reagisce
immediatamente e duramente con un lungo comunicato perché non ci sta a che il
lavoro per cui si è tanto speso venga infangato così: «Legittima ogni
valutazione tecnica; da brividi, invece, l’insinuazione – molto di moda di
fronte alle norme non gradite – che la legge provochi un assist alla criminalità
organizzata. Un sospetto che infanga il lavoro di chi ha lavorato ad un
provvedimento che va esattamente nella direzione opposta: rendere credibile ed
efficace l’azione dello Stato. E lo fa senza inventare nulla, ma recependo una
direttiva europea”.
Il parlamentare passa poi al
contrattacco: «A essere scontenti, certo, saranno coloro che fino ad oggi hanno
campato sul “marketing giudiziario” che è quanto di più pericoloso, incivile,
illiberale, arbitrario. Il “marketing giudiziario” è scientificamente studiato
da certe Procure per far conoscere ed apprezzare un prodotto parziale, non
verificato, non definitivo: l’accusa. Un prodotto – per quanto modificabile e
smentibile – presentato all’opinione pubblica come oro colato. Una forma di
condizionamento dell’opinione pubblica – continua Costa – ma anche del giudice,
raggiunto da una gragnuola di frammenti di informazione proveniente solo da una
parte”.
Costa: «Per molti giornalisti
la vera sentenza è la conferenza stampa»
E poi il dito puntato con la
stampa colpevolista: «La vera sentenza per molti giornalisti è la conferenza
stampa della Procura, perché la sentenza vera, quella pronunciata dopo il
processo, non interessa più a nessuno. Perché le indagini sono presentate come
un processo-inverso: si parte dalla sentenza-conferenza stampa, la si pubblica,
la si scolpisce nell’opinione pubblica, poi forse – quando avrà letto gli atti –
la difesa potrà controbattere. E potrà farlo in un processo a questo punto senza
riflettori, senza titoli, senza interesse».
Costa: «Conosco i numeri delle
ingiuste detenzioni soprattutto in determinate aree»
Costa, in conclusione, è molto
amareggiato e arrabbiato: «Ecco perché mi sento offeso da insinuazioni campate
in aria. Perché conosco i numeri impietosi delle ingiuste detenzioni,
soprattutto in determinate aree del territorio nazionale, e so anche che di
fronte a questi numeri lo Stato paga ingenti risarcimenti, ma chi ha sbagliato
continua serenamente la sua carriera. Se un cittadino avesse riservato a una
sentenza le stesse critiche che il dottor Gratteri ha dedicato alla legge sulla
presunzione d’innocenza, al Csm sarebbero fiorite le pratiche a tutela. Noi non
andremo a piagnucolare al Csm, né ci rivolgeremo al Guardasigilli o al Pg di
Cassazione. Sarebbe del tutto inutile. Nel nostro Paese il diritto di critica è
a senso unico».
Con Costa si è schierato con
un tweet il leader nazionale di Azione, Carlo Calenda: «Il recepimento della
direttiva europea sulla presunzione di innocenza, battaglia vinta da Enrico
Costa, viene giudicata come un aiuto ai clan da parte di Gratteri. La
Magistratura deve essere onnipotente e insindacabile. Caro Gratteri, neanche in
Urss».
«L’immagine di
Hjorth bendato non è casuale: volevano orientare l’opinione pubblica».
Al via
il processo scaturito da quello scatto che fece il giro del mondo. Parla il
legale dell’americano condannato all’ergastolo per l’omicidio Cerciello Rega.
Valentina Stella su Il Dubbio l'8 febbraio 2022.
Inizia a Roma il
processo di primo grado per il bendaggio subìto da Gabriel Natale Hjorth. Si
tratta di una costola del processo principale per la morte del vice
brigadiere Mario Cerciello Rega, per cui sono stati condannati all’ergastolo
Gabriel e Finnegan Lee Elder. Dinanzi al giudice Alfonso Sabella, ci sarà
l’imputato Fabio Manganaro, carabiniere individuato come l’autore del bendaggio.
Quella foto del
ragazzo bendato, con le mani legate dietro la schiena e la testa reclinata in
avanti ha fatto il giro del mondo. Fu scattata il 26 luglio 2019 all’interno
della Caserma dei Carabinieri di Via In Selci in Roma. L’accaduto ha fatto
nascere immediatamente una doppia indagine presso la Procura di Roma: una per
abuso di autorità contro arrestati o detenuti, di cui deve rispondere Manganaro,
e un’altra per violazione del segreto investigativo e abuso d’ufficio, per cui è
stato rinviato a giudizio Silvio Pellegrini. Ne parliamo con uno dei due legali
di Gabriel Natale, l’avvocato Francesco Petrelli, che lo assiste insieme a Fabio
Alonzi.
Avvocato quella
immagine ha suscitato immediatamente sdegno
Sul fatto
intervenne immediatamente il Generale dell’Arma Nistri, dicendo che “quanto è
successo è un fatto molto grave” e che si sarebbe avviata una “indagine interna”
e anche l’allora Presidente del Consiglio Conte disse che “riservare quel
trattamento a una persona privata della libertà non risponde ai nostri principi
e valori giuridici, anzi configura gli estremi di un reato o, forse, di due
reati”. Sul fronte della magistratura ci fu anche un importante intervento del
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Salvi, il quale aggiunse che
si sarebbero dovute anche accertare “eventuali responsabilità per omessa
vigilanza”, cosa che non ci risulta sia stata fatta.
Non pensavamo
potesse accadere una cosa del genere nelle nostre caserme
Quella del
bendaggio o blindfolding dovrebbe essere sconosciuta in un Paese civile e
democratico; infatti è una pratica diffusa nei territori di guerra, dove i
regimi statali autocratici e totalitari o Stati deboli cedono il passo ad
organizzazioni paramilitari o terroristiche. O dove anche gli Stati decidono di
sospendere le garanzie costituzionali: si pensi ad esempio ai fatti ancor più
gravi di Abu Ghraib in Iraq o a Guantanamo. ll Comitato europeo per la
prevenzione della tortura, organismo del Consiglio d’Europa, ha condannato la
pratica del blindfolding in quanto “trattamento inumano e degradante”. L’essere
bendati fa perdere il senso del tempo e dello spazio, rende inermi e si diviene
così un oggetto nelle mani dei carcerieri, è una pratica che umilia il detenuto
ma soprattutto disumanizza il rapporto con colui che è sottoposto ad una misura
limitativa della libertà e tende a rendere irresponsabile dei propri gesti o a
far sentire tale da chi la adotta. Gabriel Natale mentre era bendato venne anche
videoripreso e fu sottoposto a una sorta di interrogatorio.
Il grave episodio
è stato anche oggetto di vostre discussioni nel processo di primo grado per la
morte di Cerciello Rega
Anche la sentenza
della Corte di Assise, sebbene non ne abbia discutibilmente fatto discendere
conseguenze sul piano processuale, non ha voluto “assolutamente sottovalutare la
gravità di quel bendaggio” affermando che “si tratta di un atto lesivo della
dignità umana, ingiustificabile e come tale va certamente stigmatizzato”. Ma il
fatto va oltre l’indegnità di quel trattamento in sé e ci permette di fare anche
qualche altra considerazione sugli effetti della circolazione di quella immagine
del giovane bendato accasciato e con le mani dietro la schiena nel momento che
tale pubblicazione ha integrato un ulteriore illecito che è quello previsto
dall’art. 114 del codice di rito. Mi chiedo quale e quanta influenza abbia avuto
quella immagine nel determinare nel pubblico la convinzione della sicura
colpevolezza dell’accusato. Chi è ristretto in quelle condizioni e sottoposto ad
un simile trattamento “deve” essere colpevole, lo è sicuramente! Quella che è
stata una sconsiderata pratica vessatoria, a causa della sua vasta e immediata
diffusione ha avuto l’effetto di sostenere l’accusa facendone immediatamente
percepire la presunta fondatezza, oltre e al di là della prova. In maniera del
tutto distorta è il trattamento subìto e il modo in cui il sospettato viene
presentato in immagine a fondare la sua responsabilità. Si tratta di un
meccanismo psicologico facilmente comprensibile.
Giovedì inizierà
il processo di appello. Il suo assistito ha avuto l’ergastolo pur non avendo
accoltellato la vittima
Tutti ricordano
quella immagine ma nessuno sa che Gabriel Natale era disarmato, che neppure ha
visto ferire il povero Cerciello, che quando è fuggito, pensando di essere stato
avvicinato da un malintenzionato, neppure aveva capito che vi era stato un
ferimento, che non ha in alcun modo partecipato a quel tragico fatto. Resta
drammaticamente fondamentale il modo in cui un indiziato venga mostrato al
pubblico. È proprio questo il senso della Direttiva europea sul rafforzamento
della “presunzione di innocenza” del 2016 attuata solo da due mesi in Italia:
evitare che l’indagato e l’imputato vengano “presentati come colpevoli” anche
nella formulazione delle notizie, nei titoli, nell’informazione in genere.
Questa legge purtroppo non era in vigore quando è successo il bendaggio ma
comunque probabilmente non sarebbe bastata ad attenuare lo strapotere mediatico
e quello dei social che oramai sopravanzano anche nell’informazione giudiziaria
i media classici. In generale solo un atto di responsabilità dei singoli
comunicatori e un cambio profondo della cultura dell’informazione possono
arginare la barbarie di certe modalità di comunicare il processo, mortificando
l’immagine e la dignità delle persone, compromettendo l’equità dei giudizi e
distruggendo la vita di innocenti.
«Col patrocinio a spese
dello Stato l’avvocato ci rimette». Il promemoria dei Coa palermitani.
Duro documento
firmato dai presidenti di tutti gli Ordini del distretto, che replicano così
alle incredibili accuse del presidente della Corte d’appello Frasca, secondo il
quale «il beneficio rischia di diventare un sostegno al reddito per il Foro».
Errico Novi su Il Dubbio l'1 febbraio 2022.
Con toni corretti ma anche con
fermezza: così i presidenti dei Coa rispondono al presidente della Corte
d’appello di Palermo Matteo Frasca, che sabato scorso, nel proprio intervento
all’inaugurazione dell’anno giudiziario, aveva richiamato l’elevato numero di
cittadini beneficiati dal patrocinio a spese dello Stato come «sintomatico di
una tendenziale deriva incontrollata dell’istituto verso una anomala forma di
sostegno del reddito di una parte del Foro, snaturandone la sua effettiva e
nobile funzione».
Un’accusa incomprensibile, a
cui replicano appunto i vertici degli Ordini dell’intero distretto palermitano:
«Il patrocinio a spese dello Stato, lungi dal rappresentare una “anomala forma
di sostegno al reddito di una parte del Foro”, è un istituto di avanzata cultura
giuridica», ricordano, «disciplinato da legge dello Stato, il cui costo grava in
buona parte sull’avvocatura». Sono parole firmate in calce a un documento
unitario dai presidenti dei Coa Antonio Gabriele Armetta, Vincenza Gaziano,
Giuseppe Spada, Giuseppe Livio, Pietro Siragusa e Vito Galluffo.
La loro nota restituisce un
dato di realtà che fa a pezzi le inspiegabili insinuazioni del presidente
Frasca: «L’avvocatura», fanno notare i presidenti del distretto, «subisce, per
disposizione di legge, il pagamento di compensi inferiori alla metà» rispetto ai
riferimenti di partenza indicati dal decreto ministeriale 55 del 2014, vale a
dire la disciplina dei parametri forensi. E così, ricordano i vertici
dell’avvocatura palermitana, la classe forense «presta in favore dei non
abbienti la propria professionalità» nonostante «onorari mortificanti rispetto a
quanto previsto dalla normativa in tema di equo compenso» e per giunta «in tempi
inaccettabili, come da sempre denunciato». Il documento rammenta l’alto dato di
fatto: «Non è il difensore, ma la parte, ad essere ammessa al patrocinio a spese
dello Stato».
I presidenti dei Coa chiudono
con un gelido pro memoria, che in teoria non sarebbe necessario ma che
evidentemente va riproposto: «Andrebbe ricordato come si tenti, da anni, di
addossare ai difensori oneri di controllo addirittura sulla regolarità delle
dichiarazioni reddituali degli assistiti, compiti che», però, «sono rimessi alla
polizia tributaria, non agli avvocati».
COME IN ITALIA.
Perché il crossover Scandal
– Le Regole del Delitto Perfetto torna oggi più attuale che mai.
Nel crossover fra Scandal
e Le Regole del Delitto Perfetto emerge la condizione di perenne svantaggio e
discriminazione contro cui le persone nere hanno ripreso a manifestare in queste
settimane. Ambra Romanazzi su optimagazine.com il 12/06/2020.
La morte di George Floyd e le
proteste che ne sono derivate hanno infuocato il dibattito sulla necessità di
ripensare la natura stessa delle forze dell’ordine negli Stati Uniti. Ed è
innegabile che la brutalità della polizia scateni tanta ingiustificata violenza
verso i cittadini afroamericani, ma ciò non toglie che la condizione di
svantaggio e discriminazione delle persone nere si avverta anche in altre
declinazioni della società.
Nel corso delle sue sei
stagioni Le Regole del Delitto Perfetto ha attraversato più volte i meandri
della giustizia americana, raggiungendo picchi di cruda e dolorosa efficacia nel
racconto della class action condotta da Annalise Keating fino alla Corte
Suprema. Ed è in particolare nel crossover con Scandal che Le Regole del Delitto
Perfetto lascia emergere fatti e dati tornati tristemente attuali in queste
settimane di proteste.
Grazie all’aiuto di Olivia
Pope (Kerry Washington), Annalise riesce a sostenere in modo brillante la sua
argomentazione: lo stato della Pennsylvania non garantisce un supporto legale
adeguato a chi non può permettersi un avvocato, dunque non rispetta la
Costituzione. Di conseguenza i poveri, e in particolare i poveri afroamericani,
finiscono spesso in carcere ingiustamente e sono costretti a scontare pene più
lunghe di chi invece può permettersi un avvocato.
Le tesi che Olivia e Annalise
portano dinanzi alla Corte Suprema non sono espedienti narrativi, ma parentesi
di realtà che si fanno di volta in volta più ampie e pungenti. E ciò che emerge
è proprio la condizione di perenne svantaggio e discriminazione contro cui le
persone nere hanno ricominciato a manifestare in queste settimane.
Nel crossover, ad esempio,
Olivia e Annalise rilevano come gli afroamericani siano colpiti più di ogni
altra comunità dall’impossibilità di sostenere le spese legali. E se Le Regole
del Delitto Perfetto si sofferma sugli avvocati d’ufficio, la realtà è ben più
deprimente. Le spese da sostenere, infatti, riguardano anche le cauzioni, ed è
possibile persino che non pagarle comporti un allungamento della pena.
Non avere un avvocato, fa
notare inoltre Annalise nella serie, impedisce ai detenuti coinvolti nella class
action di vedersi garantito un giusto processo. Ed è pura realtà che gli
avvocati d’ufficio non possano fare miracoli. Il settore deve infatti fare i
conti con la cronica mancanza di fondi e una mole enorme di casi da gestire.
Chiaro, dunque, che errori e superficialità siano all’ordine del giorno.
Nella sua incursione nel mondo
de Le Regole del Delitto Perfetto Olivia Pope sottolinea poi come molte persone
nere, pur se accusate ingiustamente di aver commesso un reato, preferiscano
dichiararsi colpevoli e scontare la pena. L’alternativa sarebbe attendere
l’arrivo di un avvocato d’ufficio, affrontare un processo lungo e laborioso e
vedersi condannati a sanzioni più salate e pene più severe.
Che la materia affrontata
ne Le Regole del Delitto Perfetto tragga origine dalla realtà – e resti più
attuale che mai – è evidente anche dalle basi su cui poggia l’intera class
action di Annalise, e che richiama un caso simile affrontato nello stato di New
York nel 2014. Una rara vittoria per la pubblica difesa, scrive il New York
Times a tal proposito.
Chiudiamo quindi con il più
potente dei passaggi da Le Regole del Delitto Perfetto 4×13, in cui la potenza
evocativa di Viola Davis è il miglior veicolo di trasmissione di una realtà
durissima e ancora doloramente attuale:
Il razzismo è nel DNA
dell’America. E finché chiuderemo gli occhi dinanzi al dolore di chi ne è
schiacciato non ci libereremo mai di quelle origini. L’unica protezione che le
persone di colore hanno è il diritto a una difesa, e non riusciamo a garantir
loro neppure questo. Ciò significa che la promessa dei diritti civili non viene
mantenuta. A causa dal fallimento del nostro sistema giudiziario, e in
particolare del nostro sistema di pubblica difesa, Jim Crow è vivo e vegeto.
Leggi per cui era illegale
seppellire bianchi e neri nello stesso cimitero, per cui esistevano le categorie
di mulatti e meticci, per cui si puniva una persona nera che chiedeva di essere
curata in un ospedale per bianchi. Qualcuno potrebbe dire che la schiavitù non
esiste più. Ma ditelo ai detenuti tenuti chiusi in gabbie e a cui viene negato
qualsiasi diritto. Persone come il mio cliente, Nathaniel Lahey, e milioni di
persone come lui, relegate a una sottoclasse dell’esistenza umana nelle nostre
prigioni. Non c’è alternativa alla giustizia in questo caso. Non c’è un’altra
opzione.
Pronunciarsi contro il mio
cliente significa riempire le tasche dei proprietari delle carceri anziché
garantire una difesa fondamentale a chi ci vive dentro. Ed è forse quella
l’America in cui questa corte vuole vivere? Un’America in cui il denaro conta
più dell’umanità? In cui la salute mentale è confusa per criminalità? Il sesto
emendamento è stato ratificato nel 1791. Sono passati 226 anni da allora. È
arrivato il momento di garantirne i diritti a tutti i nostri cittadini.
LE REGOLE DEL DELITTO
PERFETTO. L’ingiustizia negli Usa.
Sara Bellomo and Anna Ragone
su sharing.school il 22 Marzo 2021.
La discriminazione nei
confronti degli afroamericani da parte del sistema giudiziario americano è un
problema all’ordine del giorno. È proprio questo uno dei temi principali
trattati dalla famosa serie televisiva ‘Le regole del delitto perfetto’. La
protagonista, Annalise Keating, è una brillante avvocatessa e docente di diritto
penale. Insieme ad alcuni dei suoi migliori studenti, si impegna nella difesa
soprattutto di persone di colore.
La popolazione carceraria
negli Stati Uniti
Secondo i dati, gli Stati
Uniti sono il primo paese al mondo per numero di detenuti, di cui la grande
maggioranza sono afroamericani. Nel 2018 i neri rappresentavano il 12-13% della
popolazione adulta americana e il 33% di quella carceraria, praticamente il
triplo della loro quota. I bianchi, che invece costituiscono il 61-63% della
popolazione adulta totale, rappresentavano solamente il 30% dei prigionieri.
Se consideriamo i detenuti che
attualmente si trovano nel braccio della morte, la percentuale degli
afroamericani sale al 42%. L’etnia sembrerebbe quindi tuttora un fattore
determinante quando si tratta di condannare a morte un uomo negli Stati Uniti.
Inoltre, in molti casi, le giurie che determinano le condanne sono composte
unicamente da bianchi.
La storia del razzismo negli
Stati Uniti
I numeri parlano da soli, ma
non è possibile capire il fenomeno senza considerare le sue origini. Per secoli
infatti, pregiudizi e miti hanno associato il criminale all’uomo di colore. Per
la National Association for the Advancement of Colored People, gli afroamericani
hanno una probabilità cinque volte maggiore di essere fermati senza una giusta
causa dalla polizia, rispetto a una persona bianca.
Tutto ciò costituisce un
problema perché chi finisce in prigione ha meno possibilità di ottenere un
lavoro o di ottenere dei benefici federali una volta usciti. Inoltre, l’alto
tasso di incarcerazione va ad influire sull’esercizio dei diritti del cittadino.
Per esempio, in 12 stati una condanna per reato comporta la perdita del diritto
di voto. Se i numeri non dovessero calare, nei prossimi dieci anni, il livello
di perdita dei diritti civili per le persone di colore sarà alto tanto quanto lo
era prima del passaggio della legge sul diritto di voto, Voting Right act del
1965, quella legge per la quale lottarono John Lewis e i Big Six.
La class action di Annalise
Nella quarta stagione delle
regole del delitto perfetto, Annalise Keating porta alla Corte Suprema una class
action per dimostrare la disparità di trattamento nei confronti delle persone di
colore da parte delle forze dell’ordine. Che la materia affrontata nella serie
tv tragga origine dalla realtà – e resti più attuale che mai – è evidente anche
dalle basi su cui poggia l’intera class action di Annalise, e che richiama un
caso simile affrontato nello stato di New York nel 2014.
Annalise riesce a sostenere
che lo stato della Pennsylvania non garantisce un supporto legale adeguato a chi
non può permettersi un avvocato. Le tesi che Annalise porta dinanzi alla Corte
Suprema non sono espedienti narrativi, ma parentesi di realtà che si fanno di
volta in volta più ampie. Non avere un avvocato impedisce ai detenuti coinvolti
nella class action di vedersi garantito un giusto processo. Ed è pura realtà che
gli avvocati d’ufficio non possano fare miracoli. Il settore deve infatti fare i
conti con la mancanza di fondi e una mole enorme di casi da gestire.
Nella sua arringa finale
Annalise dice così:
"Il razzismo fa parte del DNA
dell’America. E finché chiuderemo gli occhi dinanzi al dolore di chi ne è
schiacciato non ci libereremo mai di quel patrimonio genetico. L’unica
protezione che le persone di colore hanno è il diritto a una difesa, e non
riusciamo a garantire loro neppure questo. Ciò significa che la promessa dei
diritti civili non viene mantenuta."
La classifica delle 10
serie legal drama più belle di sempre.
Morbinati & Longo il 26
Dicembre 2018 su morbinatilongo.it.
Il Natale è appena passato ma
fortunatamente abbiamo ancora davanti a noi alcuni giorni di vacanza per goderci
un po’ di sano relax, magari comodamente sprofondati sul divano di casa pronti
per il binge watching! Eh sì, anche noi di “Morbinati &Longo Avvocati s.p.a.”
amiamo le maratone di serie tv. Ecco quindi la nostra personalissima classifica
con le dieci serie tv legal drama più belle di sempre: serie tv su avvocati…
consigliate da avvocati veri!
Ma prima ecco qualche
curiosità: Boston sembra essere una delle città preferite come sede per le
vicende dei legal drama. Spesso sono le donne avvocato le vere protagoniste.
Molti dei casi narrati in queste serie televisive si ispirano a casi realmente
accaduti in Usa o in altri Paesi. Tre delle serie della nostra classifica sono
state scritte dal medesimo autore, David E. Kelley, che forse non tutti sanno
essere sposato con la divina Michelle Pfeiffer.
1 Better Call Saul
Saul Goodman, conosciuto come
l’avvocato delle cause perse in Breaking Bad, interpretato da uno strepitoso Bob
Odenkirk, si è meritato senza ombra di dubbio una serie tutta per sé. In questa
serie seguiamo le vicende di questo improbabile e grottesco avvocato, a tratti
esilarante, ma che sa vivere con un pizzico di sano cinismo, in una sorta di
flash back. La serie si apre, infatti, in un tempo successivo a quello narrato
in Breaking Bad, salvo poi presentarci le origini di Saul, gli inizi della sua
carriera quando ancora si faceva chiamare James McGill.
2 Ally McBeal
È stato il legal drama più
amato a fine anni ’90, una serie che ha portato al successo la bravissima
Calista Flockhart e ha avuto il merito di ridare una spinta alla carriera di
Robert Downey Jr, presenza fissa della quarta stagione. La serie si apre con una
giovane avvocatessa costretta a lasciare lo studio dove lavora per le continue
molestie sessuali dei capi, incontra per strada un ex compagno della scuola di
legge che la assume nel suo studio appena aperto. Fra cause che affrontano temi
anche delicati, divertenti siparietti dovuti alle allucinazioni di Ally e
indimenticabili duetti sul palco del Maritini Bar, il locale dove si ritrovano
gli avvocati a fine giornata, questa serie durata 5 stagioni è senza dubbio un
pezzo da novanta fra le serie legal.
3 Suits
In molti la conoscono
principalmente perché fra le sue interpreti c’è Meghan Markle, costretta a
lasciare dopo il matrimonio con il principe Henry e l’ingresso nella famiglia
reale britannica. Ma Suits è un legal drama avvincente che punta l’attenzione
sulle vicende di un avvocato di grido Harvey Specter che assume come suo
assistente un ex studente di legge, Mike Ross, che non ha finito gli studi ma ha
un’incredibile memoria eidetica. Proprio questa caratteristica diventerà
fondamentale per la gestione e la soluzione di molti casi!
4 The Good Wife
Dopo Ally McBeal un’altra
donna avvocato, al centro di una serie perfettamente cucita addosso all’attrice
che la interpreta. The Good Wife vede come protagonista assoluta Julianna
Margulies, famosa a partire dagli anni ’90 per un’altra serie di grande
successo, E.R. Un ruolo che è valso all’attrice numerosi riconoscimenti e premi
e che ha permesso agli autori di indagare la mente e il cuore di una donna
avvocato, senza nascondere le sue fragilità. Lasciata la carriera di avvocato
per dedicarsi alla famiglia e al sostegno del marito procuratore, dopo uno
scandalo in cui viene pubblicamente umiliata per un tradimento proprio del
consorte, Alicia Florrik, sceglie di riprendere le redini della propria vita
assunta dallo studio di avvocati di un suo ex compagno di Università. Un lavoro
che le cambierà la vita.
5 Law&Order
Un vero e proprio cult che ha
fatto la storia del legal in tv. Per la prima volta si mescolano i tratti tipici
del legal e del police drama per raccontare i casi seguendone tutto l’iter
investigativo, legale e giudiziario. Oggi Law & Order, la cui serie madre è
andata in onda per 20 stagioni, è un vero e proprio franchising che coinvolge
una decina di spin off, prodotti o ancora in produzione, con numerosi cross
over, ovvero puntate in cui si incrociano le trame di due o più serie. Un
successo che dopo quasi 30 anni non smette di attirare il pubblico!
6 The Practice
Ambientato a Boston, proprio
come Ally McBeal con cui ci fu anche un cross over molto apprezzato dal
pubblico, The practice segue le vicende di un gruppo di avvocati penalisti
intenti a difendere facoltosi clienti invischiati in crimini e omicidi.
Curiosità: nella settima stagione entrano nel cast due volti noti di una delle
serie medical più famose di sempre Grey’s Anathomy, Jessica Capshaw e Chyler
Leigh, conosciute per i ruoli di Arizona e Lexie; mentre nell’ottava stagione
fanno la loro comparsa James Spader e Rhona Mitra che diventeranno poi
protagonisti dello spin off Boston Legal.
7 The Guardian
Prima di diventare il
mentalista più famoso della tv Simon Baker ha impersonato il fascinoso e
imprevedibile avvocato Nick Fallin condannato a 1500 ore di servizi sociali per
un’accusa di possesso di droga. La serie segue le vicende dell’avvocato di
Pittsburgh, il suo impegno per risolvere i problemi personali e di dipendenza
mentre aiuta persone in difficoltà e cerca di recuperare il rapporto con il
padre, socio dello studio di avvocati, divenuto ancora più difficile dopo la
morte della madre.
8 Le regole del delitto
perfetto
La serie televisiva narra le
vicende dell’avvocato penalista Annalise Keating, interpreta magistralmente da
Viola Davis, che si divide fra il lavoro in tribunale e quello di docente
nell’Università di Philadelphia. Insieme ad un gruppo di studenti selezionati
per aiutarla nella difesa dei casi più difficili. Una notte però un omicidio in
cui perde la vita suo marito sconvolge la vita di Annalise. Casi avvincenti e
svariate complicazioni rendono questa serie una vera chicca fra i legal drama,
assolutamente da vedere.
9 Boston Legal
Spin off di The practice,
Boston Legal ci restituisce due personaggi molto amati, Alan Shore e Tara
Wilson, oltre che il bravissimo William Shatner (chi non ricorda il capitano
Kirk di Star Trek?), in uno studio legale dove spesso si affrontano casi
difficili, in cui spesso etica e morale si scontrano con ciò che la legge impone
di fare. Vicende avvincenti e dialoghi degni di nota per un legal drama di
grande qualità!
10 American Crime Story: Il
caso OJ Simpson
Prima stagione di una serie
legal antologica incentrata su fatti realmente accaduti che hanno destato grande
partecipazione da parte dell’opinione pubblica statunitense, American Crime
Story sviscera un caso lungo tutti gli episodi ogni stagione. La prima è
dedicata proprio alla vicenda di OJ Simpson, uno dei casi mediatici forse più
famosi degli ultimi 30 anni, che tutti ricordiamo per il lungo inseguimento in
diretta tv. Lo storyline narra tutta la vicenda dall’omicidio della donna
seguendo il lungo e complesso processo giudiziario che ne seguì.
Una menzione speciale…
Come nei migliori festival,
anche noi abbiamo la nostra menzione speciale: una serie che non è strettamente
un legal drama ma che ha per protagonista un avvocato molto particolare, che
qualunque studio vorrebbe avere nel proprio organico. Si tratta di Daredevil. Il
celebre eroe della Marvel è magistralmente interpretato da Charlie Cox, capace
di rendere il personaggio estremamente credibile sia nelle vesti del
rispettabile avvocato non vedente Matt Murdock, sia nel suo alter ego che
combatte i criminali. Splendida l’ambientazione, una Hell’s Kitchen senza
tempo in cui si muove un degrado subdolo, in cui ogni città può facilmente
riconoscersi. Bravi tutti gli attori, su cui svetta l’immenso, “cattivissimo”
Vincent d’Onofrio. Non ci resta che augurarvi buona visione!
Bye bye forca: come le
serie tv hanno sdoganato il garantismo e il diritto di difesa.
I nuovi "legal drama" ci portano dentro la macchina giudiziaria nelle sue
iniquità e disfunzioni, restituendo piena dignità alla figura dell'avvocato.
Daniele Zaccaria su Il Dubbio il 4 luglio 2022.
La tensione perpetua tra legge
e giustizia, tra morale astratta e diritti concreti è sempre stata al centro
delle rappresentazioni hollywoodiane, con tutte le inevitabili semplificazioni e
concessioni (al climax narrativo da una parte e alla cultura di massa
dall’altra) proprie al filone giudiziario.
Il racconto popolare si nutre
infatti di schemi regolari, ripetitivi, è espressione dello spirito dei tempi ma
allo stesso tempo lo condiziona, contribuendo a creare e a diffondere valori e
pregiudizi. È l’immaginario collettivo, che fornisce il sostrato simbolico
all’opinione pubblica, al suo formarsi e al suo continuo mutare (o stagnare): le
opere di finzione, cinema, tv, letteratura, teatro, sono in tal senso veicoli
formidabili.
Per decenni i legal
drama hanno giocato con l’immedesimazione tra lo spettatore e i “coraggiosi
giustizieri” che si scagliano contro poteri ordinari e straordinari, Che si
tratti di avvocati o procuratori o addirittura poliziotti cambia poco, l’occhio
della cinepresa è (quasi) sempre quello dell’accusa, una soggettiva continua di
raddrizzatori di torti, che magari si battono con passione per scagionare un
innocente, però con l’idea “davighiana” di dover scovare il «colpevole che l’ha
fatta franca».
Nell’ultimo decennio l’avvento
delle piattaforme streaming, in particolare Netflix, ha rivoluzionato
profondamente questo paesaggio culurale anche grazie al format seriale, più
dettagliato e analitico del film classico, che permette di spiegare ai profani
la complessità di un’inchiesta e di un processo penale, la fragilità del sistema
e la facilità con cui le giurie fanno sbattere in cella gli imputati nel paese
più carcerario dell’occidente. E la figura più rappresentativa di questa
evoluzione e quella dell’avvocato, spogliata dei suoi attributi mitologici e
irrealistici, da supereroe degli studios, guerriero Marvel in toga, e
ricollocata senza epica nella sua funzione ordinaria, quotidiana, imperfetta e
per questo così preziosa per la vita democratica. Non c’è più bisogno di
essere Perry Mason, o l’Atticus Finch de Il buio oltre la spiepe, o il Frank
Galvin de Il Verdetto per interpretare con nobiltà il ruolo del difensore. Non è
necessario scoperchiare complotti o far cadere governi per servire lo Stato di
diritto con spirito probo.
È uno switch importante per
gli Stati Uniti, dove per tradizione i legali non godono di grande fama, al
contrario: oltreoceano circolano barzellette di gran cinismo, amenità
sarcastiche del tipo: «Come fai a capire se un pedone investito da un tir faceva
l’ avvocato? Facile: manca il segno della frenata sull’asfalto!». Astuti, avidi,
spesso senza scrupoli e in odor di zolfo, assimilati fisiologicamente ai propri
clienti e ai loro presunti crimini. Gli avvocati dei criminali, degli
stupratori, degli assassini, dei mafiosi o sull’altra sponda dei politici
corrotti e delle grandi corporation, rappresentati come ingordi affaristi, altro
che attori essenziali del diritto. L’unica figura tollerata nella cultura
cinematografica Usa era, come dicevamo, l’avvocato-investigatore, la parte
civile, che presta soccorso alla vittima di turno, che si tratti di una povera
ragazza dei bassifondi che ha subito violenza sessuale a cui nessuno crede o di
un povero diavolo truffato da una cinica multinazionale. Con il difensore che si
trasfigura in paladino-accusatore e ripara l’ingiustizia anche se inizialmente
deve affrontare avversari insormontabili e cattivissimi fino al meccanico colpo
di scena in cui il bene trionfa sul male.
Nella nouvelle vague
giudiziaria delle serie tv questo manicheismo è assente, ma la critica è
decisamente più profonda perché non riguarda il tal procuratore, il tal
poliziotto, il tal personaggio pubblico, ma il sistema, la sua equità alterata
dalle disparità sociali, dai preconcetti razziali, dal populismo penale e dai
processi mediatici. Non parliamo solamente degli “errori giudiziari” in cui i
diritti negati sono strettamente connessi al proprio status di “innocente” e
l’empatia scorre automatica tra il pubblico. La gran parte delle serie ci porta
ormai dentro la macchina giudiziaria, nei suoi meccanismi complessi a volte
perversi. E molto spesso sono tratte da storie vere riadattate dagli
sceneggiatori degli studios.
Certo, il plot deve essere
arricchito dalla fantasia degli autori, da situazioni immaginarie per ovvie
esigenze di drammaturgia, si tratta pur sempre di fiction, ma mai come ora
abbiamo potuto osservare così da vicino Prendiamo la bellissima For Life,
scritta e ideata da Hank Steinberg, prodotta dal rapper 50 Cents che racconta la
discesa agli inferi e poi il riscatto di Aaron Wallace, arrestato per spaccio di
droga e condannato alla prigione a vita perché non ha voluto patteggiare una
pena a vent’anni. In prigione Wallace decide di laurearsi in legge e diventare
avvocato.
For Life ci mostra i conflitti
e le lotte di potere, tra i detenuti e tra chi fa funzionare la macchina
infernale della prigionia, l’ottusità vendicativa delle guardie, il cinismo
dell’amministrazione, l’iniziativa, spesso interessata e priva di scrupoli della
procura. E lo fa senza retorica, senza piagnistei, con un tocco minimalista.
Wallace combatte per se stesso, certo, e riuscirà a dimostrare la propria
innocenza, ma incarna il ruolo dei difensore con fervore e lucidità: «Sono un
avvocato, farei di tutto per i miei clienti!». Già, il diritto avere una difesa
e un processo equo, che non significa soltanto disporre di uno svogliato legale
d’ufficio, ma di un professionista appassionato capace di lottare contro il
moloch giudiziario, di proteggere i suoi clienti dal bullismo dei procuratori, E
sono tanti i tabù che saltano in aria. Come quello delle testimonianze oculari
che le giurie d’oltreoceano e gli stessi procuratori hanno sempre santificato,
come profezie scolpite nel marmo.
La docuserie Innocence file,
che illumina le vicende di otto detenuti condannati ingiustamente in seguito a
indagini sbrigative, perizie approssimative e processi sommari. Una produzione
ispirata al lavoro di The innocence project, organizzazione no profit che ogni
anno riesce a far riaprire decine di casi giudiziari. Stando alle cifre
ufficiali negli ultimi trent’anni sono circa 2500 le persone condannate
ingiustamente che hanno potuto ribaltare la sentenza grazie all’aiuto di queste
ong. A seppellirli in carcere testimoni che si dicono «certi» di averli
riconosciuti sulla scena del delitto, o in fuga dal luogo del crimine, oppure
aggirandosi sospetti nei dintorni di un omicidio o di una rapina, e d’altra
parte chi può dubitare di una vittima che riconosce il volto del suo stesso
carnefice? La psicologia forense e la semplice casistica ci spiegano invece
quanto sia illusoria la memoria, anche a pochissime ore di distanza dai fatti,
figuriamoci dopo molti mesi, se non anni. C’è poi la componente emotiva che
distorce la percezione, dilata i tempi, provoca rimozioni e sostituzioni,
offusca il giudizio.
In alcuni casi le serie
possono incidere direttamente sui destini di persone in carne e ossa come
per Making of a Murderer che ha portato alla scarcerazione di Brendan Dassey,
condannato all’ergastolo per omicidio volontario. Le registe hanno messo in luce
la manipolazione delle prove da parte della polizia, gli interrogatori illegali,
l’ostracismo verso gli avvocati, ma hanno anche ricevuto diverse critiche per
l’estrema parzialità del racconto che non approfondisce le responsabilità
di Dassey per concentrarsi solamente sui metodi brutali dei suoi accusatori. Uno
degli effetti più importanti del processo Dassey è stata la messa in discussione
della prova del Dna, vero e proprio dogma per inquirenti, giudici e giurie,
dimostrando che la traccia genetica può venire alterata che non può essere
affidabile al cento per cento.
La produzione seriale
americana è anche lo specchio dei grandi cambiamenti avvenuti nell’ultimo
decennio in quella società. Il movimento Black lives matter ha messo a nudo la
feroce discriminazione che la comunità afroamericana subisce ogni giorno nei
mille ghetti d’America, dai dalle perquisizioni violente, alla detenzione
abusiva, alla negazione del diritto di difesa, alle umiliazioni del sistema
penitenziario federale. Una ferita che viene da lontano e che richiama alla
mente le grandi battaglie peri diritti civili degli anni 60 e 70, In questa
prospettiva si muove Processo ai Chicago 7, che racconta come i leader del
movimento studentesco, della controcultura giovanile e del black power tra cui
Bobby Seal della Pantere nere vennero usati come capro espiatorio per i celebri
scontri alla convention democratica del 1968 sullo sfondo della contestazione
alla guerra in Vietnam.
Arrestati senza prove, dati in
pasto alla gogna pubblica, incastrati da procuratori faziosi e giudici proni al
potere alla fine riusciranno a dimostrare la loro innocenza e le manovre
politiche che si sono giocate sulla loro pelle. Una serie toccante, che rimanda
a fatti avvenuti mezzo secolo fa ma purtroppo ancora attuali, una serie anche
figlia dei moti di Ferguson dopo l’uccisione nell’agosto del 2015 del 18enne
disarmato Michael Brown da parte di un agente di polizia bianco che innescarono
un movimento di massa, capace di far rimettere in discussione i poteri quasi
militareschi concessi ai poliziotti e la compiacenza dei tribunali nei confronti
dei loro continui abusi. Giustizia razziale, giustizia di classe, giustizia,
politica, giustizia mediatica; conoscere le perversioni del sistema è il metodo
più adatto per osservare l’andamento e la rettitudine di una società, e le tante
serie tv che ci mostrano le vicende reali di avvocati, procuratori, giudici,
imputati, testimoni, poliziotti e giornalisti tutti impegnati a far andare
avanti la macchina, ci permettono di guardare da vicino come funziona una
democrazia.
Spangher: «Film Usa
costruiti su dibattimento e ruolo dell’avvocato. Da noi su accusa e
investigatori: non è un caso…»
Serie Tv e filmografia sulla giustizia consigliate dal professore emerito di
diritto processuale penale alla "Sapienza" di Roma: «Molto istruttive pure le
pellicole francesi». Valentina Stella su Il Dubbio il 4 luglio 2022.
Quando per prima volta il
professor Giorgio Spangher, emerito di diritto processuale penale all’Università
La Sapienza di Roma, è venuto a cena a casa non abbiamo parlato solo di riforme
della giustizia ma ci siamo avventurati anche nel campo della cinematografia,
commentando insieme alcune scene di uno dei nostri film preferiti: ‘Il caso
Thomas Crawford’, con Anthony Hopkins e Ryan Gosling.
Professore ho scoperto che lei
è un vero cinefilo.
Mi piace andare al cinema. Il
mio film preferito è ‘In the Mood for Love’, una produzione cinese degli anni
2000. Ma sono appassionato anche di pellicole e serie tv che trattano casi di
cronaca giudiziaria e raccontano i processi. Da poco ho fatto anche
l’abbonamento a TimVision e sono immerso nella visione della serie americana
‘The Good Wife’.
Serie molto bella, concordo.
Lei trasferisce la passione anche ai suoi studenti, visto che continua ad
insegnare.
Non solo, anche agli avvocati.
Ogni anno con le Camere Penali organizziamo a Rimini la proiezione di un film
che tratta i temi della giustizia e poi dibattiamo tutti insieme. Film e serie
tv, come quella su Perry Mason, sono entrati nelle case degli italiani e al di
là dell’intrattenimento ci spingono a fare serie riflessioni comparative tra il
processo italiano e quello anglosassone. Ne discuto anche alla Scuola Ufficiale
Carabinieri, a quella di Polizia e con gli studenti.
Ma che film fa vedere?
Film francesi come ‘L’Affido
Una storia di violenza’ e ‘J’accuse’ diretto da Roman Polanski sull’Affare
Dreyfus. Non manca mai ‘Il caso Thomas Crawford’ perché lì si vede tutto del
caso, dall’omicidio al processo, passando per la raccolta delle prove e
terminando con il principio di diritto del ne bis in idem. Ma abbiamo visto
anche ‘Il diritto di opporsi’ sulla pena di morte. Insomma scelgo film e serie
tv in cui i profili processuali sono raccontati in maniera tecnicamente
apprezzabile.
‘Il caso Thomas Crawford’ è
emblematico di come funziona la giustizia negli Usa.
Da un lato sì, ma rappresenta
uno dei tanti tipi di processo che si celebrano negli Stati Uniti. È il processo
dei ricchi mentre se vedi il primo episodio della settima stagione di ‘The Good
Wife’ prendi visione di quello che racconta anche il professor Vittorio
Fanchiotti nel suo recente libro ‘La giustizia penale statunite – Procedure v.
Antiprocedure’ pubblicato da Giappichelli: a New York possono essere arrestate
nella notte anche trecento persone, ammassate tutte in grandi stanzoni e da lì
inizia il girone dell’inferno delle cauzioni e dei patteggiamenti. La giustizia
americana non è solo quella dei grandi studi legali ma anche quella dei poveri,
dei neri e degli emarginati che, per esempio, non possono permettersi di pagare
l’investigatore privato per cercare elementi a discolpa.
Ma qual è la prima differenza
che nota tra la rappresentazione americana e quella italiana?
La filmografia americana è
tutta concentrata sul dibattimento, sull’oralità e soprattutto sul ruolo
dell’avvocato. Mentre nelle nostre produzioni l’attenzione è più sugli
investigatori e sul rappresentante dell’accusa.
Diciamo che qui da noi
l’avvocato è visto come l’azzeccagarbugli che vuole farla fare franca al suo
cliente, mentre negli Stati Uniti è colui che ti salva, anche pro-bono, dalla
pena di morte o che in generale combatte per i diritti dell’indagato contro le
angherie della polizia, spesso corrotta o impegnata ad inquinare le prove.
Esatto. L’unica eccezione
forse è il film ‘I nostri ragazzi’ con Alessandro Gassman, Luigi Lo Cascio,
Giovanna Mezzogiorno, Barbara Bobulova. Lì un avvocato scopre che sua figlia ha
picchiato una barbona e decide di denunciarla, mentre l’altro fratello, che era
stato inizialmente dipinto come il rispettoso delle regole, il garantista, si
oppone perché è coinvolto anche suo figlio. In generale nelle nostre produzioni
c’è il tentativo di trasformare il processo in una commedia. Mentre nel processo
anglosassone il difensore è visto come il garante dei diritti.
Quali sono altri tratti
distintivi tra i due sistemi?
Lì hanno due tipi di processi,
quello federale – vediamo spesso in tv i casi gestiti dall’Fbi su droga,
terrorismo, traffico di esseri umani- e poi quelli statali.Mentre negli Usa ci
sono due treni ad alta velocità, qui abbiamo solo un binario, quello della
Procura della Repubblica che si occupa del semplice furto ma anche delle stragi
di criminalità organizzata. L’obiettivo del pubblico ministero è quello di
aumentare l’imputazione per godere delle maggiori potenzialità inquisitorie,
tipo i trojan. A Roma si è istruito un processo per Mafia capitale, poi non era
mafia, ma che importa per alcuni.
Ricordiamo che negli Usa il
prosecutor è elettivo, se sbaglia paga.
Giusto, qui invece c’è un
problema culturale con la responsabilizzazione del pm. Poi la grande differenza
è quella della giuria popolare.
A proposito della giuria,
leggevo nel libro di Fanchiotti che in alcuni casi negli Usa il mandato di
arresto può essere autorizzato anche dal cosiddetto clerck, una specie di
cancelliere, non necessariamente laureato. Basta che sia imparziale e
distaccato, in grado di decidere se esista la probable cause.
La giustizia è davvero
amministrata dal popolo e non nel nome del popolo, come avviene da noi dove
deleghiamo al giudice togato. Come noto, esistono i consulenti chiamati a
determinare gli appartenenti alla giuria. In quel sistema la decisione è
affidata a 12 persone, mentre il giudice è solo l’arbitro del processo.
Sì, in alcuni casi impiegano
anche due giorni per fare la selezione della giuria. Nel caso di O.J. Simpson
impiegarono tre mesi.
Consiglio sul tema il
bellissimo film del 1957 ‘La parola ai giurati’ con Henry Fonda, tutto girato in
una Camera di Consiglio: dodici giurati sono riuniti per decidere della sorte di
un accusato d’omicidio. Undici lo ritengono colpevole. Soltanto uno lo considera
innocente, ma per salvarlo dalla condanna a morte bisogna raggiungere
l’unanimità.
Un altro aspetto che ci
differenzia è che negli Usa il secondo grado è solo per questioni formali.
Sì, solo in caso di violazione
di diritti costituzionali.
Forse allora è meglio il
nostro sistema che dopo il primo grado ci offre un altro giudizio di merito e
uno di legittimità.
Se la giuria è stata scelta
bene, se il giudice ha rispettato le regole, se la difesa ha potuto esercitare i
suoi diritti non ho bisogno di rifare un nuovo processo. Lì hanno un vero
sistema accusatorio, che noi non abbiamo: immediatezza, concentrazione delle
udienze – lo vediamo spesso nei film: ‘la Corte si aggiorna a domattina alle 9’,
per esempio – oralità, stesso giudice. Quindi è necessario qui in Italia avere
un appello.
Le scene più belle dei film
americani sono quelle in cui si mette in scena la cross-examination, il
contro-interrogatorio. Attimi di vera tensione.
Molto interessante una serie
inglese – ‘Anatomia di uno scandalo’ – dove la presunta vittima di uno stupro
viene sconfessata da un abile difensore dell’imputato che con poche e secche
domande riesce a minare la sua versione dei fatti. Mentre da noi è una procedura
svilita dall’invadenza del giudice. E poi una cosa che ci insegna quel sistema è
di non fare mai una domanda al proprio testimone di cui non si è sicuri della
risposta.
Un caso eclatante è proprio
quanto accaduto nel processo contro O. J. Simpson.
Il processo viene ripercorso
nella serie Netflix ‘The People v. OJ Simpson’. Un procuratore azzardò in Aula
nel fargli provare il guanto che avrebbe indossato l’assassino. Ma non gli entrò
e quell’episodio lo scagionò.
“Vostro onore”: quando il
giudice integerrimo è tormentato dal dubbio.
La serie italiana, targata Rai, con Stefano Accorsi ha una duplice radice.
L'originaria "Kvodo", e l'adattamento americano "Your Honor". Boris Sollazzo su
Il Dubbio il 4 luglio 2022.
Il legal drama è un genere che
nella serialità, ben prima dell’età dell’oro attuale, delle piattaforme che
offrono storie di ogni tipo, qualità e quantità, ha sempre avuto successo e
continuità. Chi non ricorda Law and order che ha alfabetizzato diverse
generazioni di spettatori sul sistema giuridico statunitense ma ha anche
portato, decenni dopo il più granitico e classico Perry Mason, un dibattito
etico e morale su limiti e perversioni di leggi, meccanismi giuridici e politici
del vero sistema portante degli Stati Uniti, come è stato dimostrato dalla Corte
Suprema e la sua pronuncia sull’aborto. Poi arrivò The Practice che ci raccontò
di quegli avvocati difensori che si prendono, a dispetto di record e
percentuali, casi disperati o colpevoli (a volte sono entrambi) perché a tutti
va garantito un processo giusto e il diritto alla difesa e perché almeno i
secondi, di solito, pagano bene.
Un rovesciamento forte, seppur
troppo breve, rispetto al modo abitudinario della nostra tv di entrare nei
tribunali e in qualsiasi altro luogo di legge e governo. Ora abbiamo Vostro
Onore che guarda laddove tv e cinema spesso non si sono soffermati, se non
funzionalmente a storie che vedevano negli imputati, negli avvocati, persino
nelle mogli di politici che praticano la professione legale un cardine di questa
narrazione così capillare. Curioso, perché il giudice in realtà è il motore
della vicenda e in ogni caso sancisce, con le sue decisioni, il destino della
storia, ma quasi sempre nelle serie come nei film diventa una sorta di deus ex
machina, un alieno che interviene inizialmente con antipatica pedanteria e
spesso alla fine con provvidenziale equilibrio nel punire i cattivi e premiare i
buoni, ovviamente in extremis.
Vostro onore racconta le
ambizioni, i tormenti, l’inferno di un giudice che deve tradire se stesso. La
figura che altrove è una pedina di lusso, qui diventa fondamentale e fondante.
Ed è curioso come nei diversi adattamenti si siano trovati molti punti di
contatto ma anche altri di rottura. La serie con Stefano Accorsi, targata Rai,
ha infatti una duplice radice. Quella originaria di Kvodo, prodotto israeliano
(la tv in Israele ha trovato nella formula narrativa e visiva della serialità un
successo clamoroso, da In Treatment in poi, tratto dal loro BeTipul, è un
serbatoio di idee, talenti e remake) e Your Honor, l’adattamento americano
con Bryan Cranston che si toglie, qui, parte dell’eredità pesantissima
di Breaking Bad riuscendo, finalmente, a essere altro.
La trama è semplice e
implacabile. Un adolescente uccide una persona con la macchina. Il pirata della
strada è figlio di un magistrato rigoroso, ossessionato dal lavoro e dagli
obiettivi che si è posto. Giudice che dolorosamente ma con onestà intellettuale
e morale pretende che il figlio si costituisca. Quando arrivano e il ragazzo sta
per farlo, però, il padre scopre che la vittima è di una famiglia legata alla
criminalità organizzata: la posta non è più evitare il carcere, ma la morte e la
vendetta di un boss. Da qui inizia una discesa agli inferi di chi, da sempre
ligio alle regole, deve violarle tutte – peraltro, incompreso – per proteggere
ciò che ha di più caro.
Il finale è conciliante
in Italia, devastante in America, equilibrato in Israele. Vostro Onore si ispira
maggiormente al modello originale per la “soluzione” di questa sorta di tragedia
greca togata, Your Honor fa una crasi tra le due stagioni di Kvodo), ma il punto
è che ci offre finalmente una visione umana, anche controversa di un ruolo e di
un uomo che spesso sottovalutiamo nella sua complessità. E sì, forse persino
fragilità.
Più interessante è andare a
guardare al ritratto che ne fanno le tre serie. Se Yoram Hattab ha uno spettro
espressivo e emotivo complesso, compresso ma anche profondo, Cranston ha
l’intuizione interessante e profondamente politica di portare il suo personaggio
a mettere nel tentativo di salvare l’erede lo stesso impegno ossessivo e
implacabile che ha sul lavoro. Ma a fare un’opera davvero di cesello è proprio
Accorsi, capace di dare una tridimensionalità a un ruolo che è invece una somma
di archetipi virili, il giudice severo e il padre padrone (del destino del
figlio).
L’attore italiano, aiutato
anche da un casting intelligente (su tutti la sempre più brava Barbara Ronchi,
nemesi del giudice, dal momento che indaga sull’incidente), dà una profondità
lacerante a quest’uomo, vedovo dolente e padre indolente e bloccato, giudice
integerrimo e professionista ambizioso al limite del cinismo. Invece della
strada della semplificazione e di un lavoro atto a scolpire un antieroe
epico, Stefano Accorsi preferisce cercare l’umanità, le ferite, l’empatia, il
tormento. Tanto Cranston rimaneva granitico pure nelle pose e nelle espressioni,
quanto in Vostro onore il protagonista muta, si ricrede, apre costantemente un
ventaglio interpretativo sempre diverso. Fuori e dentro l’aula. Che altro non è,
in fondo, che un anfiteatro da tragedia greca, con tanto di coro (la giuria) e
maschere.
Avvocati perseguitati e
messi al bando: è dovere di noi giuristi ricordarli.
Non è sufficiente onorare la
memoria per pacificare un Paese e garantire a una comunità una visione condivisa
di futuro, perché bisogna scavare e individuare le corresponsabilità che
portarono all'orrore delle leggi razziali. Il Dubbio il 27 gennaio 2022.
Oggi, in tutto il mondo, si
celebra la “giornata internazionale della commemorazione in memoria delle
vittime della ferocia nazista”; lo ha voluto l’Assemblea generale delle Nazioni
Unite con una risoluzione del 1 novembre 2005, scegliendo la data del 27 gennaio
in ricordo di quel giorno del 1945 quando le truppe dell’Armata Rossa entrarono
nel campo di concentramento di Auschwitz svelando al mondo intero l’orrore del
genocidio nazifascista.
Al nostro Paese, il merito di
avere, alcuni anni prima della risoluzione delle Nazioni Unite, istituito con
legge dello Stato, nella stessa data, il “giorno della memoria”. La risoluzione
dell’ONU del 2005 impegna tutti gli stati membri delle Nazioni Unite ad
inculcare nelle generazioni future le “lezioni dell’olocausto”; un significato
simbolico, una commemorazione pubblica delle vittime della Shoah e delle leggi
razziali approvate sotto il fascismo, il ricordo collettivo degli uomini e delle
donne, ebrei e non, che sono stati uccisi, deportati ed imprigionati, e di tutti
coloro che si sono opposti alla ‘soluzione finale’ voluta dai nazisti,
rischiando la vita e spesso perdendola.
Non è sufficiente onorare la
memoria per pacificare un Paese e garantire a una comunità una visione condivisa
di futuro, perché bisogna scavare, individuare le corresponsabilità – legali,
morali e storiche – che portarono all’emanazione, all’esecuzione e
all’applicazione delle leggi razziali; perché per un ministro della Giustizia
che firmò quei provvedimenti, ci furono magistrati che perseguirono, Tribunali
che condannarono e Consigli dell’Ordine che cancellarono dagli albi gli avvocati
di razza ebraica; e quasi tutta la cultura giuridica italiana che sostenne, con
il silenzio, quell’ignominia.
Riprendendo una riflessione
pubblica di Andrea Mascherin, “possiamo davvero dirci sicuri che la cultura che
generò quell’inferno non sia in essere anche nella nostra società sotto le
mentite spoglie della mancanza di solidarietà, della primazia della logica del
profitto su quella del diritto, del linguaggio dell’odio sui giornali e sui
social, dell’indifferenza nei confronti degli emarginati, del rifiuto
preconcetto al confronto con chi è diverso da noi ?”. È una domanda che dobbiamo
porci, individualmente come cittadini e come avvocati, collettivamente come
comunità di giuristi, coltivando, con la memoria, il dovere di non dimenticare.
Sergio Paparo, presidente
Associazione InsieMe, past presidente Ordine degli avvocati di Firenze
Roberto Cota per "Libero
Quotidiano" il 27 gennaio 2022.
La Corte Costituzionale ha
dichiarato illegittima la norma che prevede la censura della corrispondenza tra
cliente detenuto in regime di 41 bis e avvocato. La questione di
costituzionalità, peraltro, era stata sollevata dalla Corte di Cassazione.
Il Giudice delle leggi ha
osservato in sentenza come l'esercizio del diritto di difesa comprende il
diritto di comunicare in modo riservato con i propri difensori. Tale diritto
spetta a chi è recluso in carcere ed anche a chi è in regime di 41 bis. Direi
tutto normale.
L'anomalia era la limitazione
precedentemente in essere, assolutamente non in linea con uno dei principi
cardine dello stato di diritto. Inoltre, la Corte Costituzionale ha sostenuto
che la tesi contraria rappresenterebbe "una generale ed insostenibile
presunzione di collusione del difensore dell'imputato".
Senonché, nel successivo
dibattito è intervenuto Il Fatto Quotidiano che con un titolo ad effetto ha così
dato la notizia della decisione: "La Consulta cancella la censura della
corrispondenza tra i detenuti al 41 bis e gli avvocati. Geniale: così i boss
potranno ordinare omicidi e stragi".
Oltre a sposare la tesi
secondo la quale chi è in regime di 41 bis non deve avere neppure il diritto di
difendersi, il giornale di Travaglio, nella sostanza, qualifica tutti gli
avvocati come mafiosi.
I sostenitori della campagna
giustizialista e manettara utilizzano adesso un nuovo argomento: quello di
confondere l'avvocato con il cliente. Se l'avvocato difende un mafioso è un
mafioso. Lo schema delegittimante, purtroppo, è quello tipico dei sistemi
antidemocratici, dove la figura del difensore viene relegata ad inutile e
fastidioso orpello.
La Giunta delle Camere Penali
ha giustamente reagito, ma questa tendenza sta prendendo piede, non soltanto
sulle pagine de Il Fatto e non sempre può arrivare la Corte Costituzionale a
sistemare le cose.
Il recente caso Pittelli è
emblematico. Pittelli, avvocato ed ex parlamentare, è in carcere perché accusato
di aver concorso, nel difendere dei clienti appartenenti alla ndrangheta, nei
reati dei propri assistiti.
La materia è delicata, ma il
problema del perimetro del lavoro del difensore va affrontato e non lasciato al
caso. La politica, come al solito, ha la tendenza a non occuparsi delle
questioni, soprattutto quelle spinose.
Il rapporto professionale
avvocato-cliente dovrebbe essere rispettato e tutelato perché siamo in un paese
democratico dove i diritti fondamentali hanno ancora un senso. Nei mesi scorsi
c'è stata una sacrosanta mobilitazione per chiedere all'Egitto il rispetto dei
diritti umani nel caso Zaki: da noi è tutto a posto?
Niente fango sui penalisti.
Basta fango sui penalisti e sul ruolo della difesa.
Riccardo Polidoro su Il
Riformista il 27 Gennaio 2022.
I penalisti insorgono avverso
la diffamatoria presa di posizione de “Il Fatto quotidiano” che, all’indomani
della sentenza della Corte Costituzionale sull’abrogazione della censura della
corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art.
41 bis e i difensori, ha scritto che ora «i boss potranno ordinare omicidi e
stragi per lettera». La gravissima affermazione, che rispecchia i valori a cui
s’ispira il citato quotidiano, rappresenta esplicitamente la volontà di gettare
fango sulla professione di avvocato, visto come complice ed esecutore delle
volontà illecite dei suoi assistiti.
Il visto di censura eliminato
dalla Corte consentiva l’apertura della corrispondenza da parte dell’autorità
giudiziaria o dell’amministrazione penitenziaria e la sua integrale lettura.
All’esito della stessa, si poteva poi determinare la mancata consegna al
destinatario, sia che esso fosse il difensore ovvero il detenuto. La procedura
comportava, dunque, il venir meno della segretezza nel rapporto
detenuto-difensore e poteva arrivare anche a non far conoscere, all’insaputa
degli interessati, non solo quanto scritto nella corrispondenza, ma anche il suo
stesso invio. Tutto ciò a giudizio discrezionale di chi esercitava il controllo.
Un sistema in palese violazione del diritto di difesa, principio cristallizzato
nell’art. 24 della Costituzione.
E quale tutela potrebbe avere
il detenuto se la sua strategia processuale venisse conosciuta anzitempo
dall’accusa? Se il confronto con il difensore sui fatti oggetto dell’imputazione
venisse mediato dalla lettura da parte dell’autorità giudiziaria? Argomenti che
non interessano evidentemente “Il Fatto quotidiano” che, nell’occasione, ha
ritenuto – non condividendo la pronuncia della Corte – di gettare una luce di
sospetto sul difensore, indicandolo come colluso con sodalizi criminali. Eppure
il ruolo della difesa è storicamente insostituibile, in quanto garanzia dello
Stato di diritto. Non potendo, pertanto, aspirare alla sua abolizione si cerca
di sminuirne la funzione, nella cieca convinzione che gli indagati siano tutti
colpevoli e che l’avvocato costituisce un inutile intralcio processuale che
ostacola la conclusione di un rapido processo da concludersi con la condanna.
Non molto tempo fa, un autorevole personaggio politico ebbe, infatti, a
dichiarare che la procedura penale inizia con le indagini che sfociano nel
processo e poi, appunto, nella condanna. Non venne presa in considerazione altra
soluzione. Si vuole ignorare che, purtroppo, gli errori giudiziari nel nostro
Paese sono moltissimi e che le ingiuste detenzioni, statisticamente, giungono a
un numero impressionante, pari a tre al giorno.
Contrariamente a quanto
sostenuto, dunque, il diritto di difesa va rafforzato e non indebolito e
meritano maggiori tutele le garanzie processuali, nel rispetto non solo della
tenuta di uno Stato democratico, ma nell’interesse di tutti. Ben venga, dunque,
la sentenza della Corte Costituzionale che, tra l’altro, oltre a ribadire quanto
già indicato da norme europee e internazionali, conferma un principio già
stabilito, in passato, dalla stessa Corte, in ordine ai colloqui con il
difensore: l’eventualità che persone appartenenti ad un ordine professionale,
tenute al rispetto di un codice deontologico nello specifico campo dei rapporti
con la giustizia e sottoposte alla vigilanza disciplinare dell’ordine di
appartenenza, si prestino a fungere da tramite fra il detenuto e i membri
dell’organizzazione criminale, se non può essere certamente esclusa a priori,
neppure può essere assunta ad una regola di esperienza, tradotta in un enunciato
normativo. Vi possono essere, dunque, rare eccezioni e le regole. L’importante è
che le prime non si tramutino nelle seconde, come avviene proprio per il 41 bis,
al cui regime sono sottoposte circa 800 persone: tutti boss? Riccardo Polidoro
Altro che “perdonismo”, da
Consulta e Cassazione le uniche risposte alla mafia.
Con i vecchi stereotipi
rischiamo di rendere invincibili le cosche. E la sentenza sulle comunicazioni
reclusi-avvocati è una vera lezione. Alberto Cisterna Il Dubbio il 27 gennaio
2022.
In una notevole intervista
resa sulle colonne di questo giornale il 28 novembre 2021, lo storico Salvatore
Lupo ha detto cose importanti sul versante del contrasto alla mafia e delle
ideologie che ne stanno a fondamento. La questione, per così dire, ideologica –
ossia l’identificazione delle regole giuridiche, sociali, morali che orientano
la lotta alle cosche – costituisce uno snodo importante del dibattito che sta
agitando le acque tutto sommato mai troppo navigate di questa discussione.
La cosiddetta cultura
dell’antimafia si è eretta, in questo ultimo decennio soprattutto, a monolite
totalitario, troppe volte insofferente a qualunque critica e sospettoso verso
ogni obiezione. A quanti, ai pochi che osano sollevare dubbi e suggeriscono
riflessioni aggiornate o distinguo a grana fine, si contrappone facilmente
l’accusa di voler far retrocedere la soglia della repressione, di essere
sensibili a istanze pacificatorie o, peggio ancora, di essere conniventi con i
clan. E siccome in questo delicato snodo della vita collettiva le parole pesano
come pietre, in molti tacciono, qualcuno sospira, qualcuno ancora si occupa
d’altro ritenendo tutto sommato che il variegato pantheon che compone la
galassia antimafia sia un territorio infido da cui è meglio stare lontani e che
non è mai conveniente inimicarsi. Insomma, è problematico criticare.
Ma Salvatore Lupo ha, con
l’onestà intellettuale che gli appartiene, puntato l’indice non sulle carriere,
su quelli interessati al circuito dell’emergenza, sulle vestali di cerimonie e
commemorazioni spesso popolate di soggetti impresentabili agli occhi delle
stesse vittime, ma ha puramente e semplicemente affermato che tutto questo mondo
vive in una visione culturalmente arretrata, da ancien regime. Recita lo
storico: «L’antimafia degli anni Novanta è una forza, una componente formata da
persone con responsabilità e funzioni istituzionali che ritengono di dover
conservare un sistema di risposta alla mafia adatto al quadro di trent’anni
orsono», molti in perfetta buon fede, sia chiaro. La questione è cruciale perché
mette in discussione l’egemonia ideologica che ha sostenuto le scelte e le
indicazioni di tutto questo importante fronte politico, sociale e istituzionale.
Privati della convinzione per
cui sussistono ancora le condizioni che hanno giustificato una certa visione
della società, della politica, dell’economia e, quindi, della mafia, importanti
spezzoni dell’antimafia si troverebbero sprovvisti di ogni riferimento “alto”,
di ogni degna rappresentazione delle dinamiche sociali che considerano il
piedistallo, anche etico, delle proprie ragioni. Rappresentazione che non era un
inganno, ma che anzi era stata loro consegnata in decenni da una pubblicistica,
però, divenuta nel tempo scadente, da serie televisive orgiastiche, da convegni
parolai, da analisi adagiate anzi supine verso le risultanze processuali. Se,
effettivamente, l’antimafia è diventata “nostalgica”, come dice Lupo, di un
mondo che è venuto meno ed è incapace di leggere le coordinate più recenti della
complessità, il problema è grave assai e proprio perché prolunga indefinitamente
la sconfitta delle cosche nel Terzo millennio. Come quella impostazione – che ha
radici lontane e nobili nella storia del paese – è stata indispensabile per la
lotta senza quartiere sferrata dallo Stato dopo le stragi del 1992-1993; così la
mancanza di un aggiornamento dei modelli interpretativi della società e dei suoi
mille rivoli sta compromettendo ogni possibilità di vittoria verso le nuove
manifestazioni dell’attività mafiosa che vengono solo mediaticamente declamate
per qualche dollaro di pubblicità (il Covid-19, il Pnrr, i bitcoin, addirittura
l’Isis).
Qualcuno soffre di una perenne
“annuncite” cui non seguono azioni concrete, processi, documenti, testimonianze.
Ormai si ipotizza soltanto che la mafia abbia connessioni con la politica, con
l’economia, con l’universo mondo, ma non si dispone un modello ideologico
adeguato per approntare – e ci vorranno anni – una risposta di contrasto moderna
e aggiornata. Così si vive imbalsamati in un tetro museo delle cere, in un parco
della rimembranza da cui non si ha il coraggio di uscire per sfidare il nuovo
che da qualche parte pur ci sarà o almeno dovrebbe esserci. Scrive Lupo: «Non
esistano più i presupposti di quella reazione brutale operata trent’anni fa
dallo Stato: pensare di perpetrarla non è utile né alla libertà né all’ordine».
Si è incapaci di cogliere il segnale profondo che la Consulta sta consegnando al
paese, anche in questi giorni. Importanti plessi istituzionali, la Corte europea
dei diritti dell’uomo (sul caso Contrada), la Corte costituzionale (con il
warning lanciato a proposito dell’ergastolo ostativo e con un’altra sentenza in
tema di permessi premio di pochi giorni or sono), la Corte di cassazione (con la
decisione a Sezioni unite in materia di riti di affiliazione) non stanno
svolgendo alcuna pericolosa opera di “revisionismo”, né sono ispirate da un
mellifluo “perdonismo”.
Il punto è che stanno venendo
meno – uno a uno – i baluardi ideologici di una certa antimafia. Un complesso di
stereotipi, di generalizzazioni, di precomprensioni, talvolta di pregiudizi che
costituivano il retroterra culturale e ideologico di un preciso orientamento
interpretativo delle norme dell’emergenza e della società in generale, si sta
sgretolando sotto i colpi di una diversa visione della società e degli uomini.
Un’antropologia moderna, scevra da preconcetti (del tipo: «o ti penti o resti
mafioso a vita» oppure «i figli dei mafiosi sono mafiosi in erba»), vuole
semplicemente togliersi dal groppone (per citare il memorabile Sidney Poitier di
“Indovina chi viene a cena?”) una retorica della mafia o una interpretazione
della mafia che ritiene sia stantia, superata, parruccona, addirittura
inconcludente. Tanto da ostacolare la vittoria sulle cosche, mica niente.
Ecco perché le parole spese
dalla Corte costituzionale nella sentenza che ha cancellato il visto di censura
sulla corrispondenza tra avvocati e detenuti di mafia in regime di 41-bis, non è
il viatico rilasciato da giudici “molli” per far consumare nuove efferatezze e
dipanare nuove trame, ma la mera constatazione che non è proponibile in termini
assoluti e generali lo stereotipo dell’avvocato complice, del consigliori del
Padrino che sussurra all’orecchio. Scrive la Consulta che, certo, «non può
escludersi in assoluto che tali ordini o istruzioni possano essere trasmessi
anche attraverso l’intermediazione di un difensore; sicché l’estensione alle
comunicazioni con i difensori del visto di censura potrebbe, in astratto,
ritenersi misura funzionale a ridurre il rischio di un tale evento».
E, poi, nella traiettoria di
quanto sopra detto, la Corte assesta il più micidiale dei colpi all’ideologia di
cui si diceva: «La disposizione censurata si fonda su una generale e
insostenibile presunzione – già stigmatizzata dalla sentenza n. 143 del 2013 –
di collusione del difensore con il sodalizio criminale, finendo così per gettare
una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge
per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello
stato di diritto nel suo complesso. Ruolo che, per risultare effettivo, richiede
che il detenuto o internato possa di regola comunicare al proprio avvocato, in
maniera libera e riservata, ogni informazione potenzialmente rilevante per la
propria difesa, anche rispetto alle modalità del suo trattamento in carcere e a
violazioni di legge o di regolamento che si siano, in ipotesi, ivi consumate».
Si infrange così un altro
totem, va in frantumi un altro dei molti corollari che sono stati eretti a
giustificazione della cultura egemone dell’emergenza antimafia e si squaderna la
fallacia degli stereotipi e dei pregiudizi che la alimentano. Una nuova lampada
di Diogene che cerca nel buio di comprendere dove l’uomo mafioso si sia davvero
nascosto.
Il ruolo dell’avvocato. La
Corte Costituzionale non è giustizialista e tutela il diritto alla difesa.
Guido Stampanoni Bassi su L'Inkiesta il 26 Gennaio 2022.
La Consulta ha stabilito con
una sentenza che i detenuti al regime di carcere duro possono scrivere al loro
legale senza che le loro missive vengano censurate. Si è ribadito la centralità
del ruolo della difesa e l’impossibilità di identificarla con i crimini che
vengono contestati all’assistito.
È stata da poco depositata una
importante sentenza della Corte Costituzionale sul cd. carcere duro (art.
41-bis) relativa – più nello specifico – alla sottoposizione a censura della
corrispondenza del detenuto, senza esclusione di quella indirizzata ai
difensori.
A dubitare della legittimità
della disposizione era stata la Corte di Cassazione, secondo la quale la
previsione generalizzata del visto di censura sulla corrispondenza dei detenuti
sottoposti al regime del 41-bis costituirebbe una irragionevole compressione
tanto del loro diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza,
quanto di quello alla difesa e al giusto processo.
Nel ritenere la questione
fondata – risparmieremo ai lettori i profili più tecnici – la Corte
Costituzionale svolge alcune considerazioni sul ruolo del difensore che appaiono
particolarmente importanti in un periodo – qual è quello attuale – nel quale è
sempre più diffusa la cattiva abitudine di identificare l’avvocato con il
crimine che viene contestato all’assistito.
I giudici della Consulta
prendono le mosse osservando come, in termini generali, la sottoposizione a
censura della corrispondenza di chi si trovi detenuto al 41-bis risponda a una
precisa (e condivisibile) logica: quella di impedire che il detenuto possa
continuare a intrattenere rapporti con l’organizzazione criminale di
appartenenza e possa, dunque, continuare a ricoprire un ruolo attivo all’interno
di tale organizzazione impartendo o ricevendo ordini o istruzioni.
Se questa è la logica che si
trova alla base di questa misura (come delle altre previste del regime del
41-bis), la Corte compie poi un passaggio ulteriore osservando come – sempre in
astratto – tali ordini o istruzioni ben potrebbero essere trasmessi anche
attraverso l’intermediazione di un difensore, il che porta alla conseguenza che
– ancora sempre in astratto – sottoporre a censura le comunicazioni con i
difensori potrebbe essere una misura funzionale a ridurre il rischio di
comunicazioni verso l’esterno.
Se queste conclusioni non
possono seriamente essere messe in dubbio, la Corte Costituzionale si chiede
però se la sottoposizione a censura della comunicazione con i difensori – se
letta alla luce delle altre misure che caratterizzano il regime penitenziario –
appaia effettivamente idonea a raggiungere tale scopo.
Nel rispondere a tale domanda,
si ricorda come il temuto passaggio di informazioni tra difensori e detenuti
potrebbe, in realtà, già avvenire nell’ambito dei colloqui visivi o telefonici –
i quali sono consentiti – rispetto al cui contenuto non può essere operato alcun
controllo.
Se così stanno le cose – e a
prescindere dagli altri profili tecnici di illegittimità della disposizione – la
Corte si chiede che senso abbia continuare a imporre una misura così incisiva
quale la sottoposizione a censura della corrispondenza (misura che può arrivare
addirittura a impedire che talune comunicazioni giungano al proprio difensore).
Ed è qui che si innesta il
passaggio della sentenza che merita di essere evidenziato.
Secondo la Corte la
sottoposizione a censura della corrispondenza con i difensori «si fonda su una
generale e insostenibile presunzione di collusione del difensore con il
sodalizio criminale, finendo così per gettare una luce di sospetto sul ruolo
insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei
diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo
complesso».
Si mette poi in evidenza un
altro delicato aspetto relativo al diritto, del detenuto, di potersi tutelare da
eventuali abusi della autorità: «Il ruolo del difensore, per essere davvero
effettivo, richiede che chi si trova in stato di detenzione possa comunicare al
proprio avvocato, in maniera libera e riservata, ogni informazione
potenzialmente rilevante per la propria difesa, anche rispetto alle modalità del
suo trattamento in carcere e a violazioni di legge che si siano, in ipotesi, ivi
consumate».
Si diceva dell’importanza di
una pronuncia che, soprattutto in un’epoca quale quella attuale, abbia ribadito
la centralità del ruolo del difensore e l’impossibilità di identificarlo con i
crimini che vengono contestati all’assistito.
Che si tratti di un tema
realmente avvertito lo conferma, a strettissimo giro, la prima pagina del “Fatto
Quotidiano” (guarda caso…), che così titola: «La Consulta cancella la censura
sulla corrispondenza fra i detenuti al 41-bis e gli avvocati. Geniale: così i
boss potranno ordinare omicidi e stragi per lettera».
Si tratta delle ennesime
affermazioni disarmanti – alle quali, probabilmente, sarebbe ormai più opportuno
non replicare – che sono l’esatto opposto di una corretta informazione e che non
fanno altro che confermare una palese insofferenza verso il diritto di difesa e
tutto ciò che si contrappone alla visione giustizialista e populista che le
genera.
Attenzione a non
mortificare ancora il ruolo della difesa. Giustizia sbilanciata, sempre più pm e
pochi giudici.
Alfredo Sorge su Il Riformista il 25 Gennaio 2022.
Gli interventi in occasione
della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario a Napoli, tornata a svolgersi
nello splendido Salone dei Busti in Castelcapuano, permettono alcune
riflessioni. Nel silenzio assordante dovuto alle misure sanitarie ancora in
atto, davanti agli sguardi dei grandi avvocati che quel Salone testimonia per
sempre, il presidente della Corte d’Appello De Carolis ha ribadito ancora una
volta le doglianze per la obiettiva penuria di uomini e mezzi che affligge
l’apparato giudicante e segnatamente l’organico della Corte d’Appello. I dati
offerti suggeriscono una prima riflessione integrata dal sempre più grande
divario di uomini e di mezzi – e dunque di risorse – tra la magistratura
inquirente e quella giudicante.
Le Procure, in particolare
quella di Napoli, forte di 112 pubblici ministeri (ed oltre cento
viceprocuratori onorari) e della Dda, costituisce un complesso apparato dotato
di uomini e strumenti investigativi notevoli, se si considera anche la polizia
giudiziaria al suo servizio e che la spesa per le indagini, in primis per le
intercettazioni (telefoniche, ambientali, informatiche), resta molto elevata.
Eppure, l’inquirente presenta risultati quantomeno contraddittori rispetto a
simile schieramento di forze, se è vero che circa il 50% dei procedimenti con
indagati “noti” termina con una richiesta di archiviazione, spesso al termine di
indagini ben poco approfondite. Il dato deve far riflettere: non parliamo dei
procedimenti a carico di ignoti (furti etc.) bensì di reati denunciati da
privati o dalla polizia giudiziaria che hanno dato luogo a un’iscrizione a
carico di un ben individuato indagato.
Come si spiega questo dato che
risulta, peraltro, in costante aumento? La tematica merita un approfondimento
per conoscere le ragioni di negare qualsivoglia approfondimento anche in
relazione a fatti che segnano pesantemente la vita della persona offesa che si è
rivolta al pm per veder tutelati i propri diritti personali e patrimoniali.
Altra assenza di rilievo nei dati della Procura è costituita dai procedimenti in
tema di responsabilità da reato dell’ente ex D. L.vo 231/01, modello
organizzativo che va invece promosso ed incentivato (e perciò perseguito in sua
assenza) proprio per meglio valutare la serietà delle aziende. Altro dato su cui
riflettere è l’ingresso di alcuni istituti legati al Pnrr. In particolare, nel
corso della relazione del presidente Giuseppe De Carolis di Prossedi, si è
discusso del disposition time per la definizione degli affari civili e penali.
Ben vengano tutti gli aiuti e le risorse per colmare le lacune degli organici
della magistratura e del personale amministrativo (si pensi alla situazione
drammatica in cui versa il Tribunale di Sorveglianza, problematica gravissima
quanto trascurata nelle relazioni) ma certamente non è accettabile che lo stesso
rappresenti un altro ostacolo per un accertamento giudiziario che deve essere
condotto in modo sereno e completo nel corso dei procedimenti di primo grado e
di appello.
Sotto questo profilo, va
ricordato come la pandemia abbia già determinato una serie di limitazioni al
sistema delle garanzie e al diritto di difesa, addossando all’avvocato una serie
di ulteriori compiti e responsabilità come l’essere il destinatario delle
comunicazioni del processo anche per la parte che rappresenta, il dover
presentare tempestive richieste per ottenere che il processo venga celebrato non
da remoto o in una inaccettabile forma scritta, per non parlare della espulsione
dell’imputato detenuto dall’aula e dell’assenza del pubblico che è il primo
momento di controllo democratico: non si dimentichi che la giustizia è
amministrata in nome del popolo italiano che da due anni è assente per legge dal
processo. Insomma, già la difesa non è presente durante le indagini e in fase
cautelare non si muove certo alla pari rispetto alla pubblica accusa ma almeno
nella fase dibattimentale non può vedersi sottratto l’accertamento istruttorio
in nome di un cronometro; fare in fretta è un concetto che ben difficilmente si
declina con il fare bene e mai con il fare giustizia. La vera novità di cui s’è
detto nelle relazioni è l’ufficio del processo, si sa che ci sarà ma nessuno sa
a quali compiti sarà concretamente destinato.
Rinviando a fasi successive
ogni valutazione, auguriamoci soltanto che non si tratti, come purtroppo è stato
detto nel corso della cerimonia, di persone cui affidare il compito di studiare
il processo e di scrivere la sentenza lasciando al giudice il compito di
decidere. È bene dirlo subito: se si intende assegnare all’ufficio del processo
il compito più importante del giudizio, ovvero la motivazione dei provvedimenti
giudiziari – atto che per costituzione e per legge il giudice deve porre a base
della sua decisione –, la scelta sarebbe inaccettabile: non può essere giusto il
verdetto emesso da un giudice che per legge vede lo studio di altri e la
motivazione da altri ancora. Tutti d’accordo, invece, sull’atto di accusa
al Csm da parte del procuratore generale Luigi Riello: a fronte di una serie di
vicende che hanno messo alle corde l’organo di autogoverno chiamato dalla
Costituzione ad assicurare autonomia ed indipendenza della magistratura, è del
tutto mancato quel profondo esame di coscienza collettivo ed è stato così
inferto un danno grave alla credibilità dell’intera magistratura.
In particolare, ha detto il
pg, nulla di concreto risulta essere stato fatto per arginare lo strapotere
delle correnti interne alla magistratura che era ed è alla base del malessere di
cui è emersa soltanto la punta di un iceberg e le cui dimensioni sono ancora
ignote. «Che ci sta a fare un Csm così?», ha chiesto, retoricamente, Riello. In
conclusione, il presidente del Consiglio dell’Ordine di Napoli Antonio Tafuri ha
fatto bene ad evidenziare il cospicuo numero dei procedimenti e delle sanzioni
disciplinari che il Consiglio distrettuale di disciplina, con rinnovata energia,
ha portato avanti con tempismo. L’augurio più grande, dunque, lo dirigo ai
colleghi avvocati, perché non si deve mai dimenticare che il conto più salato
della pandemia lo ha pagato proprio l’avvocatura (come tutti i lavoratori
autonomi), costretta a lavorare tra mille difficoltà a causa delle penalizzanti
misure sanitarie, delle perduranti carenze organizzative e della diffusa crisi
economica. Alfredo Sorge
Lettera di un magistrato ad
un avvocato.
Antonio Zama, Direttore responsabile FiloDiritto.Com, su Il
Corriere del Giorno il 4 Gennaio 2022. Trovare un magistrato che scrive con
sensibilità e profondo rispetto della classe forense è assai difficile. Per
onestà intellettuale dobbiamo sottolineare che è altrettanto difficile trovare
un avvocato che lodi i magistrati. In questo mare tempestoso, che circonda la
vita nei tribunali, rileggere la lettera, scritta nel 2017, del dottor Giacomo
Ebner ha un effetto lenitivo sulle profonde e reciproche diffidenze e polemiche
che sembrano il leitmotiv che accompagna il rapporto dell’avvocatura con la
magistratura. Rapporto fatto di rivendicazioni, proclami, dissensi e veri propri
attacchi al campo avverso. Diciamo la verità avvocatura e magistratura sembrano
due cavalieri che si affrontano in una giostra medioevale.
Agli iniziali e cavallereschi
inchini e saluti di circostanza scambiati nei convegni, seguono le mazzate e
randellate tirate alla cieca contro il “nemico” quando si scrive e si parla con
la propria “fazione” e in pubblico, dimenticando “l’uguaglianza di origini”,
come scriveva l’avvocato Enrico De Nicola.
Ci piace l’idea che si possa
provare a percorrere una strada comune nell’anno delle riforme della Giustizia.
In tal senso ricordiamo lo scritto “Avvocati e magistrati” del 1920 di Enrico De
Nicola, dove il futuro primo Presidente della Repubblica ricordava
all’avvocatura che: “… Non si può parlare della nostra famiglia, cementata nei
diuturni rapporti e irradiata dalle sue virtù senza che il pensiero volga alla
magistratura, che ha con noi uguaglianza di origini, identità di
scopi, comunanza di ideali, di opere e di fede”.
Sono trascorsi 100 anni e
l’avvocatura ha le sue responsabilità per la perdita di stima e di autorevolezza
che la professione ha nel comune sentire, questo è un tema che ci svierebbe
dalle considerazioni espresse da un magistrato nei confronti di un avvocato. Con
le dovute proporzioni, non si adombri il dottor Giacomo Ebner, passiamo dalle
parole del Presidente De Nicola alla lettera del magistrato Ebner.
Siamo consapevoli che la
realtà non è così ma ci piace l’idea che le parole di Ebner sulla figura
dell’avvocato siano lette da più magistrati possibili, in particolare dai
giovani giudici che sembrano avulsi dal considerare che il valore di un
magistrato si vede anche da come tratta un avvocato. Iniziamo il 2022 quindi con
la lettera scritta dal dottor Giacomo Ebner magistrato presso il Tribunale di
Roma:
Lettera di un magistrato ad un
avvocato
Caro Avvocato,
ogni giorno ci vediamo e
condividiamo una parte del lavoro assieme.
Sì ma tu facendo la fila fuori
dalla mia porta, io alla mia scrivania;
tu entrando col sorriso anche
se hai i tuoi cavoli, io dipende dall’umore;
tu in piedi, io seduto;
tu in giacca e cravatta anche
a luglio, io in jeans;
tu paziente dei miei orari, io
non sempre dei tuoi;
tu che hai il cliente sul
collo, io che ho tutto apparecchiato;
tu che torni più volte per
vedere se ho deciso ed io che mi sento in colpa per non averlo ancora fatto;
tu che hai vent’anni più di me
e mi saluti con rispetto;
tu che mi racconti storie di
altri e dagli occhi capisco che mille ne avresti da dirne di tue;
Ti rispetto, ti ammiro, ti
sono grato.
Dott. Giacomo Ebner
E il giudice disse:
«Avvocato, ha solo mezz’ora di tempo».
DIFESA INTERROTTA. La denuncia
di un legale a cui è stata impedita la discussione in appello con una sorta di
conto alla rovescia da parte della Corte. Valentina Stella su Il Dubbio il 14
gennaio 2022.
Sulla scia delle diverse
segnalazioni che ci stanno arrivando in merito al controesame della difesa nel
quale si intromette indebitamente il giudice, ce n’è giunta una diversa e
davvero singolare da parte dell’avvocato Giovanni Falci a cui- ci scrive – è
stato « “vietato” di difendere l’imputato, è stato vietato di poter svolgere la
discussione orale in grado di appello». Il fatto è avvenuto innanzi la Corte di
Assise di Appello di Potenza nell’ambito di un delicato processo per
associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidi, rapine ed altro. Il
Presidente, prima che l’avvocato iniziasse la discussione, gli ha detto
testualmente: «avv. Falci, prego, non più di mezz’ora». Ogni tentativo «di
ricondurre alla ragione quel Presidente è stato vano», ci racconta l’avvocato,
che aggiunge: « allo scadere del trentesimo minuto il Presidente mi ha
interrotto per segnalare che il tempo era scaduto e avrei avuto un solo minuto
per rassegnare le conclusioni. Ha iniziato un vero e proprio conto alla
rovescia».
Per tale episodio l’avvocato
ha presentato ricorso presso la Cassazione che però ha rigettato il motivo ed
ora ha riproposto la questione alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il
legale ci ha inviato il motivo di nullità del giudizio di appello per omessa
discussione della difesa. Vediamo i dettagli: « all’udienza conclusiva del
processo in grado di appello la difesa dell’imputato non ha potuto formulare ed
illustrare le proprie conclusioni perché impedita in tale funzione dal
Presidente della Corte di Assise di Appello. La discussione dell’avv. Falci
inizia con un termine assegnato dal Presidente: “Allora avvocato Falci, non più
di mezz’ora”». Questa disposizione del Presidente, secondo l’avvocato Falci,
«integra sicuramente la violazione dell’art. 178 lett. c) c.p.p. e, quindi
dell’art. 602 e di conseguenza dell’art. 523 n. 3 c.p.p., dell’art. 24, 11
Costituzione e dell’art 6 CEDU». Cosa dicono le norme? Sono chiare e semplici:
«Il Presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e
interruzione – È sempre prevista a pena di nullità l’osservanza delle
disposizioni concernenti: l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza
dell’imputato».
Nel caso di specie il
Presidente, con quella sua iniziale disposizione, «non ha diretto la discussione
in maniera da garantire il diritto di difesa dell’imputato. Egli non ha impedito
“divagazioni” perché non è possibile divagare per un intervento che ancora deve
iniziare. Egli non ha impedito “ripetizioni” perché non è possibile ripetersi se
non si è neanche iniziato. Egli non ha impedito “interruzioni” perché non è
possibile interrompere ciò che ancora non ha avuto inizio». In definitiva il
Presidente – si legge ancora nel motivo di nullità – «con quella disposizione
impartita ha esercitato una potestà riservata dalla legge a organi legislativi e
cioè ha ritenuto di poter inserire una disposizione che il codice non contiene e
cioè che il Presidente decide il termine da assegnare per la discussione della
difesa dell’imputato. Tale termine è previsto nel nostro ordinamento, ad
esempio, per i procedimenti camerali che pongono un limite di ammissibilità di
memorie scritte, ma non esiste riguardo alla discussione orale che è regolata
dalle norme richiamate nel presente motivo».
Prosegue il legale nel suo
motivo di ricorso: «La questione non è di poco conto e soprattutto ha
determinato in concreto un effettivo pregiudizio all’imputato. A fronte di 43
pagine di motivi di appello con ben 5 capi e punti della sentenza impugnati,
ritenere possibile l’esercizio della difesa in “non più di mezz’ora” significa
ridurre la presenza del difensore a mero simulacro e a soli fini scenografici.
Inoltre l’assegnazione del termine così come fatto dal Presidente del collegio
non è in sintonia con la disposizione normativa. Durante tutta la discussione
che si è potuta svolgere (tra l’altro addirittura in un lasso di tempo inferiore
ai 30 minuti), non vi è stato mai un intervento del Presidente volto a impedire
una eventuale divagazione, ripetizione e interruzione. […]La prova della lesione
del diritto di difesa è contenuto proprio nelle parole conclusive del Presidente
della Corte di Assise di Appello nel punto in cui dopo aver “concesso” cinque
minuti si esprime testualmente nel seguente modo: “avvocato, i cinque minuti
sono passati a dieci”; e poi, a seguire: “un minuto le do, un minuto, sessanta
secondi”». In conclusione, scrive Falci, « è di tutta evidenza che il
Presidente non adduce nessuna ragione “legale” per tale sua disposizione; non
evoca nessuna delle ragioni per le quali il legislatore gli attribuisce il
potere di intervenire per impedire condotte non consentite alla parte che
discute. Si verte nel caso in esame in una sicura ipotesi di abuso del
processo».
«Ora nuove regole per il
controesame, i giudici sono rimasti all’inquisitorio».
INTERVISTA A VALERIO
SPIGARELLI. Il past president dell’Unione Camere penali analizza nel dettaglio
l’origine delle condotte processuali di tanti magistrati che tendono a
ostacolare o scavalcare il difensore nel controesame testimoniale. «Come avete
documentato voi del Dubbio, c’è una tendenza a violare i limiti posti dal
codice, ma anche l’ignoranza degli approdi che esperienze come quelle del
laboratorio Lapec avevano realizzato proprio nel dialogo fra avvocati e
magistrati». Valentina Stella su Il Dubbio il 24 Dicembre 2021. In merito alla
nostra inchiesta sui controesami interrotti indebitamente dai giudici, abbiamo
raccolto il parere dell’avvocato Valerio Spigarelli, past president dell’Unione
Camere penali, che ci dice: «La prima ragione delle degenerazioni è la cultura
sulla prova che i giudici hanno ereditato dal codice inquisitorio. Questa
cultura inquisitoria è sopravvissuta al mutamento del codice». Perciò «occorre
modificare le norme, prevedendo delle sanzioni processuali in caso di violazione
delle regole per l’esame testimoniale da parte di tutti, giudici compresi».
Avvocato, lei ha letto i
nostri racconti degli ultimi giorni. Che idea si è fatto?
Abbiamo introdotto la tecnica
dell’esame e del controesame con la riforma del 1989, per tradurre in pratica il
metodo del contraddittorio nella formazione della prova. Lo abbiamo fatto
riconoscendo che il contraddittorio è il modo migliore per arrivare alla verità.
Purtroppo la prassi applicativa da subito ha prodotto una marea di
degenerazioni, alcune delle quali sono state messe in evidenza nei vostri
articoli. Il problema è che il contraddittorio vero, quello in azione, non è mai
stato digerito dalla maggioranza dei magistrati italiani, in particolare dai
giudici, anche in tema di esame testimoniale. Pensi che da un questionario
somministrato a un campione di giudici, pm e avvocati, dall’Università di Torino
nel 2004, quindi a 15 anni dall’entrata in vigore del nuovo codice, è emerso che
oltre il 50 per cento dei giudici sentiva che il loro ruolo, rispetto al
passato, per quanto concerneva l’esame testimoniale, “non si era modificato in
modo significativo”, eppure le regole dal codice inquisitorio a quello
accusatorio erano state rivoluzionate. Ma in effetti rispondevano il vero:
regole nuove ma modi di comportarsi da codice inquisitorio. “Tutto cambia perché
nulla cambi”.
In questo sistema che ruolo ha
il giudice?
Non è un ruolo notarile: ha
sempre la possibilità di intervenire per avere dei chiarimenti, ed è giusto
perché è lui che decide. Però non deve essere un giudice bulimico, invadente,
che non considera, per esempio, che le parti, pm e difensore, hanno una serie di
informazioni preventive che lui non ha. Il giudice vede per la prima volta il
testimone in aula e solo lì apprende la sua versione, deve essere recettivo, non
protagonista. La prima ragione delle degenerazioni è la cultura sulla prova che
i giudici hanno ereditato dal codice inquisitorio, in cui ricoprivano il ruolo
di dominus. In quel sistema erano le parti a chiedere al giudice di poter porre
una domanda che poi veniva rivolta al teste dal giudice stesso. Questa cultura
inquisitoria sulla prova è sopravvissuta al mutamento del codice.
Il giudice si rende
protagonista di indebite interferenze?
Spessissimo, checché ne dica
Anm, anche perché la giurisprudenza ha sempre negato, in questi casi, che ci si
trovi dinanzi a ipotesi di nullità o di inutilizzabilità. Si parla di mere
irregolarità nella conduzione dell’esame che però non portano all’invalidazione
dello stesso. E questo dipende dal fatto che il codice dell’89 non prevede
specifiche sanzioni processuali in questi casi, tranne in rarissime ipotesi,
quando, per esempio, il giudice impedisce a una delle parti di svolgere l’esame
o il controesame.
Quindi l’avvocato è disarmato.
Tendenzialmente è l’apparato
normativo che è imbelle dinanzi alle numerose prassi degenerative, ma anche
l’avvocatura è troppo arrendevole di fronte alla disapplicazione delle regole in
questo campo. A tal proposito, quando sento e leggo che non c’è dialogo tra
avvocatura e magistratura sul tema, o che si fanno pochi convegni, ricordo già
che nel lontano 2003 si dibatté, a Siracusa, presso l’Istituto Superiore
Internazionale di Scienze criminali, proprio di “prassi degenerative dell’esame
e controesame”. Ciò portò, nel 2008, alla nascita del La.p.e.c., Laboratorio
permanente esame e controesame, su iniziativa di Ettore Randazzo. Un gruppo di
lavoro, formato da avvocati, magistrati, professori, ormai presente in molti
Tribunali italiani, che da allora organizza convegni in materia. Il La.p.e.c.,
nel marzo 2010, elaborò le Linee guida per l’esame incrociato nel giusto
processo, dopo un ciclo di incontri durato anni, che coinvolse magistrati di
altissimo livello come Canzio, Iacoviello, Fumu, Bricchetti, professori come
Spangher e Amodio, avvocati cultori della materia come Antonio Forza e anche
esperti di psicologia della testimonianza come il professor Sartori. Una sorta
di vademecum virtuoso sull’esame dei testi.
Quali sono i punti principali
di queste linee guida?
Primo: il rispetto della
regola del codice che prescrive che lista testimoniale deve contenere
l’indicazione specifica delle circostanze oggetto dell’esame. Questa è la prima
regola vanificata dalla giurisprudenza: oggi nelle liste dei pm leggiamo ‘cito
Tizio sui fatti di causa’, in maniera estremamente generica. Secondo: il giudice
ha un suo momento per fare le domande, ossia dopo l’esame e il controesame, per
investigare aspetti che le parti non hanno toccato. Oppure può intervenire per
vietare domande non ammesse, ma non deve debordare e deve rispettare e far
rispettare la turnazione nelle domande. Terzo: per il codice chi fa l’esame
diretto non può fare domande che suggeriscono la risposta, lo può fare solo chi
fa il controesame. Ma al contempo permette che la domanda vietata possa essere
riformulata: ciò è sbagliato, perché ormai il suggerimento al teste è arrivato e
va impedito. Infine la previsione più simbolica: il divieto per il giudice di
utilizzare domande “che tendono a suggerire la risposta”.
Perché, che succede in
pratica?
Incredibilmente la
giurisprudenza permette domande suggestive da parte del giudice ritenendo che il
divieto che il codice stabilisce per chi fa l’esame diretto sia posto per
evitare i rischi di combine fra il testimone e chi lo introduce; e siccome il
giudice non introduce testi, e per definizione non è sospetto di combine, per
lui il divieto non vale. Ma la domanda suggestiva è un “suggerimento della
risposta” che, se proviene dal giudice, perde la sua funzione di test sulla
credibilità del testimone. Quando è il giudice che suggerisce le risposte il
teste si adegua perché vede nel giudice l’autorità assoluta del processo, le
combine non c’entrano nulla. Fortunatamente alcune sentenze hanno riconosciuto
che il divieto di porre domande suggestive vale anche per il giudice.
Dai racconti che abbiamo fatto
sembra che i giudici impediscano al difensore di stressare la prova ma poi lo
facciano loro.
Esatto. Se il giudice è
insoddisfatto, magari secondo il suo pregiudizio, di come sta andando la prova
testimoniale, ad esempio il controesame della parte offesa, si inserisce
indebitamente con domande suggestive. E quando l’avvocato fa presente che non
può fare quel tipo di domande, l’80% dei giudicanti sgrana gli occhi: non solo
non conoscono le Linee guida di La.p.e.c. e il dibattito che le ha prodotte ma
neppure le sentenze che lo hanno riconosciuto. Soprattutto non conoscono le
norme che già esistono. Le faccio un esempio. Secondo l’articolo 507 cpp il
giudice può disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova. In
questo caso l’articolo 151, comma 2, delle Disposizioni di attuazione stabilisce
che dopo aver posto delle domande al teste il giudice indica “la parte che deve
condurre l’esame diretto”. Quindi alla fine il giudice non può fare mai l’esame
diretto, ovviamente, né, men che meno, il controesame. Siccome le domande
suggestive le può fare solo chi conduce il controesame il giudice non le può
fare.
Le linee guida vanno bene, la
cultura condivisa avete tentato di crearla ma evidentemente tutto questo non è
bastato. Le soluzioni dunque quali sono?
Considerato che la
magistratura ha il codice accusatorio sulle labbra, ma quello inquisitorio
nell’anima, bisogna muoversi in più direzioni per invertire la rotta. Occorre
modificare le norme, prevedendo delle sanzioni processuali in caso di violazione
delle regole per l’esame testimoniale da parte di tutti, giudici compresi.
Soprattutto i giudici devono sentirsi terzi davvero: e non avverrà senza la
condivisione del primato epistemologico del contraddittorio nella ricostruzione
dei fatti. Paolo Ferrua scrisse: “Per chi ancora crede nel processo accusatorio,
l’impegno, il punto da dibattere sarà allora questo: la ricerca della verità,
avvertita dalla coscienza sociale come valore irrinunciabile, è agevolata e non
ostacolata dal contraddittorio: non perché esso garantisca la genuinità della
prova, ma perché è il miglior mezzo per verificarla, per scoprire se difetti”.
Ultima domanda: l’Anm di Roma
ha criticato il nostro modo di condurre questa inchiesta sull’esame incrociato
ma senza entrare nel merito. Guardare il dito e non la luna?
Da un lato è il solito
riflesso di natura sindacale-corporativa dell’Anm, che però in questo caso si
traduce un censorio ammonimento alla stampa a non raccontare comportamenti non
corretti della magistratura, d’altro lato è la dimostrazione della perfetta
ignoranza dei temi giuridici, e deontologici, che il tema coinvolge e di cui
abbiamo parlato fin qui. Non conoscono il dibattito culturale sulla materia che
è partito proprio dal riconoscimento che le prassi degenerative della
cross-examination all’italiana si fondano su violazioni di legge e di
canoni deontologici, compiute, soprattutto, dai giudici.
Quel giudice a Milano che
vuole impedire il controesame e che si crede un Pm. La denuncia
dell'avvocato Michele Andreano impegnato in un processo per stalking a Milano.
«Controesame interrotto in modo flagrante durante l'interrogatorio
dell'accusatrice». Valentina Stella su Il Dubbio il 23 Dicembre 2021. Continuano
a giungerci segnalazioni da parte degli avvocati in merito all’eccessiva
invadenza del giudice durante la cross-examination. Oggi vi portiamo al
Tribunale di Milano, dove si è svolto un processo per stalking, durante il quale
la direzione di tutto – esame e controesame – è stata svolta dal giudicante in
modo non certo ortodosso. Vediamo perché. È il giorno dell’esame della teste
principale, la presunta parte offesa. La particolarità di questo caso è che il
giudice, oltre a interrompere il controesame della difesa, si sostituisce quasi
del tutto al pubblico ministero nell’esame della presunta vittima. E il pm resta
a guardare.
Lo dimostra il verbale di
udienza dove l’indice riporta “Esame del pubblico ministero” da pagina 4 a
pagina 18 ma incredibilmente sarà quasi esclusivamente il giudice a porre
domande alla teste, il pm riuscirà a farne solo 3. Il giudice dice persino “Le
parti permettano che prosegua un po’ il giudice nel condurre le domande o ci
sono osservazioni? Grazie”. Dopo aver terminato si rivolge al pm: “Ci sono
domande per il Pubblico Ministero?’ Pm: “no grazie”. Qui due sono le cose: o
davvero pm e giudice hanno la stessa cultura e quindi è una ennesima
dimostrazione della necessità della separazione delle carriere o siamo dinanzi
ad un pm che ha abdicato alla sua funzione.
Ma ora passiamo al controesame
con l’avvocato Michele Andreano che subito esordisce: “Il mio controesame si
articolerà in due blocchi, il primo è quello che tenderà a mettere in luce
alcune cose che il Giudice ha, devo dire con maestria, come facevano i vecchi
pretori.” Giudice: “Ho fatto il pretore in effetti”. Per far capire la cultura
di questa figura, riprendiamo quanto scrisse il professor Giorgio Spangher ‘”Il
pretore, come correttamente affermato da Cordero, costituisce il “fossile” del
sistema inquisitorio, quello nel quale giudice e p. m. si identificano, anche
fisicamente, in un unico soggetto. Una specie di Giano bifronte”. Ma andiamo
avanti.
L’avvocato cerca di verificare
l’attendibilità della presunta vittima, su cui pende un procedimento in altra
sede per calunnia ma il giudice subito lo ferma: “Avvocato, ad evitare uno
stillicidio di tentativi di domande e opposizioni e miei interventi blindo, per
così dire, la problematica dicendo che oggi procediamo per il reato di atti
persecutori nei confronti della signora, le domande sulla sua situazione
giudiziaria hanno trovato risposta parte nelle sue dichiarazioni e parte nei
margini di acquisizione dei documenti che il Codice vi offre
copiosamente”. L’avvocato cerca di prendere un’altra strada per saggiare la
teste ma il Giudice pone un altro stop: “la domanda non è ammessa perché attiene
ai fatti fuori dall’imputazione. Avvocato abbiamo un teste, non abbiamo una
imputata, quindi lei cortesemente terrà conto…”. Avv: ‘”ai fini
dell’attendibilità”- Giudice: “Avvocato, terrà conto ai fini
dell’attendibilità.. è stata bersagliata di domande anche da parte del
giudice. Ricorderà il dovere di rispetto nei confronti dei testimoni, la
qualifica di persona offesa della signora in questo processo ed esprimerà la
sensibilità che nei confronti dei soggetti intesi vittime di reati e vittime
vulnerabili Codice, deontologia e la mia disciplina dell’udienza impongono”.
Come se lo schema delle
domande del giudice fosse lo stesso di quello dell’avvocato e come se cercare di
“stressare la prova” fosse un delitto. L’avvocato cerca di spiegare il perché
della sua domanda al giudice: “Come lei ha fatto, mi passi il termine più da Pg,
compulsato sul quadro generico della posizione giuridica della teste, la domanda
è su un episodio”. Il controesame prosegue, seppur tra diverse difficoltà per il
difensore dell’imputato, al quale ad un certo punto – udite, udite – viene
intimato di sbrigarsi, come già abbiamo appurato negli altri casi che vi abbiamo
descritto. Giudice: “Scusi, mi permetto con rispettosa cordialità di dire che
dovremmo cercare di contenere i temp”. Avv: “Però presidente, io non le nascondo
che ho una estrema difficoltà a procedere al controesame, anche perché sto più o
meno facendo come fa lei, cioè come ha fatto lei: prendo tutti gli episodi e
cerco in qualche modo di chiarire degli aspetti che non sono chiari né in
querela, né nel capo di imputazione”. E poi, dulcis in fundo, c’è il Giudice che
rende edotto il testimone, prima ancora che questi risponda, che si può anche
dire “non ricordo”: “Allora se ricorda. Se non ricorda: dica non
ricorda”. Testimone: “Non penso di ricordare” Giudice: “Bene”.
Il controesame procede tra
diverse interruzioni e molte domande non ammesse. Il Giudice ha fretta: “Mi
permetto di chiedere se ha ancora molte domande”. L’avvocato stizzito: “Dipende
anche da quante interruzioni ci sono”. Arriva il momento del co-difensore.
Giudice: “non ha altre domande?” Avv. D’Andria: “Ce le ho’ Giudice:
‘”Addirittura. Non posso pensare purtroppo di dedicare 3 ore ad una prova, sia
pure importante come questa”. L’avvocato non sarà più fortunato del suo collega,
in quanto la maggior parte delle domande non verranno ammesse. Giudice: “Signori
avvocati questa non è una sala di dibattito. Non mi costringete ad assumere
provvedimenti che non mi sono propri, di togliere la parola o quant’altro”.
Amen.
E il giudice disse: «Avvocato, le
impedisco di fare domande perché posso…». DIFESA
INTERROTTA. Processo a Laura Taroni, "l’infermiera killer" condannata per
omicidio: la difesa chiede la nullità della sentenza per l'impossibilità di
controesaminare l'esperto nominato dal Tribunale. Valentina Stella su Il Dubbio
il 30 dicembre 2021. Dopo il caso Cerciello, ci arriva un altro ricorso in cui
la difesa chiede la nullità di una sentenza di condanna «per avere la Corte
violato i principi del contraddittorio nell’esame del perito, impedendo
illegittimamente alla difesa di rivolgergli domande sulla metodologia del suo
accertamento (a dire del Presidente superflue e semmai di sola pertinenza dei
consulenti tecnici) e sul contenuto di alcune sue precedenti pubblicazioni in
materia delle quali respingeva l’acquisizione e la lettura».
Contestualizziamo il caso: il processo è quello a
carico di Laura Taroni, nota alle cronache come l’infermiera killer. La donna è
stata condannata per l’omicidio del marito e della madre tramite la
somministrazione di dosi eccessive di farmaci: a iniettare i farmaci sarebbe
stato il medico Leonardo Cazzaniga, con cui aveva una relazione. La donna in
primo grado con rito abbreviato era stata condannata a 30 anni, sentenza
confermata in appello. Poi la Cassazione annulla con rinvio e quest’anno viene
condannata nuovamente nell’appello bis. Ora i suoi avvocati, Monica Alberta e
Cataldo Intrieri, propongono un nuovo ricorso in Cassazione, adducendo come
primo motivo proprio l’impossibilità di controesaminare il perito nominato dal
Tribunale.
Il problema che emerge sembra essere sempre lo
stesso per i giudici: il pregiudizio secondo cui il difensore è un mestatore che
tende a confondere le acque. In questo caso alla difesa è impedito di
‘stressare’ il perito del Tribunale – “Non screditiamo nessuno” ammonisce
infatti il giudice -. Siccome è stato scelto dal Presidente, è ritenuto quasi
intoccabile. La difesa nei motivi di appello ricorda che «il giudice di
legittimità aveva annullato la sentenza d’appello sia per le accertata mancanza
di una sezione della motivazione ma anche perché la prima perizia condotta dai
professori M. e M. non aveva dato adeguata risposta al profilo
dell’imputabilità» della donna. Il tema della perizia sulla capacità di
intendere e volere costituisce infatti il cuore del giudizio. Dunque Alberta e
Intrieri stigmatizzano il «pretestuoso impedimento del controesame della difesa
che, per imperscrutabili motivi, la Corte ha espressamente vietato potesse
vertere sulla metodologia ed i criteri adottati dal perito, quasi fosse un
dozzinale espediente difensivo e non il criterio guida di fondamentali sentenze
della Corte di Cassazione nell’ultimo decennio, anche a livello delle Sezioni
Unite sulla prova scientifica». Inoltre « la Corte ha espresso un’ulteriore
sorprendente tesi secondo cui il contraddittorio sulla prova sia di pertinenza
dei soli consulenti e periti come se il processo penale venisse espropriato ai
giuristi».
Leggiamo un estratto del verbale: Presidente:
“Avvocato mi scusi, sul metodo vogliamo lasciare la parola ai Consulenti? Cioè
adesso addentrarci in questioni di metodo dopo che la perizia è stata fatta, nel
contraddittorio…”. Avv. Intrieri: “No, Presidente. Mi dispiace
Presidente…”. Presidente: “Sì, se non mi interrompe preferirei, Avvocato”. Avv:
“Io questo non… Presidente, lei può levarmi la parola ma non può dire, mi
scusi…”. Presidente: “Avvocato, però non mi interrompa”. Avv: “…che non siano
domande…”. Presidente: “No, mi scusi lei, Avvocato. Sto dicendo: visto che la
perizia è stata fatta nel pieno contraddittorio con condivisione del metodo…
adesso capisco qualche aspetto ma se vogliamo riprendere tutto il discorso
metodologico io però non sono d’accordo. La invito a domande specifiche
possibilmente fatte dal Consulente più che dall’Avvocato perché sennò non
arriviamo più al merito della perizia sulla quale invece la inviterei a fare
tutte le domande che crede”. Avv: “No, mi scusi Presidente, ritengo che faccia
parte…”. Presidente: “Prego, Avvocato”. Avv: “…della mia attività, del mio
diritto difensivo fare domande anche sulla metodologia. Non devo ricordare io a
lei le sentenze della Cassazione da Cozzini a Pavan sull’importanza che il
Giudice valuti la metodologia utilizzata”. […] Avv: “Se lei permette, il
Consulente che è un mio assistente farà le sue domande e le sue valutazioni.
Dopodiché lei non…”. Presidente: “Va bene, vorrà dire che l’esame del Consulente
avrà meno spazio perché non abbiamo poi a disposizione…Siamo tante Parti
processuali”. Avv: “Lei può anche levarmi la parola”. Presidente: “Sentiamo la
domanda e vediamo se è ammissibile”.
L’avvocato cerca di continuare il controesame,
chiedendo al perito delucidazioni su un suo intervento ad un convegno, per far
emergere alcune sue contraddizioni. Ed ecco subito che interviene il Procuratore
generale: “Mi oppongo, signor Presidente a queste valutazioni” e il presidente
puntualmente “Accolgo l’opposizione del Procuratore Generale”. Presidente:
“Avvocato cortesemente ritorniamo ai fatti”. Avv: “No, io sono
cortesissimo”. Presidente: “…e soprattutto alla sostanza di questa perizia
perché sul metodo ci siamo anche fin troppo dilungati”. Avv: “Certamente
Presidente, io vorrei evitare che ci trovassimo di fronte ad un ennesimo
annullamento un domani. Comunque faccio riferimento che quella affermazione è
stata scritta e fatta in una comunicazione nel convegno…”. Presidente: “No,
basta Avvocato. Il convegno non entra in questo processo. Lo tolga via per
favore perché non è ammessa neanche la citazione”. Avv: “Allora, guardi
Presidente, io ritengo”. Presidente: “Questa è la mia maniera di condurre il
dibattimento”. Avv. Intrieri: “che lei mi stia impedendo di fare le
domande”. Presidente: “Sì, questa domanda non è ammessa”. Avv: “E metta a
verbale che considero nullo questo tipo di contraddittorio proprio perché mi
impedisce di fare le domande “. (va infatti formalizzata l’eccezione di nullità
del controesame per farne motivo di impugnazione, ndr). Presidente: “Lo sto
impedendo perché rientra nei miei poteri”[…] Presidente: “Va bene. Prenda atto
che esercito i poteri di conduzione dell’esame”. Avv: “Ci rinuncio. Faccia come
crede, ma faccia come crede”.
«Io, giovane avvocata, ostacolata dal
giudice nel fare il mio lavoro». DIFESA INTERROTTA. Il
racconto di una legale che assisteva un richiedente asilo: «Mi ha persino
impedito di prendere degli appunti». Cristina Polimeno su Il Dubbio il 28
dicembre 2021. Leggendo negli scorsi giorni i contributi su quella che
il Dubbio ha definito la “difesa interrotta” raccontata da alcuni colleghi in
relazione a processi penali, il pensiero è immediatamente corso a tutte le volte
in cui, come studio legale nel quale fra le attività principali abbiamo
scelto la difesa dei richiedenti asilo, condotte analoghe hanno visto
mortificati i principi del giusto processo.
Una doverosa premessa per permettere ai lettori di
calarsi nella situazione: l’audizione del rifugiato nelle cause per domanda di
protezione internazionale è il momento centrale del processo. Nel diritto di
asilo, infatti, le dichiarazioni del richiedente sono spesso l’unica fonte di
prova, e dunque dei fatti costitutivi il diritto. Come osservato dall’autorevole
dr. Luca Minniti, giudice della sezione specializzata del Tribunale di Firenze,
“nel diritto di asilo, la valutazione probatoria si avvale di uno standard
inferiore, laddove la disciplina in esame consente al racconto della parte –
anche se a sé favorevole, purché coerente, articolato e plausibile – di
costituire sufficiente prova dei fatti narrati. (…) Si tratta di un passaggio
complesso per la cultura della prova del giudice civile, al quale si aggiungono
altre peculiari difficoltà.”
Mesi fa, davanti a un Tribunale presso il quale
non avevo mai operato e molto distante geograficamente dal mio Foro, durante
l’audizione del mio assistito in udienza che si svolgeva in videoconferenza, il
Giudice – che si occupava di interrogare il richiedente e verbalizzare le sue
risposte – stravolgeva il senso del racconto appiattendolo su un racconto
standardizzato. Questa (non infrequente, purtroppo) tendenza, per motivi sopra
illustrati, è un rischio che può causare una irrimediabile compromissione dei
diritti dei miei assistiti. Ho provato ad interloquire con il giudice, il
quale mi ha chiesto di tacere per non interferire nell’audizione.
Riservandomi quindi di elencare le mie
osservazioni al momento della rilettura del verbale, ho iniziato ad appuntare le
risposte del mio assistito. Quando il Giudice si è accorto del fatto che stavo
prendendo appunti, ha interrotto l’audizione e con toni molto più alti del
necessario mi ha chiesto: “Avvocato, ma lei lo sa che è vietato registrare
l’udienza?”. Davanti alla mia obiezione per la quale anche a un’udienza dal vivo
avrei potuto prendere appunti, mi è stato risposto che forse non mi rendevo
conto che stavo commettendo un reato. Per non incorrere nel grave reato di
“appunti” (in realtà solo per stemperare gli animi e non nuocere al mio cliente)
interrompevo la mia attività e mi rassegnavo a subire una verbalizzazione
distorsiva delle dichiarazioni del mio assistito. Non sarebbe stata, purtroppo,
né la prima e tantomeno l’ultima volta. Non è bastato, poiché alla fine
dell’audizione ho anche dovuto sorbirmi una bella ramanzina sul senso del mio
lavoro.
Sarà perché sono giovane, perché donna, perché
battagliera…il mansplaining, forse non lo sapevate, è di gran moda nelle aule di
Tribunale. “Avvocato, ma lei non l’ha capito che questi raccontano tutti la
stessa storia? E lei mi viene a chiedere l’asilo o la protezione sussidiaria?
Chiedete la protezione umanitaria, se hanno il lavoro ve la concediamo. Non
state a farci perdere tempo, anche per la vostra dignità: non fate bella figura
a farvi prendere in giro così da questi. Ma davvero non lo capisce che vi
prendono in giro e le storie sono finte?”.
E anche quel giorno, con buona pace della
Costituzione, della Carta UE, della Convenzione di Ginevra e (soprattutto) del
buongusto, questa giovane avvocatessa ha imparato qualcosa di utile da un fine
giurista e il suo assistito è stato discriminato in quanto immigrato. Niente di
nuovo sotto il sole, insomma.
Pignatone ci ricasca:
“Troppi avvocati cassazionisti, per questo la giustizia è lenta”.
L'ex procuratore di Roma,
Giuseppe Pignatone, ha trovato le ragioni della giustizia lumaca: troppi
avvocati... Il Dubbio il 12 gennaio 2022.
E dire che il titolo
prometteva bene: “Così i tre gradi di giudizio rallentano la giustizia”. Vuoi
vedere, ci siamo detti, che anche l’ex procuratore Pignatone si è convertito
alla nostra battaglia contro la possibilità di appello da parte della procura in
caso di assoluzione dell’imputato? Una posizione che aveva mobilitato giuristi
del livello di Paolo Ferrua: “Non v’è dubbio che l’appello del pubblico
ministero avverso le sentenze di assoluzione e, di conseguenza, la possibilità
di una condanna pronunciata per la prima volta in sede di appello rappresentino
una grave ed insanabile contraddizione all’interno dell’ordinamento
processuale”, aveva spiegato al Dubbio qualche settimana fa in articolo che
dovete assolutamente leggere. Ma ovviamente era un abbaglio, Pignatone nel suo
articolo non solo non accenna minimamente alla soppressione dell’appello da
parte dei pm, ma addirittura sostiene che la colpa delle lentezze è colpa dei
troppi avvocati.”In Francia e in Germania – spiega Pignatone- gli avvocati
abilitati al patrocinio in Cassazione sono rispettivamente 50 e 100 a fronte dei
55mila italiani. Ciò significa che all’estero sono gli stessi avvocati abilitati
a fare da filtro e a limitare i ricorsi alle questioni più importanti o sulle
quali non esista una giurisprudenza consolidata. Questo spiega anche perché le
sentenze di quelle Corti sono poche migliaia l’anno a fronte delle oltre 50mila
emesse dai giudici di Piazza Cavour, costretti a occuparsi anche di processi di
importanza trascurabile e di questioni riproposte all’infinito, dato che
comunque conviene fare ricorso sperando nella prescrizione (e, in futuro, nella
improcedibilità), o in una nuova legge o in un mutamento di giurisprudenza che
capovolga il giudizio o almeno mitighi la pena. Una valanga di decisioni che
peraltro implica un certo tasso di contraddittorietà e quindi un’erosione di
autorevolezza dell’organo che dovrebbe assicurare l’uniformità della
giurisprudenza”. Ma c’è altro. L’altro motivo di rallentamento della giustizia,
sempre secondo Pignatone, è dato dalla mancata riforma della reformatio in
pejus, cioè la possibilità che il giudice, se rigetta l’appello, possa aumentare
la pena inflitta in primo grado: “Quanto all’appello – spiega ancora Pignatone-,
ci sono Paesi come la Francia che prevedono la reformatio in pejus: il che
impone una certa prudenza nell’impugnazione, dato che questa comporta un rischio
che l’avvocato e il cliente devono calcolare per non proporre appelli temerari
che potrebbero ritorcersi contro l’imputato. Quando si è proposto questo
correttivo in Italia siè gridato allo scandalo per la presunta violazione della
Costituzione”.
Quanto è fragile il teorema
dei processi rallentati dai difensori cassazionisti.
Da ultimo, è stato l'ex
procuratore Pignatone a ipotizzare un nesso fra numero di patrocinanti e ricorsi
in Cassazione. Ma le leggi escludono la strumentalità delle impugnazioni.
Alessandro Parrotta, Avvocato, direttore Ispeg, su Il Dubbio il 30 gennaio 2022.
Non è certamente un caso che
da tempo le istituzioni si concentrino sull’importanza della figura
dell’avvocato, arrivando a ipotizzare di riconoscerle un rilievo più esplicito
sul piano costituzionale, per il tramite della modifica dell’articolo 111, sì da
rafforzarne la sua libertà, autonomia, indipendenza nell’ambito del sistema
giudiziario, quale sua parte fondamentale.
Eppure, sebbene l’inserimento
in Costituzione sia in linea anche con la riforma Cartabia – come attentamente
osserva il vicepresidente del Csm, l’avvocato David Ermini, con il quale chi
scrive ha condiviso un importante seminario sul tema a Torino – e sebbene
diverse forze collaborino per rafforzare lo spirito costruttivo in seno a questo
ambizioso progetto, non mancano le campane fuori dal coro e c’è chi, ancora
oggi, ritiene che la Giustizia sia lenta per i troppi avvocati.
Chi scrive ha letto nelle
scorse settimane le pagine de La Stampa ove il già procuratore della Repubblica
di Roma Giuseppe Pignatone esprime alcuni concetti che limiterebbero i principi
del giusto processo, come lucidamente osservato su queste pagine da Valentina
Stella. Ci si vuole, ora, soffermare sull’affermazione secondo cui la lentezza
della giustizia sarebbe determinata dall’elevato numero degli avvocati abilitati
al patrocinio in Cassazione.
Che il sistema penale italiano
sia strutturato su più livelli di giudizio affinché vengano ridotti, al minimo,
gli errori giudiziali è un dato di fatto e questa non è la sede per riprendere i
più che condivisibili ragionamenti circa la battaglia contro la possibilità di
appello da parte della Procura in caso di assoluzione dell’imputato; parimenti è
un dato di fatto che la nuova disciplina dell’Ordinamento della professione
forense (legge 31 dicembre 2012 n. 247) abbia modificando il sistema di accesso
all’Albo speciale dei patrocinatori avanti alle giurisdizioni superiori,
stabilendo che tale iscrizione – dopo il 2 febbraio 2022 – possa essere
richiesta al Cnf da chi sia iscritto in un Albo ordinario circondariale da
almeno 5 anni e abbia superato l’esame ex legge 1003 del 1936 e Regio decreto 9
luglio 1936, n. 1482, nonché da chi abbia maturato un’anzianità di iscrizione
all’Albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola superiore
dell’Avvocatura. Questo è un punto di partenza di primaria importanza che già va
ad imporre un vaglio non di poco conto.
L’idea, però, che l’opinione
pubblica si potrebbe fare sulla base della suggestiva affermazione relativa
all’associazione fra “lentezza dei processi” e “troppi avvocati” va
vigorosamente sfatata e non per doveri di categoria ma per obiettivi motivi di
carattere tecnico, procedurale e, infine, deontologico. Andiamo per punti.
L’avvocato è sempre stata una
figura difficile per la democrazia; come osservavano i colleghi nel saggio
“L’Avvocato necessario” (di F. Gianaria ed A. Mittone) proprio l’avvocato
difensore è garanzia essenziale per il cittadino: finché l’avvocato è libero di
scegliere chi assistere, se presentare o meno mezzi d’impugnazione, ricorsi e
gravami e goda d’indipendenza massima, il cittadino che non ha commesso reati sa
“che qualsiasi cosa gli accada, in qualsiasi circostanza si trovi, potrà avere
un difensore. La garanzia che il colpevole sia difeso rassicura l’innocente. E
alimenta la democrazia”.
Il difensore è, per dettami
deontologici, il primo baluardo di screening circa la fondatezza o meno in
ordine alla presentazione di cause e mezzi d’impugnazione, come già chi scrive
faceva notare su queste pagine negli accesi giorni di esame parlamentare della
riforma Bonafede sulla prescrizione. La falcidia dell’inammissibilità dei
ricorsi impone il necessario preliminare studio, ex ante, da parte dell’avvocato
in ordine all’esito dell’atto difensivo medesimo; e non si dica che si ricorre
in Cassazione per puntare alla prescrizione (o alla prossima cosiddetta
improcedibilità) in quanto tale affermazione è un orrore giuridico a mente della
manifesta infondatezza dei motivi che rende inoperante il decorso del tempo
prescrizionale.
Pur ragionando a lungo non si
arriva a capire come la riduzione del numero degli avvocati cassazionisti
dovrebbe condurre all’accelerata della Giustizia o, ancora, alla riduzione del
numero dei ricorsi.
È il Patto Internazionale sui
diritti civili e politici che garantisce il diritto al “riesame” della
colpevolezza, e il ricorso in Cassazione è strumento che volge in tal senso, col
limite di eseguire il solo controllo di legittimità, escludendo l’assunzione di
prove diverse da quelle documentali. Pertanto i correttivi sono già intrinseci
al Sistema medesimo e l’avvocato nulla può su questi se non osservarli,
adempiere al proprio incarico e difendere l’Assistito contro ogni accusa.
Come rimediare alla invocata
lentezza? Non già riducendo il numero dei difensori abilitati avanti le
Giurisdizioni superiori ma investendo abbondantemente in risorse presso i
Palazzi di Giustizia. La lentezza si annida: 1) nella fase delle indagini
preliminari, per carenza del numero dei magistrati inquirenti applicati agli
Uffici di Procura; 2) nelle udienze preliminari, per carenza di un vero ed
effettivo filtro procedurale, ove il Gup pare esser stato spogliato dei propri
poteri decisionali; 3) per mancanza di personale di segreteria e di cancelleria
che porta un ritardo nelle notificazioni e negli adempimenti; 4) per carenza di
numero di giudici presso le Corti d’Appello e presso i Tribunali territoriali. E
l’elenco potrebbe proseguire.
Non si dimentichi la mancata
riforma circa lo snellimento dell’intero processo penale e l’inascoltato
consiglio di sopprimere l’appello avverso le sentenze di proscioglimento.
Auspica pertanto la Presidente
Masi, quanto lo scrivente, di ripartire proprio da quella riforma ad esordio
citata, ora depositata in Senato, con l’obiettivo di raggiungere “il
rafforzamento dello Stato di diritto e dell’intera giurisdizione a favore dei
cittadini”.
L’Avvocatura non può e non
deve essere additata per carenze che vanno imputate a scelte politiche o di
budget finanziario, dovendo preservare il proprio ruolo di Parte nel Sistema
Giustizia, al pari delle altre Parti, Inquirente e Giudicante.
·
Gli Incapaci…
Carlo Gilardi,
chi è l’uomo facoltoso rinchiuso in una Rsa contro la sua volontà?
Giorgia
Bonamoneta il 13 Novembre 2022 su money.it.
La vicenda di Carlo
Gilardi è divenuta nota a tutti dopo l’inchiesta de Le Iene. Chi è l’uomo troppo
generoso che è stato rinchiuso in una Rsa contro la sua volontà?
Nel 2020 il
programma Le Iene presentavano il dramma di Carlo Gilardi, un uomo rinchiuso in
una Rsa contro la sua volontà. Gilardi era stato inserito all’interno della
struttura in seguito alla decisione di un giudice e della sua amministratrice di
sostegno. Davide Parenti, autore de Le Iene, ne descrisse la storia attraverso
un articolo denuncia su Corriere della Sera.
Carlo Gilardi è un
uomo di oltre 90 anni, piuttosto facoltoso, che nel pieno delle sue capacità
mentali - non è mai stato dimostrato il contrario - è sottoposto da due anni a
un ricovero coatto nel reparto psichiatrico di una Rsa. Avvocati e familiari, al
momento del prelievo, non erano al corrente del motivo e dell’operazione stessa.
L’amministratrice di sostegno, Elena Barra, aveva affermato che Gilardi l’aveva
seguita volontariamente, ma la presenza di carabinieri e un ordine del giudice
che autorizzava l’uso della Forza pubblica (Carabinieri) per l’accertamento
sanitario obbligatorio hanno subito acceso dubbi sulla vicenda.
Sempre secondo Barra
il trattamento coatto era stato reso necessario perché Gilardi era “troppo
generoso” nei confronti della comunità. L’uomo aveva infatti permesso a chi non
aveva la possibilità di pagare un affitto di stare nella propria casa, aveva
donato diversi beni immobili e aveva anche donato al Comune un parcheggio e un
parco per i bambini. “Troppo generoso” o un tentativo di sfruttare il patrimonio
dell’uomo? Questo dubbio proveniva direttamente dalle lettere scritte da Carlo.
Anziano generoso o
sfruttato? Ecco chi è Carlo Gilardi
Carlo Gilardi ha una
pensione da insegnante, eppure tutta la vicenda che lo circonda sembra essere
incentrata su un ricco patrimonio. Infatti Gilardi nel 2017 ha ricevuto una
grossa eredità da parte della defunta sorella e questo, in seguito a una serie
di notevoli atti di generosità dell’uomo, potrebbe aver attirato l’attenzione di
terze persone interessate a mettere mani sul patrimonio.
Una sorella di
Gilardi ha così chiesto che l’uomo fosse affiancato da un amministratore di
sostegno per gestire il patrimonio ed evitare spese che, al di là della
generosità, potevano apparire come frutto di manipolazione. L’uomo non ha mai
dato segni di demenza e non ci sono prove nella sua cartella clinica che abbia
bisogno di un effettivo controllo, tanto che lui stesso denunciò la precedente
amministratrice di sostegno in più occasioni per avergli sottratto dei soldi.
Sottoposto a una
perizia psichiatrica da lui richiesta, Gilardi è risultato “con un pensiero
privo di alterazioni”, ma nonostante questo è stato trasportato contro sua
volontà in una Rsa. Il 21 novembre 2022 si svolgerà il processo a cinque persone
accusate di aver raggirato Carlo Gilardi per farsi dare soldi o case, tutte
straniere, mentre è ancora silenzio sulle vicende portate alla luce da Le Iene.
Due anni dopo: cosa
è successo a Carlo Gilardi?
La storia di Carlo
Gilardi ha raggiunto moltissime orecchie, persino quelle di Giorgia Meloni che
in Parlamento aveva chiesto spiegazioni sui motivi per i quali si
poteva limitare la libertà di un uomo senza una giustificazione valida. A
distanza di due anni un amico di infanzia di Girardi è riuscito a entrare di
nascosto nella Rsa e a incontrarlo.
L’uomo presenta
ancora le capacità cognitive riscontrate dall’ultimo accertamento volontario
fatto e in un video registrato dall’amico, prima che è una suora interrompesse
lo stesso, Gilardi teme che la decisione di bloccarlo all’interno di una Rsa in
maniera definitiva provenga dalla sorella ancora in vita. L’interessamento di
terzi, quali giudice e le due ultime amministratrici di sostegno (amiche), è
quindi dovuto al patrimonio, dice Gilardi.
Carlo Gilardi in
Rsa contro sua volontà? Le Iene “Inside”: l’odissea del benefattore.
Silvana
Palazzo su Il Sussidiario.it il 13.11.2022
Carlo Gilardi,
rinchiuso in una Rsa contro la sua volontà? Le Iene ritornano sull’odissea del
benefattore di Airuno con lo speciale “Inside” e preannunciano novità sul caso…
È dedicato a Carlo
Gilardi e all’amministrazione di sostegno la terza puntata di “Inside“, speciale
de Le Iene. Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri preannunciano novità sulla vicenda
dell’anziano e ricco benefattore di Airuno, che dal 24 ottobre 2020 si trova in
nella Rsa “Airoldi e Muzzi” di Germanedo apparentemente contro la sua volontà.
Si tratta di una vicenda a dir poco delicata, perché l’ex badante di
Gilardi, Brahim El Mazoury, e le due giornaliste del programma sono finite a
processo per diffamazione aggravata nei confronti dell’avvocato Elena Barra,
amministratore di sostegno del facoltoso insegnante.
L’accusa riguarda le
puntate andate in onda il 17 novembre 2020 e il 16 febbraio 2021, quelle
che hanno raccontato l’odissea di Carlo Gilardi e alcuni punti oscuri della
vicenda, a partire dal ricovero forzato in casa di riposo che, stando alla
teoria illustrata dal programma, sarebbe stato deciso dalle amministratrici di
sostegno dell’ex docente del Parini di Lecco per mettere mani al suo ingente
patrimonio. Nel frattempo, il comitato “Libertà per Carlo Gilardi” continua a
farsi sentire: “I giudici si diano una mossa a riportare a casa Carlo Gilardi e
ad attuare i dovuti percorsi a sua tutela, come indicato dal Garante“.
Carlo Gilardi, nato
ad Airuno (Lecco), è noto per la sua cultura e per essere una persona molto
generosa. Infatti, l’ex professore in passato ha fatto donazioni anche di un
certo rilievo sia a enti che persone fisiche, ad esempio ha regalato un
defibrillatore al suo paese e un parcheggio al comune per l’asilo nido. Con Le
Iene è diventato un caso nazionale, perché veniva denunciato il ricovero in Rsa
contro la sua volontà. La vicenda inizia quando Sandra Gilardi, sorella del
professore in pensione, chiede l’intervento di un giudice, alla luce della
facilità col cui fratello regalava i suoi soldi. Dunque, nel 2017 il patrimonio
dell’anziano è stato gestito da un giudice tutelare, poi da un amministratore di
sostegno.
Nell’ottobre 2020
c’è stato il trasferimento in Rsa, a scoprire quale fosse è stato il
programma Le Iene. Alcuni parenti hanno collaborato e, dopo aver minacciato di
ricorrere all’avvocato, sono riusciti a parlare al telefono con Carlo Gilardi.
“Sto benissimo! Spero un giorno o l’altro di poter essere cacciato via ma non mi
cacciano via. Sono stato prelevato, messo in ospedale, poi in ospizio e cosa
vuoi farci. Come siano andate le cose non lo so esattamente… solo che la colpa
prima è di mia sorella Sandra che mi ha messo nelle mani degli avvocati. È lei
la colpevole di tutto, gli altri fanno solo il loro dovere“, le parole raccolte
dal programma. La tutrice di Carlo Gilardi, l’avvocato Elena Barra, e il
direttore della Rsa hanno sempre negato il Tso, parlando di ricovero temporaneo,
invece fonti interne citate da Le Iene sostengono il contrario.
Le Iene presentano
Inside, stasera alle 20.30. Carlo e gli altri: quando la tutela diventa la
ragnatela
Terzo appuntamento
stasera in prime-time su Italia1 con “Le Iene presentano Inside”. Con Nina
Palmieri vi parliamo dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e del caso
di Carlo Gilardi, il ricco e anziano benefattore di Airuno che da più di due
anni si trova in una rsa apparentemente contro la sua volontà
Torna, stasera in
prime-time su Italia1, “Le Iene presentano Inside”. Il terzo appuntamento dal
titolo “Carlo e gli altri: quando la tutela diventa ragnatela” è un
approfondimento, in onda dalle 20.30, dedicato all’amministrazione di sostegno,
la figura istituita per coloro che si trovano nell’impossibilità di provvedere
ai propri interessi.
Il sistema è nato
circa vent’anni fa con il buon intento di tutelare persone fragili, anziane o
non del tutto autosufficienti, aiutarle nella gestione del loro patrimonio e
nella cura dei loro bisogni quotidiani rispettandone sempre gli interessi. In
molti casi sostiene chi ha bisogno ma, in altri, mostra delle falle che
porterebbero alla trasformazione della tutela in ragnatela.
In questa
puntata Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri pongono l’attenzione su quelle
situazioni in cui sono apparse contraddizioni e punti poco chiari. Partendo
dalle novità che riguardano l’ormai nota vicenda di Carlo Gilardi, l’anziano e
ricco benefattore di Airuno che da più di due anni si trova in una rsa
apparentemente contro la sua volontà, si racconteranno le storie di coloro che
ai microfoni de Le Iene hanno testimoniato i loro disagi.
La trasmissione in
questi anni ha fatto conoscere diverse storie di persone che hanno subìto
stravolgimenti della loro vita e a cui le istituzioni avrebbero tolto la libertà
di scegliere come, dove, con chi vivere e persino dove morire. Nel corso della
serata tanti gli spunti di riflessione e le domande a cui provare a rispondere,
una tra tutte: un Paese civile può o meno permettere che un uomo perda la
possibilità di decidere per se stesso e per la sua felicità?
Che fine ha fatto
Carlo Gilardi: l’uomo generoso rinchiuso in una Rsa contro la sua volontà.
GIUSEPPA GIORDANO il 14 novembre 2022 su tag24.it.
Che fine ha fatto
Carlo Gilardi. Carlo Gilardi è un ex professore in pensione, un signore
piuttosto facoltoso, che nel pieno delle sue capacità mentali - non è mai stato
dimostrato il contrario - è sottoposto da due anni a un ricovero coatto nel
reparto psichiatrico di una Rsa.
Che fine ha fatto
Carlo Gilardi. Carlo Gilardi è un ex professore in pensione, nato ad Ariuno, in
provincia di Lecco, il 4 dicembre 1910 ed è un signore piuttosto facoltoso,
che nel pieno delle sue capacità mentali – non è mai stato dimostrato il
contrario – è sottoposto da due anni a un ricovero coatto nel reparto
psichiatrico di una Rsa. Avvocati e familiari, al momento del prelievo, non
erano al corrente del motivo e dell’operazione stessa. L’amministratrice di
sostegno, Elena Barra, aveva affermato che Gilardi l’aveva seguita
volontariamente, ma la presenza di carabinieri e un ordine del giudice che
autorizzava l’uso della Forza pubblica (Carabinieri) per l’accertamento
sanitario obbligatorio hanno subito acceso dubbi sulla vicenda.
Che fine ha fatto
Carlo Gilardi: chi è, il patrimonio e la generosità
Carlo Gilardi ha una
pensione da insegnante, eppure tutta la vicenda che lo circonda sembra essere
incentrata su un ricco patrimonio. Infatti Gilardi nel 2017 ha ricevuto una
grossa eredità da parte della defunta sorella e questo, in seguito a una serie
di notevoli atti di generosità dell’uomo, potrebbe aver attirato l’attenzione di
terze persone interessate a mettere mani sul patrimonio.
Una sorella di
Gilardi ha così chiesto che l’uomo fosse affiancato da un amministratore di
sostegno per gestire il patrimonio ed evitare spese che, al di là della
generosità, potevano apparire come frutto di manipolazione. L’uomo non ha mai
dato segni di demenza e non ci sono prove nella sua cartella clinica che abbia
bisogno di un effettivo controllo, tanto che lui stesso denunciò la precedente
amministratrice di sostegno in più occasioni per avergli sottratto dei soldi.
Sottoposto a una
perizia psichiatrica da lui richiesta, Gilardi è risultato “con un pensiero
privo di alterazioni”, ma nonostante questo è stato trasportato contro sua
volontà in una Rsa.
Gilardi era stato
inserito all’interno della struttura in seguito alla decisione di un giudice e
della sua amministratrice di sostegno, Elena Barra. Sempre secondo Barra il
trattamento coatto era stato reso necessario perché Gilardi era “troppo
generoso” nei confronti della comunità. L’uomo aveva infatti permesso a chi non
aveva la possibilità di pagare un affitto di stare nella propria casa, aveva
donato diversi beni immobili e aveva anche donato al Comune un parcheggio e un
parco per i bambini. “Troppo generoso” o un tentativo di sfruttare il patrimonio
dell’uomo? Questo dubbio proveniva direttamente dalle lettere scritte da Carlo.
Il processo il 21
novembre
Il 21 novembre 2022
si svolgerà il processo a cinque persone accusate di aver raggirato Carlo
Gilardi per farsi dare soldi o case, tutte straniere. Alla sbarra: Abdelmalak
Rougui, 40 anni, marocchino, si sarebbe fatto prestare denaro, mai
restituito; Hichem Horroun, 45, algerino, sarebbe stato beneficiario di ingenti
somme; Khalifa Mejbri, 40 anni, tunisino, si sarebbe prestare 100mila euro per
beneficenza e per l’acquisto di un’auto; Nedal Abushunar, 49, Israele, in
carcere di Bollate per altra causa, avrebbe beneficiato in comodato d’uso di un
immobile e Abdellatif Ben Mustapha Hamrouni, 53 anni, tunisino, avrebbe ottenuto
soldi.
Il caso Gilardi in
Parlamento
I parenti di Carlo,
un gruppo di cugini, si sono rivolti all’avvocato Mattia Alfano e hanno fatto
ricorso alla Corte per i diritti dell’uomo, ricorso che è stato accolto.
La storia di Carlo
ha innescato un moto di solidarietà. La sua situazione è arrivata fino in
Parlamento e la premier Giorgia Meloni, che quando era deputata aveva presentato
un’interrogazione parlamentare, ha chiesto alle Iene di farle avere tutto il
materiale raccolto sul caso Gilardi per sottoporlo al ministero della Giustizia.
“Nessuno può
sostituirsi ad un altro nella presa di decisioni che riguardano la vita di
quell’altro” ha ribadito l’avvocato Michele Capano, presidente dell’associazione
diritti alla follia e a stabile questo concetto è l’Onu.
Davanti al malato psichico
che diventa assassino siamo senza difese.
Maddalena Bonaccorso il 28 Ottobre 2022 su Panorama.
I casi di ieri ad Asso e ad
Assago mostrano ancora una volta la pericolosità e l'imprevedibilità di queste
«mine vaganti» contro cui la sanità ha pochi strumenti
Una giornata drammatica,
segnata da due gravissimi episodi criminali che sembrano avere un unico punto in
comune: la follia, un forte disagio psichico alle spalle che sembrava superato e
probabilmente è stato sottovalutato. All’ipermercato Carrefour di Assago, il
46enne Andrea Tombolini ha ucciso a coltellate una persona e ne ha ferite
gravemente altre 5, con l’arma reperita nei corridoi dello stesso esercizio
commerciale. Nelle stesse ore ad Asso, in provincia di Como, il brigadiere
Antonio Milia, 57 anni, ha ucciso il suo comandante con la pistola d’ordinanza,
barricandosi poi in caserma per quasi tutta la notte, fino all’intervento
risolutore dei Carabinieri dei corpi speciali che l’hanno bloccato e
successivamente arrestato.
Nel passato di entrambi ci
sono gravi episodi psichiatrici che, alla luce dei fatti, avrebbero dovuto
essere meglio indagati: Milia era stato ricoverato nel reparto di Psichiatria
dell’ospedale Sant’Anna di Como, poi dimesso e dopo una lunga convalescenza
durata diversi mesi giudicato idoneo al servizio da una commissione
medico-ospedaliera. Tombolini, che durante l’interrogatorio di oggi ha
dichiarato che avrebbe voluto “farla finita” pensando di essere gravemente
ammalato, ma che poi, avendo visto “quelle persone felici” , ho provato invidia
e ha deciso di aggredirle, il 18 ottobre era stato medicato in un PS lombardo
per essersi inferto da solo delle ferite al volto e al cranio con dei pugni:
anche nel suo passato ci sono ricoveri psichiatrici ed era seguito pure da un
professionista privato. COME DIFENDERSI? RAFFORZANDO LA SANITA’ Episodi
inquietanti, che instillano in una popolazione già segnata da pandemia, guerra e
crisi economica, il timore di non essere adeguatamente protetta dalla follia
dilagante che rende pericoloso persino recarsi in un supermercato a fare la
spesa. Ma come possiamo difenderci da queste situazioni, che cominciano a essere
sempre più diffuse? “Possiamo difenderci rafforzando i servizi di salute
mentale” spiega il professor Leo Nahon, già direttore di Psichiatria
dell’Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano “destinando loro più risorse e più
tempo per l’ascolto dedicato, facendo diminuire lo stigma che si crea attorno
alla psichiatria: che non è solo una disciplina curativa, ma spessissimo anche
preventiva. Per ogni evento tragico come quelli riportati oggi in cronaca, ce ne
sono centinaia altrettanto gravi che vengono evitati quotidianamente da un buon
lavoro di prevenzione e cura che viene fatto nei servizi psichiatrici, che
peraltro lavorano oggi con risorse di personale ridotte ai minimi termini. Ma
questi eventi evitati, sia contro gli altri che contro se stessi, e che sono
tantissimi, non fanno notizia”. Si tratta anche in questo caso di sanità in
crisi, di risorse carenti, di medici e psichiatri che fanno il possibile e
riescono a evitare drammi nella maggior parte dei casi ma che sono comunque,
evidentemente, insufficienti per numero rispetto al fabbisogno. Sempre più sola
e abbandonata a sé stessa e ai deliri della propria mente, molto difficili da
indagare e comunque da non derubricare sempre e solo a episodi di depressione:
“È sbagliato etichettare questi casi come depressione” continua Nahon “I
rapporti tra depressione, paranoia e impulsività sono molto complessi ma anche
curabili, sia farmacologicamente sia con interventi psicosociali integrati che
rompano l’isolamento e diano sollievo dai fantasmi persecutori. Purtroppo in
questi disturbi, spesso, l’insufficiente consapevolezza di malattia, la tendenza
a celare una parte importante dei sintomi e la scarsa adesione alle cure rendono
molto più difficile la diagnosi e la terapia. Va aggiunto comunque che anche la
difesa sociale e la punizione del reato possono avere un valore terapeutico”. I
CAMBIAMENTI BIOLOGICI E L’INFLUSSO SULLA MENTE Una situazione sicuramente
complicata, dunque, nella quale si rischia anche che le persone interiorizzino
il pericolo e comincino a temere di svolgere anche le operazioni più semplici e
apparentemente innocue, con il timore di trovarsi accanto -in qualunque
condizione- una bomba pronta a esplodere: “E’ proprio cosi” , spiega Fabrizio
Mignacca, psicologo e psicoterapeuta “Anche perché è vero che le cosiddette mine
vaganti, purtroppo, sono più numerose di quanto si sia portati a pensare. Siamo
sempre insicuri, nei supermercati, nella metro, per strada: perché le malattie
mentali, anche se facciamo finta di non vederle, hanno un’enorme diffusione. Ci
sono poi sicuramente dei periodi critici, e queste persone esplodono: ora, a
parte la difficile situazione che viviamo tutti, appena usciti dalla pandemia e
ancora immersi nei venti di guerra e nella crisi economica, dobbiamo anche
tenere conto del fatto che il mese di settembre coincide con l’inizio della
nuova stagione biologica. L’anno biologico, infatti, non corrisponde con quello
solare: l’autunno, con le giornate che si accorciano, il freddo, il desiderio di
stare in casa e chiudersi all’esterno, acuisce sempre i disagi psichici e
mentali, ed è per questo che questi avvenimenti succedono quasi sempre a
cascata, a grappolo, in periodi definiti dell’anno”. INTERCETTARE I MALATI PER
CURARLI MEGLIO Le persone che hanno già problematiche psichiatriche molto
importanti, dunque, si rivelano particolarmente sensibili a questi cambiamenti.
E quando si innesca il corto circuito drammatico dello stravolgimento dei ritmi
e del non saperlo fronteggiare, in una situazione mentale già precaria, scoppia
la tempesta perfetta e avvengono questi drammi: “E per fortuna, la sanità, anche
se tagliata e massacrata da due anni di Covid” continua Mignacca “riesce ancora
a contenere il problema: infatti in Italia, rispetto a quanto succede in altri
Paesi, basti pensare agli USA, gli episodi di questo genere sono fortunatamente
molto meno frequenti. Questo accade perché il SSN è estremamente attento, riesce
a intercettare i casi e a bloccarli, anche se solo con la “sedazione”. Se ci
fossero più risorse, oltre che sedare si potrebbe curare efficacemente”.
E’ fuor di dubbio, però, che
quantomeno nel caso del brigadiere Milia, una Commissione medico-ospedaliera ne
avesse certificato l’idoneità al rientro in servizio dopo un lungo periodo di
disagio psichico, trascorso in parte in un reparto psichiatrico di un ospedale.
Come può essere successo? “Questo è davvero grave” conclude Mignacca “e rientra
nel campo delle responsabilità che andranno accertate. Io posso dire che è un
episodio rarissimo, perché le forze dell’ordine, peraltro, sono molto attente a
segnali di squilibrio e seguono i percorsi di cura e recupero con grande
precisione e attenzione. Può essere successo che si sia agito in questo modo –ma
le mie sono solo ipotesi perché nelle persone che hanno manifestazioni
psicotiche o psicopatiche, spesso il rientro nella normale aiuta il recupero. E
nella stragrande maggioranza dei casi questo modo di agire funziona molto bene.
Forse c’è stata una reale sottovalutazione del problema”.
"Ma chi soffre di disturbi
psichici di solito fa male solo a se stesso".
L'esperto: "Attacchi imprevedibili, solo il 3% attribuibili a malati mentali.
Sui pazienti servono analisi più attente". Marta Bravi il 29 Ottobre 2022 su Il
Giornale.
Claudio Mencacci, direttore
emerito di Psichiatria dell'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano e
co-presidente della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF) l'uomo di
46 anni che due giorni fa nel centro commerciale di Assago ha accoltellato 6
persone, uccidendone una, è stato descritto come una persona che viveva ritirata
dalla società, in casa con i genitori e che non è mia stato aggressivo.
«Sembra una condizione di
psicosi, con un aspetto di persecutorietà. Non posso fare una diagnosi ma la
cosa si manifesta con queste caratteristiche fatte dall'isolamento, ritiro,
poche amicizie, qualcosa che sposta il campo della psicosi più sul versante di
tipo persecutorio e paranoico».
I genitori dicono che da
quando è stato operato alla schiena ha iniziato a vedersi come gravemente
malato.
«Non sappiamo che idea della
malattia si sia fatto, se si sentisse danneggiato o invalido ma sono forme che
si definiscono dell'area psicotica e a volte correlate da aspetti allucinatori,
uditivi o imperativi. Siamo di fronte a un crescente discontrollo degli impulsi:
quando uno si autopercuote o passa alla violenza verso gli altri si tratta di
una condizione di discontrollo dell'impulsività. Non si capisce bene se chi è
attorno venga vissuto come qualcosa di fortemente minaccioso».
Si prendeva a pugni il volto,
ma in pronto soccorso non era stato in grado di spiegare il motivo del suo gesto
autolesionistico.
«Il fatto di essere preda di
questa impulsività e aggressività... le indagini stabiliranno se aveva
utilizzato anti inibitori come alcol o altro. È un luogo comune che le persone
che soffrono di disturbi mentali sono violente. Solo il 3 per cento degli atti
di violenza sono attribuibili a persone che soffrono di malattie mentali. Di
norma chi soffre di disturbi psichici è vittima piuttosto che carnefice».
Anche i genitori dicono non è
mai stato violento o aggressivo. Cosa prevede il protocollo nel caso di un
accesso al pronto soccorso per atto autolesionistico?
«C'è sempre una valutazione
della condizione fisica e della psicopatologia messa in atto, sulla scorta della
storia della persona, se c'è o meno abuso di sostanze... si valuta la gravità
delle condizioni. Non è che tutti quelli che commettono un atto autolesionistico
devono essere ricoverati, basti pensare alla quantità di adolescenti che si sono
presentati in pronto soccorso in questi 2 anni con lesioni da taglio o di chi ha
tentato il suicidio, in questi casi non si utilizza il ricovero ma la presa in
carico».
È automatica?
«No viene segnalata la persona
e poi viene avvisato il centro di riferimento».
Se non chiama?
«Quando viene data
un'indicazione di rivolgersi al centro è perché la persona possa ricevere le
cure adeguate e sono sempre di natura volontaria ad eccezione del Tso».
Qual è il rischio di passaggio
da un atto autolesionistico a un atto di violenza verso altri?
«Le persone tendono a farsi
del male tanto che nel nostro Paese si contano 4mila suicidi l'anno, di cui 1200
di giovani cioè sotto i 26 anni. Il passaggio alla violenza verso gli altri è
abbastanza raro».
Quali i campanelli di allarme?
«Il livello di irascibilità,
irritabilità e persecutorietà».
Venendo al caso di Asso, il
brigadiere che ha ammazzato il proprio comandante era stato ricoverato per
depressione ma giudicato idoneo.
«Il tema delle armi per le
forze dell'ordine è delicatissimo: se l'agente o il militare viene giudicato non
in grado di portare l'arma viene segnata gravemente la sua carriera. La
commissione giudica sulla base della documentazione specialistica che viene
fornita».
Cos'è sfuggito allora?
«L'elemento
dell'imprevedibilità che si può essere sovrapposto a una valutazione non attenta
di alcune situazioni».
Estratto dell'articolo di
Alessia Marani per “Il Messaggero” il 28 giugno 2022.
Una volta c'erano le perizie
psichiatriche che i componenti della Banda della Magliana si compravano per
passare dal carcere in clinica. Clamorosa fu l'evasione da Villa Gina dell'ex
boss Maurizio Abbatino che aveva ottenuto dal controverso professore Aldo
Semerari una relazione sul suo stato di salute mentale, tanto squilibrato sulla
carta da fargli evitare la galera ma altrettanto incompatibile con il profilo
del criminale di rango, astuto e intelligente quale Crispino - il Freddo di
Romanzo Criminale - era.
Passano gli anni, cambiano gli
stratagemmi. E ora per le mani dei giudici e del Dap, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, fioccano i certificati che attestano la
tossicodipendenza di una sempre più vasta, e sospetta, platea di
narcos-consumatori di droghe.
Malavitosi ambiscono alla
comunità quasi fosse un soggiorno in hotel: scelta la struttura, basta pagare la
retta. E i soldi non tardano ad arrivare.
La convinzione, avvalorata da
informative di polizia e carabinieri approdate in Procura, è che l'iscrizione al
Sert non sia altro che il primo passo per l'ottenimento di un lasciapassare che
garantisca, successivamente all'arresto, il pretesto (sfruttando la legge) per
chiedere la misura alternativa al carcere in una delle tante (meglio se già
collaudata) comunità di recupero.
«Ormai sono tanti, troppi, gli
esponenti della criminalità organizzata, anche in odore di mafia, legati a
ndranghetisti o a epigoni della Camorra che godono di questo beneficio -
denuncia Edoardo Levantini, presidente del Coordinamento antimafia di Anzio e
Nettuno, territorio di pesanti infiltrazione - circostanza che fa pensare a un
preciso sistema.
L'obiettivo? Continuare a
intessere relazioni, rapporti con altri pregiudicati e proseguire nei loschi
affari che rischiavano di essere interrotti, rafforzando con la presenza la
propria forza intimidatrice».
Nicola Graziano, il giudice
che si è internato in un Opg per vedere come vivevano i reclusi.
Enrico Bellavia su
L'Espresso il 9 maggio 2022.
Nel 2014 il magistrato è
andato in incognito per tre giorni nell’Ospedale psichiatrico giudiziario di
Aversa. «Non immaginavo che tre giorni potessero essere un’eternità».
Ha raccontato il magistrato
Dino Petralia, ex capo del Dap, il dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, che quando vinse il concorso, il suocero, avvocato penalista, gli
disse che «per ogni toga sarebbe utile vivere per qualche settimana la vita del
carcere».
Nicola Graziano, magistrato
del tribunale di Napoli, che vive ad Aversa dove ha sede l’Ospedale psichiatrico
giudiziario, lo ha fatto per davvero. Nel 2014, si è immerso per tre giorni in
incognito nell’inferno dell’ex Opg, internato volontario tra i detenuti malati e
a esaurimento. Insieme con il fotoreporter Nicola Baldieri ha realizzato un
documento tanto drammatico quanto intriso di profondissima umanità. “Matricola
zero zero uno”, si intitola (Giapeto Editori). La postfazione è di Franco
Corleone.
Quando Graziano intraprende il
viaggio è il momento in cui gli Opg stanno per cedere il posto alle Rems con le
attese tradite che L’Espresso ha documentato. Scrive: «Nella vita sono un
giudice ma per 72 ore sono un uomo che le difficoltà della vita e della mente
hanno condotto qua dentro. Non immaginavo che tre giorni potessero essere
un’eternità». La spinta a valicare il portone di Aversa è in una domanda: «Ma lì
ci vive la follia?». E l’unica risposta possibile appare «immedesimarsi e
confrontarsi». In definitiva è questa la molla di un’esperienza limite fatta di
incontri e di storie. Di solitudini, di dolore e di emozioni. E di un pugile che
spacca tutto ma non chiude occhio senza il suo peluche.
Luigi Ferrarella per
il “Corriere della Sera” il 3 giugno 2022.
Stavolta è ammesso tutto, pure
le lacrime di coccodrillo, ma la finta meraviglia almeno no. Perché G.T., il
21enne detenuto uccisosi con inalazioni di gas nel carcere milanese di San
Vittore, dove in una settimana anche il detenuto di 24 anni A.E.M. si era tolto
la vita, non soltanto aveva già tentato 15 giorni fa il suicidio, ma soprattutto
non sarebbe proprio dovuto stare in carcere.
E questo perché la diagnosi
delle sue condizioni mentali lo aveva destinato a una delle «Rems-Residenze per
l'esecuzione delle misure di sicurezza», subentrate nel 2014 alla sacrosanta
chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e però zavorrate da una lista
d'attesa - dieci mesi la media - di persone «non imputabili» (e perciò poi non
giudicabili nei processi per reati commessi in «incapacità di intendere e
volere»), ma al contempo «socialmente pericolose» a motivo dei propri disturbi.
Solo che le Regioni hanno tardato ad aprire le Rems (oggi sono 36), i posti
(652) restano sottodimensionati, i servizi territoriali arrancano, i centri
diurni dentro le carceri fanno quello che possono con la scarsità di psichiatri
e psicologi, i giudici non hanno per legge il potere di ordinare l'ingresso del
detenuto in una Rems, la lista d'attesa si gonfia.
E se la Corte Costituzionale
ha iniziato a farsi sentire a gennaio, sempre più spesso la Corte di Strasburgo,
attivata dai legali più incisivi, intima all'Italia di mettersi in regola e
l'Italia (come di recente in una offerta di risarcimento a un detenuto pur di
schivare la condanna di Strasburgo) promette di rimediare ma intanto riconosce
di stare violando l'articolo tre della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo. E ogni volta - al netto dei volonterosi tentativi di arrangiarsi,
oggetto lunedì di un convegno di «Area» in Tribunale a Milano tra magistrati,
avvocati e psichiatri - parte così un vorticoso carteggio tra
Procure-Rems-ministeri-Regioni, ciascuno in cerca del pezzo di carta che
formalmente lo esenti da responsabilità. Sia quando, nel limbo di 750 persone
che restano in libertà benché dichiarate socialmente pericolose, qualcuno
aggredisce un passante per strada; sia quando invece, nel limbo di 60 persone
che in lista d'attesa restano tacitamente ma illegalmente in cella, qualcuno si
uccide. Come il 21enne di San Vittore, che da ottobre 2021 a San Vittore non
doveva stare.
Nelle carceri
italiane sono rinchiuse almeno sessanta persone con disturbi mentali: ma la
legge lo vieta.
Dovrebbero essere ospitate nelle
Rems e curate, ma i posti sono pochi e così almeno sessanta pazienti (ma
probabilmente molti di più) finiscono nei penitenziari ordinari. Malgrado le
denunce della Corte costituzionale. Ecco perché il sistema non funziona. Glora
Riva su L'Espresso il 2 Maggio 2022.
Per due anni
Giacomo Seydou Sy, 28 anni, italiano, con problemi psichiatrici, è stato
trattenuto illecitamente nel carcere romano di Rebibbia. Un fatto grave, tanto
che a gennaio è piovuta sull’Italia la condanna della Corte Europea dei diritti
dell’Uomo. Giacomo Seydou Sy è affetto da disturbo bipolare e della
personalità e nel 2019 è stato accusato di molestie all’ex fidanzata, resistenza
a pubblico ufficiale, percosse e lesioni.
I malati
psichiatrici in cella o legati: l’Italia è rimasta a cinquanta anni fa.
Lirio
Abbate su L'Espresso il 29 aprile
2022.
L’Espresso torna
a denunciare il degrado delle condizioni dei pazienti reclusi: una situazione -
illegale - di cui parliamo ormai da decenni. Che ancora una volta la Corte
Costituzionale ha sanzionato, chiedendo al Parlamento una riforma urgente
Nel carcere di
Pescara, in quello di San Vittore a Milano, e a Rebibbia e Regina Coeli a Roma
ci sono dei “repartini” in cui sono chiusi una decina di pazienti. Molti di loro
sono segregati in celle singole o massimo di due persone. E poi in altre
strutture ci sono i malati che in piena crisi vengono contenuti nel letto,
legati mani e piedi per impedire di far del male a sé o agli altri.
La sentenza della Consulta.
Cosa sono i Rems e perché la vera riforma è cancellare il Codice Rocco.
Franco Corleone su
Il Riformista il 30 Gennaio 2022
La sentenza 22 del 27 gennaio
2022 della Corte Costituzionale, redattore Francesco Viganò, sulla questione
delle Rems e del superamento degli Opg è di grande valore e pone in maniera
ineludibile questioni di importanza strategica. Vengono messe in luce
contraddizioni nelle norme che hanno sostanziato una scelta rivoluzionaria, la
chiusura del manicomio giudiziario che io ho definito subito una rivoluzione
gentile, ma contemporaneamente emergono contraddizioni nella ricostruzione della
vicenda e nella prospettazione di un intervento legislativo correttivo.
È fondamentale e costituisce
un punto fermo la dichiarazione di inammissibilità delle questioni poste dal
giudice di Tivoli per aberratio ictus, relativamente agli articoli del Codice
Penale 206 e 222, ma anche rispetto alle questioni relative alla legge 9, alla
luce dei risultati emersi dall’istruttoria deliberata dall’Ordinanza n.
131 del 24 giugno 2021 che chiedeva al Governo una relazione di chiarimento su
quattordici punti. La Corte esplicita con nettezza che una dichiarazione della
norma contestata avrebbe comportato la caduta integrale del sistema
delle Rems «che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile processo
di superamento dei vecchi Opg e produrrebbe non solo un intollerabile vuoto di
tutela di interessi costituzionalmente rilevanti», ma anche un aggravamento
delle difficoltà denunciate sulla efficienza del sistema.
Tutto bene dunque? Non
proprio, perché la Corte suggerisce dei correttivi sostanziali e richiama
l’attenzione sul fatto che «non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi
dell’inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati nella
pronuncia». Infatti la Corte Costituzionale conferma la nuova linea adottata di
dare indicazioni di modifiche legislative al Parlamento, in alcuni casi con
tempi ultimativi, e indica la necessità di definire un’adeguata base legislativa
alla nuova misura di sicurezza, la realizzazione e il buon funzionamento,
sull’intero territorio nazionale, di un numero di Rems sufficiente a far fronte
ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente
potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi
alternativi adeguati rispetto alle necessità di cura e di quelle, altrettanto
imprescindibili, di tutela della collettività e dunque dei diritti fondamentali
delle potenziali vittime dei reati che potrebbero essere compiuti dai soggetti
sottoposti alle misure di sicurezza perché socialmente pericolosi e infine in un
adeguato coinvolgimento del Ministro della Giustizia nell’attività di
coordinamento e nel monitoraggio del funzionamento delle Rems esistenti e degli
altri strumenti di tutela della salute mentale attivabili nel quadro della
diversa misura della libertà vigilata.
La Corte è perentoria
nell’affermare che il ricovero in una Rems, per come è concretamente configurata
nell’Ordinamento, «non può essere considerata come una misura di natura
esclusivamente sanitaria», perché la misura di sicurezza è strettamente legata
alla pericolosità sociale, seppure presunta. L’incapacità di intendere e volere
al momento del fatto, attraverso il proscioglimento si riverbera dunque sul
presente e sul futuro, con una incapacitazione permanente che si salda con la
affermazione di possibilità della reiterazione del reato. Evidentemente scoppia
l’insostenibilità denunciata già ora di un ruolo ambivalente di cura e custodia.
La Corte condivide con assoluta chiarezza la scelta del superamento dell’Opg e
dell’abbandono di una logica custodialistica, ma lega la finalità terapeutica a
una tutela della sicurezza delle vittime.
È anche decisivo il giudizio
sulla essenzialità dei principi cardine della territorialità e del rispetto del
numero chiuso e in particolare del numero ottimale di 20 ospiti, come anche
l’affermazione che non spetti alla Corte individuare la ragione della lunga
lista d’attesa per l’ingresso in Rems. In ogni caso viene espresso un ventaglio
di responsabilità che illuminano la realtà, dalla insufficienza dei posti
disponibili a un eccesso di provvedimenti di assegnazione alle Rems da parte
dell’autorità giudiziaria in conseguenza di una diffusa mancata adesione al
nuovo approccio culturale sotteso alla riforma e al non rispetto
dell’indicazione di extrema ratio, dalla assenza sul territorio di soluzioni
alternative per salvaguardare le esigenze di salute del singolo e di sicurezza
pubblica, al mancato esercizio di poteri sostitutivi: nomina di un commissario
nei confronti delle regioni in difficoltà. La Corte Costituzionale invita a una
decisione.
Che fare? Ci sono due strade
alternative. Subire le indicazione della Corte intervenendo sulla legge
81 (magari eliminando la possibilità di ingresso in Rems per le misure di
sicurezza provvisorie) con il rischio di consolidare una soluzione di
piccoli Opg (ma bisognerebbe abbattere il bubbone di Castiglione delle
Stiviere con i suoi 160 posti) e la conferma del doppio binario del Codice
Rocco o mettere in campo la grande riforma radicale di eliminare la non
imputabilità e stroncare alla radice le attuali contraddizioni. Discutere quindi
la proposta 2939 presentata alla Camera dei Deputati da Riccardo Magi che ha
raccolto l’elaborazione proposta dalla Società della Ragione e da molte altre
associazioni e movimenti che scioglie i nodi legati a vecchi principi e afferma
nuove categorie legate alla legge 180 per cui la libertà è terapeutica.
Il senso è chiaro: «Scegliamo
la via del giudizio per le persone affette da gravi disabilità psicosociali, non
per arrivare a una pena dura o esemplare, ma per riconoscere la loro dignità di
soggetti, restituendo la responsabilità – e con ciò la possibilità di
comprensione- delle loro azioni; e risparmiando lo stigma che il verdetto di
incapacità di intender e volere e l’internamento recano con sé». Franco Corleone
La sentenza della Cedu. Le
carceri non sono luoghi di cura, ma non serve invocare più Rems.
Michele Miravalle su Il
Riformista il 27 Gennaio 2022.
Chi si occupa della questione
della cura/controllo delle persone con patologia psichiatrica autori di reato
(i folli-rei, li definisce il linguaggio novecentesco del codice penale) sapeva
che il 2022 si sarebbe aperto con almeno tre decisioni importanti: due
della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, il caso Sy e il caso Ciotta, e una
della Corte Costituzionale, a seguito dell’Ordinanza 131/2021 su impulso della
questione sollevata dal giudice di Tivoli. Lunedì è arrivata la prima delle tre
decisioni (Sy contro Italia), le altre sono attese a stretto giro. Nel merito,
ci sono alcune differenze, ma sarà opportuno leggere i tre provvedimenti con uno
sguardo “politico”, per capire che impatto avranno e quali sono gli interventi
di indirizzo che vanno messi in campo.
Il tema è “fare un tagliando”
al percorso di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, capendo ciò
che ha funzionato, ed è molto, e ciò che invece va corretto. È stato un percorso
tortuoso, iniziato con la riforma della sanità penitenziaria nel 1999 e passato
attraverso la vergogna pubblica delle immagini di degrado e abbandono girate nei
sei Opg italiani dalla Commissione d’inchiesta del Senato nel 2012. Concluso
solo nel maggio 2017 con la chiusura degli “ultimi manicomi” italiani, in
applicazione della legge 81/2014. Un percorso che ha portato alla creazione di
una trentina di residenze sanitarie (le Rems), capillarmente diffuse sul
territorio e con un limite massimo di venti posti fissato per legge. I dati
ufficiali – confusi e difficilmente accessibili – parlano di circa 550 persone
ricoverate nelle Rems (pari al numero massimo di posti disponibili). Al di fuori
delle Rems, ci sono poi quasi 4.000 persone sottoposte a misure di sicurezza non
custodiali, su tutte la “libertà vigilata” che si svolge principalmente in forma
residenziale nelle molte comunità che costellano il territorio italiano.
Ma la riforma ha inciso su due
punti fondamentali: da una parte ha reciso la cinghia di trasmissione che
collegava il carcere alle misure di sicurezza. Oggi, dunque, nel sistema delle
misure di sicurezza non si possono più “scaricare” le persone dichiarate capaci
di intendere e volere, le cui condizioni psichiche si aggravano durante la loro
detenzione. Queste persone devono essere “gestite” in carcere o affidate ai
servizi di salute mentale del territorio, che sono però spesso refrattari, per
molte ragioni, ad accogliere paziente provenienti dal circuito penale.
Dall’altra parte, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il
sistema del “numero chiuso”. Un principio tanto banale, quanto rivoluzionario:
il numero di ospiti in Rems non può mai derogare la capienza massima e dunque le
Rems non possono essere “sovraffollate”. Ciò ha prodotto una “lista di attesa”
di persone che attendono di essere ricoverate in Rems. I casi più critici, sono
coloro che trascorrono questa attesa in carcere. Su quanti siano e come vengano
gestite dalle singole Regioni e Aziende sanitarie le liste d’attesa c’è poca
chiarezza: poche decine o centinaia? Le informazioni divergono a seconda delle
fonti e questo non aiuta la comprensione.
Sono queste, in estrema
sintesi, le due questioni su cui la Cedu è intervenuta e su cui la Corte
Costituzionale è chiamata a fare chiarezza. Il futuro dunque deve partire da due
principi ineludibili, di diritto e di umanità. Il primo, le carceri non sono
luoghi di cura per la presa in carico di patologie psichiatriche gravi, vanno
dunque immaginati nuovi modelli per la salute mentale, in stretto contatto con i
servizi territoriali. È quello che vediamo tutti i giorni durante le visite
dell’Osservatorio sulle condizioni detentive. Anche la gestione ibrida – un po’
carceri, un po’ luoghi di cura – di sezioni “speciali” per pazienti
con patologie psichiatriche diventa, nei fatti una soluzione che enfatizza gli
aspetti punitivi a scapito di quelli terapeutici. Se davvero “servono” luoghi
dentro le mura del carcere dove promuovere la salute mentale, come ribadiscono
ad ogni livello gli operatori penitenziari, allora occorre immaginare soluzioni
del tutto nuove. L’esperienza delle sezioni “a custodia attenuata” per madri
detenute o per il trattamento delle tossicodipendenze possono diventare esempi
da imitare?
Il secondo principio è che
le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) devono essere
luoghi di “passaggio”, uno dei luoghi dove il paziente psichiatrico autore di
reato può essere destinato, ma non l’unico. Esistono altre soluzioni, di tipo
comunitario o residenziale, che vanno prese in considerazione. Questo significa
non rassegnarsi alla “istituzionalizzazione” e a ricoveri molto lunghi, con
continui passaggi da un luogo all’altro (Rems, comunità e ritorno). È un
principio cardine della riforma, ma che fatica ad essere messo in pratica dai
giudici, soprattutto per mancanza di dialogo con i servizi di salute mentale. Il
peggio che può avvenire alla luce di queste tre decisioni delle Alte Corti, è
limitarsi a dire “servono più Rems”. Sarebbe un errore grave ed un’occasione
mancata, che non salverebbe il Paese da ulteriori condanne. Michele Miravalle
Una laurea, un tirocinio. E
la speranza di un futuro. “Le nostre storie di riscatto di reclusi nelle Rems”.
Erika
Antonelli La Repubblica il 19 Maggio 2022.
L’Espresso ha dedicato una
lunga inchiesta alle condizioni delle strutture che hanno sostituito i manicomi
criminali. Ma ci sono anche esempi virtuosi
Andrea, 25 anni, nome di
fantasia, soppesa ogni parola prima delle domande impegnative. Un silenzio
lungo, poi risponde. «Come mi sento qua dentro? Sulle montagne russe. Appena
esco vorrei costruire una mongolfiera». Parla la sua «parte più sognatrice»,
quella pratica invece gli suggerisce di trovarsi un lavoro e farsi una famiglia.
Un passo alla volta, lentamente. Perché Andrea è uno dei 20 pazienti della Rems
di Bra, in provincia di Cuneo, Piemonte. Le Rems sono strutture sanitarie in cui
sono ricoverati gli autori di crimini gravi considerati pericolosi per la
società.
Nascono con l’obiettivo di
curare la fase acuta della malattia e riabilitare il paziente attraverso un
percorso di terapia e assistenza psicosociale. Che hanno portato Andrea, in
attesa del processo per un fatto-reato commesso nel 2020, a riprendere gli
studi.
«Appena arrivato non ero molto
convinto. Mi mancava solo la laurea, gli esami li avevo finiti. L’ho fatto per
me stesso e per la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto. È stato il mio modo
per restituirgli almeno in parte quel che mi ha dato». Si è laureato in Scienze
dell’informazione poche settimane fa, con una tesi sull’analisi del sentiment
sui social media. Affiancato dall’educatrice e dalla psicologa, con la
collaborazione della sua relatrice. La tesi scritta in struttura, ogni giorno
dalle 13 alle 16, la fascia oraria in cui ai pazienti è consentito l’accesso a
internet. «È stato impegnativo, qui dentro si vivono alti e bassi, il morale va
giù anche per piccole cose. Ma nei momenti in cui ero più scoraggiato trovavo
l’energia ricordandomi per chi lo stavo facendo. Non escludo di prendere anche
la magistrale. Riguardando la mia storia, forse in psicologia».
L’inserimento nelle Rems,
spiega Grazia Ala, psichiatra nella struttura dove Andrea è detenuto, «deve
essere l’ultima ratio». La scelta si prende qualora non ci siano misure
alternative a gestire la situazione del paziente, ritenuto socialmente
pericoloso e non imputabile perché parzialmente o totalmente incapace di
intendere e di volere al compimento del fatto-reato. «I loro percorsi
riabilitativi - prosegue Ala - devono favorirne il ritorno sul territorio. Nella
stragrande maggioranza dei casi significa che l’uscita avviene in modo graduale
e passa attraverso la permanenza in una comunità». Non è un passaggio
obbligato, una piccola parte dei pazienti fa rientro al domicilio, ma è
un’opzione poco frequente perché sono spesso autori di reati contro i familiari.
Medici e operatori lavorano
per decostruire lo stigma che pesa sulla testa di ogni persona che hanno in
cura. «Non dobbiamo mai stancarci di forzare i muri legati alla non conoscenza,
al timore, al fatto che in queste situazioni si intersechino due topoi, quello
del “cattivo” e del “folle”. I nostri pazienti sono gravemente malati e in una
società civile hanno il diritto di essere assistiti», dice la dottoressa Ala.
Quei muri si forzano portando fuori le persone chiuse dentro, impegnandole in
attività artistiche e teatrali. Andrea ha scoperto di amarle, «al teatro devo
molto perché suscita emozioni e crea normalità», racconta. Se non è impegnato
con gli spettacoli, passa il pomeriggio a disegnare o leggere. Soprattutto
poesie. Le ultime, quelle de “Il canto degli alberi” di Hermann Hesse.
Anche Serghei, 26 anni, altro
nome di fantasia, amante del calcetto e abile preparatore di tiramisù, ha
scoperto di avere una vena artistica. L’ha unita a una sua vecchia passione,
quella per i fiori, e così ha già pronta l’idea da realizzare per la mostra di
luglio. «Porterò una pianta. Sarà al buio, coperta da un contenitore. In cima la
scatola avrà dei piccoli fori da cui passa la luce, uno per ogni sensazione di
libertà. Quella pianta sono io e metterò un foro per ogni cosa che mi piace
fare. Uno per le attività, uno per le uscite, un altro per il lavoro». Da pochi
giorni Serghei, in struttura da sette anni, ha infatti iniziato un tirocinio
retribuito in un’azienda che produce vini. Lavora tutte le mattine, impegnato in
attività di magazzino e a etichettare bottiglie. «Per il futuro nessun programma
preciso, solo il bisogno di dare sempre il meglio sul posto di lavoro. Mi
piacerebbe rimanere nell’azienda in cui sono adesso e guadagnare per avere la
mia indipendenza economica».
La Rems di Bra esiste dal
2015. «Le iniziative che organizziamo ci permettono di far capire ai cittadini
che non siamo un problema per la loro sicurezza. I primi mesi avevano paura, il
malato di mente autore di reato rappresenta la massima espressione di pericolo.
Poi le cose sono migliorate», dice Luca Patria, psichiatra e collega della
dottoressa Ala. Che aggiunge: «Le persone che arrivano qui hanno un enorme
carico di dolore e lo portano con sé fin da piccolissime, quando dovevano essere
protette. La causa della malattia non è tutta lì. Ma in quella condizione,
spesso unita alla miseria materiale e morale, si rischia di rimanere impigliati
se non si è biologicamente preparati a lasciarsela alle spalle in cerca del
riscatto». Ed è da quelle catene che Andrea e Serghei stanno provando a
liberarsi. Un passo alla volta, lentamente.
·
Figli di Trojan.
Gogna o strumento
d’indagine? È lite sulle intercettazioni.
Il no dei magistrati
al piano del guardasigilli: «Sono indispensabili». Esultano i penalisti:
«Finalmente se ne discute». Valentina Stella Il Dubbio il 9 dicembre 2022.
Il tema delle
intercettazioni continua ad essere terreno di scontro tra una parte della
politica e la magistratura. Abbiamo raccolto il parere di Rossella Marro,
presidente di Unicost: «In materia di intercettazioni va sgomberato il campo da
un primo equivoco, ossia che in Italia in modo ingiustificato se ne facciano
molte di più che in altri Paesi.
L’Italia infatti ha
purtroppo il primato delle organizzazioni criminali di stampo mafioso
(ndrangheta, sacra corona unita, camorra, mafia) ed il contrasto alle
organizzazioni criminali, così come a qualunque altra forma di reato
associativo, è possibile soprattutto grazie alle intercettazioni. Anche il
fenomeno della concussione o corruzione assume contorni allarmanti ed anche in
questi casi lo strumento delle intercettazioni è indispensabile».
Premesso ciò, Marro
prosegue: «Condividiamo pienamente la preoccupazione del ministro per le
indebite diffusioni di intercettazioni riguardanti anche aspetti di nessun
interesse pubblico che tuttavia stravolgono la vita di persone che fino a prova
giudiziaria contraria sono innocenti. La gogna mediatica è un fenomeno da
contrastare e, sotto questo profilo, è meritorio mantenere sempre alta
l’attenzione». Ma si tratta «di un aspetto diverso che nulla ha a che vedere con
la indispensabilità dello strumento investigativo. Sul tema della diffusione
peraltro di recente è intervenuta una disciplina molto restrittiva in attuazione
di una direttiva della Comunità europea, che ha proprio la finalità di
assicurare la riservatezza e la tutela della dignità delle persone coinvolte a
vario titolo nelle intercettazioni. Occorre verificare sul campo l’efficacia
della nuova normativa». È in ogni caso «ingeneroso» attribuire ai magistrati «la
responsabilità della diffusione perché spesso proprio i magistrati “subiscono”
le fughe di notizie da altri provocate. Le intercettazioni infatti sono
necessariamente nella disponibilità di diverse persone che potrebbero avere
interesse ad un eventuale uso strumentale delle stesse».
Altre riflessioni ci
arrivano da Eugenio Albamonte, segretario di AreaDg, a partire dal sostegno di
Nordio alle intercettazioni preventive: «Mi pare chiaramente contraddittorio con
la sua reclamata appartenenza culturale di tipo liberale perché, in realtà, esse
sono sostanzialmente fuori dal circuito giudiziario. Vengono sì autorizzate dal
procuratore generale ma, innanzitutto, non c’è una autorizzazione di un giudice
come quelle ordinarie. Poi, soprattutto, la grande differenza tra quelle
ordinarie e quelle preventive è che queste ultime rimangono per sempre segrete.
Neanche l’interessato, ex post, verrà mai a sapere di essere stato intercettato.
E non verrà neanche a sapere che quelle intercettazioni contengono elementi
della sua vita privata. Invece oggi, grazie alla legge Orlando, si può ottenere,
a posteriori, la distruzione delle intercettazioni non rilevanti per le
indagini. Mi sembra singolare che il ministro non colga la differenza tra questi
due meccanismi, proprio sul piano delle garanzie».
Nordio ha riportato
degli esempi di persone, anche magistrati, la cui vita è stata rovinata dalle
intercettazioni. «Ma questi episodi fanno parte del secolo scorso», ricorda
Albamonte che continua: «Nel frattempo è cambiata la legge. La disciplina
Orlando prevede che quelle non rilevanti vengano già controllate e custodite
sotto la responsabilità anche disciplinare del procuratore della Repubblica.
Quindi non capisco a cosa faccia riferimento Nordio». Per il pubblico ministero,
«questo tema, come diversi altri, è trattato dal ministro in modo pretestuoso
per solleticare le aspettative di una certa parte della maggioranza politica –
mi riferisco a Forza Italia che ne ha sempre fatto un cavallo di battaglia – e
di un segmento di opinione pubblica, che teme le intercettazioni». Anche perché,
conclude Albamonte, «ho sentito esponenti del Governo sostenere in televisione
che le intercettazioni non verranno toccate per i reati di mafia e terrorismo,
pedopornografia, prostituzione e tratta di esseri umani. Stringi, stringi a me
pare che non si abbia il coraggio di dire chiaramente quale sia l’obiettivo
perseguito: eliminare le intercettazioni per i reati di concussione e
corruzione».
È «importante»
invece per Eriberto Rosso, segretario dell’Unione Camere penali, «che si torni a
discutere della disciplina delle intercettazioni ed è un bene che il ministro
Nordio abbia riconosciuto come il bilanciamento tra poteri di investigazione e
diritti fondamentali della persona nel nostro sistema processuale sia pessimo».
Rosso ricorda che «nella scorsa Legislatura si è mandata al macero la riforma
Orlando, che pure qualche freno alle intercettazioni e alla loro divulgazione
aveva previsto, e si è adottata una disciplina ben poco garantista che prevede
il sostanziale via libera all’uso del trojan».
Infine «è utile
ricordare a coloro che ancora oggi – sempre con il solito refrain della lotta
alla criminalità organizzata – paventano l’impunità per i criminali che, con la
legge n. 7 del 2020 e con la foglia di fico di due aggettivi, si sono in un sol
colpo superati gli stessi limiti che la Corte di Cassazione aveva individuato
prima con le Sezioni Unite Scurato e poi con la sentenza Cavallo. La fotografia
dell’oggi sono i fenomeni della cosiddetta “pesca a strascico” per la ricerca
del reato e non della prova». Mettere mano alle intercettazioni «servirà
finalmente a ribadire che le comunicazioni tra difensore e indagato non debbono
essere non solo utilizzate ma neppure ascoltate».
Aggiotaggio
giudiziario. Le riforme di Nordio, le indagini sulla Juventus e il problema
tutto italiano dell’inquinamento delle informazioni.
Cataldo Intrieri su
L’Inkiesta il 9 Dicembre 2022.
Le proposte del
Guardasigilli, non così garantiste come sembrano, sono state bocciate dal solito
circo giornalistico-giudiziario, proprio mentre i giornali riportano
intercettazioni sul club bianconero diffondendo solo le tesi dell’accusa. Una
vera piaga, mai risolta, della nostra democrazia
Il
Guardasigilli Carlo Nordio ha esposto alla Commissione giustizia della Camera
una sorta di personale “libro dei sogni” in cui sono contenute quelle “riforme
minime” – dalla separazione delle carriere alle intercettazioni, al rispetto
concreto ed effettivo del principio di legalità – che sarebbero appunto il
“minimo sindacale” per un paese degno di qualificarsi come governato come uno
stato di diritto.
Per questo motivo,
l’ex magistrato veneziano ha subito il solito trattamento che il partito
giornalistico delle procure riserva a chiunque osi mettere sul tavolo questi
temi, vale a dire un indifferenziato pestaggio mediatico e la “fatwa” dei
giustizialisti nostrani.
Da ultimo,
l’immancabile Gustavo Zagrebelsky ha unito in un unico tratto le critiche al
presidente della Repubblica, a Bankitalia e alla magistratura come un
complessivo disegno d’assalto alle istituzioni di garanzia mosso dalla destra
italiana.
Chi scrive ha avuto
modo, su questo giornale, di esprimere la personale diffidenza nei confronti del
nuovo Guardasigilli, in particolare sottolineando come la sua visione sia
sostanzialmente autoritaria perché, a fronte di massime garanzie per i
“galantuomini” nel processo, egli sostiene massimo controllo e chiusura nella
fase di prevenzione dei crimini e di esecuzione della pena.
Dunque, per Nordio,
le intercettazioni sono da restringere come fonte di ricerca della prova durante
l’indagine, ma vanno invece abbondantemente usate prima e a prescindere da ogni
controllo giudiziario di legalità come strumento di contrasto sociale alla
criminalità.
Così il ministro
della Giustizia teorizza che le forze di polizia, in segreto e senza controllo
della stessa magistratura, e senza mai darne pubblico conto, possano
intercettare i sospetti di ipotetiche illecite attività ancora da accertare. Un
modello di stampo ungherese da rigettare in toto.
Nessuna misericordia
inoltre per i condannati, con qualche rara eccezione per i responsabili di reati
minori. In questa visione, come dimostra il recente decreto anti-rave, i “ladri
di Stato” corrotti e corruttori sono equiparati a mafiosi e trafficanti, per cui
nessuna alternativa vi può essere al marcire nelle più vergognose carceri
europee.
Per questa idea di
giustizia chi scrive non ha nessuna simpatia, al contrario delle
tante cheerleader di Nordio tra insospettabili organi di stampa e politici
sedicenti garantisti.
Tuttavia il vero
scandalo è lo squadrismo mediatico che si abbatte su chi osa toccare i fili, a
partire dalla famosa e “limacciosa” commissione bicamerale di Massimo D’Alema di
fine millennio.
In ragione di ciò, a
oggi è problematico finanche eleggere i membri laici per il Consiglio superiore
della magistratura dove concorrono personaggi che la magistratura non ama come
gli avvocati Gaetano Pecorella e Mauro Anetrini, garantisti e pure autorevoli e
per questo invisi alle toghe.
Tuttavia il vero
problema non è solo una magistratura arroccata sui suoi privilegi, bensì una
diffusa sottocultura che la protegge e accompagna nei suoi vizi, magari per
interessi di bottega.
Il mercato delle
intercettazioni indiscriminatamente pubblicate sulla stampa, ad esempio, non è
una fisima di Nordio ma una piaga reale che inquina la democrazia.
Tramite esso si
colpisce un principio di civiltà come la presunzione di innocenza vanamente
ribadito da una legge di recente introdotta in mezzo agli strepiti del partito
filo-procure dei Travaglio, Bianconi, Bonini e Giannini e non se ne abbiano a
male alcuni destinatari (“Amicus plato sed magis veritas…”).
La legge impone ai
magistrati la prudenza e la riservatezza sulle indagini, una cosa ovvia, ma non
impedisce di surrogare le vecchie conferenze stampa di pm e carabinieri con
estesi editoriali sui giornali amici. E dunque basta passare le carte per avere
le solite vecchie sentenze anticipate di condanna.
Tale sorte accomuna
potenti e cittadini comuni, cardinali, imprenditori e vecchi pregiudicati, dagli
Agnelli a Massimo Carminati.
Ultimamente è
capitato anche ai proprietari di Gedi, il più importante gruppo editoriale
italiano, a proposito del procedimento penale che coinvolge una delle loro più
rilevanti partecipazioni, la Juventus, di cui va evidenziato un curioso quanto
significativo episodio.
Raccontano le
cronache che Cristiano Ronaldo, ex calciatore bianconero negli anni oggetto di
indagine, abbia fatto richiesta di accesso agli atti del processo che sono stati
depositati per le parti al termine delle indagini, quale soggetto interessato.
Richiesta
legittimamente respinta perché il contenuto del fascicolo, ancorché non più
coperto dal segreto d’indagine, non può comunque essere pubblicato almeno fino
al termine dell’udienza preliminare e la copia dei singoli atti addirittura sino
al processo vero e proprio a norma dell’articolo 114 del codice di procedure
penale.
Il punto è che
invece le gazzette hanno riportato pezzi interi di intercettazioni, alcune con
soggetti non coinvolti e hanno diffuso le tesi dell’accusa.
Quasi nessuno ha
illustrato le ragioni della difesa e ha correttamente spiegato che l’unica volta
in cui è intervenuto un giudice “terzo e imparziale” ha dato torto all’accusa
non solo respingendo la solita richiesta di misure cautelari ai danni dei
principali imputati, ma addirittura ponendo in dubbio la rilevanza penale delle
strombazzate plusvalenze che costituiscono la polpa delle accuse di falso in
bilancio e aggiotaggio informativo.
Stiamo parlando di
una società quotata in Borsa ma lo stesso discorso ormai è ricorrente in
svariati casi. L’aggiotaggio e l’inquinamento dell’informazione giudiziaria sono
un grosso problema di democrazia non ancora risolto e duro a morire.
"Anm fuori dalla
realtà. È cambiato il clima: Nordio non è Mastella".
L'ex magistrato: "Il
ministro è inattaccabile. E ora tutti censurano le toghe politicizzate". Luca
Fazzo l’8 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Il nuovo ministro
della Giustizia Carlo Nordio ci ha messo solo quarantadue giorni per scatenare
le ire dell'Associazione nazionale magistrati. E adesso cosa accadrà?
Cercheranno di silurarlo per via giudiziaria?
«In passato è
accaduto spesso - risponde Luca Palamara, che dell'Anm è stato a lungo il
potente presidente - che ministri della Giustizia pagassero cara la
contrapposizione alle correnti. Basti pensare a quanto accadde al ministro
Clemente Mastella. Ma stavolta la vedo dura. Il profilo professionale di Nordio,
uno che ha fatto per tutta la vita il pubblico ministero, lo rende difficilmente
attaccabile».
Non è paradossale
che a entrare quasi immediatamente in rotta di collisione con le correnti delle
toghe sia il primo Guardasigilli che viene proprio dalle fila delle Procure?
«Me lo spiego
semplicemente col fatto che ormai ci sono problemi divenuti a tal punto
patrimonio comune dell'opinione pubblica che non è più possibile nascondersi
dietro una foglia di fico. Nordio ha avuto il coraggio di mettere sul tavolo
emergenze che, fuori dall'ipocrisia, sono vissute come tali dall'intera società
civile italiana. Proprio perché ora provengono da uno che ha fatto per tutta la
vita il pm sarebbe il caso che anziché ricorrere alle solite, stereotipate
invettive l'Anm affrontasse serenamente i problemi che ha posto. Aggiungo:
sarebbe il caso che a rispondere a Nordio fossero persone qualificate e non
soggetti che puntano senza titolo a qualificarsi come grandi giuristi. Parlo
ovviamente di alcuni giornalisti».
In passato, Cartabia
compresa, la scena era sempre la stessa. Arrivava un nuovo ministro, annunciava
riforme più o meno epocali, le correnti dei giudici ruggivano e la riforma
finiva in niente o quasi. L'Anm di oggi ha ancora il potere di fermare Nordio?
«Tutto quello che è
accaduto ha inciso in profondità nel tessuto connettivo della magistratura
italiana. La magistratura non è più quella di dieci anni fa, non siamo più
all'epoca delle corazzate antiberlusconiane. La politicizzazione della
magistratura è vista come un male dalla grande parte della magistratura, anche
se l'Anm cerca disperatamente di riproporre le stesse parole d'ordine di sempre.
Ancora più incredibile è che a farlo sia l'attuale presidente dell'Associazione,
che prima era il capo dell'ufficio legislativo del ministro di centrosinistra e
che mischia i due ruoli in maniera clamorosa».
L'altro giorno
all'assemblea di Area, la corrente dei giudici di sinistra, si sentivano cose da
anni Settanta. Il governo di centrodestra è stato accusato di volere «un
ridimensionamento del modello costituzionale di magistrato», di lavorare
«all'idea di un pubblico mistero sempre più compresso e sacrificato».
«Ci sono pezzi della
magistratura refrattari a qualunque maturazione, decisi a portare avanti fino
alla fine l'idea che schierarsi politicamente sia un diritto e anzi un dovere.
Sono tagliati fuori dalla realtà».
A mettere Nordio
sotto tiro è stato soprattutto il suo annuncio di ridurre l'utilizzo delle
intercettazioni. Così si aiutano i criminali, è stato detto. La leader di Area
ha definito le intercettazioni «pacificamente indispensabili per le attività di
indagine».
«Il problema delle
intercettazioni si trascina da vent'anni, l'abuso che ne è stato fatto è
perfettamente noto anche a tutti i pubblici ministeri e a tutti i giudici. Oggi
si difendono a spada tratta le intercettazioni solo perché sono funzionali a un
processo penale utile a interessi diversi da quelli della giustizia: utile ai
giornali, utile alle forze politiche per eliminare l'avversario di turno. È un
insulto all'intelligenza dei cittadini sostenere che limitare questi abusi
vorrebbe dire indebolire la tenuta del processo penale. Nordio non ha nessuna
intenzione di indebolire la lotta al crimine, e accusarlo di avere questa
intenzione è una clamorosa bugia, una falsità indegna di qualunque magistrato
perbene. Ed è grave che venga rilanciata in maniera acritica dai soliti organi
di stampa».
Lei sembra convinto
che sia la volta buona perché la politica non subisca i diktat delle toghe
organizzate.
«Sì. È cambiato il
clima, è cambiato l'atteggiamento dell'opinione pubblica. E fortunatamente sono
cambiati anche i giudici».
Liana Milella per “la Repubblica” il 9 dicembre 2022.
«Nordio? Non mi
piace più come ministro della Giustizia dopo i suoi discorsi in Parlamento».
L'ex Guardasigilli ed ex presidente della Consulta Giovanni Maria Flick
ripercorre con Repubblica il Nordio pensiero che «rischia di non risolvere i
tanti problemi della giustizia».
Tra Senato e Camera
Nordio ha distrutto la magistratura. Reati inutili, intercettazioni di fatto
illegali, Csm "palamariano", presunzione d'innocenza violata.
Come giudica questa
"tabula rasa"?
«Mi lascia perplesso
usare questa definizione per una realtà complessa che viene molto semplificata,
da un lato con le parole di Nordio, e dall'altro con le critiche che gli si
muovono. Preferisco vedere la magistratura nei termini in cui essa è stata
richiamata dal capo dello Stato nel giorno del suo insediamento».
Cosa disse che l'ha
stupita?
«Sono rimasto
colpito dalla distanza tra l'elogio alla magistratura che il presidente aveva
fatto nel 2018, e la durezza del quadro che ne ha fatto quest' anno. Necessità
di un profondo impegno riformatore, perplessità di fronte a un terreno di
scontro che ha fatto perdere di vista gli interessi della collettività,
necessità che il Csm corrisponda alle pressanti esigenze di efficienza e
credibilità».
Allora lei è un
"nordiamo"?
«Per niente.
Condivido le censure pesanti che tanti, compreso Nordio, muovono alla dinamica
delle intercettazioni e alla loro divulgazione. Non credo però che il rimedio
possa essere quello che lui propone, intercettazioni segrete di competenza
pressoché esclusiva della polizia, senza un controllo effettivo della
magistratura e senza garanzie di conoscenza per chi ne è oggetto».
Nordio ce l'ha con
gli ex colleghi?
«In alcuni passaggi
ne parla troppo male per non ingenerare il sospetto di un inconscio freudiano e
di una latente rivalsa».
Le intercettazioni,
Nordio minaccia di dimettersi se non riesce a ridurle e a non farle più uscire.
«Le registrazioni
che stanno all'interno del processo e che sono "assolutamente indispensabili"
per proseguire le indagini, sono già regolate da una legge precisa e valida, che
proposi io 20 anni fa e che ha attuato dopo molte discussioni il Guardasigilli
Orlando nel 2017. Il problema è far rispettare questa legge e usare le
intercettazioni quando ne ricorrono i presupposti. Ma non è logico contestare un
reato con pene alte al solo fine di poter intercettare».
Come altri prima di
lui, vedi Berlusconi e Renzi, Nordio agogna una riforma costituzionale.
«Qualche modifica
costituzionale può essere necessaria. La prima è riconoscere al capo dello Stato
la nomina del suo vice al Csm che oggi è oggetto di una trattativa tra correnti
dei togati e laici. Le "porti girevoli" vanno chiuse non solo per chi entra ed
esce dalla magistratura per fare politica, ma anche da chi esce dalla politica
per andare al Csm. La Costituzione richiede, per i laici, non requisiti di
rappresentanza politica, ma di preparazione tecnica».
Un ministro dura in
carica, se tutto va bene, 5 anni. Ha senso imbarcarsi in una riforma
costituzionale? I precedenti di Berlusconi e Renzi sono fallimentari
«Se si vogliono
separare le carriere, obiettivo mitico e storico del contrasto tra giudici e
avvocati, e se si vuole eliminare l'obbligatorietà dell'azione penale che da
principio di eguaglianza finisce per diventare foglia di fico di una
discrezionalità abnorme, occorre la modifica costituzionale. Ma è così
necessaria e urgente? A me pare che la concretezza dei problemi della giustizia
richieda interventi subito operativi e non anni di attese».
Che garanzie dà la
discrezionalità dell'azione penale? Perché invece tutti i reati, grandi e
piccoli, non vanno perseguiti?
«Sì, ma solo se è
possibile. L'esperienza insegna che i reati sono tanti e per giunta si continua
a prevederne altri».
Pensa al decreto
Rave?
«Come ha fatto a
indovinare?».
Da avvocato vede un
connubio "scandaloso" tra pm e giudici?
«Ho visto qualche
episodio che mi ha lasciato perplesso, ma non si può generalizzare. Il problema
non è quello di separare le carriere, quanto di chiedere ai pm il rispetto
rigoroso delle regole».
"Garantisti nel
processo, giustizialisti nella pena", dice Meloni.
"È un binomio
contrario alla Costituzione, per me inaccettabile, che mi auguro Nordio
rettifichi totalmente nel suo "vasto" programma"».
Se serve un
pm per regolare i pm.
È proprio vero, per
rimettere a posto il nostro sistema giudiziario c'era bisogno di un pm. Augusto
Minzolini il 9 Dicembre 2022 su Il Giornale.
È proprio vero, per
rimettere a posto il nostro sistema giudiziario c'era bisogno di un pm. È il
pedigree che differenzia Carlo Nordio dai tanti predecessori che negli ultimi
quarant'anni hanno tentato di rimettere ordine invano in un settore in cui da
decenni le gerarchie sono saltate, come pure i ruoli, in un meccanismo perverso
di bracci di ferro e prove di forza. Il fatto che l'attuale Guardasigilli
provenga dalla categoria che più di altre ha esondato dai propri poteri, che ha
fatto il bello e cattivo tempo in giustizia come in politica, cioè i pubblici
ministeri, è un punto di forza, perché ne conosce limiti, ossessioni e
ambizioni. Soprattutto non subisce i timori, le minacce più o meno velate, le
intimidazioni che hanno spesso tenuto al guinzaglio il Parlamento e bloccato una
riforma degna di questo nome.
Quella del ministro
Cartabia, ad esempio, anche se è intervenuta su temi importanti - come
l'andirivieni di magistrati tra tribunali, Procure, Camera e Senato - si è
tenuta distante dai nodi cruciali, cioè quelli che hanno permesso ai pm di avere
il sopravvento sul resto del mondo togato e di condizionare non poco le fasi
politiche. Parlo dell'uso smodato delle intercettazioni e della separazione
delle carriere fra giudici e pm, questione di cui si parla nei convegni, mai in
Parlamento. Sono argomenti che possono determinare una svolta, la fine di
un'epoca in cui l'equilibrio dei poteri previsto dalla Costituzione è stato
messo a repentaglio senza che nessuno abbia potuto - e saputo - opporsi
efficacemente.
Nordio il coraggio
lo ha. Lo si comprende dalla chiarezza del suo disegno che non sta appresso alle
fumisterie che spesso hanno accompagnato riforme molto declamate ma che non
hanno portato risultati. E si arguisce dalla determinazione con cui persegue il
suo progetto, che ha messo in allarme tutti quelli che sono interessati a
mantenere lo «status quo».
A cominciare dalla
corrente dei magistrati di sinistra, le «toghe rosse», che hanno accusato il
ministro di volere comprimere il ruolo dei pm. Un altolà preventivo che dimostra
l'irrequietezza di chi vede messo in discussione il ruolo di protagonista di cui
ha goduto in questi anni. Nei quali, con avvisi di garanzia e indagini basate
sul nulla, si facevano saltare governi e si distruggevano carriere politiche o
imprenditoriali. O, ancora, ne è prova il nervosismo con cui la sinistra, la
parte politica che più è stata favorita da certa magistratura, ha cominciato ad
erigere barriere, rifiutandosi di aprire un confronto. Anzi, l'ex responsabile
Giustizia del Pd, Walter Verini, si è lasciato andare ad una previsione che non
promette niente di buono: «Ricomincerà la guerra tra politica e toghe».
Era prevedibile. È
una guerra di potere e ricomporre l'equilibrio non sarà semplice, né indolore.
Molto dipenderà dalla capacità della maggioranza di centrodestra di restare
unita e magari di coinvolgere una parte dell'opposizione che, non fosse altro
per esperienze provate sulla propria pelle (Renzi), è più sensibile a questi
temi.
Carlo Nordio
monumentale: lezione agli spioni, cosa ha detto.
Carlo Nordio su
Libero Quotidiano il 10 dicembre 2022.
Nel seguente
stralcio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio risponde, nel corso di una
seduta della Commissione giustizia del Senato in cui lo stesso ministro illustra
le linee programmatiche del suo dicastero, a una domanda del senatore Roberto
Scarpinato, ex magistrato e attuale senatore del Movimento 5 Stelle, sul rischio
- a detta di Scarpinato - di «depotenziamento delle capacità di risposta del
sistema penale al fenomeno della corruzione», e questo con particolare
riferimento alla «riduzione dell'area di applicazione del reato di abuso di
ufficio» e al «taglio alle spese di intercettazioni». Ecco dunque la risposta di
Nordio.
Questa valutazione è
stata fatta in ambito politico in questi giorni, ed è stata fatta in qua rant'
annidi procura della Repubblica, ruolo che ho avuto l'onore di ricoprire prima
nel 1982 del indagando sulle Brigate Rosse e ricevendo a casa spesso lettere con
la stella a cinque punte; poi indagando sulla Tangentopoli veneta tra il 1992 e
il 1996, mandando a giudizio tutti i vertici dell'allora pentapartito -
Democrazia Cristiana, Partito Socialista, ministri come De Michelis, Bernini,
presidenti di regione; indagando sulla mafia del Brenta, la banda Maniero,
indagando su tutti i sequestri di persona che hanno vulnerato la nostra regione
negli anni Ottanta e Novanta, e per quanto riguarda la corruzione concludendo la
mia carriera coordinando l'inchiesta del Mose, di fronte alla quale la
corruzione e gli sprechi di Mani Pulite degli anni Novanta, compresa Milano,
impallidiscono, perché corruzione e sprechi del Mose hanno portato a una cifra
che grosso modo abbiamo contabilizzato in poco meno di un miliardo di euro.
Quindi lei mi consentirà di parlare non ex cattedra, ma con una certa esperienza
di questo (argomento).
EFFICACIA PLATONICA
Ho maturato la
convinzione prima di tutto che l'intimidazione della norma penale così come è
comminata, e che non è quasi mai irrogata, abbia un'efficacia intimidatoria
puramente platonica. Va da sé che lo Stato deve prevedere pene molto severe per
i gravi reati, va da sé che il giudice le deve irrogare in modo non dico
esemplare ma equo, e va da sé che debbano essere eseguite come ho detto prima in
modo certo. (Per quanto riguarda il reato di abuso di ufficio) Abbiamo avuto
5.400 procedimenti nell'anno 2021 e si sono conclusi con 9 condanne davanti al
Gip e 18 condanne davanti al dibattimento, che significa che a fronte di circa
5.500 indagini abbiamo avuto poco più di una ventina di condanne.
Se noi mettiamo a
confronto... Lei mi parla di costi e benefici, lei ha abbastanza esperienza per
sapere cosa significa un processo per abuso di atti d'ufficio, significa fare un
processo al processo, perché significa ricostruire l'iter amministrativo che ha
dato luogo a un atto illegittimo, e significa ricostruire il dolo o il doppio
dolo che è stato alla base, o sarebbe stato alla base, di chi ha commesso
quell'atto amministrativo. Il costo medio di uno di questi processi è in termini
di risorse umane e materiali insostenibile, perché il numero di udienze medie
per un reato di abuso di atti di ufficio è di circa tre o quattro, perché ripeto
occorre una tale acquisizione di materiale cartaceo e di pareri più o meno
interessanti, illuminati, di consulenti e periti, che confondono i magistrati e
alla fine si riducono - carta canta, come si dice - in assoluzioni o
archiviazioni o non luogo a procedere. Il fatto che si debba avere una
prospettiva di 27 condanne a fronte di 5.400 e passa indagini dà già una
risposta economica al problema.
Per quanto riguarda
le intercettazioni, esse ci costano mediamente 200 milioni l'anno - lei ha posto
la domanda in termini economici, io rispondo in termini economici. Nessuno
dubita che in certi reati, soprattutto di criminalità organizzata, le
intercettazioni siano utili, talvolta indispensabili. Personalmente, credo che
le più utili siano quelle preventive, che vengono autorizzate dal pubblico
ministero e hanno il vantaggio di rimanere secretate, sotto la responsabilità di
chi le ha autorizzate, e con la conseguente individuazione di chi un domani le
divulgasse, ne consentisse la diffusione. Premetto subito che su questo punto
questo ministro sarà estremamente rigoroso: ogni qualvolta un domani uscissero
usciranno violazioni del segreto istruttorio in tema di intercettazioni, la
ispezione sarà immediata e rigorosa. Non è più ammissibile che, non si sa da
quale parte provenienti, conversazioni che riguardano la vita privata di
cittadini che non sono nemmeno indagati e finiscono sui giornali: questo non è
tollerabile e non sarà tollerato, almeno nella parte in cui questo ministro ha
competenza.
SOLDI PER LE CARCERI
Quindi, il taglio
delle intercettazioni: perché? Perché anche qui la montagna ha partorito il
topolino. A fronte di duecento milioni l'anno di intercettazioni, quando non
abbiamo i soldi per ristrutturare le carceri, dove vengono commessi suicidi
perché non c'è l'assistenza psichiatrica, psicologica e medica, l'idea di
spendere l'ottanta per cento di questi denari in intercettazioni che sono
assolutamente inutili, perché le abbiamo viste, le abbiamo firmate, io stesso le
ho firmate a Venezia come procuratore aggiunto, è assolutamente intollerabile.
In definitiva, io
sono convinto che la lotta alla delinquenza... Non sono convinto che la
magistratura debba lottare, sono convinto che la magistratura debba applicare la
legge e che la lotta debba essere fatta dalla politica, dall'educazione, dal
senso civico, ma poiché nell'attuale sistema il pubblico ministero è capo della
polizia giudiziaria, non trovo improprio che si possa parlare di lotta da parte
dei pubblici ministeri nei confronti della criminalità organizzata... Resta il
fatto che la sproporzione tra i risultati che sono stati raggiunti da parte di
molti pubblici ministeri, dà molte procure della Repubblica, o che non sono
stati raggiunti, a fronte di spese enormi e abnormi attraverso le
intercettazioni, sono assolutamente incompatibili sia con la civiltà giuridica,
con l'articolo 15 della Costituzione che tutela la segretezza delle
informazioni, e sia con il momento drammatico economico che stiamo
attraversando, che non consente sprechi di risorse.
Da Togliatti a
Saragat Il garantismo appartiene al Dna della sinistra.
Nordio sta tentando
di spostare a destra una tradizione che, prima alla discesa in campo di
Berlusconi, le era estranea. Aldo Varano su Il Dubbio il 10 dicembre 2022.
È un errore grave,
sarebbe un errore grave, leggere le proposte sulla giustizia del
ministro Nordio come lo schema di una strategia politica pronta a rilanciare e
diffondere un messaggio di vicinanza alle culture della destra sovran-
populista. Tradizioni e conoscenza della storia del nostro paese, casomai, fanno
del “Pacchetto Nordio” un messaggio di senso opposto che non ha nulla a che
vedere con quelle culture che, perfino nella loro componente liberal- liberista
(mi riferisco alla concretezza della storia italiana), non hanno mai avuto
cedimenti garantisti.
Per quanto possa
suonare curioso e paradossale, delle proposte di Nordio si può dire che sembrano
voler recuperare, anche per i cittadini che non sono potenti, una giustizia mite
che aiuta e sostiene le ragioni di tutti senza discriminare i più deboli. Con
una piccola forzatura si potrebbe sostenere che Nordio sulla giustizia sta
tentando di spingere e spostare a destra una tradizione che è stata di parte del
centro e della sinistra che ha conosciuto il nostro paese. Nella
storia dell’Italia repubblicana il garantismo, per un periodo lungo che va dalla
sua nascita agli anni novanta del Novecento, fu infatti la marca esibita
soprattutto dalle culture delle aree del centro e delle sinistre.
La prima grande
amnistia nell’Italia repubblicana, del resto, fu concepita e varata
dall’onorevole Palmiro Togliatti, ministro della Giustizia, ma prima di
tutto, capo del Partito comunista. Non fu un gesto isolato. Con lui concordavano
da Alcide De Gasperi (costretto negli anni precedenti a rifugiarsi
in Vaticano per sottrarsi alle leggi fasciste che per quelli come De
Gasperi prevedevano la galera) a Pietro Nenni, da Giuseppe Saragat a Vittorio
Foa (che era finito in carcere perché studente torinese di sinistra e,
pericolosa aggravante, ebreo). Per non dire del gruppo dei cattolici fiorentini,
ma non solo, legati a Giorgio La Pira.
Il garantismo ha
accompagnato sempre le sinistre anche quelle radicali (con l’eccezione della
rottura drammatica e feroce del terrorismo, che fu fenomeno anche di
destra). Giorgio Amendola e Riccardo Lombardi, Emanuele Macaluso e l’ex
“galeotto” Giancarlo Pajetta, fino all’ultima generazione in blocco dei
socialisti, da Craxi a Mancini a Martelli, ai socialdemocratici e ai
repubblicani di La Malfa, furono fieramente garantisti. Nessuno di loro ebbe
cedimenti su questo fronte. E questa fu la cultura del cuore della Democrazia
cristiana e della quasi totalità delle sue componenti.
La svolta
giustizialista nel nostro paese arrivò dopo. È la Lega a far pendolare il cappio
in Parlamento senza che Forza Italia si opponga a quella barbarie a cui, anzi,
ammicca. Del resto sarà proprio Forza Italia a unire in un unico schieramento sé
stessa con la Lega che fa pendolare un cappio, e la destra fascista, fondata
da Almirante e poi ereditata e rivisitata da Fini, dove crescerà e si
formerà Giorgia Meloni, che ne dà conto diffusamente nel suo libro Io sono
Giorgia.
Debole è, e resterà,
la reazione dei comunisti ex, alla svolta leghista. Tra loro giocherà molto la
sensazione, che diventerà via via convincimento e poi certezza, che ci sia
qualcosa di illegale e di marcio, un vero e proprio trucco nel successo
di Berlusconi. Giocherà un peso determinante l’incomprensione del potere di
convincimento di una televisione che opera senza alcun vincolo e concorrenti.
Nel frattempo Craxi è stato costretto a fuggire in Africa per sottrarsi
all’umiliazione, che di certo non merita, del carcere.
I suoi amici e
nemici non muoveranno un dito per difenderlo. Anche se è stato Craxi,
incontrando nel suo camper D’Alema e Veltroni (siamo nel 1990) ad aprire la
strada dell’Internazionale socialista agli eredi del Pci garantendo per il loro
ingresso. Il nuovo eroe della politica italiana da lì a poco, per una parte
ampia della sinistra, diventerà il magistrato Di Pietro che abbandona la toga
per infilarsi in Parlamento con un partito tutto suo (fin dal nome).
Ed è proprio per il
convincimento del marcio nel successo berlusconiano (mai dimostrato) che una
parte della sinistra italiana si convincerà ad appoggiare la ventata
giustizialista, che in realtà saccheggerà a piene mani la tradizione antica e
permanente dell’estrema destra italiana.
Nessuno “virò” su
Viola ma da quella parola fraintesa nacque il Palamaragate.
Fra i tanti casi di
“errori giudiziari” dovuti ad intercettazioni telefoniche mal trascritte va
senza dubbio annoverato lo scandalo che travolse il Csm all’inizio dell’estate
del 2019. Giovanni M. Jacobazzi su Il Dubbio il 9 dicembre 2022.
Ma se ci fossero
regole diverse sulle intercettazioni telefoniche e sul contrasto alla loro
diffusione illecita, come affermato l’altro giorno dal ministro della
Giustizia Carlo Nordio, il Palamaragate sarebbe scoppiato? Fra i tanti casi di
“errori giudiziari” dovuti ad intercettazioni telefoniche mal trascritte va
senza dubbio annoverato lo scandalo che travolse il Csm all’inizio dell’estate
del 2019.
A differenza, però,
di quanto accaduto ad esempio ad Angelo Massaro, che per una telefonata distorta
scontò da innocente 21 anni di carcere, nel Palamaragate le manette non
scattarono: ci si limitò alle dimissioni di sei consiglieri su 16 del Csm e a
quelle del procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, oltre allo stop
della nomina di Marcello Viola a procuratore di Roma. Il telefonino dell’ex
presidente dell’Anm Luca Palamara, come si ricorderà, era stato prima
intercettato e poi “infettato” con il famigerato trojan per scoprire se ci fosse
corruzione nelle nomine di Procure e Tribunali.
Nella richiesta di
archiviazione, per uno dei filoni, firmata dal procuratore di Perugia Raffaele
Cantone e dai pm Mario Formisano e Gemma Miliani il 13 dicembre del 2021,
accolta dal gip Piercarlo Frabotta lo scorso 2 febbraio 2022, si è scoperto come
iniziò e si sviluppò l’indagine con il ricorso alle intercettazioni che, in
realtà, nulla avevano poi rivelato sulla presunta corruzione, limitandosi a
dimostrare che tutti si rivolgevano a Palamara per essere nominati nella ambite
cariche senza tuttavia corrispondergli alcuna contropartita, se non quella
tipica correntizia.
In particolare, l’ex
magistrato di Siracusa Giancarlo Longo aveva riferito nell’interrogatorio del 26
aprile 2019 che l’avvocato Giuseppe Calafiore gli aveva confidato di avere
consegnato 40mila euro a Palamara per ottenere la nomina dello stesso Longo
quale procuratore di Gela, senza che tuttavia si fosse concretizzato nulla,
poiché la toga non prese alcun voto al Csm, neppure quello di Palamara. Non
solo. Sempre i pm di Perugia scrissero che Calafiore, interrogato il 10 maggio
2019, aveva negato «fermamente di aver dato 40mila euro a Palamara… Io non ho
rapporti con lui». Ebbene, ciononostante per questi 40mila euro mai
riscontrati Palamara venne intercettato da febbraio 2019 a maggio 2019 e
nell’ultimo mese anche con il trojan.
Il 30 maggio
successivo la Procura di Perugia eseguì una perquisizione nei confronti
di Palamara, che finì su tutti i giornali, contestandogli anche «il reato di
corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, nel caso specifico per avere
ricevuto, quale componente del Csm, la somma pari ad euro 40mila
da Calafiore per la nomina di Longo quale procuratore di Gela».
Anche se Calafiore,
come detto, aveva smentito Longo 20 giorni prima. Per non farsi mancare nulla,
all’ex deputato dem Luca Lotti, uno dei partecipanti al dopo cena presso l’hotel
Champagne, registrato con il trojan nel telefono di Palamara, venne messa in
bocca la frase cardine di tutta la vicenda: «Si vira su Viola». In realtà quella
frase, riportata dal Gico della guardia di finanza e finita anch’essa su tutti i
giornali ad indagini in corso, non era stata mai pronunciata. Lotti si limitò ad
affermare «si arriverà su Viola».
Non si trattò,
quindi, di una “spinta” del parlamentare nei confronti di Viola quanto, invece,
di una constatazione. Insomma, non ci fu nessun accordo toghe- politica per
pilotare la nomina di un procuratore compiacente a Roma e favorire Lotti,
all’epoca imputato proprio nella Capitale. Quando l’errore venne scoperto, dopo
oltre un anno, era ormai troppo tardi. L’iniziale clamore mediatico aveva
determinato l’immediato azzeramento del voto in Commissione a favore di Viola e
la sua estromissione dal concorso.
La stretta di
Nordio sulle intercettazioni serve contro il fango giudiziario.
Federico
Novella su Panorama il 07 Dicembre 2022.
Per anni, forse
decenni, certe procure hanno fatto uscire grazie ad una certa stampa complice
pezzi di conversazioni inutili ai fini dell'inchiesta ma perfette per rovinare
vite. È ora di dire basta
L’Italia è il Paese
dove, spesso, il banale è rivoluzionario. Il Ministro della Giustizia Carlo
Nordio stamattina ha ripetuto il concetto: “"La diffusione arbitraria di
intercettazioni non è civiltà né libertà" , bensì “una porcheria” e per
combatterla "sono pronto a battermi fino alle dimissioni". Al di là del
polverone che si è sollevato, sotto sotto sappiamo tutti che l’ex magistrato
oggi Guardasigilli ha ragione da vendere: le intercettazioni sono uno strumento
utile, che tuttavia in Italia è da anni oggetto di abuso. E una riforma è
indispensabile.
Il Ministro, forte
della sua esperienza da pm, ha le spalle abbastanza larghe per affrontare
l’argomento senza girarci intorno. Ed era prevedibile che le sue parole
venissero storpiate dagli avversari. La parte più giustizialista
dell’opposizione, con certi giornali in scia, sta raccontando che Nordio
vorrebbe abolire le intercettazioni, e alcuni giornalisti suonano l’allarme
sulla fine della lotta alla mafia e alla criminalità. Ovviamente non è ciò che
ha detto Nordio. Il Ministro ha semplicemente precisato che le intercettazioni,
da strumento per ottenere prove, si trasformano troppo spesso nella prova
stessa, divenendo in sostanza una trappola mediatica per “delegittimare” gli
indagati o gli avversari politici. Allo stesso tempo, Nordio denuncia
l’”intollerabile arbitrio” , spesso elevato a sistema, degli stralci di
intercettazioni assolutamente estranee alle indagini, che inspiegabilmente
filtrano dagli uffici giudiziari sulle prime pagine dei giornali. E anche
questo, nessuno può negarlo: il mistero del fango giudiziario trasportato dalle
cancellerie dei tribunali alle redazioni è sempre stato un giallo non chiarito
della vita pubblica italiana, fin dai tempi di Tangentopoli. Per questo Nordio
chiede una profonda revisione di questi istituti. E per l’appunto suona come
disperata la risposta di chi, nel Pd, giudica “deludenti le frasi del Ministro”.
Mentre truffaldina suona la risposta del manettarismo a cinque stelle, che tuona
contro non si sa quale “attacco alla legalità”. E’ paradossale che a farsi
paladini della legalità siano gli stessi che, su temi delicati come la sicurezza
nelle città e l’immigrazione clandestina, portano avanti da anni la linea più
lassista. E più in generale, è fallimentare il tentativo di confondere la
legalità con il garantismo. Nessuno vuole eliminare le intercettazioni, ma
regolarle è d’obbligo. Qualcun altro vorrebbe invece lasciare tutto così com’è:
per poter continuare ad attaccare l’avversario politico tramite vie giudiziarie.
O semplicemente per vendere qualche copia in più, sbattendo il mostro indagato
in prima pagina, salvo poi dimenticarsene in caso di assoluzione.
Urge la riforma
Nordio. Ecco le intercettazioni taroccate da Gratteri e le troppe persone
innocenti arrestate.
Piero Sansonetti su
Il Riformista il 8 Dicembre 2022.
Sono quei casi che
un profano potrebbe ritenere rarissimi. Non sono rarissimi. Specialmente non lo
sono a Catanzaro. Cosa è successo? Che un signore che si chiama Francesco
Pannace, di 35 anni, è stato condannato all’ergastolo perché ritenuto colpevole
di un omicidio. Anche particolarmente ignobile. Aveva freddato con la pistola –
secondo l’accusa e la Corte – un padre di famiglia che teneva per mano il
figlioletto di sei anni. A incastrarlo alcune testimonianze dei pentiti, che
però erano in contrasto una con l’altra, e dunque non potevano provare nulla, ma
soprattutto una intercettazione, presentata dall’accusa, che era stata
interpretata come una specie di confessione.
Pannace avrebbe
detto a un amico: “Hai saputo? Mi hanno incastrato per l’omicidio Polito”. Per
la verità non sembra una frase così chiara, ma alla Procura di Gratteri e alla
Corte era sembrata chiara e inequivocabile. Al processo d’appello però gli
avvocati hanno chiesto che si ascoltasse l’originale dell’intercettazione. E si
è scoperto che nella trascrizione era stato tagliato un pezzo della
frase. Pannace diceva: “Hai saputo cosa si dice in giro?”. Cioè semplicemente
riferiva delle voci contro di lui che poi erano le voci che portarono alla sua
incriminazione. Nessuna confessione. Anzi. I giudici della Corte d’appello non
hanno avuto dubbi e lo hanno assolto.
Dicevamo che
taroccare le intercettazioni a Catanzaro non è una cosa rarissima. Recentemente
è emersa l’intercettazione taroccata con la quale due anni fa fu incastrato-
appunto: incastrato, che non vuol dire “scoperto” – l’avvocato Pittelli. Era la
voce di una signora che diceva al marito, considerato dall’accusa un
mafioso: “qui abita l’avvocato Pittelli. È mafioso”. Più che sufficiente questa
affermazione per spiccare il mandato di cattura. Poi l’intercettazione è stata
ascoltata. Era diversa. La moglie chiedeva al marito: “Ma è mafioso?”, col punto
interrogativo. Il marito rispondeva: “No: è avvocato”.
Lo show di Gratteri
da Lilli Gruber, le bufale del pm: “Io garantista, tra i miei arresti non ce ne
è uno infondato”
Pensateci un po’ a
questi episodi. Ieri Gratteri ha dichiarato a un giornale che nessuno mai lo
farà tacere perché lui è un uomo libero. Va bene: nessuno lo farà tacere. Il
problema è se qualcuno gli impedirà di arrestare troppa gente innocente. Che non
è libera perché lui, per sbaglio, li ha messi in cella. Magari ci
penserà Nordio, se rispetterà la parola e riformerà drasticamente le
intercettazioni. Speriamo.
Piero Sansonetti.
Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di
cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004
al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per
poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre
2019.
(ANSA il 7 Dicembre
2022) "Non è vero che ho accusato i pm di aver diffuso le intercettazioni" ma
"c'è stato un difetto di vigilanza", "quando usando questo strumento
delicatissimo che vulnera, non vigili abbastanza per evitare che persone che non
c'entrano nulla con le indagini vengano delegittimate". Lo ha detto il ministro
della Giustizia, Carlo Nordio, illustrando le linee programmatiche. "Il vulnus
non ha colpito solo politici e amministratori, ma anche magistrati", ha
ricordato, citando anche Loris D'Ambrosio, deceduto "forse perché coinvolto in
questa porcheria di diffusione arbitraria". "Sono disposto a battermi fino alle
dimissioni", ha detto.
"Qualcuno ha detto
che mi sono scatenato contro i pubblici ministeri, ma figuriamoci se uno che ha
fatto il pm per 40 anni può scatenarsi contro i suoi colleghi. Potete immaginare
che io possa volere una soggezione del pm al potere esecutivo? E' quasi un
insulto. La separazione delle carriere non è soggezione all'esecutivo": questa è
una 'speculazione' per non dire che il problema esiste". La ha detto il ministro
della Giustizia, Carlo Nordio, in audizione alla Commissione della Camera sulle
linee programmatiche.
"Reati evanescenti"
come l'abuso di ufficio e il traffico d'influenze "vanno rimodulati", e "vi sono
delle opzioni che vanno dalla abrogazione, a una maggiore accentuazione della
tassatività e della specificità". Così il ministro della Giustizia, Carlo
Nordio, in commissione Giustizia. Nordio li ha definiti reati che "rendono i
pubblici amministratori inerti, paralizzati" e "non per paura della condanna" ma
di "dimissioni, estromissioni, fine delle carriere politiche, per la
strumentalizzazione da parte di nemici e, soprattutto, di amici", che chiedono
un passo di lato, insomma: "la morta politica di queste persone".
"Non ho mai detto e
non dirò mai che le intercettazioni debbano essere eliminate. L'inchiesta che ho
coordinato sul Mose ha avuto migliaia di intercettazioni, ma erano mezzi di
ricerca della prova, non di prova" e "non è uscita una parola sui giornali, non
è uscita una delegittimazione su un cittadino di Venezia o del resto d'Italia.
Se si vuole si può, se non avviene vuole dire che c'è una culpa in vigilando".
Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo alle domande
dei deputati dell'opposizione in audizione alla Commissione Giustizia.
"Voglio che qualcuno
mi dica che è tollerabile che escano sui giornali", ha ribadito, ma "se esiste
un modo per coniugare la forza delle indagine e la segretezza delle
comunicazioni siamo perfettamente d'accordo". "C'è un rimedio? In parte c'è -
secondo Nordio -, sono le intercettazioni preventive. E' vero che negli altri
Stati esistono le intercettazioni, ma sono solo quelle che noi chiamiamo
preventive: segretissime, servono come spunto di indagine e sono conservate
nella cassaforte di chi le ha autorizzate sotto la sua responsabilità". "Non si
troverà uno scritto in cui dico che vanno eliminate, vanno regolamentate, e
impedito che chi non è direttamente coinvolto possa essere delegittimato", ha
concluso.
"Si può immaginare
se dopo aver fatto 40 anni di magistratura ho intenzione di attaccarla. E' solo
perché sono deluso per il comportamento di alcuni, pochi, magistrati, e per
l'amore che ho per la magistratura che mi rifiuto che abbia perso legittimità".
Lo ha detto il Guardasigilli Carlo Nordio, rispondendo ai deputati. "Quando
facevamo le indagini sulle Brigate rosse, e io ricevevo la stella a 5 punte a
casa, la nostra credibilità era all'85%. Sa cosa pensano di noi gli italiani?
Meglio non dirlo. E questo è un dolore", ha aggiunto, "se oggi la nostra
credibilità è crollata è perché molti di noi hanno contribuito a farla
crollare".(ANSA)
DAGONEWS il 7
Dicembre 2022.
Nessun Pm della
Procura di Milano è andato ieri sera ad assistere alla prima della Scala con il
Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel carcere di San Vittore, come era
previsto.
La mancata
partecipazione è una reazione, in evidente dissidio, alle affermazioni di Nordio
sulle intercettazioni, ritenute gravi. Era prevista la presenza del Procuratore
Capo, del Procuratore Generale e di vari Pm aggiunti, ma nessuno si è
presentato, lasciando il Ministro con la sola “Mestizia” Moratti.
Vana l’attesa del
Direttore di San Vittore, Giacinto Siciliano che ha fatto rimuovere i posti a
sedere dei pm assenti, alcuni dei quali sono andati direttamente al Teatro della
Scala a seguire l’opera dal vivo.
Estratto
dell’articolo di Paola Di Caro per il “Corriere della Sera” il 7 Dicembre 2022.
Giorgia Meloni
approva, Matteo Salvini esulta e Carlo Nordio mette nero su bianco […] il
programma del governo per la riforma della giustizia. […] Una «profonda
revisione» della disciplina delle intercettazioni, la separazione delle
carriere, la fine dell'obbligatorietà dell'azione penale che si è ormai tradotta
in «intollerabile arbitrio» e, nella pratica immediata, l'accelerazione della
riforma della giustizia civile per non perdere i fondi del Pnrr sono i capisaldi
del lavoro che intende fare, con severità nei confronti della magistratura
inquirente.
Il tutto nel giorno
in cui in commissione Giustizia è stata votata l'abolizione della parificazione
dei reati della Pubblica amministrazione con quelli di mafia, ai fini del
diritto ai benefici penitenziari, misura - come denuncia il viceministro della
Giustizia Francesco Sisto - che era stata voluta «dalla foga giustizialista dei
Cinque Stelle: una delle battaglie storiche di Forza Italia si avvia così al
successo».
[…] Se Matteo Renzi
apprezza ma attende che si passi «dalle parole ai fatti», il Pd con Walter
Verini parla di relazione «deludente, contraddittoria, con alcuni contenuti
inaccettabili» e il M5S insorge: «Nordio vuole la stretta alle intercettazioni,
indebolisce la legalità: la lotta alla corruzione non è una priorità di questo
governo». L'Associazione nazionale magistrati reagisce con delusione: «Sulle
intercettazioni parole vaghe e ingenerose»
[…] Secondo Nordio
la riforma del Codice penale va adeguata al dettato costituzionale. Bisogna
intervenire perché la presunzione di innocenza «continua a essere vulnerata in
molti modi», perché appunto c'è un uso «eccessivo e strumentale delle
intercettazioni», perché «l'azione penale è diventata arbitraria e capricciosa»
e la custodia cautelare è usata «come strumento di pressione investigativa». […]
Estratto
dell’articolo di Giuseppe Salvaggiulo per “la Stampa” il 7 Dicembre 2022.
Carriere separate
tra pm e giudici, meno intercettazioni, azione penale discrezionale su linee
guida politiche, uso massiccio e repentino delle ispezioni nelle Procure: non
tradendo attese né biografia, il ministro Carlo Nordio ha declamato in Senato il
suo manifesto sulla giustizia. […] marcerà «la profonda revisione dei reati
generici che intimoriscono sindaci, assessori e governatori: non solo abuso di
ufficio ma anche concussione per induzione e traffico di influenze illecite,
«vaghe e proteiformi fattispecie». Cambierà anche la legge Severino che sospende
gli amministratori condannati in primo grado: «Applicata retroattivamente è una
manifesta iniquità».
[…] Nordio intende
spogliare il giudice per l'indagine preliminare della competenza a decidere
sulle richieste di arresti cautelari delle Procure, affidandola a collegi di
giudici incardinati nelle Corti di appello. Quindi più esperti e anziani, in
grado di garantire «maggiore ponderatezza e omogeneità di indirizzo». Ma nulla
dice sul fatto che le Corti di appello sono già il collo di bottiglia
dell'organizzazione giudiziaria, con durata dei processi di 1167 giorni, dieci
volte più che in Europa; che hanno organici sottodimensionati del 20%, con punte
del 35%; che i bandi di reclutamento vanno regolarmente deserti.
Nordio vuole
limitare le intercettazioni, sia telefoniche che ambientali che telematiche
(virus trojan inserito nel cellulare). «Il loro numero è di gran lunga superiore
alla media europea, e ancor più rispetto a quello dei paesi anglosassoni». […]
Nei Paesi anglosassoni anche organi non giurisdizionali (polizia, autorità di
regolamentazione di settore) possono disporre intercettazioni. In Italia no: il
pm chiede, il giudice autorizza.
Le statistiche
ministeriali dicono che negli ultimi anni le intercettazioni in Italia sono
diminuite.
Le utenze-bersaglio
(le persone sono meno, circa 65mila, perché in genere ne hanno più di una) erano
141mila nel 2013 (record) e oltre 121mila nel 2019; nel 2021 sono state 109mila
(stima su dati del primo semestre). Merito di riforme e sentenze della
Cassazione che hanno limitato fortemente in senso garantista le autorizzazioni e
il travaso da un processo all'altro. Nordio ha aggiunto: «Gran parte delle
intercettazioni si fanno sulla base di semplici sospetti e non concludono nulla.
Non si è mai vista una condanna inflitta sulla sola base delle intercettazioni».
In realtà, finora le critiche garantiste erano alla dominanza probatoria delle
intercettazioni rispetto alle indagini tradizionali soprattutto per reati di
mafia, corruzione, droga.
[…] Fioccheranno
ispezioni nelle Procure in caso di fughe di notizie segrete. Quanto alla pena,
il ministro di una coalizione bicefala prova ad accontentare i forcaioli («pena
certa, eseguita e rapida») e i liberali («non significa tuttavia sempre e solo
carcere»). Quindi pene alternative per i reati minori, patteggiamenti allargati
e giustizia riparativa. Se tutto ciò andrà in porto, la fase due punterà a
modificare la Costituzione. […] Csm a cui Nordio vuole cambiare i connotati su
nomine e valutazioni professionali e sottrarre i processi disciplinari,
affidandoli a un'alta corte di nomina mista (proposta Violante); appellabilità
da parte del pm delle sentenze di assoluzione, su cui a suo tempo Berlusconi fu
respinto dalla Corte Costituzionale. […]
Estratto
dell’articolo di Maria Corbi per “la Stampa” il 7 Dicembre 2022.
È l'avvocato più
famoso d'Italia […] il decano dei penalisti che ha difeso da Giulio Andreotti a
Silvio Berlusconi […] Franco Coppi sospira quando gli si chiede cosa pensa di
questa annunciata riforma della Giustizia firmata Carlo Nordio. […]
Ma partiamo da
Nordio, che ha annunciato una revisione della disciplina delle intercettazioni.
«Vigileremo in modo rigoroso su ogni diffusione che sia arbitraria e impropria».
Soddisfatto?
«Il segreto
istruttorio esiste o non esiste […] Occorre rivedere il tema del segreto
istruttorio non solo nella prospettiva delle intercettazioni, ma stabilirne i
limiti e le sanzioni e come possa essere contemperato con le esigenze
dell'informazione. Le intercettazioni sono un mezzo di ricerca della prova che
va accettato se disciplinato bene. […]».
[…] Nordio vuole la
divisione delle carriere dei magistrati. D'accordo su questo?
«Io affronterei
invece il tema dell'immissione dei magistrati in ruolo. Ci si deve chiedere se
il sistema sia al passo con i tempi. Si deve cambiare il concorso con forme che
garantiscano veramente l'idoneità del candidato al ruolo, al di la delle
conoscenze giuridiche. Ricordo una brillante studentessa che mi chiese la tesi;
e voleva fare il pm perché "si sentiva giustizialista". Tutti 30 e 30 e lode, ma
io non le ho dato la tesi».
Torniamo alla
separazione delle carriere.
«Il problema non è
la separazione delle carriere, ma separare le persone intelligenti da quelle che
non lo sono. Una persona perbene e preparata sa come deve comportarsi da pm e da
giudice».
Quale sono i punti
della giustizia da riformare secondo lei?
«[…] c'è sicuramente
da rivedere l'udienza preliminare, che si è risolta in un fallimento, dove non
c'è un effettivo spazio per le difese. Meglio andare direttamente al
dibattimento. Oggi a Roma tra udienza preliminare e inizio del processo passa
anche un anno. Ad allungare i tempi ci si mette anche il fatto che il giudice
del processo non può conoscere gli atti dell'istruttoria».
[…] Abuso di
ufficio?
«Reato al limite
della costituzionalità per mancanza di tassatività e determinatezza, […] di
difficile definizione normativa e riscontrabilità pratica. […]». […]
L'attacco al
guardasigilli. L’innocenza dei pm non esiste, le procure insorgono per la
riforma Nordio su intercettazioni e separazione carriere.
Tiziana Maiolo su Il
Riformista l’8 Dicembre 2022
Non se lo
aspettavano, che dal bozzolo sarebbe uscita la farfalla. Nella prima riunione
del Consiglio di ministri, il neo-guardasigilli Carlo Nordio pareva chiuso in se
stesso, passivo, mentre si decidevano cose -il rinvio della riforma Cartabia, il
peggioramento della norma sull’ergastolo ostativo, un decreto frettoloso e male
scritto sui rave party– che rappresentavano il contrario di quel che lui negli
anni aveva detto e scritto.
Si erano rilassati,
dalle toghe militanti fino all’avvocato del popolo che sta girando l’Italia,
soprattutto del sud, per difendere lo stipendio di Stato a chi non lavora, e
anche il suo quotidiano di partito. Ma è stata sufficiente un’audizione
in commissione Giustizia del Senato perché saltasse per aria il tavolo
del conformismo giudiziario, appiattito da trent’anni sulla sub-cultura di Mani
Pulite, nonostante gli sforzi di tanti ministri, ultima Marta Cartabia. Dal
bozzolo in cui stava rinchiusa quel 31 ottobre è uscita poco più di un mese dopo
la farfalla-Nordio con il suo programma, i suoi cavalli di battaglia, la sua
storia. E pareva stesse leggendo uno dei suoi libri, uno dei suoi tanti
articoli. Non ha ceduto su nulla. Ha evocato lo spirito di Vassalli e la
sua riforma del processo del 1989 con l’introduzione del sistema
“tendenzialmente” accusatorio.
Ma ha anche
annunciato implicitamente che quell’avverbio che aveva denotato un coraggio a
metà, andrebbe abolito per sposare il sistema del common law, che prevede la
discrezionalità dell’azione penale e la separazione delle carriere fino a
portare il pubblico ministero fuori dallo stesso alveo della magistratura. Il
giudice e il pm svolgono ruoli diversi, ha detto il guardasigilli, e non possono
percorrere la medesima carriera. Facendo insorgere non solo il sindacato delle
toghe, ma anche ex procuratori considerati mostri sacri come Giancarlo
Caselli e Armando Spataro. Con argomenti, spiace dirlo, molto banali oltre che
scontati e un po’ bugiardi. Come si fa infatti a parlare ancora di “cultura
della giurisdizione” del pm, dopo i metodi usati dalla Procura di Milano nelle
inchieste di Tangentopoli ma anche nel recente processo Eni, o quelle di Nicola
Gratteri in Calabria? E vogliamo parlare dell’obbligo per legge del pm di
raccogliere anche le prove a favore dell’indagato?
Naturalmente il
ministro sa bene che questo tipo di riforma, di rilievo costituzionale, può
essere solo un programma di legislatura, per i tempi tecnici necessari per
cambiare la legge delle leggi. Alla Camera sono già pronte le proposte di
partiti di governo sulla separazione delle carriere. Ma intanto sarà il lavoro
quotidiano della formichina a decidere se davvero quella di Carlo Nordio, prima
di arrivare alla rivoluzione copernicana da lui (e da noi) auspicata, sarà la
svolta della giustizia che il Presidente delle Camere Penali Giandomenico
Caiazza già vede come l’apertura di una “nuova stagione dopo le storture viste
in questi decenni”. La custodia cautelare, non solo in carcere, prima di tutto.
E la disciplina sulle intercettazioni con la loro divulgazione, quella che ha
fatto venire l’orticaria ieri al sindacato dei magistrati, che si è sentito
chiamato in causa da quella battuta su ispezioni ministeriali contro “ogni
diffusione impropria”.
È vero, come ha
ricordato con tono saputello l’Anm, cha esiste già una riforma del 2017 che
dovrebbe preservarne la riservatezza, ma è ancor più sacrosanto il fatto che gli
atti giudiziari, soprattutto quando riguardano il mondo della politica, sono dei
veri colabrodo. E sono armi micidiali contro il principio di non colpevolezza
dell’indagato e la sua reputazione. E il pm, che dovrebbe essere il custode
sacro della segretezza degli atti, non ne risponde mai quando questa viene
violata. E non bisogna dimenticare la necessità di scindere anche la complicità
tra magistrati, forze dell’ordine e giornalisti. Ma c’è tutta una lunga
meticolosa attività quotidiana di formichina che il ministro di Giustizia, e con
lui il Parlamento, può avviare per poi giungere alla rivoluzione copernicana.
Due giorni fa nel
pomeriggio per esempio, nella stessa giornata in cui i senatori avevano
interloquito al mattino con il guardasigilli, la commissione Giustizia di
Palazzo Madama aveva approvato un emendamento del capogruppo di Forza
Italia Pierantonio Zanettin di modifica della legge “spazzacorrotti” voluta dal
ministro grillino Bonafede. Un emendamento che ha sottratto i reati contro la
Pubblica amministrazione all’elenco di quelli “ostativi”, che impediscono la
possibilità di accedere ai benefici penitenziari, come accade per la mafia e
il terrorismo. Un tentativo già portato avanti in aula nella scorsa legislatura,
ma con poca fortuna, dal deputato di più Europa Riccardo Magi.
Un passo in avanti,
per il ripristino della civiltà giuridica, votato anche dal senatore Ivan
Scalfarotto di Italia Viva. Naturalmente ci sarà da fare i conti con le
contraddizioni sempre più convulse degli esponenti del Pd. Che si sono astenuti,
ma che hanno già fatto sapere, dalla voce della responsabile
giustizia Rossomando, che faranno rientrare negli ostativi l’aggravante
associativa. Con il risultato (possibile non lo capiscano?) che il reato
associativo sarà contestato più spesso. O qualcuno crede ancora a Babbo natale e
all’innocenza di certi pm?
Tiziana Maiolo.
Politica e giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella
XI, XII e XIII legislatura.
Da Casarini a
Gori, i supporter che non t’aspetti per Nordio «garantista».
Storia di Lorenzo
Salvia Bruxelles su Il Corriere della Sera il 10 dicembre 2022.
«Non sono certo
amico di ma non posso che condividere con lui la volontà di mettere un freno a
questo strapotere dei magistrati». Ricordate Luca Casarini? Ex capo dei
Disobbedienti veneti negli anni ‘90, leader del Movimento no global italiano,
oggi vive a Palermo e lavora con una ong che si occupa de i migranti in arrivo
dalle coste africane. Una voce di sinistra, sebbene irregolare per definizione e
per metodo. Che però appoggia gli interventi annunciati dal ministro della
Giustizia, iscrivendosi di diritto al fronte pro Nordio che non t’aspetti.
E
sull’eliminazione preventivo sono completamente d’accordo con lui» ha detto ieri
al Corriere del Veneto, dopo una discreta serie di post e di interventi vari in
cui aveva già messo agli atti la sua posizione. Certo, dietro un ragionamento
politico c’è spesso un concreto elemento autobiografico. Forse anche stavolta è
così. Casarini è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, le
intercettazioni delle sue telefonate sono state pubblicate facendo scoppiare un
caso: «Ma ero contro la diffusione delle intercettazioni ben prima che capitasse
a me» assicura lui, che poi chiama in causa addirittura Berlusconi:
«L’accanimento giudiziario contro di lui a cosa ha portato? A vent’anni di
berlusconismo».
Resta il fatto che
quella di Casarini non è l’unica sorpresa tra le voci a sostegno della riforma
annunciata dal nuovo ministro della Giustizia. Difficile immaginare una sinistra
più lontana da Casarini rispetto a quella rappresentata da Giorgio Gori, sindaco
di Bergamo per il Pd. Eppure, il suo tweet pubblicato pochi giorni fa esprime
gli stessi concetti: «Il garantismo è il fondamento dello Stato di diritto». E
poi: «Le proposte di Nordio — rafforzamento presunzione d’innocenza, separazione
carriere tra pm e giudici, stop abuso carcerazione preventiva e intercettazioni
— vanno sostenute. Stop al giustizialismo di destra e di sinistra». Tra i
commenti sotto il suo post, che naturalmente non costituiscono un campione
statisticamente rappresentativo, ci sono tanti complimenti. Ma anche chi gli
dice «basta, vai con Renzi».
Ecco, Renzi. alle
riforme annunciate dal ministro Nordio non è certo una sorpresa. Resta il fatto
che si tratta di un partito che sta all’opposizione, anche se mai dire mai. E
che lo stesso Renzi fino al 2017, non una vita fa, era proprio il segretario del
Pd.
Nel fronte pro
Nordio che non t’aspetti c’è anche Anna Paola Concia, deputata del Pd fino al
2013. Anche lei ha scelto Twitter per sostenere il ministro della Giustizia dopo
il suo intervento in Parlamento: «Bravissimo Nordio oggi in commissione
Giustizia. Speriamo riesca a fare tutto quello che promette».
Ex di molte cose —
tra tutte, consigliere di Massimo D’Alema a Palazzo Chigi — Claudio Velardi è
abituato ad andare controcorrente. A volte anche per il gusto di sparigliare, ma
stavolta la questione è seria: «Sulla giustizia —scrive su Twitter — hanno
fallito tutti i governati del passato. Se il ministro Nordio fa l’ottima riforma
annunciata, avvia a soluzione il principale problema italiano dell’ultimo
trentennio». E ancora: «Se ci riuscirà, il governo di Giorgia Meloni acquisirà
un merito storico. Se». L’ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione,
verrebbe quasi da dire.
Il processo a
cosa serve? Intercettazioni usate come gossip e materiale scandalistico: la
lapidazione vissuta sulla mia pelle.
Luca Casarini su Il
Riformista l’8 Dicembre 2022
Non so se alla
fine Nordio potrà fare quello che dice. Non so quanto sia ostaggio o vera
anomalia di questo governo. Da eretico fruitore di “Law and Order”, ho ben
presente quale possa essere l’utilità, in termini di immagine e consenso, dei
contrasti sbandierati che poi servono solo a “rafforzare” il sistema. La vecchia
storia del poliziotto buono e di quello cattivo, insomma. Vedremo.
Certo è che quando
il neo ministro dichiara al Senato che le “intercettazioni sono utilizzate per
delegittimare politicamente l’avversario”, dice una sacrosanta verità. Lui è al
governo con quelli che proprio su questo hanno costruito la loro fortuna
politica, con tanto di carriere folgoranti come quella del suo
collega Salvini, passato direttamente dalla Ruota della Fortuna a un reddito di
cittadinanza a molti zeri da più di vent’anni e a un futuro vitalizio per una
serena vecchiaia. Da allora, da quando il suo partito, la Lega, faceva oscillare
il cappio in Parlamento al grido di “Di Pietro coraggio c’è ancora il terzo
raggio”, l’uso “politico” di spie, microspie, intercettazioni, telecamere
nascoste e quant’altro, uso politico e non solo giudiziario, con processi
celebrati sui media prima e a volte unicamente, non nei tribunali, ha avuto un
crescendo esponenziale.
Questo paese certo,
ha conosciuto ben prima di Tangentopoli sia l’abuso del controllo, sia
l’utilizzo della carcerazione preventiva come mezzo per far parlare l’indagato.
Gli anni 70 e tutta la legislazione di emergenza non sono stati uno scherzo per
lo “stato di diritto”. Ma oggi vi è un di più. La “Information Society”, la
società dei media, “dello spettacolo” come la descriveva Guy Debord, ma
moltiplicato mille. Le tendenze autoritarie, manettare, giustizialiste
connaturate fisiologicamente ad ogni democrazia in crisi, si fondono con la
mutazione antropologica che ha trasformato i “sapiens” in “Homo Social”. Ne esce
un quadro che giustamente Nordio, parlando delle gogne mediatiche imbastite su
conversazioni private, manipolate da sapienti “copia incolla” e utilizzate per
sbattere il mostro in prima pagina, definisce “inquietante ed inaccettabile”.
Certo, i travagliati
apologeti del Minority Report dall’altra parte, dicono che
senza intercettazioni a pioggia, non si sarebbero
sconfitte mafie e terrorismi. E che questo abdicare al diritto di restare
innocente finché un regolare processo non provi il contrario, è un “incidente
collaterale” accettabile. Io penso invece a quella mattina, quando mi sono
piombati in casa molti poliziotti di varie “specializzazioni”, con un mandato di
perquisizione in mano. Mentre stavano facendo il loro lavoro, uscivano già le
agenzie con gli stralci delle intercettazioni, che “sapientemente” il pm aveva
trascritto sul provvedimento, in modo da non incorrere nel reato di divulgazione
di notizie secretate. Non c’è stato bisogno nemmeno delle
classiche “veline”: dalla Procura, non saprei dire da dove altro, qualcuno aveva
inviato il tutto a giornalisti “amici”, che stavano scrivendo a nove colonne la
sentenza.
Io sono stato
condannato, e con me i miei coindagati, mentre ancora la polizia stava
“cercando”. Le intercettazioni inoltre, non possono certo restituire la
complessità di un dialogo, il tono, il contesto, quello che si dice alla fine.
Ci vorrebbero giornali di tremila pagine, e poi chi li leggerebbe? Ci vuole un
titolo ad effetto, per vendere quella mercanzia. E quindi “frasi”, prese da
trascrizioni di mesi ( perché tanto durano le intercettazioni, mica due giorni)
e se fai la cazzata di dire una parola sbagliata, o di scherzare troppo al
telefono, sei morto. Marchiato dallo stigma. Perché quello che dovrebbe essere
parte di una attenta e scrupolosa valutazione degli inquirenti nel segreto delle
indagini, diventa gossip, materiale scandalistico, lapidazione pubblica.
Il processo a quel
punto a cosa serve? L’obiettivo è già stato raggiunto. Che era sicuramente altro
dal “fare giustizia”. Lo so, il fatto che sia capitato a me, e oggi ne scriva,
magari non c’entra con il dibattito che si è scatenato nei palazzi dopo le
dichiarazioni del Ministro. E forse lui si riferiva ai danni patiti dai potenti,
da Renzi, Berlusconi etc. Ma a me non cambia l’opinione questo. Come non sono
mai stato un fan di Di Pietro e dei metodi del pool quando erano dei santi
intoccabili, allo stesso modo credo che in un paese civile quello che hanno
fatto con molti esponenti politici da me lontanissimi e di cui vado fiero di
essere avversario radicale, sia vergognoso. E pericoloso per tutti.
Nel frattempo, il solito
collega di governo di Nordio, ha in questi giorni montato l’ennesima bufala
contro le Ong, addirittura utilizzando “intercettazioni effettuate da un
sommergibile”. L’uso politico delle intercettazioni non ha limiti, e chi
dovrebbe inabissarsi per quello che ha fatto a donne, uomini e bambini da
Ministro, invece emerge. Luca Casarini Valeria Di
Corrado per “Il Messaggero” il 5 settembre 2022.
«Sulle intercettazioni, in Italia, c'è un vero e
proprio Far West.
Siamo addirittura stati messi in mora dall'Ue,
nonostante il Copasir abbia denunciato con documenti approvati all'unanimità,
per ben tre volte nell'attuale legislatura, le ricadute che questa situazione ha
sulla privacy dei cittadini e sulla sicurezza nazionale».
Il senatore Adolfo Urso, presidente del comitato
che esercita il controllo parlamentare sull'operato dei servizi segreti
italiani, dà manforte all'ex magistrato Carlo Nordio, candidato alle elezioni
politiche nelle liste di Fratelli d'Italia, che proprio due giorni fa è
intervenuto a Mestre sul tema: «Per uscire dalla crisi si può risparmiare anche
su tutti gli sprechi che ci sono nel mondo della giustizia, a cominciare dalle
intercettazioni telefoniche ambientali che costano 200 milioni di euro l'anno,
con i quali si potrebbero assumere segretari e cancellieri per accelerare il
corso dei processi».
«Nordio ha scoperchiato un vaso di Pandora -
commenta il senatore Urso - In primo luogo esiste un problema sull'uso massiccio
di questo strumento da parte dei pm italiani, con il ricorso, spesso, ad
intercettazioni a strascico: siamo il Paese più intercettato al mondo, in
rapporto alla popolazione». Basti pensare che ogni anno ci sono circa 130mila
bersagli, di cui 110mila utenze telefoniche che restano sotto intercettazione
una media di 57 giorni. Il 12% di questi bersagli sono comunicazioni di tipo
ambientale, mentre il 3% di tipo telematico (i cosiddetti trojan).
«La seconda criticità è legata al fatto che non
c'è controllo di alcun tipo sulle tariffe e sulle società a cui vengono affidate
le captazioni. Siamo sotto infrazione europea - precisa il presidente del
Copasir - perché le Procure si rifiutano di applicare la legge e di consegnare i
contratti secretati alla sezione speciale della Corte dei conti istituita a
questo scopo».
La Commissione europea, infatti, ha messo in mora
l'Italia perché non ha ottemperato a una specifica direttiva del 2011 che
assimila i contratti per le intercettazioni a transazioni commerciali. In quanto
tali, andrebbero quindi sottoposti a un controllo preventivo e successivo da
parte della Corte dei conti; nello specifico, alla Sezione centrale per il
controllo dei contratti secretati.
Ma, come evidenziato nella relazione trasmessa
alle Camere lo scorso 19 agosto sull'attività svolta dal Copasir, «appare ancora
eccessivamente esiguo il numero delle Procure della Repubblica che sottopongono
alla preposta Sezione della Corte dei conti i contratti relativi alla fornitura
di sistemi di intercettazione».
«Questo comporta che ci sia una differenza abnorme
dei costi, con Procure che spendono mille per un'intercettazione e altre che
spendono cento», spiega Urso. Le più spendaccione sono quelle di Palermo, Roma,
Napoli, Milano e Reggio Calabria. Nel 2019, a fronte di uno stanziamento
complessivo di bilancio da 125 milioni e 352 mila euro per le intercettazioni,
ne sono stati utilizzati 191 milioni. Per il 2021 e il 2022, invece, lo
stanziamento si è leggermente ridotto: a 213,7 milioni di euro l'anno.
La riforma Orlando della giustizia ha previsto
misure di razionalizzazione in questo settore. Il 18 febbraio 2021 era stato
inviato al Parlamento un decreto ministeriale dall'allora capo del dicastero,
Alfonso Bonafede, che aveva individuato una sorta di listino, con prezzi massimi
per ogni tipo di prestazione: 2,40 euro al giorno per un'intercettazione
telefonica; 75 euro per un'ambientale; 120 euro per una telematica.
Ma il ministro Marta Cartabia ha ritirato questo
decreto, spiegando che «armonizzare le tariffe è un elemento problematico
nell'interlocuzione con le Procure; il tariffario proposto è stato considerato
troppo rigido», si legge nella relazione del Copasir approvata lo scorso 21
ottobre sulla disciplina per l'utilizzo dei contratti secretati, che ha come
relatori il senatore M5S Francesco Castiello e il deputato Elio Vito (ex FI).
Riguardo invece la direttiva europea che l'Italia non ha rispettato, la Cartabia
«sta valutando la richiesta di un'interpretazione ufficiale alla Corte di
giustizia dell'Unione europea».
Manca, infine, un controllo sulle società a cui le
Procure affidano le intercettazioni: non esiste un albo di tali agenzie e spesso
alcune hanno i server all'estero. Ciò comporta delle criticità sulla
«conservazione e gestione dei dati raccolti», allerta il Copasir. Lo dimostra,
per esempio, il caso Exodus, un software usato da diverse Procure che, nel corso
del 2019, è stato oggetto di indagine a Napoli. «Se non c'è certezza della
distruzione delle intercettazioni non rilevanti, come quelle captate a strascico
dai trojan, rischia di azionarsi - conclude Urso - un sistema di ricatto che
mina non solo la privacy, ma la sicurezza nazionale».
Uccisi dalla
gogna. Morire di intercettazioni, le storie dei pm D’Ambrosio, Coiro e Misiani:
le tre bombe della malagiustizia.
Tiziana Maiolo su Il
Riformista il 9 Dicembre 2022
Morire di inchiesta
giudiziaria, morire di intercettazioni, morire di reputazione distrutta. Lo
abbiamo visto accadere troppe volte, soprattutto nel mondo politico o quello
delle amministrazioni locali, in terra di mafia. Ma se mettiamo insieme anche la
possibilità di “morire di Csm”, ecco che si parla dell’assassinio di magistrati.
Morte professionale e toga sporca, locuzione cara a certi giornali.
Il ministro Carlo
Nordio ne ha citati tre, di questi magistrati, nel suo discorso di programma
alla Camera dei deputati. Loris D’Ambrosio, consigliere giuridico del
Presidente Giorgio Napolitano, ucciso nel 2019 a 64 anni da un vero infarto
giudiziario per un’intercettazione con l’ex ministro Nicola Mancino, nelle
indagini nel fallimentare “processo trattativa”. Avrebbe dovuto portare
pazienza, potrebbe commentare il cinico, visto che due anni dopo, con
l’assoluzione di tutti gli imputati in appello, il processo finì dove avrebbe
sempre dovuto stare, nel cestino della carta straccia. E chissà se il senatore
Scarpinato, che finalmente può lottare a viso aperto con quel ruolo politico che
alle toghe non dovrebbe essere consentito, ogni tanto ripensa al recente passato
in cui fu pg nel “processo trattativa” e a quel collega morto di crepacuore
all’ombra di quelle inchieste finite con la bocciatura dei giudici di Palermo.
Il secondo nome
citato dal Guardasigilli è quello di Michele Coiro, che fu tra i fondatori
di Magistratura Democratica, e poi Procuratore capo a Roma verso la fine degli
anni novanta, e lui stesso membro di quel Csm che fu covo di serpi nei suoi
confronti. E lui c’è morto, di ictus, a 71 anni. E allora, ma solo allora, gli
furono tributati i funerali di Stato. I membri del Csm, tranne un paio di amici
personali, rimasero a casa, quel giorno. Nel picchetto d’onore alla bara rimase
per molte ore un pm che aveva lavorato con lui e che indosserà la toga per
l’ultima volta, Francesco “Ciccio” Misiani, travolto insieme al suo capo dalla
furia del famoso rito ambrosiano dei tempi di Mani Pulite. Morirà nel 2009, di
malattia, un po’ come Enzo Tortora quando disse “mi è scoppiata una bomba
dentro”.
La bomba della
malagiustizia. Che vedrà questo altro esponente importante di Md tradito
dai “compagni” che a Milano avevano saltato il fosso e abbandonato il
tradizionale garantismo della corrente, e poi esposto alla gogna peggiore. Con
le telecamere in agguato dietro la porta dell’ufficio mentre ancora non sapeva
di essere indagato, lui toga rossa, dalle toghe rosse di Milano. In un processo
per il quale sarà assolto anni dopo “perché il fatto non sussiste” da un reato
di favoreggiamento ormai prescritto, mentre la Procura colse l’occasione per non
ricorrere in appello.
Ciccio e Michele
erano due amici. Due magistrati democratici e garantisti. Bisognerebbe ricordare
che cosa era la corrente di Md della magistratura, in quegli anni precedenti
alle inchieste di Tangentopoli e alla nascita di quel mostro che verrà
chiamato “rito ambrosiano” che ruppe ogni schema, trasformò gli amici in
calunniatori e la logica del sospetto mise sotto la lente di ingrandimento
chiunque fosse fuori dal fortino del quarto piano del Palazzo di giustizia di
Milano, uffici della Procura della repubblica. Ciccio Misiani è finito dentro un
imbroglio, interrogato due volte dai pm milanesi Gherardo Colombo e Ilda
Boccassini sulla base di un’intercettazione che tale non era. Il magistrato
romano era stato visto da un poliziotto in un locale, il bar Mandara di Roma,
insieme al capo dei gip Renato Squillante, già inquisito per corruzione e che
poco dopo sarà arrestato.
L’agente, che
evidentemente controllava l’alta toga romana, aveva cercato di origliare e preso
appunti su un tovagliolino di carta. Nella relazione aveva aggiunto qualche
considerazione personale per far apparire Misiani nella veste di consigliere e
complice. Emergerà in seguito che lui, di fronte ai timori del superiore di
essere arrestato, visto che ormai giravano voci, si era limitato a dirgli di
stare tranquillo e dire la verità ai colleghi, dal momento che Squillante si
dichiarava innocente e sosteneva di essere in possesso di denaro vinto in borsa.
Ma la graticola del Csm, oltre che, nel caso di Misiani, il processo penale, fu
la fine per i due esponenti di Magistratura democratica. Coiro a un certo punto
non resse più al sospetto e all’isolamento, dopo aver scoperto che in un altro
bar romano frequentato da magistrati, i suoi colleghi milanesi avevano messo una
microspia per spiarli tutti. La pratica per il suo trasferimento fu troncata a
metà dalla sua decisione di accettare la proposta del ministro Flick di andare a
dirigere il Dap. Sarebbe stato un ottimo capo delle carceri, se un ictus non lo
avesse fermato pochi mesi dopo.
Ciccio Misiani aveva
invece affrontato il procedimento di trasferimento per incompatibilità
ambientale con astuzia politica, oltre che con l’angoscia di chi sente non solo
di subire un’ingiustizia ma anche di essere tradito da coloro che considerava i
suoi amici e compagni: Gherardo Colombo, Ilda Boccassini e soprattutto Francesco
Greco, suo ex uditore, il più “rosso” di tutti, quello che nelle riunioni
bisognava sempre trattenere perché il suo dogma era “lo Stato borghese si
abbatte e non si cambia”. Misiani con il suo discorso sincero e appassionato era
riuscito a spaccare il Csm e la sinistra. Il ruolo dell’accusatore era svolto
dal professor Fiandaca e il vicepresidente era il professor Carlo Federico
Grosso, altro insigne giurista, indicato dal Pds. La votazione finì 11 a 11, con
il voto favorevole al trasferimento del vicepresidente che valeva doppio.
Così Francesco
Misiani fu mandato a Napoli, finché non decise poi di lasciare
la magistratura. Solo in seguito fu assolto nel processo milanese di primo
grado. Poi la malattia, e il ricordo di quella toga che aveva indossato per
tanti anni e che aveva dovuto abbandonare dopo la morte del suo amico Coiro. Che
differenza fa? Infarto o ictus o quella bomba che ti scoppia dentro. Questi tre
magistrati sono stati uccisi, e Carlo Nordio bene ha fatto a ricordarli. Bravo
ministro, te ne siamo grati. Uno dei tre, Ciccio, era mio amico, e quella frase
che gli dissi al funerale del suo capo “Ti raccomando non farci scherzi anche
tu” e che lui ha citato nel libro “La toga rossa”, significava proprio non
lasciarti uccidere. Purtroppo è accaduto.
Tiziana Maiolo.
Politica e giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella
XI, XII e XIII legislatura.
«Così combattiamo la nuova
piaga criminale delle estorsioni online».
La guerra ma anche i raid
estorsivi alle aziende. E la zona grigia dei mediatori. Parla Roberto Baldoni il
capo della Cybersicurezza italiana. «Siamo partiti tardi ma la nostra catena di
comando è corta. Presto altre assunzioni». Giancarlo Capozzoli su L'Espresso il
9 Agosto 2022
Roberto Baldoni, lei è da un
anno il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L’Agenzia delle
entrate è stata attaccata, cosa è accaduto?
«È stato attaccato uno studio
di commercialisti. La cyber gang ha pensato erroneamente di essere all’interno
del sistema tributario nazionale e ha dato la notizia sul suo sito scatenando il
panico. Ma sia l’infrastruttura digitale di Sogei, che è la società partner
tecnologico della Agenzia delle entrate, sia i server dell’Agenzia non hanno
riscontrato danni. Alcune infrastrutture digitali che gestiscono servizi critici
per la sicurezza nazionale, come il sistema tributario, sono all’interno del
cosiddetto “perimetro di sicurezza nazionale cybernetica”, una legge approvata
all’unanimità nel novembre 2019. Il perimetro impone una serie di misure di
sicurezza molto elevate definite dal Dis, Dipartimento informazioni per la
sicurezza, la struttura da cui io provengo».
Sono inattaccabili?
«Il rischio zero non esiste,
ma seguendo queste misure certamente si aumenta di molto il costo che un
attaccante deve sostenere per penetrare la vittima e questo la rende meno
appetibile».
L’Agenzia che lei dirige ha
compiuto un anno il 6 agosto. Un primo bilancio?
«Un anno fa ero l’unico
dipendente, ora siamo 100 e saremo 300 alla fine del 2023. È stato un anno
fondamentale in cui abbiamo corso parecchio. Pandemia e guerra hanno avuto un
forte impatto sul numero degli attacchi cyber. E le cyber gang criminali sono in
costante crescita. Tutto questo ha dato una accelerazione formidabile alla
nostra crescita. Se lo smart working non è configurato e gestito adeguatamente
dai gestori dei sistemi aziendali può creare vulneralbilità in più e le cyber
gang le hanno sfruttate per le loro attività di ransomware».
E sul versante bellico?
«Oltre agli attacchi meno
evidenti che riceviamo costantemente, ci sono state le tre ondate di attacchi
che abbiamo ricevuto nel maggio scorso, di tipo Ddos (Distributed denial of
service) con lo scopo di rendere non accessibili siti nazionali rilevanti, da
parte del gruppo di matrice russa Killnet. Farci trovare operativi e reattivi
mentre creavamo l’Agenzia da zero è stata una sfida affascinante. Nella prima
ondata sono stati attaccati i siti di grandi organizzazioni statali e diversi
sono stati messi offline. Abbiamo studiato questi attacchi e nel giro di 20 ore
abbiamo stabilito delle regole per poterci difendere. Regole che hanno fatto sì
che alla seconda ondata di attacchi, il numero di siti di organizzazioni
governative primarie andati offline siano diminuiti fortemente. Alla terza
ondata, nessun sito governativo di una certa rilevanza è andato offline».
Più ci evolviamo, più
diventiamo vulnerabili. Scenari che ci apparivano fantascientifici si
realizzano. Che contromisure abbiamo a disposizione?
«Più diventa grande la
massa del software utilizzata, più diventa difficile mantenere tutto il software
stesso aggiornato e ben configurato. Siamo passati dalle 6.500
vulnerabilità scoperte nel mondo e raccolte dal Cve (Common vulnerabilities and
exposures) nel 2016 alle oltre ventimila del 2021. I software andrebbero
immediatamente aggiornati quando i produttori intervengono. I
ritardi creano finestre di vulnerabilità. Dobbiamo imparare a gestire questo
rischio come cittadini, come impiegati, come dirigenti d’azienda. Le
vulnerabilità cibernetiche saranno sempre in continuo aumento. Se ne
aggiungeranno di nuove che si aggiungeranno a quelle del passato. Se non
opportunamente mantenuti, i software aumentano nel tempo le loro stesse
vulnerabilità. A questo va aggiunto che più pezzi di software facciamo più
bisogna montarli assieme, interfacciarli, in quelle che si chiamano
configurazioni».
Proprio come per la
configurazione dei sistemi di smart working durante la pandemia?
«Esattamente: si portano
fuori, delle connessioni a delle applicazioni che prima erano all’interno del
firewall e se non viene configurato bene il sistema, si creano delle aperture da
dove l’hacker può entrare».
È difficile stabilire il
numero esatto delle vulnerabilità potenziali?
«Si stima con le stesse
tecniche matematiche per quantificare il numero dei pesci in un lago. Sappiamo
che è in continua crescita. Detto ciò, deve essere altrettanto chiaro che dal
mondo digitale in cui siamo immersi non è possibile tornare indietro».
Anche perché ha vantaggi
straordinari.
«Di efficienza, di conoscenza
e di velocità. Non avremmo più una economia competitiva. Andare avanti significa
saper gestire il rischio, proprio come accaduto con la diffusione
dell’automobile. Non attraverseremmo mai una strada trafficata senza guardare a
destra e a sinistra. Questa consapevolezza che pur non azzera il rischio, rende
il pericolo di essere investiti poco probabile. Questa è la mentalità che
dovremo avere ciascuno per il proprio ruolo. Se un cittadino deve stare attento
a non aprire gli allegati sospetti delle mail e ai siti che visita, il Ceo di
un’azienda deve sapere che è necessario attivare dei framework di gestione del
rischio cyber che deve governare in linea con le migliori best practices
internazionali».
Un salto di qualità nella
nostra cultura digitale?
«Veniamo da un mondo
prettamente fisico e stiamo entrando in un mondo che ibrida il fisico con il
digitale. Nel mondo fisico ci sono delle regole di sicurezza chiare e stabili e
che derivano dalla conoscenza che ci tramandiamo tra le generazioni. In questo
mondo ibrido le regole di sicurezza cambiano nel tempo e dipendono dalle
tecnologie e dai tipi di attacchi».
E dagli alert dell’Agenzia?
«L’Agenzia dovrà essere un
faro che ricava le regole di sicurezza da adottare studiando l’attacco in corso
o dando misure di sicurezza a scopo preventivo».
Che sono in costante
aggiornamento?
«L’avvento del quantum
computing renderà lo scenario tecnologico molto diverso da quello attuale. Si
supereranno alcuni problemi di sicurezza attuale, ma se ne creeranno di nuovi a
cui dovremo trovare delle risposte lungo la strada. Cosa che abbiamo cominciato
a fare a livello internazionale definendo algoritmi di cifratura che sono in
grado di resistere ad attacchi portati da computer quantistici. Ma
contemporaneamente il quantum porterà immense opportunità economiche e di
conoscenza per la società. Quindi gestire il rischio e cogliere le opportunità,
questo sarà il nostro futuro di società».
Con una partecipazione attiva
della vigilanza da parte di tutti, è così?
«Nella cyber security non si
delega. Nel mondo fisico il cittadino delega la difesa dei propri confini
nazionali alle forze armate: in questo ambito non si può delegare. Bisogna
seguire le indicazioni che dà l’Agenzia ed implementare queste indicazioni nei
propri sistemi. Dallo smartphone o dal pc dell’utente domestico al
sistema informativo aziendale».
Quanto l’Italia è indietro?
«Siamo partiti tardi rispetto
alle altre esperienze europee: trent’anni dopo la Germania, 15 dopo la Francia,
20 anni dopo Israele. Nel 2013 il Dpcm Monti ha dato una prima organizzazione.
Nel 2017, è stata fatta una revisione con il Dpcm Gentiloni, con il quale veniva
posto, al centro di questa architettura cyber nazionale, il Dis. Dal 2018
abbiamo iniziato a creare una certa capacità di resilienza a livello nazionale
anche in termini di acquisizione di personale specializzato. Siamo in
cento anche se con prospettive di crescita fino ad ottocento entro il 2027.
Numeri comunque inferiori agli oltre 1000 impiegati nelle agenzie dei nostri
colleghi francesi e tedeschi. Ma questo ritardo ci ha dato la possibilità di
studiare le esperienze dei nostri colleghi europei, israeliani e americani e
creare un’Agenzia che già a livello normativo superasse certe problematiche».
Quali?
«La prima e più importante,
quella del coordinamento: il premier è il capo della cyber security. Significa
aver compreso a fondo che è strategica per il nostro futuro. In Germania,
l’Agenzia dipende dal ministero degli Interni. È complesso coordinare giganti
come il ministero della Difesa o quello dell’Economia. Tanto che stanno
studiando una legge che riprende i principi della nostra agenzia creando una
catena di comando corta come la nostra».
Il mondo cyber non ha confini,
vale in termini di dominio su uno spazio dentro al quale i singoli Paesi si
muovono. Una condizione che i criminali informatici conoscono bene. La
territorialità della risposta è un limite, invece?
«Nel cyber spazio tutti
confinano con tutti: una cyber gang può aver il suo capo agli antipodi ma può
attaccare senza problemi una nostra infrastruttura. Parliamo di organizzazioni
che per definizione sono distribuite in varie nazioni e a più livelli. Che
permettono di attaccare da più parti. Gli attacchi Ddos di maggio scorso sono
arrivati da server ospitati in oltre 40 Paesi diversi».
Come si regola la risposta
transnazionale?
«La Nato ha già definito il
cyber come un dominio di guerra al pari degli altri domini. La differenza
fondamentale è che nel mondo fisico tutto può essere molto più palese, evidente
come l’attribuzione di una certa azione. Certamente la Russia ha attaccato
l’Ucraina. Nel mondo virtuale queste certezze sono molto più difficili da
raggiungere. Arrivare ad una attribuzione di un attacco cyber, a meno che non ci
sia una chiara rivendicazione, può essere molto complesso».
Con quello che comporta in
termini di controattacco?
«Il cyber è un mondo dove è
molto facile lasciare “false flag” all’interno di uno scenario di attacco. Per
questa ragione, bisogna stare molto attenti quando si attribuisce un attacco a
qualcuno e pertanto agire sempre con estrema cautela. Il mondo anglosassone è
molto più proattivo rispetto al mondo latino in termini di attribuzione. E in
ambito Nato una attribuzione in ambito cyber rischia di generare risposte a
livello cinetico con la possibilità di una escalation».
L’Agenzia si occupa del
versante civile.
«La cyber defense è delegata
al Comando operazioni in rete (Cor) per la difesa delle infrastrutture digitali
militari, l’Agenzia si occupa invece della cyber resilienza del sistema Paese,
dalle sue infrastrutture critiche fino ad arrivare progressivamente a tutti i
cittadini».
Come ridurre la portata degli
attacchi ransomware, le estorsioni del mondo cyber?
«Una vera piaga criminale. Noi
stiamo cercando di capire come diminuire queste ondate di ramsonware sia
trovando soluzioni tecniche adeguate sia distruggendo del tutto o in parte il
modello di business associato a questo tipo di attacchi ovvero rendendo meno
profittevole questa industria criminale che si sviluppa su scala globale. Su
questo ultimo punto stiamo studiando delle misure con i nostri partner
internazionali. Purtroppo non saranno tempi brevi così come non lo saranno i
tempi di innalzamento delle difese di una qualsiasi azienda, perché l’ampiezza
di questo intervallo di tempo passa anche per una questione di diffusione della
cultura cyber a tutti i dipendenti. Dietro a un attacco ramsonware spesso c’è
infatti un errore umano».
All’aumento del cyber crime è
corrisposto una diminuzione dei crimini reali.
«I rischi a cui ci si espone
perpetrando un attacco cyber sono infinitamente minori. Inoltre molte aziende
pur di non perdere in credibilità e reputazione e recuperare immediatamente
l’operatività preferiscono pagare i riscatti e non lasciare trapelare gli
attacchi subiti. Questo sta creando un indotto che si muove in una zona grigia
tra le vittima e la cyber gang».
Un po’ quello che accade per
alcuni fenomeni criminali, penso ai mediatori per i sequestri di persona o al
meccanismo che regola il mercato delle estorsioni nel quale tra vittima e
carnefice si interpolano soggetti che svolgono una sorta di triangolazione.
«È un indotto da bloccare
poiché alimenta le azioni criminali foraggiando la ricerca e lo sviluppo di
sempre più sofisticate metodologie di attacco. Ricordiamoci poi che nulla
garantisce che la cyber gang non lasci delle backdoor nell’azienda anche dopo
averle restituito il controllo sui dati e sugli applicativi in modo da
riattaccarla successivamente, magari sotto altre spoglie».
Torniamo alla Agenzia. A
febbraio scorso avete fatto un concorso per assumere le prime sessanta unità di
personale.
«Ne faremo un altro per cento,
centoventi persone a settembre al fine di cercare diplomati con esperienza in
cyber security. Poi cerchiamo, laureati con esperienza in relazioni
internazionali e in questioni giuridiche, della comunicazione e analisti del
mondo tecnologico. Mentre il primo è stato un concorso prettamente tecnico,
perché avevamo la necessità di far partire l’Agenzia, ora apriremo a tutta
questa serie di professionalità non tecniche ma certamente non meno importanti
per la riuscita della missione dell’Agenzia».
Con quali obiettivi?
«Stiamo cercando persone in
grado di lanciare e gestire progetti di ricerca e sviluppo innovativi in alcuni
settori come il quantum, l’Intelligenza artificiale, i big data. Creeremo una
struttura interna che si occuperà di organizzare partnership pubblico-private
per arrivare a realizzare più tecnologia nazionale ed europea».
Fin qui dipendiamo molto
dall’estero, non è così?
«Più saremo indipendenti dal
punto di vista tecnologico più saremo capaci di gestire meglio il rischio
cibernetico in questo nuovo mondo fisico e digitale. Con la consapevolezza che
non saremo mai del tutto indipendenti. Purtuttavia esistono delle tecnologie su
cui è fondamentale investire perché ci rendono più autonomi e quindi meno
attaccabili. Sottolineo: meno attaccabili. La geopolitica della tecnologia è un
fattore che dovremo affrontare, come Italia e come Europa, in termini di
dipendenza/indipendenza da determinati Paesi. Questo è un altro aspetto
determinante, correlato al rischio di attacchi cyber, per quel che riguarda la
prosperità e lo sviluppo del nostro Paese nel prossimo futuro».
«Condannato per
un’intercettazione illegale»: assolto in appello.
Crollano le accuse dopo una
condanna a 9 anni: all'epoca dei fatti il trojan poteva essere installato in
casa solo per reati di criminalità organizzata e non per i reati comuni, come
quelli di droga. Il Dubbio il 28 luglio 2022.
È stato intercettato
illegalmente dalla magistratura con un trojan, condannato in primo grado e
infine assolto dai giudici d’appello per tutti i capi d’imputazione basati su
quei colloqui privati. Con l’esplicito riconoscimento dell’errore compiuto da
cinque toghe, tre rappresentanti dell’accusa e due giudici.
La vicenda ricostruita
dall’agenzia Agi riguarda un cittadino albanese, M.J., arrestato il 23 marzo del
2021 per reati di droga dopo tre mesi in cui era stato ascoltato a casa sua e
altrove attraverso quello che gli addetti ai lavori definiscono un “captatore
informatico”, meglio noto come Trojan dal cavallo della mitologia greca. Uno
strumento invisibile in grado di “succhiare” tutta la vita privata di una
persona la cui intrusività ha alimentato discussioni e polemiche da quando è
stato introdotto in campo giudiziario.
In primo grado M.J. viene
condannato col rito abbreviato a 9 anni e 4 mesi dal gup lecchese Salvatore
Catalano per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti su richiesta del pm
Paolo Del Grosso. La sua legale, l’avvocato Francesca Beretta, si vede
respingere dal gup l’obiezione che le intercettazioni sarebbero nulle perché in
quel momento storico si poteva usare il trojan solo in luoghi di privata dimora
per reati di criminalità organizzata. Ma Beretta non demorde riproponendo il
tema in appello e questa volta le viene data ragione, nonostante il procuratore
generale incorra nello stesso sbaglio dei suoi colleghi chiedendo di nuovo la
condanna per M.J. Secondo il collegio milanese presieduto da Antonio Nova, la
sentenza del giudice di Lecco è «illogica ed erronea» perché per tutti i
procedimenti iscritti prima del 29 febbraio 2020, e quello in discussione
risaliva al 2019, si applica una pronuncia della Cassazione del 2016 per cui il
trojan può essere installato solo per reati di criminalità organizzata e non per
i reati comuni, come quelli di droga.
Ecco che allora crolla la gran
parte delle accuse a M.J.: «Visto il divieto assoluto di utilizzo del captatore
in procedimenti diversi da quella di criminalità organizzata, tutte le
conversazioni intercettate con quello strumento – sanciscono i giudici di
secondo grado – sono inutilizzabili anche nel giudizio abbreviato, trattandosi
di prove illegali». L’errore non è stato solo del giudice che ha pronunciato la
sentenza ma anche della Procura che ha chiesto e fatte svolgere le
intercettazioni col trojan dalla polizia giudiziaria, del procuratore generale
che ha insistito per la condanna e dei giudici per le indagini preliminari che
le hanno autorizzate con più decreti.
La condanna a M.J. è stata
quindi ridotta di quasi 8 anni e rideterminata in un anno e sei mesi di carcere
con immediata revoca della custodia cautelare. Per i reati commessi dopo il 31
agosto del 2020 è tuttora in vigore la riforma Orlando che consente i trojan
anche per reati comuni ma in presenza di condizioni molto rigide a garanzia
dell’indagato. «La corte d’Appello ha ripristinato e ridato vigore al senso di
giustizia – commenta Beretta – e ha ricollocato sul piano della legalità una
vicenda autorizzata e avallata da diversi operatori del diritto che si sono
succeduti. Non è difficile comprendere quali siano state le conseguenze di
questo abuso dello strumento investigativo ai danni degli indagati, alcuni dei
quali sono stati privati della libertà in modo illegittimo. Consideriamo inoltre
che un captatore ha un costo giornaliero di 300-400 euro al giorno, soldi che lo
Stato ha speso inutilmente».
Senatore spiato dai pm
senza autorizzazione. Il Parlamento si ribella.
Fabrizio Boschi l'1 Luglio
2022 su Il Giornale.
Esposito venne intercettato
per tre anni. Voto in Aula: "Ora intervenga la Consulta".
Una storia da far impallidire
la vicenda Renzi o il caso Palamara. Tanto che anche questa meriterebbe un
libro. Palazzo Madama solleva il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte
costituzionale, in merito alla vicenda delle intercettazioni «indirette»
avvenute mentre l'ex senatore del Partito democratico Stefano Esposito era
ancora un parlamentare.
Dieci anni in Parlamento e tre
di questi, dal 2015 al 2018, ascoltato oltre 500 volte dai poliziotti notte e
giorno sulla sua unica utenza telefonica, attraverso quella di un suo amico al
quale hanno polverizzato vita professionale e familiare. Tutto inizia nel 2015
quando la procura di Torino apre un'inchiesta nei confronti di Giulio Muttoni,
noto imprenditore dello spettacolo (definito «il re dei concerti») e amico di
lunga data di Esposito, tanto da fare da padrino al battesimo di una delle
figlie di quest'ultimo. Gli inquirenti indagano sull'azienda di Muttoni
ipotizzando addirittura infiltrazioni mafiose.
Ma il colpo di scena è
arrivato ieri. Via libera del Senato, con 117 voti a favore, 37 contrari e 8
astenuti, alla relazione della Giunta per le Immunità di Palazzo Madama che si è
espressa duramente su questo caso. Palazzo Madama è arrivato addirittura a
sollevare il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.
Il senatore Giuseppe Cucca
(Italia viva) illustrando la relazione, commenta: «Si è manifestata una palese
violazione della Costituzione perché il senatore Esposito è stato sottoposto ad
intercettazione dal 2015 al 2018 mentre era ancora senatore e quindi avrebbero
dovuto chiedere un'autorizzazione preventiva. Quando è stato chiesto
reiteratamente che venisse trasmesso tutto alla Giunta, il giudice prima non ha
risposto e poi ne ha fatto una questione di merito disattendendo le richieste di
un parlamentare».
A sorprendere tutti le parole
del senatore Pietro Grasso, di solito molto schierato a favore delle toghe.
Invece stavolta è stato proprio lui, prima in giunta e poi in aula, a chiedere
la trasmissione degli atti al Csm.
«Sono molto avvilito dalle
parole della rappresentante dei Cinquestelle Gallicchio che ha detto una
montagna di sciocchezze offensive per l'intero Parlamento facendo riferimento
alla mafia e per questo anche duramente ripresa dal presidente Calderoli»,
conclude Cucca.
L'ex senatore Esposito è
demoralizzato da tanta superficialità: «Certamente siamo di fronte a una delle
vicende più clamorose di violazione dell'articolo 68 che si siano mai
verificate. Ciò che ha detto Grasso è esemplificativo della gravità della
situazione. Lui che è da sempre un giustizialista chiede di avviare un
procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, clamoroso. Io e Grasso
abbiamo litigato violentemente quindi mai mi sarei aspettato questa attenzione
ma lui in quanto ex magistrato è l'unico che in giunta legge le carte. Quando ha
visto la prima proroga di indagini ha capito tutto. Per tre anni prima il pm e
poi il gip hanno intercettato un mio amico per ascoltare me, un parlamentare, e
senza chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza, violando tutte le
norme, ci rendiamo conto? Così si sta costruendo una norma consolidata per cui
la magistratura può intercettare chiunque e quando vuole. Ho anche chiesto copia
delle intercettazioni ma me le hanno negate dicendo che c'è la privacy, ma quale
privacy, la mia! Hanno cercato di associarmi alla mafia senza riuscirci perché
ero sostenitore della Tav».
Adesso la presidente Casellati
deve trasmettere gli atti al ministro della Giustizia, al Csm e al procuratore
della Cassazione. Il 19 luglio c'è la prima udienza del processo. E sul tavolo
c'è l'annullamento del decreto del rinvio a giudizio. Si ricomincia da capo?
La sentenza Cavallo
ignorata in tanti processi. Intercettazioni a strascico, ecco il metodo
Woodcock: il pm le usa o ignora a piacimento.
Viviana Lanza su Il Riformista
il 16 Giugno 2022.
La notizia dell’archiviazione
dell’inchiesta sulle Universiadi a Napoli dell’estate 2019 solleva una
riflessione. I motivi sono due: il primo è legato al fatto che l’inchiesta è
stata archiviata, su richiesta degli stessi pubblici ministeri, per una
questione relativa all’inutilizzabilità delle intercettazioni a strascico e il
secondo è legato al fatto che tra i pm che hanno firmato la richiesta di
archiviazione c’è il pm Henry John Woodcock. Andiamo al nodo della vicenda. Il
pm Woodcock è in vari processi un sostenitore della utilizzabilità
delle intercettazioni a strascico.
Dicesi a strascico quelle
intercettazioni autorizzate nell’ambito di un procedimento e utilizzate poi come
una sorta di esca per agganciare altre persone in relazione a fatti reato
diversi. La Corte di Cassazione, con la sentenza Cavallo emessa dalle Sezioni
unite a novembre 2019, ha messo dei paletti all’uso di questo metodo di
captazione ritenendo di limitarlo a quei reati oggetto di procedimenti diversi
ma uniti da una forte connessione, a reati per cui si prevede l’arresto in
flagranza, per cui la pena non può essere inferiore nel minimo a cinque anni e
nel massimo a venti anni. Il tema della utilizzabilità o meno delle
intercettazioni, anche prima della sentenza Cavallo, è comunque stato sempre
molto dibattuto e oggetto di confronti tra accusa e difesa.
Ebbene, il pm Woodcock ne ha
sempre sostenuto l’utilizzabilità, tanto che per definire il suo metodo
investigativo si è fatto riferimento all’uso del trojan come base di ogni
inchiesta, indagini spesso accompagnate tra l’altro da un certo clamore
mediatico che trasformava ogni minimo sospetto in una prova, ogni ipotesi di
reato in una condanna prima ancora che si arrivasse in tribunale, sicché quando
poi il tribunale, quello vero, quello della giustizia reale e non mediatica, si
pronunciava, la sentenza, anche se di assoluzione, riscuoteva meno attenzione da
parte dei media, tra le macerie di vite e carriere nel frattempo già fatte a
pezzi. Colpisce, quindi, che proprio il pm Woodcock, autore di inchieste nate e
portate avanti sulla scia di intercettazioni anche a strascico, abbia firmato
una richiesta di archiviazione in cui per giustificare la chiusura del caso si
fa riferimento indovinate a cosa? All’inutilizzabilità delle intercettazioni a
strascico. E in che modo? «Nel caso di specie – scrivono i pm nella richiesta di
archiviazione – si pone in primo luogo una questione di ordine processuale che
appare decisiva…».
La questione riguarda appunto
le intercettazioni. «Ebbene – scrivono ancora – si tratta di una questione che
si pone, almeno allo stato (nel senso che altrettanto evidentemente la questione
non si poneva al momento in cui tali intercettazioni sono state acquisite e al
momento in cui furono delegati i primi approfondimenti investigativi) a seguito
della sentenza pronunciata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione il 28
novembre 2019». Praticamente, dicono che siccome l’inchiesta è nata sulla base
di intercettazioni autorizzate in un altro procedimento prima della sentenza
Cavallo e siccome per effetto di questa sentenza tali intercettazioni sono da
ritenersi inutilizzabili, l’inchiesta non ha più fondamenta ed è dunque da
archiviare. E solo in calce alla richiesta, in poche righe, si fa riferimento al
fatto che «in relazione a nessuna delle vicende sopra illustrate risulta
esaustivamente comprovata la sussistenza di quella relazione sinallagmatica e
corrispettiva che caratterizza in particolare qualsivoglia rapporto di natura
corruttiva…».
A questo punto viene da
pensare: non è che la chiusura del caso sia da attribuire più al fatto che si è
indagato a vuoto per tre anni, tenendo per tutto questo tempo professionisti e
imprenditori sulla graticola con tutti i danni che ciò comporta? E non è che la
questione della utilizzabilità delle intercettazioni a strascico in questo caso
sia un altro modo per utilizzarle comunque quelle intercettazioni? Nel senso che
nell’archiviazione si usano per chiudere anni di indagini che non hanno prodotto
alcuna prova contro nessuno, mentre in tutti gli altri processi le si usano per
provare accuse contro qualcuno? Domandare è lecito.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Il virus del riscatto.
Report Rai
PUNTATA DEL 09/05/2022 di Lucina Paternesi
Collaborazione di Goffredo De
Pascale
Basta un clic per consegnare
nelle mani dei criminali informatici l'accesso a tutti i nostri dati.
Nel 2021 si sono registrati
oltre 2000 attacchi informatici gravi, il 10% in più rispetto all'anno
precedente. Le cyber gang lavorano come la criminalità organizzata e gli
obiettivi sono sempre più istituzionali perché l'imperativo è fare business:
sfruttando le vulnerabilità dei sistemi esposti in rete riescono a risalire le
reti aziendali con privilegi da amministratori e poi sferrano l'attacco
ransomware, cioè bloccano macchine e dati rendendoli illeggibili per poi
chiedere un riscatto. Dopo Regione Lazio, sono state vittime di ransomware anche
l'Asl3 di Napoli, alcune strutture ospedaliere di Milano e, a fine 2021, anche
l'Ulss di Padova. È bastato avere una copia di backup di tutti i dati per
limitare i danni? Chi deve mettere al riparo i dati sensibili dei cittadini?
IL VIRUS DEL RISCATTO
Di Lucina Paternesi e Goffredo De Pascale
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO È
il tre dicembre del 2021 quando i sistemi informatici dell’azienda sanitaria 6
euganea vengono mandati in tilt da un attacco hacker: sospesi cup, prelievi,
analisi, laboratori, liste d’attesa per fare tamponi e, ovviamente, anche gli
hub vaccinali.
ANDREA ATZORI - MEDICI CON
L’AFRICA CUAMM Siamo stati informati dall’Asl di una problematica informatica, e
un’ora dopo all’incirca abbiamo avuto un software sostitutivo e siamo ripartiti.
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO
L’azienda sanitaria locale 6 copre più di cento comuni da nord a sud di Padova e
una popolazione di quasi 1 milione di abitanti.
RAFFAELLA MEGNA - FUNZIONE
PUBBLICA CGIL PADOVA La gente che è stata qua 12 ore per fare a mano quello che
normalmente fai col sistema computerizzato. C’è gente che veramente c’ha sputato
il sangue, eh.
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO
Risultano bloccati gli oltre settemila pc dislocati nei quattro ospedali. Viene
creata una task force per ripristinare le attività più urgenti.
INFERMIERA OSPEDALI RIUNITI
PADOVA SUD – SCHIAVONIA (PD) Ci si doveva riorganizzare giorno per giorno.
Quindi prendere il telefono, chiamare, accettare le persone che arrivavano
perché non avendo gli elenchi di chi doveva fare la visita quel giorno.
LUCINA PATERNESI Ma perché
nessuno vuole parlare di questa storia?
INFERMIERA OSPEDALI RIUNITI
PADOVA SUD – SCHIAVONIA (PD) Purtroppo, siamo in una sorta di dittatura. Se la
sanità ti dice che non devi parlare non devi parlare.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Bocche cucite perché nascondono un imbarazzo, c’è da nasconderlo… perché un
milione di cittadini veneti all’improvviso non ha più potuto contare su un
organizzatissimo modello sanitario. Il sistema informatico era bloccato, che
cosa era successo? che un gruppo di hacker era riuscito a penetrare nei pc, di
fatto, diventando l’amministratore di parte del sistema informatico sanitario.
Sono riusciti a penetrare, hanno inserito un software malevolo, il ransomware,
che ha di fatto cifrato i dati dei cittadini rendendoli inagibili e poi, prima
però li aveva copiati e sfilati dal pc. Per non pubblicarli ha chiesto un
riscatto di tre milioni di dollari. Ora, Report è venuta in possesso delle chat
originali della trattativa. In esclusiva, la nostra Lucina Paternesi.
LUCINA PATERNESI Quando se ne
sono accorti alla Asl?
GIANFRANCO TONELLO - ANALISTA
MALWARE E FONDATORE TG SOFT Immediatamente, subito, già 40 minuti che era
successo l’attacco.
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO
Grazie ai backup aggiornati l’azienda sanitaria non ha perso i dati, ma ha
dovuto far fronte al ricatto degli hacker che minacciavano di pubblicare i dati
sensibili dei pazienti. Gli ingegneri di Tg Soft si mettono sulle tracce del
virus che ha infiltrato il sistema sanitario. Vanno su virustotal, una
piattaforma molto usata dai ricercatori anti-virus.
GIANFRANCO TONELLO - ANALISTA
MALWARE E FONDATORE TG SOFT Il software che noi abbiamo trovato genera delle
istruzioni di riscatto che contiene una login e una password per accedere alla
chat.
LUCINA PATERNESI Quindi è
sicuro che sia quello, non è un’ipotesi?
GIANFRANCO TONELLO - ANALISTA
MALWARE E FONDATORE TG SOFT No no è proprio questa. Eccola qua, questa è la
chat.
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO
Gli analisti di Tg Soft hanno scoperto che qualche minuto dopo la mezzanotte del
3 dicembre qualcuno dentro l’Ulss inizia a chattare con i cybercriminali.
CYBER CRIMINALI HIVE Salve e
benvenuti su Hive. Come posso aiutarvi?
ULSS 6 Abbiamo necessità di
decriptare i file, aiutateci per favore.
CYBER CRIMINALI HIVE Per
decriptare i file devi pagare 3 milioni e mezzo di dollari in bitcoin.
ULSS 6 È uno scherzo? Noi
siamo un ente sanitario governativo.
CYBER CRIMINALI HIVE Sappiamo
chi siete. ULSS 6 Dimmi quanto vuoi realmente e possiamo discutere.
CYBER CRIMINALI HIVE Posso
farti uno sconto di cinquecentomila dollari. ULSS 6 Dovremmo pagare 3 milioni di
dollari per i dati? Siete folli!
CYBER CRIMINALI HIVE Non mi
insultare altrimenti chiudo la conversazione immediatamente.
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO
Dunque, qualcuno ha provato a contrattare con i criminali. Ha chiesto anche lo
sconto, ma poi accade l’impensabile. ULSS 6 Prima puoi baciarmi il c*** e poi
dare l’indirizzo di tua madre verrò a trovarla. Cercate un’altra occupazione
stupidi bastardi. CYBER CRIMINALI HIVE Se non ci sarà il pagamento renderemo
tutti i file esfiltrati pubblici.
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO
Dalla direzione dell’Ulss smentiscono le trattative con i cybercriminali. Ma
allora chi parlava con gli hacker?
GIANFRANCO TONELLO - ANALISTA
MALWARE E FONDATORE TG SOFT Io sono convinto, e lo spero, che i dirigenti della
Asl non sappiano, non abbiano autorizzato questo tipo di trattativa perché se no
sarebbe una follia.
LUCINA PATERNESI Ma perché c’è
un manuale per come si conducono le trattative?
GIANFRANCO TONELLO - ANALISTA
MALWARE E FONDATORE TG SOFT Beh, non c’è un manuale ma c’è un buonsenso. Quando
tu hai in mano i dati di, come ha detto lei, un milione di persone forse
bisognerebbe andare coi piedi di ferro, di piombo… insomma.
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO
Avere un backup aggiornato consente di non perdere tutti i dati. Ma questo non
basta a fermare le minacce e un mese dopo, il 1 gennaio, entra in gioco un
secondo gruppo di cyber criminali: Lockbit. Parte il countdown: se l’Ulss non
paga verranno pubblicati tutti i dati trafugati dai computer.
LUCA ZAIA - PRESIDENTE REGIONE
VENETO CONF. STAMPA 17/01/22 Non abbiamo pagato il riscatto, quindi mi spiace
hanno anche lavorato tanto per niente. Che poi io non so se sta roba è una roba
di una persona fisica di uno che è lì che fa ste robe, o se è proprio questione
di macchine, di algoritmi, di intelligenza artificiale. Non ho ben capito, è un
mondo che non conosciamo però è un mondo pericolosissimo.
GIANFRANCO TONELLO - ANALISTA
MALWARE E FONDATORE TG SOFT Arriva il giorno dell’ultimatum, succede alla sera
verso le 22 che Lockbit non aspetta la scadenza pubblica e mette online i dati.
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO
Finiscono online oltre 9mila file, divisi in 51 cartelle. Documenti
amministrativi, verbali, regolamenti, disposizioni interne, ma anche risultati
dei tamponi, certificati medici, referti specialistici, diagnosi, denunce da
aggressione e persino i nomi e i numeri di telefono dei pazienti oncologici del
Veneto.
CESARE BUREI - BROKER
ASSICURATIVO Quando ci sono stati i breach sulle cartelle cliniche, son stati
valutati, a cartella clinica, sui mille dollari.
LUCINA PATERNESI Sono tutti di
un ospedale, ci sono gli elenchi dei pazienti oncologici.
CESARE BUREI - BROKER
ASSICURATIVO Documenti d’identità completi, diplomi, quindi io potrei
sostituirmi a delle persone in toto, crearmi un’identità digitale completa, con
tanto di scansione del documento fronte retro a colori. Ci sono i moduli per
ordinare i vaccini, le etichette, i codici di ordine. Conosco le procedure
interne, bene. Voglio infilarmi in una procedura sanitaria. Ti studio, ti ho
dato materiale per studiarmi.
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO
Sulla vicenda il Garante per la privacy ha aperto un’istruttoria per capire se è
stato fatto il possibile per impedire la divulgazione online di dati sensibili.
Rischiano una multa fino a 10 milioni di euro. INFERMIERA OSPEDALI RIUNITI
PADOVA SUD – SCHIAVONIA (PD) Adesso hanno iniziato a cambiare i computer, hanno
iniziato ad aggiornare il sistema, perché potrebbe anche esser stato un
dipendente involontariamente ad aver messo qualcosa su un computer, ad aver
aperto la porta, cioè chi lo sa?
LUCINA PATERNESI SPOSTATO QUI
Ma secondo lei ci possono essere delle responsabilità da parte dell’azienda per
quello che è successo?
INFERMIERA OSPEDALI RIUNITI
PADOVA SUD – SCHIAVONIA (PD) Ma sicuramente sì. Addirittura alcuni computer
erano all’età di Windows 8 dove non si potevano fare più aggiornamenti.
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO Ma
a chi toccava mettere in sicurezza le reti informatiche della sanità veneta?
Secondo la stessa legge che l’ha istituita nel 2016, Azienda Zero, società in
house della Regione Veneto, aveva tra i suoi compiti la gestione delle
infrastrutture tecnologiche, dei sistemi informativi e dei dati degli enti del
servizio sanitario regionale.
ALESSANDRO ZAN - DEPUTATO PD
Questo non è stato fatto e le singole Ulss hanno dovuto continuare con i loro
sistemi informatici ma che non erano assolutamente adeguati per contrastare un
attacco hacker come quello che c’è stato lo scorso 3 dicembre all’Ulss 6 di
Padova.
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO
Dai verbali riservati della commissione sanità d’inizio marzo emerge con
chiarezza che negli ospedali mancavano le più basilari forme di protezione, come
la doppia autenticazione per aprire la posta elettronica e i corsi di formazione
per sanitari e medici.
ALESSANDRO ZAN - DEPUTATO PD
Oggi è una scatola quasi vuota, perché fa solo bandi e appalti. Le Ulss sono
state svuotate di competenza, ma dall’altra parte non c’è stata ad esempio la
creazione di un team di uno staff in Azienda Zero che potesse dare quel sostegno
da un punto di vista informatico e della protezione dei dati.
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO
Oltre il danno, la beffa. Solo per bonificare e sostituire i computer
compromessi e dotarsi di una consulenza da parte di una società esterna di cyber
Security, nei due mesi successivi l’attacco l’Ulss 6 ha speso in emergenza quasi
1 milione di euro.
ROBERTO BALDONI - DIRETTORE
AGENZIA CYBER NAZIONALE Noi siamo entrati in contatto con l’Ulss6 di Padova
proprio per cercare di aiutarla a superare l’evento che hanno subito, credo che
faccia parte della Nis.
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO La
Nis è la normativa europea che prevede l’obbligo di creare un livello comune di
sicurezza delle reti. Sono tenuti a rispettare gli obblighi imposti da questa
normativa anche gli enti pubblici che offrono servizi essenziali sanitari,
proprio come la Ulss6 di Padova. Il ruolo di controllo è in capo alle Regioni,
che possono anche sanzionare chi non rispetta i requisiti.
LUCINA PATERNESI La Regione
che fa, sanziona sé stessa?
ROBERTO BALDONI - DIRETTORE
AGENZIA CYBER NAZIONALE Esattamente. Ma infatti è un sistema che non stava in
piedi.
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO La
Regione Veneto, dunque, avrebbe prima dovuto garantire la sicurezza, poi
controllare e addirittura arrivare a sanzionare sé stessa nel caso in cui
l’attacco hacker si fosse verificato per sua inadempienza.
LUCINA PATERNESI É mai stato
sanzionato qualcuno ad oggi?
ROBERTO BALDONI - DIRETTORE
AGENZIA CYBER NAZIONALE Francamente non credo.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Sarà l’Agenzia cyber nazionale a controllare e verificare se ci sono i requisiti
e anche a sanzionare in caso di inadempienza. Questo per togliere alle regioni
l’imbarazzo di decidere se sanzionare o meno se stesse. Però la Ulss padovana
con noi non ha voluto parlare. Ci ha scritto e ci dice:” è stata vittima di un
crimine e sta dando il massimo del supporto agli utenti coinvolti, e che è
sempre rimasta in possesso dei dati perché aveva il backup". Evviva, Dio. Però
su questa vicenda sta indagando la Direzione distrettuale antimafia di Venezia e
anche il Garante della privacy, ovviamente per le parti che competono sulla
responsabilità della violazione a danno degli utenti. Attacchi hacker ci sono
stati anche ai danni del sistema informatico sanitario della Lombardia, della
Campania e anche del Lazio. Ed è per questo che continueremo a seguire questa
vicenda perché intorno ai dati sanitari, ci sono interessi pazzeschi, a partire
da quelli di un Paese che si sta preparando alla guerra.
Scoppia il caso a
Napoli. Avvocati intercettati, così i pm aggiravano le norme.
Viviana Lanza su Il Riformista l'8 Maggio
2022.
Tra le mille pagine di un
provvedimento cautelare notificato qualche giorno fa a 66 indagati per appalti e
camorra nell’inchiesta Rfi circa dodici pagine riportano le conversazioni spiate
tra un penalista e la moglie di un suo cliente e le conversazioni di un altro
penalista con quello che di lì a qualche mese sarebbe diventato suo cliente. Nel
primo caso si parla del marito detenuto che ha bisogno di una visita
odontoiatrica con urgenza, nel secondo di questioni processuali che interessano
un amico del futuro cliente del penalista, il quale intanto è già difensore
dell’amico del suo interlocutore.
Insomma si parla di processi,
strategie difensive, ricorsi, istanze. Di tutto quello di cui normalmente parla
un avvocato penalista quando incontra qualcuno che finisce nelle maglie della
giustizia e ha bisogno di assistenza legale. Conversazioni, quindi, che
dovrebbero essere sacre, protette, rese inviolabili dal trojan a meno che non vi
siano indizi di reato a carico del difensore stesso. E invece cosa accade?
Accade che i paletti messi dalla legge (tanto per cominciare l’articolo
103 del codice di procedura penale) vengono facilmente arginati dai pm. Qualcosa
di simile alle famose intercettazioni a strascico con cui per anni si è puntato
a indagare la persona per trovare un indizio di reato e non a indagare su un
reato per verificarlo.
Una distorsione che fa pendere
l’ago della bilancia a favore della Procura, rimarcando ancora una volta che
purtroppo la parità tra le parti processuali nella realtà non esiste, perché è
chiaro che accusa e difesa giocano con armi impari. I pm possono intercettare
chi vogliono, i difensori non possono nemmeno parlare, devono misurare ogni
parola persino quando sono a colloquio con i propri clienti. Guai a fare
commenti su inchieste, spingersi in qualche valutazione su posizioni processuali
vicine a quelle che direttamente interessano il proprio cliente; può essere
rischioso persino concedersi quel pourparler che in fondo è cortesia, è
educazione, è l’umano scambio di chiacchiere tra due persone che devono comunque
entrare in relazione per affrontare una vicenda delicata come
quella giudiziaria, l’uno in quanto avvocato difensore e l’altro come indagato,
imputato o parte lesa. Si può finire intercettati, la propria voce stampata nei
brogliacci e le parole pronunciate messe nero su bianco, addirittura trascritte
in un’ordinanza di custodia cautelare e perciò rese pubbliche.
È accaduto a due penalisti
napoletani i cui nomi sono nell’inchiesta sul clan dei Casalesi, intercettati
pur senza aver commesso nulla di illecito né essere minimamente sospettati di
averlo fatto. I loro dialoghi con amici o familiari di loro assistiti sono
finiti nelle pagine del provvedimento cautelare come se avessero valore di
prova. Ma prova di che? Al momento sembra più la prova di una forzatura che
interferisce sulla riservatezza del rapporto tra difensore e assistito e quindi
su un diritto inviolabile qual è il diritto di difesa. Sapete
come pm e gip superano l’ostacolo? Visto che non possiamo intercettare e
trascrivere i dialoghi del penalista e del detenuto in carcere o dell’imputato
sotto processo, intercettiamo e trascriviamo i dialoghi che il penalista fa con
chi sta accanto al cliente detenuto o imputato, cioè un familiare. Ma vi sembra
normale? Quelle frasi sono messe accanto ad altre fonti di prova per motivare
una serie di arresti per reati di associazione a delinquere di stampo
camorristico, i Casalesi.
Nel firmare il provvedimento il
gip si pone il problema della trascrizione e della utilizzabilità delle
conversazioni che riguardano i due penalisti le lo supera con una conclusione
che è questa: «Le conversazioni captate, di seguito esposte, devono ritenersi
pienamente utilizzabili atteso che, a quanto emerge dagli atti, al momento del
dialogo tra l’indagato e l’avvocato quest’ultimo non era il difensore». Lo
sarebbe diventato di lì a poco, era una conversazione forse esplorativa e in tal
caso, quindi, più vicina a quella sfera di riservatezza che fa parte
dell’inviolabile diritto di difesa. «La giurisprudenza – scrive il gip – ha in
maniera assolutamente univoca evidenziato che non esiste una zona di immunità
per la quale non è possibile ascoltare i colloqui dei difensori con soggetti
privati, pur magari loro abituali clienti». Eccolo arginato, quindi, il paletto
della norma che tutela la segretezza del rapporto tra difensore e cliente. E
allora, viene da chiedersi, come si salvaguarda la dignità professionale degli
avvocati?
Come si garantisce la libertà
nello svolgimento dell’attività difensiva? Come si rispetta il segreto
professionale? Può dirsi equo un processo del genere? Sarà equo il processo e si
potrà definire libera la difesa di questi indagati raggiunti da un provvedimento
in cui ci sono nero su bianco anche i dialoghi origliati con i difensori? Il
tema è delicato e negli ultimi anni è venuto a galla più volte. La legge traccia
la linea maestra: in sintesi, un avvocato sospettato di aver commesso un reato
può essere intercettato come ogni altro cittadino. Ma qui non siamo in questa
sfera, le intercettazioni fatte dalla Dda di Napoli e trascritte in un
provvedimento contro una serie di presunti affiliati a clan della camorra sono
intercettazioni cosiddette indirette. Ed eccola la nota che crea la distorsione,
che genera il caso, che dà ai pm di superare i paletti messi dalla norma:
la Cassazione ha stabilito che il divieto di intercettazione riguarda
esclusivamente le dichiarazioni pronunciate nell’ambito del mandato difensivo e
non quelle di tipo più amicale. E così, altro che parità tra le parti
processuali.
Uno studio di alcuni fa,
condotto dall’università di Bologna, ha rivelato l’abitudine delle Procure a
intercettare in tali contesti. Lo studio raccoglieva le risposte di 1.265
penalisti sulla frequenza con cui si fossero imbattuti in casi di
intercettazioni tra l’indagato e il suo difensore effettuate e trascritte: il
3,6 % aveva risposto che accade sempre, il 25,3% che accade di frequente, il
43,2% poche volte, e appena il 27,9% degli avvocati aveva risposto mai.
A Napoli non è la prima volta che il dialogo di un avvocato finisce negli atti
di un’inchiesta. La vicenda dei due penalisti di cui parliamo non ha suscitato
finora grande clamore mediatico ma è all’attenzione della Camera penale di
Napoli che sta studiando il caso.
Qualche anno fa, sempre a
Napoli, ci fu una vibrante protesta dei penalisti, con la denuncia di sempre più
frequenti casi in cui stralci di conversazioni venivano poste alla base di
richieste ( e concessioni ) di misure cautelari e richieste di rinvio a
giudizio e persino citate durante l’esame dibattimentale dagli ufficiali di
polizia giudiziaria che le avevano ascoltate e/o trascritte. «Si tratta di una
intollerabile lesione di un principio basilare delle garanzie di libertà della
funzione difensiva che deve valere per tutti i tipi di comunicazione e per tutte
le fasi del rapporto confidenziale con l’assistito, ivi comprese quelle
prodromiche alla assunzione dell’incarico», si disse. Sono trascorsi circa sei
anni da allora. E cosa è cambiato?
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
La polvere sotto il
tappeto. Cassazione, la Pg fuori legge fa intercettare l’avvocato: e il Csm sta
a guardare.
Otello Lupacchini su Il Riformista il 22 Marzo 2022.
Gesù ammonisce: «Non c’è nulla
di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto.
Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che
avrete detto all’orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui
tetti.» (Luca, 12, 2-3). Ed è questo un insegnamento al quale intendo attenermi,
sebbene prudenza vorrebbe che non si parlasse di corda né in casa dell’impiccato
né in casa del boia. Del resto, non v’è ragione alcuna perché si debba tacere,
di fronte alla spregiudicatezza di taluni esponenti di quell’aristocrazia togata
prodotto della riforma dell’ordinamento giudiziario, nota come «Riforma
Castelli», dal nome del guardasigilli leghista del governo Berlusconi che la
propose nel 2002, approvata con legge 25 luglio 2005, n. 150, e completata da
una serie di decreti legislativi emanati nella prima metà del 2006.
Se, illo tempore, nel rispetto
dell’articolo 107 della Costituzione, in virtù del quale «i magistrati si
distinguono tra loro solo per le funzioni», il concetto di «carriera» era
estraneo all’organizzazione della magistratura e il «capo» di un ufficio altro
non era che un primus inter pares, investito di responsabilità organizzative
nell’interesse di tutti e di tutti al servizio, oggi non è più così:
concentrati, in nome dei “miti” dell’efficienza e della trasparenza, sempre
maggiori poteri in mano ai dirigenti degli uffici giudiziari, si è creata una
«divisione tra la magistratura alta e quella bassa». In particolare, mentre si
sono attribuite ai capi degli uffici di procura tutte le scelte relative
all’esercizio dell’azione penale, si è peraltro abolito il cosiddetto sistema
tabellare che, bene o male, imbrigliava la discrezionalità del «capo»; al che
sono conseguiti, a catena, l’affievolimento dell’indipendenza dei singoli
sostituti, vincolati alle decisioni sostanzialmente insindacabili del «capo»,
nell’esercizio delle funzioni, nonché il venir meno sia del pluralismo
decisionale sia della diffusa assunzione di responsabilità all’interno dei
singoli uffici.
Il resto lo fa quello
che Friedrich Nietzsche chiama Wille zur Macht, cioè la cieca tendenza degli
organismi a espandersi a detrimento del circostante, nonché necessità di
dominare, occupare, sottomettere, neanche, poi, in virtù di un supposto
«piacere» che ciò conferirebbe, ma per la pura tensione espansionistica in sé:
unico comun denominatore di tutti gli episodi di malcostume che hanno afflitto
la magistratura, specie negli ultimi anni, l’ansia degli interessati di avere o
mantenere un incarico direttivo o di incrementarne l’importanza, dato che un
organismo non fa altro che cercare di essere ed essere di più. È, dunque,
semplicemente disgustoso ascoltare gli individui de quibus agitur dolersi, dando
la grottesca sensazione di descrivere sé stessi mentre si osservano allo
specchio, della corruzione a tutti i livelli della vita economica, civile e
politica; della pratica endemica degli scambi di favori; dello sfruttamento di
risorse pubbliche a vantaggio di interessi privati; della diffusa mafiosità dei
comportamenti; di una sorprendente maggioranza di concittadini che approva e
nutre questa impresa. Per non dire di quanto sia irritante sentirli chiedersi
come si sia giunti alla misera situazione nella quale ci si trova. E non solo
perché la funzione di tanto ostentata indignazione, per dirla con Alessandro
Manzoni, è quella dei bei vasi dello scaffale più alto nelle farmacie: «Sono
vuoti, ma servono a dar lustro alla bottega»; quanto, piuttosto, perché
diversamente dalla «gente», alla quale Fabrizio De Andrè riserva il proprio
sarcasmo in Bocca di rosa, che «dà buoni consigli/Sentendosi come Gesù nel
tempio», sol perché «non può più dare cattivo esempio», costoro il cattivo
esempio possono ancora ben darlo e, ahimè, lo danno pure.
Accanto a loro, si schiera,
peraltro, la pletora di famigli, cioè «todos los ricos, nobles, y los
delinquentes», direbbe ancor’oggi, come nel 1577 a proposito dei «familiari» del
Sant’Uffizio in Sicilia, il viceré Marco Antonio Colonna, che affolla redazioni
di giornali, spesso online, ed emittenti televisive, a diffusione spesso locale,
mossa evidentemente da vivi motivi di gratitudine nei confronti
dell’aristocrazia togata, di cui veicolano l’illuminato pensiero, non perdendo
occasione, ad esempio, di ripetere, per un verso, che esiste una vasta rete di
consiglieri fiscali, commercialisti esperti in diritto societario, tributario,
bancario, del lavoro e, perché no, giornalisti chiamati a svolgere un
fondamentale ruolo di consulenza e di supporto ad attività delinquentesche; e,
per l’altro, che, nell’ambito di questa vasta rete di protettori, un ruolo a
parte sia da assegnare agli avvocati difensori, perché il loro intervento
professionale si sovrappone al diritto di difesa: mai che si riconosca, magari
obtorto collo, che la stragrande maggioranza degli avvocati impegnati nella
difesa di indagati e/o imputati, prestano la loro assistenza legale nel pieno
rispetto delle regole della deontologia professionale; anzi, lungi dal
difenderli di fronte all’opinione pubblica, perché rendono un servizio non solo
ai loro clienti, ma agli interessi della giustizia, si avanzano, piuttosto,
riserve o insinuazioni nei loro confronti, ricorrendo, per evitare querele, a
espedienti retorici subdoli, odiosi e insidiosi, accomunandoli nel giudizio
negativo ai propri impopolari assistiti.
In quasi cinquant’anni, ho
visto scorrere tanta acqua torbida o nera sotto i ponti dell’amministrazione
della giustizia, ma non m’era mai capitato d’imbattermi in una vicenda in cui
l’abuso è talmente spudorato da far supporre una consegna o intese sotto banco.
Una vicenda vieppiù intrigante, perché vittima, detto col disagio che
l’antipatico pronome suscita nei lettori delle Pensée, c’est moi. Non la sola,
naturalmente, e non la principale. Si tratta di vicenda condotta a emersione da
una questione preliminare spiegata dall’avvocato I.I., difensore dell’incolpato,
nel corso della prima udienza, davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura, nel procedimento a carico del dottor E.F.. Questo
l’incipit della perorazione difensiva (cito dalla registrazione del 18 febbraio
2022, reperibile in Radio radicale): «Ci sono alcune questioni, signor
Presidente e signori Consiglieri, e non (…) so (…) se sarò più imbarazzato io
nel rappresentarle oppure (se maggiore sarà l’imbarazzo per) la procura generale
(della Cassazione) e anche (per) il Consiglio (…). (Quello di cui parlerò)
riguarda, infatti, una prerogativa dello Stato al rispetto del principio di
legalità: ho partecipato a un interrogatorio del dottor E.F. davanti alla
procura generale (della Cassazione) senza conoscere gli atti; una volta,
tuttavia, che questi sono stati versati (nel presente procedimento
disciplinare), è stato sorprendente quello che da essi si è potuto apprendere».
E il riferimento è alle intercettazioni: «Agli atti del fascicolo ci sono una
infinità di telefonate tra me e i miei assistiti, il dottor E.F. e il dottor
Lupacchini».
Inspiegabile, continua il
difensore, come mai la procura di Salerno e la procura generale
della Cassazione abbiano ritenuto di calare una sonda tanto invasiva nelle sue
conversazioni difensive con i propri assistiti. Di qui lo sfogo critico, in cui
è involuta una denuncia: «A me non interessa che qualcuno dica si tratti di
captazioni inutilizzabili: esse sono illegali! Tant’è che direi alla procura
generale (della Cassazione) che (…) deve procedere contro sé stessa per illeciti
disciplinari oppure (…) contro Salerno. È un fatto grave, perché qui non c’è la
tutela del diritto di difesa, che è diritto inviolabile secondo la Costituzione
per la persona fisica e una prerogativa dello Stato alla legalità». Quindi, un
ulteriore affondo: «(…) in alcune (di tali conversazioni) c’è addirittura
scritto “da valutare” (…): ma come, da valutare? Ma perché deve essere valutata
una conversazione (…) tra un difensore e il suo assistito? E da chi deve essere
valutata? Chi è che ha il diritto di farlo? La procura generale (della
Cassazione)? Forse, la procura di Salerno? Riflettiamo anche su questi aspetti.
(…), a me serve capire perché è stato fatto questo; perché la procura di Salerno
avesse necessità di sapere in anticipo (il contenuto delle) mie conversazioni
difensive; perché ha così invasivamente (fatto irruzione) nella vita difensiva
di un (mio) assistito». Sarebbe molto grave, e mi rifiuto di crederlo, se gli
investiganti salernitani avessero voluto conoscere in anticipo le strategie
difensive degli assistiti dell’avvocato I.I., per meglio e più utilmente
calibrare le performances accusatorie. Ancor più grave sarebbe qualsiasi altra
spiegazione, ma non è nel mio stile avventurarmi a formulare ipotesi fantasiose.
Resto, invece, ai fatti.
L’articolo 103 comma 5 del
codice di rito penale vieta le intercettazioni telefoniche, nel caso comunichino
difensori, consulenti tecnici o ausiliari degli stessi; oppure uno dei predetti
e l’assistito, sia esso l’imputato, il sottoposto alle indagini, una parte
eventuale, l’offeso. Certo, non si può pretendere che a tutti questi soggetti
sia garantita l’assoluta segretezza di qualsiasi emissione o ricezione, con
chiunque interloquiscano e su ogni argomento: fosse così, l’establishment
criminale acquisterebbe a buon mercato basi-santuario da cui tessere
indisturbato le sue tele; garantiti dalla segretezza assoluta sono, dunque,
soltanto i discorsi relativi a difese o consulenze, anche se diretti al terzo o
da lui emessi, come, ad esempio, fra difensore e testimonio; ovvio, peraltro,
che le operazioni difensive non devono essere malaffare delinquentesco. Ebbene,
che le conversazioni intercorse tra l’avvocato I.I. e i suoi assistiti
attenessero sempre ed esclusivamente alla difesa e fossero contenute nel
penalmente lecito, ben lo sapeva chi materialmente captava i messaggi, ma era
certamente circostanza che non poteva sfuggire neppure a chi, inquirenti
salernitani e procuratore generale della Cassazione, ha disposto la trascrizione
e il versamento in atti di quel materiale illegalmente raccolto, dunque non
valutabile ad alcun fine processuale. È forse temerario, allora, pensare che
anche questi ultimi abbiano condiviso tacitamente, salvo un non meno inquietante
«non aver compreso il fatto», nell’illegale acquisizione, nel procedimento
disciplinare? Il Consiglio superiore della magistratura, come le stelle del
romanzo di Archibald Joseph Cronin, The Stars Look Down, sembra sia rimasto e
voglia rimanere, purtroppo, soltanto a guardare.
Otello Lupacchini.
Giusfilosofo e magistrato in pensione
Spyware, l’Ue ora indaga
sul software israeliano.
Il Parlamento europeo istituisce una Commissione per verificare
eventuali violazioni dei diritti con l'uso di Pegasus nei Paesi membri. Simona
Musco su Il Dubbio l'11 marzo 2022.
Il Parlamento europeo ha
deciso di istituire una commissione sul presunto uso dello spyware israeliano
Pegasus o di altri software di sorveglianza e sui rischi di violazione dei
diritti e dei valori sanciti dall’Unione. Una vera e propria task force,
composta da 38 membri, che entro 12 mesi dovrà presentare una relazione,
indagando sulle presunte violazioni del diritto europeo nell’uso del software di
sorveglianza da parte, tra gli altri, di Ungheria e Polonia.
Tra gli obiettivi quello di
stabilire se l’utilizzo di tali sistemi di controllo «abbia contribuito a spiare
illegalmente giornalisti, politici, funzionari delle autorità di contrasto,
diplomatici, avvocati, imprenditori, attori della società civile o altri attori
in paesi terzi e abbia portato a violazioni o abusi dei diritti umani che
destano grave preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi della politica
estera e di sicurezza comune dell’Ue, e se tale uso sia stato in violazione dei
valori sanciti dall’articolo 21 Tue e dalla Carta dei diritti fondamentali,
anche tenendo debitamente conto dei principi guida delle Nazioni Unite su
imprese e diritti umani e di altri diritti sanciti dal diritto internazionale in
materia di diritti umani».
Il lavoro di indagine prevede
anche un’analisi delle leggi nazionali esistenti in merito alla sorveglianza e
una valutazione del presunto impatto negativo di tali sistemi sui diritti
fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, L’istituzione della
commissione d’inchiesta è stata approvata con 635 voti favorevoli, 36 contrari e
20 astenuti, a seguito della richiesta presentata da 290 deputati, che hanno
ritenuto necessario sottoporre a esame e indagine le denunce di infrazione o di
cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione.
Tra le altre cose, la
commissione avrà il compito di verificare se gli Stati membri abbiano assicurato
salvaguardie istituzionali e giuridiche sufficienti per evitare l’uso illegale
di spyware e se le persone che sospettano che i loro diritti siano stati violati
da tali sistemi di controllo abbiano accesso a mezzi di ricorso efficaci.
La denuncia del Comitato
per la sicurezza. “Intercettazioni fuorilegge”, il Copasir contro gli abusi
detto Pm.
Viviana Lanza su Il Riformista il 16 Marzo 2022.
«Nella relazione del Copasir
sul sistema di intercettazioni abbiamo denunciato come perduri una situazione di
assoluta discrezionalità su modalità e criteri con cui vengono affidati i
mandati ad eseguire le intercettazioni giudiziarie, anche in merito alla
conservazione o alla distruzione delle stesse». È uno dei passaggi
dell’intervento del presidente del Copasir, Adolfo Urso, in occasione della
discussione al Senato sulla relazione annuale sull’attività svolta dal Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio
2022.
Il Riformista, la scorsa
settimana, ha raccontato le criticità che ruotano attorno allo strumento
investigativo delle intercettazioni, le opacità segnalate anche nella relazione
del Copasir, i dubbi relativi alle garanzie sull’integrità del dato raccolto
durante le attività di intercettazione e sulla trasparenza dell’intera filiera.
«Ricordo a tutti che siamo sotto infrazione europea – ha aggiunto Urso – perché
le Procure non intendono attuare quanto previsto in una precisa direttiva
europea e quanto stabilito dalla legge italiana. Aspettiamo che il ministro
della Giustizia mantenga quel che si era impegnata a fare nel corso
dell’audizione». Si attende, quindi, che la ministra Marta Cartabia affronti il
problema regolando meglio questo complesso e cruciale aspetto delle attività di
indagine. Sappiamo, infatti, che ormai quasi non c’è indagine che non nasca da
una conversazione spiata. Sappiamo anche che, da strumento straordinario di
raccolta della prova, l’intercettazione è diventata non solo lo strumento di
prova più amato dai pubblici ministeri ma addirittura il mezzo per cercare la
notizia di reato. Al di là di questo, poi, si pongono questioni in relazione
alle modalità con cui le intercettazioni vengono custodite e archiviate, ai
margini di discrezionalità dei pm nella scelta di una o di un’altra azienda a
cui rivolgersi per avere il supporto tecnico alle attività di captazione, al
rispetto delle norme a partire da quella che obbliga all’utilizzo di server
ubicati nei locali delle Procure e non altrove.
«Oggi finalmente discutiamo in
modo compiuto di Sicurezza nazionale sulla base della relazione annuale
del Copasir. È una novità importante – ha sottolineato Urso – . In passato non è
mai avvenuto. La legge 124 del 2007 prevede, infatti, la relazione annuale del
Copasir e analoga relazione annuale della Presidenza del Consiglio. Non sono
state mai esaminate né in Aula né in una Commissione del Parlamento». «Per
questo – ha aggiunto – , a nome del Comitato, ringrazio la Presidenza e i gruppi
parlamentari di averne condiviso la necessità e spero che ciò accada ogni anno
con una specifica sessione parlamentare». E ha concluso: «In questi quindici
anni c’è stato solo un dibattito tematico su un problema, quello delle
intercettazioni, su cui peraltro siamo stati costretti a fare noi stessi una
relazione al Parlamento il 21 ottobre dello scorso anno». Relazione in cui si
mette in risalto, in particolare, «un duplice contrasto».
Il primo riguarda il costo
dell’attività di intercettazione inteso come spesa di giustizia, «con la
conseguenza – si spiega nella relazione – che l’affidamento di tale attività non
soggiace all’obbligo di controllo da parte della Corte dei Conti mentre
il Consiglio di Stato è orientato nel qualificare gli affidamenti dei servizi di
intercettazioni telefoniche e ambientali, da parte delle Procure, come contratti
secretati». Il secondo elemento di opacità sta nel contrasto tra l’indirizzo
dato dalle norme europee e la giurisprudenza interna, contrasto «che deve essere
necessariamente superato, anche per evitare l’infrazione europea cui l’Italia è
stata sottoposta». Inoltre, «malgrado le rassicurazioni fornite, il Governo non
è ancora intervenuto per affrontare le problematiche di questo settore, anche
nella direzione di individuare dei requisiti di base unici a cui gli operatori
si debbano attenere, come accade in altri settori per i quali è previsto un
processo di qualificazione degli operatori economici».
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Focus sul
bilancio sociale della Procura di Napoli. Intercettazioni, il lato oscuro delle
indagini e i dubbi sui dati.
Viviana Lanza su
Il Riformista il
9 Marzo 2022.
Il settore è
quello della cyber intelligence e security. Molte società si sono lanciate in
questo mercato che assicura ingenti guadagni. Basta leggere i bilanci delle
Procure. A Napoli la voce di spesa per le intercettazioni corrisponde a più
della metà delle spese sostenute per l’intero funzionamento della giustizia
partenopea. Ma quali sono le società a cui si affidano i pm napoletani? Quali
criteri specifici vengono seguiti per la loro scelta? Come viene assicurata la
sicurezza dei dati che queste società maneggiano? E soprattutto l’integrità dei
dati. Perché il vero nodo è tutto qui: come fa un cittadino a essere certo che
il flusso di parole intercettate non venga in qualche modo manipolato? Come si
garantisce la genuinità di tutto quello che finisce nei cosiddetti brogliacci
per poi confluire eventualmente negli atti di un’indagine e di un processo? Una
risposta c’è: le intercettazioni devono essere gestite da pubblici ufficiali,
quindi dai sostituti procuratori, e i flussi di dati devono passare su server
nei locali della Procura.
Ma ci sono casi
che hanno evidenziato come così non sempre accade, e come ogni garanzia a tutela
dei diritti del cittadino rischi di vacillare. Nel bilancio sociale, pubblicato
nei giorni scorsi dal grande ufficio giudiziario partenopeo, non ci sono
risposte chiare alle domande e ai dubbi che sorgono di fronte a numeri di
bersagli intercettati e a somme così elevate di spesa (quasi 19mila di bersagli,
13 milioni di euro di spesa). Si sa che c’è un elenco di società nel quale i
sostituti procuratori possono scegliere quella a cui affidare le attività di
supporto per svolgere intercettazioni. Si apprende però, dal bilancio sociale,
che qualora un pm ritenga di avvalersi di un’impresa non ancora accreditata può
farlo informando il procuratore aggiunto e motivando la sua scelta. C’è dunque
un margine di autonomia nell’iniziativa del singolo pm sotto questo aspetto.
Inoltre, fino al 30 settembre 2021 le imprese fornitrici delle prestazioni
funzionali alle intercettazioni era avvenuta tra aziende autorizzate
all’installazione di un server presso l’ufficio di Napoli, e l’affidamento dei
servizi di intercettazioni ambientale telematica di videosorveglianza e gps era
attribuito a tutte le società accreditate tenuto conto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per ogni singola prestazione proposta da ogni
azienda con un proprio listino.
L’obiettivo era
dunque orientato a garantire la riduzione dei costi per le intercettazioni. Con
la nuova disciplina in materia di intercettazioni, la Procura si è dovuta
adeguare dotandosi di un listino unico delle prestazioni, «imponendo alle
imprese fornitrici – si legge nel documento di bilancio – la garanzia di
dettagliate e specifiche condizioni funzionali, soggettive e tecniche, per
accrescere il risparmio di spesa, la qualità delle forniture, la sicurezza dei
sistemi, l’innovazione tecnologica dello strumento investigativo». I dubbi
restano. Sicurezza e integrità dei dati sono le parole chiave. Come garantirli?
È vero che la Cassazione ha fissato dei paletti precisi, e che la legge prevede
che i server debbano stare nei locali della Procura e che il privato non possa
immagazzinare alcun dato attraverso server intermedi. Ma è anche vero che
attraverso il cosiddetto “sistema Mito” (un sistema informatizzato multimediale
per la registrazione, l’ascolto, la visualizzazione e la decodificazione delle
intercettazioni vocali e multimediali) l’architettura dei server consente anche
di accedere alle conversazioni intercettate da siti diversi da quelli della
Procura.
Del resto, la
cronaca di qualche mese fa ha raccontato di un’indagine, coordinata proprio
dalla Procura di Napoli, su una delle società che forniscono ai magistrati
apparati e programmi per svolgere le intercettazioni, sollevando il dubbio di
una violazione della procedura relativa al server su cui attivare
le intercettazioni. Esiste, insomma, un tema relativo alla integrità e sicurezza
dei dati. E la digitalizzazione rischia di rilevarsi un’arma a doppio taglio.
Secondo la Procura la digitalizzazione può concorrere a garantire l’integrità
dei dati e la loro riservatezza prevedendo procedure informatiche di
trasmissione tramite Tiap degli atti relativi alle intercettazioni. E sarebbe il
pubblico ministero a garantire che la polizia giudiziaria assicuri il rispetto
delle finalità dell’archivio digitale delle intercettazioni destinato alla
custodia segretata delle intercettazioni destinate a non confluire in alcun
processo in quanto inutilizzabili o irrilevanti.
Il nodo archivio
è, dunque, un altro aspetto controverso. Nel bilancio della Procura di Napoli si
legge che con il passaggio dei dati all’archivio «le registrazioni vengono
eliminate dai server delle aziende fornitrici delle prestazioni ad esse
funzionali», poi «il gestore procede alla cancellazione dai propri server delle
registrazioni e dei verbali conferiti, alla distruzione e alla formattazione dei
supporti informatici utilizzati per l’esportazione dei dati». E i consulenti
informatici, allo scadere dell’incarico, «rendono una dichiarazione sottoscritta
attestante che non viene conservata alcuna informazione relativa ai dati
personali raccolti». I dubbi restano.
Viviana Lanza.
Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è
giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed
economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del
quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il
Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Il bilancio sociale della
Procura. Le intercettazioni non possono essere il primo e unico strumento di
indagine.
Riccardo Polidoro su Il Riformista l'8 Marzo 2022.
La trasparenza dovrebbe essere
un elemento essenziale della pubblica amministrazione. Negli ultimi anni si sono
fatti passi in avanti in tal senso, ma non basta. Ci sono ancora molti aspetti
oscuri e domande a cui non viene data una risposta chiara. Sono le inchieste
giornalistiche – non sempre basate su dati certi – che, a volte, strappano il
velo su circostanze ignote all’opinione pubblica. Va vista, pertanto, con grande
soddisfazione la meritoria pubblicazione del bilancio sociale della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, reso noto nei giorni scorsi.
Non è la prima volta e non è
il solo Ufficio giudiziario che provvede a tale impegno. Il bilancio sociale è
l’esito di un processo con cui l’amministrazione rende conto delle scelte, delle
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da
consentire ai cittadini di conoscere come l’amministrazione interpreta e
realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato. Quello della Procura di
Napoli – la più grande d’Italia, con oltre 100 pubblici ministeri – consta di
368 pagine ed è stato realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi
Federico II. È una relazione completa sull’attività svolta nel territorio di
competenza. Il dato che maggiormente colpisce è quello relativo alle
intercettazioni telefoniche, la cui spesa, di euro 12.785.000,00, supera di
circa un milione quella dell’anno precedente e rappresenta il 60% della spesa
complessiva dell’Ufficio, pari a euro 21.313.000,00. Tra intercettazioni
telefoniche, ambientali e telematiche sono stati fatti 8.873 ascolti nel 2021.
In un solo anno, sono migliaia
i cittadini che vedono controllate le loro utenze, i loro luoghi privati, le
loro relazioni. L’intercettazione viene ritenuta, dunque, dagli inquirenti
l’incontrastata regina delle indagini ed il più importante strumento
investigativo. Il suo uso massiccio comporta, inevitabilmente, il fenomeno così
detto delle intercettazioni a strascico. Da un soggetto controllato si arriva ad
indagarne altri che sono, a volte, occasionalmente in contatto con
l’intercettato. Basta una frase criptica, anche non in relazione all’indagine in
corso e si aprono altri fascicoli, si moltiplicano gli indagati sottoposti a
controlli invasivi sulla loro vita privata. È chiaro che siamo di fronte ad un
meccanismo perverso nel quale l’intercettazione diventa il primo atto d’indagine
– ed a volte resta l’unico – a carico dell’indagato, mentre l’uso di tale
attività investigativa dovrebbe presupporre gravi indizi di colpevolezza a
carico del soggetto che s’intende controllare e non viceversa. Sarebbe
interessante conoscere il dato relativo all’esito processuale di tali fascicoli,
per poter effettivamente valutare costi e benefici. Altro dato rilevante – ce ne
sarebbero molti, ma lo spazio a disposizione non consente ulteriori
approfondimenti – è quello relativo ai criteri di priorità sui reati da
perseguire.
In merito, il bilancio dà atto
che tale scelta è stata fatta coinvolgendo l’avvocatura e che il principio
invalicabile dell’obbligatorietà dell’azione penale non consente di praticare
altre strade. È questa una situazione paradossale, che vivono tutte le
grandi Procure del Paese. L’esercizio dell’azione penale varia a seconda del
territorio. Il cittadino denuncia, ma se quel reato non è tra gli obiettivi
prioritari della Procura, la sua legittima azione non troverà risposte. È
evidente che tale compito dovrebbe spettare esclusivamente alla politica, le cui
scelte possano valere per tutti in ugual misura, senza connotazione di luoghi.
Ed è altrettanto pacifico che occorre la depenalizzazione di alcuni reati privi
di concreto allarme sociale, le cui fattispecie potranno trovare una più
efficace sanzione amministrativa. Resta il grande merito della Procura di Napoli
di aver messo sul tavolo i dati necessari ad un vero proficuo confronto sugli
importanti temi dell’attività investigativa. Riccardo Polidoro
Napoli, il bilancio della
procura: nel 2021 boom di intercettazioni. Il dato elaborato con l'Università
Federico II: negli ultimi due anni oltre il 75% delle richieste cautelari è
stato accolto. Nell'ultimo anno 4.672 le richieste di autorizzazione a disporre
captazioni.
Valentina Stella su Il Dubbio l'8 marzo 2022.
L’Università degli Studi di
Napoli Federico II e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
hanno presentato il Bilancio Sociale 2020-2021. «L’idea del bilancio sociale –
scrive il procuratore Giovanni Melillo nell’introduzione – muove dalla
consapevolezza che la trasparenza dell’organizzazione e delle prassi
dell’ufficio del pubblico ministero è una componente essenziale dello Stato di
diritto e al tempo stesso una delle garanzie del giusto processo».
A plaudire all’iniziativa il
presidente della Camera Penale di Napoli, l’avvocato Marco Campora, che ci dice:
«È un esempio molto importante di responsabilità e trasparenza istituzionale
perché, attraverso i numerosi dati statistici, si dà al cittadino la possibilità
di conoscere le scelte di politica criminale adottate dalla Procura. Questa
iniziativa dovrebbe essere fatta propria da tutti gli uffici giudiziari
d’Italia».
Criteri di priorità nella
trattazione degli affari
«L’analisi dei flussi delle
notizie di reato – si legge nel report – e la consapevolezza del numero e della
tipologia dei reati che costituiscono oggetto dei singoli fascicoli hanno
consentito di individuare soluzioni organizzative mirate ad evitare il ricorso
alla mera casualità e a garantire la massima trasparenza e uniformità di azione
nella selezione dei procedimenti». Tra le priorità della procura di Napoli
troviamo reati per mafia, stalking, in materia di ambiente e paesaggio, per i
quali vi sono beni in sequestro sottoposti a custodia giudiziale onerosa o di
rilevante valore, relativi a pene superiore ai 4 anni, con termine di
prescrizione che non maturi prima dei due anni dalla prima udienza. Per Campora,
«si tratta, al fine di ridurre il contenzioso penale, di un tipico esempio di
scelta di natura politica che secondo me andrebbe fatta in maniera diversa,
addivenendo, attraverso una operazione di tipo culturale, a quel diritto penale
minimo che non può non essere il punto di approdo in una società realmente
liberale e democratica».
Ci spiega Campora che «abbiamo
toccato con mano che quasi il 98% dei processi attinenti a reati bagatellari si
conclude con la prescrizione. La procura di Napoli ha adottato condivisibili
linee guida per garantire la ragionevole durata dei procedimenti ed evitare la
stasi di molteplici fascicoli negli armadi dei sostituti procuratori. Questa
scelta è certamente apprezzabile perché mira a non ingolfare il Tribunale;
tuttavia sarebbe auspicabile arrivare ad una visione unitaria del diritto
penale, che deve essere unico in tutto il territorio nazionale. Occorrerebbe
giungere, quindi, ad una rivendicata operazione di depenalizzazione
accompagnata, magari, da un’ampia amnistia per ridurre gli arretrati».
Misure cautelari
Nel 2020 la Dda ha fatto
richiesta di misure cautelari per 1307 indagati, concesse per 981 di loro, pari
ad una percentuale del 75%. Nel 2021 le richieste sono state 1304, quelle
accolte 1019, pari ad una percentuale del 78%. «Il dato interessante e
allarmante – evidenzia Campora – è quello relativo all’alta percentuale di
accoglimento che ci porta a dire che il giudice terzo si è smarrito, e con esso
il suo controllo filtro sull’attività della procura. Non voglio trovare un alibi
al giudice però, soprattutto per reati di criminalità organizzata, si tratta di
analizzare in pochissimo tempo fascicoli enormi, in cui la Dda, in particolare,
spesso riversa migliaia di pagine». Tutto questo, ovviamente, «incide sul
diritto di difesa del cittadino».
Boom di intercettazioni
Nell’anno 2020 sono state
2.891 le richieste di autorizzazione a disporre, che sono arrivate a 4.672 nel
2021. Per quanto concerne le richieste di proroga da parte del pm ne abbiamo
10.028 nel 2020 e 13.909 nel 2021. Per le intercettazioni sono stati spesi
11.811.411,09 per il 2020 e 12.785.338,67 per il 2021. «Le spese per
intercettazioni – si legge ancora nel bilancio sociale – rappresentano la voce
di costo più rilevante nel panorama delle spese di giustizia della
procura (oltre la metà del totale), a conferma dell’assoluto rilievo dello
strumento investigativo per il contrasto ai più gravi fenomeni criminali. La
parte più importante del costo è quella relativa alle attività di
intercettazione telefonica (circa 7 milioni su 11,8 nel 2020; 5,6 milioni su
12,7 nel 2021). Nell’ultimo anno, a fronte di una riduzione del costo per
intercettazioni telefoniche, si è registrato un incremento delle spese per
intercettazioni informatiche ed ambientali».
In particolare quelle relative
al Trojan nel 2021 sono costate quasi 3 milioni, nel 2020 la spesa si era
fermata a circa 1,7 milioni. Quella telematica per Android costa 174 euro al
giorno, mentre quella per Ios 243. A fare ampio uso delle intercettazioni è la
Dda. Secondo Campora, «per analizzare questi numeri dobbiamo ricordare che siamo
in un territorio ad altissimo tasso criminale e poi non spetta a noi avvocati
fare una valutazione economica delle spese relative allo strumento intercettivo.
È chiaro però che si tratta di un mezzo invasivo, che andrebbe adottato solo in
casi eccezionali. Nel nostro Paese vi è stato spesso un abuso delle
intercettazioni, soprattutto per la pesca a strascico. C’è una tendenza ad
utilizzarle affinché costituiscano la prova unica del reato, quando invece
dovrebbero rappresentare un elemento a riscontro degli altri risultati
investigativi».
Quasi 19mila persone spiate
per un costo di 13 milioni (su 21 totali) ogni anno. Intercettazioni, Procura di
Napoli sempre più Grande Fratello: ma sei indagini su dieci muoiono.
Viviana Lanza su Il
Riformista l'8 Marzo 2022.
Ci sono quasi 19mila
persone (18.581 per la precisione) sotto intercettazione. Sono tante,
tantissime. Le loro conversazioni sono spiate dagli 007 della Procura di Napoli,
diventata ormai una sorta di Grande Fratello che ascolta e annota dialoghi e
movimenti. Ma davvero si tratta sempre di attività di indagine necessarie e
irrinunciabili? A leggere le percentuali di assoluzioni e di archiviazioni con
cui si concludono poi le inchieste (parliamo di circa il 60 per cento), non
sembra. E non sembra nemmeno che siano attività di indagine utilizzate sempre a
completamento di ricostruzioni investigative su notizie di reato già in buona
parte accertate, se è vero che molto alto è il dato sulle
cosiddette “intercettazioni a strascico”, cioè intercettazioni attivate in un
procedimento ma utilizzate anche in altri.
Come se le intercettazioni
servissero a trovare la notizia di reato e non a verificarla. Come se fosse
normale impiegare il Trojan come primo e unico strumento di indagine. Quasi
19mila persone intercettate in un anno è un numero elevatissimo. Nel 2021
la Procura di Napoli ha avanzato 13.909 richieste di proroga delle
intercettazioni e 4.672 richieste di autorizzazione a disporre. Numeri che
indicano un trend in crescita rispetto al passato, se si considera che sono
state poco più di 10mila le richieste di proroga tra il 2019 e il 2020 e poco
più di 2mila le richieste di autorizzazione a disporre. Ingente anche la spesa:
quasi 13 milioni sui 21 milioni impiegati per il funzionamento della macchina
giudiziaria della Procura partenopea. La Procura di Napoli, guidata dal
procuratore Giovanni Melillo, ha reso noto questi e altri dati nel bilancio
sociale, redatto con il supporto dell’università di Napoli Federico II e
presentato sabato nel complesso di San Marcellino dell’ateneo federiciano.
Un atto di trasparenza di cui
bisogna dare merito al procuratore Melillo, il primo anche a regolare le
comunicazioni con la stampa e a formalizzare la modalità con cui i giornalisti
possono avere accesso a un atto come l’ordinanza di custodia cautelare. «La
magistratura funziona se si carica su spalle l’effettività delle garanzie, la
durata del processo – ha spiegato il procuratore, capo della Procura più grande
d’Italia – Io non ho mai considerato gli avvocati come utenti, penso che non sia
lontano il momento in cui gli avvocati siederanno nel consiglio di
amministrazione degli uffici giudiziari per partecipare alla definizione delle
linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici giudiziari», ha aggiunto
sostenendo la necessità di una nuova apertura da parte della magistratura. Ma la
questione non è solo quella morale legata alla crisi di fiducia che investe la
categoria delle toghe da quando sono esplosi il caso Palamara e quello del
correntismo. La questione è anche quella della «orizzontalità della
magistratura», come l’ha definita il presidente dell’Unione Camere penali Gian
Domenico Caiazza.
«Questo bilancio sociale è un
atto di grande importanza e spero che diventi un parametro che valga al più
presto per tutti gli uffici giudiziari italiani – ha commentato l’avvocato
Caiazza, intervenendo alla presentazione del bilancio della Procura partenopea –
. È un metodo che laicizza il confronto. Ovviamente quando condividiamo dei dati
discutiamo di quei dati, e i dati non sono mai neutri, ognuno li legge come
ritiene». E sulle intercettazioni, «il numero di persone intercettate è
impressionante, su questo – aggiunge Caiazza – abbiamo opinioni diverse. Il
fatto però che un singolo sostituto abbia autonomia di scelta nell’ambito di una
rosa di società selezionate dalla Procura, o che si possa andare anche fuori da
quella con un’autorizzazione, credo sia il frutto estremo di un’idea di
orizzontalità della magistratura distrettuale che a noi non piace».
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Il report sulle indagini.
Flop intercettazioni, nel 77% dei casi i procedimenti vengono archiviati.
Viviana Lanza su Il
Riformista il 21 Gennaio 2022.
Il bilancio dell’anno
giudiziario investe anche l’attività delle Procure del distretto, da Napoli
a Napoli nord, Avellino, Benevento, Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Torre
Annunziata, Nola. L’ultimo anno ha fatto registrare un aumento delle inchieste
avviate dai pm e del ricorso all’uso delle intercettazioni. Rispetto al 2020, i
procedimenti iscritti presso le Procure del distretto con indagati noti sono
aumentati, passando da 94.267 del 2020 a 110.311. Sono aumentate anche le
definizioni: 113.384 rispetto alle 95.970 dello scorso anno. E sono diminuiti,
anche se di poco, da 1.797 a 1.747, i procedimenti iscritti presso la Procura
dei minorenni.
Il dato, però, che più balza
agli occhi è quello che riguarda gli esiti delle indagini dinanzi
al gip/gup. Secondo il bilancio dell’ultimo anno, il 77% dei procedimenti si è
concluso con un decreto di archiviazione, il 6% con una sentenza di rito
alternativo, il 2% con un decreto di condanna esecutivo, il 15% con un rinvio a
giudizio. Fra le varie Procure del distretto si fa riferimento a un totale di
58.594 procedimenti contro noti definiti dinanzi a un giudice delle indagini
preliminari o un giudice in udienza preliminare. Puntando la lente sui dati
della Procura di Napoli, la più grande d’Italia, sono stati 21.628 i
procedimenti totali, di questi 15.928 sono stati archiviati, 3.353 hanno portato
a un rinvio a giudizio, 1.454 a una sentenza con rito alternativo, 893 a decreto
di condanna.
Nel 54% dei casi c’è da dire
che l’archiviazione proviene da una richiesta della stessa Procura. Procura che
a Napoli, nel 2021, ha avviato 40.477 procedimenti penali. Rilevanti anche i
dati sulle intercettazioni: 10.031 bersagli in un anno. In particolare, si sono
contate 1.958 utenze telefoniche e intercettazioni ambientali o di altro tipo
disposte dalla Procura ordinaria, 7.961 nell’ambito di indagini coordinate
dalla Direzione distrettuale antimafia, 112 nell’ambito di inchiesta
dell’Antiterrorismo.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Si sgonfia la bufala
dell'"archivio Genchi".
Massimo Malpica il 18 Gennaio 2022 su Il Giornale.
L'esperto di intercettazioni
che inguaiò politici e pm "non commise illeciti".
L'archivio costruito da
Gioacchino Genchi nella sua attività di consulente per tante procure? Secondo il
garante della privacy rappresentava una sfilza di violazioni nella raccolta,
conservazione uso di quei dati, tanto da sanzionarlo, a marzo 2016, per 192mila
euro. Ma prima un giudice di Palermo, a luglio 2019, e ieri la Cassazione hanno
annullato quella decisione, stabilendo la liceità dell'archivio informatico
dell'ex poliziotto, che oggi dopo essere stato reintegrato in servizio e aver
scelto di prepensionarsi - fa l'avvocato.
Proprio Genchi, dopo la
conferma arrivata ieri dalla prima sezione civile della Suprema corte, esulta:
«Si chiude il suo commento - una vicenda fondata sulla bufala dell'archivio con
cui hanno cercato di farmi fuori, tra Palermo e Catanzaro, con l'indagine Why
not, dove ero impegnato nelle indagini più importanti che c'erano in quel
momento». Insomma, il modo in cui l'ex superconsulente di De Magistris e di
altri pm aveva trattato i dati delle indagini e dei processi ai quali
collaborava era corretto. Con buona pace, tra gli altri, dell'ex viceprocuratore
nazionale antimafia Alberto Cisterna, del quale Genchi - mentre lavorava come
consulente per De Magistris alle inchieste Why Not e Poseidone - aveva
rintracciato i rapporti con Luciano, uno dei figli del boss della ndrangheta
Giuseppe Lo Giudice (vicenda al centro del libro Il Caso Genchi di Edoardo
Montolli). Cisterna aveva omesso di informare di questi contatti il suo
superiore dell'epoca, Piero Grasso, e anche se l'inchiesta penale si era
conclusa con un proscioglimento, il Csm lo aveva trasferito d'ufficio, e la toga
aveva presentato un esposto al Garante per la privacy contro Genchi. Ma per la
Cassazione non c'è alcuna prova che il superconsulente avesse «trattato i dati
in suo possesso per finalità estranee a quelle di giustizia, in ragione delle
quali ne era avvenuta l'acquisizione», e dunque Genchi non ha commesso «nessun
illecito». Ora l'ex poliziotto si toglie sassolini dalle scarpe e legge la sua
odissea come «un disegno per farmi fuori», ribadendo appunto di essere stato in
prima linea in indagini molto calde, comprese quelle sulle morti di Falcone e
Borsellino: «Hanno preso a pretesto la vicenda di Catanzaro che, peraltro, era
la meno importante di tutte e mi hanno fatto fuori», spiega all'Adnkronos
Genchi. A sua difesa si schiera anche l'ex pm ed ex sindaco di Napoli De
Magistris, che plaude alla pronuncia della Cassazione che «indirettamente
conferma anche la bontà della scelta che feci nel 2006 nominandolo consulente» e
ricorda il suo stupore per le «notizie che facevano girare», ossia che «noi
avevamo intercettato l'universo mondo, dalle cariche istituzionali più elevate
ad altri, quando invece non c'erano quasi intercettazioni». E la decisione della
prima sezione di ieri conclude l'ex pm conferma anche «quanto quelle indagini
erano doverose e che non c'era nessun elemento né strumentale né illecito».
Massimo Malpica
Focus sul fenomeno delle
intercettazioni. Quanti processi inutili nati dalla smania di intercettare
tutti.
Gennaro De Falco su Il Riformista il 16 Gennaio 2022.
Nel 2007 il premio Oscar per
il miglior film straniero venne assegnato al film tedesco La vita degli
altri, una storia ambientata nel 1984 nella ex DDR che racconta le vite
parallele del drammaturgo Georg Dreyman e di Gerd Wiesler, un capitano della
Stasi, codice HGW XX/7, che, grazie alle microspie poste nella casa dell’artista
per ordine di un ministro, controllava passo dopo passo la vita di Dreyman e
della sua compagna.
In difesa del “cattivo” devo
anche dire che alla fine non ha commesso violenze fisiche né alterato prove né
si è arricchito o ha fatto carriera alterando le prove contro la vittima delle
sue indagini, e non ha maliziosamente “omissato” per usare non a caso un
orribile neologismo utilizzato nella prassi investigativa. Alla fine HGW XX/7 è
stato più che corretto. Anzi, bisogna anche dire che dal film emerge che le
prove a carico nella DDR degli anni ‘80 non venivano inventate, costruite a
tavolino o alterate. Insomma nella DDR degli anni ‘80 senza vere prove si veniva
assolti e in ogni caso non si veniva arrestati per costringere alla confessione,
se le prove della colpevolezza dell’indagato non si trovavano nessuno ne metteva
di false né c’erano pentiti pronti a tappare docilmente qualunque buco. Comincio
col dire che a me HGW XX/7 piace, il mio eroe nel suo grigiore è lui, e
non Georg Dreyman, il drammaturgo che stava inutilmente intercettando.
Devo ammettere che molto
spesso mi sento come HGW XX/7: lui era con la cuffietta sempre in testa ad
ascoltare suo malgrado le vite degli altri, io con gli occhialetti a leggerle.
Come lui passo molto, troppo del mio tempo chiuso nella penombra dello studio a
leggere le intercettazioni dei processi che di volta in volta mi capitano.
Insomma leggo, a volte anche dalla mattina alla sera, le vite degli altri. Non
solo le vite della gente di strada, dei cosiddetti camorristi nella loro
miserrima e il più delle volte poverissima vita quotidiana. A volte capita anche
di leggere le vite di persone che si conoscono, del medico che cerca di fare
carriera, del poliziotto, del politico nazionale o anche locale che cerca
favori, del giornalista, dell’imprenditore sotto estorsione che non può
denunciare e che, se lo facesse, dovrebbe chiudere in quattro e quattr’otto
perché lo Stato non è assolutamente in grado di difenderlo. A differenza di HGW
XX/7, che entrava nella vita soltanto di due persone e da ufficiale superiore su
delega di un colonnello e su impulso del ministro, insomma in via assolutamente
eccezionale, nell’Italia del 2022, sotto l’imperio del codice garantista
dell’89, le cose in materia di intercettazioni vanno in questo modo: qui le
intercettazioni sono il più delle volte guardonismo di massa. Qui da noi,
rispetto alla DDR degli anni ’80, le cose vanno decisamente peggio.
In realtà, qui da noi essere
intercettati è semplicissimo, basta che un poliziotto qualsiasi scriva
un’informativa assolutamente generica raccontando la storia della camorra,
aggiunga un po’ di numeri di telefono, magari non del tutto a caso, e chieda al
pm di porli sotto intercettazione aggiungendo, come per legge e quando si
ricorda, che si tratta di intercettazioni urgenti ed assolutamente
indispensabili alla prosecuzione delle indagini. Il pm regolarmente emette il
decreto di intercettazioni di urgenza e poi manda gli atti al gip per la
convalida, insomma prima autorizza le intercettazioni e poi chiede al gip di
essere autorizzato ad autorizzare, e le intercettazioni iniziano subito e a
valanga. Occorre dire che questi decreti di convalida sono delle formalità del
tutto inutili, in circa quarant’anni i rigetti delle richieste del pm che ho
visto saranno stati tre o quattro, più o meno uno ogni dieci anni su qualche
migliaio di richieste; in altri termini le probabilità di vincere al
superenalotto sono certamente maggiori del rigetto di una richiesta di
intercettazione o di proroga e, se qualche volta il gip dovesse dire di no al
pm, il pm che fa? Cambia gip e ripresenta la richiesta, in pratica il pm comanda
e decide e il gip sta lì a ratificare.
Le intercettazioni poi
dovrebbero avvenire esclusivamente nei locali della Procura e sotto il diretto
controllo del pm ma, nella pratica, questo non avviene quasi mai. Le
intercettazioni, o meglio la loro sintesi la scrive, nel suo ufficio in un
brogliaccio, non il capitano HGW XX/7 sotto il controllo del colonnello e del
ministro ma il maresciallo Pincopallo di turno. Detto ciò dobbiamo aggiungere
che il 90% dei provvedimenti di intercettazione telefonica che conosciamo si
fondano su valutazioni quanto meno erronee poiché presuppongono l’urgenza e
l’indispensabilità degli ascolti, e questo perché la massima parte delle
intercettazioni telefoniche vengono abbandonate quasi subito in quanto ritenute
ininfluenti dagli stessi richiedenti che ne spergiuravano l’assoluta
indispensabilità ed urgenza sulla scorta di valutazioni che secondo me al di là
delle forme prende la polizia giudiziaria. Insomma, la massima parte delle
intrusioni dello Stato nelle vite dei cittadini si rivelano quasi subito
infondate e per questo vengono quasi sempre immediatamente abbandonate, per poi
finire sui giornali se si tratta di storie piccanti o di vip.
Poi ci sono le cosiddette
intercettazioni a strascico che, come le reti da pesca, vengono gettate a caso
nel mare delle nostre chiacchiere intercettando decine e decine, se non
centinaia, di numeri e poi i pm prendono quello che trovano. Si potrà dire: sì
ma in genere almeno per quello che emerge qualcosa esce. Questo è anche vero, ma
noi sappiamo pochissimo di quello che si ascolta, e poi in un Paese in cui è
vietato tutto e tutti fanno tutto è assolutamente normale che qualcosa esca. Ma
poi chi dice che il maresciallo abbia capito bene la conversazione e il suo
senso e l’abbia trascritta senza forzature o errori? La verità è che nell’Italia
giudiziaria di questi anni le garanzie reali sono molto inferiori a quelle
della DDR degli anni ‘80, può sembrare un’esagerazione ma in effetti non è così.
È vero che i Vopos sparavano a vista su chi cercava di fuggire all’ovest e che
questo da noi sarebbe inconcepibile, ma è anche vero che altri diritti, come
quello alla segretezza delle comunicazioni o le garanzie processuali, erano
riconosciuti e garantiti. Nelle mie intrusioni nella vite degli altri ho letto e
visto di tutto, posso dire che non c’è parlamentare o funzionario pubblico di
rango di cui non siano stati intercettati amori, vita, morte e miracoli.
All’inizio la lettura sembrava
interessante e divertente, ma poi alla fine si è fatta noiosa e ho smesso di
leggere, anche perché era del tutto inutile e anche piuttosto nauseante. La
verità è che brogliacci e intercettazioni non li legge mai nessuno, anche perché
sono talmente tanti che sarebbe del tutto impossibile farlo. È raro che un
imputato in un processo complesso abbia i mezzi per competere con quelli del pm,
che sono praticamente illimitati, e un avvocato che solleciti il proprio cliente
a nominare un consulente per perizie di questo tipo verrebbe immediatamente
sostituito con qualche rassicuratore professionista di passaggio. Una volta una
poliziotta mi disse che con un incarico che aveva avuto per trascrivere un
processo si era comprata casa ed allora, se questa è la situazione, mi pare ci
si trovi di fronte ad un’altra espressione di quel grande ammortizzatore sociale
che chiamano giustizia. Gennaro De Falco
SOLITA GIUSTIZIOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
·
Le Mie Prigioni.
Galera, Prigione, Carcere.
La vita dietro le sbarre. Che differenza c’è tra ‘prigione’ e ‘carcere’: quando
con le parole nasce il castigo.
Antonio Coniglio su Il
Riformista il 10 Giugno 2022.
La parola, nel momento in cui
viene scandita, pensa, concepisce, crea. A volte distrugge, rade al suolo. In
ogni caso, la parola fucina e modella il destino. Perché, in principio, fu il
verbo, il logos e, trovare le parole giuste, rimane l’unico viatico per capire,
intenderci, dar vita alla realtà. Nel corso dell’ultima assemblea di Nessuno
tocchi Caino, a Roma, presso la Società Romana di Nuoto, Sergio D’Elia ha
riflettuto, per esempio, sulla parola “galera”. Sino al XVIII secolo, il reo era
costretto, infatti, a remare nelle galee o galere: navi medioevali spinte dalla
forza delle braccia sui remi.
Nessuno avrebbe potuto
immaginare che, nel momento in cui le navi avessero ammainato le proprie
bandiere, i detenuti, sarebbero stati costretti a trasformarsi in “automi
peripatetici”: coartati a muoversi, come pesci in un acquario, avanti e
indietro, dentro quattro mura, senza un senso, un verso, una destinazione, un
destino! Quale parola usare per definire questa condizione? Di uomini e donne
condannati alla inutilità e all’impotenza? Non certo la
parola “prigione”. “Prigione” deriva dal latino “prehensio”: prendere,
afferrare. Ti prendo, ti afferro e ti porto in luogo distinto dalla società
perché sei pericoloso, nocivo. Per un tempo determinato e senza alcuna
intenzione punitiva. Starai lì, solo fino a quando sarai portatore di insidie e
pericoli per gli altri. Lo Stato deve “sorvegliare”, vivaddio, ma mai “punire”!
L’etimologia di “prigione”, ci consegna allora questa realtà. La crea, gli dà un
nome.
La prigione ha una funzione
meramente preventiva. Non è un caso se, nel mondo classico, i prigionieri erano
protetti da un semplice vestibolo, nel quale, in taluni casi, avevano finanche
la libertà di incontrare parenti e amici. Un vestibolo, un passaggio, un passo
verso qualcosa. Che poteva essere la libertà o anche la morte. Oggi – che è
quasi patrimonio diffuso aver superato la pena di morte nel nome dei diritti
umani universali – il termine “prigione” avrebbe potuto esplicarsi al pieno
della sua capacità inventrice. Uno spazio funzionale solo a “raffreddare”,
stiepidire le passioni morbose, pericolose, per un periodo centellinato della
propria esistenza. Dopo, il quale si potesse ritornare al teatro della vita. La
prigione serve ad continendos homines, non ad puniendos.
In Italia, invece, abbiamo
partorito l’idea insalubre e venefica di abolire le prigioni! Di creare
il “carcere”. Nomen omen: nel nome il presagio, la realtà creata. Carcere deriva
dal verbo latino coerceo. Che significa contenere ma anche domare, reprimere,
frenare, punire, castigare, correggere, costringere all’obbedienza. Prigione non
è sinonimo di carcere. Carcere è invece sinonimico di penitenziario, di istituto
di pena. Sono luoghi progettati ontologicamente per infliggere dolori e
patimenti. Gattabuie del castigo e della terribilità. Se ci incamminiamo oltre,
dobbiamo ulteriormente spaurire. Abbiamo dovuto finanche aggiungere un attributo
perché il nome carcere, in sé e per sé, non rendeva sufficientemente la
proporzione enorme di piaghe e flagelli inflitti. C’è, infatti, un carcere
“ostativo”. Ostativo deriva dal latino ob-stare: stare di contro, opporsi,
contrastare. È la modernità della tortura. Il castigo perpetuo nei confronti
dell’hostis, del nemico. È il coerceo senza limite: la dannazione dell’essere
cristallizzata dallo Stato. Di questo, in questi mesi forse torridi, discuterà
il Parlamento italiano. La Corte Costituzionale ha infatti inspiegabilmente
concesso altri sei mesi al legislatore per superare una norma – l’art. 4
bis della legge sull’ordinamento penitenziario – dichiarata incostituzionale.
Freud era convinto che le
parole originariamente fossero incantesimi. Sarebbe un miracolo, se i signori
deputati cambiassero parole, pronunciassero incantesimi di segno diverso.
Sostituissero, al “coerceo”, il “prehensio”: un prendere, afferrare, per un
tempo limitato, nel nome della sicurezza sociale, compatibile con i diritti
umani universali. E sarebbe un incantesimo, capace di rompere un maleficio,
eliminare quantomeno la parola ostativo. Sarebbe superare una
parola, carcere, che potrebbe anche avere, tra gli avi, l’ebraico carcar, ossia
tumulare, sotterrare. Può lo Stato sotterrare, tumulare, un uomo? I signori
parlamentari hanno dinnanzi a loro, non capi mafia, boss potenti, “giganti della
montagna”, ma uomini ristretti in carcere da più di 20 anni. Inermi, che hanno
il diritto di lasciare il vestibolo, laddove abbiano raggiunto nuovi livelli di
coscienza. Di ritornare nel teatro della vita, oltre ogni scambio sinallagmatico
che umilia le coscienze. I “giganti della montagna” di Pirandello rischiano
invece di essere i deputati del parlamento italiano che – alla stregua di quelli
del dramma pirandelliano – non accettano la proposta della compagnia teatrale
della contessa Ilse e degli scalognati di assistere alla rappresentazione di
un’opera che racconta la storia della vita. Non fate come “i giganti della
montagna”, signori deputati: non ammazzate. Pronunciate parole di segno diverso!
Antonio Coniglio
La costruzione di
nuove carceri. Carceri a pezzi: riprendete i progetti di edilizia penitenziaria
dimenticati dal 1997.
Domenico Alessandro
De Rossi su Il Riformista il 9 Novembre 2022
La “lettera aperta”
pubblicata recentemente su Il Riformista dall’architetto Cesare Burdese, da
tempo consulente del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, affronta
la grave situazione delle carceri italiane ormai resa drammatica. Il documento
indirizzato ai ministri Nordio e Salvini e quindi anche al Dap, dalle pagine del
giornale lamenta l’arretratezza degli interventi sulle carceri, e riguarda la
decisione che il ministro della Giustizia dovrebbe prendere sul modello
Genova per sciogliere il nodo gordiano se ristrutturare le carceri preesistenti
o costruirne di nuove. La testimonianza volta all’attenzione di ben due ministri
così come è stata congegnata parte da una prima asserzione riguardante le
«…questioni irrisolte che appartengono alla nostra edilizia penitenziaria: i
tempi biblici necessari per la realizzazione di un carcere e i limiti culturali
che ne caratterizzano la vicenda progettuale…».
Per prudenza
metodologica è appena il caso di osservare che qualora esistessero effettivi
limiti culturali e altre questioni irrisolte, le diverse problematiche
potrebbero essere meglio risolte proprio all’interno delle diverse compagini
consulenziali chiamate dal Dap e partecipanti ai Tavoli tecnici e nelle
Commissioni. L’architetto tiene a informare i ministri che «…più volte, nel
corso dell’ultimo decennio, sono stato seduto ai tavoli tecnico-consultivi
ministeriali, organizzati sulle questioni carcerarie ed in particolare
sull’architettura penitenziaria…» e in forza di ciò, tiene a precisare che
«…meno problematiche, sotto il profilo temporale, apparirebbero le
ristrutturazioni delle carceri esistenti, che richiederebbero però una più
matura e chiara visione delle soluzioni progettuali ed una programmazione
strategicamente concertata…».
Nella lettera aperta
purtroppo non si menziona quanto fu a suo tempo studiato, per volontà del
presidente Di Gennaro, il problema dell’edilizia penitenziaria sulla base di una
approfondita quanto fondamentale ricerca compiuta dai tecnici del Ministero
della Giustizia nel lontano 1997 con lo studio “Repertorio del patrimonio
edilizio penitenziario in Italia”. A confutare la pretesa originalità
riguardante l’attualità del problema del recupero degli edifici, viene a
sostegno anche quanto emerso ufficialmente nel più recente Seminario di Udine
del maggio di quest’anno “Carcere: Ripartire dalla Costituzione” che sgombra in
modo risolutivo il dubbio in merito alle più opportune azioni da intraprendere
sulla preesistenza edilizia.
Occasione quella del
convegno nella quale uno dei relatori, l’architetto Leonardo Scarcella coautore
insieme all’architetto Daniela Di Croce del sopra citato Repertorio, a chiare
lettere nella sua relazione stigmatizzava: «…Fu così avviata ed effettuata
un’attenta ricerca di archivio e un censimento “sul campo” dei dati di
funzionamento degli istituti in attività così come di quelli ormai inattivi e
degradati. Tutto questo materiale ha consentito la redazione del primo (ed
unico) “Repertorio del patrimonio edilizio penitenziario italiano”, tre volumi
in cui sono stati catalogati ben 219 complessi edilizi (di cui attivi 193) e
individuate sette tipologie edilizie ripartite secondo l’epoca di costruzione e
i finanziamenti operati dai diversi Governi post-unitari: dagli istituti
definiti “storici” (alcuni dei quali addirittura di epoca medioevale) edificati
per altre funzioni ed adattati a carcere, alle carceri di epoca pre-unitaria e
via discorrendo sino al 1997…».
Ma il punto più
significativo della relazione di Leonardo Scarcella, presentata a Udine nel
maggio del 2022 e che scioglie definitivamente il quesito, dimostrando la
consolidata attenzione tecnica (e culturale) del Ministero della Giustizia,
riguarda proprio l’importanza del recupero delle preesistenze edilizie anche
all’interno dei centri urbani consolidati. Infatti: «…oggi, come ieri, appare
evidente l’utilità per l’Amministrazione di conservare il patrimonio immobiliare
storico posto all’interno del tessuto urbano, sia per poter fronteggiare
eventuali e specifiche esigenze logistiche che, come l’esperienza ha insegnato,
emergono nel corso del tempo, sia per realizzare di fatto quella
“differenziazione” di trattamento e degli istituti prevista dall’Ordinamento che
dal 1975 regola l’attività penitenziaria italiana…».
A sostegno ulteriore
di questa tesi, ormai da molti decenni culturalmente acquisita nel sistema
tecnico e professionale degli architetti e degli urbanisti esperti in materia
di edilizia penitenziaria e non solo, è appena il caso di menzionare anche alla
precisa attenzione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al fine
di ampliare la riflessione intorno al problema, il contributo di AA. VV. nei
seguenti volumi che trattano in modo organico e sistemico la tematica in
oggetto: “L’universo della detenzione, storia, architettura e norme dei modelli
penitenziari” – Mursia ed. 2011 e “Non solo carcere, storia e architettura dei
modelli penitenziari” – Mursia ed. 2016, di cui chi scrive è stato curatore e
coautore. In finale, dato che il problema del più corretto approccio
metodologico al recupero del patrimonio edilizio preesistente è ampiamente da
tempo studiato, rimane ora ai più alti responsabili capire quanto sia
fondamentale in questo momento consentire un dibattito il più articolato ed
aperto possibile sul problema delle carceri avvalendosi anche di diversi
contributi dei vari esperti in materia finora inascoltati. Domenico Alessandro
De Rossi
L’Ue bacchetta
l’Italia: «Celle stracolme, basta abusi del carcere preventivo».
Il monito del
commissario europeo per la Giustizia Didier Reynders: il nostro Paese tra i
peggiori in Europa. Nordio: «Giusto processo anche per la confisca dei beni
russi». Simona Musco su Il Dubbio il 10 dicembre 2022
La carcerazione
preventiva nell’Ue «dovrebbe essere usata solo quando strettamente necessaria,
come extrema ratio». A dirlo, al termine del Consiglio di Giustizia a Bruxelles,
è il commissario europeo per la Giustizia Didier Reynders.
«Vediamo una grande
diversità nella detenzione prima del processo nell’Ue – ha sottolineato – la
durata media varia da 2,4 mesi a Malta a 12,9 in Slovenia». E le differenze
riguardano anche il costo medio per detenuto, che varia «da 6,45 euro al giorno
per detenuto in Bulgaria a 332,63 euro al giorno in Lussemburgo», mentre in
Italia il costo è di 135,5 euro al giorno, a fronte di una media Ue di poco
superiore ai 125 euro.
Il Consiglio ha
approvato giovedì le raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di
detenzione nell’Unione, un documento dal quale l’Italia esce fuori con le ossa
rotte, collocandosi – con una media di sei mesi e mezzo – tra i peggio in europa
per utilizzo dello strumento della custodia cautelare. Sono soltanto quattro i
Paesi che possono “vantare” una durata superiore: oltre alla Slovenia si tratta
di Ungheria (12,3), Grecia (11,5) e Portogallo (11). Ma mancano dati precisi su
Paesi come la Francia e la Germania. Secondo il monitoraggio Ue, in Italia circa
il 31,5 per cento delle persone in carcere non ha una condanna definitiva, dato
che si scontra con la media europea, fissata al 25 per cento. Ma negativo è
anche il dato sul sovraffollamento, con una media di 105 detenuti ogni cento
posti. Così il nostro Paese è tra i peggiori Paesi in Ue, collocandosi al quinto
posto dopo Romania (119,3), Grecia (111,4), Cipro (110,5) e Belgio (108,4). Va
solo leggermente meglio in Francia, dove i detenuti sono 103,5 ogni cento posti.
La Commissione ha
dunque chiesto ai Paesi membri di limitare l’uso della carcerazione preventiva
al minimo indispensabile e di provvedere a revisioni periodiche in caso di sua
applicazione. Ma le raccomandazioni riguardano anche gli spazi minimi destinati
ad ogni detenuto, che deve poter usufruire di una superficie minima di almeno 6
metri quadrati nelle celle a occupazione singola e 4 metri quadrati nelle celle
con più persone. Calcolo che deve includere l’area occupata dagli arredi, ma non
quella occupata dai servizi igienici. Il vertice di ieri si è però concentrato
sulla «lotta contro l’impunità nella guerra di aggressione della Russia contro
l’Ucraina», valutando la possibilità di istituire un tribunale speciale per
giudicare «i presunti crimini di guerra commessi dai russi in Ucraina».
Ma non si tratta
dell’unica possibilità, ha sottolineato Reynders, che ha evidenziato una
soluzione ibrida, ovvero un mix di giudici ucraini e di stati membri dell’Ue con
il sostegno dell’Onu e l’input della Corte Penale Internazionale. «La
Commissione – ha evidenziato – è ad ogni modo determinata a far sì che i
responsabili siano assicurati alla giustizia».
Nordio: «Giusto
processo anche per la confisca dei beni russi»
Presente al
Consiglio anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha ribadito
l’impegno dell’Italia a perfezionare l’adozione di un codice dei crimini
internazionali, per assicurare l’adempimento degli obblighi assunti con la
ratifica dello Statuto di Roma. Ma tra i temi affrontati c’è anche quello della
confisca dei beni. «Condividiamo pienamente l’impostazione della proposta che
mira ad assicurare a tutte le persone interessate da queste misure il diritto a
un ricorso effettivo e a un giusto processo – ha evidenziato il ministro -. In
questo senso siamo molto sensibili alle considerazioni che sono state espresse,
affinché le persone interessate possano far valere le proprie ragioni e
contestare gli elementi di fatto e di diritto su cui il provvedimento si fonda.
La nostra esperienza dimostra che è possibile costruire un sistema efficace di
misure patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata. Condivido
l’ipotesi di estendere gli strumenti di confisca previsti dalla direttiva, alla
violazione di misure restrittive dell’Unione».
L’ergastolo non è
uguale in Europa, alcuni Stati lo hanno abolito.
In Italia, in caso
di buona condotta, il condannato all'ergastolo può chiedere la libertà
condizionale solo dopo 26 anni. Damiano Aliprandi su Il Dubbio il 10 dicembre
2022
La pena
all’ergastolo, considerando i Paesi Europei, è un istituto che si presenta in
forme variegate per quanto riguarda la richiesta dell’accesso ai benefici. Per
quanto riguarda la libertà condizionale, il panorama europeo su questo fronte è
piuttosto variegato, e l’Italia è tra i Paesi più “duri” sull’accesso a questo
beneficio. Ad aver formalmente abolito l’ergastolo sono in pochi: Norvegia,
Croazia, Serbia, Bosnia, Portogallo e Città del Vaticano. Per quest’ultimo,
ricordiamo che Papa Francesco nel 2013 l’ha sostituito con la detenzione fino a
un massimo di 35 anni, in linea con la sentenza della Corte Europea dei Diritti
Umani del 9 luglio 2013.
Per quanto riguarda
l’Italia, come oramai è noto, abbiamo anche l’ergastolo ostativo e il dibattito
– nonostante le condanne da parte della Cedu e le recenti sentenze
costituzionali – è ancora molto forte. Ma parliamo dell’ergastolo “normale” che
è previsto per delitti contro lo Stato, l’incolumità pubblica e la vita e per
tutti quei reati per cui, fino al D.leg.lgt 10/08/44 n.224, era istituita la
pena di morte. Il sistema italiano permette al detenuto, in caso di buona
condotta, di chiedere la libertà condizionale dopo 26 anni e maturi sconti di 45
giorni ogni sei mesi per buona condotta.
Ma altrove? Il
periodo minimo da scontare prima che un detenuto possa avvalersi della libertà
condizionale varia da paese a paese, il minimo va dai 12 anni (per esempio
Danimarca e Finlandia) ai 15 (per esempio Austria, Belgio, Germania, Svizzera).
Nel nostro Paese bisogna attendere 26 anni per fare richiesta. Nelle
giurisdizioni del Regno Unito, il periodo di reclusione è determinato al momento
della sentenza da parte dell’organo giudicante; la legge non prevede un periodo
minimo assoluto a tal riguardo.
Altri paesi come
la Bulgaria, Lituania, Malta, Olanda e per alcuni reati, Ungheria, Repubblica
Slovacca e Turchia, non hanno un sistema di scarcerazione condizionale per i
detenuti condannati all’ergastolo, per cui una condanna a vita significa
letteralmente e biologicamente a vita. Per rendere bene però l’idea della
“durezza” nostrana, bisogna ricapitolare: la legge austriaca ammette
l’ergastolo, ma di fatto dopo 15 anni, se è accertato che non esiste più il
rischio di recidiva, si può provvedere alla scarcerazione o richiedere la
grazia.
Lo stesso avviene
negli ordinamenti giudiziari di Danimarca (dopo aver scontato almeno 12 anni),
Finlandia (11 anni), Germania e Regno Unito (in entrambi 15 anni). Il Belgio di
fatto assimila l’ergastolo a 30 anni di reclusione, con possibilità di
scarcerazione dopo un terzo della pena prevista se il detenuto, prima del
delitto, era incensurato e dopo due terzi se è recidivo, e lo stesso prevede
l’ordinamento francese, ma con limiti minimi rispettivamente di 18 e 22 anni,
mentre la scarcerazione anticipata si può applicare solo per motivi gravi di
salute. Da noi invece – e parliamo sempre di quello “normale” – bisogna
attendere 26 anni senza se e senza ma. Da ribadire che, ovviamente, non c’è
alcun automatismo. La decisione di concedere o meno la libertà condizionale
spetta sempre alla magistratura di sorveglianza.
“Dotto’ vi posso offrire
qualcosa”, il giudice Puglia e la visita al detenuto in sciopero della fame.
Viviana Lanza su Il Riformista il 3 Novembre 2022
Carcere, funzione della pena,
diritti, garantismo, magistratura. A volte, per comprendere a fondo il senso di
tutto ciò, più delle teorie possono valere i fatti e le parole con cui quei
fatti sono raccontati. È per questo che credo meritino di essere condivise le
parole che, giorni fa, Marco Puglia, magistrato di Sorveglianza, uno di quei
magistrati che entra nelle carceri e il cui impegno e il cui valore umano e
professionale sono unanimamente e diffusamente riconosciuti negli ambienti
giudiziari, ha usato per raccontare sulla sua pagina Facebook un’esperienza
vissuta.
Il suo è un racconto che
diventa un messaggio di speranza e una lezione di garantismo per chi sta ancora
a domandarsi se davvero è necessario che i magistrati imparino a entrare
nelle carceri per vedere con i propri occhi qual è la realtà della reclusione e
imparino anche a coltivare una certa sensibilità giuridica e umana. «Oggi due
vicende molto significative sono accadute nella mia giornata: una terribile,
l’altra piena di speranza. Voglio raccontarle perché sono state per me motivo di
riflessione», esordisce il magistrato Puglia nel suo racconto. «Le racconterò,
però, in ordine cronologico inverso, perché voglio rischiarare il buio con la
luce».
«Oggi pomeriggio un’auto è
rimasta parcheggiata davanti al passo carraio del portone di ingresso della
palazzina dove abito, impedendo a tutte le vetture di entrare e di uscire.
Quando, dopo una lunga attesa, il proprietario si è deciso a tornare gli ho
fatto notare il suo comportamento. Per tutta risposta sono stato pesantemente
minacciato, con una rabbia ed una violenza che raramente ho visto. Sono rimasto
nel mio difficile quartiere, che a volte amo ed altre volte odio, e ho messo in
conto anche questo…». Poi c’è l’altra parte del racconto.
«Oggi c’è stato, però, un
evento speciale per me. Stavo lavorando in carcere quando una educatrice mi ha
chiesto di parlare con un detenuto che da più di un mese stava facendo lo
sciopero della fame. Nonostante avessi pochissimo tempo le ho detto di sì e sono
corso con lei nella cella dove c’era questo ragazzo di ventotto anni, ormai
magrissimo, disteso a leggere. Sono entrato da solo. Appena mi ha visto, con
fatica, si è messo a sedere ed io mi sono seduto accanto a lui. Abbiamo iniziato
a parlare e ad un tratto mi ha chiesto: “Dotto’ vi posso offrire qualcosa?”. Ed
io: “Sì, ma solo se lo dividete con me”. E allora barcollando si è diretto al
suo armadietto dove in una piccola busta legata con un nodo, c’erano dei pacchi
di salatini. Me ne ha passato uno, l’ho aperto e, mentre parlavamo della sua
storia, abbiamo condiviso quel piccolo pasto insieme. Ed è stato così che ho
capito che ciò di cui quel ragazzo era più affamato, era il bisogno profondo di
essere ascoltato. Avevo davanti a me un uomo smarrito e spaventato. Ed i suoi
occhi hanno parlato con sincerità ad un giudice che era contento di stare seduto
su un letto di una cella di un carcere a mangiare dei salatini. Ed io, in quel
luogo tanto disadorno ed inconsueto, mi sono sentito utile e meno solo. Perché
la giustizia non è fatta solo di articoli di legge o processi. È fatta anche di
speranza, di una speranza fatta anche di piccoli gesti che arrivavo da chi non
ci aspettiamo. Oggi un uomo libero mi ha causato un dolore. Un uomo che la
propria libertà l’ha persa mi ha donato, invece, un raggio di speranza. Ed è a
questo dono, solo a questo dono, che voglio continuare a pensare per non
perdermi mai nel buio in cui alcuni sembrano irrimediabilmente persi».
Perché la giustizia è
speranza, come dice il giudice Puglia. E invece certa politica e certa
magistratura sembra voler mirare a spegnerla quella speranza, a mortificare i
diritti che la sorreggono, ignorare l’umanità a cui sottende. Un cambio di
passo, quante volte lo si è anelato, quante volte lo si è inserito tra le
priorità sempre poi sacrificate quando è stato il momento di passare dalle
parole ai fatti. Intanto nelle carceri si muore (siamo arrivati ormai
a settantadue suicidi dall’inizio dell’anno e a un numero impressionante di atti
di autolesionismo), dalle carceri non si esce rieducati, le carceri non servono
a fare giustizia né a garantire maggiore sicurezza. Sono il buio.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Manettari all'attacco del
giornale dei detenuti. Il Fatto si scaglia contro Ristretti Orizzonti:
“Colpevoli di scrivere”
Tiziana Maiolo su Il Riformista il 17 Novembre 2022
Sembra una vera istigazione a
punire, quella lanciata ieri dal Fatto contro una serie di detenuti chiamati con
nomi e cognomi, colpevoli di scrivere le proprie opinioni sulla rivista del
carcere che va sotto il nome di Ristretti orizzonti. Vengono sfottuti, anche, “I
boss diventano opinionisti”, e richiamati, in modo che chi di dovere si imprima
bene l’elenco delle loro malefatte nella memoria, i tremendi reati commessi,
quelli che, venti o trent’anni fa li hanno portati all’ergastolo. “Ostativo”,
ecco la parola chiave. Detenuti al regime del “41-bis”, ecco l’altra parola
chiave. Sembra un paradosso. Da una parte si legittima Roberto Saviano e il suo
diritto a insultare con la parola più infame nel nome della libertà di pensiero
e di parola. Dall’altra si mettono alla gogna gli ergastolani, come se non
stessero comunque e da lungo tempo scontando la loro pena, perché osano pensare,
avere opinioni, e persino comunicarle con la scrittura.
Lo spunto arriva da un atto
più che discutibile di una onlus dal nome “Casa della carità”, diretta
da Christian Abbondanza, che avrà sicuramente avuto il merito di studiare
l’espansione delle mafie, in particolare la ‘ndrangheta, nelle regioni del nord,
ma questa volta ha compiuto un atto violento e cinico. Secondo quanto raccontato
dal Fatto questa onlus avrebbe presentato un esposto alla Dia, perché
“attraverso Ristretti Orizzonti vengono promosse o diffuse pubblicazioni, anche
scritte dagli stessi detenuti, di sistematico attacco all’ergastolo ostativo e
al 41-bis”. Dunque, se abbiamo capito bene, la Direzione Investigativa
Antimafia dovrebbe aprire indagini sulle carceri di mezza Italia e censurare il
diritto di pensiero di parola e di scrittura dei detenuti che si esprimo sulla
loro rivista. Perché questo è Ristretti Orizzonti, il luogo di espressione di
chi è “ristretto” e spera che il proprio orizzonte non cominci e finisca dentro
le mura di una prigione. È la rivista della speranza, del riscatto e del
cambiamento, di quelli che hanno fatto un percorso autocritico, hanno lavorato,
hanno studiato, alcuni si sono laureati. In giurisprudenza, spesso. E questo fa
scandalo.
Lo stesso articolo
del Fatto riconosce l’importanza dell’esistenza di un luogo del pensiero come
quello. Ma il suo ruolo è anche di denuncia, andrebbe aggiunto, come il lavoro
minuzioso e certosino di ricerca sul fine vita, oltre che sul fine pena.
Sulle morti “naturali”, dietro cui si nasconde troppo spesso la non voglia di
sopravvivere più se non si può vivere. E sui suicidi, tragico conteggio che
quest’anno sta arrivando agli ottanta. Ristretti Orizzonti parla di libertà e di
diritti. E perché non dovrebbe divulgare il proprio pensiero critico sia su quel
laccio che stringe alla gola coloro che sono destinati dalla condanna
all’ergastolo ostativo, vera pena di morte sociale, che sul trattamento previsto
dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario che aggiunge chiusura a
chiusura, catenacci a catenacci? Vogliamo togliere loro anche l’aria, oltre alla
libertà? Singolare modo di ragionare, quello di coloro che hanno chiamato in
causa la Direzione Investigativa Antimafia. Fanno le pulci mettendo il naso
dentro la redazione della rivista. “Fino al 2014 – denunciano nell’esposto – vi
scrivevano perlopiù detenuti comuni, dopo è cambiato tutto”.
Sarebbero stati i boss
mafiosi a impadronirsi della rivista, a conquistare il potere (il potere?), a
imporre le proprie battaglie. Pensate che osano persino comunicare concetti come
questo: “Non si può comprimere la volontà di riscatto… a chi sta rivedendo la
sua storia, riesaminando le sue scelte criminali, rendendosi disponibile a fare
testimonianza della sua vita e del suo percorso in varie forme…”. Ma tra questa
forme non è contemplata la collaborazione, fa subito notare il Fatto. Sta tutto
qui il succo del discorso, lo scandalo da segnalare addirittura alla Dia. C’è da
domandarsi a che tipo di sub-cultura appartengano gli aderenti alla onlus che ha
presentato l’esposto. Sia per aver cercato di coinvolgere un’importante agenzia
investigativa che ha il compito di prevenire l’espandersi delle attività
criminali e non certo quello di soffocare la rivendicazione dei propri diritti
da parte di chi sta scontando la pena e sta rivisitando in forma autocritica il
proprio passato. Ma anche per l’ignobile divulgazione di nomi e cognomi con
allegata casella giudiziaria. Una vera gogna cui, ma di che stupirsi,
il Fatto si è prestato a fare da trombettiere.
Tiziana Maiolo. Politica e
giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e
XIII legislatura.
Lettere al
Riformista. “La solitudine dei numeri ultimi in carcere grida in silenzio”.
Redazione su Il Riformista il 7 Dicembre 2022
Riceviamo e
pubblichiamo il testo della lettera al nostro giornale di Luigi Mollo, studente
del Corso di Laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti
Umani presso l’Università degli studi di Padova, progetto università in carcere.
Ai numeri si può far
dire qualsiasi cosa e quando l’hanno detta gli si può attribuire la lunga scia
di suicidi, decessi e presunte torture in diversi Istituti Penitenziari, oggetto
di recenti indagini da parte della Magistratura in varie regioni del nostro
belpaese. Una sorta di solitudine dei numeri ultimi, si, perché qualsiasi
persona che commette un reato, diventa numero ultimo della società. I numeri
ultimi che si sono suicidati sono per la maggior parte detenuti in attesa di
giudizio o con pena residua inferiore ai due anni. Nel corso di quest’anno, sono
giunte ai Garanti Regionali e al Garante Nazionale, nonché alle varie Procure
della Repubblica e ai Magistrati di Sorveglianza, allarmanti segnalazioni di
un’aumento relativo ad abusi e maltrattamenti che rendono alcuni Istituti
Penitenziari, luoghi punitivi e non rieducativi. Dato di rilievo sono anche i
suicidi dei custodi delle persone private della libertà, sebbene regni
un’incertezza sulle dimensioni del fenomeno e delle cause che spingono un agente
di polizia penitenziaria a togliersi la vita.
Ci si chiede perché,
le maggioranze di governo presenti e passate negli ultimi anni hanno attribuito
alla pena, soprattutto alla sua declinazione più afflittiva, il valore di
elementi identitari dei loro manifesti ideologici in grado di risolvere con la
privazione della libertà personale ogni male sociale, attraverso l’ordine
giudiziario che nel complesso ha partecipato attivamente ad infliggere condanne
e custodie cautelari senza applicare per gli eventi di minor delittuosità,
misure alternative alla detenzione. Eppure la Corte Europea con i suoi moniti e
strumenti normativi deflattivi di ordine e genere ha consegnato nelle mani della
magistratura il ruolo di protettrice della libertà e dei diritti umani
essenziali, ma mese dopo mese, la solitudine dei numeri ultimi è aumentata in
modo esponenziale, come aumentate le sanzioni disciplinari interne, gli episodi
giornalieri di autolesionismo, aggressioni, scioperi della fame e interruzione
delle terapie farmacologiche.
L’opinione pubblica
conosce poco rispetto alla moltitudine di aspetti della vita dei ristretti, non
è al corrente se sul serio è assicurato il diritto alla salute fisica e
psicologica e, soprattutto, non conosce quali guasti comporti fisiologicamente
la detenzione, costituita da mille privazioni ulteriori alla condanna emessa da
un tribunale. L’aria in un carcere diventa rarefatta, come lo sono i contatti
con i familiari e la propria intimità. Solo chi ha vissuto una detenzione ha
conosciuto cosa significhi vivere in spazi sovraffollati, lavarsi mani e faccia
con acqua gelida, espletare funzioni fisiologiche mentre sei costretto a subire
il controllo da parte degli agenti dalla finestrella posta nel bagno-cucina,
provare l’esperienza di una cella vuota o comunemente chiamata liscia, riservata
a detenuti con tendenze depressive o suicide.
I segreti del
carcere sono ben protetti da muri alti e spessi, nessuno può sapere cosa accada
realmente e quanti episodi di ordinaria follia finiscano nell’omertà che lo
Stato Italiano trova ineleganti ed inopportuni raccontare, preferendo un che
marciscano in carcere.
La solitudine dei
numeri ultimi grida in silenzio, se qualcuno ha qualche dubbio fategli delle
domande, i numeri risponderanno sempre.
Ultraottantenni
dietro le sbarre. Nonnetti in carcere, le storie di Antonio, Enrico e Santo e
dei ‘piantoni’ in via d’estinzione.
Fabio Falbo su Il
Riformista il 9 Dicembre 2022
Il rispetto
della Costituzione italiana è di tenere in gattabuia dei “nonnetti”? Sono
detenuto a Rebibbia da molti anni. Da un anno sono nel reparto G8 dove condivido
il mio tempo e il mio spazio con persone molto anziane. Di nonni dietro le
sbarre voglio segnalare solo tre casi, ma ce ne sono molti altri a Rebibbia e in
altri luoghi di pena.
Il primo è quello
di Antonio Russo. È nato a Napoli il 7 luglio del 1938. Ha quindi 84 anni e un
residuo pena di anni 10. Il secondo è quello di Enrico Mariotti. È nato a Roma
il 19 dicembre del 1940. Ha perciò 82 anni, è detenuto dal 15 marzo del 2007 e
un fine pena fra 7 anni. Il terzo è quello di Santo Barbino. È nato a Sinopoli
il 13 dicembre del 1942. Ha quindi già vissuto 80 primavere, è detenuto dal 23
aprile del 2009 e il suo fine pena è “mai”. Che prospettiva di riabilitazione,
percorso e senso di rieducazione potranno mai esserci su persone
ultraottantenni? Se per il Russo la libertà sarà a 94 anni, per il Mariotti a 90
anni e per il Barbino mai? Dov’è il Diritto in questi casi? V’è la violazione
del principio di proporzionalità affidato alla stessa pena e connesso
alla funzione rieducativa insita nell’articolo 27, terzo comma,
della Costituzione.
V’è anche la
violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’articolo
3 della Costituzione. Vi è almeno una presunzione relativa di incompatibilità
con il regime carcerario fondata su ragioni umanitarie oltre che sulla evidente
inadeguatezza della gattabuia a svolgere pienamente la sua funzione
costituzionale nei confronti di chi ha un’età così avanzata. Lo stesso
legislatore ha presupposto la diminuzione della pericolosità sociale del
condannato ultrasettantenne e il contenimento mediante l’obbligo di permanenza
nel domicilio, con le prescrizioni e i controlli impartiti dal giudice.
Il nostro
legislatore ha posto l’attenzione sulla presunzione relativa di incompatibilità
facendo capire che con l’avanzare dell’età cresce il carico di afflizione
associato alla permanenza in gattabuia, considerate le grandi necessità
di cura e assistenza personalizzate, che non possono essere assicurate
nell’attuale contesto intramurario, contrassegnato dalla coabitazione forzata
con persone di ogni età, con diverse patologie anche psichiatriche, con
posizioni giuridiche e pene diverse. A tutto ciò sì aggiunge la mancanza dei
cosiddetti “piantoni”, persone anch’esse detenute che si prendono cura di
persone affette come nel caso di Antonio Russo da gravi malattie: ipertensione
arteriosa; cardiopatia ipertensiva; episodi di extrasistole; esofagite; artrosi;
insufficienza venosa con problemi agli arti inferiori. Stessa condizione
sofferente riguarda i tanti ultrasettantenni per i quali anche statisticamente
la sola età costituisce una patologia.
I “piantoni” si
prendono cura dei “nonnetti” facendo le pulizie della loro stanza,
accompagnandoli a fare la doccia o in infermeria, lavando loro i panni e altro
ancora. Purtroppo queste figure sono in via d’estinzione per mancanza di fondi e
i “nonnetti” sono lasciati a perire e soffrire senza cura. Anche per una
semplice operazione come il taglio delle unghie c’è chi è costretto ad affidarsi
al buon cuore di un compagno di detenzione o per motivi di dignità a
soprassedere. L’età avanzata della persona condannata e la conseguente
sofferenza addizionale connessa alla permanenza in carcere devono essere
considerazione preminente circa l’attualità e necessità della pena, di
qualsiasi pena e regime detentivo. Ciò vale anche per i detenuti
ultrasettantenni in regime di 41 bis, perché la morte per vecchiaia di un
detenuto rappresenta una grave sconfitta per lo Stato di diritto.
Il giudizio sulla
pericolosità ritenuta nel passato è superato e neutralizzato nel presente
di “nonnetti” che sono ormai ben lontani nel tempo e nello spazio da contesti,
ambienti, occasioni, relazioni, capacità al delitto, tant’è che alcuni
usufruiscono di permessi premio, sono stati ai domiciliari o hanno avuto accesso
al lavoro esterno. È ora che questa realtà sia considerata non solo dalla
società civile, ma dal legislatore perché emani norme definitive che
stabiliscano un automatismo della scarcerazione non più affidata al potere
discrezionale del Giudice che, purtroppo, finisce per creare discriminazione tra
casi analoghi.
Intanto spero che ai
miei “nonnetti’ del reparto G8 di Rebibbia sia concessa una misura
alternativa ispirata al principio di umanità della pena. Ho raccontato di loro
perché la Costituzione si capisce meglio se la mettiamo a confronto con i casi
concreti. Come i personaggi del romanzo di Victor Hugo sono persone cadute in
una condizione di miseria umana che non è personalmente la loro, ma quella che
connota il loro stato di detenzione in luoghi detti di privazione della libertà
ma che sono – non solo per loro, ormai “vecchi”, ma anche per quelli
ancora “giovani” – divenuti di privazione anche della salute e della vita. Della
dignità di esseri umani.
Fabio Falbo Detenuto
a Rebibbia
Lettera di un ex
detenuto a Sbarre di Zucchero.
“Dopo 24 anni di
privazione della dignità, da uomo libero ho corso verso il sole con il gusto
della vita in bocca”. Rossella Grasso su Il Riformista l’8 Dicembre 2022
G. ha espiato una
pena di 24 anni, tra carcere, lavoro esterno e il regime di semilibertà. Mentre
il mondo fuori correva e cambiava rapidamente, lui ha trascorso gli anni della
sua giovinezza lontano dalla vita vera e dalle sue evoluzioni anche
tecnologiche. A un certo punto gli è stata data la possibilità di poter lavorare
all’esterno. Racconta la sensazione di poter mettere un piede fuori dal carcere
dopo 14 anni che era recluso. E anche la miriade di contraddizioni e intoppi che
devono affrontare i detenuti che riescono a ottenere la possibilità di lavorare
all’esterno del carcere. “La privazione della dignità di un uomo o di una donna
continua, anche fuori, in altri termini, sotto altra forma ma persiste”, scrive.
Poi è passato alla semilibertà, e dopo all’affidamento in prova ai servizi
sociali. La “libertà” diventa così un cumulo si sensazioni contrastanti, le
contraddizioni continuano: “Sei fuori, ma non sei libero”, scrive G. Poi è
arrivato quel momento che ha tanto aspettato, la fine della pena, la libertà
vera. “Quando i carabinieri ti comunicano la scarcerazione, corri. Corri verso
il sole, con un sapore del tutto nuovo, corri con il gusto della vita in bocca.
Ed è un gran bel gusto, scopri che la vita ha un gran bel sapore”. Riportiamo di
seguito la lettera di G. a Sbarre di Zucchero.
Sono stato
condannato a 24 anni. Ho compiuto 21 anni in carcere. Nel 2013 ho avuto accesso
all’art 21 esterno, erano 14 anni che non mettevo piede fuori, permessi esclusi.
Prima esperienza di lavoro una cooperativa sociale che si occupava di
manutenzione del verde. Per accedere a questa misura serviva aver raggiunto
alcuni termini di espiazione pena, avere una proposta di lavoro e una relazione
di sintesi che si esprimesse positivamente su quella che viene chiamata
esperienza extra muraria. Se per l’equipe che redige la relazione di sintesi sei
pronto, se il magistrato di sorveglianza è d’accordo e il PM non si appella,
viene redatto un programma di trattamento contenente delle prescrizioni molto
precise e dettagliate. Al primo “sgarro” la misura può essere sospesa o
revocata. La teoria dice questo. La pratica è un po’ diversa.
Nel programma di
trattamento trovi scritto che non puoi fare uso di un telefono cellulare.
Peccato che nel mondo esterno non esista altro strumento di comunicazione. Io
che avevo persino saltato il boom del web, delle mail e dei social, sarei stato
completamente tagliato fuori, se qualcuno non mi avesse aiutato. Ti dicono che
puoi mandare una mail. Peccato che non tutti sappiano cosa sia e come si fa. Non
hai la patente, quindi ti muovi in bicicletta. Questo vuol dire che se abiti a
Palermo ti bagni 10 volte su 100 giorni, ma se abiti a Padova ti bagni 70 giorni
su 100 giorni. Se stai male, sei come lavoratore tutelato dalla malattia,
peccato però che se ti senti male nella notte, dopo aver fatto rientro, risulta
difficile comunicare al numero della reperibilità della tua azienda che alle 05
del mattino non potrai essere in turno.
Impensabile
modificare gli orari contenuti nel programma di trattamento, quindi se l’azienda
che ti assume ha bisogno per esigenze di servizio di cambiarti il turno, o di
chiederti straordinario non può minimamente contare su di te, anche se risulti
essere il dipendente più volenteroso e affidabile. Il tuo compenso viene versato
dall’azienda che ti assume in un libretto di risparmio intestato al carcere, e
gestito da un ufficio addetto denominato conti correnti che amministra per tuo
conto il denaro. Se vuoi comprarti una maglia, devi avere qualcuno che ti presta
quella cifra, presentare ai conti correnti la richiesta di rimborso, e loro con
i loro tempi ti rimborseranno la cifra spesa. Idem se devi malauguratamente
andare dal dentista, o se vuoi comprare un regalo. Tu non sei padrone dei tuoi
soldi. Gli stessi soldi che ti sei sudato tagliando l’erba nelle aiuole.
Così la privazione
della dignità di un uomo o di una donna continua, anche fuori, in altri termini,
sotto altra forma ma persiste. Il tuo datore di lavoro, deve sempre
interfacciarsi con la casa di reclusione di appartenenza se ha una qualsiasi
esigenza, l’ufficio apposito che si occupa dei detenuti ammessi al lavoro
esterno risponde quando riesce, perché ovviamente in termini di numeri sono
sempre oberati. Nel frattempo, l’attesa per il datore di lavoro diventa un
limite oggettivo, quindi alla prima possibilità, tu sei sempre quello più
sacrificabile. L’unica alternativa in termini di comprensione sono sempre le
cooperative sociali, che non comprendono perché sono umane, ma perché hanno un
comprensibile ritorno economico che gli permettere di essere un po’ più
pazienti. Ecco perché c’è stato un avvento di cooperative sociali che accolgono
persone “svantaggiate”.
Dopo l’art.21
esterno, sono passato alla semilibertà, e poi all’affidamento in prova ai
servizi sociali. Quest’ultima misura, tra tutte, la più rigida e la più
rischiosa. Termini di accesso: lavoro sicuro, una residenza, una capacità
economica utile al sostentamento del nucleo che sei o che crei, obbligo di
prestare opera di volontariato. Se inceppi, in qualsiasi momento, torni dentro,
e il tempo espiato, viene resettato. Cancellato. Torni indietro dallo start
senza passare dal via, un po’ come al Monopoli. Solo che qui gli imprevisti e le
probabilità non sono ammessi. Tenendo conto dell’epoca storica, è impensabile
per tutti quelli che raggiungono i termini giuridici averne accesso, ma resta
l’unica misura che ti permette di chiudere con le sbarre, le guardie, i
cancelli, e di riprendere in mano con fatica la tua vita.
Inizi a rispondere
solo all’UEPE (Unione Esecuzione Penale Esterna) e alle forze dell’ordine
responsabili di controllare il rispetto delle prescrizioni. Esci per andare a
lavoro, hai qualche ora di svago che devi motivare con un hobby, e devi
incastrare il volontariato. Nel tempo che resta puoi pensare a te stesso. Una
volta concessa la misura ti chiama la casa di reclusione e ti chiede di andare
prima possibile a prendere le tue cose. Caspita, dopo che per anni ti
trattengono in un posto, e si accertano mille volte che tu sia rientrato, ad un
certo punto devi raccogliere velocemente tutto e andartene. Cosa si prova? Mah.
Di tutto, è un misto di emozioni e sensazioni, che solo con il tempo riesci ad
elaborare. Ti dicono di prendere le tue cose, io ho ritirato le carte per la
scarcerazione, foto segnaletiche come quando arrivi, firme come se fossi un divo
del cinema, di mio non ho preso quasi niente, ho regalato tutto. Eravamo
d’accordo che a casa non avrei portato niente. Ed effettivamente non volevo
niente, mi portavo già dentro un peso e un bagaglio di stati d’animo e
vicissitudini che sarebbe rimasto dentro di me per sempre, non mi serviva altro.
La mia vita ormai
era fuori già da tempo. Non avevo un sacco, io. Molti però vengono sbattuti
fuori con un sacco nero. Li vedi alla fermata del bus o per la strada con dentro
un mondo in un sacco di plastica. Sono loro quelli che come me stanno uscendo
per riprovarci fuori. Non ero smarrito, lo smarrimento lo avevo provato già anni
prima appena uscito per la prima volta. Ero però destabilizzato. Per quanto fin
dal primo giorno che entri, non vedi l’ora di uscire, quando questa arriva così
tra capo e collo, sei destabilizzato. Per un paio di giorni, mi sono sentito
frastornato. Poi tutto ha iniziato a funzionare, e mi sono buttato in questa
nuova avventura. Colloqui mensili con l’assistente sociale, è a lei che chiedi
di muoverti o spostarti, è lei che filtra le tue richieste all’ufficio di
sorveglianza, che le tara e le corregge secondo il suo senso del giusto.
Sono compresi come
in ogni rapporto, gli sforzi, le incomprensioni e le arrabbiature. E anche i
fraintendimenti. Le fatiche e i nervosismi. E’ ingannevole come misura. Sei
fuori, ma non sei libero. Hai del tempo per te, ma non è tuo il tempo. E dalle
21.00 alle 05.00 del mattino che erano i miei orari, l’unico modo per verificare
che io avessi rispettato rientro e uscita era quello di suonare il campanello.
Ognuno fa il suo mestiere. Non c’è inverno o freddo che tiene, se suonano devi
farti vedere. Ma sei a casa. Ormai hai imparato a vedere il lato positivo delle
cose, e la libertà ha solo lati positivi. Ormai ti sei di nuovo fatto spazio nel
mondo. Ormai sei di nuovo in gioco. Sei di nuovo vivo, autonomo e responsabile
del nucleo famigliare che sei hai avuto fortuna sei riuscito a creare. Senti di
nuovo la vita che ti scorre tra le mani. La libertà che trasuda da ogni poro
della tua pelle. L’affidamento dura due anni. E due anni davanti ad una pena
così lunga cosa vuoi che siano. Te li bevi in un bicchiere d’acqua due anni.
Così quando i carabinieri ti comunicano la scarcerazione, corri. Corri verso il
sole, con un sapore del tutto nuovo, corri con il gusto della vita in bocca. Ed
è un gran bel gusto, scopri che la vita ha un gran bel sapore. a cura di
Rossella Grasso
L'indifferenza
della società civile e la politica che vorrebbe nuove prigioni.
Il carcere urla,
siamo tutti sordi: il report della strage che non interessa a nessuno. Francesca
Sabella su Il Riformista il 7 Dicembre 2022
Siamo dietro le
sbarre. In carcere. In queste celle ci sono stati 79 suicidi nei primi undici
mesi dell’anno 2022. Si tratta del dato più alto degli ultimi dieci anni. 79
persone che hanno deciso di togliersi la vita perché vivere in quelle carceri è
come vivere in un girone infernale. Negli ultimi dieci anni, negli Istituti
penitenziari nazionali, si sono verificati 583 suicidi di persone di età
compresa tra i 18 anni e gli 83 anni. Con un lenzuolo stretto intorno al collo,
inalando il gas che viene fuori dai fornelli per cucinare, lasciandosi morire
semplicemente… Si uccidono così gli uomini e le donne che vivono in cella, gli
invisibili.
Eppure, la loro
anima pesa ventuno grammi, esattamente come la nostra, come quella dei liberi,
come i bravi di questa società. Solo che quando muoiono loro fanno tutti
spallucce: che importa tanto era un derelitto, un rifiuto umano, uno che
dopotutto stava in carcere. E nessuno dice niente. Eppure i numeri non mentono,
parlano, urlano. Sono i numeri diffusi dall’ultima relazione del garante
nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Mauro
Palma. A Napoli, tra le celle del carcere di Poggioreale, negli ultimi dieci
anni, c’è stato il più alto numero di suicidi: 21 e si contano anche 267
tentativi di suicidio.
Il carcere
napoletano è diventato lo scenario di una strage. È una strage senza precedenti,
è una strage che passa in sordina tra l’indifferenza della politica che anzi ha
come unica soluzione la costruzione di nuove carceri-cimitero e dei media. Non
c’è spazio per gli ultimi né dentro ai penitenziari dove il sovraffollamento è
ormai una regola né fuori dove la gente libera, quella che appartiene alla
società civile non ha e non vuole avere idea di cosa succede nelle carceri. Ma
torniamo ai numeri diffusi dal garante. Analizzando i dati personali, si rileva
che delle 79 persone che si sono tolte la vita 74 erano uomini e 5 donne. Va
ricordato che la popolazione detentiva complessiva alla data del 30 novembre è
di 56.524 persone, di cui 2.389 donne. Queste ultime – lo ricordiamo –
rappresentano mediamente il 4% della popolazione detenuta. Riguardo alla
nazionalità, 46 erano italiane e 33 straniere (18 delle quali senza fissa
dimora), provenienti da 16 diversi
Paesi: Albania (5), Tunisia (5), Marocco (5), Algeria (2), Repubblica
Dominicana (2), Romania (2), Nigeria (2), Brasile (1), Nuova
Guinea (1), Pakistan (1), Cina (1), Croazia (1), Eritrea (1), Gambia (1), Georgia (1), Ghana (1), Siria (1).
Le fasce d’età più presenti sono quelle tra i 26 e i 39 anni (33 persone) e tra
i 40 e i 54 anni (28 persone); le restanti si distribuiscono nelle classi 18-25
anni (9 persone), 55-69 anni (6 persone) e ultrasettantenni (3 persone).
Sono i detenuti più
giovani che non ha retto il peso della disumanità del carcere e hanno deciso di
farla finita. Le fasce d’età più presenti nella relazione, infatti, sono quelle
tra i 26 e i 39 anni (33 persone) e tra i 40 e i 54 anni (28 persone); le
restanti si distribuiscono nelle classi 18- 25 anni (9 persone), 55-69 anni (6
persone) e ultrasettantenni (3 persone). Si rileva che 12 persone appartengono
alle fasce d’età dei più giovani e dei più anziani e che l’età media delle 79
persone che si sono suicidate è di 40 anni. Con riferimento alle modalità che
hanno caratterizzato l’atto suicidario, in 71 casi (89,9%) è avvenuto per
impiccamento, in 4 per inalazione di gas; in 3 per lesioni alle vene. In un caso
il dato non è stato riportato. Leggere come si sono tolte la vita 79 persone che
erano sotto la tutela dello Stato forse apre uno spiraglio per riflettere su
questa smania giustizialista e manettara che affligge la nostra società.
È facile dire «più
carcere per tutti, più carcere per più tempo». Ma se carcere fa rima con morte
siamo ancora convinti di continuare a urlare questo? Prima della morte arriva la
solitudine. A proposito del periodo dell’anno in cui avvengono i suicidi, dallo
studio è emersa una loro distribuzione nell’anno solare che incontra
ciclicamente dei picchi di maggior concentrazione in occasione di periodi
festivi, come il mese di agosto, nei quali, verosimilmente, diminuisce negli
Istituti la presenza di personale e di soggetti della comunità esterna e si
riducono le attività, a cominciare da quella scolastica. Sono soli sempre, in
alcuni periodi dell’anno la solitudine diventa insopportabile. La carenza di
medici, psicologi, educatori è una piaga della quale abbiamo scritto e scritto,
lo hanno urlato i garanti e i familiari dei detenuti. Ma nulla.
Sono parole vuote,
sono tutti sordi. E sordi sono stati pure alle grida d’aiuto dei detenuti che
poi hanno deciso di farla finita. La lettura ha fatto emergere che 65
persone (pari all’82,28%) erano coinvolte in altri eventi critici, mentre altre
26 (ossia il 33%) avevano precedentemente messo in atto almeno un tentativo di
suicidio (in 7 casi addirittura più di un tentativo). Inoltre, 23 persone (ossia
per il 29% dei casi) erano state sottoposte alla misura della “grande
sorveglianza” e di queste 19 lo erano anche al momento del suicidio. Grande
sorveglianza. Leggere queste due parole mentre scorriamo la lista di suicidi in
carcere è un ossimoro. Nessuno li sorveglia, non li sorveglia la politica, la
società civile. Non li sorveglia uno Stato che è fuorilegge…
Francesca Sabella.
Nata a Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole ha
deciso, non senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro.
Giornalista pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi
protagonisti.
Lettere dal carcere a
Sbarre di Zucchero. “Quando sono entrato in carcere mi hanno spogliato di tutto,
anche della dignità”
Redazione su Il Riformista il 17 Novembre 2022
“Quando si entra in un
istituto, perdere la tua dignità avviene immediatamente, eliminata con dei
procedimenti medioevali e da torture psicologiche e fisiche”. Sono queste parole
di F., che racconta quello che gli è successo quando è entrato in carcere. F.
racconta come una persona smetta di essere un uomo e diventa matricola, numero.
F. ripercorre come, appena varcata la soglia del carcere, lui abbia perso
completamente la dignità, diventando una “marionetta”, “nudo come un bambino
appena nato, come un verme”, impaurito e inerme. E paradossalmente l’unica cosa
che gli viene da dire mentre viene spogliato di tutto, compreso della sua anima,
è “grazie”. Dopo quegli interminabili momenti di terrore, quando ormai è rimasto
solo, sente finalmente una voce amica, un altro detenuto che dalla cella accanto
gli dice: “Ti ho fatto un caffè, poi più tardi cucino, ti faccio la pasta”.
Anche lui come F. aveva subito quella sorta di rito con cui un uomo perde la sua
dignità. Riportiamo di seguito la sua lettera a Sbarre di Zucchero.
Eh si la dignità, ciò che un
essere umano ha per se stesso. La dignità non si può condividere, si può
spiegare, si può mostrare, però non si può vendere o dare. Però quando si entra
in un istituto perdere la tua dignità avviene immediatamente, eliminata con dei
procedimenti medioevali e da torture psicologiche e fisiche. Quando arrivi in un
istituto passi per un ufficio matricola dove apparentemente loro sanno di te, il
perché sei lì, e ovviamente dopo la decima volta che ti prendono le
impronte, parlano fra di loro chiamandoti “il pacco”. Arrivi in un’ altra stanza
che si chiama “Casellario” e lì uno capisce che la sua vita, la sua dignità è
pari a meno zero. Manca solo un camino ardente in bianco e nero utilizzato nel
1940.
“Spogliati! Dammi tutto quello
che hai! Soldi, anelli, vestiti, catenina,…”. “Già sono le 18”, dice l’altro. Tu
sei lì, perso a guardare a cercare di capire che cosa vogliono da te. Però
niente, continuano. “Ahhh ma questi sono 1000 euro, allora sei ricco! Vedrai qua
dentro. Togliti le mutande”, e li le guardi come se la tua vita stesse per
finire. “SPOGLIATI HO DETTO!”, grida uno. E tu pensi “ma chi è sta gente che ti
grida addosso”, ma niente. Alla fine ti spogli, ma spogliandoti poco a poco ti
senti morire dentro umiliato e finito, la tua dignità sta scomparendo poco a
poco, per ogni cosa ogni vestito che ti levi, ogni tua cosa personale. Poi
quando sei lì nudo come un bambino appena nato, nudo come un verme, non hai più
forze ne per parlare per ribellarti, una voce arriva dritta al cuore: “METTITI A
NOVANTA GRADI CHE DOBBIAMO VEDERE SE NASCONDI QUALCOSA”.
Non hai neanche più la forza
di dire qualcosa, ti senti stuprato, violentato, ti senti zero e anche meno di
zero. Poi un tipo viene e guarda. Cosa guarda? La tua dignità. Ti dice: “GIRATI
FAI DELLE FLESSIONI, ANZI NO, FANNE 3, POI ALZA TUTTO CHE DOBBIAMO VERDERE,
GIRATI RIMETTITI A NOVANTA GRADI”. E tu come una marionetta senza anima lo fai
perché non sei più chi eri mezz’ora ora prima. Poi ti dicono: “ADESSO VESTITI,
SEI QUASI FELICE PERÒ”. Una voce dice: “Ma quello adesso dove lo mettiamo?”.
E li ti senti come se il mondo che conoscevi non c’è più, cerchi di pensare ai
figli, a tua moglie, a tua a madre, tuo padre, agli amici. Ma niente. Il tuo
cervello si è chiuso, non hai neanche più il minimo istinto preistorico.
Poi un’altra voce. E lì inizi
a sudare freddo, a pensare di tutto, a tutto quello che ti possono fare ancora.
Però era solo per dirti: “Queste sono le tue scarpe senza lacci. Questa è la tua
felpa senza il cappuccio. La tua cinta la teniamo noi”. E tu gli dici ok, e
anche grazie! Non so perché gli ho detto grazie. Si vede che ancora dentro di me
c’era qualche istinto di galateo. Poi ti portano in una stanza. Sono solo,
guardo intorno vedo un letto di ferro con un materasso di gomma con un cucino
dello stesso materiale, una sedia un tavolo di legno dove puoi leggere messaggi
di altri come me passati in questa stanza.
Finalmente sono solo, cerco di
iniziare a capire dove sono, cosa sono, cosa succederà. Ancora però poco a poco
cerchi di ridarti la fiducia in te. Inizi a fare il letto. Piangi, ti stendi.
Pensi, pensi e piangi. E ripiangi. Poi una voce dalla stanza accanto: “Ciao
fratello chi sei? Di dove sei? Perché sei qui? Ti ho fatto un caffè, poi più
tardi cucino, ti faccio la pasta”. Una voce amica, una voce che ha passato lo
stesso che ho passato io, una voce che non cerca di spogliarmi ma di darmi
conforto. Eh si questa voce mi ha abilitato al carcere. Il mio inizio, la mia
entrata.
Lettere dal
carcere a Sbarre di Zucchero. "Apri e chiudi, apri e chiudi. Mi porterò per
sempre dentro il rumore di quelle chiavi".
Rossella
Grasso su Il Riformista il 30 Novembre 2022
Dal carcere
femminile una detenuta racconta la sua quotidianità in carcere cadenzata dal
"rumore assordante delle chiavi". Prima di arrivare dov’è adesso ha vissuto in
un altro carcere dove le detenute erano poche e quasi traspare dalle sue parole
un senso di maggiore umanità nel contesto e nella vita. Ma nel carcere dove si
trova adesso invece sembra che anche le persone abbiano perso umanità, che tutto
sia ridotto a quell’ "apri, chiudi. Apri, chiudi" che sembra quasi il ticchettio
di un orologio che lava spazio alla speranza. Dalla sua testimonianza di donna
traspare quanto condizioni di vita più umane in carcere possono favorire meglio
percorsi di riabilitazione alla vita. Riportiamo di seguito le sue parole
nella lettera a Sbarre di Zucchero.
Quando entrai in
carcere 5 anni fa, ebbi una bella accoglienza dalle ragazze; il primo dove sono
stata è un carcere piccolo, ospita circa 30 donne detenute, e quando entrai io
il periodo di detenzione non mi pesò particolarmente a differenza di quando fui
trasferita in un altro carcere. Quando entrai in quest’altro carcere, a parte la
trafila che devi fare, mi misero in cella con una donna con disagio psichico che
il giorno prima aveva tentato di impiccarsi, potete capire quindi il mio
sgomento: mi misi in un angolo nel mio letto e piansi fino a non avere più
lacrime.
La signora
occupava tutti i mobiletti e a me ne lasciò uno piccolo nel quale dovevo mettere
tutte le mie cose… vestiti, scarpe, piatti, tutto ciò che avevo. In questo
carcere non ho visto una sola ragazza che mi sia venuta in soccorso, anche solo
per chiedermi come stavo, le prime volte che scendevo all’aria mi guardavano
tutte come se fossi un’extraterrestre, nessuna si avvicinò; solo dopo una
settimana due ragazze mi si avvicinarono e cominciarono a parlare con me, e
furono proprio loro ad offrirmi il lavoro che tutt’ora svolgo. Queste due
ragazze ora sono uscite, ma intrattengo con loro un rapporto di corrispondenza
bellissimo, fa piacere sapere che nonostante non siano più detenute non si sono
dimenticate di me.
Sono detenuta qui
da circa 5 anni, e dirvi che va tutto bene e che tutto funziona alla perfezione
sarebbe una bugia, tutti i santi giorni ti devi scontrare con la burocrazia,
anche solo per avere i giorni di liberazione anticipata, richiesti mesi prima e
ancora non arrivati, oppure devi discutere con le agenti per poter frequentare
un corso e magari loro non hanno segnato il tuo nome, e vieni costretta ad
aspettare che loro chiamino per verificare, con tutta calma, non capendo che per
noi che frequentiamo i corsi questi minuti sono molto importanti, visto che ogni
lezione dura solo un’ora e mezza. Qui in questo carcere ci aprono le celle alle
9 del mattino, dopo che è passata la terapia, e possiamo andare all’aria oppure
ai corsi o al lavoro (per chi ha la fortuna di lavorare); alle 11 ci chiudono di
nuovo per il passaggio del vitto e ci riaprono alle 11.30 ma rimaniamo in
sezione.
Alle 13.30
possiamo invece tornare all’aria o, eventualmente, a qualche corso se è previsto
nel pomeriggio. Ed in queste 2 ore in sezione restiamo a parlare tra noi, a
giocare a carte, o incontrarci con altre detenute dell’altro reparto. Alle 15.30
altra chiusura per il nuovo passaggio della terapia, e qui mi voglio soffermare
un attimo in più: questa chiusura dura quasi sempre più del previsto, e mi
chiedo perché chiuderci alle 15.30 se poi la terapia non passa mai prima delle
16.10? E considerando anche che alle 16.50 ci richiudono un’altra volta per la
cena, non potrebbero lasciarci aperte qualche minuto in più? Dopo la cena
possiamo stare con le celle aperte fino alla definitiva chiusura delle 18.45 e
buonanotte, se ne riparla il giorno dopo. Ed io mi chiedo: a cosa servono tutte
queste chiusure? Apri e chiudi, apri e chiudi, un rumore assordante di quelle
chiavi, un rumore che ti entra dentro e che temo continueremo a sentire anche
quando non saremo più lì dentro.
Lettere sul
carcere a Sbarre di Zucchero.
“Avete mai visto
come muore un uomo in carcere? Io sì, da marzo ad agosto per ben tre volte”.
Redazione su Il Riformista il 4 Novembre 2022
“La vita detenuta
è una lunga marcia attraverso la notte, e si avanza verso un vuoto senza nessuno
sbocco. Non si vive, si mantiene in vita solo un corpo che non ti appartiene più
perchè è diventato di proprietà del Ministero di Grazia, talvolta
dell’Ingiustizia”. Così scrive L., 42 anni, iscritto al Corso di laurea in
Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani grazie al progetto
università in carcere. Non ci sta a rassegnarsi all’idea che la vita dopo il
carcere sia solo al buio e si impegna costantemente, con tutte le sue forze, a
cambiare le cose e il suo futuro. Ha raccontato la sua esperienza in carcere a
Sbarre di Zucchero. Sottolinea la sua “osservanza in particolare a: chi mi ha
dato l’ opportunità di iniziare un percorso di studi universitari in carcere e
di poterlo continuare attualmente, auspicando ad un futuro lavorativo per i
diritti e doveri delle persone private della libertà personale, a chi lotta con
idee di carta e penna ogni giorno, a tutti gli uomini di potere che possono
migliorare le condizioni detentive”. Riportiamo di seguito le sue parole,
raffinate e delicate, ma che arrivano dritte al punto come un pugno allo
stomaco.
Il carcere, così
com’è pensato e amministrato attualmente, è come il mercatino degli uccelli di
Bangkok, nel quale i mercanti vendono ai moltissimi turisti gli uccelli
catturati e tenuti in gabbia, così che i turisti possano acquistarli per poi
liberarli, credendo ingenuamente di liberare il loro karma negativo come narra
la mitologia orientale. Peccato che i turisti non sappiano che i mercanti
abbiano addestrato gli uccelli a far ritorno nelle loro gabbie. Con licenza
poetica ecco che i carceri/mercati sono le gabbie di uccelli/detenuti, e i
detenuti/uccelli vengono addestrati a far ritorno nelle loro gabbie/celle.
Questa è l’amara
realtà, e finché il carcere non cambierà prospettiva, il reinserimento e il
recupero del reo resteranno sempre un fallimento dello Stato Italiano. Il reo,
la cui condanna diventa definitiva dopo il terzo grado di giudizio, dovrebbe
subire solo la privazione della libertà ed iniziare il percorso di recupero
previsto dalla Costituzione, ma le attuali violazioni della dignità e i
trattamenti inumani hanno portato quest’ultimo a commettere gesti di
autolesionismo nell’ordine delle migliaia, e decine di suicidi di cui tanto si
parla ma per i quali a pochi importa. Tanto era solo un delinquente!
Domando a voi: avete
mai visto come muore un uomo in carcere? Io sì, da marzo ad agosto per ben tre
volte. Chiudono immediatamente tutta la sezione, si attendono le autorità di
turno e d’improvviso vedi la forma di un corpo in una barella, chiuso in due
grandi sacchi neri, giunti a metà da nastro per pacchi portato via
frettolosamente. Poi tutta quell’aria ristagnante torna normale, come se non
fosse accaduto nulla. Questo come può essere classificato? Un problema
politico? Lo stesso Parlamento non ha mai mostrato reale interesse ad
un’esecuzione della pena con modalità legali, nonostante l’attuale voragine in
cui versano gli Istituti Penitenziari Italiani sia sotto gli occhi di tutti i
perbenisti.
Un problema di
opinione pubblica? Nessuno pensa che per il reo che riottiene la propria
libertà, inizia una seconda carcerazione costituita da negazioni lavorative e
personali. I perbenisti conoscono la realtà del carcere? È un ambiente
difficile, se non sei strutturato e forte per sopportarlo la tua mente finisce
per esserne distrutta. Il tempo infinito, il dover aspettare per ricevere
qualsiasi cosa logora. E poi c’è la solitudine, il senso di abbandono, lo
sconforto, il sentirsi continuamente sbagliati, la sensazione di essersi
rovinati la propria vita e di non avere più alcun un futuro. Perdi la speranza e
se in quel momento sei solo ti lasci andare alla disperazione e commetti atti
terribili.
Nonostante io creda
fermamente che sia giusto “pagare” per quanto commesso, penso che sia
altrettanto giusto e fondamentale, avere la possibilità di ricostruire una vita
dietro le quinte, lontana dai giudizi.
Ribadisco
che, quando un detenuto ritorna in libertà ancora vivo ma senza soldi, casa,
famiglia, con il nulla con cui è entrato, torna inevitabilmente a delinquere e
scatta quella terribile cosa che è la recidiva. C’è bisogno di una maggior
collaborazione con la società esterna, il detenuto non è sempre e solo una
persona da cui stare alla larga, non è un mostro né per forza un delinquente è
spacciato. È una persona che ha sbagliato, ha pagato e che molto spesso ha solo
tanta voglia di riscatto. La certezza della pena non è solo carcere. E i tempi
biblici del paese di santi poeti e navigatori per attuare un piano adeguato per
l’edilizia penitenziaria, lasceranno spazio a nuove lesioni commesse per mano
dello Stato sul detenuto materiale umano.
Lettere dal
carcere a Sbarre di Zucchero. “La mia colpa è di essere donna e straniera,
nessuno mi ascolta. È questa la giustizia? Io la chiamo violenza”.
Redazione su Il Riformista l’8 Novembre 2022
C. è una detenuta
straniera. È finita nelle maglie della giustizia e poi in carcere. Fino ad ora
non aveva mai avuto a che fare con tribunali e avvocati ne tantomeno con il
carcere. Da incensurata si è sempre professata innocente e sin da subito ha
cercato di far sentire la sua voce ma senza esito. In una lettera a Sbarre di
Zucchero racconta tutta la sua frustrazione nell’affrontare il carcere e tutta
la burocrazia della Giustizia che le impedisce anche di poter lavorare come
infermiera perchè per i giudici sarebbe sprovvista del titolo professionale. Ma
lei racconta che il titolo lo possiede dal 1998, riconosciuto dal ministero
della salute in Italia, ma soprattutto è iscritta all’Albo professionale agli
infermieri, dove paga regolarmente la quota annuale. “Posso solo dire a squarcia
gola che sono innocente, non sono mai stata presa in considerazione, mai
ascoltata, mai compresa, forse perchè sono donna, straniera? Questa e la mia
grande colpa?”, scrive nella lettera. Riportiamo di seguito le sue parole.
Ricordo come fosse
oggi il fatidico giorno del mio arresto. Sono le ore 7.20 e il campanello di
casa suona insistentemente… la mia libertà, la dignità, la fiducia,
l’onorabilità mi viene portata via. La mia vita da quel giorno cambierà
drasticamente!
Da quel
momento iniziò l’incubo della mia vita, risuonano come un macigno le parole dal
ispettore della Polizia quella mattina: “vedrai che tra pochi giorni uscirai”. I
pochi giorni diventarono settimane, mesi, quasi un anno…La domanda mi sorge
spontanea: Che tipo di giustizia abbiamo oggi in Italia? Fortuna? Accanimento?
Il PM che segue il caso? il giudice obbiettivo? l’avvocato preparato e
competente? Non so più cosa pensare e cosa aggiungere…Posso solo dire a squarcia
gola che sono innocente, non sono mai stata presa in considerazione, mai
ascoltata, mai compresa, forse perchè sono donna, straniera? Questa e la mia
grande colpa?
Ho sempre creduto
molto nella giustizia, nelle istituzioni e nelle leggi ma oggi posso dire che
tutto e crollato. La mia verità nessuno e ripeto, nessuno ha mai voluto
sentirla, 5 minuti in video conferenza chiamiamolo pure monologo non certo
interrogatorio e tutto quello che mi è stato concesso. Speravo fortemente in una
seconda possibilità, essere ascoltata dal PM ma mai mi e stata concessa! Solo se
avessi patteggiato mi avrebbe preso in considerazione. Questa e giustizia? Io la
definisco violenza, notti cariche di incubi, pianti, tristezza e tanta tanta
rabbia. Perché negare la possibilità di parlare e ascoltare? E poi perché
patteggiare e confermare cose che io non ho mai fatto, di cui sono stata
accusata ingiustamente? La mia negazione ha fatto si che la mia permanenza in
carcere durasse ben un anno, e altri tanti mesi privati della libertà fra
domiciliari e obblighi sulla persona, tutto questo da incensurata.
La mia forza fu la
mia innocenza che mi permise di essere combattiva e determinata, tanto
che scrissi direttamente io tramite la matricola del carcere al P.M. chiedendo
cortesemente di venire ascoltata perché ero l’unica che poteva spiegare, con
prove alla mano la veridicità dei fatti. Una risposta non mi e mai pervenuta, a
distanza di tempo trovai nei fascicoli la risposta del PM: viene rigettata la
richiesta in quanto non e stato specificato il motivo dell’incontro. Vorrei
urlare al mondo intero il mio dolore, ma qualcuno mi ascolterà mai? Sono
fermamente convinta che la giustizia non e uguale per tutti. Si basa sulla
persona? su chi la giudica? dal tribunale? dalla scalata della carriera? dal
conto in banca? Dall’avvocato potente? da chi sei? da dove vieni? Oggi da
incensurata mi chiedo: perché non ho mai avuto diritto ad un beneficio? La legge
non è uguale per tutti.
A giugno
vengo condannata in primo grado a quattro anni per aver costituito
l’associazione di cui non conosco neppure i partecipanti, e non ho mai avuto
contatti con loro ne visivi ne telefonici. In questi giorni si parla molto della
certezza della pena di chi sbaglia deve pagare ma, della mala giustizia non se
ne fa riferimento. E lì chi sbaglia e giusto che non paghi mai? A oggi non
faccio neanche l’elenco dei rigetti ricevuti con le motivazioni più assurde e
della continua delusione accumulata. Vi faccio un breve cenno
all’ultima richiesta dove chiedo di poter svolgere il mio lavoro di
Infermiera (parlando della giustizia riparativa). Mi viene rigettata l’istanza
di richiesta delle revoche delle firme dando come motivazione che da nessun dato
emerge che io possegga il titolo professionale richiesto. Vorrei precisare
che possiedo il titolo di infermiera dal 1998 con un riconoscimento del Ministro
della salute italiana e sono iscritta all’Albo professionale agli infermieri,
dove pago regolarmente la quota annuale. GRAZIE A CHI SA ASCOLTARE!
Peggio di una
fogna, il carcere è una cloaca che non va da nessuna parte.
I suicidi sono gente
come noi. E non è vero che hanno l’esclusiva della depressione. Ascanio
Celestini su Il Dubbio il 18 novembre 2022.
I suicidi sono gente
come noi. E non è vero che hanno l’esclusiva della depressione.
Mi ricordo uno che a
San Vittore aveva scritto una lettera a un amico suo che viveva a Monza. Non si
ricordava il cap e l’ha chiesto al secondino, ma quello non aveva l’obbligo di
dirglielo. E infatti non gliel’ha detto. Passano due o tre giorni e viene la
moglie a colloquio, ma manco lei si ricorda il cap. Dopo qualche altro giorno
ritorna e glielo dice. Quel detenuto milanese mi fa “Si può impazzire in una
cella con una lettera che ci hai attaccato pure il francobollo e non la puoi
spedire”.
Mi ricordo uno che
studiava per laurearsi. Poi è tornato in galera nei giorni di Natale, ma era il
carcere di Trani e l’anno era il 1980. Si cena presto in galera e questo lo
ammanettano a uno che viene sbattuto giù per le scale. Pure lui caracolla di
sotto. Fino al santantonio di botte. Ma gli avevano imparato a proteggersi la
testa e i testicoli e si è salvato. Adesso è diventato buddista. Ha scritto un
libro. Mi ricordo uno che mi dice “Io non sono razzista… anzi, sono razzista.
Quando sono entrato per la prima volta in carcere ho chiesto al comandante di
stare con un siciliano come me. C’era un palermitano, io sono di Catania. Mi ha
messo con lui. Non li sopporto gli stranieri. Coi veneti ci posso pure provare a
stare. Ma i bulgari o peggio ancora gli arabi non li sopporto”.
Mentre faccio
l’intervista scoppia una rissa nei passeggi dell’ora d’aria. Albanesi contro
marocchini. Si tagliano. Arriva l’ambulanza. Gli infermieri si mettono i guanti
di plastica per raccattare i feriti. Si difendono da Aids e epatite. Le guardie
non intervengono subito. Bisogna prepararsi. Servono guanti e scudi. Quando
arrivano… quello che doveva succedere è successo. Uno mi racconta che gli
psicologi sono pochi e riescono a stare con i detenuti per un tempo medio di 25
minuti al mese. E poi è come il pollo di Petrolini. Qualcuno ne mangia due e
qualcun altro resta a pancia vuota. Lo stesso succede con lo psicologo. Qualcuno
lo incontra per un paio d’ore. Qualcuno se lo scorda per mesi e mesi. Qui
dovrebbero esserci gli psicologi tutti e tutti i giorni. Invece ci stanno gli
psicofarmaci che tengono tutti buoni e rincoglioniti. Se li inghiottono quei
pilloloni, ma se li sniffano pure, li sbriciolano e se li pippano.
I sessantamila
detenuti sono buttati con un calcio nel sedere in un buco nero che è peggio di
una fogna. Perché le fogne a volte sfociano nel mare, mentre il carcere è una
cloaca che non sfocia da nessuna parte.
Lettere a Sbarre
di Zucchero. “Le giornate in carcere non passano mai, a darci la forza sono solo
le compage di cella”.
Rossella Grasso su
Il Riformista il 23 Novembre 2022
Come trascorrono le
giornate in carcere? A raccontarlo in una lettera a Sbarre di Zucchero è una
detenuta che ha vissuto anche l’ isolamento. Racconta di aver dormito per giorni
interi, sola e estraniata, rincuorata solo dalle visite delle altre detenute che
ogni tanto le allungavano un caffè e qualche sigaretta. Poi la vita in carcere è
cambiata quando è stata trasferita in sezione insieme alle altre. Una
abitudinaria routine fatta di nulla o poco, che si ripeteva inesorabilmente
tutti i giorni a orari precisi e sempre uguale. In carcere tutti i giorni sono
identici e rischiano di gettare le persone recluse in un vortice di
disperazione. “Quel posto veramente è stato molto duro e faticoso, ma le persone
che ho avuto vicino mi hanno dato la forza e ho cercato anche io di dare la
mia per rendere almeno la nostra convivenza piacevole e di supporto ad una
situazione già brutta di per sé”, racconta la detenuta nella lettera. Ne
riportiamo di seguito il testo integrale.
Sono entrata in
carcere a febbraio 2021. La sera in cui arrivai mi ricordo che ero estraniata
completamente, non sentivo niente in merito a quello che stava succedendo e dopo
una intera giornata dalla finanza arrivai alla sera e mi chiusero in isolamento,
dopo il tram-tram del controllo. Ho dormito penso giorni interi, le ragazze
venivano alla mia cella, per fortuna, e mi portavano sigarette e caffè. Che
felicità ricevere quelle piccole cose. Finito isolamento inizio la vita vera in
carcere, tra doccia mattutina calda o fredda a seconda della giornata e altre
cose, ho sempre cercato di tenermi impegnata. Col periodo Covid però non c’ era
molto da fare, non c’ erano tante attività promosse. Anzi nessuna. Sono finita
nella cella 290, la mitica cella 290, la mia dimora per un anno, eravamo in
3, ragazze che considero famiglia ora. Tutte le ragazze della sezione sono state
per me persone importanti. Senza di loro non sarebbe stato uguale. E ringrazio
dio che ho trovato belle persone nel mio viaggio.
Già alle 6 ero
sveglia, io e una mia concellina scendevamo dal letto e ci trasferivamo per non
svegliare l’ altra concellina. Nel bagnetto della cella, mettevamo sul
fornellino la moka già pronta dalla sera prima per il primo caffè. Mi ricordo il
freddo (io e la mia concellina abbiamo indossato il pigiama in pile fino a
maggio!). Dopo 2 moke e sigarette al bagno, e il buon giorno, arrivava l’
infermiera e il carrello con la colazione e così cominciava la giornata. Si
svegliava anche la nostra altra concellina e la terza colazione aveva inizio
sedute a tavola, il momento più bello della giornata (con un po di fantasia)! Un
rassetto veloce della camera, due chiacchiere, oroscopo mattutino alla TV, rtl
music per iniziare bene la giornata a ritmo di musica e tatan si sente urlare al
microfono: battitura! Già, ogni mattina stessa routine: con un martello le
guardie passavano a verificare che le sbarre fossero integre.
Se era mio turno
andavo a lavorare, pulivo sezione, sennò c era l’orario per le docce comuni e si
andava all’ aria a camminare. Giù ci si incontrava con le ragazze delle altre
sezioni e diciamo la mattina andava. Con l’ orario di pranzo alle 12.30 mi
incontravo con le mie concelline e si chiaccherava del più e del meno. Cercavo
sempre di tenere su il morale anche se non è stato sempre facile ma ci si
aiutava in questo l’una con l’altra: quando una non ne poteva più una c’era l’
altra che cercava di dare quel sorriso in più. Per quello ringrazio sempre per
le persone che ho avuto vicino. Il pomeriggio era un po’ più lungo, infinito
direi. Dopo l’aria del post pranzo, in cui giocavo a calcetto (ero numero uno,
ogni tanto). Era divertente perché tenere impegnato cervello non ti fa pensare
tanto ai problemi, alla condanna e alla pesantezza di quello che vedi, senti.
Della tristezza che vedi negli occhi delle persone, della rabbia,…
Di fatto dopo le 16
non c era molto da fare, tra tv e TV arrivava l’ora della cena alle 18.30 in
seguito partita a carte, ci ritrovavamo in saletta e via quante guerre a carte
eravamo agguerrite proprio! Arrivano finalmente le 9 orario di chiusura e dalla
saletta ci chiudevano di nuovo in cella. Per me era il secondo momento più bello
della giornata, un altro giorno era passato. Se avevano voglia con le radioline
di radio Maria ci sintonizzavamo sulla stessa frequenza cuffiette e via si
rideva scherzava ballava sennò chiaccheravamo e se ci andava preparavano
frittelle o cose da mangiare per il film serale. Ho vari bei ricordi nel cuore
che ho costruito con fatica perché quel posto veramente è stato molto duro e
faticoso, ma le persone che ho avuto vicino mi hanno dato la forza e ho cercato
anche io di dare la mia per rendere almeno la nostra convivenza piacevole e di
supporto ad una situazione già brutta di per sé. Purtroppo solo tra noi
detenute: non c’era nient’altro che ti dava la forza, almeno parlo per me. Ora
sono ai domiciliari, la fine ancora non la vedo, ma vado avanti perché non si
può mollare mai.
Rossella Grasso
Lettere sul
carcere a Sbarre di Zucchero. “Essere la moglie di un detenuto significa avere
ogni giorno il cuore rotto”.
Rossella Grasso su
Il Riformista il 12 Novembre 2022.
Il carcere non è
un dramma solo per i detenuti, ma anche per le loro famiglie. Spesso la pena non
la paga solo chi ha commesso un reato, ma anche sua moglie o marito, i figli, le
mamme, i fratelli. Persone che soffrono non solo la lontananza fisica, che a
volte è lunga chilometri, ma anche il quotidiano fuori dalle mura del carcere
che è più difficile da affrontare in solitudine. A Sbarre di Zucchero scrive la
moglie di un detenuto che racconta la sua vita che è come una corsa ad ostacoli:
nel crescere i figli da sola, nell’andare e venire dal carcere lontano 172
chilometri da casa, nel trovare e mantenere un lavoro “perché quando chiedi il
giorno di permesso per andare ai colloqui si spaventano e pensano che anche tu
non sei una brava persona e quindi devi essere emarginata”. Nel riuscire a
mantenere un rapporto affettivo diviso tra 4 telefonate da 10 minuti e 6 ore di
colloquio al mese. “Essere la moglie di un detenuto è sacrificio ma è anche
coraggio e forza di affrontare la vita da sole, perché l’unica cosa che ti senti
dire ‘è bhe se sta li qualcosa ha fatto'”. Riportiamo di seguito la lettera
della moglie di un detenuto.
Oggi ti voglio
raccontare cosa significa essere la moglie di un detenuto. Essere la moglie di
un detenuto significa avere ogni giorno il cuore rotto. Avere la responsabilità
di crescere i figli da sola e non importa se sia, un figlio o più. Perché
comunque è dura. Essere la moglie di un detenuto significa dover fare avanti e
indietro nei carceri o nelle comunità, e quando non sei ne compagna ne moglie ma
semplicemente il vostro amore è nato da poco devi combattere per avere la 3°
persona e non sai nemmeno se te la accettano. Se sì, vali poco. Perché l’amore
tra un detenuto e la 3° persona non vale come amore? No sembra di no.
Ti scrivo per dirti
che mio marito oggi ha già finito le 4 chiamate, gliele hanno messe solo ieri ma
sai, 10 minuti volano e adesso dobbiamo aspettare lunedì per poterci sentire
ancora 10 minuti. Niente videochiamata sta settimana perché ha solo 6 ore di
colloquio visivo e se fa la video non posso andare al colloquio. Ci separano 172
chilometri e ogni mese sono soldi per poter andare da lui, soldi per la persona
che ti guarda i bambini, soldi per chi ti accompagna, soldi per il pacco, soldi
da lasciare a lui. Tutto questo per avere 2 ore di ossigeno. Ma sono anche tanti
sacrifici che vengono fatti con il cuore ma pesano su una famiglia dove solo la
madre porta avanti tutto.
“La mia colpa è di
essere donna e straniera, nessuno mi ascolta. È questa la giustizia? Io la
chiamo violenza”
Essere la moglie di
un detenuto alla quale un magistrato di sorveglianza ha dato solo rigetti anche
per i lavorativi. Un lavoro capisci! Un lavoro con cui voleva cambiare vita e
mantenere la famiglia e qualcuno ha deciso per un no. Essere la moglie di un
detenuto significa perdere ogni lavoro che trovi perché quando chiedi il giorno
di permesso per andare ai colloqui si spaventano e pensano che anche tu non sei
una brava persona e quindi devi essere emarginata. Essere la moglie di un
detenuto significa dover sostenere da sola le spese dei figli della casa e di
tuo marito che avendo un fine pena magari più breve di altri allora non ha
diritto a lavoro ma ha comunque una dignità e tu da moglie la devi portare in
alto.
Essere la moglie di
un detenuto è sacrificio ma è anche coraggio e forza di affrontare la vita da
sole, perché l’unica cosa che ti senti dire “è bhe se sta li qualcosa ha fatto”.
Essere la moglie di un detenuto è questo e molto altro. Ma una cosa è certa:
essere la moglie di un detenuto è anche sapere che il vostro amore è più forte
di tutto questo e che fuori da quelle 4 mura siete più forti di tutto ciò che
avete passato. Scusa lo sfogo.
Rossella Grasso.
Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su
varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia.
Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra
le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos,
Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli.
Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’
autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio
mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.
"C'è chi inizia a
drogarsi quando entra in carcere".
Inferno carceri, la
denuncia della garante: “La droga in cella è il malessere silente che
distrugge”. Rossella Grasso su Il Riformista il 12 Novembre 2022
“La droga in carcere
è un problema enorme, un malessere silente. Chiedo alle istituzioni aiuto e
cooperazione per avviare una catena di interventi che sia efficace e
risolutiva”. È questo l’appello di Emanuela Belcuore, Garante dei detenuti della
Provincia di Caserta. La garante racconta al Riformista che stanno aumentando le
segnalazioni di droga che circola in carcere. Un problema che è sintomo di un
malessere diffuso e che peggiora l’inferno delle carceri.
“Ho denunciato alle
autorità competenti la presenza di droga in carcere, un vero dramma – spiega la
Garante – Succede che ex tossicodipendenti, che magari erano riusciti a non fare
più uso di sostanze dopo tanto tempo, una volta in carcere riprendano a
drogarsi. E c’è anche chi inizia proprio quando entra. Così ci troviamo madri
con figli carcerati che diventano anche tossicodipendenti, difficoltà
all’interno delle celle tra chi vorrebbe fare bene il suo percorso e chi non è
lucido e persino liti per debiti per comprare la droga. Ci sono madri, mogli e
sorelle che lavorano e si ammazzano di fatica per guadagnare soldi che poi i
loro figli, mariti e fratelli detenuti chiedono per pagare la dose. A volte
scattano anche liti familiari per questo motivo che le mura del carcere e la
condizione emotiva che questo comporta rendono impossibili da gestire. Una
situazione che sta diventando sempre più insostenibile”.
All’origine del
problema secondo la garante c’è sia un problema di sotto organico degli
agenti che non riescono a fare bene il loro lavoro e i controlli, ma anche la
carenza di attività dell’area trattamentale e di lavoro. “C’è chi sente il
bisogno di fuggire almeno mentalmente dalla dura realtà del carcere, di trovare
sollievo in qualche modo, e per farlo ricorre allo ‘sballo’ della droga,
dell’alcol o addirittura respirando il gas dei fornellini. Qualcuno prepara
anche dei beveroni con frutta lasciata a fermentare e alcol per ubriacarsi più
facilmente”. La garante racconta di denunce fatte dai familiari per fermare
questo vortice di malessere in carcere che può essere causa e sintomo allo
stesso tempo di come e quanto le carceri siano un luogo invivibile. “Se pure il
carcere fosse davvero un luogo rieducativo, cosa ce ne facciamo di detenuti
storditi, impossibili da rieducare?”, si chiede la garante.
“Ci sarebbe bisogno
di maggiori controlli – continua Belcuore – magari anche con l’aiuto di cani
antidroga. Per esempio, a Santa Maria Capua Vetere potrebbe essere una proposta
che venga fatta una ristrutturazione degli ambienti. Lo so che lo spostamento
dei detenuti è complesso, ma questo renderebbe più semplice fare i controlli
evitando il rischio di mattonelle o muri malmessi che possono essere perfetti
nascondigli”.
“Ci battiamo per i
diritti dei detenuti come una buona sanità in carcere, il lavoro e il loro
reinserimento nella società – continua la garante – Combattere la droga in
carcere significa continuare a battersi per la tutela dei diritti dei detenuti,
di chi è in condizione di fragilità e cede alla droga che può solo farlo stare
peggio, di chi vuole fare un percorso positivo in carcere e nel rispetto della
legalità: il carcere non può essere una piazza di spaccio”.
La garante aggiunge
che in carcere sta prendendo piede anche un altro problema, quello del gioco
d’azzardo. “Se i detenuti non sono stimolati diversamente, spinti a fare
qualcosa di costruttivo, si finisce che anche un mazzo di carte possa diventare
un problema. E anche in questo caso partono le liti, l’isolamento e chi chiama
il divieto di incontro con gli altri detenuti. Oltre ovviamente al problema dei
debiti che spesso ricadono sulle famiglie”. Belcuore non è disposta a cedere su
queste battaglie che sono il diritto a stare bene in carcere. Il 30 novembre nel
palazzo della Provincia di Caserta ha organizzato un convegno proprio sul tema
della tossicodipendenza in carcere, del gancio che ci deve essere tra interno ed
esterno, sulle comunità a doppia diagnosi e sulle comunità dove far andare i
detenuti tossicodipendenti. Al confronto prenderanno parte esperti del settore
tra cui psicologi, sanitari, personale dei sert per ragionare insieme su come
affrontare al meglio questo dramma che rischia di catapultare le persone in un
buco nero senza ritorno. E il dramma dei 77 suicidi in carcere dall’inizio
dell’anno ne è la testimonianza.
Rossella Grasso.
Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su
varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia.
Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra
le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos,
Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli.
Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’
autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio
mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.
La testimonianza.
Storia di un ergastolano: a 78 anni con un tumore da oltre 50 anni dentro al
carcere.
Domenico Papalia su Il Riformista il 10 Novembre 2022
Voglio raccontare la
mia storia anche se per me è un po’ faticoso. Non ho una base scolastica, ho
imparato a leggere e scrivere in carcere, da autodidatta. Sono detenuto da circa
mezzo secolo e una volta non c’era possibilità di studiare. Parto dall’inizio e
dico subito che, oltre a quelle dello Stato, ci sono le mie responsabilità che
hanno contribuito alla mia emarginazione e persecuzione. Ma sono incapace di
odiare. Non riesco a provare odio contro lo Stato del quale avrei voluto far
parte. Ho sempre pregato anche per i giudici che mi hanno condannato, spesso
innocentemente.
Sono nato e
cresciuto in una famiglia numerosa e nella miseria. Avevamo del bestiame e ho
fatto il pastore fino all’età di 18 anni.
Eravamo ancora
piccoli quando nostra madre si ammalò ed è caduta in depressione, costretta a
letto per vent’anni, fino alla sua morte. Ho iniziato da ragazzo con piccoli
furti. Per necessità, non perché in me era innata la tendenza a delinquere.
Nel 1964 un mio fratello fu ucciso senza motivo da un paesano ubriaco. Ripeto,
avevo 18 anni e per placare ogni istinto di vendetta sono emigrato a Corsico,
Milano. Ho trovato lavoro in una impresa edile, ma il diavolo volle che io
incontrassi cattive compagnie. Accettai di andare a rapinare una gioielleria. Me
l’hanno fatta vedere ed esitai perché il luogo era pericoloso, cercai di
scoraggiarli. Mi dissero che avevo paura e per dimostrare che non era così
entrai con loro. Il gioielliere reagì e io sparai un colpo di pistola in aria
per non fargli male. I clienti di un bar di fronte accorsero verso il negozio.
Riuscii a scappare con un complice, un altro fu preso dalla folla e consegnato
alla polizia. Confessò i nostri nomi, fui arrestato e pagai la mia pena. Dopo
tre anni e mezzo uscii dal carcere e ritornai a Platì. Avevo capito la lezione e
trovai un lavoro, ma quel precedente ha segnato la mia vita. Negli anni
successivi sono rimasto legato come un cane alla stessa catena di fatti:
soggiorno obbligato lontano da casa, lavoro che trovavo e che poi perdevo,
ritorno obbligato a Platì e poi di nuovo via verso un altro soggiorno obbligato.
Stavo lavorando
a Platì con una ditta di Genova che operava nel campo elettrico quando per il
precedente della rapina la questura di Reggio mi propose per le misure di
prevenzione. Fui mandato al soggiorno obbligato in un paesino della provincia di
Rovigo. Trovai lavoro in edilizia ma dopo quattro mesi il ministero mi trasferì
a Lonate Mezzola, un paesino in provincia di Sondrio. Il Sindaco mi disse subito
che se avesse avuto un posto di lavoro lo avrebbe dato a un suo cittadino e non
a me. Ho resistito una settimana. Poi, pagai l’albergo, andai dal Sindaco, gli
feci vedere la ricevuta, mi recai dai Carabinieri e comunicai che sarei tornato
in Calabria. Mi avrebbero denunciato per allontanamento dagli obblighi. Me ne
andai lo stesso, mi presentai al Procuratore della Repubblica di Reggio e gli
raccontai la situazione. Non mi fece arrestare, mi disse di tornare al paese
natio e aspettare la nuova assegnazione.
Ero stato assunto
dal comune di Platì e lavoravo da otto mesi quando arrivò il soggiorno obbligato
nel comune di Cinisello Balsamo. Ho preso alloggio presso un albergo a spese del
comune e trovai lavoro presso un’impresa edile. Una mattina di luglio
del 1970 vennero a prendermi i carabinieri. Il giorno prima avevo prestato la
mia macchina a un amico. Venne trovata a Firenze abbandonata poco distante da
una banca che era stata rapinata. Ero un pregiudicato per rapina, non feci il
nome dell’amico a cui l’avevo prestata e fui condannato a 5 anni e 6 mesi. A
nulla valse la testimonianza del personale dell’albergo che il giorno della
rapina non ero proprio uscito dalla camera. Dopo due anni sono stato scarcerato
per decorrenza termini, ho scontato il residuo di soggiorno obbligato e come nel
gioco dell’oca sono tornato al punto di partenza. In Calabria, a Platì. Mi venne
incontro una ditta di Rozzano che vendeva mezzi meccanici per conto di
un’impresa francese, la Ploclain. Raccontati al direttore la mia storia e i miei
precedenti. Gli dissi che avevo solo 3 milioni di vecchie lire e chiesi di
acquistare un escavatore a credito.
Mi ha dato fiducia e
un escavatore nuovo del costo di 30 milioni di lire. Altrettanto feci con la
Fiat di Gioia Tauro che mi vendette un camion a rate. Avviai una ditta di
movimento terra e a mano a mano che lavoravo pagavo tutte le cambiali anche in
anticipo. Stavo lavorando onestamente, quando i “precedenti” mi riacchiapparono.
Nel luglio del 1975, la Questura di Reggio mi propose nuovamente per il
soggiorno obbligato e il Tribunale mi assegnò a Frasso Telesino, nella provincia
di Benevento. Mi accolse la stessa storia di pregiudizio ed emarginazione da
parte delle istituzioni locali. Scappai e mi diedi alla latitanza perché nel
frattempo la pena per la rapina di Firenze era diventata definitiva e mi
restavano tre anni e mezzo da espiare. Con la latitanza arrivarono nuove accuse
e nuovi processi.
Il 2 novembre
1976 ero in via Archimede a Roma quando il mio amico Antonio D’Agostino venne
ucciso. Ero presente ma essendo latitante chiesi alle persone di chiamare
un’ambulanza e mi allontanai. Sono stato arrestato l’8 marzo 1977 per un
sequestro di persona e per il residuo pena della rapina di Firenze. Ma fui
accusato anche dell’omicidio di D’Agostino. Per il sequestro tennero conto della
mia posizione marginale, della breve durata del rapimento e del trattamento
umano nei confronti dell’ostaggio. Mi furono concesse tutte le attenuanti e sono
stato condannato a una pena tutto sommato lieve per il tipo di reato. Tra buona
condotta, indulto e liberazione anticipata, dopo alcuni anni ho terminato la
pena, ma sono restato dentro innocentemente per l’omicidio D’Agostino. Negli
anni 90 lo stesso giudice che mi aveva fatto condannare, Ferdinando
Imposimato, si era ricreduto e fece una campagna di stampa a mio favore. La
prima istanza di revisione fu rigettata, ma non mi sono arreso e ho continuato a
lottare finché, dopo 41 anni, la Corte di Appello di Perugia in sede di
revisione mi ha assolto, grazie anche a una nuova perizia disposta dalla Corte
che era sempre stata da me richiesta e rigettata.
Purtroppo, sono
ancora detenuto perché durante la carcerazione per l’omicidio D’Agostino sono
stato accusato da falsi pentiti per l’omicidio dell’avvocato Pietro
Labate di Reggio Calabria ucciso a Milano il 17 novembre 1983 dal poi
collaboratore di giustizia Saverio Morabito. L’esecutore materiale mi aveva
scagionato, ma sono stato condannato come mandante. Non è stata creduta la mia
innocenza perché – si è sostenuto – ero un pregiudicato di omicidio, quello
di Antonio D’Agostino che 41 anni dopo avrebbero riconosciuto di non aver
commesso. In Cassazione, lo stesso Procuratore Generale chiese l’annullamento
della sentenza e i miei avvocati stanno facendo le indagini investigative per la
revisione del processo. Sempre per accuse false di collaboratori di giustizia
sono stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’educatore
carcerario Umberto Mormile, commesso l’11 aprile 1990. Anche per questo ci sono
indagini difensive in corso per l’eventuale revisione. Ho già 78 anni, sono
malato e di certo non vivrò altri 41 anni per vedere riconosciuta, come per
l’omicidio D’Agostino, la mia innocenza.
Nella mia vita
carceraria, sono stato ammesso al lavoro esterno e ho usufruito di circa 50
permessi premio. Fino al 1992, anno di inizio dell’emergenza. Sono stato
ricoverato in ospedale senza scorta o in detenzione domiciliare per motivi di
salute. Mi sono costituito da solo quando non fu rinnovata. Ma non si tiene
conto di tutto ciò per darmi fiducia. Proprio ultimamente mi è stato rigettato
un permesso premio. Hanno considerato i due omicidi come reati ostativi, anche
se l’ultimo risale all’11 aprile del 1990, prima della dichiarazione dello stato
di emergenza. Non hanno tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale
contro l’ergastolo ostativo e del mio percorso positivo: il mio impegno di
studio universitario, la collaborazione con Ristretti Orizzonti, il corso di
sociologia, i Laboratori Spes contra spem di Nessuno tocchi Caino. In carcere ho
fatto sempre volontariato. Ho perso mio figlio di 19 anni la notte di capodanno
quando una pallottola vagante rimbalzata sulla campana della chiesa del paese lo
colpì a morte. Ho autorizzato l’espianto degli organi salvando la normalità
della vita di sette persone. Da circa 32 anni sono iscritto al Partito
Radicale e a Nessuno tocchi Caino. Sono 30 anni che collaboro con la Missione
Don Bosco per i progetti nel terzo mondo.
La sofferenza della
detenzione per un reato che non ho commesso ha influito sulla mia salute. Le mie
difese immunitarie sono venute meno a causa delle arrabbiature giornaliere. In
mezzo secolo di detenzione ne ho ingoiate tante. Ora ho 78 anni e un tumore in
metastasi. Ho chiesto una sospensione pena o la detenzione domiciliare per gravi
motivi di salute più di un anno fa e sono in attesa di una decisione del
tribunale. In Italia esiste ancora lo stato di diritto? C’è o no
una Costituzione che prevede che la pena debba essere rieducativa? Il prosieguo
della mia sofferenza è inutile e gratuita. È un paradosso, ma il carcere di oggi
è molto più disumanizzato e degradante di quello di una volta.
Tutti questi
circuiti detentivi differenziati non hanno fatto altro che peggiorare la
situazione. Una volta esistevano le Case di Reclusione per i condannati
definitivi con lavoro assicurato e celle singole; oggi si vive in promiscuità:
giudicabili e definitivi, ergastolani e condannati a pene di qualche anno.
Ricordo quando dal 1970 al 1972 ero detenuto a Firenze nel carcere di Santa
Teresa. Lavoravamo tutti alla sartoria e all’Atala Sport. Le celle venivano
aperte alle 7 e chiuse alle 23, cosa impensabile con la mentalità di oggi. Roba
da medioevo. Per gli ergastolani che si comportavano bene, spesso, veniva
chiesta la loro liberazione condizionale dal Direttore. Oggi non esiste che un
Direttore chieda la liberazione condizionale o la grazia di un ergastolano che
lo merita. A volte mi chiedo: se Cesare Beccaria fosse un nostro contemporaneo
cosa scriverebbe a proposito del nostro carcere. Mi riferisco al carcere che
abbiamo ognuno ormai dentro di noi.
Domenico Papalia
Ergastolano detenuto a Parma
Il caso del carcere
napoletano. Vedi Poggioreale e poi… nulla: 20 anni di passerelle dei ministri
della Giustizia.
Viviana Lanza su Il Riformista il 5 Novembre 2022
All’indomani della visita del
ministro della Giustizia Carlo Nordio nel grande istituto penitenziario
cittadino le riflessioni sono tante, il dibattito è vivo. Perché giustizia e
carcere sono due temi cruciali. Ormai lo sanno anche le pietre. Partiamo da una
premessa: a Napoli, forse più che altrove, le criticità sono sempre state tali e
tante e così durevoli nel tempo che per farvi fronte si è costretti a dare fondo
a tutte le proprie individuali energie e capacità.
Accade, quindi, che anche
nel carcere di Poggioreale, una sorta di inferno in terra per chi lo abita da
recluso ma anche per chi lo vive da lavoratore, bisogna rimboccarsi le maniche e
fare l’impossibile per non collassare. Partiamo da questa premessa per chiarire
che non sorprende che il ministro Nordio abbia elogiato l’impegno e la
professionalità del personale, dai dirigenti agli operatori del carcere,
sorprende piuttosto che abbia evitato di spendere due parole sulla realtà più
dura che riguarda la stragrande maggioranza dei detenuti, sulle celle
sovraffollate, sulla sanità carente, sulle misure alternative, sulle attività
trattamentali da attuare. A Poggioreale si sono avviati bei progetti
ultimamente, questo è vero: ci sono detenuti che lavorano in Procura, altri per
l’Esercito e altri per il Teatro San Carlo.
Ma sono una goccia
nell’oceano. Cinque, dieci, venti detenuti su duemiladuecento. Entusiasmarsi per
un buon progetto va bene, ma utilizzare questo come pretesto per dire
che Poggioreale sia un modello da seguire appare un po’ troppo. Si corre il
rischio di esaltarsi per poco e perdere di vista tutto il resto, svuotando di
significato e opportunità la visita nel penitenziario napoletano. Già
opportunità. Quante se ne sono perse in questi anni. Volendo guardare agli
ultimi venti, perché vent’anni ci sembrano un tempo più che ragionevole per
realizzare qualcosa di valido, si nota che ogni ministro della Giustizia ha
visitato Poggioreale dichiarando, promettendo, annunciando, ma la realtà alla
fine non è migliorata.
Luglio 2000, il ministro della
Giustizia Piero Fassino visita il carcere minorile di Nisida e quello
di Poggioreale e annuncia un pacchetto giustizia con investimenti per 900
miliardi da ripartirsi in tre anni, con una parte dei fondi per costruire nuove
carceri. A luglio 2001 il ministro della Giustizia Roberto Castelli arriva a
Poggioreale dove, secondo la denuncia dei sindacati della polizia penitenziaria,
«ci sono condizioni che non assicurano una detenzione nei canoni di civiltà e
non consentono uno standard di sicurezza per l’intera collettività». Luglio
2006, il ministro della Giustizia Clemente Mastella visita Poggioreale alla
vigilia del dibattito parlamentare: «Voterò però per l’indulto e sono per
l’indulto. Le istituzioni sono forti quando esprimono un gesto di clemenza».
Nel marzo 2009 è la volta
di Angelino Alfano che da Napoli afferma: «La maggior parte delle carceri è
stata costruita in secoli lontani. Il risultato è che talvolta siamo fuori dal
principio costituzionale dell’umanità». Luglio 2012, Paola Severino, da ministro
della Giustizia, è a Poggioreale che rischia di esplodere per i troppi detenuti:
2600 a fronte di una capienza di 1300. Un anno dopo, luglio 2013, il
ministro Annamaria Cancellieri invia gli ispettori a Napoli: «Poggioreale è
forse il carcere italiano che si trova nelle condizioni peggiori. È ai massimi
livelli del male» e anche per lei la ricetta sarebbe «costruire nuove strutture,
ci stiamo lavorando». Poi è la volta di Andrea Orlando: a settembre 2015 da
ministro della Giustizia compie una visita ispettiva a sorpresa
nel carcere di Poggioreale.
Sono i tempi della denuncia
dei pestaggi nella cosiddetta “cella zero” e Orlando entra nelle celle, parla
con alcuni detenuti. Dicembre 2020, pandemia Covid: il ministro Alfonso
Bonafede arriva a Poggioreale affermando «Ci tenevo a portare personalmente la
mia vicinanza a tutti coloro che lavorano e vivono nell’istituto». Luglio 2021:
la Guardasigilli Marta Cartabia visita Santa Maria Capua Vetere, il carcere
delle torture del 6 aprile 2020 e annuncia più formazione per la polizia
penitenziaria e più misure alternative per rendere il carcere extrema
ratio, mentre la sottosegretaria Anna Macina, a luglio 2022 in visita
a Poggioreale, commenta: «È un istituto in chiaroscuro, molto particolare». E
arriviamo all’altro ieri, con Carlo Nordio che esce da Poggioreale parlandone
come un modello da seguire seppure tra le annose criticità. Bah!
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Altro che
sovraffollamento, docce inesistenti e sanità a rischio...Falegnameria
e pizzeria, il carcere di Poggioreale visto con gli occhi di Nordio sembra un
albergo…Viviana Lanza su Il Riformista il 4 Novembre 2022
La Jeep nera si
ferma davanti al carcere di Poggioreale. Il neo ministro della Giustizia Carlo
Nordio esce affiancato dagli uomini della scorta. Si dirige spedito verso
l’ingresso della grande casa circondariale napoletana, la più grande d’Italia e
tra le più affollate d’Europa. Il tragitto si consuma in pochi passi, interrotti
solo da una brevissima sosta davanti al capannello di giornalisti per
annunciare: «Dopo farò una dichiarazione sul sistema carcerario e sul
significato della visita, non su altro».
Quindi varca il
portone, posa per la foto di rito con il direttore del carcere di
Poggioreale Carlo Berdini e il provveditore regionale dell’amministrazione
penitenziaria Lucia Castellano e poi via, che la visita abbia inizio. Il tour
dura poco più di un’ora. Al termine il ministro Nordio mantiene la promessa con
i giornalisti e si ferma a rendere qualche dichiarazione. «Ho visitato la
pizzeria, la falegnameria ma anche una serie di strutture dove i detenuti
lavorano. Ho trovato una straordinaria attivazione del lavoro», afferma. Ad
ascoltarlo viene da pensare ai dati diffusi dal garante dei detenuti non meno di
qualche settimana fa e da alcune associazioni impegnate nella tutela dei diritti
nel sistema penale come Antigone: a Poggioreale lavora solo
il 13% dei detenuti, solo poche decine di reclusi sugli oltre duemila che ci
sono frequentano la scuola, non ci sono mediatori linguistici, gli educatori non
arrivano ai venti previsti dall’ordinamento così come mancano alcuni agenti
della polizia penitenziaria.
E viene pure da
chiedersi se nel suo tour a Poggioreale ci sia stata, oltre alla visita nella
falegnameria e nella pizzeria che sono indiscutibilmente realtà valide e da
lodare, anche una visita nei padiglioni delle celle senza docce denunciate
da Antigone giorni fa o nei reparti superaffollati da detenuti con problemi di
tossicodipendenza o di salute mentale i cui drammi sono costantemente denunciati
dal garante regionale dei detenuti. Una curiosità che Nordio non soddisfa perché
non ne fa cenno. A sentirlo, il ministro, non sembra appena uscito dal carcere
simbolo nazionale delle criticità del sistema penitenziario: una struttura
vecchia, concepita su un modello di detenzione per nulla finalizzato alla
rieducazione e senza spazi della pena adeguati, con ambienti fatiscenti e
inviabili che erano da ristrutturare anni fa ma i fondi non sono rimasti
bloccati per anni non si sa bene perché, con un alto tasso di sovraffollamento e
si potrebbe continuare.
Uscendo
da Poggioreale, Nordio concede dichiarazioni della serie: «Sicuramente vi sono
molti problemi che sono connessi alla carenza di strutture, di personale e alla
carenza più in generale di risorse, però vi è anche un lato buono, l’assoluta
professionalità del personale che ho incontrato», afferma. «La mia visita è
sintomatica di un’attenzione primaria che ministero e governo dedicano al
sistema carcerario. Dobbiamo prendere atto di una formidabile evoluzione sia
nell’educazione del personale sia nella formazione verso il recupero del
detenuto. Nulla quanto il lavoro e lo sport, sempre nell’ambito della certezza
della pena che deve essere eseguita, può recuperare e rieducare il detenuto
secondo quando imposto dalla Costituzione».
Ma con i detenuti ha
parlato il ministro Nordio? Sappiamo che c’è stata una lieve battitura
organizzata dai detenuti di Poggioreale proprio mentre il Guardasigilli visitava
la falegnameria e la pizzeria. Più che una protesta forse, un modo per farsi
sentire. Sarebbe stato utile raccogliere qualche testimonianza tra chi vive da
recluso, no? Eppure era parso di intravedere uno spiraglio di nuova luce nelle
parole dette dal ministro nel momento della visita in cui ha incontrato i
rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria e alcuni operatori del
mondo penitenziario. «Sono qui per vedere con i miei occhi», ha detto spiegando
di non essere a Napoli per una visita di cortesia né di voler essere come quel
generale a cui la truppa risponde sempre che il rancio è buono e la paga ottima.
Quello spiraglio di luce era solo un miraggio?
Viviana Lanza.
Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è
giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed
economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del
quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il
Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Anni di denunce inutili,
per il neo ministro i detenuti lavorano e sono anche pagati.
La gita di Nordio a Poggioreale, così il carcere più infernale d’Italia diventa
un modello da seguire. Ciro Cuozzo su Il Riformista il 3 Novembre 2022
Solo cose belle.
Così Poggioreale, il carcere del sovraffollamento con oltre 2200 detenuti
reclusi rispetto alla capienza di poco superiore alle 1500 unità, diventa
una casa circondariale modello perché ha la falegnameria e la pizzeria, luoghi
che coinvolgono poco più del 10% dei detenuti in attività lavorative che,
precisazione assai superflua, prevedono anche un (misero) corrispettivo
economico.
Avrà sicuramente visto un
altro carcere il neo ministro della Giustizia Carlo Nordio. Le sue parole dopo
la visita di un’ora a Poggioreale (in mattinata ha visitato Regina Coeli a Roma)
fanno quasi venire la pelle d’oca. Anni di denunce sprecati. Segnalazioni di
celle sovraffollate, anche con 12 detenuti che usufruiscono di un solo bagno e,
se va bene, di una doccia, il tutto separato con un muretto, alto poco più di un
metro, da cucina e mini-dispense, cadute nel vuoto.
Denunce inutili anche quelle
relative a detenuti che da mesi aspettano una semplice radiografia e chiedono
solo di ricevere una assistenza sanitaria adeguata. Tutto questo Nordio o non
l’ha visto o preferisce ometterlo nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa.
Sarebbe interessante sapere quali padiglioni ha visitato l’ex magistrato.
“Sicuramente ci sono molti
problemi connessi alla carenza di strutture, di personale e alla carenza di
risorse” si è limitato a dire al termine della visita condotta insieme al capo
del Dap Carlo Renoldi, alla provveditrice regionale Lucia Castellano, al
direttore di Poggioreale Carlo Berdini e al comandante Gaetano D’Iglio.
Qui “vi è anche un lato buono
– ha sottolineato il ministro – l’assoluta professionalità del personale che ho
incontrato, dai massimi dirigenti fino agli operatori. Poi c’è una cosa che
ritengo fondamentale nelle carceri: una straordinaria attivazione del lavoro” ha
aggiunto forse senza conoscere la reale percentuale di detenuti che davvero
lavorano nel carcere di Poggioreale.
“Ho visitato – racconta
entusiasta – la pizzeria, la falegnameria ed una serie di strutture dove i
detenuti lavorano e non vi è niente quanto il lavoro che possa riparare
dall’ozio e anche dalla disperazione. Sono detenuti, tra l’altro, che vengono
retribuiti (e ci mancherebbe, ndr). Io spero che questa parte di Poggioreale
aumenti sempre di più e che si diffonda anche negli altri istituti carcerari.
Non tutti – ha spiegato Nordio – sono in grado, per ragioni logistiche, di
attuare questa straordinaria opera che invece è stata attuata qui”.
“Non c’è nulla quanto il
lavoro e lo sport – aggiunge – fermo restando la certezza della pena, che possa
recuperare e rieducare il detenuto secondo quanto impone la nostra
Costituzione”.
Nessuna parola sulle
criticità. Nessuna parola sul numero esiguo di educatori, medici di reparto,
psicologi e psichiatri. Nessuna parola sul numero dei suicidi, 74, registrato
dall’inizio del 2022 nelle carcere di tutta Italia (a Poggioreale ad agosto un
43enne si è tolto la vita).
Ciro Cuozzo. Giornalista
professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport
prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in
Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola
di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le
esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a
VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del
Riformista.
Lettere al Riformista. “La
vita dopo la detenzione è un binario morto dove aspetti ma non passa più nulla”.
Redazione su Il Riformista il 27 Ottobre 2022
“La vita del detenuto è una
lunga marcia attraverso la notte, e si avanza verso un vuoto senza nessuno
sbocco”. Scrive così un lettore al Riformista. Attualmente è uno studente di
Scienze Politiche relazioni internazionali diritti umani che sta frequentando
grazie al Progetto Università in carcere nella sua città. Le sue parole sono
preziose, per comprendere meglio le difficoltà delle persone detenute e della
tragedia di essere per sempre bollati come “ex detenuti” anche dopo aver
scontato per intero la pena. Riportiamo qui di seguito le sue parole.
Dopo aver letto gli articoli
in merito al Garante Metropolitano Pietro Ioia, vi scrivo per ringraziarvi,
nonostante il vortice di accuse e ignoranza, per aver mantenuto impresso e vivo
lo spiraglio di speranza delle persone detenute con le Vostre parole. Mi
permetto perché sono stato anch’io detenuto nell’inferno di Poggioreale e
conosco bene, anzi benissimo Pietro Ioia, e ricordo quanto ha fatto per i
detenuti ristretti presso il reparto Salerno sinistro, volgarmente chiamato
dagli agenti penitenziari “quello dei ricchioni”.
Sono stato fortunato, avendo
padronanza di linguaggio mi sono salvato da tutti gli abusi subiti, e sono stato
trasferito nella mia città. Oggi sono studente universitario in scienze
politiche, relazioni internazionali, diritti umani, con il progetto università
in carcere dapprima presso il Polo Universitario interno e, attualmente in
misura alternativa per gravissimi problemi di salute cagionati da figure losche
in quel di Poggioreale, ma non mi arrendo e sto scrivendo quanto accaduto e
collaboro con diverse associazioni che si occupano di diritti umani.
Avete perfettamente ragione in
merito alla vita dopo la detenzione, io fotograficamente parlando la paragonerei
ad un binario morto dove aspetti ma non passa più nulla, ma di fronte a te c’è
la vita, i normali, i benpensanti che salgono e scendono dai vari
treni. Certezza della pena non vuol dire essere umiliati e morire per mano dello
Stato, e io di morti ne ho viste…La vita del detenuto è una lunga marcia
attraverso la notte, e si avanza verso un vuoto senza nessuno sbocco. Non si
vive, si mantiene in vita solo un corpo che non ti appartiene più perchè è
diventato di proprietà del Ministero di giustizia fino al giorno della
liberazione…poi inizia un altro tipo di detenzione…la solitudine. Vi auguro buon
lavoro
Con profonda stima.
La testimonianza. I buoni
fuori, i cattivi in cella: facce della stessa medaglia.
Argia Di Donato su Il Riformista il 21 Ottobre 2022
Ho partecipato per la prima
volta a un laboratorio di Nessuno tocchi Caino nel carcere di Secondigliano con
i detenuti sottoposti al regime di alta sicurezza, quelli considerati dalla
società “i più cattivi di tutti”. Rievoco gli occhi di quei “ragazzi” – perché
ai miei occhi restano tali –, in cui si agitano oceani densi di luci e ombre di
interminabili colori dalle mille sfumature, narratori sofferenti di realtà
possibili e opportunità negate. Universi infinitesimali di mondi generati da
illusioni, sogni e incubi, visioni e dolori, fede e speranza, cedimenti e
ricostruzioni. Sono stati momenti molto intensi.
Eravamo come immersi nello
stesso fiume, le cui acque mutavano direzione di continuo. Abbiamo parlato di
fede, speranza, autenticità, volontà, diritti, doveri, toccando le vette più
alte del pensiero filosofico occidentale e orientale. E poi abbiamo parlato di
farfalle. Ho chiesto loro se conoscessero il ciclo di una farfalla. Tutti hanno
risposto che la farfalla vola. Libera, ha aggiunto qualcuno. Uno dei ragazzi,
Giosuè, come per magia, si è alzato in piedi e ha detto “Io ho scritto una
poesia su una farfalla” ed è scappato per andare a cercarla. È tornato con versi
straordinari, come questi: “Ti sei appoggiata in queste quattro mura, qualcuno
mi dice che mi porterai fortuna. Eri bella ondulante e profumata, ma io dalla
mia cella fuori ti ho cacciata. Voglio che tu spieghi le ali e voli via. Qui
troverai solo lamento e malinconia. Qui non c’è un campo fiorito e aromatizzato,
c’è solo cancelli, cemento e ferro temprato.”
Mentre osservavo i ragazzi
interagire con noi, pensavo al fatto che se non si conoscesse il ciclo di vita
di questo incredibile insetto capace di stravolgere completamente le proprie
forma ed essenza, pochissimi riuscirebbero a ritenere come vera e possibile la
sua metamorfosi. In effetti, basta osservare per bene un bruco. Egli è
sgraziato, vorace, famelico e distruttore. In taluni casi è assai brutto e
spaventoso da vedere. Davvero pochissimi crederebbero al fatto che la farfalla è
la sua faccia “altra”. La nostra è una società ipocrita. Mira a sanzionare senza
rieducare. Punire o privare qualcuno della libertà senza consentirgli di
comprendere la natura del proprio errore per imparare dallo stesso, non ha alcun
senso se non quello di generare altri tipi di mostri. Dentro e fuori le stesse
mura che separano noi, qui, da loro, lì.
La nostra società è una
società malata. Non riesce a guardarsi allo specchio, non è capace di essere
sincera con se stessa, non riesce a essere autentica. Siamo ancora tropo legati
a una visione dualistica del mondo. Bene e male ci separano sia dall’“altro”,
sia da noi stessi, nella nostra parte più autentica. E solo abbandonando questa
schematica “opposizione” avviene il miracolo della trasformazione. Come le
farfalle. Che muoiono strisciando per rinascere volando. Sono fermamente
convinta che i detenuti degli istituti penitenziari siano la nostra parte
nascosta a noi stessi, quella parte scomoda che non vogliamo vedere perché
giudicanti e impauriti. È più facile chiudere i mostri in gabbia. Così evitiamo
di vedere il nostro di mostro. Quel mostro che rifiutiamo, puniamo, giudichiamo.
Quel mostro che rinneghiamo e che condanniamo. Perché non ascoltarlo? Vederlo
per ciò che è? Accoglierlo? E perdonarlo?
La storia della nostra civiltà
è testimone che il genere umano, a livello collettivo, pensa per separazione. I
grandi pensatori, i grandi artisti, i letterati, gli scienziati, i maestri
spirituali ci dicono invece che siamo parte di un unico tutto. E che siamo tutti
collegati. Gli uni con gli altri. Se guardiamo le stelle, il sole e la luna e
gli astri del cielo, in essi c’è sia la parte illuminata sia la parte in ombra.
Perché in ogni cosa respira la Luce e l’Ombra, e queste due realtà – necessarie
per l’evoluzione dell’Anima – dentro di noi si alternano danzando in una spirale
possibilistica di estatica bellezza. Senza conflitto. Questo fa di tutti noi
esseri unici e irripetibili. Bene e male sono soltanto termini inventati dalla
nostra specie per “confinare” ciò che non può essere definito nettamente per
nostra incapacità.
Bene e male sono concetti che
nascono per la nostra difficoltà a pensare in termini di unicità. Bene e male
sono solo parole. Perché la sostanza delle cose resta quella che è. Ed il
cambiamento, quello vero, è il grande miracolo. Anche se difficile, pericoloso e
doloroso. Bruchi e farfalle. Noi, qui, e loro, lì. Non c’è differenza né
separazione. Siamo l’uno specchio dell’altro, facce della stessa medaglia, petto
e schiena dello stesso corpo. Noi siamo loro. E loro sono noi. È soltanto la
fede nella Speranza a dare forza alle nostre ali e a sollevarci fin su nella
parte più alta del cielo per guardare la luce delle stelle. Argia Di Donato
Cosa succedeva
nel carcere di Bari e perché tre agenti sono stati arrestati.
Angela Stella su Il
Riformista il 10 Novembre 2022
Ieri all’alba, come
sempre quando si vogliono privare della libertà personale le persone, tre agenti
della Polizia penitenziaria di Bari sono stati arrestati e posti ai domiciliari
con l’accusa di “tortura in concorso” in applicazione di un’ordinanza di misura
cautelare emessa dal gip di Bari, Giuseppe Montemurro, per presunte violenze ai
danni di un detenuto di 41 anni che si sarebbero verificate il 27 aprile scorso.
Altri sei agenti sono stati sospesi, tre dei quali accusati pure per concorso in
tortura e rifiuto d’atti di ufficio, e altri tre solo per quest’ultimo reato.
Tra gli indagati ci
sono altresì tre infermieri e il medico di guardia all’infermeria, che avrebbe
omesso di denunciare il pestaggio pur sapendo che era avvenuto e non ha
riportato le lesioni nel diario clinico. Quindici in totale gli indagati. Le
indagini sono state condotte dalla pm Carla Spagnuolo e dal procuratore
aggiunto Giuseppe Maralfa. L’inchiesta è nata da una denuncia da parte della
direzione della Casa circondariale e del Comando della polizia penitenziaria. Il
tutto sarebbe nato da un materasso incendiato. Secondo l’accusa, il personale
destinatario delle misure, “in servizio presso le diverse sezioni del carcere,
conseguentemente ad un intervento in una cella di detenzione, infieriva, con
plurime condotte violente nell’arco temporale di circa quattro minuti, nei
confronti di un 41enne detenuto”.
Secondo quanto hanno
riferito i carabinieri, il personale della polizia penitenziaria, nel trasferire
il detenuto nella medicheria della struttura, avrebbe posto in atto “atti di
violenza” consistiti in particolare, “da parte di alcuni, nello sferrare calci e
schiaffi e, da parte di altri, nel trattenere il detenuto ‘bloccato’ sul
pavimento sul quale era riverso, con la partecipazione omissiva di altri agenti
che presenziavano agli atti di violenza senza impedirli”. Inoltre, secondo
l’accusa, non è stata segnalata “nessuna lesione sul detenuto”, poi ricoverato
nell’infermeria della struttura di detenzione immediatamente dopo. Non si è
lasciato attendere il commento dell’Associazione Antigone, tramite il
Presidente Patrizio Gonnella: “ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso
e si chiariscano le eventuali condotte e responsabilità. Da quando è stata
introdotta la legge contro la tortura nel 2017 sono diversi i processi e le
indagini in corso che vedono coinvolti appartenenti alla Polizia penitenziaria.
Segno di un testo che era e continua ad essere fondamentale per prevenire e
perseguire abusi in un luogo chiuso come il carcere. Ci auguriamo, altresì, che
chiarezza venga fatta anche sul coinvolgimento del personale medico, più di una
volta indagato o condannato in procedimenti simili, per la mancata refertazione
di ferite e lesioni”.
Per Gennarino De
Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria: “Chi sbaglia va
individuato, isolato e perseguito, ma se le indagini per il reato di tortura
sono ormai numerose e interessano carceri diverse in tutto il Paese,
probabilmente, c’è molto di più di qualcosa nell’organizzazione complessiva che
non funziona e da correggere”. “Anche per questo chiediamo al governo Meloni e
al ministro Nordio riforme immediate e investimenti mirati”, conclude il
sindacalista. Proprio in serata è arrivata la nota congiunta del Guardasigilli e
del capo del Dap Renoldi, circostanza che fan sperare che quest’ultimo non venga
mandato via: “La contestazione di gravi reati ad alcuni agenti di Polizia
penitenziaria in servizio nella Casa circondariale di Bari ci addolora molto: il
Corpo è composto di poliziotti che ogni giorno – con grande abnegazione e
passione – adempiono al proprio dovere nel pieno rispetto della legalità. Accuse
come queste rischiano di offuscare il grande impegno profuso. L’Amministrazione
penitenziaria ha però in sé tutte le risorse per garantire un servizio sempre
orientato al pieno rispetto della legalità, secondo il giuramento di fedeltà
alla Costituzione e alle Leggi che ciascuno di noi ha fatto. Siamo rispettosi
dell’operato della Magistratura e attendiamo, con fiducia, l’ulteriore sviluppo
dell’azione giudiziaria, ricordando, una volta di più, anche il principio
costituzionale della presunzione di non colpevolezza”.
Angela Stella
Da lastampa.it il 9
novembre 2022.
Tre agenti della
Polizia Penitenziaria di Bari sono stati arrestati, e sei sono stati sospesi,
con le accuse di «tortura in concorso» in applicazione di un'ordinanza di misura
cautelare emessa dal gip di Bari, per presunte violenze ai danni di un detenuto
di 41 anni che si sarebbero verificate il 27 aprile scorso. Quindici sono le
persone indagate, come comunicato dalla Procura di Bari.
La presunta vittima
delle torture è un detenuto di 41 anni affetto da una patologia psichiatrica.
Alcuni agenti - secondo l'accusa - erano intervenuti nella cella dopo che questo
detenuto aveva dato fuoco al materasso. Le violenze sarebbero avvenute durante
il trasporto del 41enne nell'infermeria del carcere: sono state acquisite le
immagini delle telecamere interne.
Alcuni agenti -
secondo l'accusa - erano intervenuti nella cella del detenuto dopo che questi
aveva dato fuoco al materasso. Le violenze sarebbero avvenute durante il
trasporto del 41enne nell'infermeria del carcere. Durante l'attività
investigativa per ricostruire l'accaduto sono state acquisite le immagini delle
telecamere interne.
Arrestati 3
agenti della polizia penitenziaria di Bari: pestarono e torturano un detenuto
con problemi psichici per poi occultarne le prove.
Redazione CdG 1947 su Il Corriere del Giorno il 9 Novembre 2022.
Nelle 55 pagine
dell'ordinanza cautelare firmata dal gip Giuseppe Montemurro del Tribunale di
Bari, è riportato che gli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Bari
colpiti oggi dai provvedimenti cautelari "hanno dimostrato una disarmante
naturalezza nell’adoperare o nel consentire che altri adoperassero violenza nei
confronti di un detenuto" a "riprova di un atteggiamento di prevaricazione e di
abuso che parrebbe essere tutt'altro che occasionale".
L’inchiesta è stata
condotta dalla sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri delegata dalla
Procura di Bari e coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Maralfa e dalla
pm Carla Spagnuolo ha avuto origine grazie ad una denuncia presentata dalla
direzione della Casa circondariale e del Comando della polizia penitenziaria di
Bari, che ha portato all’arresto di tre poliziotti per il reato di tortura e
alla sospensione dal servizio di sei assistenti, 3 dei quali accusati di
concorso in tortura e rifiuto d’atti di ufficio, e altri 3 solo per quest’ultimo
reato. Nelle 55 pagine dell’ordinanza cautelare firmata dal gip Giuseppe
Montemurro del Tribunale di Bari, è riportato che gli agenti di polizia
penitenziaria del carcere di Bari colpiti oggi dai provvedimenti cautelari
“hanno dimostrato una disarmante naturalezza nell’adoperare o nel consentire che
altri adoperassero violenza nei confronti di un detenuto” a “riprova di un
atteggiamento di prevaricazione e di abuso che parrebbe essere tutt’altro che
occasionale“.
Agli arresti
domiciliari sono finiti su ordinanza del gip Giuseppe Montemurro, chiesta
– Domenico Coppi 58 anni di Turi, Giacomo Delia 57 anni di Palo del Colle
e Raffaele Finestrone 57 anni di Bitritto. La sospensione dal servizio per un
anno è stata invece disposta nei confronti di Antonio Rosati 55 anni di Bitritto
e di Giovanni Spinelli 41 anni di Triggiano; otto mesi di sospensione
per Michele De Lido 31 anni di Bari, Leonardo Ginefra (48 anni di Bari) e Vito
Sante Orlando 54 anni di Turi, e Francesco Ventafridda 53 anni di Bitonto. Tra i
15 indagati compaiono anche 3 infermieri e il medico di guardia all’infermeria,
che pur sapendo che era avvenuto il pestaggio ha omesso di denunciarlo e non ha
riportato nel diario clinico le lesioni riscontrate.
Gli agenti della
polizia penitenziaria di Bari indagati sono responsabili secondo l’ipotesi
accusatoria della procura barese di aver colpito con calci e pugni di un
detenuto con problemi psichici detenuto nel carcere di Bari . Ancora più grave
il silenzio e la complicità dei colleghi che hanno assistito al pestaggio,
culminata nella mancata segnalazione delle lesioni sul corpo della vittima, un
42enne barese, dopo il ricovero in infermeria. All’origine della violenza dei
poliziotti della penitenziaria sarebbe stato l’incendio di un materasso causato
dal detenuto. L’episodio contestato è accaduto lo scorso 27 aprile scorso nel
carcere di Bari e si sarebbe svolto durante il trasferimento di un detenuto
dalla sua cella alla medicheria.
Un pestaggio vero e
proprio come hanno ricostruito i Carabinieri che sarebbe durato quattro minuti,
durante i quali alcune guardie carcerarie avrebbero bloccato sul pavimento ed
altri colpito l’uomo, mentre altre guardie sarebbero rimasti immobili a guardare
il pestaggio. La posizione più grave è quella delle tre persone che
materialmente avrebbero effettuato il pestaggio mentre gli altri agenti non lo
avrebbero impedito o lo avrebbero coperto, così diventandone complici. Secondo
l’accusa il sovrintendente Domenico Coppi, coordinatore della sorveglianza
generale, avrebbe colpito con schiaffi e calci il detenuto 41enne, che era stato
fatto cadere di proposito dall’assistente Giacomo Delia durante il trasporto in
infermeria dopo l’incendio del materasso nella sua cella. Secondo quanto emerso
dalle indagini l’ assistente Delia avrebbe inflitto calci al torace del
detenuto, mettendosi anche di peso sui piedi del 41enne per tenerlo fermo.
Condotte violente per le quali viene accusato anche l’assistente Raffaele
Finestrone, che avrebbe colpito il detenuto con calci alla schiena ed in pieno
volto.
Secondo quanto è
stato accertato dagli investigatori dei Carabinieri a seguito della visione
delle immagini filmate dalle telecamere del carcere, il detenuto avrebbe tentato
inutilmente di difendersi dai colpi ricevuti. Il tutto per quattro minuti. Lo
stesso detenuto, pochi giorni dopo la presunta aggressione, avrebbe parlato
delle violenze con i vertici del carcere di Bari che lo avevano convocato per
una contestazione disciplinare.
Immediata la difesa
d’ufficio del sindacato Sappe “Invito tutti a non trarre affrettate conclusioni
prima dei doverosi accertamenti giudiziari. La presunzione di innocenza è uno
dei capisaldi della nostra Carta costituzionale e quindi evitiamo illazioni e
gogne mediatiche. Niente è più barbaro dei processi mediatici ” ha dichiarato il
segretario generale del Sappe Donato Capece , a proposito dell’indagine della
Procura di Bari. “In molti casi ed in diverse città, detenuti sono stati
condannati per calunnia per le false accuse di presunti pestaggi subìti da
alcuni poliziotti penitenziari durante la detenzione – afferma Capece – Noi
confidiamo nella Magistratura perché la Polizia penitenziaria, a Bari come in
ogni altro carcere italiano, non ha nulla da nascondere”. Forse Capece si è
distratto un pò dimenticando che quanto successo a S. Maria Capua Vetere (
scandalo emerso proprio grazie ai giornalisti e non certo al Sappe) anche a Bari
hanno parlato purtroppo delle immagini violente commesse da appartenenti
alla Polizia Penitenziaria che per questi casi dovrebbero nascondere la faccia.
“Dell’indagine sulle
presunte torture nel carcere di Bari eravamo a conoscenza da tempo e aspettavamo
il primo atto ufficiale arrivato nelle ore scorse. Come sempre avviene in questi
casi ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso e si chiariscano le
eventuali condotte e responsabilità” ha dichiarato Patrizio Gonnella presidente
dell’ Associazione Antigone . ” Da quando è stata introdotta la legge contro la
tortura nel 2017 sono diversi i processi e le indagini in corso che vedono
coinvolti appartenenti alla Polizia penitenziaria – aggiunge Gonnella – Segno di
un testo che era e continua ad essere fondamentale per prevenire e perseguire
abusi in un luogo chiuso come il carcere“. “Ci auguriamo che chiarezza venga
fatta anche sul coinvolgimento del personale medico, più di una volta indagato o
condannato in procedimenti simili, per la mancata refertazione di ferite e
lesioni. Nel caso specifico di Bari la buona notizia è stata la collaborazione
dei vertici del carcere – sia della direzione che della stessa Polizia
Penitenziaria – per individuare i presunti colpevoli delle violenze e arrivare
ad un primo accertamento dei fatti. Anche in questo caso, come ripetiamo, la
legge sulla tortura può aiutare a rompere il muro di omertà che spesso si è
creato in passato, garantendo ampio riconoscimento a chi porta avanti il proprio
lavoro nel rispetto dei diritti e della dignità degli
individui” conclude Gonnella.
“La contestazione di
gravi reati ad alcuni agenti di Polizia penitenziaria in servizio nella Casa
circondariale di Bari ci addolora molto: il Corpo è composto di poliziotti che
ogni giorno – con grande abnegazione e passione – adempiono al proprio dovere
nel pieno rispetto della legalità. Accuse come queste rischiano di offuscare il
grande impegno profuso. L’Amministrazione penitenziaria ha però in sé tutte le
risorse per garantire un servizio sempre orientato al pieno rispetto della
legalità, secondo il giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi che
ciascuno di noi ha fatto. Siamo rispettosi dell’operato della Magistratura e
attendiamo, con fiducia, l’ulteriore sviluppo dell’azione giudiziaria,
ricordando, una volta di più, anche il principio costituzionale della
presunzione di non colpevolezza”. Così hanno commentato la vicenda il Ministro
della Giustizia, Carlo Nordio ed il Capo del DAP il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, Carlo Renoldi.
Gli agenti invocano “Gratteri al Dap”, ma
il governo vuole Riello. Il Sappe “sceglie” il
procuratore di Catanzaro facendo il tifo come allo stadio. Ma il rischio è di
mettere in ombra Nordio. Giovanni M. Jacobazzi su Il Dubbio il 19 novembre 2022.
Nicola Gratteri, Luigi Riello, o ancora Carlo
Renoldi. La partita del nuovo capo del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria (Dap), uno degli incarichi più importanti (e remunerati) della
pubblica amministrazione, si giocherà molto probabilmente su questi tre nomi,
tutti di magistrati. La procedura prevede che la proposta venga formulata dal
ministro della Giustizia Carlo Nordio per poi essere ratificata dal Consiglio
dei ministri. Sul nome del procuratore di Catanzaro c’è stato in questi giorni
l’endorsement dei sindacati della polizia penitenziaria.
Il Sindacato autonomo polizia penitenziaria
(Sappe) a tal proposito ha pubblicato un lungo articolo sulla propria rivista
online, poliziapenitenziaria.it, dal titolo particolarmente esplicito:
“Gratteri, Gratteri, Gratteri”. Richiamandosi alla torcida degli stadi, i
sindacati di polizia stanno facendo apertamente il tifo per il magistrato che in
passato Matteo Renzi, prima di essere stoppato, avrebbe voluto come
Guardasigilli nel suo governo. «Non siamo mai entrati (e mai vogliamo entrarci)
nell’agone politico italiano ma per il bene e a salvaguardia della polizia
penitenziaria che rappresentiamo saremmo i primi ad alzarci in piedi sugli
spalti dello Stadio Penitenziario e gridare in coro: Gratteri! Gratteri!
Gratteri», scrivono i dirigenti del Sappe.
La liason fra Gratteri e la polizia penitenziaria
è nota da tempo. Sul sistema carcerario il procuratore ha le idee molto chiare.
Intervenendo ieri a Milano ad una manifestazione letteraria svoltasi all’interno
proprio del carcere di San Vittore, Gratteri ha illustrato le sue proposte, ad
esempio «mettere ai domiciliari i detenuti tossicodipendenti, con percorsi di
terapia», facendo poi «una formazione adeguata agli agenti». La polizia
penitenziaria, per Gratteri, necessita di una profonda riorganizzazione. Pur
essendo una della quattro forze di polizia nazionali (erano cinque prima dello
scioglimento del corpo forestale dello Stato, secondo il procuratore calabrese è
di «Serie C» , gettata in uno stato di «depressione e frustrazione» dalle
istituzioni che non se ne curano. A cominciare dalle scuole di formazione:
«Nelle scuole ci deve andare gente che sul campo ha dimostrato di saper fare
qualcosa, non gli amici degli amici. Altrimenti le lezioni diventano una
passerella e i ragazzi non imparano nulla».
Il procuratore ha, ovviamente, anche la ricetta
per risolvere il sovraffollamento nelle carceri: «La costruzione di nuove
strutture detentive o l’ampliamento di quelle esistenti». Una idea da sempre
sostenuta dalla Lega e da Fratelli d’Italia con il sottosegretario alla
Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Una proposta, pur utilizzando i fondi
del Pnrr, allo stato però difficilmente realizzabile. Sono anni, infatti, che in
Italia non si costruisce un’opera pubblica. Le normative, ad iniziare dal codice
degli appalti, con il prevedibile strascico di contenzioni amministrativi,
rendono impossibile porre in essere opere del genere in tempi relativamente
brevi. Le uniche opere pubbliche, infatti, vengono realizzate quando si
sospendono le procedure di legge e si nomina, come per il ponte di Genova, un
commissario. Ma sul punto serve una volontà politica forte. Gratteri, comunque,
ha incassato anche l’appoggio della segretaria nazionale dell’Associazione
dirigenti e funzionari di polizia penitenziaria, Daniela Caputo, secondo cui
serve «un capo per il nostro corpo operativo, unico tra le forze dell’ordine a
non averlo. Un problema non più rinviabile, come hanno dimostrato le rivolte
carcerarie del 2020. Il sistema di prevenzione penitenziario è parte integrante
dell’ordine pubblico ed è giusto che abbia un vertice a regolarlo e
organizzarlo».
L’outsider della contesa potrebbe allora essere
Riello, procuratore generale di Napoli, recentemente “scottato” dalla mancata
nomina a procuratore generale della Cassazione. Riello, in un duro articolo,
aveva recentemente criticato il Consiglio superiore della magistratura. Una
presa di posizione che potrebbe agevolarlo nel trovare sponda nell’attuale
maggioranza che non ha mai lesinato critiche verso l’attuale gestione di Palazzo
dei Marescialli post Luca Palamara. Per Renoldi, invece, l’eventuale conferma
andrebbe letta nel segno della continuità, essendo stato scelto dall’allora
ministra della Giustizia Marta Cartabia con cui Nordio ha sempre avuto un buon
rapporto. Tornado, comunque, a Gratteri, la sua scelta non potrebbe non mettere
in “difficolta” lo stesso Nordio. La forte personalità del procuratore, molto
mediatica e che non ha bisogno di comunicatori, metterebbe sicuramente in ombra
il ministro. Con conseguenze facilmente immaginabili.
Riecco Nicola
Gratteri: «Datemi il Dap, ma voglio pieni poteri».
Il procuratore si
candida alla guida del Dipartimento che si occupa di carcere e la cui poltrona
vale più di 300mila euro. E si dichiara «vero garantista». Il Dubbio il 25
novembre 2022.
«Con Nordio ho
parlato di arte, lui è un grande conoscitore di Storia. Anche io mi considero un
garantista, io e il mio ufficio osserviamo in modo ortodosso le norme del
codice. Ci sono diffamatori quotidiani che scrivono notizie false, ho iniziato
cause civili contro questi diffamatori seriali. Da quando sono a capo della
procura di Catanzaro non c’è una sola condanna per ingiusta detenzione, lo dice
il presidente della corte d’appello. Non ci sarebbero le carceri piene in
Calabria se le mie indagini fossero tutte un bluff». Così il procuratore di
Catanzaro Nicola Gratteri, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.
Dal ponte sullo
Stretto – «che i calabresi non vogliono mentre i siciliani non ne hanno bisogno
perché i turisti arrivano coi voli low cost» -, alla questione migranti.
Insomma, Gratteri, gran frequentatore di salotti televisivi dai quali lancia le
sue nuove fatiche letterarie, non smette di stupire e ormai parla come un
tuttologo qualsiasi. Non solo, sull’immigrazione e sullo scontro
tra Roma e Parigi, veste i panni di ministro degli esteri e invita al
silenzio Francia e Inghilterra che, dice, “non possono parlare per il loro
passato coloniale”.
Poi il velato, ma
neanche troppo, apprezzamento al governo Meloni – «l’unico che ha parlato di
mafia” – e l’ammiccamento per la poltrona di capo del Dap, che vale più di
300mila euro l’anno: «Nessuno mi ha chiesto di fare il capo del Dap. Forse è un
desiderio della polizia penitenziaria ma dipende da che libertà mi danno, devo
avere mani libere». Il che ricorda il poco fortunato voglio pieni poteri di
una Salvini convinto di vincere le elezioni, salvo poi scoprire di stare sotto
il 10%. Insomma, il solito Gratteri, che tra un giudizio e l’altro, non
dimentica di ricordare che lui è un «vero garantista» (sic!), che la
separazione delle carriere sarebbe una iattura e che la
riforma Cartabia andrebbe cancellata. Punto.
Un passaggio il
procuratore di Catanzaro lo dedica anche all’annunciata modifica dell’abuso
d’ufficio. «L’abuso d’ufficio è un reato difficile da dimostrare, così come è
formulato – ha sottolineato -. Ma è un reato spia, e secondo me serve. Non
vorrei che alcuni sindaci scegliessero di usare il Comune come casa propria.
Dovremmo accorpare i comuni più piccoli, poi i sindaci se vogliono un parere
tecnico prima di apportare una firma possono chiederlo, se invece vogliono
favorire il parente o l’amico è giusto che gli arrivi l’avviso di garanzia».
L'amministrazione penitenziaria merita
ben altro. Gratteri non può andare al Dap, non si affidano le carceri a chi ha
fatto inchieste show senza costrutto. Otello
Lupacchini su Il Riformista il 18 Novembre 2022
A fronte dei rumors raccolti e rilanciati da
il Riformista, circa le grandi manovre in corso per insediare il dottor Nicola
Gratteri al vertice del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, mi
sorge spontanea la domanda, considerata la vocazione di «Rattenfänger» o
«ciaparat» che dir si voglia, confessata ore rotundo dall’odierno procuratore
della Repubblica di Catanzaro, se sia assurta, fra le altre, a irrinunciabile
«priorità» del Gabinetto Meloni, anche la «derattizzazione» degli Istituti di
pena della nostra amata Patria.
Il pretesto per avanzare un simile interrogativo
mi è offerto dalla lettura di un passo delle Memorie dell’architetto Andreï
Mikhaïlovitch Dostoevskï, fratello del più noto Fëdor, relativo a una delle
brutte «sorprese» riservategli dalla cella in cui era stato rinchiuso dopo una
giornata e parte della notte trascorse nella «terza sezione» degli uffici della
polizia moscovita, a seguito dell’arresto per motivi politici patito il 23
aprile del 1849, «Non appena si fece buio, e mi portarono il lumino», racconta,
infatti, Andreï Mikhaïlovitch, «piano piano cominciarono a comparire dei ratti
di dimensioni enormi (…). Talora ce n’erano dieci alla volta e io, temendo che
si arrampicassero nella mia cuccetta, non dormivo, fino all’alba. Non riuscivo a
capire da dove saltassero fuori (…). Alla luce del giorno non si vedevano. Ma
bisogna pur dire che era fine aprile e inizio maggio faceva giorno presto,
l’avevo, il tempo per dormire. Oltretutto, dormivo sempre anche di pomeriggio,
dopo pranzo». Non mi nascondo il rischio che qualcuno dei tanti, per dirla
con Friedrich Nietzsche (Götzen-Dämmerung, 1889), «fari nel mare dell’assurdo»,
magari un Maitre ein Stifter dell’«io sto con…», incistati da grassi parassiti
nelle Istituzioni, «mito impossibile», d’«esaltazione che si toglie la sottana»,
potrebbe muovermi la resistibile obiezione che n’è passato di tempo da quando
l’architetto Dostoevskï era ospite non di un carcere di questa Nazione, ma di
una prigione della Russia zarista, potrebbe muovermi l’accusa, è già successo,
del resto, di essere «sarcastico». Poco male. Conservare la propria allegria in
mezzo a faccende oscure e oltremodo gravide di responsabilità, non è artificio
da poco, ma del resto cos’è più necessario dell’allegria?
Com’è ovvio che sia, il dottor Carlo Nordio, che
anche in virtù della sua generalmente riconosciuta cultura garantista è stato
insediato al vertice del ministero della Giustizia, certamente, sempre che
addirittura non l’abbia già fatto, smentirà sdegnosamente, non solo a parole,
naturalmente, ma soprattutto con i fatti, la notizia diffusa da il Riformista. A
meno che non voglia «perdere la faccia». L’Os aureum di Gerace, infatti, non
perde occasione, nella sua bulimia mediatica nota lippis et tonsoribus, di
ostentare l’allergia per la Costituzione, la fedeltà alla quale, nell’ambito
della legislazione penale, è specchio dell’autentica democraticità dello Stato:
a prescindere dal suo retorico pessimismo come rigurgito del pranzo sui
futuribili in generale del processo penale e specialmente
dei «maxiprocessi», per effetto dell’entrata in vigore della pur
timidissima riforma Cartabia, aliena gli è l’idea stessa che teoria generale del
reato e funzione della pena non siano due momenti concettuali distinti, posto
che dal fine costituzionalmente attribuito alla pena può derivare una
connotazione globale e sostanziale dello stesso illecito penale; è altresì fuori
dai suoi orizzonti culturali il «nuovo volto» del reato, quale risulta dalla
combinazione dei principi desumibili soprattutto, ma non solo, dagli articoli 2,
3, 13, 24, 25 e 27 della Costituzione, come fatto previsto in forma tassativa
dalla legge, di realizzazione esclusiva dell’agente o in ogni caso al medesimo
riconducibile tramite un atteggiamento colpevole (doloso o colposo), idoneo a
offendere un valore costituzionalmente significativo, minacciato con una pena
proporzionata anche alla significatività del valore tutelato e strutturalmente
caratterizzato dal teleologismo costituzionalmente attribuito alla sanzione
penale e, infine, intollerante rispetto ad ogni articolazione probatoria che
faccia in qualche modo ricadere sull’imputato l’onere della prova o il rischio
della mancata allegazione di elementi di ordine positivo che ne caratterizzano
la struttura; al fondo di ogni suo discorso è dato leggere, del resto, il
messaggio che tolti lui e quelli che la pensano come lui l’ordine decade a caos,
la convinzione, cioè, ch’egli e quelli come lui stiano adempiendo a una sorta di
missione salvifica: il male pullula nel mondo, dunque va represso, la scimitarra
della giustizia non ha guaine, incombe continuamente.
Sintomatico di tutto questo è l’ossessivo
susseguirsi, del resto, di «massicce operazioni» o «grandi retate» o «mega
blitz» anti-’ndrangheta, con decine e decine, se non addirittura centinaia di
arresti, abbattentisi sulla Calabria, per iniziativa della direzione
distrettuale antimafia della quale l’Os aureum è a capo; blitz, operazioni e
retate che, per dirla con Boncompagno da Signa, «evanescunt sicut umbra
lunatica»: dopo le roboanti conferenze stampa promozionali, ben presto esse
vengono irrimediabilmente ridimensionate, se non addirittura travolte e
totalmente vanificate, nei procedimenti incidentali de libertate, quali riesame
e Cassazione, e nei dibattimenti davanti ai tribunali o alle Corti d’assise o
alle Corti d’appello o alla Corte di cassazione, le motivazioni dei cui
provvedimenti evidenziano, in inquietante sintesi, l’incontenibile pulsione che
prova il titolare della funzione d’accusa a punire, purtroppo, senza legge,
senza verità, senza colpa. Pur non essendovi evidenza alcuna che il
ministro Carlo Nordio sia in qualche modo disponibile a «perdere la faccia»
chiamando il dottor Nicola Gratteri al vertice del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, la vulgata, alimentata dal continuo
rincorrersi di voci correnti nel pubblico, vedrebbe un bizzarro sodalizio,
quello che chiamerò M.U.F., esercitare fortissime pressioni sia sul Governo sia
sulle Opposizioni, per favorire la nomina dell’Os aureum di Gerace.
Pur in mancanza di evidenze in tal senso, non è
tuttavia temerario intravvedere, sulla scorta dell’id quod plerumque accidit –
si chiama, questa, «prova critica» – quale possa esserne il fondamento, non
perdendo di vista né i posizionamenti politici dei membri del M.U.F. né
l’influenza che ognuno di essi può avere, e su chi, per le funzioni da essi, sia
precedentemente sia attualmente, svolte. Ma altri sono gli indici rilevanti dai
quali non si può prescindere. La prigione, come evidenziato dalla letteratura
scientifica e constatato, anche da me, nella pratica quotidiana, è di sicuro la
più efficace e la più feconda fra tutte le istituzioni che producono
illegalismi. Dalle carceri si esce quasi sempre più delinquenti di quando vi si
è entrati: per via degli effetti del disinserimento sociale, dell’esistenza del
casellario giudiziale, del formarsi di sodalizi delinquenteschi e di tant’altro.
Il funzionamento interno delle prigioni, inoltre, è possibile solo a prezzo di
un gioco di illegalismi, al tempo stesso molteplici e complessi: i regolamenti
interni sono sempre assolutamente contrari alle leggi fondamentali che, nel
resto della società, garantiscono i diritti umani; la galera è luogo di violenza
fisica e sessuale esercitata sui detenuti, dai detenuti e dagli agenti di
custodia; è luogo di commerci incessante e, ovviamente, illegale, tra detenuti,
detenuti e agenti di custodia, tra questi e il mondo esterno; è, altresì, un
luogo in cui l’amministrazione pratica quotidianamente l’illegalismo, fosse
anche solo per coprire agli occhi della giustizia e dell’amministrazione
superiore, da un lato, e dell’opinione pubblica, dall’altro, tutti gli
illegalismi che si producono al suo interno; è finalmente un luogo di cui gli
apparati polizieschi si servono per reclutare la loro manovalanza, i loro
informatori, i loro scagnozzi, all’occorrenza i loro assassini e ricattatori.
La sempre maggiore consapevolezza che tra le tante
priorità vi sia anche quella del carcere, grave e incivile situazione, indegna
perché offende innanzitutto la dignità, a cui si accompagnano la richiesta, dai
pulpiti più autorevoli, di riconsiderare il ricorso alla detenzione intramuraria
come forma prevalente di esecuzione della pena e la stigmatizzazione del fatto
che la restrizione in un penitenziario offende la dignità della persona, negando
l’affettività, privando dello spazio e annullando il tempo, che cessa di
esistere nel momento in cui chi è recluso in una cella viene anche privato della
prospettiva del riscatto, vanno di pari passo con la progressiva perdita
d’utilità del ruolo della prigione, quale macchina per la fabbricazione dei
delinquenti in vista della diffusione e del controllo degli illegalismi. I
grandi traffici di armi, di droga di valuta sfuggono, infatti, sempre più alla
competenza di un ambiente di delinquenti tradizionali, che magari erano dei
bravi ragazzi, ma forse incapaci, perché formatisi in galera, di diventare i
grandi trafficanti internazionali di cui c’è bisogno ora. Qui, tuttavia, si
profila prepotente un altro interrogativo: è concepibile un potere che non ami
l’illegalismo, che non abbia bisogno di possedere gli illegalismi, controllarli
e mantenersi saldo se non mediante il loro esercizio? La risposta, com’è ovvio è
negativa, la domanda va dunque elusa. E chi, meglio dell’Os aureum di Gerace, o
simili, al vertice del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, potrebbe
compiere l’esorcismo? Ecco perché, paradossalmente, ma anche con buona pace di
tutti, in nome della ragion di Stato, le chances di Nicola Gratteri potrebbero
essere, nonostante tutto, molto concrete.
Otello Lupacchini, Giusfilosofo e magistrato in
pensione
Il
sottosegretario voleva premiare gli agenti delle violenze in carcere.
NELLO
TROCCHIA su Il Domani l’08 novembre 2022
«Se il Ministro
interpellato intenda sollecitare da parte del direttore generale
dell’amministrazione penitenziaria il conferimento dell’encomio solenne al corpo
di polizia penitenziaria in servizio presso l’istituto penitenziario di Santa
Maria Capua Vetere che, in operazione di particolare rischio, ha dimostrato di
possedere, complessivamente, spiccate qualità professionali e non comune
determinazione operativa».
Il primo firmatario
era Andrea Delmastro Delle Vedove che, nel nuovo governo di Giorgia Meloni, è
diventato sottosegretario alla Giustizia.
‘Pestaggio di stato’
è il libro di Nello Trocchia, in uscita l’11 novembre, editore Laterza, che
ricostruisce l’inchiesta e svela le menzogne di stato.
«Se il ministro
interpellato intenda sollecitare da parte del direttore generale
dell’amministrazione penitenziaria il conferimento dell’encomio solenne al corpo
di polizia penitenziaria in servizio presso l’istituto penitenziario di Santa
Maria Capua Vetere che, in operazione di particolare rischio, ha dimostrato di
possedere, complessivamente, spiccate qualità professionali e non comune
determinazione operativa».
Recitava così
l’interpellanza parlamentare, presentata nell’aula della camera dei Deputati, il
15 giugno 2020, dai deputati di Fratelli d’Italia che chiedevano l’encomio
solenne per i poliziotti penitenziari coinvolti in una delle pagine più buie
della storia carceraria italiana. Il primo firmatario era Andrea Delmastro Delle
Vedove che, nel nuovo governo di Giorgia Meloni, è diventato sottosegretario
alla Giustizia, il ministero che decide sulle sospensioni degli agenti.
L’interpellanza,
rimasta senza risposta, era destinata proprio al dicastero dove l’allora
deputato oggi occupa la poltrona di sottosegretario. Il deputato criticava
l’operato della magistratura, arrivava a proporre un premio e ricostruiva le
vicende seguendo le indicazioni dei vertici dell’amministrazione, dell’allora
governo M5s-Pd e dei sindacati, ricostruzioni che si sono rivelate totalmente
false e che erano già state messe in discussione dall’avviso di garanzia
notificato a 44 agenti. Il reato contestato era quello più grave per chi indossa
la divisa: tortura.
IL GIORNO DELLA
MATTANZA
Il 6 aprile 2020,
nel carcere Francesco Uccella, 283 poliziotti penitenziari entrarono e
massacrarono di botte i detenuti inermi del reparto Nilo. Nell’aula bunker del
tribunale di Santa Maria Capua Vetere è iniziato il processo a carico di 105
persone accusati di tortura pluriaggravata, lesioni, falso, calunnia. In 77 sono
stati sospesi dal servizio, altri hanno continuato a lavorare con tanto di
avanzamento di carriera. Decisioni che spettano al dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e proprio al ministero della Giustizia. Ma
cosa c’era scritto in quell’interpellanza?
I deputati di
Fratelli d’Italia ricostruivano i fatti così: «Il giorno 5 aprile 2020 è esplosa
una violentissima rivolta nell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua
Vetere nel corso della quale circa 150 detenuti, dopo aver occupato alcuni
reparti, hanno minacciato gli agenti della polizia penitenziaria con olio
bollente e alcuni coltelli». Non era andata così. Nessuna protesta violentissima
era esplosa, il dato era facilmente desumibile dalle parole pronunciate
all’esterno del carcere dal magistrato di sorveglianza, Marco Puglia. «Il
profilo dell’ordine e della sicurezza è sotto controllo, c’è stata solo una
protesta, rientrata», aveva detto al tg regionale della Rai.
La ricostruzione dei
deputati continuava riferendo dei fatti accaduti l’indomani. «Il giorno 6 aprile
2020, a seguito di una perquisizione straordinaria disposta dalla
amministrazione penitenziaria, sono state ritrovate e sequestrate diverse
spranghe, bacinelle piene di olio, numerosi pentolini per far bollire l’olio e
altri oggetti contundenti nella disposizione dei detenuti; nel corso della
predetta perquisizione gli animi si sono surriscaldati e vi sono stati alcuni
contusi che, comunque, non hanno riportato conseguenze tali da essere ricoverati
in ospedale fra i detenuti mentre 50 agenti della polizia penitenziaria sono
stati refertati».
Le bacinelle piene
d’olio non c’erano e neanche le spranghe, le fotografie erano state manipolate.
I poliziotti erano stati refertati, ma le ferite erano le conseguenze dei pugni,
degli schiaffi e delle botte sferrate ai detenuti inermi.
Quattro giorni prima
della presentazione dell’interpellanza c’era stata la notifica di 57 decreti di
perquisizione e di 44 avvisi di garanzia ad altrettanti agenti del carcere. Ma
anche l’atto della magistratura, la perquisizione, veniva bollata come
un’operazione «spettacolare di dubbia utilità investigativa», veniva citato
anche l’intervento del procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, che «ha
avvertito la necessità di intervenire sulle modalità spettacolari dell’azione
diretta dalla procura».
GLI ALTRI FIRMATARI
Gli interroganti
concludevano ricordando anche un’aggressione avvenuta, il 12 giugno 2020, ai
danni di alcuni agenti prima di sottoporre all’attenzione del ministro della
Giustizia, Alfonso Bonafede, l’insolita richiesta perché «è necessario
riaffermare, oltre alla indipendenza della magistratura, che nel caso di specie
condurrà le indagini, anche l’indipendenza della politica». Il 6 aprile veniva
definita «una necessaria operazione di contenimento della rivolta carceraria».
Abbiamo contattato
il sottosegretario per chiedergli se intende promuovere l’iniziativa
dell’encomio oppure si è pentito, ma non ha risposto. Tra gli interpellanti,
oltre ad Andrea Delmastro Delle Vedove, c’erano Wanda Ferro ed Emanuele Prisco,
diventati sottosegretari al ministero dell’Interno; Alessio Butti, nominato
sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri e Galeazzo Bignami,
diventato sottosegretario alle Infrastrutture. Sono stati tutti promossi.
NELLO TROCCHIA. È
inviato di Domani. Ha firmato inchieste e copertine per “il Fatto Quotidiano” e
“l’Espresso”. Ha lavorato in tv realizzando inchieste e reportage per Rai 2
(Nemo) e La7 (Piazzapulita). Ha scritto qualche libro, tra gli
altri, Federalismo Criminale (2009); La Peste (con Tommaso Sodano,
2010); Casamonica (2019) dal quale ha tratto un documentario per Nove e Il
coraggio delle cicatrici (con Maria Luisa Iavarone). Ha ricevuto il premio Paolo
Borsellino, il premio Articolo21 per la libertà di informazione, il premio
Giancarlo Siani. È un giornalista perché, da ragazzo, vide un documentario su
Giancarlo Siani, cronista campano ucciso dalla camorra, e decise di fare questo
mestiere. Ha due amori, la famiglia e il Napoli.
"I garanti
restino fuori dal procedimento". Mattanza in carcere, parte il processo ed è
scontro sulle parti civili: la posizione paradossale del ministro della
Giustizia.
Viviana Lanza su Il Riformista l’8 Novembre 2022
Schermaglie
procedurali e un braccio di ferro tra accusa e difesa e tra difesa e parti
civili. Il maxi-processo per le torture e i pestaggi avvenuti il 6 aprile
2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere si apre così. Ieri c’è stata la
prima udienza nell’aula bunker del carcere sammaritano ristrutturata e riaperta
appena quattro giorni fa. Centocinque gli imputati, fra medici e soprattutto
dirigenti, funzionari e agenti dell’amministrazione e della polizia
penitenziaria, tutti finiti sotto processo a diverso titolo per i reati di
tortura, lesioni personali, maltrattamenti, abuso di autorità contro detenuti,
falso in atto pubblico, perquisizioni personali arbitrarie, omessa denuncia,
calunnia, frode processuale, depistaggio, favoreggiamento, rivelazione di
segreto d’ufficio. Ad alcuni degli imputati è contestato anche il concorso nelle
circostanze che hanno causato la morte di Hakimi Lamine, il detenuto algerino
che dopo i pestaggi fu messo in isolamento e un mese dopo fu trovato morto in
cella.
Il primo scontro
giudiziario del processo è sulle parti civili. Ieri, ad apertura del processo di
primo grado che dovrà accertare le singole responsabilità di quella terribile
mattanza, molti degli imputati sono tornati a sollevare eccezioni sulle
costituzioni di parte civile: secondo loro i garanti, quello regionale ma
soprattutto quello nazionale, non avrebbero diritto ad essere ammessi a un
eventuale risarcimento, così come si è tornati a contestare la posizione
del Ministero della Giustizia, presente nel processo sia come parte civile sia
come responsabile civile. Tutte questioni che la difesa degli imputati aveva
proposto in fase di udienza preliminare ottenendo un secco no da parte del
giudice e che ora ripropone alla Corte d’assise (il collegio presieduto dal
giudice Roberto Donatello). Si torna in aula il 14 novembre per affrontare
questa ed altre questioni preliminari, come la costituzione di parte civile di
altri 26 detenuti individuati dalla Procura come vittime dei pestaggi e che ora
chiedono di essere aggiunti agli oltre settanta che si sono già costituiti come
parti offese, e la costituzione dell’associazione “Italiastatodidiritto”.
La Corte, inoltre,
dovrà sciogliere la riserva anche sulla richiesta, avanzata sempre da alcuni
imputati, di smembrare il processo, lasciando in Corte d’assise solo le
posizioni chiamate a rispondere del reato di tortura e delle presunte
responsabilità nella morte del povero Lamine e stralciando davanti al Tribunale
tutte le altre posizioni. Si vedrà. Intanto è una coincidenza che si carica di
simbolismo il fatto che il processo si svolga nell’aula bunker annessa al
carcere dove il 6 aprile 2020 si verificò la mattanza al centro delle accuse.
Ieri in aula erano presenti molti imputati e alcune vittime o loro parenti. Tra
questi ultimi Antonella Cacace, la figlia di Vincenzo, il detenuto sulla sedia a
rotelle selvaggiamente picchiato nel reparto Nilo del carcere sammaritano. Le
telecamere di videosorveglianza che ripresero le scene dell’orribile mattanza
catturarono anche le fasi del pestaggio di Vincenzo costretto su una sedia a
rotelle.
Cacace è deceduto il
18 giugno scorso: la figlia con la madre e il fratello ora sono pronti a portare
avanti la sua battaglia giudiziaria per avere giustizia su ciò che accadde
quel 6 aprile 2020. «La vicenda di mio padre la conoscono tutti, i video sono
evidenti – afferma Antonella -. Mio padre ha sbagliato nella sua vita ma non
avevano alcun diritto di fargli quello che gli hanno fatto. Rimase molto
sconvolto, gli abusi in carcere gli causarono un forte stress post traumatico».
«Fin quando è stato in cella – aggiunge – non ci ha mai detto cos’era accaduto.
Lo abbiamo saputo solo dopo che è stato scarcerato, perché la sua salute
peggiorava, non riusciva più a dormire, si svegliava urlando. Quelle botte gli
erano rimaste impresse».
Viviana
Lanza.Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e
Comunicazione, è giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si
occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha
lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare
con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews,
Askanews).
Pietro Ioia, arrestato il Garante dei
detenuti di Napoli: portava droga e cellulari in carcere.
Fulvio Bufi su Il Corriere della Sera il 18 ottobre 2022.
Nominato nel 2019 dall’allora sindaco de
Magistris, Ioia ha un passato da narcotrafficante per cui ha scontato 22 anni di
reclusione
Il garante dei detenuti del Comune di
Napoli, Pietro Ioia, è stato arrestato insieme ad altre sette persone
nell’ambito di una indagine, condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura
partenopea, mirata a fare luce sull’introduzione di droga e telefoni
cellulari nel carcere di Poggioreale.
Sì tratta di episodi che sarebbero avvenuti tra il
giugno del 2021 e il gennaio di quest’anno. A gestirli quella che gli
investigatori hanno individuato come una strutturata associazione per delinquere
(reato contestato a tutti gli indagati nell’ordinanza di custodia cautelare
firmata dal gip) composta da alcuni reclusi e dalle loro mogli, oltre che dal
garante.
Secondo le indagini Ioia avrebbe approfittato del
suo ruolo, e della facilità di accesso alla casa circondariale che questo
comportava, per incontrare i detenuti coinvolti nell’organizzazione e consegnare
la droga e i cellulari. Hashish e cocaina venivano poi spacciati in
carcere fruttando all’organizzazione un guadagno che successivamente era
ripartito tra i vari partecipanti.
Pietro Ioia, 63 anni, ha un passato da
narcotrafficante che lo ha portato a scontare 22 anni di reclusione. Da molto
tempo sembrava aver abbandonato ogni tipo di attività illecita e si era a lungo
impegnato per i diritti dei detenuti. Nel dicembre del 2019 l ’allora sindaco
Luigi de Magistris lo nominò Garante dei diritti delle persone private o
limitate nella libertà personale. Ioia è anche autore di un libro sulla
cosiddetta “cella zero”, una stanza del carcere di Poggioreale che sarebbe stata
utilizzata per pestaggi e violenze sui detenuti. Sulla “cella zero” ha indagato
a lungo la Procura senza però accertarne la reale esistenza.
LA PARABOLA DEL GARANTE DEI DETENUTI DA
ATTORE IN TV A SPACCIATORE IN CARCERE. Antonio E.
Piedimonte per “La Stampa” il 19 ottobre 2022.
Dall'inferno al paradiso, e ritorno. Ancora un
paio di giorni fa era comodamente seduto nell'aula «Giancarlo Siani» del
Consiglio regionale della Campania per partecipare alla Conferenza nazionale dei
garanti dei detenuti, solo 24 ore dopo Pietro Ioia si è ritrovato tra quei
carcerati di cui si prendeva cura ma stavolta per restare con loro, in cella.
Il 63enne è stato arrestato dai carabinieri perché
- come raccontano immagini e intercettazioni - si è scoperto che oltre a
garantirgli i diritti li riforniva di droga, telefonini e altro. I mercatini
illegali nelle carceri non sono una novità, ma l'episodio ha fatto scalpore
perché l'ex narcos nato alla Sanità e cresciuto a Forcella che dopo 22 anni di
prigione si era redento, era diventato un personaggio piuttosto noto.
Grazie a un libro-denuncia sul carcere di
Poggiorale - nel quale svelava l'esistenza di una cella segreta usata per i
regolamenti di conti durante le guerre di camorra - che provocò un'indagine
della magistratura e divenne uno spettacolo teatrale. E grazie all'associazione
«Ex detenuti organizzati napoletani» (Ex Don) e alle attività nel mondo dello
spettacolo: location manager alla docuserie di Sky «Camorriste 2», o il ruolo
recitato nel film di Claudio Giovannesi «La Paranza dei bambini» tratto
dall'omonimo libro di Roberto Saviano. Insomma, un simbolo per tutti quelli che
amano una certa narrazione della parte oscura della città.
Da lì la nomina (avversata da molti) di garante
comunale, un ruolo peraltro non previsto dalla legge (c'è il garante regionale),
voluta dall'allora sindaco De Magistris (ieri l'ha definita «scelta coraggiosa»)
e poi confermata in automatico dalla giunta attuale, anche se intanto tra i
detenuti si era aggiunto un suo fratello.
A leggere l'ordinanza del gip Valentina
Giovanniello si scapisce che quello era l'ultimo dei problemi: «Ioia è il perno
principale dell'attività illecita del sodalizio () era a piena disposizione del
gruppo criminale, legato a doppio filo soprattutto dal forte movente economico,
visti i lauti guadagni».
Il resto lo dice lui (intercettato): «Ora vedo di
entrare altri due cosarielli là dentro, sotto Natale... devo prendere pure il
motorino a quello», dice Ioia prospettando l'introduzione di un paio di
cellulari nel carcere per racimolare altro denaro (mediamente 850 euro a
consegna) da usare per comprare lo scooter al figlio in vista delle festività
natalizie.
O con le parole rivolte a un detenuto dopo aver
saputo dove aveva nascosto il cellulare: «Bravo, metti sempre le mutande
strette». E lì, in un attimo, si è chiusa la parabola: da brillante testimone di
redenzione&riscatto a imbarazzante simbolo di tutto ciò che appare irredimibile.
Fulvio Bufi per il “Corriere della Sera” il 19
ottobre 2022.
Quando uscì dal carcere di Velletri, dopo aver
scontato l'ultima condanna a sedici anni, Pietro Ioia aveva nella borsa, tra
lettere, foto e ritagli di giornale, un bigliettino con un numero di telefono
scritto a penna. Glielo aveva lasciato prima di andarsene un compagno di cella
calabrese, uno che al suo paese era soprannominato Escobar . Gli aveva detto di
chiamarlo, perché di certo avrebbero trovato qualcosa da fare insieme.
Pietro quel numero non lo compose mai. Strappò il
biglietto e lo buttò. E con quello pensò di aver buttato via tutta la malavita
vissuta fino a quel giorno. Voleva tenersi i ricordi dell'infanzia a vico
Lammatari, nel cuore del Rione Sanità, con il papà di quelle parti e la mamma di
Forcella, dove lei vendeva le sigarette di contrabbando e lui giocava a fare
piramidi con i pacchetti di Marlboro, finché non arrivava Salvatore, il fratello
più grande - uno dei sette che aveva - e gliele buttava giù solo per fargli
dispetto.
Voleva tenersi l'amore di sua moglie, Pina, che
chiamavano la giornalista , perché aveva l'edicola dei giornali davanti al
vecchio tribunale di Castel Capuano, e dimenticarsi di Marina, la colombiana
conosciuta in Spagna che gli presentò il patrigno narcotrafficante e quello fece
di lui un broker della droga, uno che andava a Bogotà e faceva arrivare a Napoli
chili di cocaina da distribuire alle famiglie che gestivano lo spaccio.
Voleva cominciare a raccogliere ricordi dei suoi
figli, perché su di loro da detenuto aveva messo insieme solo i racconti della
moglie, e dimenticare di quando, appena diciannovenne, fu il primo a vendere il
fumo a Forcella, togliendo l'esclusiva alla «sposa», la piazza di spaccio dei
Quartieri spagnoli dove era un andirivieni continuo di ragazzi da tutta Napoli.
Solo una cosa non voleva eliminare dai ricordi: la
miseria del carcere. E la violenza nella «cella zero» di Poggioreale, quel luogo
del quale la magistratura non ha mai accertato l'esistenza ma che nei racconti e
nelle denunce di Ioia era un buco nero «dove le guardie ti pestavano e ti
umiliavano e qualche detenuto ci ha pure lasciato la vita».
Pietro voleva essere un ex narcotrafficante che
mai più avrebbe venduto droga, ma anche un ex recluso che mai avrebbe cancellato
dalla memoria le sofferenze della reclusione, né si sarebbe dimenticato di chi
quelle sofferenze continuava a patirle. E di sicuro è stato sia una cosa che
l'altra. Perché l'associazione che costituì nel 2004, Exdon (Ex detenuti
organizzati napoletani), ha fatto moltissimo per aiutare chi usciva dal carcere
a reinserirsi nella vita sociale e lavorativa.
E perché non possono essere stati tutti pazzi o
ciechi o sordi quelli che hanno creduto in lui. Non Luigi de Magistris che da
sindaco, nel 2019, lo nominò Garante dei detenuti del Comune di Napoli; non
Ilaria Cucchi che nello stesso anno lo inserì tra i premiati della Onlus
intitolata a suo fratello Stefano, riconoscendogli l'impegno in favore dei
diritti umani; e nemmeno Marotta e Cafiero, la casa editrice che ha aperto una
libreria a Scampia, e nel 2017 ha pubblicato il libro La cella zero, morte e
rinascita di un uomo in gabbia.
Alla fine l'unico che non ha creduto in Pietro
Ioia è stato Pietro Ioia. Vissuto troppo a lungo nel male per credere alle
favole a lieto fine, o almeno per credere che la favola a lieto fine potesse
avere lui per protagonista. E forse in una intervista a Gaia Martignetti di
FanPage lo aveva anche detto, a modo suo: «Se Pietro Ioia sbaglia di nuovo,
allora dovete infierire su Pietro Ioia». Ecco, ha sbagliato di nuovo.
Sbatti il mostro in prima pagina: il
garante Pietro Ioia, il “colpevole perfetto”. In
galera perché indagato di aver abusato della sua posizione per introdurre droga
e telefonini. Il garante nazionale chiede una linea guida, quelli territoriali
temono la messa in ombra della loro funzione. Damiano Aliprandi il 19 ottobre
2022 su Il Dubbio.
Sono giunti alle cinque di martedì mattina per
notificare l’arresto preventivo nei confronti di Pietro Ioia, Garante per i
diritti dei detenuti di Napoli. Ironia della sorte, il giorno prima ha
partecipato al convegno organizzato dalla Conferenza dei Garanti territoriali
delle persone private della libertà. Proprio quel giorno ha denunciato diverse
criticità che persistono al carcere di Poggioreale. Secondo l’ordinanza di
custodia cautelare, Ioia avrebbe abusato – in concorso con altre undici persone
– della sua funzione di garante per introdurre in quel carcere i telefonini e la
droga dietro un corrispettivo in denaro. Un’accusa che però, attraverso i mass
media, si traduce già come un fatto certo.
Già condannato da sindacati di polizia
penitenziaria e da alcuni partiti
I sindacati di polizia penitenziaria, partiti
politici come la Lega – all’epoca critici per l’elezione di Ioia a Garante – già
lo condannano. E questo nonostante la riforma Cartabia abbia rafforzato la
presunzione di innocenza. Ricordiamo che la critica nei suoi confronti è stata
trasversale visto la polemica avuta con il neodeputato dei Verdi Francesco
Emilio Borrelli solo perché durante il primo lockdown dovuto all’emergenza
Covid, insieme al garante regionale Samuele Ciambriello, si batteva per la
tutela della salute anche nelle carceri. Ed è lo stesso Borrelli che ora
afferma: «Va rimosso dal ruolo e condannato severamente». Anche i Verdi hanno
già emesso la sentenza prima ancora della formulazione dell’accusa e dell’esito
di un eventuale processo.
È stato testimone chiave nel processo sulla “cella
zero”
Pietro Ioia è il colpevole perfetto, visto il suo
passato da narcotrafficante tanto da aver scontato ben 22 anni di carcere tra
Spagna e Italia. Nel 2002, finito di scontare la pena, ha iniziato la sua
battaglia per i diritti dei detenuti, tanto da essere stato il testimone chiave
per il processo sulla “cella zero” di Poggioreale, ovvero dove avvenivano le
torture. Eletto garante di Napoli dall’allora sindaco De Magistris e confermato
anche dall’attuale nuova amministrazione, ha fatto emergere diverse criticità e
mai si è risparmiato nel denunciare più volte le condizioni atroci che si vivono
dietro le sbarre.
L’accusa, se provata, è certamente gravissima. In
primis perché metterebbe a rischio la credibilità di una istituzione importante
come quella dei garanti. A tal proposito, interviene il garante nazionale delle
persone private della libertà precisando che, come è noto, non esiste una
connessione istituzionale tra il suo ruolo e quello delle figure che
territorialmente le singole Amministrazioni nominano.
Ma nonostante ciò ha più volte sollecitato negli
anni l’adozione di “Linee guida” per indicare parametri di indipendenza,
professionalità e integrità che le Amministrazioni stesse potessero seguire
nella delicata individuazione di tali figure. «Indipendentemente da ogni
valutazione sull’indagine in corso che ha portato oggi ai provvedimenti
restrittivi e nella forte speranza istituzionale che il Garante del Comune di
Napoli possa mostrare la sua estraneità ai fatti, nonché, ovviamente, nel pieno
rispetto dell’autonomia degli Enti locali, il Garante nazionale auspica che si
giunga a una strutturazione organica dei rispettivi compiti e perimetri delle
relazioni Istituzionali che dia all’esperienza positiva portata avanti in questi
anni una riconoscibile fisionomia di responsabilità istituzionale», chiosa il
Garante Nazionale.
Il garante campano Ciambriello: «Spero che
dimostri la sua estraneità»
Interviene anche il garante della regione Campania
Samuela Ciambriello, sottolineando la sua piena fiducia nella magistratura che
con gli interrogatori di garanzia sarà chiamata a valutare il quadro
accusatorio. «Spero che, in questa circostanza o nelle future fasi, Pietro Ioia
riesca a dimostrare la sua estraneità ai fatti. Intanto, la mia posizione non
può che essere orientata verso la presunzione di innocenza», sottolinea il
garante campano.
Nello stesso tempo auspica che l’arresto di Pietro
Ioia non deve delegittimare o sminuire l’operato di tutti i Garanti, regionali,
provinciali e comunali. «Il Garante – chiosa Ciambriello – è una figura
istituzionale, che viene eletta o nominati dai rispettivi Consigli. Questo
episodio non può e non deve compromettere il lavoro di chi, ogni giorno, si
muove nella direzione di garanzia dei diritti dei detenuti. Garantire i diritti
non equivale assolutamente a rendersi complici. Accanto alla correttezza
individuale di ognuno è necessario mostrare anche una correttezza istituzionale,
questo soprattutto per garantire una tutela più soddisfacente e, quindi,
impedire che alle esigenze dei detenuti si risponda con l’illegalità». Fa da eco
anche Stefano Anastasia, portavoce dei garanti territoriali, sottolineando che
«I Garanti nominati dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, da vent’anni
svolgono un lavoro prezioso nella tutela dei diritti dei detenuti che è parte
della legalità penitenziaria e che non può essere messo in ombra dall’eventuale
abuso dei propri poteri da parte di uno di loro».
Bernardini: «questo episodio non metta in
discussione l’opera dei garanti»
Rita Bernardini di “Nessuno Tocchi Caino”, ricorda
che ogni giorno ci sono notizie riguardanti il traffico di cellulari e
stupefacenti all’interno delle carceri. A volte sono i familiari, altre volte è
il personale (soprattutto agenti), altre volte ancora il traffico si fa con i
droni o con pacchi gettati nell’intercinta dell’istituto. Sottolinea che pochi
giorni fa è stato arrestato il cappellano del carcere di Enna accusato di
portare droga in carcere. «Mai faremo abbastanza – osserva Bernardini – per
contrastare il proibizionismo sulle sostanze stupefacenti che è criminogeno a
tal punto da arrivare a corrompere interi apparati statali», e mette in guardia:
«Non sia questo episodio a mettere in discussione l’opera preziosissima in
termini di conoscenza e vigilanza che i garanti svolgono quotidianamente nei
quasi 200 istituti carcerari italiani».
Ma ritorniamo a Pietro Ioia. Secondo l’ordinanza
di custodia cautelare avrebbe commesso i fatti – almeno così si evince
osservando le date – nell’arco dei primi del mese di dicembre 2021 fino ai primi
di gennaio del 2022. In concorso con altri soggetti, avrebbe dapprima consegnato
illegalmente due cellulari dietro un compenso di 600 euro, poi altri apparecchi
per 500 euro, infine tra il 30 dicembre e l’8 gennaio 2022 avrebbe consegnato a
due detenuti un imprecisato quantitativo di hashish dal valore di 10mila euro, i
quali poi lo cedevano a terze persone non identificate. Secondo le indagini, un
detenuto e sua moglie sarebbero i capi, promotori e organizzatori, con il
compito di programmare tali traffici, avvalendosi della complicità del garante
Ioia avendo appunto la facoltà di visitare il carcere di Poggioreale.
Ioia è attualmente in carcerazione
preventiva. Preventivamente è stato subito rimosso dal suo incarico da Gaetano
Manfredi, l’attuale sindaco di Napoli, colui che ad aprile scorso lo ha
riconfermato garante comunale riconoscendone le sue qualità. «Era stato
individuato precedentemente come garante – ha commentato a caldo il sindaco – e
noi non eravamo intervenuti su questa nomina, ma adesso provvederemo subito alla
revoca. È molto grave che chi deve tutelare i detenuti possa essere oggetto di
un’inchiesta giudiziaria».
La vicenda di Ioia è ancora tutta da capire, così
come è ancora da apprendere cosa dirà in sua difesa. Ma non si può sbattere
subito il mostro in prima pagina. Il mondo penitenziario è complesso, c’è un
sottobosco poco inesplorato e dove basta poco per perdersi dentro. Il giro di
droga e cellulari non è una novità. «Alcuni detenuti mi hanno detto che ci sono
istituti penitenziari dove vige un vero e proprio tariffario per droga,
cellulari o altri oggetti proibiti. Forse non è vero, ma è verosimile», racconta
la storica radicale Rita Bernardini.
L'arresto del garante dei detenuti. Nelle
carceri si traffica di tutto, il problema è il proibizionismo.
Rita Bernardini su Il Riformista il 19 Ottobre 2022
In tanti siamo stati raggiunti dalla sconvolgente
notizia dell’arresto del nostro amico Pietro Ioia con l’accusa di traffico di
stupefacenti e di telefoni cellulari all’interno del carcere di Poggioreale. Lo
avrebbe fatto approfittando del suo ruolo di garante e ciò, se fosse provato e
vero, sarebbe gravissimo. Vedremo a cosa porteranno le indagini e se l’accusa
sarà provata. Constato che anche in questo caso poteva essere evitata la
custodia cautelare in carcere.
Ogni giorno ci sono notizie riguardanti il
traffico di cellulari e stupefacenti (droghe illegali, perché quelle legali sono
profuse a gogò) all’interno delle carceri. A volte sono i familiari, altre volte
è il personale (soprattutto agenti), altre volte ancora il traffico si fa con i
droni o con pacchi gettati nell’intercinta dell’istituto. I mezzi sono i più
fantasiosi. Pochi giorni fa è stato arrestato il cappellano
del carcere di Enna accusato di portare droga in carcere. Alcuni detenuti mi
hanno detto che ci sono istituti penitenziari dove vige un vero e proprio
tariffario per droga, cellulari o altri oggetti proibiti. Forse non è vero, ma è
verosimile.
Mai faremo abbastanza -come dovremmo- per
contrastare il proibizionismo sulle sostanze stupefacenti che è criminogeno a
tal punto da arrivare a corrompere interi apparati statali. Non sia questo
episodio a mettere in discussione l’opera preziosissima in termini di conoscenza
e vigilanza che i garanti svolgono quotidianamente nei quasi 200 istituti
carcerari italiani. Qualche benpensante dovrebbe poi spiegarmi come mai le
illegalità sistematiche dello Stato nei confronti della popolazione detenuta non
vengano mai sanzionate… Rita Bernardini
Il ritratto. Pietro Ioia, dalla cella
zero ai diritti degli ultimi: la seconda vita dell’ex narcos.
Viviana Lanza su Il Riformista il 19 Ottobre 2022
Nato al rione Sanità e cresciuto a
Forcella, Pietro Ioia si è sempre raccontato come chi non dà tutte le colpe al
destino. «Ho sbagliato tanto e ho scontato la mia condanna», ha sempre ammesso
parlando del suo passato di narcotrafficante
internazionale di hashish e cocaina e della condanna a ventidue anni espiata fra
le carceri italiane e quelle spagnole.
A Poggioreale ci rimase rinchiuso sette anni e una
volta fuori raccontò quell’inferno, arrivando a denunciare i pestaggi che alcuni
agenti avrebbero commesso nella cosiddetta “cella zero” per stabilire rapporti
di forza con i detenuti. Da quella denuncia è nato un processo, che a distanza
di dieci anni dai fatti ancora si trascina lentamente nella fase del primo grado
di giudizio, ed è nato un libro, «La cella zero», scritto dallo stesso Ioia e
pubblicato da Marotta & Cafiero editore.
Il libro è diventato poi uno spettacolo teatrale e
più in generale la storia raccontata da Ioia è diventata la molla per spostare
l’attenzione di tutti, politici e opinione pubblica, sui diritti di chi sconta
la pena in cella. Per Ioia fu l’occasione per aprire e aprirsi una nuova strada
che lo ha portato, negli anni, a impegnarsi nel sociale e approdare persino al
cinema e in teatro. Ha avuto una parte nel film “La paranza dei
bambini” di Claudio Giovannesi, premiato al Festival di Berlino per la
sceneggiatura e ispirato al libro di Saviano e a un’inchiesta della Procura sui
traffici di droga e la guerra tra giovani emergenti nei quartieri del centro
storico, e ha collaborato al documentario “Camorriste 2” nel 2017.
Ma a segnare la sua seconda vita sono stati
soprattutto l’impegno da presidente dell’associazione Ex detenuti organizzati
napoletani e, nel 2019, l’incarico, ottenuto dall’allora sindaco di Napoli Luigi
de Magistris, di garante cittadino delle persone private della libertà
personale. Ci furono moltissime polemiche per la scelta di Ioia come garante dei
detenuti di Napoli, e oggi, alla notizia del suo arresto per droga e telefoni
cellulari introdotti nel carcere di Poggioreale sfruttando le prerogative del
suo ruolo di garante, quelle polemiche sono tornate a galla come a dire «Ve lo
avevamo detto…» e anticipare una sentenza di condanna che mortifica e ignora un
sacrosanto principio, quello della presunzione di innocenza.
Non sappiamo come evolverà l’inchiesta, non
sappiamo se le accuse ipotizzate nell’ordinanza di custodia cautelare notificata
a Ioia e ad altre sette persone saranno confermate o meno. È presto per emettere
sentenze. Quel che è certo è che in questa sua “seconda vita” Pietro Ioia ha
comunque affrontato tante battaglie accanto ai garanti, ai Radicali, a
rappresentanti delle istituzioni in difesa dei diritti degli ultimi. Ora la
notizia del suo arresto, la nuova inchiesta della Procura, le accuse contenute
in intercettazioni telefoniche e ambientali sembrano inaugurare per lui una
terza stagione di vita.
Viviana Lanza. Napoletana, laureata in Economia e
con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal
2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca
nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli
per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie
di stampa (TMNews, Askanews).
Dal carcere in Spagna alla denuncia della
cella zero. Chi è Pietro Ioia, il garante dei detenuti che battaglia “contro” il
giustizialismo di Salvini e Borrelli. Ciro Cuozzo su
Il Riformista il 18 Ottobre 2022
Da poche ore è nuovamente recluso in una cella del
carcere di Poggioreale a Napoli. Quello che ha denunciato in passato per le
violenze subite sulla sua pelle (la cella zero) e quello che continuava a
visitare in questi ultimi tre anni da garante dei detenuti per tutelare e
aiutare le persone recluse.
E’ un fulmine a ciel sereno l’arresto di Pietro
Ioia, ex narcotrafficante che, dopo aver scontato ben 22 anni di carcere tra
Spagna e Italia, ha iniziato la sua battaglia a difesa dei detenuti prima con il
movimento “Ex detenuti napoletani organizzati” poi, dal dicembre 2019,
attraverso il ruolo di garante cittadino affidatogli dall’ex sindaco Luigi de
Magistris e confermato nei mesi scorsi dall’attuale primo cittadino Gaetano
Manfredi. Ruolo per il quale, è bene precisarlo, non riceve alcun compenso.
Ioia è accusato dai magistrati della Procura di
Napoli di aver sfruttato il suo ruolo per introdurre all’interno del carcere di
Poggioreale droga e cellulari. Non abbiamo ancora letto l’ordinanza che ha
portato all’arresto di 8 persone per “un giro d’affari di diverse migliaia di
euro”. Sappiamo però che Ioia in questi ultimi tre anni è diventato
un riferimento assoluto dei familiari dei detenuti.
“Mi definisco un garante abusivo, il mio ufficio è
il bar dove incontro i familiari dei detenuti” ha raccontato Ioia in passato al
Riformista prima di avere un ufficio dall’amministrazione comunale. “Prendo nota
di tutti i problemi denunciati dai loro parenti e li porto al direttore del
carcere e al dirigente sanitario”. E ancora: “Mi chiamano a qualsiasi ora, anche
di notte, per chiedermi un consiglio o informarmi di quello che sta accadendo in
carcere”.
Ex detenuto (è stato in carcere 22 anni per
narcotraffico), ha denunciato le “cella zero” di Poggioreale, dove venivano
commesse violenze nei confronti dei reclusi, compromettendo definitivamente i
suoi rapporti con la polizia penitenziaria che in questi anni, attraverso alcuni
sindacati, ha rivolto più di qualche attacco al garante cittadino. Il processo,
avviato a dicembre 2017, non ha avuto un iter molto spedito. Dodici agenti
della polizia penitenziaria, all’epoca in servizio a Poggioreale, sono imputati
a piede libero ma c’è il rischio della prescrizione. Entrare nella cella
zero voleva dire essere costretto a spogliarsi, fare flessioni e prendere le
botte, stare poi in isolamento fino a quando non si riusciva a reggersi di nuovo
in piedi sulle proprie gambe.
“Sono stato arrestato e trattenuto in carcere per
22 anni. Nel 2002 sono uscito e ho deciso di cambiare vita. Da 15 anni lotto per
i diritti dei detenuti”, raccontava in una vecchia intervista al Riformista.
Attaccato dopo la sua nomina dalla Lega di Matteo
Salvini per il suo passato, è stato definito “garante della chiavicumma” dal neo
deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli solo perché durante il
primo lockdown dovuto all’emergenza Covid, insieme al garante regionale Samuele
Ciambriello, si batteva per la tutela della salute anche nelle carceri.
Offese pronunciate nel corso di una diretta
Facebook. Parole che hanno portato Ioia, assistito dall’avvocato Raffaele
Minieri, consigliere della Camera Penale di Napoli e membro della Direzione
Nazionale Radicali Italiani, a presentare denuncia-querela presso la Procura di
Napoli. Dopo l’iniziale richiesta di archiviazione avanzata dal pm Francesca De
Renzis perché le espressioni adottate da Borrelli “non appaiono idonee a ledere
la reputazione della persona offesa”, il Gip del Tribunale di Napoli, Roberto
D’Auria, ha accolto l’opposizione dell’avvocato Minieri chiedendo al magistrato
la formulazione dell’imputazione coatta.
L’ESULTANZA DI SALVINI E BORRELLI – Adesso sia
Salvini che Borrelli gongolano. Siamo ancora nella fase delle indagini
preliminari ma da buoni giustizialisti a orologeria (soprattutto Salvini, il
caso Morisi avrebbe dovuto insegnargli qualcosa…) hanno prontamente puntato il
dito contro Ioia: “Garante dei detenuti, ex detenuto, e adesso ancora arrestato:
le grandi nomine della sinistra in Campania…” scrive il segretario del Carroccio
sui socia. “Un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria e
grazie per il loro straordinario lavoro” aggiunge.
Borrelli è quasi entusiasta dell’arresto: “Va
rimosso dal ruolo e condannato severamente. Abbiamo sempre avuto ragione e
invece lui mi insultava mi ha anche querelato in passato”.
Nel 2019 Ioia ha vinto il “Premio Diritti Umani
Stefano Cucchi onlus” promosso e consegnato da Ilaria, la sorella di Stefano, il
ragazzo morto il 22 ottobre 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare. Un
premio che lo ha particolarmente emozionato perché arriva come riconoscimento
della sua instancabile attività in difesa dei diritti dei detenuti. “È un premio
che arriva da una famiglia che ha subito un morto in quel modo, un morto in mano
allo Stato, una tragedia immane – dice Pietro – Questo premio mi fa capire che
le battaglie che si fanno per i diritti umani vanno sempre fatte. E io
continuerò a farle con tutte le mie forze”.
Ciro Cuozzo. Giornalista professionista, nato a
Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal
2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della
Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo
e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky
Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it.
Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista
Il caso di
Pietro Ioia. Il delirio giustizialista della Lega: in carcere garante per i
poliziotti e non per i detenuti.
Riccardo Polidoro su Il Riformista il 22 Ottobre 2022
La custodia
cautelare in carcere di Pietro Ioia, garante delle persone private della libertà
per l’area della Città Metropolitana di Napoli, è stato un macigno che si è
abbattuto su un terreno già disastrato e rischia, dopo quest’ulteriore
deterioramento, di precipitare definitivamente nell’abisso
del giustizialismo più deleterio. La condanna mediatica, puntualmente giunta a
poche ore dall’arresto, con riferimento virgolettato ad intercettazioni e al
contenuto di riprese video, sembrerebbe non lasciare spazio alla difesa
dell’indagato, che, nell’interrogatorio di garanzia, si è avvalso- vista la mole
di documenti da esaminare – della facoltà di non rispondere.
Una prima
riflessione va, dunque, fatta, ancora una volta, sulla pubblicazione di stralci
di atti relativi alle indagini, che dovrebbero essere riservati, esclusivamente,
alle parti e che, invece, diventano patrimonio comune. Nonostante la legge sulla
presunzione d’innocenza, che stabilisce l’espresso divieto di indicare
pubblicamente come colpevole la persona indagata, finché l’eventuale
responsabilità non sia accertata con provvedimento irrevocabile di condanna, i
media hanno illustrato, nel dettaglio, la tesi accusatoria, con precisa
distinzione dei ruoli che ciascun indagato avrebbe avuto nel commettere l’azione
criminale, unitamente alle prove che accertano tali condotte. È un dèja vu, che
non si riesce a fermare. Ma il caso Ioia ci porta ad altre valutazioni.
L’augurio è che
possa, al più presto, dimostrare la sua innocenza, per se stesso e per quello
che egli rappresenta. La sua storia, infatti, è stata, fino a questo momento, un
vero e proprio simbolo di riscatto. Ex detenuto, scontata la condanna – 22 anni
per narcotraffico internazionale – si è immediatamente dedicato ad attività che
potessero sostenere il reinserimento sociale di coloro che avevano lasciato il
carcere. Autore del libro “La cella zero”, poi divenuto opera teatrale. Un
viaggio nel mondo sconosciuto della detenzione, con particolare riguardo al
sopruso, all’abuso di potere, alla sospensione dei diritti. Da qui la denuncia
di quanto avveniva nell’istituto di Poggioreale, in quella stanza luogo di
tortura, dove i detenuti venivano vessati da agenti della Polizia
Penitenziaria. Il processo, a carico di alcuni agenti della Polizia
Penitenziaria, è ancora in corso presso il Tribunale di Napoli. Ieri l’ultima
udienza istruttoria. Il 10 novembre prossimo è prevista la discussione del
Pubblico Ministero, mentre le difese prenderanno la parola il 22 dicembre, il 5
e il 12 gennaio.
Quello di Ioia è
stato un impegno costante, anche quale Presidente dell’Associazione Ex Detenuti
Organizzati. Chi lo ha conosciuto, vedeva nei suoi occhi la passione per
l’attività di volontariato che svolgeva. La nomina a Garante, voluta dall’allora
Sindaco de Magistris e poi confermata da Manfredi, suscitò varie polemiche,
proprio per il suo passato. Mentre altri – tra cui chi scrive – sostennero
che “era la persona giusta, al posto giusto”. Chi meglio di lui, infatti, poteva
conoscere le problematiche relative alla detenzione e quelle dell’effettivo
reinserimento sociale, una volta liberi? È presto per dire se avevamo sbagliato,
in quanto la verità sarà accertata nell’unica sede possibile, quella
giudiziaria. Intanto la notizia di quanto accaduto ha immediatamente aperto il
dibattito sui criterio di scelta dei Garanti nominati dagli Enti Locali e sulla
stessa loro utilità.
La Lega, che già
in passato aveva criticato la figura dei Garanti, si è affrettata ad emanare un
comunicato in cui afferma che «al di là del nome del ministro, la Lega avrà
certamente un ruolo nel dicastero della Giustizia guidato dal centrodestra. Tra
i primi dossier da affrontare, anche alla luce dell’arresto del garante dei
detenuti del Comune di Napoli, la necessità di un garante per le donne e gli
uomini in divisa che lavorano nelle carceri italiane, troppo spesso in
condizioni inaccettabili». Ma la Polizia Penitenziaria non ha già i Sindacati –
peraltro molto attivi – a tutelare i loro diritti? Tale dichiarazione,
proveniente da un partito della coalizione di maggioranza che si accinge a
governare il Paese, è l’ulteriore prova – semmai ce ne fosse stato bisogno –
che, in materia di Giustizia ed in particolare di Esecuzione Penale, non vi sarà
alcuna possibilità che vengano pienamente rispettati i principi costituzionali.
Per questo, se
davvero Pietro Ioia fosse colpevole, la sua azione criminale colpirà non solo la
sua persona, ma, come in realtà già sta avvenendo, darà forza a quella deriva
giustizialista che ai detenuti nulla vuole concedere, neanche i loro diritti. La
sua colpevolezza rappresenterebbe, inoltre, per coloro che in lui hanno creduto
e ne hanno ammirato la volontà di riscatto, un vero e proprio tradimento.
Dopo l’arresto
dell’ex garante cittadino dei detenuti. Arresto Ioia, dietrofront della
penitenziaria: “Si a garanti ma indipendenti”.
Francesca Sabella su Il Riformista il 23 Ottobre 2022
L’arresto
dell’ormai ex garante cittadino dei detenuti Pietro Ioia, accusato di aver
introdotto all’interno del carcere di Poggioreale droga e cellulari (ricordiamo
che fino al terzo grado sarebbe bene osservare il principio della presunzione
d’innocenza) ha agitato l’animo dei tanti giustizialisti. Dalla politica alle
istituzioni tutti hanno sventolato la bandiera del “colpevole subito, colpevole
da sempre”.
Più laica e meno
giustizialista è apparsa, invece, la posizione di Gennarino De Fazio, Segretario
Generale della UILPA Polizia Penitenziaria: «L’arresto del già tanto discusso
garante dei detenuti del comune di Napoli per gravi reati anche connessi al
traffico di droga e all’illecita introduzione in carcere di sostanze non
consentite e telefoni cellulari ripropone l’urgenza di dettare linee guida
omogenee affinché per tale ruolo vengano individuate figure che rispondano a
criteri d’indipendenza e professionalità».
E ancora, si
legge nella nota diffusa ieri dal sindacato: «Guardiamo con favore a chiunque
operi per la difesa dei diritti e della legalità e il Corpo di polizia
penitenziaria ha anche il compito, per dirla con le parole di Dino Petralia, già
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, di garantire le
garanzie e, dunque, di garantire persino i garanti dei detenuti. Tali figure del
resto – aggiunge – possono svolgere, e non di rado lo fanno, una funzione non
secondaria per la tenuta dell’intero sistema carcerario e nella ricerca di
soluzioni utili a farlo uscire dalla crisi in cui versa. In qualche caso,
tuttavia, abbiamo assistito alla designazione di personaggi molto discussi o
comunque ‘sui generis’ che hanno destato molte perplessità e, paradossalmente,
per restare in metafora, non offrivano alcuna garanzia di poter garantire,
rischiando, al contrario, di esacerbare gli animi in un contesto in cui gli
equilibri sono intrinsecamente precari».
Da qui la
richiesta di linee guida specifiche: «Trovandoci peraltro in sintonia con il
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà
personale, Mauro Palma, riteniamo che l’adozione di linee guida che orientino le
nomine possa essere la giusta soluzione. Non va dimenticato – conclude – che i
garanti locali dei detenuti hanno il libero accesso alle strutture penitenziarie
dei rispettivi territori, le quali, come nel caso di Napoli, possono essere più
di una, anche di notevoli dimensioni, e ospitare migliaia di reclusi. Per noi,
dunque, indipendenza e professionalità costituiscono un indice di competenza,
moderazione ed equilibrio, ma anche di sicurezza».
Francesca
Sabella. Nata a Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole
ha deciso, non senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo
lavoro. Giornalista pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e
i suoi protagonisti.
L’inchiesta su droga e telefoni
introdotti in carcere. Garante arrestato, non si usi Pietro Ioia per svilire chi
si adopera per la tutela dei detenuti. Viviana
Lanza su Il Riformista il 19 Ottobre 2022
La misura cautelare, il tempismo dell’inchiesta,
le accuse ipotizzate dagli inquirenti: la notizia dell’arresto di Pietro
Ioia, garante dei detenuti della Città metropolitana di Napoli, arriva come un
terremoto. Scuote, coglie alla sprovvista, lascia attoniti. Ioia è accusato di
essersi fatto corrompere accettando di far parte di un’associazione a delinquere
che lucrava facendo entrare droga e telefoni cellulari in carcere,
nel carcere di Poggioreale.
Appena ventiquattro ore prima
dell’arresto, Ioia era alla Conferenza nazionale dei garanti regionali e
territoriali tenutasi a Napoli e aveva preso la parola per fornire il proprio
contributo di idee e denunciare le criticità nella gestione del vitto e del
sopravvivo in alcuni istituti penitenziari. Adesso è al centro di accuse
gravissime, aggravate dal fatto di aver agito sfruttando il suo ruolo di garante
e la possibilità, che da tale ruolo deriva, di entrare nelle carceri e avere
contatti con i detenuti. Se queste accuse non dovessero trovare alcuna conferma
processuale ci troveremmo dinanzi a un ennesimo caso di gogna
mediatica e giudiziaria, se invece la conferma dovesse arrivare si tratterebbe
della responsabilità del singolo che non deve intaccare né svilire la figura del
garante dei detenuti.
In ogni caso, tuttavia, appare ancora una volta
evidente quanto fallimentare sia il sistema carcere così come è strutturato. Il
carcere genera violenza, produce aberrazioni, distorce i rapporti tra le persone
che lo popolano, siano essi reclusi o chi all’interno di quelle strutture ci
lavora. Il grande rischio, in questo momento, è di fare di tutta l’erba un
fascio e demolire non solo la figura del garante ma anche la funzione della pena
che è poi la sua stessa natura, cioè la funzione di recupero del condannato ai
fini della sua rieducazione, di un suo reinserimento nella società. Pietro
Ioia ha incarnato proprio tutto questo, diventando una sorta di simbolo del
riscatto dopo il carcere, della seconda chance per cambiare vita, obiettivi e
frequentazioni.
Da ieri mattina è in carcere, e ironia della sorte
proprio a Poggioreale, e, assistito dall’avvocato Raffaele Minieri, oggi
comparirà davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. I carabinieri di
Castello di Cisterna, coordinati dalla Procura di Napoli, hanno intercettato per
mesi, a cavallo tra giugno dell’anno scorso e gennaio di quest’anno, il suo
telefono e quelli di altri sette indagati e hanno ripreso, con intercettazioni
ambientali, i colloqui che da garante cittadino aveva con alcuni detenuti.
Accusano Ioia di esseri fatto corrompere per «i soldi per il motorino, i soldi
per Natale, i soldi per il primo dell’anno». È duro il gip nel ritenere le
esigenze cautelari gravi al punto da non poter scegliere altra misura se non il
carcere: «Ioia, sfruttando il suo ruolo di garante dei detenuti, piuttosto che
agire nell’interesse della collettività ne approfittava per trarne occasione di
ingenti guadagni».
«È una notizia sconvolgente – commenta Rita
Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino – Vedremo a cosa porteranno le
indagini e se l’accusa sarà provata. Constato che anche in questo caso poteva
essere evitata la custodia cautelare in carcere». Si dice «attonito» il garante
regionale Samuele Ciambriello: «Ho piena fiducia nella magistratura e spero che
il garante Ioia possa dimostrare la sua estraneità ai fatti. Questo episodio non
può e non deve delegittimare l’operato di tutti noi garanti». Anche il portavoce
della conferenza dei garanti territoriali, Stefano Anastasia interviene su
questo punto: «I garanti svolgono un lavoro prezioso nella tutela dei diritti
dei detenuti che è parte della legalità penitenziaria e non può essere messo in
ombra dall’eventuale abuso dei propri poteri da parte di uno di loro». Intanto
il Comune di Napoli ha avviato la procedura per revocare a Pietro
Ioia l’incarico di garante cittadino.
Viviana Lanza. Napoletana, laureata in Economia e
con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal
2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca
nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli
per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie
di stampa (TMNews, Askanew
Il Comune verso la revoca della nomina.
Perché è stato arrestato Pietro Ioia, il garante dei detenuti di Napoli.
Angela Stella su Il Riformista il 19 Ottobre 2022
La notizia è “sconvolgente”, come ha scritto la
presidente di Nessuno Tocchi Caino, Rita Bernardini: il garante dei diritti
delle persone private della libertà personale del Comune di Napoli, Pietro
Ioia, è stato arrestato ieri insieme ad altre sette persone nell’ambito di una
indagine, condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura partenopea, mirata
a sgominare una presunta associazione per delinquere, radicata nel capoluogo
partenopeo, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti
tra cui l’introduzione illegale di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti
all’interno della Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale.
Gli episodi contestati risalirebbero al periodo
compreso tra il giugno del 2021 e il gennaio di quest’anno. La Direzione del
carcere e la polizia penitenziaria hanno collaborato alle indagini nella fase di
osservazione dei colloqui. Ioia sarebbe addirittura il deus ex machina di questa
strutturata associazione per delinquere (reato contestato a tutti gli indagati
nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip) composta da alcuni reclusi
e dalle loro mogli, oltre che dal garante appunto. Secondo le indagini Ioia
avrebbe approfittato del suo ruolo, e della facilità di accesso alla casa
circondariale che questo comportava, per incontrare i detenuti coinvolti
nell’organizzazione e consegnare durante i colloqui, dietro un compenso di
500/600 euro, la droga e i cellulari, avuti dalla compagna di uno dei reclusi.
A fare da intermediario tra Ioia e la donna, la
moglie del garante. Hashish e cocaina venivano poi spacciati in carcere
fruttando all’organizzazione un guadagno che successivamente era ripartito tra i
vari partecipanti. Le indagini avrebbero evidenziato l’esistenza di un dilagante
fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina), del valore
economico di diverse migliaia di euro, all’interno dell’istituto penitenziario.
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha emesso,
su richiesta della Procura partenopea, sei misure cautelari in carcere e due ai
domiciliari. Dietro le sbarre rimane Ioia, 63 anni, con un passato da
narcotrafficante che lo ha portato a scontare ventidue anni di reclusione.
Nel dicembre del 2019 l’allora sindaco Luigi de
Magistris lo nominò Garante dei diritti delle persone private o limitate nella
libertà personale. Alla luce dell’inchiesta giudiziaria, il Comune “sta
predisponendo gli opportuni provvedimenti di revoca della carica affidata a Ioia
dalla precedente amministrazione”, si è letto in una nota di palazzo San
Giacomo. Ioia è anche autore di un libro sulla cosiddetta “cella zero”, una
stanza del carcere di Poggioreale che sarebbe stata utilizzata per pestaggi e
violenze sui detenuti. Le indagini sono partite nel giugno 2021 con
l’intercettazione di una utenza telefonica in uso a diversi detenuti i quali,
mentre parlavano con i propri familiari, facevano riferimento ad un certo
‘Pierino’ poi identificato dagli inquirenti con Ioia, che avrebbe usato anche il
nome di copertura ‘avvocato’. Da lì sono state poste sotto monitoraggio le
utenze della compagna di un recluso e del garante, a cui è stato anche inserito
un trojan nel cellulare. In più Ioia sarebbe stato inquadrato dalle telecamere
in carcere mentre passava la merce ai detenuti. Il condizionale è d’obbligo e
non solo per puro formalismo perché fino a condanna definitiva vige
la presunzione di innocenza di tutti i coinvolti.
Diverse comunque le reazioni alla notizia. Non
aspettava altro l’onorevole leghista Jacopo Morrone, pronto forse a tornare a
Via Arenula nuovamente come sottosegretario: “In attesa di conoscere più
dettagliatamente i risultati delle indagini e che la magistratura svolga il
proprio lavoro, non possiamo che ricordare le perplessità che furono sollevate
in tempi non sospetti rispetto a questa nomina poco meditata e più d’effetto
ideologico/propagandistico che determinata da valutazioni obiettive e oggettive
e da un curriculum adeguato al ruolo”. Di parere opposto Sandra Berardi,
Presidente presso Associazione Yairaiha Onlus: “Non credo minimamente che Pietro
Ioia sia stato così stupido da portare droga e telefoni in carcere. Credo,
piuttosto, che si stia cercando di infangare e silenziare una voce libera che
non ha paura di stare al fianco degli ultimi e di denunciare, invece, i crimini
del sistema carcerario”.
Ha parlato anche il Garante nazionale dei diritti
dei detenuti che ha precisato come “non esista una connessione istituzionale tra
il suo ruolo e quello delle figure che territorialmente le singole
Amministrazioni nominano”. Una netta presa di distanza a cui ha aggiunto di aver
“più volte sollecitato negli anni l’adozione di ‘Linee guida’ per indicare
parametri di indipendenza, professionalità e integrità che le Amministrazioni
stesse potessero seguire nella delicata individuazione di tali figure”. Quasi a
dire che forse Ioia non sarebbe stato candidabile con quei parametri. Infine il
garante auspica che Ioia “possa mostrare la sua estraneità ai fatti”. In realtà
nel nostro sistema giudiziario l’onere della prova spetta all’accusa. In una
nota si è espresso anche Stefano Anastasia, Portavoce della Conferenza dei
Garanti, per cui il lavoro ventennale dei garanti “nella tutela dei diritti dei
detenuti non può essere messo in ombra dall’eventuale abuso dei propri poteri da
parte di uno di loro”. Angela Stella
Il giorno dopo l’inchiesta
su droga e telefoni in carcere. Arresto Ioia, la gogna dei saputelli contro i
garanti dei detenuti: lo show della polizia penitenziaria.
Viviana Lanza su Il Riformista il 20 Ottobre 2022
È difficile dire se somigliano
più ai saputelli del giorno dopo, quelli del «Te lo avevo detto io…», oppure a
quelli dallo sguardo sempre obliquo pronti a cogliere il minimo sbaglio per
poter infierire. Sta di fatto che stanno venendo fuori uno dietro l’altro. Viene
da immaginarseli mentre gonfiano il petto e si sfregano le mani per commentare
l’arresto del garante dei detenuti di Napoli Pietro Ioia, ricordando che è un ex
detenuto, e dare fiato al giustizialismo più sfrenato.
Per qualcuno Ioia è già
colpevole, da rimuovere dall’incarico e condannare. E questo qualcuno è
impossibile che abbia letto tutti gli atti dell’inchiesta, al più avrà letto
qualche articolo di giornale o forse soltanto qualche titolo (purtroppo molti
fanno così: leggono il titolo e credono di sapere già tutto). E questo qualcuno
avrà probabilmente fatto un bel ghigno alla notizia che ieri mattina Pietro
Ioia è apparso provato all’interrogatorio di garanzia e si è avvalso della
facoltà di non rispondere, e avrà pensato «Ha fatto scena muta» come se questo
portasse automaticamente a certe frettolose conclusioni, senza pensare che
avvalersi della facoltà di non rispondere è un diritto concesso all’indagato e
rientra nel normale iter giudiziario in questa fase dell’inchiesta, quindi non
significa nulla sul piano dell’accertamento della responsabilità penale. Questo
lo dice la legge, mica noi garantisti!
Assistito
dall’avvocato Raffaele Minieri, Ioia potrebbe scegliere di presentare istanza
al Riesame: anche questo rientra nelle sue facoltà di indagato e sempre perché
lo stabilisce la procedura penale. Sarà la magistratura a coordinare le indagini
e verificare tutti gli indizi e le ipotesi di reato e sarà nel contraddittorio
delle parti che si risolverà questa vicenda giudiziaria, sembra pertanto
prematuro sparare sentenze già oggi, a due giorni dall’arresto. Eppure in tanti
lo stanno facendo. Pietro Ioia è accusato di essersi prestato a
consegnare droga e telefoni cellulari ad alcuni detenuti
del carcere di Poggioreale dietro compenso in denaro. Queste accuse, se provate,
sono sicuramente molto gravi e in questo momento il rischio è che sia messa in
dubbio non soltanto la responsabilità del singolo garante ma la figura di tutti
i garanti territoriali. Infatti è già iniziata la guerra ai garanti.
I primi ad aver impugnato le
armi verbali contro questa figura di tutela dei diritti delle persone private
della libertà personale sono stati i sindacati della polizia penitenziaria.
Alcune agenzie hanno rilanciato ieri le dichiarazioni di Giuseppe
Moretti, presidente dell’Unione sindacati di polizia penitenziaria, che in un
certo senso se la prende con i garanti, regionale e nazionale. «Prendiamo atto
che il sindaco ha avviato le procedure per la revoca della nomina di Pietro
Ioia quale atto dovuto, mentre riteniamo che chi debba tacere dovrebbe farlo, ad
esempio il garante regionale della Campania, invece di parlare
di “sciacallaggio” sui gravi fatti che stanno emergendo, avrebbe lui dovuto
monitorare le attività dei garanti comunali da lui coordinati», ha affermato
Moretti aggiungendo che «anche le dichiarazioni del garante nazionale appaiono
tardive rispetto alle richieste avanzate dall’Uspp di regolamentazione delle
caratteristiche che devono avere queste figure, ricordando le limitazioni
previste già per il solo accesso negli istituti penitenziari per chi ha
precedenti penali».
E poi il colpo finale: «Resta
fermo il fatto che per l’Uspp queste figure in ambito territoriale sono solo un
costo per la collettività, visto che per noi i primi garanti delle condizioni
detentive restano i magistrati di Sorveglianza. Auspichiamo un urgente
provvedimento del nuovo esecutivo per scongiurare altri casi come quello di
specie». Insomma, si sta cogliendo l’occasione per dare spazio a posizioni
meno garantiste e più giustizialiste, con frasi trite e ritrite. Della serie:
sbattiamo il mostro in prima pagina e facciamo di tutta l’erba un fascio.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Aska
A Regina Coeli c’è un detenuto che dorme
da 4 mesi e nessuno sa cosa abbia. La denuncia di
Antigone: "l'uomo che dorme" ha 28 anni, non mangia, non risponde, non reagisce
agli stimoli. In carcere lo chiamano "il simulatore". Il Dubbio il 19 ottobre
2022.
Nel carcere di Regina Coeli c’è un detenuto che
dorme da quattro mesi e nessuno sa cosa abbia. Per tutti è “l’uomo che dorme”.
Ha 28 anni, è originario del Pakistan, ed è soprannominato dal personale il
“simulatore”.
A raccontare la storia Susanna Marietti,
coordinatrice dell’associazione Antigone, che ha incontrato l’uomo a giugno
scorso. «In questi mesi ho chiesto notizie, spiegazioni, soluzioni. Ma non sono
riuscita ad arrivare a capo di nulla», spiega Marietti. «L’ho incontrato in una
stanza di degenza del centro clinico del carcere. Dormiva. O comunque era
sdraiato sul letto, a occhi chiusi e immobile. L’infermiere mi ha spiegato che
il ragazzo dorme sempre. Lui gli svuota il catetere, gli cambia il pannolone,
gli infila un po’ di cibo liquido in bocca che l’uomo deglutisce in maniera
meccanica. Gli ho domandato da quanto tempo il ragazzo si trovasse in quelle
condizioni. Alcuni mesi, mi è stato risposto», dice Marietti che ha raccontato
questa storia nel suo blog su Il Fatto Quotidiano e che è stata rilanciata da
Antigone in un post su Facebook.
«Il personale del carcere che mi accompagnava in
visita si riferiva a lui con l’appellativo di “simulatore”. Ho chiesto il perché
e mi è stato detto che i vari controlli medici – molti, anche esterni al
carcere, presso l’ospedale Sandro Pertini dove il ragazzo è stato più volte
ricoverato – non hanno mai riscontrato nulla di oggettivo. Ho provato a dire –
sottolinea Marietti – che la simulazione è un comportamento che viene messo in
atto intenzionalmente e che nessuno simulerebbe mesi di morte apparente».
«Il ragazzo – aggiunge Marietti – non ha ancora
una sentenza definitiva e nelle settimane passate, secondo quanto mi è stato
raccontato durante la mia visita, si erano tenute alcune udienze del processo
che lo riguarda. Ma il ragazzo dorme. Quando gli viene domandato se intende
rinunciare a presenziare in tribunale, lui semplicemente dorme. Non risponde, né
tantomeno afferra una penna per firmare il modulo apposito. Dorme e basta. E la
presenza al processo è un diritto procedurale che non si può negare se non su
esplicita rinuncia. L’uomo veniva quindi adagiato su una barella, portato in
tribunale e fatto stare lì, nell’aula dove si teneva l’udienza, addormentato e
immobile, con il suo catetere e il suo pannolone, mentre i magistrati facevano
il loro lavoro, per poi essere riportato nella sua stanza del carcere».
«Figure apicali del carcere in queste settimane si
sono dedicate con grande impegno a cercare di individuare una soluzione
praticabile. Ma sembra non esserci. E il ragazzo è lì, che dorme. Da mesi e
forse per mesi. “Hai cambiato il pannolone al simulatore?”, “va pulita la cella
del simulatore”, “il simulatore deve andare all’udienza”. La colpa non è di
nessuno in particolare. Ma in un sistema che può tollerare la presenza dell’uomo
che dorme in una cella al centro di Roma c’è qualcosa che non funziona»,
conclude Marietti.
Il dramma dietro le sbarre.
L’unica libertà concessa in carcere? Impazzire.
Raffaella Stacciarini su Il Riformista il 14 Ottobre 2022
Ogni volta come la prima. La
prima cosa a cambiare quando si mette piede in un carcere è la luce: si entra in
un mondo altro illuminato da una luce diversa, livida e parassita, che s’attacca
alle pareti, agli oggetti, alle persone. Impregna e uniforma tutto. A fine
settembre con Nessuno tocchi Caino, Cellula Coscioni Marcuzzo e i rappresentanti
delle camere penali di Ascoli Piceno siamo entrati nella Casa Circondariale
di Marino del Tronto (Ascoli Piceno), ultima tappa del “Viaggio della speranza”
negli istituti penitenziari marchigiani per verificare le condizioni di
detenzione e fornire ai detenuti dettagli sulla recente circolare sui colloqui
diramata da Carlo Renoldi, capo del DAP.
Nel microcosmo
del carcere cambia la luce, ma non la società, che si traspone netta nella
separazione tra le sezioni: la media sicurezza sovraffollata da storie di
disperazione e povertà, e quindi tossicodipendenti e stranieri; l’articolazione
salute mentale che cura (poco e male) chi dovrebbe essere curato altrove; la
sezione protetti che protegge i detenuti dimenticandoli; l’alta sicurezza
popolata per lo più da persone compassate e preparatissime, come se in qualche
modo subdolo il male fosse correlato al livello culturale o spingesse ad
accrescerlo per fronteggiare vita e processi.
Nel penitenziario di Marino
del Tronto poco o nulla resta di quel ventaglio di attività propedeutiche al
reinserimento sociale e alla riparazione del reato presenti fino a cinque anni
fa: i percorsi di alfabetizzazione per stranieri, la scuola media e il biennio
superiore, i corsi professionali, la pet therapy, il teatro, il cineforum,
l’orto sociale interno, le giornate ecologiche. Oggi nessuna attività formativa,
nessun accesso allo studio, scarse e mal retribuite possibilità di lavoro
interno, celle con sei persone progettate per tre, celle per una persona con una
persona che ha due ore d’aria al giorno, l’aria di un corridoio coperto da un
reticolato che riflette l’ombra dell’acciaio – pure l’ombra ti ricorda dove sei.
Rimangono cappella e palestra, simulacri spaziali dell’espiazione del peccato e
della produzione di endorfine funzionali a una più sopportabile sopravvivenza.
Come si fa a convivere col
nulla, e di quello vivere per tutta la durata della detenzione? A chi o a cosa
serve? Di certo non alle finalità rieducative e riabilitative della
pena stabilite in maniera chiara dalla nostra Costituzione. Né alla società né
al reo. «L’unica libertà che il carcere concede è quella di impazzire», dice un
detenuto della media sicurezza. Quello di Ascoli è un caso critico – acuito
dalla presenza/assenza di una direttrice sostituta che ha già la guida
dell’istituto di Fermo e dal personale penitenziario perennemente sotto organico
– ma simboleggia la spia di un malessere generalizzato e diffuso.
Per le carceri
italiane il bilancio del 2022 è tragico, mai tanti suicidi come nei primi nove
mesi dell’anno: 67 persone si sono tolte la vita, di queste 3 a Marino del
Tronto; l’ultimo in piena estate, ad agosto, un ragazzo di 37 anni da poco
dimesso dal reparto psichiatrico dell’ospedale di San Benedetto del Tronto dopo
l’ennesimo tentativo di farla finita. A morire sono per lo più giovani dietro le
sbarre per reati minori o in condizioni di fragilità psicofisica. Con la
chiusura degli OPG, infatti, una grossa mole di detenuti con patologie
psichiatriche è stata dirottata negli istituti, un travaso che ha svelato nel
tempo l’inadeguatezza dei livelli essenziali di assistenza da parte del sistema
penitenziario. Con loro fanno il paio i detenuti tossicodipendenti, che
rappresentano circa il 30% del totale e hanno difficile accesso alle misure
alternative, peraltro spesso inadeguate al corretto trattamento sanitario,
rischiando di compromettere il percorso di recupero sociale dell’individuo.
Nonostante la situazione di
per sé emergenziale, il futuro sulla carta non sembra promettere alleggerimenti
della popolazione carceraria. Giorgia Meloni ha rimarcato la necessità della
certezza della pena, si è già dichiarata contraria ad amnistia e indulto e per
risolvere il problema sovraffollamento – che in Italia sfiora il 108% – ha
rilanciato la popolarissima e antipopolare proposta di costruire nuove strutture
per la detenzione, senza spiegare con quali fondi, in quali tempi e dove. La
certezza della pena c’è sempre, è sulla sua umanità e sui diritti chiusi in
cella che bisogna continuare a vigilare.
Raffaella Stacciarini
Giustizia e carcere.
Riscopriamo l’umanesimo penale: recuperiamo la lezione di Moro su vittima e
colpevole.
Gennaro Salzano su Il Riformista il 4 Ottobre 2022
C’è stato un tempo,
in Italia, in cui la politica trattava le questioni della giustizia, del reato,
della pena tenendo d’occhio innanzitutto l’umanità: quella della vittima, che
erano insieme la società ed il singolo, e quella del reo. É l’Italia di Aldo
Moro che era leader politico di livello internazionale, ma anche filosofo di
profondissimo pensiero. Formato alla scuola positivista del suo maestro Biagio
Petrocelli, ne prende le distanze per aderire e, per certi versi, fondare un
pensiero penalistico che assume i connotati del personalismo di Maritain.
Per comprendere la “filosofia
penalistica” di Moro occorre dare innanzitutto uno sguardo veloce alla sua
stessa idea di diritto che era, per lui, strumento etico di unità dell’umanità.
Nell’idea di diritto di Moro non vi è nulla di meccanico, di formale: esso è
invece lo strumento attraverso il quale lo Stato e, prima ancora, la società,
positivizzano i percorsi di normazione che accompagnano l’umanità verso il
raggiungimento della sua pienezza che si può dire essere l’unità etica di tutti
gli individui-persona nei progressivi stadi di avanzamento dalla comunità
familiare, alle formazioni sociali, allo Stato alla comunità internazionale. Il
diritto che via via si pone è, quindi, per Moro sempre un diritto giusto, poiché
è frutto dello spirito che accompagna questo processo unificante della intera
umanità. Non può non essere così, almeno finché esso non si sclerotizza in forme
che impediscono l’unità piuttosto che realizzarla. In questa idea di diritto si
inserisce la concezione morotea della pena e della coercizione.
La funzione primaria della
pena, in Moro, va ricercata nel ristabilimento della condizione di equilibrio
etico precedente la commissione del fatto illecito. Non è quindi, per Moro, un
semplice, quanto spesso impossibile, recupero della precedente realtà materiale,
quanto invece il recupero di una condizione della convivenza in cui trionfa la
giustizia. In questa dinamica, avverte Moro, il protagonista è l’umanità: quella
dell’offeso e quella del reo. La pena è la reazione che la società pone di
fronte alla commissione dell’atto illecito. Affinché essa abbia successo e porti
al recupero della condizione di giustizia deve essere personale, legale,
proporzionale. Fondata sul diritto essa è personale in quanto non può avvenire
senza la piena adesione del reo al cui recupero la pena stessa è funzionale. Il
soggetto che ha rotto l’equilibrio sociale col comportamento deviante deve cioè
essere messo in condizione di comprendere il suo errore e di aderire liberamente
alla punizione che la società ha posto verso il suo comportamento.
Solo così, per Moro, la pena
può veramente avere successo e ristabilire l’equilibrio etico che è stato rotto.
È un’idea che sottende praticamente tutto il pensiero di Moro, in ogni campo:
non c’è vera stabilità e non c’è successo nell’agire umano, se la soluzione ad
un problema non trova l’adesione di tutti coloro che sono chiamati a dare
soluzione a quel problema stesso. Va da sé, quindi, che in una tale visione, non
solo la pena di morte, ma anche la detenzione perpetua sono ritenute delle pene
ingiuste. La prima è, di tutta evidenza, la negazione stessa del diritto e della
giustizia poiché sopprime uno degli elementi essenziali alla ricostruzione
dell’equilibrio, la seconda perché nega la possibilità di riabilitazione del reo
e quindi la sua adesione al ristabilimento della giustizia.
«Alla coercizione – sosteneva
Moro nelle sue lezioni – non è rimesso il compito della definitiva restaurazione
dell’ordine etico giuridico, ma di porre le condizioni che agevolino questo
ritrovamento del soggetto (…) che si opera con gli strumenti insostituibili
della libertà della persona umana». L’uso della forza come reazione che
individuo e società pongono verso il reo, dunque, è «avviamento ad una libera
accettazione. E (…) garanzia del successo è la misura dell’amore che individuo e
società pongono nella loro reazione; è la sincerità del desiderio di bene, la
effettiva imparzialità, la ponderatezza che animano i soggetti i quali entrano
in questa vicenda».
Certo Moro prendeva in
considerazione la possibilità che il reo permanesse nell’errore: «in quel punto
il diritto è fallito e resta un ineliminabile residuo di male». Così come può
accadere che sia la forza della coercizione ad essere fonte del male. È questo
il caso in cui la resistenza del reo, animato dalla volontà di emendare sé
stesso, diventa addirittura trionfo della vita morale. Ecco, in un’Italia dove
da anni impera un giustizialismo violento, la riscoperta delle radici dell’idea
di giustizia sottesa alla Costituzione stessa, cui Moro diede ampio contributo,
sarebbe un esercizio utile al recupero della nostra civiltà politica e
giuridica. Gennaro Salzano
Quei 55 giudici e pm in
galera per provare l’effetto che fa….
In Belgio sono stati
“incarcerati” 55 magistrati tra pm e giudici che volontariamente hanno scelto di
sperimentare la vita dei detenuti. Valentina Stella su Il Dubbio il 20 settembre
2022.
In Belgio, sabato scorso, sono
stati “incarcerati” 55 magistrati tra pm e giudici che volontariamente hanno
scelto di sperimentare la vita dei detenuti. L’istituto di pena che si trova
nella zona di Bruxelles è il carcere di Haren, una nuova struttura con una
capacità di 1.190 detenuti che sarà inaugurata il 30 settembre. L’obiettivo è
stato quello di comprendere meglio la vita quotidiana dei reclusi e cosa
significa essere privati della libertà personale.
L’esperimento è però durato
poco, solo fino a domenica. I togati hanno dovuto seguire gli ordini e le
istruzioni del personale carcerario, è stato tolto loro il cellulare, hanno
mangiato gli stessi pasti e compiuto le stesse attività degli altri detenuti.
Sono stati impiegati, tra l’altro, in cucina e in lavanderia. E avrebbero potuto
ricevere le visite dei familiari. Insomma sono stati trattati come veri e
proprio prigionieri.
«I magistrati – ha
commentato il ministro della Giustizia belga Vincent Van Quickenborne – sanno
ovviamente come funzionano le cose in un carcere, ma viverle in prima persona
offre loro un’opportunità unica che può aiutarli a emettere sentenze con piena
cognizione di causa». Il funzionario fiammingo, membro del partito liberale Open
Vld, ha aggiunto che questa esperienza dovrebbe aiutare a preparare meglio
l’apertura di questo nuovo carcere, ottimizzandone la disposizione e
«sviluppando un approccio moderno». Certo, come hanno sottolineato Riccardo Radi
e Vincenzo Giglio sul blog Terzultima fermata, non va dimenticato “il più
formidabile dei benefit” concesso ai magistrati, ossia la possibilità di
“lasciare il carcere a semplice domanda, gli basta dire che non sopportano più
la clausura”. Giustissimo, ci mancherebbe: tuttavia questa opportunità segna la
grandissima differenza a livello di approccio psicologico tra chi entra in
carcere e sa di non avere la chance di uscirne presto e quando desidera e chi
con una alzata di mano al primo cedimento può tornare in libertà.
In Italia purtroppo non ci
sono queste possibilità di sperimentazione. Come ci ha ricordato tempo fa in una
intervista il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze, Marcello
Bortolato, «quando Presidente della Scuola Superiore della Magistratura era il
professor Valerio Onida, i giovani magistrati in tirocinio erano tenuti a
frequentare degli stage penitenziari addirittura per 15 giorni. Poi, per alcune
ingiustificate polemiche che sono sorte anche all’interno della magistratura,
non se ne è fatto più nulla perdendo, a mio avviso, un’occasione unica di
crescita professionale ed esperienza umana».
Tornando alla prigione di
Haren, il progetto di costruzione si è basato sul principio del villaggio
carcerario, ovvero una serie di edifici distribuiti sul sito piuttosto che un
unico enorme edificio. Il complesso carcerario è composto, da un lato, da una
serie di edifici con strutture comuni come aree di visita, laboratori, un
palazzetto dello sport e, dall’altro, da diversi edifici dove saranno alloggiati
i detenuti. I detenuti potranno spostarsi tra il proprio edificio e le strutture
comuni in modo sicuro e controllato. Eppure, nonostante l’entusiasmo delle
autorità, questo progetto di “prigione cittadina” ha incontrato una forte
opposizione da parte dei cittadini e delle associazione forensi: la prigione di
Haren sarebbe, per molti, l’ultima incarnazione della corsa all’incarcerazione
senza riuscire poi a risolvere il problema del sovraffollamento.
Magistrati in carcere, cari
pm seguiti l’esempio dei vostri colleghi in Belgio.
Riccardo Polidoro su Il
Riformista il 21 Settembre 2022
In Belgio cinquantacinque
magistrati hanno deciso di trascorrere il fine settimana
nel carcere di Haren, nella zona di Bruxelles, per conoscere “dal vivo” la
quotidianità della detenzione. La struttura sarà inaugurata il 30 settembre. Non
è la prima volta che ciò avviene. Nel luglio 2018 circa cento persone, tra
avvocati, giudici, giornalisti, poliziotti, furono rinchiusi per quarantotto ore
nel carcere belga di Beveren che si sarebbe inaugurato successivamente, al fine
di collaudare il nuovo istituto ed in particolare il corretto funzionamento dei
sistemi di sorveglianza e della piattaforma digitale destinata ai detenuti per
seguire i corsi on-line. Agli ordini del personale penitenziario, i giudici ed
i pubblici ministeri – privati del telefono cellulare – sono stati rinchiusi
nelle stanze, hanno mangiato il cibo del carcere, hanno lavorato in cucina e in
lavanderia, hanno curato la pulizia dell’istituto e partecipato ad attività
trattamentali.
L’esperimento va accolto con
favore, pur con gli evidenti suoi limiti. Trascorrere due giorni in una
struttura nuova, non ancora deturpata dal sovraffollamento, priva del tanfo che
caratterizza i corridoi dove sono collocate le celle e igienicamente ancora
intatta, non equivale certo a sperimentare effettivamente quali sono le reali
condizioni di detenzione. Né possono essere verificate sulla propria pelle le
carenze sanitarie, in caso di malattie ovvero l’effettivo accesso a corsi e
laboratori. Ma, come dire, meglio di niente. Crediamo che siano, invece,
indispensabili visite periodiche agli istituti di pena da parte di tutti gli
operatori della Giustizia, per comprendere davvero la reale situazione e il
dramma di una detenzione, nella maggior parte dei casi, fuorilegge. Non è
necessario fingere di essere detenuti, ben sapendo che in qualsiasi momento si
può chiedere di uscire. Una tale situazione assomiglia più ad un reality e,
forse, in alcuni casi, può appagare la voglia di sperimentare qualcosa di
diverso. Entrare in carcere, vedere, toccare con mano la quotidianità di un
istituto a regime. Aprire il blindato di una cella e vedere persone rinchiuse in
pochi metri quadrati a disposizione, in condizioni igieniche disastrose, muffa
alle pareti, a volte il water a vista o nascosto da una tendina, poca la luce
che entra.
Mortificarsi vedendo lo stato
di abbandono del reparto docce. Verificare che sono pochissimi quelli che
possono accedere al lavoro ovvero ad attività trattamentali. Mangiare il cibo
che proviene dalla cucina che, come nella casa
circondariale di Poggioreale, deve provvedere ad oltre duemila persone.
Ascoltare e verificare i molteplici drammi personali dovuti a immorali ritardi
nelle cure mediche. Informarsi sulle modalità d’intervento per urgenti cure
specialistiche. È questo che andrebbe fatto. Su queste pagine, il mese scorso,
il giudice Eduardo Savarese ha scritto che la visita delle carceri «andrebbe
prescritta come medicina socio-politica ineludibile almeno una volta all’anno a
beneficio di molte altre espressioni della classe dirigente cittadina, non solo
della magistratura, ovviamente coinvolta in maniera diretta nell’istituzione
penitenziaria». Siamo d’accordo. Risale al dicembre 2018, la visita (unica?)
della giunta dell’Associazione Nazionale Magistrati di Napoli alla casa
circondariale di Poggioreale, mentre iniziative analoghe in altre città non ci
risultano o, comunque, con certezza, si conteranno sulle dita di una mano. Del
resto, i magistrati di Sorveglianza che dovrebbero, per compiti del proprio
Ufficio, visitare continuamente gli istituti penitenziari, spesso non vi
accedono. Gli avvocati delle Camere Penali, da sempre, si recano in carcere con
visite periodiche e, con le loro relazioni, descrivono le reali condizioni di
vita dei detenuti.
C’è dunque da porsi una
domanda? Perché l’avvocatura mostra tale particolare sensibilità che, invece,
sembra del tutto estranea alla magistratura? Non vi è dubbio che una maggiore
conoscenza delle condizioni di detenzione aiuterebbe l’opinione pubblica a
comprendere che quel mondo non va considerato estraneo, ma è parte integrante
della società perché dovrebbe svolgere la funzione primaria di recupero del
condannato, proprio nell’interesse stesso della collettività. L’Unione Camere
Penali, alcuni anni fa, ideò il progetto “Carceri Porte Aperte”, dando la
possibilità ai cittadini interessati di visitare gli istituti di pena.
Pubblicato l’annuncio sui quotidiani, in poche ore fu raggiunto il numero chiuso
stabilito. A Napoli cinquanta persone ebbero la possibilità di entrare nella
casa circondariale di Poggioreale e rendersi conto dell’effettivo svolgersi
della vita detentiva. La trasparenza è il sale della democrazia e il carcere ne
ha un gran bisogno. Riccardo Polidoro
Le pene e le condizioni dei
detenuti. Dramma carceri, il problema? Il codice fascista.
Alberto Cisterna su Il
Riformista il 22 Settembre 2022
Sessanta suicidi dall’inizio
dell’anno. 60 morti tra le mura di un carcere. In gran parte giovani vite che
non sopportano la carcerazione, la convivenza forzata, le promiscuità, il caldo,
le prospettive della cella con i letti a castello. Il buio che avvolge
improvvisamente e repentinamente spegne la vita. Non si tratta di individuare
colpe e responsabilità. O meglio non si deve fare solo questo. La polemica è
scontata, l’indignazione inevitabile, ma poi la clessidra della morte torna a
scorrere e ingoia, come granelli di sabbia, esistenza dopo esistenza. Urgerebbe
una riflessione più ampia, una meditazione meno condizionata da posizioni
preconcette o polemiche faziose. È innegabile che una parte, tutt’altro che
marginale, della società è completamente indifferente a questo dramma. “Qualche
delinquente in meno” è l’impronunciabile che tanti recitano a mente o sibilano
complici, facendo finta di provare compassione. In fondo il carcere è stato
concepito per secoli come una sorta di pattumiera della società, il luogo degli
scarti e la sentina degli avanzi (non a caso di galera).
È quasi scontato non ci sia
vera pietà o vera compassione per chi è in cella e quindi anche per chi in cella
decide di togliersi della vita. In fondo, si sussurra velenosamente, se la sono
cercata. Così guadagna spazio e cerca legittimazione una sorta di terrificante
doppio binario sanzionatorio: il carcere per tutti e poi la morte per i fragili,
per quelli che sopprimono la propria esistenza perché non sopportano le mura e i
lori miasmi. Da dove partire, quindi. Da dove prendere le mosse per riannodare
le fila di un discorso sulla detenzione che si sfrangia in mille rivoli e perde
di vista la sostanza della questione. Non si deve solo depenalizzare, mitigare
le pene, contenere il carcere come luogo privilegiato della punizione,
sostituirlo con misure alternative, trasformare la detenzione
domiciliare (soprattutto per la carcerazione preventiva) come lo strumento
privilegiato della costrizione personale, certo con tutte le precauzioni del
caso (in primo luogo i cosiddetti braccialetti elettronici). Cose necessarie,
reclamate da decenni, sempre al centro del dibattito e sempre affossate dalle
folate giustizialiste che attraverso il paese cavalcando le vesti di questa o
quella forza di politica a caccia di facile consenso.
Il punto cruciale sta nel
fatto che la misurazione delle pene, per come concepita nel codice penale
fascista tuttora in vigore e alimentata dalle cicliche emergenze del paese –
il terrorismo interno, la mafia, il terrorismo internazionale, gli omicidi
stradali, lo stalking e via seguitando – prescinde dalla reale percezione di
quale sia la condizione dei detenuti nelle carceri del paese. Si guarda sempre e
soltanto alla pena dall’alto, la si contempla nella sua astratta capacità
dissuasiva, inibitoria, preventiva e la politica, impreparata e ignara, pensa
semplicisticamente che più alta sarà la sanzione comminata più speranze vi sono
che ci si astenga dal delinquere. Quasi che l’ubriaco alla guida, il picchiatore
delle risse, il compagno ossessivo – prima di commettere delitti efferati –
vadano a compulsare il codice penale per verificare quale pena gli tocchi. Una
società polverizzata dalle pulsioni mediatiche, sorvegliata dai social che
ciascuno adopera e in cui ciascuno si disvela all’altro, disarticolata
dall’affievolimento delle relazioni interpersonali, isolata dall’indifferenza
consumistica non risponde più agli strumenti della dissuasione punitiva o al
diritto penale totale (come lo definiva il compianto Filippo Sgubbi) inteso come
panacea per ogni devianza.
Per cui la cella, le
promiscuità, la società carceraria sono vissute, dai più, come un dramma
gigantesco, inaspettato, inatteso, impreparato. Per secoli le mura hanno recluso
i delinquenti e li hanno così tenuti separati da una società civile che poi era
non così diversa nelle sue condizioni di vita materiale tra un “dentro” e
un “fuori”. Tra la vita carceraria e le condizioni della stragrande maggioranza
delle classi di popolazione da cui provenivano i reclusi non vi era l’abisso di
questi tempi. È vero che anche oggi tanti sono extracomunitari, molti sono
soggetti dediti allo spaccio di droga e ai microreati, ma obiettivamente pochi
di costoro hanno condizioni di vita che possono anche solo avvicinarsi alla
detenzione in carcere di questi tempi. La modernità, il complessivo
miglioramento delle condizioni di vita hanno interrotto la linea di continuità
che rendeva almeno tollerabile la reclusione carceraria. Finita l’osmosi, le
carceri sono diventate il luogo della totale separazione, dell’irreversibile
interruzione tra il “dentro” e il “fuori” e così le vite implodono e si spezzano
spesso nelle coscienze, altre volte con la violenza dell’autodistruzione.
Alberto Cisterna
Un privilegio concesso a
pochi reclusi. Sbattiamoli in cella e facciamoli lavorare… magari: in carcere
solo il 13% dei detenuti lo fa.
Viviana Lanza su Il Riformista
il 22 Settembre 2022
Il lavoro nobilita l’uomo,
recita un antico proverbio. La mancanza di lavoro è tra le cause del degrado e
della criminalità, sostengono quelli che studiano le dinamiche sociali. Il
lavoro sarà la priorità, promettono i politici salvo poi non riuscire quasi mai
a mettere i pratica quello che dicono. L’Italia è una Repubblica fondata sul
lavoro, recita la nostra amata e a volte dimenticata Costituzione. Già, il
lavoro. Un tema centrale nella vota di ognuno. Anche di chi vive dietro le
sbarre, se è vero che è l’ago della bilancia negli equilibri della vita di ogni
cittadino. In Campania, regione con i più alti livelli di disoccupazione, sembra
quasi un’incongruenza parlare di lavoro per i detenuti, perché ci sono migliaia
di disoccupati nel mondo fuori dal carcere.
Ma questo non può essere
l’alibi per evitare di affrontare di petto uno dei nodi centrali del sistema
penitenziario, uno dei tanti nodi irrisolti che ingarbugliano la funzione
rieducativa della pena costituzionalmente prevista, mortificano i diritti di chi
vive dietro le sbarre, rendono un inferno i luoghi della pena. I dati sui
suicidi e sulle morti in cella hanno raggiunti cifre che urlano tutta la
violenza che c’è nel mondo penitenziario, tutta la drammaticità, tutto il
fallimento dell’intero sistema. Di carcere si è sempre parlato poco, perché non
è un tema che interessa alla politica, non fa avere voti, non incide sui
consenti populistici e popolari. Anzi, per decenni si è cavalcata l’onda del
populismo giustizialista e tutti a dire che bisognerebbe buttare la chiave,
salvo poi ritrovarsi con una società sempre più votata alla violenza, con tassi
di recidiva alti e un senso di insicurezza ancora più diffuso di prima.
Che vuol dire? Vuol dire che
la direzione deve essere un’altra, che bisogna rendere i luoghi della pena
luoghi di responsabilizzazione e reinserimento sociale in modo da ridare alla
pena la sua naturale funzione, quella di rieducare come dice
la Costituzione. Vuol dire tener presenti studi ed esempi europei secondo cui la
recidiva si abbassa nei casi di detenuti che hanno seguiti percorsi alterativi
alla reclusione finalizzata a sé stessa, che in carcere hanno avuto la
possibilità di studiare e di lavorare. Torniamo al lavoro. Che in carcere non
c’è. Che a volte non c’è nemmeno per quelli che potrebbero beneficiare di misure
alternative, figurarsi per chi è in cella e basta. «Eppure il lavoro in carcere
dovrebbe essere una parte fondamentale del percorso trattamentale e del processo
di risocializzazione delle persone detenute», ci ricorda Antigone, associazione
impegnata da anni nella tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e
penitenziario. «Eppure in carcere il lavoro è poco e nella maggior parte dei
casi dequalificato e con scarsa spendibilità all’esterno». Antigone ha visitato
diversi istituti di pena e raccolto dati relativi alla presenza di esperienze
lavorative nei percorsi di recupero dei detenuti. Il risultato è questo: in
media solo il 33% dei detenuti è impiegato alle dipendenze dell’amministrazione
penitenziaria e solo il 2,2% dei reclusi è in media impiegato alle dipendenze di
altri soggetti.
Questi numeri descrivono la
situazione all’inizio dell’anno. E sono numeri ancor più avvilenti quelli che
fanno riferimento alla realtà napoletana, e più in generale campana.
In Campania, infatti, queste percentuali scendono drasticamente fino ad arrivare
allo 0,3%. A Poggioreale, tanto per prendere come riferimento il più grande
carcere della città, della regione e per la verità dell’Italia intera, su una
popolazione di oltre duemila detenuti (si arriva a sfiorare e talvolta a
superare i duemiladuecento reclusi) è merso che lavorano solo in 280, cioè meno
del 13%. Antigone sottolinea che inoltre gli istituti scelgono di far lavorare i
detenuti solo per poche ore e per pochi giorni, così da offrire possibilità
lavorative a più persone possibile. «Ma questo – fanno notare – fa sì che lo
stipendio percepito sia molto ridotto e spesso basti solo a pagare i costi del
mantenimento».
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Detenuti votate, la libertà
è partecipazione: i giustizialisti se ne faranno una ragione.
Francesca Sabella su Il
Riformista il 16 Settembre 2022
Le sbarre di ferro
del carcere possono imprigionare il corpo, non devono fare lo stesso con la
mente, con le idee, con i diritti di chi ha sbagliato e sta scontando la sua
pena. L’Italia, infatti, fa parte di quei Paesi che non negano in modo assoluto
la possibilità di votare ai detenuti (come invece succede in Bulgaria e
nel Regno Unito), ma nella maggior parte dei casi tale diritto si considera
soltanto sospeso e questo avviene solo per alcune categorie di reclusi: per chi
è condannato all’ergastolo e per chi deve scontare una pena superiore a cinque
anni. Tutti gli altri, quindi, possono votare? La risposta è sì. E quindi…
detenuti votate! Votate! E votate! Sappiamo già che giustizialisti e forcaioli a
questo punto dell’articolo saranno già caduti dalla sedia, ma lo dice la legge,
non noi, che i detenuti possono e devono votare. È un diritto e un dovere
civico. Il carcere serve (o almeno dovrebbe servire, ma questa è un’altra
storia) a rieducare, a reinserire chi ha sbagliato nella società, ecco perché è
importante che anche loro contribuiscano a cambiare la società nella quale
ritorneranno a vivere.
«Andate a votare, esprimete la
vostra preferenza di voto, divenendo così cittadini attivi – afferma il garante
regionale dei detenuti Samuele Ciambriello – Sarebbe un errore madornale non
recarsi alle urne, il voto è un diritto e un dovere sacrosanto per tutti i
cittadini; è l’espressione massima della democrazia. Anche i detenuti,
chiaramente coloro su cui non pende un’interdizione dal diritto di voto, possono
e devono esercitare questo diritto/dovere». Ma per un recluso qual è l’iter da
seguire per poter votare? Il detenuto che desidera esprimere il suo voto deve
fare una istanza, considerata valida fino a tre giorni dalle elezioni, al
sindaco del suo Comune che, una volta appurato che il richiedente ha diritto al
voto, spedisce al carcere il certificato elettorale. A quel punto viene
instituito un “seggio speciale” all’interno del carcere. «Mi dispiace solo che
le procedure per accedere al voto negli Istituti di pena sono farraginose,
lunghe, complesse e che i detenuti siano poco informati sui loro diritti e non
sanno nulla rispetto alle modalità di come esercitarli – afferma Ciambriello – I
politici, pur avendo la possibilità di entrare in carcere per ispezione e
controlli, non lo fanno. Il vento che spira è assai preoccupante: il “populismo
penale” si coniuga con il “populismo politico” e così si evita di parlare di
carcere».
Ma le carceri esistono, esiste
l’inferno in terra ed è per questo che è importante che i detenuti chiedano di
poter votare. «L’invito ai detenuti è di esprimere la propria idea politica –
ribadisce Ciambriello – ai direttori degli istituti di pena di avviare una
giusta informazione sulle modalità di voto, così da preparare per tempo tutta la
documentazione necessaria per poter barrare un simbolo. Anche se privati della
libertà, i detenuti possono contribuire alla formazione del Parlamento. Devono
essere consapevoli del fatto che anche loro possono essere attori dei processi
di cambiamento e non semplici spettatori. Solo esercitando il diritto al voto,
però, possono essere protagonisti – conclude il garante –chi non lo fa, non
potrà proferire parole di lamentela sulle condizioni delle carceri e più in
generale del nostro Stato, perché decidere di non votare equivale ad ammettere
di non voler partecipare». E se guardiamo alle precedenti elezioni, i numeri non
sono per niente confortanti. Ecco perché è importante che si parli di politica
in carcere e ancor di più che la politica parli di carcere. Alle elezioni
Europee del 2019 l’affluenza è stata quasi pari allo zero. Hanno chiesto di
poter votare due detenuti del carcere di Aversa, uno del carcere
di Salerno, sette in quello di Secondigliano. Nel 2016, invece, in Campania
parteciparono alle elezioni Amministrative solo nove detenuti. Votate, perché
libertà è partecipazione. Anche se si vive ancora in pochi metri quadri
circondati da sbarre di ferro.
Francesca Sabella. Nata a
Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole ha deciso, non
senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro. Giornalista
pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi protagonisti.
La testimonianza. La mia
prima volta in un carcere, a incrociare sguardi che chiedono ascolto.
Sarah Brizzolara su
Il Riformista il 16 Settembre 2022
Ho visitato per la prima volta
un carcere nei giorni di ferragosto, come Consigliera Comunale di Monza. Qualche
giorno prima, a San Quirico, nel carcere della mia città, un detenuto di 24 anni
si era tolto la vita. Era in prigione dal 2018 e mancavano due anni al suo fine
pena. Era il terzo suicidio da inizio anno nella Casa circondariale di Monza e
la notizia aveva provocato una mezza rivolta di molti altri detenuti.
Ho visitato un luogo di
confine, di transito, dove arrivano e stanno tutti coloro che la nostra comunità
ha lasciato indietro. È uno specchio che riflette la società attuale, troppo
frenetica per creare legami, aiuti e reti di supporto verso il prossimo.
Indubbiamente il carcere di Monza, come tutte le altre carceri d’Italia, soffre
del problema del sovraffollamento. Oltre la metà dei detenuti sono stranieri, e
molti hanno enormi difficoltà culturali e linguistiche. Lo abbiamo visitato
tutto. Dai blocchi nuovi a quelli più vecchi, i cui muri hanno visto passare più
storie e più intrecci di vite. Sicuramente quello che colpisce sono le persone,
il loro vissuto. Non puoi fare a meno di riflettere sul perché non sei tu al
loro posto. E ti senti sicuramente privilegiato. Perché sai che alla fine tu
uscirai, e ad aspettarti ci sarà una casa con tutti i confort, che magari spesso
sottovaluti.
Parli con i detenuti. Ti
colpisce un ragazzo in particolare, della Repubblica Dominicana, che sta lì
nella sua cella seduto e ti fissa con degli occhi pieni di rabbia. C’è tanta
rabbia in carcere. Ma c’è anche tanta umanità. Parlando capisco che ha la mia
stessa età e dice di essere dentro perché ha tentato due volte di compiere un
omicidio. E lì ti chiedi quali strade hai percorso tu così diverse rispetto a
lui. E se magari potevi esserci tu al suo posto. Ci sono varie sezioni super
controllate. I lunghi corridoi vuoti che collegano le varie sezioni si chiamano
tangenziali. Ho parlato con la direttrice e il capo degli agenti penitenziari.
Ci hanno sottolineato tutti i problemi legati alla salute mentale che hanno i
detenuti e le difficoltà e la carenza di personale per poter realizzare per loro
delle terapie serie e con una prospettiva di lungo periodo. Il reparto
psichiatrico è forse quello più emotivamente denso. Poche celle, singole,
piccole e spoglie. Con persone dagli sguardi persi. Alcuni carcerati a un certo
punto ci hanno con gentilezza fatto capire che era il momento per la loro
partita a calcetto settimanale. Un momento magico.
A Monza alcuni detenuti
possono partecipare a laboratori per imparare diversi lavori per reinserirsi un
domani. Hanno un orto, possono lavorare con diverse aziende esterne per
assemblare cartellette per la scuola e bulloni, lavorare i tessuti,
scannerizzare gli Archivi storici della Cassazione di Milano e lavorare il legno
per creare arredi in collaborazione con il Politecnico di Milano. Riguarda
ancora troppo pochi, ma è una strada, fondamentale, importante. Raccontare il
carcere solo come un luogo di pazzi e di rivoltosi non aiuta a far entrare le
aziende in questa realtà, ma credo che il Comune possa e debba implementare le
reti con le aziende, contribuire a rilanciare progetti per rilanciare la serra e
la sala della musica. E allora emergono gli sguardi. Sguardi di detenuti che
hanno una prospettiva. Che vedono un orizzonte oltre i loro sbagli, quelle mura.
Che vivono nelle celle più nuove nell’area dell’ex carcere femminile che è stato
finito di ristrutturare a fine luglio. Sguardi. Sguardi di una speranza che
chiama il nostro impegno.
E la necessità di far
conoscere e far capire che se un detenuto in carcere riceve un trattamento umano
e positivo, esce migliore; che ci sussurra che la paura crea solo odio e che
quest’ultimo alimenta la contrapposizione; quella coscienza che ci sussurra che
il diverso siamo noi e che il carcere è solo il modo per lavarci quella stessa
coscienza nel momento in cui non è alimentata dalla conoscenza. È molto facile
l’appiattimento di tutto verso il basso, è facile dire che un delinquente deve
andare in carcere e rimanerci, è facile schiacciare ancora più in basso chi
striscia per terra. Di contro è facile anche scadere nel buonismo a prescindere,
ci si sente redenti e fiduciosi del prossimo, unici. E quindi è anche facile e
comodo mettere etichette e categorie, ci semplifica la vita, ci aiuta a mettere
ordine nel nostro ragionamento. Ma non si può fare per gli esseri umani. Per gli
esseri umani bisogna provare ad andare oltre, dare ad ognuno la possibilità di
divenire, di essere diverso, di cambiare. Sarah Brizzolara
L'iniziativa dei penalisti. Codice
ristretto, arriva il vademecum per i detenuti: la guida per comprendere regole e
agevolazioni. Viviana Lanza su Il Riformista il 27
Settembre 2022.
Avrebbe potuto pensarci l’amministrazione, invece
lo hanno fatto gli avvocati, con il contributo dei garanti. Poi lo Stato si è
accodato. Meglio di niente, si dirà. Sta di fatto che adesso il “Codice
ristretto” c’è. È un opuscolo per i detenuti, soprattutto per quelli più soli e
più deboli, quelli che hanno meno possibilità di essere informati pur avendo il
diritto di esserlo come gli altri. “Codice ristretto” è dunque un vademecum,
fornisce informazioni sulle norme che regolano i percorsi di risocializzazione.
Si tratta di una rapida guida che serve anche a
non ingolfare la Sorveglianza di fascicoli destinati ad essere definiti con
provvedimento di inammissibilità, perché indica al detenuto tutta una serie di
informazioni per renderlo consapevole dei suoi obblighi e dei suoi diritti, di
ciò che può richiedere e di quello che non può essergli concesso in base alla
pena che sta scontando: parliamo di liberazione anticipata, lavoro esterno,
permessi ordinari e quelli speciali, affidamento in prova ai servizi
sociali o affidamento di tossicodipendenti, detenzione domiciliare, semilibertà.
Uno strumento di informazione, quindi, che diventa per il detenuto un modo per
acquisire maggiore consapevolezza di sé e della realtà, quella penitenziaria, in
cui si trova ad essere nel momento in cui varca la soglia di un carcere. Uno
strumento utile soprattutto a quei detenuti più soli, più deboli, quelli che non
possono permettersi la guida costante di un avvocato, quelli che non hanno
famiglia o non hanno una famiglia che li affianca e li aiuta nel percorso
detentivo e rieducativo.
Quelli, insomma, che pur avendo una condanna da
scontare potrebbero avere accesso a dei benefici ma non ne chiedono perché non
hanno tutte le informazioni necessarie per avanzare richieste in tal senso.
Inoltre, il “Codice ristretto” può rivelarsi un vademecum utile anche per chi
opera all’interno di un istituto di pena, quindi per gli operatori della
giustizia che intendono conoscere e confrontarsi con i diritti e con le
preclusioni previsti dalle norme che regolano l’esecuzione della pena. Sabato
il “Codice ristretto” realizzato per gli istituti penitenziari della Campania (e
già in parte distribuito) è stato presentato a Santa Maria Capua Vetere, nella
sala convegni del Palazzo San Carlo, alla presenza del presidente del Tribunale
sammaritano Gabriella Maria Casella, del procuratore della Repubblica Carmine
Renzulli, del magistrato di sorveglianza Marco Puglia, dell’avvocato Riccardo
Polidoro, responsabile nazionale dell’Osservatorio Carcere dell’Unione camere
penali italiane, del garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello.
Il “Codice ristretto” nasce da un’iniziativa della
Camera penale di Bologna con il patrocinio dell’Osservatorio Carcere delle
Camere penali. «Valutato il pregio dell’opera – ha sottolineato
l’avvocato Polidoro -l’Osservatorio carcere ne ha proposto la diffusione a tuti
i presidenti delle Camere penali territoriali. La suddivisione in tre tabelle
(una per i detenuti ordinari, una seconda per quelli condannati per delitti
inseriti nell’articolo 4bis e una terza per i casi speciali) consente, con
l’incrocio dei dati, di comprendere immediatamente se vi sono le condizioni per
l’applicazione di una misura alternativa». «Ho accolto con entusiasmo la
proposta dell’Osservatorio Carcere di diffondere in Campania il “Codice
ristretto” – ha spiegato il garante Ciambriello -. Questo testo è uno strumento
per fornire informazioni comprensibili e immediate. Non vuole sostituite la
consultazione delle norme di legge ma esclusivamente agevolare la comprensione
del possibile accesso ai benefici. Il supporto del difensore – ha concluso –
rimane un riferimento fondamentale e irrinunciabile per la piena tutela dei
propri diritti».
Viviana Lanza. Napoletana, laureata in Economia e
con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal
2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca
nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli
per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie
di stampa (TMNews, Askanews).
L'iniziativa. Codice Ristretto, una guida
per chi vive in cella. Viviana Lanza su Il Riformista
il 14 Aprile 2022
Conoscere è sempre il primo passo. Anche per chi
entra in carcere. Aiuta a capire, ad avere consapevolezza, a orientarsi. Per
questo il Codice Ristretto, promosso dal garante dei detenuti della Campania, «è
un’opera importantissima destinata ai detenuti campani, che può snellire il
lavoro di molti: delle direzioni delle carceri, della magistratura di
Sorveglianza, degli avvocati», ha spiegato lo stesso garante Samuele
Ciambriello presentando l’opuscolo nella sala Nassirya della sede del Consiglio
Regionale della Campania. Il Codice Ristretto contiene informazioni utili sui
diritti dei detenuti e sulle modalità con cui tali diritti possono essere
esercitati, fornendo consigli pratici sulla vita durante la detenzione.
L’opuscolo è stato realizzato anche in
collaborazione con il Provveditorato campano dell’amministrazione penitenziaria,
l’Osservatorio carcere dell’Unione delle Camere Penali italiane e la Camera
Penale di Bologna. «Il detenuto – ha aggiunto Ciambriello – leggendo queste
poche tabelle è già in grado di comprendere se possiede i requisiti necessari
per avanzare richieste di misura alternativa. Non è cosa da poco, specie se si
considerano i numeri, in Italia e in Campania, di tutti i soggetti condannati in
maniera definitiva». Il presidente del Consiglio regionale della
Campania, Gennaro Oliviero, ne ha sottolineato l’utilità, la direttrice del
provveditorato regionale Assunta Borzacchiello, ha aggiunto: «L’opuscolo è
intuitivo, valido e un ottimo strumento per agevolare non solo i detenuti ma
anche gli operatori». «L’opuscolo è composto da tabelle grazie alle quali il
detenuto comprende le informazioni essenziali per l’espiazione della sua pena –
ha sottolineato l’avvocato Riccardo Polidoro, responsabile dell’Osservatorio
carcere Unione Camere Penali italiane – La Campania è stata la prima regione, ma
sono state già sollecitate altre Camere penali, affinchè si possa ultimare
presto questo lavoro eccellente anche altrove».
Viviana Lanza. Napoletana, laureata in Economia e
con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal
2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca
nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli
per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie
di stampa (TMNews, Askanews).
La Procura di Taranto
chiede il processo per la Baldassari ex direttore del carcere di Taranto.
Redazione CdG 1947
su Il Corriere del Giorno il 16 Settembre 2022
La Procura di Taranto aveva
chiesto l'archiviazione per le accuse della Papa alla Baldassari, ma il gip
Francesco Maccagnano ha disposto l’imputazione coatta, ed adesso l' ex
direttrice del carcere di Taranto dovrà rispondere anche delle accuse di
ripetuti maltrattamenti elencati nella richiesta di rinvio a giudizio formulata
dal pm Vittoria Petronella, nei confronti della funzionaria Vincenza Papa in
servizio nel carcere di Taranto
Si terrà il prossimo 26
ottobre l’udienza preliminare dinnanzi al Gip Giovanni Caroli del Tribunale di
Taranto nei confronti dell’ormai ex-direttore del carcere di Taranto Stefania
Baldassari, che è anche indagata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce
per altre vicende giudiziarie inerenti ad un presunto voto di scambio avvenuto
in occasione delle elezioni amministrative del 2017 quando la Baldassari si
candidò a sindaco di Taranto, con il clan del noto pregiudicato Michele Cicala,
accuse per le quali è stata sospesa sine die dal servizio dal suo ruolo dal DAP
il dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria del Ministero di Giustizia.
L ’inchiesta della Direzione
distrettuale Antimafia di Lecce nei confronti di Stefania Baldassari, ex
direttrice del carcere di Taranto verte sulle accuse per aver chiesto e
ottenuto, secondo gli inquirenti, voti da alcuni ex detenuti durante la campagna
elettorale per le amministrative 2017 che la vedeva candidata sindaco del
capoluogo ionico. I militari della Guardia di finanza nei giorni scorsi si erano
recati presso la casa circondariale di Taranto per sequestrare numerosi
documenti che riguarderebbero proprio gli anni della direzione
della Baldassari.
Documenti che adesso dovranno
essere verificati dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria della Guardia di Finanza, guidato dal colonnello Valerio
Bovenga sotto il coordinamento del sostituto procuratore della Dda di
Lecce Stefano Milto De Nozza . Appare chiaro che gli inquirenti vogliano
verificare tutti gli atti compiuti dalla Baldassari nel suo incarico al vertice
del penitenziario ionico.
La Procura di Taranto aveva
chiesto l’archiviazione per le accuse della Papa alla Baldassari, ma il
gip Francesco Maccagnano ha disposto l’imputazione coatta, ed adesso l’ ex
direttrice del carcere di Taranto dovrà rispondere anche delle accuse di
ripetuti maltrattamenti elencati nella richiesta di rinvio a giudizio formulata
dal pm Vittoria Petronella, nei confronti della funzionaria Vincenza Papa in
servizio nel carcere di Taranto, nei cui confronti incurante del suo stato di
salute in quanto invalida al 75% per sclerosi multipla, le urlava continuamente
“Se devi stare malata con quella faccia malata stattene a casa“, “Non capisci
niente ! Smettila di fare la malata, tanto si vede che è finta la tua malattia“,
“Sapete i cessi dove si trovano nei lunghi corridoi ? Di solito in fondo a
destra. Beh lì si trova l’ufficio della dottoressa Papa” con “rifiuti e
richieste della Papa di usufruire di ore di riposo compensativo” umiliandola al
punto tale che la Papa si vedeva costretta a richiedere il distacco lavorativo
presso il carcere di Bari “pur distante dalla propria dimora in Taranto e
nonostante il suo stato di salute, già compromesso“. Redazione CdG 1947
Detenuto morto a Regina
Coeli: nel mirino della Procura la mancata sorveglianza.
Ilaria Sacchettoni su Il
Corriere della Sera il 29 Settembre 2022
L’ipotesi di una negligenza.
Arrestato all’inizio dell’estate per rapina e tentato omicidio Carmine Garofalo
era a Regina Coeli in attesa di giudizio. É morto il 16 agosto scorso
Il sospetto di omicidio e
l’ipotesi di una sorveglianza lacunosa. Nell’attesa che il medico legale de «La
Sapienza» depositi il risultato degli esami sul corpo di Carmine Garofalo, il
detenuto fragile trovato morto il 16 agosto scorso nella sua cella a Regina
Coeli, il pm Edoardo De Santis ragiona sulle poche certezze acquisite. Una di
queste sarebbe la negligenza dei piantoni disposti dalla direzione carceraria e
anche se, al momento, nel fascicolo non sono ipotizzate vere e proprie omissioni
la Procura vuole rispondere a un basilare interrogativo: perché nessuno,
all’interno della settima sezione, intercettò tempestivamente il suo malore?
Due detenuti che avrebbero
assistito alla scena (e che si sono rivolti alla garante capitolina dei diritti
dei detenuti, Gabriella Stramaccioni, dalla quale è partita l’inchiesta)
sostengono che si sia trattato di un omicidio. Garofalo, dicono, sarebbe stato
stretto alla gola con un avambraccio e poi, una volta soffocato, abbandonato sul
pavimento della sua cella. La vita non è stata generosa con Carmine Garofalo, 49
anni, avviato sul piano inclinato di un’esistenza precaria. Arrestato all’inizio
dell’estate per rapina e tentato omicidio — coltello in pugno aveva cercato di
rubare il camper di un tipo salvo colpirlo quando questi aveva tentato di
fermarlo — era a Regina Coeli in attesa di giudizio. Nel frattempo, oltre a una
serie di risse e devastazioni, aveva tentato il suicidio e dal 2 agosto scorso
era piantonato a vista come soggetto fragile.
Un’ulteriore possibilità,
tutta da esplorare, è che il decesso di Garofalo sia dovuto a stupefacente,
teoricamente (ma solo in linea di principio) proibito. Da qui la perizia
tossicologica disposta dal pm. Questo aprirebbe un altro scenario. Chi e con
quali complicità avrebbe introdotto la sostanza nel perimetro carcerario?
La Procura ha disposto un
nuovo sequestro del corpo in modo da poter effettuare tutti gli accertamenti del
caso. Una misura che ha impedito la cremazione inizialmente richiesta dai
familiari fra cui il figlio Samuel Garofalo, attore nella serie «Le fate
ignoranti». Nei giorni scorsi il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
(Dap) ha eseguito un’ispezione all’interno della sezione nella quale Garofalo
era detenuto. Ispezione che potrebbe raccontare i dettagli di quanto avvenuto e
isolare alcune responsabilità all’interno del carcere. I risultati potrebbero
essere acquisiti agli atti delle indagini.
Estratto dell'articolo di Michela Allegri per "il
Messaggero" il 28 settembre 2022.
Lo hanno trovato steso in terra, nella sua cella
di Regina Coeli, la numero 24, in pieno pomeriggio. Carmine Garofalo, 49 anni,
detenuto per tentato omicidio e tentata rapina, è morto il 16 agosto scorso,
mentre era appoggiato alle sbarre in attesa di un caffè. Un decesso che il
carcere ha catalogato come legato a cause naturali, ma sul quale ora indaga la
Procura di Roma, dopo la segnalazione della Garante dei detenuti del
Campidoglio, Gabriella Stramaccioni: Garofalo sarebbe stato ucciso, preso alle
spalle e soffocato, forse dal compagno di cella.
LA DENUNCIA
A raccontarlo sono stati altri due detenuti, che
hanno detto di avere assistito alla scena. Hanno spiegato che nell'ultimo
periodo a Garofalo era stato cambiato compagno di reclusione: secondo la loro
versione, il secondo letto della cella sarebbe stato occupato da un uomo
pericoloso, con problemi psichiatrici e che aveva tentato di uccidere il suo
precedente compagno di cella. Lo hanno sentito urlare diverse volte, hanno detto
di avere assistito a scontri e liti.
[…] A distanza di una decina di giorni, la
segnalazione dei detenuti: Garofalo sarebbe stato afferrato da dietro, la
persona che era insieme a lui gli avrebbe stretto un braccio intorno al collo
fino a farlo soffocare. I vicini di cella avrebbero anche detto che, all'arrivo
degli agenti penitenziari il compagno di reclusione di Garofalo si sarebbe
infilato a letto facendo finta di dormire.
Poco prima sarebbe anche stato visto pulire in
terra con uno straccio.
Alla Garante è stato detto che la versione
ufficiale fornita parla di una caduta accidentale, a causa della quale Garofalo
avrebbe sbattuto la testa a terra. Subito dopo i fatti, alcuni detenuti
avrebbero iniziato a battere le inferriate gridando: «Assassini». […]
Estratto dell'articolo da "il Messaggero" il 28
settembre 2022.
Ci sono sei segnalazioni sul comportamento
carcerario di Carmine Garofalo che ora potrebbero finire agli atti del fascicolo
aperto dalla Procura. Rapporti interni della casa circondariale di Regina Coeli
che parlano di atti di protesta, gesti di autolesionismo e, soprattutto, liti e
risse con il compagno di cella. Lo stesso compagno di cella che, secondo le
dichiarazioni choc di altri due detenuti, potrebbe averlo soffocato e che, tempo
prima, avrebbe cercato di uccidere il precedente vicino di letto.
I DUBBI
[...] Una morte che è stata inizialmente
dichiarata accidentale, ma sulla quale i vicini di cella sembrano non avere
dubbi: «È stato ucciso, il compagno di stanza faceva finta di dormire quando
sono arrivati gli agenti», avrebbero raccontato. Ma c'è anche un altro dettaglio
che ha attirato l'attenzione: il compagno di cella di Garofalo - sempre a dire
degli altri reclusi - era pericoloso: aveva problemi psichiatrici e qualche
tempo prima avrebbe aggredito il suo precedente vicino. Garofalo, trovato morto
sul pavimento della sua stanza il 16 agosto scorso, in pieno pomeriggio, si
sarebbe lamentato più volte.
IL RACCONTO
«Lo sentivamo urlare», avrebbero raccontato i due
detenuti che hanno anche detto di avere praticamente assistito al suo omicidio.
Sarebbe stato afferrato alle spalle e soffocato. Un caso su cui ora sta
indagando la Procura di Roma.
Ci sono sei segnalazioni su cui gli inquirenti
dovranno fare chiarezza. Vanno dagli ultimi giorni di luglio fino a poco prima
del presunto omicidio. Il primo rapporto parla di atti di autolesionismo:
Garofalo si sarebbe procurato escoriazioni e ferite alla fronte, forse come atto
di protesta. Circostanza che aveva portato il medico di guardia a disporre a suo
carico il regime di grandissima sorveglianza.
LA RISSA
Il giorno seguente, il cinquantenne aveva litigato
con un altro detenuto per motivi legati alla convivenza forzata. […] . Qualche
giorno dopo, il cinquantenne avrebbe cercato di impiccarsi utilizzando una
maglia. Da quel momento per lui era stato disposto il regime di sorveglianza a
vista. Passati circa dieci giorni, per due volte, il detenuto aveva distrutto il
suo materasso, gettando i pezzi nel corridoio della sezione.
L'ultimo rapporto parla di una nuova rissa
all'interno della cella, sempre per problemi di convivenza. […]
Estratto dell'articolo di
Michela Allegri per “il Messaggero” il 29 settembre 2022.
Gli addii social, dai quali
traspare tutto l'amore di un figlio e l'affetto, misto alla rabbia, della
moglie. Sulla sua pagina Instagram, il giorno dopo la morte di Carmine Garofalo,
deceduto nel carcere di Regina Coeli il 16 agosto scorso mentre era nella sua
cella insieme a un compagno forse violento - che dopo i fatti non è stato
trasferito di sezione - il figlio Samuel ha pubblicato una fotografia e un
messaggio: «Ciao papà, ti voglio ricordare così, felice e spensierato,
proteggici sempre».
Samuel è un volto noto: attore
in film e serie televisive. Ha esordito al cinema nel 2012 in Anni felici di
Daniele Luchetti, ed è uno dei protagonisti della serie Le fate ignoranti,
diretta da Ferzan Ozpetek, reboot dell'omonimo film del 2001. […]
IL RAPPORTO
[...] Il rapporto
dell'istituto penitenziario parla di «decesso per cause naturali», circostanza
che sembrava confermata dal primo esame effettuato dal medico legale. Dopo le
dichiarazioni choc di altri due detenuti, che hanno detto di avere visto
Garofalo afferrato alle spalle e poi soffocato dal compagno di stanza, però, la
Procura di Roma ha disposto nuovi accertamenti autoptici. Il pm Edoardo De
Santis indaga per omicidio e ha incaricato un pool di esperti di effettuare
rilievi.
[…] I detenuti non sono ancora
stati ascoltati in Procura: il magistrato attende i risultati dell'autopsia, per
decidere come procedere.
L'ARRESTO
[…] Dal 21 luglio fino al
giorno del decesso, risultano sei segnalazioni a carico di Garofalo: atti di
autolesionismo, gesti di protesta e, soprattutto, liti e risse «per motivi di
convivenza forzata» con il compagno di cella che, sempre secondo i due detenuti,
aveva problemi psichici e in passato aveva aggredito il precedente vicino di
letto. L'ultimo litigio, tre giorni prima della morte, il 13 agosto. Dal 2
agosto, inoltre, dopo un tentativo di impiccagione, Garofalo era stato
sottoposto al regime di sorveglianza a vista.
Nonostante questo, a parte i
due compagni di sezione, al momento del decesso sembra non fosse presente
nessuno. I detenuti hanno raccontato che il compagno di cella di Carmine è stato
visto pulire il pavimento subito dopo e poi infilarsi a letto facendo finta di
dormire. Il corpo di Garofalo è arrivato all'obitorio del policlinico Umberto I
il 17 agosto: il motivo della morte è stato attribuito a un ictus. […]
Arrestati agenti
penitenziari a Reggio Calabria responsabili di torture a un detenuto.
Redazione
CdG 1947 su Il Corriere del Giorno il 28 Novembre 2022
Le indagini avviate
dopo la denuncia dei familiari. Lo hanno lasciato seminudo per ore e lo hanno
poi pestato con manganelli, calci e pugni: 8 i poliziotti coinvolti.
Avrebbero fatto
spogliare un detenuto lasciandolo seminudo per due ore in una cella per poi
colpirlo ripetutamente con i manganelli in dotazione e con pugni. E’ quanto si
legge nell’ordinanza di applicazione di misure cautelari del Gip Valerio
Trovato, eseguita dalla polizia, su delega del dell’aggiunto Giuseppe Lombardo,
e del sostituto procuratore Sara Perazzan della Procura di Reggio Calabria
guidata dal procuratore capo Giovanni Bombardieri , nei confronti di 8
appartenenti alla Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
“G. Panzera” di Reggio Calabria a cui sono stati contestati i reati di tortura e
lesioni personali aggravate. I fatti contestati agli indagati risalgono al 22
gennaio 2022 e vedono come parte offesa un solo detenuto campano Alessio Peluso,
30 anni, considerato un esponente di spicco della camorra, rifiutandosi di far
rientro nella cella dopo aver usufruito del previsto passeggio esterno.
Secondo la
ricostruzione operata contenuta negli atti giudiziarie, per coprire tali
condotte, Stefano Lacava Comandante del Reparto per mettersi al riparo da
conseguenze avrebbe poi redatto per una eventuale denuncia da parte del
detenuto, una serie di relazioni di servizio, comunicazioni di notizie di reato
ed informative al Direttore del carcere, in relazione alle quali gli sono state
contestati i delitti di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto
pubblico, di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico
per induzione, di omissione d’atti d’ufficio e di calunnia.
Nei giorni
successivi, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lo stesso ufficiale
avrebbe tentato di costringere, illegittimamente, un suo sottoposto a mostrargli
delle relazioni di servizio relative alla sorveglianza dello stesso detenuto, e
per tale motivo è stata formulata a suo carico anche l’ipotesi di tentata
concussione.
Le indagini condotte
dalla Squadra Mobile reggina, diretta da Alfonso Iadevaia. su delega dalla
Procura di Reggio Calabria, sono state avviate a seguito della denuncia
depositata dai familiari di alcuni detenuti, tutti di origine campana, a cui le
persone recluse, nel corso di colloqui telefonici, avevano riferito di essere
stati malmenati all’interno del carcere. I successivi approfondimenti
investigativi, anche attraverso l’escussione dei reclusi da parte del pm
titolare delle indagini, hanno permesso già in una prima fase di circoscrivere
ad un solo detenuto le condotte violente, così come poi confermato dalla visione
e analisi delle telecamere interne alla casa circondariale.
“Va segnalato che le
gravi condotte contestate sono ascrivibili alla responsabilità personale solo di
alcuni appartenenti alla Polizia Penitenziaria, – evidenzia la Questura di
Reggio Calabria in una nota – che presta servizio all’interno della struttura
penitenziaria in questione con abnegazione, sacrificio e senso del dovere, e con
pieno rispetto dei diritti e della dignità dei detenuti ivi ristretti“.
I nomi
Sei gli indagati
colpiti dalla misura degli arresti domiciliari: il comandante della
Penitenziaria, Stefano Lacava (classe 1974, nato a Firenze e residente a Reggio
Calabria); Fabio Morale (1977, Messina); Domenico Cuzzola (1977, Reggio
Calabria); Pietro Luciano Giordano (1967, Villa San Giovanni); Placido
Giordano (1971, Taurianova); Alessandro Sgrò (1983, Sant’Agata MilItello).
Due gli indagati
sospesi dall’esercizio di un pubblico ufficio: Alessandro Guglietta (1969,
Sant’Agata Miltello Messina) e Carmelo Vazzana (1970, Reggio Calabria).
Diversa, e più
attenuata, la posizione di altri sei indagati, che il Gip di Reggio Calabria si
è riservata la decisione all’esito dell’interrogatorio: Stefano Munafò (1988,
Villa San Giovanni), Angelo Longo (1981, Barcellona Pozzo di Gotto), Diego
Ielo (1965, Reggio Calabria), Antonio Biondo (1976, Melito Porto Salvo), e il
medico Sandro Parisi (1959, Reggio Calabria), Vincenzo Catalano (1969, Reggio
Calabria) ed Egidio Vincenzo Catalano (1969 Reggio Calabria). Redazione CdG 1947
Giuseppe Legato e
Lodovico Poletto per “La Stampa” il 23 novembre 2022.
L'infortunio sul
luogo di lavoro era falso. E quel braccio rotto non era altro che la conseguenza
delle botte che gli avevano dato gli agenti. Tante. Senza pietà. Eppure agli
atti del carcere quelle ferite al detenuto erano classificate come un semplice
infortunio. Perché così nessuno faceva domande. Anche se, in realtà, tutti, o
quasi, sapevano e tacevano.
Carcere di Ivrea:
240 reclusi in uno spazio che ne potrebbe contenere a malapena 200. Parte da
questo episodio l’ultima inchiesta che squarcia il velo su ciò che accade in
quel cubo di cemento e acciaio alla periferia della città. Indagine corposa,
partita in estate e arrivata ieri ad una svolta. Con perquisizioni nel cuore
della notte. Computer sequestrati. Agenti prelevati da casa e accompagnati al
penitenziario ad aprire gli armadietti: frugati anche quelli.
Quarantacinque gli
indagati. Sono agenti di custodia, il loro comandante, tre educatori, alcuni
medici, il direttore della struttura e il suo predecessore. Per i primi le
accuse sono gravissime. La prima è tortura. Ma ci sono anche le violenze,
fisiche e psicologiche. Ciò che fino ad oggi - e nelle cinque inchieste
precedenti - non era mai stato contestato. I reati più abbietti. Nei confronti
degli altri indagati, invece, le accuse sarebbero di carattere omissivo:
sapevano e avrebbero taciuto. Oppure non avrebbero scritto nei documenti
ufficiali tutta la verità. Come, appunto, accaduto nella storia del braccio
spezzato al detenuto.
Teatro delle
violenze due locali di quel carcere già ampiamente citati nelle precedenti
indagini: la «cella liscia» e l’«acquario». Dove - e qui vale la pena citare le
parole del procuratore capo di Ivrea, Gabriella Viglione - «i detenuti venivano
picchiati e rinchiusi in isolamento senza poter avere contatti con alcuno,
nemmeno con i loro difensori». Ecco le torture. Le violenze psicologiche.
Quindici i casi
ricostruiti dagli inquirenti, tutti nell’ultimo biennio. Ma quelli più recenti
risalgono all’ultima settimana di luglio e alle prime due di agosto. Vale a dire
proprio nei giorni in cui la Procura generale di Torino raggruppava i fascicoli
di precedenti indagini. Riprendeva i fili di storie vecchie e fascicoli
archiviati e abbozzava un quadro di quel penitenziario tutt’altro che idilliaco.
Ecco, mentre il Pg Francesco Saluzzo e il sostituto Gian Carlo Avenati Bassi
esaminavano le carte, a Ivrea la pm Valentina Bossi lavorava già su altro.
In quel mare di
carte ancora tutte segrete ci sono anche quelle che raccontano del «trattamento»
riservato al detenuto Vincenzo Calcagnile finito a Ivrea a scontare un «cumulo
pene» lo scorso mese di luglio, e trasferito d’urgenza a Lecce a fine agosto
dopo aver perso 18 chili. Durante la detenzione quell’uomo di 37 anni aveva
anche cercato di suicidarsi. Il giorno in cui La Stampa pubblicò la coraggiosa
denuncia della madre, fu interrogato nel penitenziario salentino da due
ispettori. A loro disse: «Non abbiatene a male, ma parlerò solo davanti a un
magistrato».
E cosi la dottoressa
Bossi lo ha fatto salire su un aereo. Interrogatorio: «Sono entrati in cinque
nella mia cella, mi hanno costretto a bere tranquillanti in dosi massicce, molto
superiori a quelle che dovevo assumere per una blanda terapia che mi era stata
prescritta». Parlò a lungo delle botte. E sui presunti aggressori disse: «I nomi
non li so, ma se mi fate vedere le foto sono in grado di riconoscerli». Da lì è
partita l’indagine. Da lì si è iniziato a parlare di torture. Di silenzi
complici. A tanti, troppi livelli.
Tra di loro anche
alcuni medici. Botte e torture ai detenuti del carcere di Ivrea: nuova inchiesta
sulla polizia penitenziaria, 45 indagati.
Redazione su Il
Riformista il 22 Novembre 2022
Sono 45 gli
indagati tra appartenenti alla polizia
penitenziaria, medici, funzionari e direttori pro-tempore del carcere
di Ivrea nell’ambito di una nuova inchiesta, coordinata dalla procura, in merito
ai pestaggi subiti dai detenuti della casa circondariale. I reati ipotizzati
sono quelli di tortura con violenze fisiche e psichiche nei confronti di
numerosi detenuti, falso in atto pubblico e reati collegati. Nella notte
personale della polizia penitenziaria, dei carabinieri e della guardia di
finanza, su disposizione della Procura di Ivrea, ha eseguito 36 perquisizioni,
all’interno del carcere e nelle abitazioni degli indagati.
La nuova indagine,
che segue quella della Procura Generale riferita a fatti del 2015, riguarda
diversi episodi dell’ultimo biennio, fino all’estate 2022. Le indagini hanno
permesso di raccogliere numerosi elementi a conferma delle denunce presentate
nel corso degli anni, anche in merito all’esistenza di una “cella liscia” e di
una cella “acquario”, all’interno delle quali i detenuti venivano picchiati e
rinchiusi in isolamento senza poter avere contatti nemmeno con i legali. “I
reati risultavano tuttora in corso, situazione che ha reso inevitabile
l’intervento degli inquirenti“, fanno sapere dalla procura di Ivrea.
Nel frattempo, in
concomitanza con la notizia della perquisizione, è arrivata puntuale la denuncia
del sindacato Sinappe, che ha dichiarato di un’aggressione ai danni del
personale della polizia penitenziaria da parte di un detenuto. L’agente sarebbe
stato colpito con calci, pugni e sputi, tanto da essere costretto a ricorrere
alle cure del pronto soccorso. “Come se ciò non bastasse, il detenuto ha
continuato a danneggiare i beni dell’amministrazione – ha segnalato Raffaele
Tuttolomondo, segretario regionale del Sinappe – la situazione delle carceri è
disastrosa. Abbiamo informato il sottosegretario alla giustizia, Andrea
Delmastro, da sempre dalla parte dei poliziotti, con l’auspicio che il nuovo
Governo presti attenzione quanto prima alle condizioni in cui i nostri colleghi
sono costretti a lavorare“.
Andrea Bucci e Irene Famà
per “la Stampa” il 23 settembre 2022.
Il carcere è pensato per
scontare una pena, non per espiare i peccati come se fosse un girone
dell'inferno. E Taufic, che stava scontando la sua condanna nel penitenziario di
Ivrea, voleva solo poter sentire i propri familiari, i suoi figli e la moglie.
«Vorrei fare una chiamata, ma non è possibile». Ha fatto richiesta agli agenti
di custodia, ma «ho preso calci e schiaffi. Ho domandato di poter fare una
telefonata e per punizione sono finito in isolamento per dieci giorni». E no,
«non è successo solo a me. È capitato a tanti altri. Hanno preso botte gratuite,
io li ho visti».
Taufic, nel 2016, raccontava
tutto questo alla garante dei detenuti di Ivrea e all'associazione Antigone.
Come lui, Gerardo che è finito con «uno zigomo tumefatto e un labbro rotto». E
ancora Hamed: «Mi hanno immobilizzato e trasportato di peso». Hanno denunciato
le violenze. Hanno parlato per sé e per gli altri che non trovavano il coraggio
di farsi avanti. Perché il timore era più o meno questo: se ne ho prese così
tante per aver chiesto di fare una telefonata, chissà succede se denuncio. E
ancora. Chi potrebbe credere a dei malviventi? A chi ha rubato, rapinato, magari
ucciso?
Lo ha fatto l'associazione
Antigone, che quelle denunce, su fatti tra il 2015 e il 2016, le ha portate in
procura. Dopo una rivolta, scoppiata sei anni fa nel penitenziario e repressa
con violenza spropositata, è partita un'inchiesta, poi archiviata. Ora la
procura generale di Torino ha avocato il fascicolo e ha indagato 25 persone tra
agenti e medici. «Avevamo più volte sollecitato la procura di Ivrea, ma non
arrivavano mai risposte», commenta l'avvocata Simona Filippi che rappresenta la
onlus. Detto in altri termini: «Finalmente qualcuno ci ascolta».
Violenze e omertà. Ecco il
quadro che raccontavano i detenuti. Qualcuno, con qualche operatore del carcere,
si era pure confidato. Era finito nella stanza delle punizioni, quella che
chiamavano «acquario» perché il vetro era quasi totalmente oscurato ma da fuori
si poteva assistere a tutto ciò che accadeva dentro. Uno dei difensori degli
indagati, l'avvocato Celere Spaziante, ribatte: «Il quadro che emerge dalle
indagini non è veritiero». E aggiunge: «Credo sia più che mai opportuno
sottolineare le difficoltà in cui, ad Ivrea, operano gli agenti con analogo
disagio da parte dei detenuti che stanno scontando la loro pena nel rispetto
delle leggi».
Che in quel penitenziario ci
fossero «tensioni e gravi conflittualità» lo ha annotato, in visita nel novembre
2016, anche l'allora garante nazionale dei detenuti. Che per ricostruire gli
accadimenti incontrò non poche difficoltà: «Nell'istituto sono assenti i
registri degli eventi critici e dei provvedimenti disciplinari, sostituiti
dall'archiviazione in un unico database informatico degli eventi quotidiani».
Tensioni, dunque. Com' è normale in un carcere. E nelle denunce è spiegato bene:
«Il fatto che Gerardo fosse un detenuto "fortemente aggressivo", se può
rappresentare il movente delle violenze, non ne può elidere la valenza
illecita». La legge è cosa ben diversa dalla vendetta. E dall'esaltazione della
forza. Vale per tutti.
Giuseppe Legato e Lodovico
Poletto per “la Stampa” il 22 settembre 2022.
Botte e omissioni, violenze e
bugie. Un'infermeria trasformata per alcuni mesi nella stanza dei pestaggi. E
ancora: verbali falsificati per raccontare un'altra storia, per coprire le
percosse, i pugni, i calci, le manganellate che alcuni detenuti avrebbero subito
nel carcere di Ivrea tra il 2015 e il 2016 con preoccupante regolarità.
Una decina, i casi finiti agli
atti dei magistrati, 25 gli indagati tra agenti, medici interni del
penitenziario e detenuti omertosi che l'altroieri hanno ricevuto l'avviso di
garanzia dalla procura generale di Torino (Pg Giancarlo Avenati Bassi e Carlo
Maria Pellicano). Le accuse: lesioni e falsi aggravati. Gli inquirenti non
contestano il reato di tortura, ma solo - pare di capire - perché l'entrata in
vigore della fattispecie è successiva alla consumazione dei presunti reati.
L'11 novembre 2015 Hamed fu
picchiato - secondo l'accusa - con pugni e calci da sette agenti. In due gli
tenevano ferme le braccia, gli altri menavano. «E il medico di turno della casa
circondariale continuava a sorseggiare il caffè alla macchinetta automatica».
Non un cenno «non un intervento per fermarli».
Nemmeno «una comunicazione al
direttore come sarebbe stato suo dovere». scrivono i pm. Ma è lunga la lista di
casi diventati oggi - dopo decine e decine di audizioni di testimoni - titoli di
reato. Il 25 ottobre del 2016 il detenuto Angeli G. viene accompagnato dagli
agenti in infermeria. Lo prendono a pungi, lo colpiscono con manganello. Il
certificato medico dirà che lo avevano conciato male: «estese ferite al volto, a
naso, al costato». Uno degli agenti che per i pm avrebbe partecipato al
pestaggio, scriverà poche ore dopo in una falsa relazione di servizio che «il
detenuto perdeva l'equilibrio sul pavimento reso scivoloso dall'acqua utilizzata
per spegnere i focolai accesi da alcuni detenuti in sezione e sbatteva la faccia
contro una cella».
Manganellate, schiaffi, pugni
e calci li avrebbe subiti anche Marco D. Al costato, al viso, sulle braccia:
«Dopo le botte - si legge agli atti - lo hanno lasciato per un'intera notte in
infermeria nudo». Seguono anche in questo caso false attestazioni di servizio
che parlano di «scivolamento su materiale residuo lanciato per terra dai
detenuti». Senza vestiti, al freddo dell'infermeria, dopo essere stato
picchiato, è rimasto anche Edoardo S.
ma al comandante della polizia
penitenziaria arriverà tutt' altra narrazione in un verbale firmato dai suoi
agenti.
E cioè che «era il detenuto
che mentre si trovava nella saletta di attesa dell'infermeria cominciava
sbattere violentemente la testa contro un vetro pronunciando testuali parole:
Ora mi faccio male cosi vi rovino pezzi di m». Tra le ferite riportate dai
carcerati lacerazioni del timpano, zigomi e nasi fratturati. La spiegazione dei
secondini al comandante sempre la stessa: «Ha battuto volontariamente la testa
contro un pilastro dicendo che ci avrebbe messo nei guai sostenendo che eravamo
stati noi».
Tra i legali che difendono gli
indagati, tutti attesi in procura nei prossimi giorni per un primo
interrogatorio ci sono Enrico Calabrese e Celere Spaziante. Quest' ultimo
assiste una decina di agenti: «Al netto del fatto che confidiamo di provare
l'insussistenza delle contestazioni, faccio presente come siamo lontanissimi
dagli scenari già evocati nell'inchiesta del carcere di Santa Maria Capua
Vetere. I miei clienti sono amareggiati per le bugie dette sul loro conto. I
manganelli? Non sono in dotazione in carcere e non ci possono entrare».
L'indagine avviata
inizialmente dalla procura di Ivrea su due episodi sui quali i magistrati
eporediesi avevano chiesto l'archiviazione è stata avocata dal procuratore
generale in persona Francesco Saluzzo.
Ivrea, detenuti torturati
in carcere: la procura generale di Torino indaga 25 persone.
Tra le accuse più brutali c’è
quella rivolta a un medico del penitenziario in servizio il 7 novembre 2015 che
avrebbe assistito al pestaggio del detenuto Ahmed Alì da parte di 4 agenti di
polizia penitenziaria mentre altri 2 lo tenevano fermo. Le difese evidenziano la
mancanza di riscontri rispetto ai fatti contestati. Il Dubbio il 23 settembre
2022.
Calci e pugni, manganellate,
isolamenti in celle vuote, detenuti costretti a dormire nudi dopo i pestaggi e
referti medici falsificati. Sono accuse pesantissime quelle che la procura
generale di Torino muove a 25 fra agenti di polizia penitenziaria e personale
della casa circondariale di Ivrea – chi ancora in servizio, chi trasferito in
altra sede – per fatti commessi fra 2015 e 2016 e che ora devono rispondere a
vario titolo di lesioni aggravate in concorso e falso ideologico in atto
pubblico.
Il procuratore Giovanni
Saluzzo ha avocato una serie di fascicoli aperti a Ivrea per i quali i pm
locali, guidati all’epoca dal procuratore Giuseppe Ferrando, avevano chiesto
l’archiviazione per «assenza di riscontri», spiega a LaPresse l’avvocato Michele
Celere Spaziante che difende 8 agenti penitenziari. «Allo stato attuale delle
indagini – dichiara – nego ogni addebito per gli agenti che assisto». «Le
indagini di Ivrea appaiono sotto vari profili carenti», si legge nei decreti di
avocazione emessi a Torino.
L’associazione Antigone da cui
sono nati alcuni degli esposti parla, per bocca della propria legale, Simona
Filippi, di indagini «dopo anni di disinteresse» e di «sostanziale immobilismo»
della Procura di Ivrea. Per il presidente della onlus che si occupa di garanzie
nel sistema penale, Patrizio Gonnella, si tratta di fatti che «si riferiscono
pienamente alla fattispecie di tortura», reato non ancora presente nel codice
penale italiano. Ora i sostituti procuratori torinesi Giancarlo Avenati Bassi e
Carlo Maria Pellicano avranno il compito di dipanare la massa di gravi accuse e
angherie denunciate da almeno 7 detenuti, incrociando date, testimonianze,
orari, documenti e referti.
Le accuse sono nate in
particolare dal lavoro di raccolta del Garante comunale per i detenuti di Ivrea
e il Garante nazionale, Mauro Palma. Che nel 2016 ha anche stilato un Rapporto
ispettivo sul carcere piemontese dove si parla di una «sala accanto
all’infermeria, cosiddetta “Acquario“. Soprannome nato per via di un vetro
oscurato tranne che per una striscia di 15 centimetri da cui è possibile
guardare dall’esterno ciò che accade all’interno, utilizzata come «cella di
contenimento di natura afflittiva» violando la Convenzione europea dei diritti
dell’uomo.
Tra le accuse più brutali c’è
quella rivolta a un medico del penitenziario in servizio il 7 novembre 2015 che
avrebbe assistito al pestaggio del detenuto Ahmed Alì da parte di 4 agenti di
polizia penitenziaria mentre altri 2 lo tenevano fermo, il tutto sorseggiando
una bevanda accanto alle macchinette per poi refertare lui le ferite sul corpo
dello straniero. Un’altra delle ipotesi di reato riguarda 4 agenti che avrebbero
lasciato un detenuto «tutta la notte» in una cella vuota «privo di indumenti»
dopo aver subito un pestaggio da agenti che lo avrebbero «colpito con il
manganello e con calci, pugni e schiaffi sul viso, sulla bocca, sul costato e su
tutto il corpo».
Agenti di
polizia, medici e detenuti omertosi sotto accusa.
Carcere di Ivrea,
25 indagati per i pestaggi. Angela Stella su Il Riformista il 23 Settembre 2022
Per i possibili
pestaggi (la presunzione di innocenza vale sempre per tutti) perpetrati dalla
polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti del carcere piemontese di Ivrea
e per i successivi tentativi di insabbiamento ci sono 25 indagati. Tra loro ci
sono agenti di polizia penitenziaria e medici, alcuni ancora in servizio nel
carcere eporediese, altri nel frattempo trasferiti. Tra gli indagati, come
riferisce La Stampa, anche detenuti omertosi. I casi indagati dalla Procura si
riferiscono al periodo che va dal 2015 al 2016. Le accuse per le quali procedono
i magistrati sono: lesioni e falsi aggravati. Non è stato possibile procedere
per il reato di tortura perché i fatti sarebbero stati commessi prima
dell’entrata in vigore della norma. «Anche se i fatti in oggetto, se confermati,
si riferiscono pienamente alla fattispecie di tortura – ha dichiarato Patrizio
Gonnella, presidente di Antigone – questo reato non è stato contestato poiché
non ancora presente nel codice penale al momento della presentazione degli
esposti e dell’apertura delle indagini. Fortunatamente oggi questo reato c’è e
ci consente di perseguire pienamente chi commette questi crimini, nonostante ci
sia ancora chi ritiene che sia di impedimento ai poliziotti nello svolgimento
del proprio lavoro, tanto da avanzare la richiesta di abolizione o ampia
modifica della fattispecie penale».
Antigone – ha
sottolineato l’avvocata Simona Filippi, che per l’associazione segue il
contenzioso legale – «era venuta a sapere di diversi casi di presunte violenze e
aveva presentato alcuni esposti alla Procura di Ivrea, territorialmente
competente, anche a seguito delle denunce presentate dal Garante comunale della
città piemontese. Nei mesi successivi abbiamo registrato un sostanziale
immobilismo da parte della Procura eporediese che portò a ben due richieste di
archiviazione a cui ci opponemmo. Proprio a seguito di quello che, a nostro
rilievo, era un mancato esercizio dell’azione penale, chiedemmo l’avocazione
delle indagini al Procuratore generale presso la Procura di Torino che, a due
anni di distanza, avrebbe emanato questi avvisi di Garanzia». Sono infatti sette
anni che si cerca di far luce su quello che accadeva nel carcere di Ivrea.
«Le indagini
espletate dalla Procura della Repubblica di Ivrea appaiono, sotto vari profili
carenti» scrivevano, con parole dure, il procuratore generale Francesco
Saluzzo e l’allora sostituto Otello Lupacchini nel 2020 dopo aver firmato i
provvedimenti di avocazione delle inchieste sulle violenze per le quali il
procuratore capo di Ivrea aveva chiesto l’archiviazione. Nell’atto dell’accusa –
come ricorda sempre l’associazione- si legge che «Hamed, uno dei detenuti il cui
caso Antigone aveva segnalato con un esposto e ora oggetto delle indagini, fu
picchiato con pugni e calci da sette agenti. In due gli tenevano ferme le
braccia. Gli altri menavano. E il medico di turno della casa circondariale
continuava a sorseggiare il caffè delle macchinette automatiche. Non un cenno,
non un intervento per fermarli. Nemmeno una comunicazione al direttore come
sarebbe stato suo dovere». Anche il Comitato per la Prevenzione della
Tortura (Cpt), in un suo rapporto pubblicato a seguito di una visita svolta
nell’aprile del 2016, aveva segnalato le violenze che sarebbero avvenute nel
carcere di Ivrea.
Bruno
Mellano, Garante piemontese dei diritti delle persone private della libertà
personale, commenta al Riformista: «Le vicende di Ivrea sono seguite dalla rete
dei Garanti in modo assiduo da diversi anni. I vari garanti cittadini che si
sono susseguiti, e che mi risulta essere stati sentiti pure loro in queste
settimane di indagini, hanno sempre segnalato i racconti fatti dai detenuti,
lasciando sempre alla magistratura il compito della verifica. Bene ha fatto il
procuratore generale di Torino Saluzzo ad avocare a sé i fascicoli perché
occorre capire cosa è veramente successo durante quelle notti nel carcere di
Ivrea». Mellano ci dice che anche dopo i fatti del 2015-2016 «sono arrivati
all’attenzione degli inquirenti altri esposti di detenuti che sono o sono stati
in quell’istituto, quindi nulla esclude che possano aprirsi altri fascicoli di
indagine. La stessa cosa è successa a Torino e a Santa Maria Capua Vetere». In
ultimo il Garante Mellano ricorda: «Nell’immediatezza delle notizie emerse sulle
presunte violenze avevo partecipato ad una missione molto ficcante insieme
ad Emilia Rossi del Collegio Nazionale del Garante nel carcere di Ivrea.
Registrammo diversi elementi da chiarire, come una cella liscia e la famosa
stanza denominata ‘acquario’, sala di attesa dell’infermeria. Era priva di
riscaldamento, senza passaggi di circolazione dell’aria, inadatta ad ospitare
persone che necessitano di assistenza sanitaria. Infine facemmo presente che nei
quattro piani dell’istituto non era presente un sistema di video-sorveglianza.
In questi anni siamo riusciti ad ottenere che venissero messe le telecamere
almeno su due piani». Angela Stella
Il dramma al
carcere di Ariano Irpino. Costantino è morto in carcere il giorno prima
dell’udienza: “Voleva andare in comunità, ma non c’era posto”.
Rossella
Grasso su Il Riformista il 15 Novembre 2022.
Costantino aveva 45
anni, era originario di Bellizzi, in provincia di Salerno.
Era tossicodipendente, aveva bisogno di aiuto, ne era consapevole e lo voleva.
Il 15 novembre era atteso per l’udienza in Tribunale. È morto in carcere
di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, il giorno prima. Era lì da una
settimana appena. “Sono 186 le persone morte nelle carceri italiane dall’inizio
dell’anno , 77 si sono suicidate – ha detto Samuele Ciambriello, Garante dei
detenuti della Regione Campania – In Campania in 6 si sono tolti la vita.
L’ultimo è Costantino che si è tolto al vita nel carcere di Ariano Irpino. Il
male oscuro dei suicidi, va fermato”. Secondo la ricostruzione di Emilio
Fattorello, consigliere nazionale del sindacato autonomo Osapp, Costantino si è
impiccato all’inferriata della cella utilizzando una cintura. Per lui sono stati
inutili i soccorsi, è morto in carcere.
“Su questa morte
saranno fatti accertamenti. Certo è che era una morte che si poteva evitare.
Costantino era un tossicodipendente e voleva andare in comunità. Da maggio lo
chiedeva, ma per lui, come per tanti altri, non c’è mai posto”, ha detto
l’avvocato Stefania Pierro, legale di Costantino che da anni si batte per i
diritti dei detenuti tossicodipendenti che sono i più fragili e meno tutelati.
Quelli che hanno bisogno di maggiore attenzione e di aiuto concreto, di
strutture idonee al loro trattamento. Ma sembra che in Campania tutto ciò non
sia previsto.
“La morte di
Costantino mi ha sconvolta – continua l’avvocato Pierro – Per i
tossicodipendenti il carcere non rieduca e non recupera affatto. Costantino
voleva andare in comunità, lo stava chiedendo da maggio. Era fiducioso che ci
sarebbe riuscito ed eravamo in attesa di trovare una disponibilità in una
struttura in Campania. Ma il posto non si trovava. Mi domando: se non ci sono
posti nella nostra regione, perché non mandarli fuori? La sanità penitenziaria
prevede che un detenuto debba stare in una comunità nella regione di
appartenenza, salvo casi eccezionali. Ma in Campania non ci sono posti. Quindi
perché non mandarli altrove?”.
L’avvocato racconta
di un altro detenuto tossicodipendente, suo assistito, che aveva avuto
l’affidamento terapeutico in una struttura. La mattina stessa della sua
scarcerazione al comunità aveva avvertito che il posto non c’era più e il suo
assistito è tornato in carcere dove sta ancora rinchiuso. “Come Costantino sono
tanti i detenuti tossicodipendenti a cui vengono concessi affidamenti in
strutture ma che poi restano in carcere sempre perché non c’è posto”.
Ciambriello spiega
che Costantino era tossicodipendente da “doppia diagnosi”. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) definisce la Comorbidità o Doppia Diagnosi la
“coesistenza nel medesimo individuo di un disturbo dovuto al consumo di sostanze
psicoattive ed un altro disturbo psichiatrico”. In che modo il carcere avrebbe
potuto rieducarlo? “Voleva andare in comunità – dice Ciambriello – In passato ci
era stato e stava meglio. Poi era finito nuovamente in carcere. Aveva anche
ingerito una lametta in passato. Faceva laboratori di serigrafia e falegnameria.
Ieri nessuno avrebbe sospettato che volesse togliersi la vita”. È morto in
carcere, dove era recluso da Aprile in custodia cautelare.
“Oggi – continua
l’avvocato Pierro – saremmo dovuti comparire davanti al giudice. Avremmo chiesto
il giudizio abbreviato e i domiciliari in comunità. Ma comunque non avevamo il
posto”. “Ci sono soggetti che non dovrebbero stare in carcere: penso ai
tossicodipendenti, ai malati psichiatrici, ai soggetti fragili – continua il
Garante regionale dei detenuti – Occorre liberarsi dalla necessità del carcere
per queste persone. Il carcere deve essere una estrema ratio. Bisogna
incrementare più figure sociali nella carceri: educatori, psicologi, volontari.
Anche più spazi, più telefonate, più liberazione anticipata. Il carcere non può
più continuare ad essere una discarica sociale e un ospizio dei poveri”.
Ciambriello e Pierro
ricordano che Costantino quando era in carcere a Salerno è stato il testimone di
un’altra triste vicenda, la morte di Vittorio Fruttaldo, il detenuto di 35 anni,
originario di Aversa stroncato da un malore il 10 maggio scorso, dopo uno
scontro fisico con gli agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Fuorni.
Sul suo corpo, da un primo esame, furono trovati segni di violenza,
riconducibili a percosse subite nei giorni precedenti. Come appreso
dal Riformista nel tempo emersero dettagli raccapriccianti che smentirono la
versione fornita dal sindacato di polizia penitenziaria secondo cui il detenuto,
affetto da problemi di natura psichiatrica (circostanza smentita dai referti
medici), avrebbe aggredito due agenti con un coltello rudimentale e, nel corso
della colluttazione, sarebbe stato stroncato da un malore.
Costantino era uno
dei testimoni chiave di quanto accaduto a Fruttaldo, che, secondo quanto appreso
dal Riformista, era un detenuto che aveva problemi di tossicodipendenza. Avrebbe
finito di scontare la sua pena a ottobre 2022 e anche lui necessitava di una
terapia per disintossicarsi. Per il caso saranno fondamentali le testimonianze
degli altri detenuti che dovrebbero essere ascoltati dagli investigatori per far
luce su quanto accaduto nel carcere di Salerno ed evitare che si ripetano
episodi analoghi alla mattanza di Santa Maria Capua Vetere quando, prima delle
misure cautelari e delle devastanti immagini che sconvolsero l’opinione
pubblica, i detenuti, impauriti di subire ulteriori ripercussioni, derubricavano
le percosse subite con l’oramai celebre “sono caduto dalle scale”.
Rossella Grasso.
Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su
varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia.
Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra
le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos,
Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli.
Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’
autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio
mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.
I numeri del
Garante nazionale dei detenuti.
Strage nelle
carceri, 79 suicidi da inizio anno nell’indifferenza di media e politica: è il
dato più alto da dieci anni. Carmine Di Niro su Il Riformista il 6 Dicembre 2022
Una strage
silenziosa, visto che i ‘grandi media’ raramente se ne occupano o la lanciano in
prima pagina. Dall’inizio del 2022 sono stati 79 i casi di suicidio nelle
carceri italiane, il numero più alto mai registrato negli ultimi 10 anni.
Allargando l’arco temporale al 2012, sono stati invece 583 le persone che si
sono tolte la vita quando erano nelle mani dello Stato.
Il dato ufficiale è
inserito in un rapporto stilato dal Garante delle persone private della libertà
personale Mauro Palma. Numeri ancora più allarmanti se rapportati al totale
delle persone detenute negli istituti di reclusione del paese: nel 2022 sono
infatti 11mila in meno rispetto al 2012, ma ci sono stati 23 suicidi in più.
Si tratta di 74
uomini e 5 donne, 33 erano riconosciute con fragilità personali o sociali, senza
fissa dimora, persone con disagio psichico; circa un suicidio su 5 si verifica
nei primi 10 giorni dall’ingresso, il 62% dei suicidi in carcere avvengono
invece nei primi sei mesi di detenzione.
Delle 49 persone che
si sono tolte la vita nella fase ‘inziale’ della detenzione, 21 si sono uccise
nei primi tre mesi dall’ingresso in Istituto e 15 nei primi 10 giorni, 9 dei
quali addirittura entro le prime 24 ore dall’ingresso. Significa circa un
suicidio su cinque si verifica nei primi dieci giorni dall’ingresso nel carcere
Inoltre, fra le 79 persone suicidatesi 5 avrebbero completato la pena entro
l’anno in corso, 39 avevano una pena residua inferiore a 3 anni; solo 4 avevano
una pena residua superiore ai 3 anni e una soltanto aveva una pena residua
superiore ai 10 anni. Un picco si è registrato nel mese di agosto, quando in
carcere gran parte delle attività si fermano, con ben 17 casi.
Secondo Mauro Palma,
i numeri dimostrano come “le condizioni della vita detentiva o la durata della
pena ancora da scontare o della carcerazione preventiva spesso non sembrano
risultare determinanti nella scelta di una persona detenuta di togliersi la
vita“. “In questi casi – prosegue il Garante nazionale dei detenuti – sembra
piuttosto che lo stigma percepito dell’essere approdati in carcere costituisca
l’elemento cruciale che spinga al gesto estremo”.
Un rapporto
commentato a stretto giro dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, impegnato
in audizione alla Commissione Giustizia del Senato sulle linee programmatiche
del suo dicastero. “Abbiamo vissuto con grande dolore la sequenza di suicidi,
anche per questo il ministero si sta attivando con una pressante energia per
limitare i tagli previste dalla legge di bilancio e per devolvere al settore
eventuali risorse disponibili“, ha spiegato il Guardasigilli.
Nordio ha promesso
attenzione alla salute dei detenuti, in particolare “tutele per i fragili,
potenziando il coordinamento con le autorità sanitarie gli enti locali e le
comunità terapeutiche. L’obiettivo è individuare fin dall’inizio le persone con
problematiche da dipendenza o con patologie psichiatriche o rischio di
autolesionismo“.
Carmine Di Niro.
Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato
di politica, sport e tecnologia
Ancora suicidi
nelle carceri italiane: le ragioni di una strage senza fine.
Gloria Ferrari su
L'Indipendente il 12 novembre 2022.
È stato trovato con
un lenzuolo stretto attorno al collo, legato alle sbarre della sua cella, nel
padiglione C. Si è suicidato così Antonio, detenuto di 56 anni rinchiuso nella
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino dallo scorso agosto con l’accusa
di stalking nei confronti dall’ex compagna (ma non aveva ancora ricevuto un
giudizio definitivo). Nei giorni precedenti nessun campanello d’allarme: non
aveva parlato con nessuno dei suoi problemi, racchiusi tutti in un biglietto
trovato accanto al corpo in cui Antonio ha spiegato la scelta del suo gesto,
principalmente dovuta a “motivi personali”.
Prima di lui, nello
stesso penitenziario, dall’inizio del 2022 si sono tolte la vita altre tre
persone. Anche Tecca Gambe, un ragazzo del Gambia finito in cella per essere
stato complice del furto di un paio di cuffiette, si è ammazzato lo scorso 28
ottobre soffocandosi con un lenzuolo. Di lui le autorità sapevano poco, e in
realtà non erano convinte neppure che quello fosse il suo vero nome. Cioè che è
tuttora noto, invece, è che la sua morte è avvenuta circa 48 ore dopo
l’arresto. «Se potessi tornare indietro non chiamerei la polizia. Non si può
morire per delle cuffiette Bluetooth che costano 24 euro», ha detto la
proprietaria del negozio dove è avvenuta la rapina. Un paradosso, dal momento
che è giusto che chi subisce un furto denunci, così come è giusto che chi
commette un reato paghi. Ma non con la vita e non in maniera così poco
dignitosa. Prima ancora di Tecca e poi di Antonio, il 24 luglio si era impiccato
anche un altro uomo, Nuammad, originario del Pakistan, e la stessa fine se l’è
procurata il giorno di ferragosto Alessandro, un 24enne di origini brasiliane,
con passaporto italiano.
Seppur diversi per
storie e origini, tutte queste vittime raccontano di un’unica grande e
drammatica situazione: quella delle carceri italiane, dove i morti per suicidio,
dall’inizio dell’anno, sono ormai vicini agli 80. Altrettanto emblematico è il
fatto che gli ultimi episodi si siano verificati a Torino, città in cui negli
ultimi anni gli arresti sono passati dai 2.466 del 2014 ai 3.538 del 2019, ma il
77% dei detenuti è già in libertà dopo 48 ore, una volta cioè stabilita la sua
posizione giuridica.
«Alla prima visita
non c’erano segnali di alcun problema che facessero intuire la necessità di un
percorso particolare. Nessuno», e per questo, come ha spiegato Cosima
Buccoliero, la direttrice del carcere Lorusso e Cutugno, anche Gambe avrebbe
potuto lasciare il carcere da lì a breve ed eventualmente scontare la pena in
altro modo. Ma non c’è stato il tempo.
In generale
l’Italia, con i suoi 0,67 casi di suicidi ogni 10.000 abitanti, è
tendenzialmente considerato un Paese con il più basso tasso di persone che si
tolgono la vita a livello europeo. Questa realtà però cambia totalmente dietro
le sbarre, con 10,6 suicidi ogni 10.000 persone detenute (nel 2019 era 8,7 ogni
10mila, circa 13 volte superiore a quello delle persone libere). Tra le altre
cose la fascia più colpita è quella che va dai venti ai trent’anni, ragazzi che
in molti casi si trovavano in carcere da poche ore o che potrebbero essere
liberati nel giro di poco, usciti in misura alternativa. Per quale motivo i
numeri cambiano così tanto fuori e dentro le celle?
Partiamo dal
presupposto che «ogni suicidio, va ricordato, è un atto a sé, legato alla
disperazione di una persona», come ha sottolineato Patrizio Gonnella, presidente
di Antigone. Tuttavia «quando i suicidi sono così tanti e in carcere ci si
uccide 16 volte in più che nel mondo libero, l’intero sistema penitenziario e
quello politico non possono non interrogarsi sulle cause di questo diffuso
malessere».
E una fra queste è
senza dubbio la condizione di vita di chi finisce dietro le sbarre. In base alle
visite effettuate da Antigone in 85 istituti penitenziari negli ultimi 12 mesi
(dal luglio 2021 al luglio 2022), nel 31% dei casi (1 su 3) gli istituti hanno
celle in cui non sono garantiti i 3mq calpestabili per persona. Oltre al
sovraffollamento che ne scaturisce, l’Associazione ha rilevato che metà delle
carceri visitate non sono dotate di doccia (seppur previste dal regolamento
penitenziario del 2000) e che nel 44% degli istituti ci sono celle con
schermature alle finestre che limitano il passaggio di aria.
In Italia ci sono
circa 120 detenuti ogni 100 posti disponibili, con circa 20mila (37%) fra i
detenuti attualmente rinchiusi che devono scontare un residuo pena inferiore ai
tre anni: molti di loro potrebbero ad esempio accedere a misure alternative,
lasciando spazio in cella. Per non parlare di chi è ancora in attesa di
giudizio. Se consideriamo che il 34,8% dei detenuti è in carcere per violazione
delle leggi sugli stupefacenti, «intervenire sulla legge sulle droghe potrebbe
già ridurre di molto il numero delle persone in galera». In generale il nostro
Paese ha sempre mostrato una tendenza a concepire il carcere più come luogo di
espiazione anziché di rieducazione. E lo dimostrano i dati. In Italia il
personale dedicato all’amministrazione penitenziaria e alla custodia è superiore
all’80% (la media europea è del 55%). Mentre i dipendenti occupati in attività
educative e di formazione professionale sono circa il 2% (la media è del 3,3%).
In sintesi, nelle carceri ci sono 1,6 detenuti per agente e più di 80 per
educatore. La sfera psicologica ed emotiva dei carcerati è infatti spesso messa
in ultimo piano. Le strutture molte volte limitano i contatti con l’esterno, le
visite e perfino le chiamate. In molte carceri non esistono spazi adeguati a
permettere gli incontri, che finiscono per essere rimandati e alla fine
cancellati. Il rischio, come stiamo vedendo accadere, è di perdersi per strada
tantissime vite umane. [di Gloria Ferrari]
Altro che stare "al
fresco". Acqua razionata, sovraffollamento e un suicidio ogni 5 giorni: viaggio
nel disastro del pianeta carceri.
Carmine Di Niro su Il
Riformista il 28 Luglio 2022.
Nelle carceri non si sta “al
fresco”, come da luogo comune quando una persona viene sbattuta dietro le
sbarre. Anzi, i penitenziari italiani sono sempre più vicini ad un inferno
climatico, una sorta di fardello supplementare per chi sta già scontando la sua
pena con la giustizia, magari in celle sovraffollate.
È questo il quadro che emerge
dal rapporto di metà anno dell’Associazione Antigone, che da anni si occupa di
monitorare i diritti delle persone private della libertà nelle 197 carceri
italiane.
Istituti in cui mancano i
frigoriferi, i ventilatori e in casi estremi anche l’acqua, come a Santa Maria
Capua Vetere, il carcere casertano finito sulle prime pagine per la mattanza
compiuta dalla penitenziaria contro i detenuti: lì non c’è alcun collegamento
con la rete idrica comunale, così per ‘sopravvivenza’ agli ospiti vengono
forniti 4 litri di acqua potabile al giorno, prelavata da pozzi artesiani.
Patrizio Gonnella, presidente
di Antigone, illustrando il rapporto ha sottolineato che dalle osservazioni
dell’associazione “è emerso che sono troppi i luoghi dove non si respira, si
vive male. Sono condizioni durissime di vita per i detenuti e per coloro che
lavorano all’interno delle carceri”. Dalle visite effettuate da Antigone è
emerso infatti che in quasi un terzo degli istituti non sono garantiti i 3 metri
quadri di spazio calpestabile per persona, nel 58% delle celle non c’è la doccia
(anche se sono previste da regolamento dal 2005), e nel 44,4% degli istituti ci
sono celle con schermature alle finestre che impediscono il passaggio d’aria.
Quanto ai ventilatori, il cui acquisto è stato autorizzato da una recente
circolare del Dap, nelle carceri ve ne sono ancora pochissimi.
L’affollamento
Il sovraffollamento delle
carceri resta un problema ormai storico per il Paese. Stando agli ultimi dati
aggiornata al 30 giugno 2022 dal Dipartimento per l’amministrazione
penitenziaria, sono 54.841 le persone detenute negli istituti di pena, a fronte
di una capienza regolamentare di 50.900 posti, con un tasso di affollamento
ufficiale del 107,7%.
Per Antigone questi numeri
però non sono veritieri perché sul territorio nazionale ci sono al momento 3.665
posti non disponibili negli istituti di reclusione: la capienza effettiva dunque
scende a 47.235 posti e il sovraffollamento effettivo sale al 112%.
Ci sono poi alcuni casi
limite, i 25 istituti dove il sovraffollamento reale è superiore al 150%, con
picchi di oltre il 190%. Tra quelli più critici, segnalati dall’associazione,
gli istituti di Latina con un tasso di affollamento reale del 194,5%; Milano San
Vittore, che con 255 posti non disponibili ha un tasso di affollamento del
190,1%; Busto Arsizio al 174,7%. A livello regionale il tasso più alto si
riscontra in Lombardia (148,9%), che è anche la regione con più detenuti, 7.962,
seguita da Campania (6.726), Sicilia (5.955), Lazio (5.667) e Piemonte (4.015).
Il record di suicidi
L’altra grande emergenza
segnalata in questi primi sei mesi del 2022 è quella dei suicidi. Sono 38 i
detenuti che da inizio anno si sono tolti la vita dietro le sbarre, uno ogni
cinque giorni. Di questi 18 erano di origine straniera, due le donne, mentre 14
persone avevano tra i venti e i trent’anni.
Guardando al passato, il
dossier “morire di carcere”, curato da Ristretti Orizzonti, racconta come da
dieci anni a questa parte i suicidi avvenuti tra il mese di gennaio e quello di
giugno siano stati un minimo di 19 e un massimo di 27. Solo nel 2010 e nel 2011
tale numero si avvicinava a quello di oggi, rispettivamente con 33 e 34 suicidi.
Anni in cui però il sovraffollamento aveva raggiunto picchi ancora più alti
rispetto a quelli odierni: i detenuti oggi sono in numero assai minore, eppure i
disagi e i suicidi continuano.
La soluzione
Una soluzione per risolvere
almeno parzialmente i problemi all’interno delle carceri ci sarebbe, ma
servirebbe anche una volontà politica difficile da trovare in Parlamento. Il
‘jolly’ sarebbe quello di concedere agli oltre 6mila detenuti con un residuo di
pena inferiore ai tre anni di accedere a misure alternative, intraprendere cioè
percorsi di esecuzione penale esterna.
Carmine Di Niro. Romano di
nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di
politica, sport e tecnologia
La vergogna dietro le
sbarre è la disumanità. Rissa tra 40 detenuti nel carcere della mattanza, la
penitenziaria ci ricasca e carica… i numeri.
Andrea Aversa su Il Riformista
il 28 Luglio 2022.
Nessuna apocalisse. I 40
detenuti, protagonisti della rissa avvenuta nel carcere di Santa Maria Capua
Vetere, sarebbero stati in realtà in tre-quattro. Emilio Fattorello, Segretario
regionale del Sindacato autonomo della polizia penitenziaria (Sappe), ha
dichiarato ieri che «era scoppiata una rissa che ha coinvolto quasi la totalità
dei ristretti della IV Sezione del reparto Nilo (quello della “prima
accoglienza”, purtroppo diventato “famoso” per la mattanza del 2020, ndr) che si
sono serviti di oggetti contundenti come i piedi dei tavolini per scontrarsi».
Pare invece che ci sia stato
soltanto un acceso litigio tra poche persone al termine dell’ora d’aria. I
motivi sono sconosciuti, i fatti accaduti sono purtroppo la normalità. «D’estate
il carcere è una polveriera – ha spiegato a Il Riformista Emanuela Belcuore,
Garante dei diritti dei detenuti per la provincia di Caserta – nel penitenziario
le condizioni di vivibilità sono al limite a causa del caldo, della mancanza di
acqua, del sovraffollamento e dei casi di covid». A Santa Maria il personale
della Polizia penitenziaria è in sotto organico e lavora in estrema difficoltà.
Per 900 detenuti ci sono soltanto una psicologa fissa ed uno mobile. Il
personale sanitario e quello degli educatori è ridotto all’osso. Questo causa
anche lo stop delle varie attività trattamentali.
Non ci sono mediatori per i
detenuti stranieri e molti reclusi con patologie psichiche sono costretti a
convivere con tutti gli altri e viceversa. «Di positivo – ha affermato
la Belcuore – ci sono l’estremo impegno della Direttrice Donatella Rotundo e
l’azione dei magistrati di Sorveglianza che nell’ultimo periodo si sono attivati
per affievolire la piaga del sovraffollamento, facendo uscire dal carcere
detenuti che possono scontare la pena in modo alternativo». Un pizzico di
umanità in queste celle infernali e degradanti.
Andrea Aversa
“Abolire il carcere”, il
pamphlet illuminista rilancia la sfida.
Il saggio di Manconi,
Anastasia, Calderone e Resta, è ora in edizione aggiornata con il racconto della
detenzione nell’emergenza Covid. Federica Graziani su Il Dubbio il 18 luglio
2022.
Non c’è niente in questo libro
di ciò che c’è nella maggior parte dei saggi italiani che circolano oggigiorno.
Al posto delle dispute di scuola, l’osservazione diretta della realtà di cui si
scrive. Al posto delle descrizioni scorate e orfane di pars costruens un
decalogo di proposte cui manca solo la buona volontà per essere applicate. Al
posto di una sola voce, e gravata dai dettagli biografici, quattro autori che si
avvicendano nei diversi capitoli in modo indistinguibile ma contribuendo ognuno
con un’ottica e una professionalità sue alla tesi condivisa. Questo carattere
anomalo di “Abolire il carcere” viene fuori proprio dall’anomalo genere di cui
questo libro è esempio.
Tra il saggio filosofico e il
racconto storico, tra il reportage e il manuale d’istruzioni, tra la monografia
giuridica e il libello polemico, sono tanti i fili che si possono tirare da
questa lettura. E tutti quei fili precipitano intorno alla tesi, perentoria fin
dal titolo, che il carcere si possa e si debba abolire. Una tesi che si scontra
con l’abito mentale dell’ineluttibilità della prigione innanzitutto dimostrando
una verità tanto evidente quanto misconosciuta: il carcere così com’è non
funziona allo scopo che si prefigge. Con le loro parole: “il carcere non
costituisce un efficace strumento di punizione, dal momento che quanti vi si
trovano reclusi sono destinati in una percentuale elevatissima, più del 68 per
cento, a commettere nuovi delitti”. E per dimostrare quanto e come il carcere
sia inutile, i quattro autori procedono con una strategia argomentativa da
illuministi.
Prima sfatano il mito che il
carcere sia sempre esistito, indagando la storicità della pena detentiva. Poi
confrontano i principi costituzionali che reggono il nostro sistema delle pene
con le condizioni concrete della vita negli istituti penitenziari: con le
carenze strutturali degli edifici, con la mancanza di operatori qualificati e di
attività risocializzanti, con la scarsità di opportunità formative e lavorative,
con l’assenza di una reale presa in carico da parte dei servizi sul territorio e
di percorsi individuali, con la composizione della popolazione carceraria
rappresentata, per la maggior parte, da poveri, tossicomani, stranieri. E
infine, stendono il loro programma minimo di modifiche al sistema penale e
penitenziario. Dieci cose da fare subito, dieci presupposti per un percorso di
avvicinamento all’abolizione del carcere, dieci proposte concretissime che vanno
dal superamento dell’ergastolo alla riduzione della carcerazione preventiva,
dalle misure alternative alla soppressione della detenzione minorile.
Ma non solo. Il libro, in
questa nuova edizione aggiornata, contiene anche il racconto del carcere durante
la pandemia. Si racconta della “mattanza della settimana santa”, nome
dell’indagine scaturita dalle prime denunce della violenza massiccia e
organizzata a opera di centinaia di agenti e funzionari di polizia penitenziaria
ai danni dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vedere il 6 aprile 2020.
E si racconta di Stefano Cucchi, dei fatti di Asti, della vicenda di Rachid
Assarag. È qui che il tono del libro cambia. È qui che le buone ragioni per
l’abolizione ordinate fino a questo punto svelano l’urgenza etica degli autori.
Che scrivono perché vogliono rispondere alla sofferenza altrui, svelandone
l’assurdità e limitandola, come possono.
L'emergenza dietro le
sbarre. Le carceri scoppiano di poveri, derelitti ed emarginati: altro che
giustizia sociale.
Iuri Maria Prado su Il Riformista il 21 Giugno 2022.
È dagli anni Settanta del
secolo scorso che la magistratura deviata si esercita a orientare la propria
giurisprudenza in senso “sociale”, e tutto si potrà dire di quel malcostume
tranne che abbia portato i benefici di giustizia diffusa che pure erano posti a
giustificazione di quelle forzature. Analogo risultamento di ingiustizia si è
avuto nei decenni più recenti di barbarie della giurisdizione penale. Anche su
quest’altro fronte si pretendeva che l’impostazione punitiva avrebbe ricondotto
a giustizia una società oltraggiosamente proclive all’indulgenza verso i
privilegiati, i potenti, gli ammanicati, come se il traguardo sicuritario di un
ordinamento finalmente capace di assicurare più catene per tutti fosse il meglio
cui ambire.
Ma il verbo sanzionatorio e il
culto del rimedio carcerario hanno prodotto l’opposto di quel che intendevano
perseguire, e cioè le galere piene di umanità derelitta, le galere piene di
poveri, piene di immigrati, piene di emarginati, piene di malati di mente, cioè
piene della gente che quella supposta giustizia avrebbe dovuto risarcire, pensa
un po’, con lo spettacolo della tortura inflitta una buona volta anche ai
colpevoli di lusso abituati a farla franca. I propositi sociali del penalismo
giudiziario engagé si sono platealmente ridotti all’ottenimento di una giustizia
profondamente classista, che in omaggio alla persecuzione dei privilegiati, che
sono meno, accetta senza perplessità quella dei disgraziati, che sono i più.
E, quando si tratta di
ipotizzare provvedimenti che intervengano per limitare l’abuso
carcerario, puntualmente la reazione pan-penalista ricorre all’armamento
demagogico che denuncia le manovre per il salvataggio di quei pochi, i
privilegiati, e pazienza se il costo delle mancate riforme lo pagano invece quei
tanti, i disgraziati cui si riconosce il privilegio di condividere la cella coi
colletti bianchi. La perequazione sociale dell’ora d’aria. Grossa come una casa,
grossa come un carcere, c’è una questione di classe a condannare
l’amministrazione della giustizia. Iuri Maria Prado
La relazione del Garante
Palma. Sovraffollamento, ergastolo ostativo, violenze e detenuti in cella con
condanne brevi: la fotografia impietosa del sistema carceri.
Redazione su Il Riformista il
20 Giugno 2022.
La fotografia del ‘pianeta’
carceri in Italia resta a tinte fosche. Il quadro della situazione lo ha
spiegato questa mattina Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private
della libertà, nella sua relazione al Parlamento, l’ultima del suo mandato
iniziato nel 2016.
Lo stato delle carceri
italiane è inaccettabili per chi vi è ristretto e per chi vi lavora, tra spazi
inadeguati e dunque sovraffollati, al cui interno vi sono migliaia di persone
che in realtà il carcere potrebbero evitarlo perché condannati a pene brevi.
Dei 54.786 detenuti
registrati (rispetto a una capienza effettiva di 50.883 detenuti) e dei 38.897
che stanno scontando una sentenza definitiva, “1319 sono in carcere per
esecuzione di una sentenza di condanna a meno di un anno e altre 2473 per una
condanna da uno a due anni“, ha spiegato Palma nella sua relazione.
Si tratta di detenuti che,
come prevede il nostro ordinamento, potrebbero godere di forme alternative di
detenzione ma che invece restano reclusi dietro delle sbarre. Per Palma questo è
“sintomo di una minorità sociale che si riflette anche nell’assenza di strumenti
di comprensione di tali possibilità, di un sostegno legale effettivo, di una
rete di supporto. Una presenza, questa, che parla di povertà in senso ampio e di
altre assenze e che finisce col rendere meramente enunciativa la finalità
costituzionale delle pene espressa in quella tendenza al reinserimento sociale:
perché la complessa ‘macchina’ della detenzione richiede tempi per conoscere la
persona, per capirne i bisogni e per elaborare un programma di percorso
rieducativo“.
Oltre al carcere per le pene
brevi, il focus della relazione è incentrato su altri due punti di crisi del
sistema carcere su cui il Parlamento “può e, in parte, deve” intervenire in
questo scorcio di legislatura, ha auspicato Palma.
Uno riguarda la malattia
psichica in carcere. Nella relazione si legge che al 22 marzo erano 381 le
persone detenute cui è stata accertata una patologia di natura psichica che ne
comporta l’inquadramento negli istituti, giuridici e penitenziari, predisposti
per affrontarla, “ma la soluzione non è e non può essere solo sanitaria e
tantomeno di sola sicurezza: va cercata nel coinvolgimento attivo di figure
professionali ulteriori e nuove”.
Altro punto chiave è la
questione dell’ergastolo ostativo. Al 31 marzo erano 1.822 le persone condannate
all’ergastolo, di cui 1.280 all’ergastolo ostativo. Numeri che, ha
sottolinea Emilia Rossi, vice del Garante, “dicono che nel nostro Paese
l’ergastolo è essenzialmente ostativo: una pena diversa, quasi di specie
diversa, rispetto a quelle previste dal codice penale, perché non definitiva
bensì sostanziata dal tempo“.
Ma nella relazione del Garante
Palma c’è anche un fortissimo richiamo sul numero inaccettabile di suicidi in
carcere: sono 29 ad oggi, di cui oltre la metà era sottoposta a misure non
definitive, oltre a 17 decessi per cause da accertare. Altra questione centrale
è quella delle violenze, che hanno occupato le prime pagine dei giornali dopo i
drammatici fatti di Santa Maria Capua Vetere.
Per Palma sono situazioni che
richiedono “capacità di accertamento rapido” e “rapida individuazione di
responsabilità anche a tutela delle persone su cui pende una incriminazione così
grave quale di tortura o quella altrettanto grave di favoreggiamento nei
confronti di coloro che di tale reato sono imputati. I tempi non stanno andando
in questa direzione”.
La bocciatura del ‘nuovo’
ergastolo ostativo
Nel suo intervento Palma ha
criticato aspramente il testo licenziato dalla Camera sull’ergastolo ostativo e
che dovrà essere licenziata dal Senato prima dell’8 novembre, “in tensione” con
le indicazioni di ben altro tipo date dalla Corte Costituzionale e che introduce
“disposizioni decisamente peggiorative rispetto alla disciplina su cui essa è
intervenuta“.
“È francamente difficile
ricondurre quest’opera di riforma ai principi e ai parametri di revisione delle
preclusioni assolute previste dall’articolo 4-bis dell’ordinamento
penitenziario, segnati, i primi, e indicati, i secondi, dalla pronuncia della
Consulta“, scrive il Garante Palma nella sua relazione, segnalando tra le
disposizioni peggiorative della disciplina attuale l’aumento del termine di
tempo, da 26 anni a 30, per l’accesso alla richiesta di liberazione
condizionale dei condannati all’ergastolo ‘ostativo’ e quello di durata della
libertà vigilata, passata da 5 anni a 10.
“Il punto che appare di
maggiore tensione rispetto alle indicazioni della Corte, tuttavia, sta proprio
nei presupposti prescritti per l’accesso a qualsiasi beneficio (tutti, inclusi i
permessi premio) o misura alternativa previsti dalla legge nonché alla
liberazione condizionale. Una serie complessa di adempimenti probatori di
difficile se non impraticabile adempimento e che, soprattutto, sono rivolti al
passato, alla storia della persona spesso condannata in un tempo lontano oltre
che riferiti a previsioni prognostiche che tanto somigliano a una prova
diabolica”, scrive Palma nella relazione.
La relazione annuale del
garante dei detenuti. Carceri stracolme tra ex terroristi colpevoli di reati
commessi 40 anni fa e detenuti con condanne inferiori ai 24 mesi.
Angela Stella su Il Riformista il 21 Giugno 2022.
Sovraffollamento, ergastolo
ostativo, carcere anche per pene molto brevi, malattia psichica: sono i punti di
crisi delle nostre carceri e del nostro sistema di esecuzione penale emersi ieri
durante la presentazione della Relazione annuale al Parlamento da parte di Mauro
Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà
personale. L’evento è stato aperto dalla Presidente del Senato, Elisabetta
Casellati, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per
la seconda carica dello Stato « il primo pensiero non può che andare all’annosa
questione del sovraffollamento delle nostre strutture – ha detto la seconda
carica dello Stato – . Nonostante gli importanti sforzi compiuti in questi anni,
anche sul piano legislativo, per contenere i flussi in ingresso e allargare
quelli in uscita dalle carceri, il numero delle persone attualmente detenute in
Italia continua ad essere pericolosamente al di sopra dei limiti di capienza,
con un tasso medio del 105/110% dei posti disponibili».
Su una capienza regolamentare
di 50.859 posti ci sono – si legge nella Relazione – «54786 persone registrate
(a cui corrispondono 53793 persone effettivamente presenti)» di cui «38897 in
esecuzione penale, essendo le altre prive di una sanzione definitiva». Ma il
dato stigmatizzato da Emilia Rossi, componente del Collegio del Garante, è che
«al 7 giugno, sono 1.317 le persone presenti in carcere per scontare una
condanna inferiore a 1 anno, 2.467 per una condanna compresa tra 1 e 2 anni,
numeri che sollecitano la ricerca di soluzioni diverse dalla detenzione in
carcere». Ha aggiunto Palma che scontare in carcere pene così brevi in presenza
delle quali il nostro ordinamento prevede forme alternative alla detenzione, «è
sintomo di una minorità sociale che si riflette anche nell’assenza di strumenti
di comprensione di tali possibilità, di un sostegno legale effettivo, di una
rete di supporto. Una presenza, questa, che parla di povertà in senso ampio e di
altre assenze e che finisce col rendere meramente enunciativa la finalità
costituzionale delle pene espressa in quella tendenza al reinserimento sociale:
perché la complessa “macchina” della detenzione richiede tempi per conoscere la
persona, per capirne i bisogni e per elaborare un programma di percorso
rieducativo».
Per quanto concerne
la malattia psichica in carcere, al 22 marzo erano 381 le persone detenute cui è
stata accertata una patologia di natura psichica che ne comporta l’inquadramento
negli istituti, giuridici e penitenziari, predisposti per affrontarla, «ma la
soluzione – ha detto Rossi – non è e non può essere solo sanitaria e tantomeno
di sola sicurezza: va cercata nel coinvolgimento attivo di figure professionali
ulteriori e nuove». Mentre il Garante ha richiamato anche l’attenzione sui
suicidi carceri – «29 a oggi a cui si aggiungono 17 decessi per cause da
accertare» e sulle gravi vicende sulle violenze nelle carceri, come a Santa
Maria Capua Vetere, che richiedono «capacità di accertamento rapido» e «rapida
individuazione di responsabilità anche a tutela delle persone su cui pende una
incriminazione così grave quale quella di tortura o quella altrettanto grave di
favoreggiamento nei confronti di coloro che di tale reato sono imputati. I tempi
non stanno andando in questa direzione» avverte il Garante che ha ritenuto
«inaccettabile» nel caso di Torino il rinvio a giudizio nel luglio del 2023 per
accertare quanto accaduto e le responsabilità. In questo contesto il Garante
nazionale ha ribadito, ancora una volta, «l’inaccettabilità di archiviazione di
inchieste dovute all’oggettiva impossibilità di individuazione delle specifiche
responsabilità personali e chiede che sia numerato ogni strumento o mezzo di
difesa in dotazione, che l’identificativo numerico sia apposto in maniera
visibile su ciascuno di essi e che sia istituito un registro per l’annotazione
dell’assegnazione ai singoli operatori, in ogni singola occasione per cui si è
fatto ricorso a essi».
In tema di 41-bis il Garante
«ha sempre ritenuto essenziale che in questi casi si adottino e si mantengano
tutte le misure volte a non consentire il perpetuarsi di tali legami. Ritiene
tuttavia importante continuare la propria azione di vigilanza affinché nessuna
misura sia introdotta o mantenuta sulla base giustificativa di altri criteri,
dettati dalla volontà di maggiore afflittività, e che provvedimenti relativi a
tale misura abbiano ogni volta una base di fondamento che tenga conto
dell’evoluzione del singolo e dei contesti». Sono invece 1.822 le persone
condannate all’ergastolo, di cui 1.280 all’ergastolo ostativo. Il testo
licenziato dalla Camera sull’ergastolo ostativo «è in tensione» con le
indicazioni date dalla Corte costituzionale e introduce «disposizioni
decisamente peggiorative rispetto alla disciplina su cui essa è intervenuta».
Per il Garante «è francamente difficile ricondurre quest’opera di riforma ai
principi e ai parametri di revisione delle preclusioni assolute previste
dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, segnati, i primi, e
indicati, i secondi, dalla pronuncia della Consulta». Basti pensare che sono
«aumentati il termine di tempo, da 26 anni a 30, per l’accesso alla richiesta di
liberazione condizionale dei condannati all’ergastolo ‘ostativo’ e quello di
durata della libertà vigilata, passata da 5 anni a 10». Un passaggio è stato
dedicato anche al terrorismo. Appare «ineludibile la contraddizione di
ricondurre in carcere persone che hanno condotto un percorso di vita senza
commettere reati, spesso cercando di compensare quanto commesso con azioni volte
al recupero sociale, pur se responsabili di gravissimi reati nel passato».
Il riferimento è agli ex
protagonisti dei cosiddetti Anni di piombo: si ricorda come nelle nostre carceri
continuino ad esserci «una ventina di persone, condannate per reati legati alla
lotta armata degli anni ’70 e ’80» mentre «almeno una decina delle persone
allora condannate si trova in Francia in attesa degli esiti della procedura di
estradizione avviata sulla base di una richiesta formulata dal governo italiano:
sono colpevoli di reati commessi tra i 30 e i 40 anni fa e da tempo hanno
formalmente ripudiato la lotta armata – nulla risulta a loro carico nel periodo
francese». «Certamente – si legge nella Relazione – il rendere giustizia
richiede che chi ha avuto lacerazioni per le loro azioni, veda riconosciuta la
colpevolezza di chi ne è stato artefice e veda uno Stato in grado di chiamare
questi rei a risponderne. Ma lo stesso imperativo del rendere giustizia chiede
anche che non possano essere la negatività della detenzione e l’interruzione
drastica delle esistenze ricostruite la forma in cui tale esigenza si
concretizzi. Richiede azioni, gesti, imposizioni che abbiano il sapore della
positività e non dell’addizione di negatività a quanto di negativo già da essi
commesso. E chiede anche che per chi ha scontato ormai lunghi anni di vita
detentiva sia costruito un percorso di ritorno alla collettività, anche
superando quel senso di durezza identitaria che le posizioni soggettive talvolta
trasmettono».
Infine il Garante ha
sottolineato sì la positività della Commissione presieduta da Marco Ruotolo, che
ha indicato per il carcere azioni da compiere sul piano amministrativo e
regolamentare, ma ne ha richiesto «una rapida attuazione: l’oggi preme. Perché
la vita delle persone ristrette corre con un ritmo irreversibile ben diverso da
quello degli accordi per complessive riforme». Nella Relazione, tra i numerosi
interventi esterni, anche quello del cardinale Matteo Zuppi, presidente
della Cei: «Dovremmo avere un progetto per ogni persona, preparare il tempo,
cioè il futuro, avviare dei processi personali positivi, di consapevolezza, di
costruzione umana, di formazione» e «quando questo non c’è, cioè il futuro per i
detenuti, la speranza di cura per i non autosufficienti, il valore della persona
negli anziani, allora si è condannati allo spazio. E questo è inaccettabile,
oltre che oneroso e senza senso».
Sul fronte immigrazione,
invece, nel 2021 meno della metà delle persone transitate nei Cpr è stata
effettivamente rimpatriata: «l’inefficienza del sistema di tali Centri, già
rilevata nelle precedenti Relazioni al Parlamento, dunque permane e interroga su
quel tempo sottratto alla vita e sulla legittimità stessa di tale privazione
della libertà», ha detto Daniela de Robert, componente del Collegio del Garante.
Per Stefano Anastasìa, Portavoce della Conferenza dei garanti territoriali delle
persone private della libertà e Garante della Regione Lazio, «e indicazioni
contenute nella Relazione annuale al Parlamento costituiscono uno stimolo e uno
sprone per tutti i Garanti territoriali, nominati dalle Regioni, dalle Province
e dai Comuni, a esercitare al meglio le proprie funzioni». Angela Stella
A quando i fatti? Inferno
carcere, da 74 anni la Costituzione non entra in cella.
Riccardo Polidoro su Il
Riformista il 22 Giugno 2022.
La relazione al Parlamento del
garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è
stata trasmessa, quest’anno, in diretta televisiva. Non solo i numerosi
autorevoli presenti – tra cui il Presidente della Repubblica, la Presidente del
Senato, il ministro della Giustizia, onorevoli e senatori – hanno potuto
ascoltare le parole di Mauro Palma, ma anche «taluni nei luoghi di cui tratta la
Relazione», come ha specificato lo stesso garante. Il pensiero si è allora
allontanato da quella bella sala e ho immaginato una stanza della casa
circondariale di Poggioreale, dove otto detenuti, stremati dal caldo, hanno il
televisore acceso e seguono quanto sta accadendo nella Capitale. «Parlano di
noi… della situazione delle carceri… quanta bella gente… ci sta pure il
Presidente… Silenzio che inizia!».
Alle parole di saluto della
Presidente del Senato, che afferma, tra l’altro, «occorre un cambio di passo…
c’è un’urgenza morale di trovare soluzioni…», i detenuti applaudono e, quando il
loro applauso si unisce a quello dei presenti in sala, l’entusiasmo è grande.
«La signora è la seconda carica dello Stato… Avete visto, pure la prima, il
Presidente, ha applaudito… d’accordo… applaudono tutti… e poi ha citato
anche Voltaire, la civiltà di un Paese si misura dalle sue carceri… questa frase
non so quante volte l’ho sentita, la dicono tutti, ma questa volta pronunciata
da chi e a chi ha il presente e il futuro della nazione in mano, ci può far ben
sperare…». All’analisi precisa, puntuale e, come sempre, garbata del garante,
che ha come filo conduttore il tempo, declinato sia come quello della pena che
va riempito di contenuti sia come urgenza ad intervenire, i detenuti si
scambiano parole di sconforto: «Il nostro tempo è vuoto… già! Un vuoto a
perdere… a perdere per noi e per la società… un tempo che dovrebbe mirare al
recupero sociale, ed invece l’ozio ci abbrutisce e ci rende peggiori…».
E quando il garante afferma:
«Il tempo è necessario e non va sprecato, perché è un regalo, un regalo che non
si conserva», alzano le braccia verso lo schermo annuendo. Sovraffollamento,
pandemia, emergenza sanitaria, cattiva informazione, immigrati, Rems, ergastolo
ostativo, misure alternative, provvedimenti da adottare sono i temi toccati
da Mauro Palma. Un esame approfondito della situazione reale, nel segno della
Costituzione dove – come è stato evidenziato – la parola «solidarietà» compare
già nel suo secondo articolo, mentre la parola «emergenza» non c’è e l’aggettivo
«eccezionale» è richiamato solo per contenere i poteri non per estenderli. Nella
stanza sempre più calda – ormai sono quasi le 12 e il sole è alto – gli otto
telespettatori condividono quelle parole: «La solidarietà la conosciamo solo tra
noi… e, a volte, la dobbiamo ricambiare… qua è tutta un’emergenza. Dicono “ti
mando al fresco” quando ti arrestano e il caldo ci uccide, nemmeno un
ventilatore ci danno, qui l’eccezione è la regola».
Dopo gli interventi degli
altri componenti l’Ufficio del garante, Daniela De Robert ed Emilia Rossi, gli
applausi dell’intera platea hanno sancito la fine della presentazione e, mentre
il pubblico in piedi attendeva l’uscita del Presidente della Repubblica, ecco
che il pensiero lascia Poggioreale e fa apparire sul palco uno degli otto
detenuti. «Scusate signori belli! Un minutino di attenzione… Innanzitutto voglio
ringraziare il Garante…una fotografia della situazione fedele e completa… le
cose da fare sono chiare … qui ci siete tutti, o quasi… ma comunque quelli che
possono contare… Noi contiamo solo gli annunci, le promesse non mantenute.
Dal 1948 ad oggi sono 74 anni che la Costituzione non entra in carcere;
dal 1975 ad oggi sono 47 anni che attendiamo l’applicazione concreta
dell’ordinamento penitenziario; dal 2013 ad oggi, sono 9 anni che la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha condannato il nostro Paese per palesi
violazioni di norme e per trattamenti inumani e degradanti e nulla, o comunque
poco, è stato fatto. Come ha detto il garante il tempo è importante e di tempo
ne è passato davvero tanto. I vostri applausi che stanno a significare?
Riempiamoli di contenuti, di fatti, di azioni seguendo la linea già tracciata e
indelebile della Costituzione». La sala si è ormai svuotata e un gentile
commesso mi riporta alla realtà. Tutti corrono, con o senza scorta, al lavoro
quotidiano. Vi sarà tempo per i detenuti?
Riccardo Polidoro
Carcere di Catanzaro poche
educatrici, nessuna speranza.
Francesco Iacopino e Dario
Gareri, Segretario e Vice-Presidente della Camera penale di Catanzaro e
Redazione su Il Riformista il 12 Agosto 2022
“Visitare i carcerati” non è
solo un’opera di misericordia, è un viaggio della speranza da infondere nei
luoghi dove rischiano di prevalere sfiducia e rassegnazione. In questa estate
dei suicidi che tra luglio e agosto hanno raggiunto numeri mai visti, Nessuno
tocchi Caino ha fatto visite negli istituti di pena calabresi e pugliesi. Altre
visite saranno effettuate nelle prossime settimane. Questa è la prima di tre
parti di un reportage dal carcere di Catanzaro che abbiamo visitato insieme alla
Camera penale il 18 luglio scorso. Catanzaro è la parte che ben descrive il
tutto di una realtà, quella carceraria, che a chi ha occhi per vedere e orecchie
per sentire sempre più appare fuori dal tempo e fuori dal mondo.
Il nostro viaggio nella
“realtà parallela” del carcere inizia in un caldo mattino di luglio. Dopo i
controlli di rito, accompagnati dal Direttore e dal Comandante, con Rita, Sergio
ed Elisabetta ci accingiamo a visitare le sezioni che compongono l’affollato
istituto penitenziario del capoluogo calabrese, intitolato all’Agente reggino
Ugo Alberto Caridi. All’ingresso, accanto alla statua della Vergine, è presente
una tomba in pietra molto curata, con la foto di Whisky, cagnolino dal pelo
fulvo che ha svolto il ruolo di mascotte dell’Istituto, prima di congedarsi
dalla vita.
Nel tunnel che ci catapulterà
nella monotona e soffocante quotidianità dei detenuti, ci concediamo una breve e
piacevole sosta in cucina. Saggiamo una gustosissima granita al caffè preparata
dal team di cuochi – tutti ristretti – guidato da F. V., ergastolano “ostativo”.
Con i suoi “Dolci cReati”, F. cerca ogni giorno di riscattare un passato
ingombrante e difficile, che a 19 anni lo ha costretto a caricarsi sulle spalle,
troppo presto, il peso di una vita che non aveva scelto e di scelte che non era
in grado di rifiutare, né aveva la maturità di affrontare. Dopo circa 30 anni di
soggiorno in carcere e un percorso serio e “sudato” di risocializzazione,
meriterebbe quel minimo di credito fiduciario che lo Stato è disposto ad
accordare a chi porta cicatrici profonde come le sue. Non è l’unico, in sosta a
Catanzaro, che ha creduto nella possibilità di un riscatto intramurario. Ma da
queste parti, come capiremo più avanti, di permessi premio è vietato parlare. Su
oltre 200 detenuti “ostativi” non se ne conta neppure uno, ci diranno
mezz’oretta dopo, nella litania delle “lamentele”, i detenuti dell’AS1.
Proseguendo il percorso
guidato, ci vengono incontro le poche educatrici in organico. Avvertono il
bisogno di denunciare la totale paralisi della loro attività e, soprattutto, di
trovare qualcuno disposto ad ascoltare il loro disperato grido di aiuto,
evidentemente troppo spesso infranto sui muri sordi dell’indifferenza. In fondo,
a quanti interessa sul serio la (ri)educazione dei carcerati? Su una popolazione
di circa 700 detenuti, in pianta organica si registrano appena 9 educatori. Di
fatto, operano in tre. Uno ogni 230. Anche un profano intuisce che in queste
condizioni è impossibile progettare un trattamento risocializzante. È già un
miracolo se si riescono a evadere le mansioni urgenti e basiche. Sono eroiche.
Hanno persino deciso di rinunciare alle ferie per evitare che in una realtà già
pesantemente rallentata da una burocrazia esasperante e pletorica, il loro
meritato riposo possa rendere ancora più pachidermica la inceppata macchina
istituzionale. È fin troppo chiaro che lo Stato, almeno qui, ha rinunciato alla
propria opera di reinserimento sociale dei detenuti. Come se il risultato della
“partita trattamentale” non producesse effetti fuori dal recinto di giuoco. Un
finto risparmio. Che solo una ostinata cecità e una colpevole indifferenza
possono calcolare.
Se si perde la sfida del
“trattamento”, concependo il carcere come discarica sociale, si differisce il
“conto” solo al check-out. E si paga due volte. Perché chi è abbandonato alla
sua solitudine, ci insegnano la storia e la statistica, quando uscirà, non solo
sarà più esposto alla recidiva e, quindi, a commettere nuovi reati (con
inevitabile costo individuale e sociale) ma si ripresenterà, con elevata
probabilità, al check-in di un nuovo istituto di pena (con ulteriore costo umano
ed economico, visto che lo Stato spende 140 euro al giorno a detenuto),
alimentando brutalmente il circuito vizioso. Giungiamo, finalmente, all’ultimo
piano, e inizia il nostro giro. Siamo al vertice dell’Alta Sicurezza, la
cosiddetta AS1, nella sezione del “fine pena mai” dedicata agli ergastolani e ai
detenuti ritenuti più pericolosi, dagli ex 41bis ai promotori delle associazioni
criminali. Qui non esiste la “pena di morte”, ma si conosce bene il significato
della “morte per pena”.
Non è possibile sintetizzare
le successive 5 ore di intensi colloqui, affrontati attraversando anche la “AS3”
e la Media Sicurezza (“MS”), ma alcune disfunzioni sono emerse in modo
prorompente.
Francesco Iacopino e Dario
Gareri, Segretario e Vice-Presidente della Camera penale di Catanzaro
L’inferno del carcere di
Catanzaro, zero permessi premio ai detenuti: lasciate ogni speranza voi che
entrate!
Dario Gareri, Francesco Iacopino su Il Riformista il 19 Agosto 2022
Questa è la seconda di tre
parti di un reportage dal carcere di Catanzaro che Nessuno tocchi Caino ha
visitato insieme alla Camera penale il 18 luglio scorso. La prima puntata è
stata pubblicata sul Riformista del 12 agosto.
All’ultimo piano, al vertice
dell’Alta Sicurezza, inizia il nostro giro. Con lucidità di analisi, ci vengono
segnalate le aree critiche del carcere. All’apice si pone l’area sanitaria,
seguita da quella lavorativa. Ma, ancor prima, in emersione sono posti i
(difficili) rapporti con il locale Ufficio di Sorveglianza, particolarmente per
i detenuti per reati “ostativi”. Di certo, per tali categorie di ristretti,
dalla biografia penale ingombrante, è molto difficile il contemperamento tra le
esigenze di difesa sociale e il rispetto dei diritti individuali. Lo comprendono
anche i “residenti” al piano. Ma, aggiungono, si fa fatica ad accettare alcuni
processi decisionali, poco decifrabili al di fuori di una logica di rigore.
Dopo la sentenza
‘Viola’ dei Giudici di Strasburgo e l’intervento della Corte
Costituzionale, nulla è cambiato. Su 200 detenuti “ostativi”, nessuno è riuscito
a ottenere un permesso premio. Neppure uno che si sia affacciato a quella
finestra sulla speranza che non ammette “aprioristiche” chiusure ed è la base
giustificativa dei moniti europei. Eppure non mancano, proprio a Catanzaro,
esperienze serie e feconde di percorsi trattamentali “meritevoli” di un minimo
credito fiduciario. E, in assenza dei protagonisti, ci vengono segnalate almeno
due esperienze innegabilmente feconde. È il caso di F.V., cuoco e autore del
libro “Dolci cReati”, presentato in carcere alla presenza di tutte le autorità
civili e religiose, capace di disegnare un’iniziativa imprenditoriale che si
spera, a breve, possa prender corpo. E anche quello di S.F., laureato in
sociologia con il massimo dei voti grazie anche alla guida sapiente e illuminata
del Prof. Charlie Barnao.
Sono esperienze che
testimoniano plasticamente come, proprio lì dentro, con costanza e tanta forza
di volontà, cambiare è possibile. Che anche la notte più buia è attesa dalle
prime luci dell’alba. Esperienze che, nondimeno, non sono ancora riuscite a
guadagnare un “affaccio” sul davanzale della vita, anche solo per il tempo di un
permesso. Niente “premi”. Eppure, ci pare evidente che proprio l’agognato
“permesso” permetterebbe a F.V. e a S.F. di mettere alla prova la loro scelta di
archiviare un passato ingombrante, di scrivere un’altra storia sulle pagine
ancora intonse del libro della vita. Di dimostrare che il desiderio di riscatto
non è una chimera. Che a 50 anni, 30 dei quali vissuti in carcere, dopo essersi
riconciliati con se stessi e con le ferite rimarginate della società, si può (si
deve) sognare e segnare un percorso diverso, tracciare un solco positivo,
diventare seminatori di speranza, coltivare la passione per il bene possibile,
per un mondo migliore possibile e così riscattare il male commesso. Che, in
fondo, la mission e la vision dei nostri padri costituenti non è un’utopia.
Quale grande iniezione di
fiducia sarebbe il loro definitivo “successo”, la loro riuscita, per tutti gli
altri ancora imprigionati nella rete della rassegnazione. Per quelli che non
credono che la ruota del destino possa davvero cambiare direzione. Che esiste
anche per loro, ciascuno per nome, la chiamata a giocare la partita di un vero
riscatto. Ci vuole tanta visione umanistica e tanto coraggio! Proseguendo il
viaggio, raccogliamo storie di trattamenti che appaiono, non solo ai detenuti,
contrari al senso di umanità. È il caso di B.M. Nel giugno 2021 ha chiesto un
permesso (consentito dall’art. 30 O.P.) per far visita al papà in “imminente”
pericolo di vita. Permesso negato. Non è facile misurare lo spazio di
applicazione dell’aggettivo. E così, mentre la semantica pone geometricamente un
argine all’accoglimento dell’istanza, il papà, in appena due giorni, si congeda
dalla vita. Senza quel saluto. L’ultimo.
Analoga storia per il detenuto
C., e altri come lui, che lamentano di essere stati autorizzati solo all’uso di
videochiamate. Di fronte alla più terribile delle prove, il fine vita di un
familiare o di un convivente, il formante giurisprudenziale ha istituito la
visita all’infermo “da remoto”, così inserendo nel catalogo dei prodotti
virtuali anche il sentimento della pietà. O, ancora, la drammatica vicenda di
M.C., classe 1980. Per lunghi e interminabili giorni ha accusato dolori e
febbre. Raccontano i compagni di piano che avrebbe chiesto, inutilmente, di
essere ricoverato in ospedale. Chi doveva assumere decisioni, ci dicono, era
convinto che M.C. simulasse il proprio dolore. Dopo 15 giorni ci finirà in
ospedale. Ma con una setticemia che, in brevissimo tempo, gli presenterà il
conto della vita. Aveva solo 41 anni. Lascia una giovane famiglia aggrappata
alle lacrime di una perdita senza senso. È umano tutto ciò?
*Segretario e
Vice-Presidente della Camera penale di Catanzaro
La terza parte.
Inferno Catanzaro, nel carcere è vietato ammalarsi di notte: mancano medici,
farmaci e la riabilitazione non funziona.
Francesco Iacopino, Dario
Gareri, Segretario e Vice-Presidente della Camera penale di Catanzaro, su Il
Riformista il 26 Agosto 2022
Questa è la terza di tre parti di un reportage
dal carcere di Catanzaro che Nessuno tocchi Caino ha visitato insieme alla
Camera penale il 18 luglio scorso. La prime due puntate sono state pubblicate
sul Riformista del 12 e del 19 agosto.
L’area più critica del carcere è
quella Sanitaria. Manca il medico notturno, nonostante vi siano pazienti che
richiedono assistenza continua perché affetti da gravi patologie. Straziante il
caso di L.I., malato di cirrosi epatica. Una notte ha accusato dolori
lancinanti, che lo hanno portato a contorcersi e a piangere per ore, fin quando
non è giunta la guardia medica, dall’esterno, che ne ha disposto il ricovero.
Oltre al personale, mancano anche i farmaci.
Chi può, li compra da sé. Chi è povero, non ha diritto di ammalarsi. La salute,
da queste parti, non è un lusso che si possono concedere tutti. E poi, in fondo,
il cuore del problema: chi è disposto a indossare il camice in carcere?
I posti ci sono. Ma restano vacanti. Eppure,
sulla carta, Catanzaro è considerato un centro clinico nel quale si
trasferiscono i malati gravi. Sulla carta. Nella sostanza non funziona. E non
solo per mancanza di medici. E così, i viaggi della speranza si trasformano in
gironi infernali, con l’aggravante di aumentare il carico di un’area già al
collasso. L’Istituto è anche accreditato per l’attività riabilitativo-motoria.
Tra le dotazioni, una piscina e una sala per la ginnastica. Peccato, però, che
la piscina non ha mai funzionato e nella sala riabilitazione vi sono una pedana
e pochi attrezzi ammassati in un angolo. Morale: i detenuti vagano per la
sezione con le stampelle o con la sedia a rotelle, increduli rispetto a un
destino doppiamente beffardo.
Quando affrontiamo il tema, si leggono sul
viso del Direttore lo sconforto e la rassegnazione. Nonostante il suo
temperamento forte e la grande passione che infonde nel proprio lavoro, nota a
tutti, ammette di non accettare più detenuti che necessitino di cure h/24 perché
l’istituto non è (più) in grado di assicurare assistenza sanitaria continua. La
situazione di disagio non muta nell’area lavoro, nella quale la mancanza di
fondi si riflette sulle retribuzioni, poche e inadeguate. Parlare di paga
proporzionata alla qualità e quantità di lavoro prestato è un’offesa
alla Costituzione. In fondo, è vero che i salari sono (più) bassi, ma siamo pur
sempre in intramoenia.
Man mano che il livello di sicurezza si
“abbassa”, dall’AS1 all’AS3, aumenta il numero di detenuti per cella. In AS3, al
4° Piano, sono in 3. Chiedono che le porte siano aperte di giorno, per
combattere il caldo nei pochi metri quadrati ove si fa fatica perfino a
rigirarsi. Al terzo piano, mentre l’ala sinistra è stata ristrutturata, quella a
destra è composta da celle vetuste, senza docce e senza acqua calda. Puoi
mitigare il rigore dell’acqua fredda, utilizzando le docce in comune. E specie
in autunno e in inverno, è opzione inevitabile. Il quadro non migliora nella
media sicurezza, dove colpisce la natura multirazziale e multiproblematica dei
residenti. Oltre alla loro povertà. Una suora tenace usa la leva del
volontariato per contenere gli ulteriori effetti desocializzanti prodotti dalla
miseria.
Il dato che molti di loro siano
extracomunitari e tossicodipendenti, ci rafforza nella convinzione che il
carcere, per tali categorie di soggetti, i disperati del nostro tempo, è sempre
di più concepito quale pattumiera sociale. Altro che finestra di speranza sulla
vita. Per non parlare della mancanza degli spazi ‘minimi’ indicati
dalla sentenza Torreggiani. Una convinzione che diventa certezza quando, dalle
periferie esistenziali, scopriamo che un piano è dedicato ai malati
psichiatrici. Un grande giurista del secolo scorso, riflettendo sul tema,
affermava causticamente che “nella nostra allegra Repubblica i pazzi li hanno
aboliti per Legge”. Aveva ragione. Come se la malattia mentale e la
tossicodipendenza possano trovare rimedio restringendo gli spazi di libertà.
Soldi spesi male, che non curano le ferite, né quelle del corpo né quelle
dell’anima, e non promettono prospettive di sicurezza futura. Ma per lo Stato va
bene così.
Al termine del viaggio, rimane l’amarezza di
un mondo pieno di potenzialità, di persone che sarebbero ben disposte a
combattere la lotta col proprio destino, a mettercela tutta sulla via del
riscatto, ma con le armi spuntate. Nessuno, pur volenteroso, può pensare di
vincere da solo una battaglia così impegnativa. Siamo ancora lontani dal
percorso di reinserimento sociale disegnato nella nostra Magna Charta. Aveva
ragione Voltaire nel dire “non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre
carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una Nazione”. La
nostra, nonostante gli sforzi dei naviganti, sulla rotta della civiltà veleggia
ancora in alto mare. Francesco Iacopino, Dario Gareri, Segretario e
Vice-Presidente della Camera penale di Catanzaro
Viaggio nel penitenziario napoletano. Io, giudice e quel giorno a Poggioreale:
vedere il carcere ci rende meno ignoranti verso il dramma dei detenuti.
Eduardo Savarese su Il Riformista il 24 Agosto 2022
Fino a
quando non si entra e non ci si trattiene del tempo dentro l’istituzione
carceraria, è difficile comprendere effettivamente di cosa si parla quando si
parla della condizione di vita in essa. Tanto più nella realtà italiana,
vergogna che si perpetua nella più cinica indifferenza generale. Tanto più
in Campania, e a Napoli, nel carcere cittadino di Poggioreale. Per questo in
carcere bisogna entrarci, bisogna visitare i carcerati (a poca distanza da
Poggioreale riposa la visione di misericordia dipinta per Napoli da Caravaggio:
tra le opere di misericordia c’è anche quella), per questo bisogna pretenderlo
dagli uomini che rappresentano le istituzioni, non solo giudiziarie, e che
esercitano pubblici poteri.
A
dicembre 2018, la giunta dell’Associazione Nazionale Magistrati di
Napoli organizzò appunto una “visita” dentro gli spazi
di Poggioreale. Attraversammo i corridoi, ci affacciamo o entrammo dentro le
celle. In alcuni reparti c’era la possibilità per i detenuti di passeggiare per
un certo tempo al di fuori delle singole celle, che rimanevano aperte. Demmo
un’occhiata al padiglione dove scontavano la pena le persone transgender.
Siccome si era sotto Natale, per qualche minuto assistemmo alle prove per la
recita che detenuti e operatori sociali stavano mettendo su. A ogni passo si
respirava dolore, un peso indefinito, ma terribile, gravava addosso a noi,
magistrati in visita.
Un’operatrice disse che quelle prove teatrali le stavano tenendo soprattutto
i detenuti tossicodipendenti. Aggiunse che era una fatica quasi insostenibile,
quella condizione duplice di carcerazione: la detenzione per esecuzione della
pena e l’essere ostaggio della dipendenza da droghe o alcool. Non mi dilungo su
una visita che andrebbe prescritta come medicina socio-politica ineludibile
almeno una volta all’anno a beneficio di molte altre espressioni della classe
dirigente cittadina, non solo della magistratura, ovviamente coinvolta in
maniera diretta nell’istituzione penitenziaria.
Quel che
tentai dopo qualche settimana, fu però un’esperienza di volontariato in carcere,
e ne feci cenno a un caro amico, eccellente magistrato di sorveglianza, Marco
Puglia (che, tra le altre cose, del teatro coi detenuti ha fatto un’esperienza
umana rara e preziosa). Volli cioè fare ingresso in carcere non certo nella
veste di magistrato, ma come scrittore, per tenere qualche laboratorio di
scrittura creativa. Era la primavera del 2019. Incontrai una direttrice contenta
e disponibile e così, in jeans e camicia, feci il mio ingresso nel padiglione
dei detenuti omosessuali. Il primo e l’ultimo ingresso. E non certo a causa dei
detenuti, che erano affascinati, ma anche straniti dal fatto che un magistrato
facesse lì il volontario, per scrivere, o meglio per farli scrivere liberamente
di sé. In quell’occasione ognuno scrisse di chi e cosa gli mancava stando in
cella. Come sempre, quando la scrittura è autentica, leggemmo insieme cose piene
di vita, colme di verità.
Una cosa
per un detenuto in particolare fu pressante: raccontarmi la condizione bestiale
in cui erano costretti a vivere. Mi fecero vedere le macchie verdi di umidità
alle pareti, anche nello stanzino che ci diedero a disposizione per il
laboratorio. Mi spiegarono il freddo che pativano. Mi chiesero perché non
ottenevano risposta alle loro richieste. Per me fu troppo: essere gettato (in
senso esistenzialista) in quella condizione all’improvviso, senza la presenza di
un assistente sociale, di un intermediario dell’istituzione, e dover rivestire i
panni incoerenti di uno che era parte dell’istituzione, in qualche modo, e che
però andava lì a fare il volontario e l’artista, non seppi gestirlo. Non ci
tornai più. Probabilmente il lunedì successivo mi attesero. Mi è rimasto un
senso di colpa importante per quella sorta di abbandono. E spero che, prima o
poi, troverò il modo di recuperare.
Di certo
non ho dimenticato quei volti, quelle storie, quelle espressioni, e anche quella
breve gioia di poter prendere la penna e scrivere, anche solo per esprimere un
momento di nostalgia nell’invenzione. Non sono mai stato magistrato di
sorveglianza. Non ho mai approfondito i grandi temi strutturali dell’istituzione
carceraria. Non saprei elaborare metodi e soluzioni. Posso solo dire che almeno
la gelida patina di indifferenza e ignoranza che scende sui nostri sguardi
quando si tratta della condizione dei detenuti, almeno quella abbiamo il dovere
e il potere di rimuoverla. Per vedere, ascoltare, comprendere. Quanto meno per
non smettere di “visitare”. Eduardo Savarese
Un contenitore che
marcisce. Così è il carcere bollente in estate.
ISABELLA DE SILVESTRO su Il
Domani il 21 agosto 2022
Oltre alle zanzare, nelle
celle dilagano blatte e acari. I detenuti vengono colpiti dalla scabbia, docce e
ventilatori sono pochissimi. A Milano e Napoli si sono verificate proteste, il
caldo straziante aumenta anche i casi di suicidio.
Aprire le finestre serve a
poco: le strutture carcerarie, vecchie e fatiscenti, moltiplicano l’afa estiva.
L’aria è stantia, l’umidità imperversa e gli odori ristagnano. Le alte
temperature associate ad elevati valori di umidità favoriscono il diffondersi di
muffe e acari.
Anche la doccia è un lusso per
la maggioranza dei detenuti: il 58 per cento delle celle nelle galere italiane
ne è privo, malgrado il regolamento del 2000 desse tempo cinque anni al sistema
carcerario per dotare di docce tutte le celle delle strutture penitenziarie. A
Opera una sezione di 54 persone dispone di quattro docce, una delle quali è
rotta. Le pareti circostanti sono ricoperte di muffa.
Entrare in un carcere ad
agosto è un’esperienza straniante. I lunghi corridoi in genere trafficati
appaiono spogli e silenziosi. Gli agenti penitenziari sono avvolti da una nuvola
di sopore, qualcuno sonnecchia sulla sedia, qualcun altro ascolta la radio per
tenersi sveglio. L’impressione generale è che la svogliatezza e l’incuria,
quelle che incombono sugli ambienti carcerari durante tutto l’anno, ad agosto
prendano definitivamente il sopravvento.
La scuola carceraria durante
la pausa estiva è utilizzata dai pochi detenuti iscritti all’università che
nelle ore del mattino possono occupare le aule per preparare gli esami della
sessione estiva. La temperatura delle aule-celle è infernale, il silenzio è
spezzato dal ticchettio incessante delle infiltrazioni che sgocciolano sui
banchi e sul pavimento, scrostano le pareti e rendono irrespirabile l’aria.
Tra parassiti e cibo marcio
Aprire le finestre serve a
poco: le strutture carcerarie, vecchie e fatiscenti, moltiplicano l’afa estiva.
L’aria è stantia, l’umidità imperversa e gli odori ristagnano. Le alte
temperature associate ad elevati valori di umidità favoriscono il diffondersi di
muffe e acari. Tra i detenuti sono molti i casi di scabbia. Si ha l’impressione
di stare dentro un contenitore che marcisce a vista d’occhio. Un detenuto mostra
la pelle arrossata da strane punture su tutto il corpo. Oltre alle zanzare, in
parecchie celle dilagano le blatte.
Il cibo inviato dalle
famiglie, in mancanza di un numero sufficiente di frigoriferi, si guasta
velocemente e deve essere buttato. Nelle cosiddette “stanze di pernottamento” si
suda in due, in quattro, in sei, uno sopra l’altro, stipati, col naso a pochi
centimetri dalla branda superiore o dal soffitto.
Nel carcere milanese di Opera
nelle scorse settimane i detenuti hanno protestato battendo pentole e stoviglie
contro le sbarre delle celle. Chiedevano ventilatori. L’amministrazione ha
risposto mettendo in funzione due ventilatori in corridoio per l’intera sezione.
Una protesta simile è avvenuta a Napoli il 7 giugno scorso: fuori dal
penitenziario di Poggioreale i familiari dei detenuti insieme agli attivisti
hanno manifestato per denunciare le misere condizioni di vita in una delle
carceri più sovraffollate del paese, dove sono ospitati 700 detenuti in più
rispetto alla capienza regolamentare: 2.200 anziché 1.500, in pratica il 50 per
cento in più.
In galera l’estate è la
stagione più dura e, nonostante il livello di malessere dipenda dalla struttura
del carcere, dallo spessore delle mura e dalla posizione, il disagio riguarda
tutti i penitenziari.
MATERASSI BAGNATI
Racconta un detenuto: «Sulla
mia cella batte il sole fino a sera. Per riuscire ad addormentarmi mi stendo sul
pavimento. Dopo un paio d’ore mi sveglio per il mal di schiena e mi trasferisco
sulla brandina, dove sudo fino a bagnare addirittura il materasso. In sezione
non ci sono lavatrici e ogni giorno laviamo a mano le lenzuola fradice di
sudore».
Le celle delle prigioni
italiane sono stanzini incandescenti dove le temperature possono raggiungere i
40 gradi. Ottenere un ventilatore è quasi impossibile. Il Dap (Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria) ha permesso alle amministrazioni carcerarie
di metterli in vendita, ma con molte limitazioni: le pale rotanti sono
considerate pericolose e si prediligono i ventilatori a batteria dal momento che
spesso nelle celle mancano le prese di corrente e, quando ci sono, si teme un
sovraccarico dell’impianto elettrico.
Così solo un’esigua minoranza
ottiene un minimo di sollievo dall’aria mossa da un ventilatore. Il resto della
popolazione detenuta è condannato a rigirarsi nel letto senza riuscire a
prendere sonno nell’afa soffocante. La situazione è tragica soprattutto per chi
abita le celle che hanno da una parte finestre schermate da fittissime grate che
impediscono quasi del tutto il passaggio d’aria, dall’altra la chiusura ermetica
delle porte blindate.
NON C’È ACQUA
Anche la doccia è un lusso per
la maggioranza dei detenuti: il 58 per cento delle celle nelle galere italiane
ne è privo, malgrado il regolamento del 2000 desse tempo cinque anni al sistema
carcerario per dotare di docce tutte le celle delle strutture penitenziarie. A
Opera una sezione di 54 persone dispone di quattro docce, una delle quali è
rotta. Le pareti circostanti sono ricoperte di muffa.
Ma c’è di peggio. In diverse
carceri manca direttamente l’acqua. Come a Santa Maria Capua Vetere, dove la
struttura penitenziaria non è collegata alla rete idrica comunale e si è
affrontato il problema consegnando a ogni detenuto quattro bottiglie d’acqua al
giorno. In altre galere l’acqua è razionata.
Non si tratta di una misura
legata alla siccità straordinaria di quest’anno, ma di una situazione che si
ripresenta ogni estate, senza che le amministrazioni intervengano in maniera
organica con misure risolutive. Mancano i fondi per ristrutturazioni e bonifiche
urgenti e si procede mettendo toppe su strutture che, anche se il modo di dire
suona beffardo, fanno acqua da tutte le parti.
PASSEGGIO SOFFOCANTE
Nei regimi a celle chiuse,
dove si è condannati a passare venti ore al giorno sulla propria branda, l’unico
momento di respiro è rappresentato dal passeggio. Ma i cortili di cemento, su
cui è concesso camminare per un paio d’ore la mattina e un altro paio subito
dopo pranzo, più che un sollievo assomigliano a una forma di tortura
supplementare. Niente prati a smorzare il riverbero del caldo o alberi sotto la
cui ombra ci si possa riparare.
Alcuni detenuti passeggiano a
petto nudo, bagnandosi di tanto in tanto con una bottiglietta d’acqua per
resistere al caldo. I carcerati più anziani sono spesso costretti a rinunciare
all’unica attività fuori dalla cella perché il sole delle due del pomeriggio
risulterebbe per loro insostenibile.
L’agosto in galera è un tempo
speso a boccheggiare, augurandosi che passi in fretta. Tutte le attività che
alleviano la monotonia e l’angoscia della detenzione cessano. La scuola è
chiusa, i laboratori e i seminari sono sospesi e sono pochissimi i volontari che
attraversano le porte blindate delle strutture per raggiungere i detenuti. Chi
lo fa è deriso più o meno benevolmente dalle guardie che non si stufano di
chiedere se in agosto il malcapitato non abbia di meglio da fare che entrare in
galera per il suo volontariato.
PIÙ VIOLENZE
La mancanza di stimoli e di
relazioni con gli esterni, insieme alle temperature infernali e all’insalubrità
dell’ambiente, alimentano tensioni e disordini fra i detenuti. In estate si
registra una crescita di eventi critici come risse e violenze, chiaramente
collegati all’acuirsi dei sintomi di depressione e ansia.
Secondo gli ultimi dati del
Consiglio d’Europa l’Italia si colloca al decimo posto tra i paesi con il più
alto tasso di suicidi in carcere, dove l’incidenza del suicidio è 16 volte più
alta che fuori. Quest’anno si sono già tolte la vita 39 persone detenute, una
cifra che non si raggiungeva da oltre un decennio, e gli episodi di
autolesionismo sono all’ordine del giorno.
La pena è inflitta anche ai
visitatori, perlopiù parenti dei detenuti, che in molti casi si vedono costretti
ad attendere per ore sotto il sole il turno del colloquio. Le file con genitori
anziani, bambini ancora in fasce o donne incinte prese a sventolare ventagli ed
asciugarsi il sudore descrivono un malfunzionamento e un’ingiustizia verso
persone innocenti che, se durante l’anno è grave, d’estate si fa insopportabile
nella sua insensatezza.
L’estate carceraria è insomma
l’inferno dell’inferno. Il caldo non fa che esasperare problematiche antiche che
vengono aggirate da decenni e per le quali non è sufficiente qualche intervento
sporadico: sovraffollamento, strutture fatiscenti, lungaggini burocratiche,
mancato rispetto dei diritti e della dignità delle persone detenute e
insufficienza di attività rieducative. Tutte cose che con la calura di
Ferragosto si vedono molto meglio.
ISABELLA DE SILVESTRO.
Giornalista freelance, classe 1997. Scrive di diritti umani, cultura e sociale.
Ha vissuto in Colombia, Germania e Inghilterra per poi tornare in Italia, dove
ha conseguito la laurea in Storia.
Dario Gareri, Francesco
Iacopino. Il disinteresse della politica per le carceri.
“Siamo cani in un canile”, la
parole di Cagliari prima di uccidersi: cari politici andate nelle carceri.
Tiziana Maiolo su Il Riformista il 19 Agosto 2022
Dopo l’appello e l’inizio del
digiuno di Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, che tra l’altro
si rivolge ai partiti perché inseriscano nel proprio programma di governo sia
riforme sull’esecuzione penale e sull’ergastolo ostativo, ma
anche amnistia e indulto, ci piace immaginare che ci sarà una gara a chi
arriverà primo, tra sinistra, centrodestra e terzo polo.
Primo a gridare che la
situazione della giustizia e del carcere con i suoi suicidi è uno scandalo, e
che risolvere questo scandalo è il primo punto di un programma di governo su cui
il 25 settembre si chiederanno i voti ai cittadini. Così come vorremmo veder
passare davanti ai nostri occhi la lunga fila di deputati e senatori che in
questi giorni affollano gli ingressi delle carceri dove 53, dicasi cinquantatré
(se non sono aumentati mentre scriviamo) esseri umani, cioè persone, donne e
uomini, hanno detto semplicemente “basta”. Si sono uccisi. Gesto di ribellione
nei confronti dello Stato che, dopo aver preso in consegna i loro corpi, non ha
saputo averne cura, anzi ha pensato bene di sopprimerli. Così il problema non
esiste.
I rappresentanti delle
istituzioni sono autorizzati dall’ordinamento penitenziario nato dalla riforma
carceraria del 1975 a visitare gli istituti di pena senza particolari
autorizzazioni, per verificare le condizioni di vita e di salute sia dei
prigionieri che degli agenti di polizia penitenziaria. Sono autorizzati, ma in
genere non lo fanno. L’argomento non interessa, semplicemente. Anche coloro che
si occupano di giustizia e che si appassionano al processo penale, ritengono il
momento della condanna definitiva il punto terminale dell’amministrazione della
giustizia. Tutto quel che succede dopo, e che è la conseguenza che separa la
buona dalla cattiva giustizia, non li riguarda più. Il parlamentare in genere si
risveglia di soprassalto solo quando capita che finisca in galera un suo amico o
compagno di partito.
Ecco allora che ci si ricorda
di quell’articolo 57 dell’ordinamento, e si scopre che esiste la custodia
cautelare come privazione della libertà personale prima del processo, e il
sovraffollamento e l’invivibilità dell’istituzione totale. Ma pochissimi sono i
deputati e i senatori che sanno, che hanno visto e toccato con mano che cosa è
quel luogo che tiene prigionieri i corpi e distrugge le persone. Quando – e sono
ormai passati quasi vent’anni- il presidente dell’Eni Gabriele Cagliari nelle
lettere scritte prima di togliersi la vita diceva ”siamo cani in un canile”, non
parlava solo di sé e della propria sciagurata situazione processuale. Voleva
dire, e a qualcuno lo aveva anche spiegato nel dettaglio, che la separatezza del
luogo dalla società comportava anche il disinteresse delle istituzioni nei loro
confronti.
Non è un caso che, nei giorni
in cui San Vittore era pieno di politici arrestati nelle inchieste
di Tangentopoli, rinchiusi tutti nel medesimo raggio, lui, pur potendolo fare,
aveva rifiutato di andare nel luogo “privilegiato”, meta delle visite di tanti
parlamentari. Lui aveva voluto toccare con mano la realtà vera, vi si era
immerso, aveva vissuto insieme a lui la sorte di quel ragazzo del Ghana che, in
un processo celebrato senza interprete, aveva beccato dieci anni di condanna in
dieci minuti. I problemi di quel 1993 erano gli stessi di oggi. Il
sovraffollamento che, come dice Rita Bernardini, vuol dire illegalità, e
l’abbandono, il disinteresse.
Eppure, a partire dagli
operatori penitenziari, dal medico allo psicologo fino all’educatore, e poi i
direttori e i giudici di sorveglianza, fino ad arrivare al neo-direttore del
Dap Carlo Renoldi e alla ministra Marta Cartabia, quante persone per bene e di
buon cuore ci sono a occuparsi della vita e della morte dei detenuti? Tante.
Tante persone per bene e di buon cuore. Pure, non se ne esce. Quel che
diceva Cagliari vent’anni fa è ancora lì, cani in un canile. E in 53,
dall’inizio dell’anno, hanno detto basta. Il più giovane, 25anni, incensurato,
ha usato il sacchetto di plastica, proprio come quell’antico presidente
dell’Eni, poi si è rannicchiato sotto le coperte e ha chiuso gli occhi.
Dove sono i leader
politici, di destra sinistra e centro, mentre si sta consumando questa strage?
Dove sono i direttori dei grandi giornali e i famosi editorialisti? Ce ne fosse
almeno uno pronto a dire che si vergogna perché ha lasciato sola Rita
Bernardini con il suo digiuno. Che è pieno di rossore perché, pur sapendo che
“una telefonata allunga la vita” non ha strillato perché un po’ di umanità non
entri dalla porta principale delle carceri, perché un po’ di giustizia non entri
nei tribunali, perché un grosso faro vada a illuminare questo mondo dove non si
curano i malati psichici, non si aiutano i tossicodipendenti, non si contano
gli atti di autolesionismo e i tentati suicidi, oltre a quelli realizzati. E
cavolo, deputati e senatori, uscite un attimo dai vari cerchi magici dove state
sbavando per la candidatura e girate gli occhi a guardare il mondo. È mondo
anche quello, sapete? E un giorno potrebbe togliervi il consenso, persino il
voto.
Tiziana Maiolo. Politica e
giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e
XIII legislatura.
La crisi delle prigioni.
Finché c’è il carcere non ci sarà giustizia, serve una rivoluzione copernicana.
Tiziana
Maiolo su Il Riformista il 22 Giugno 2022.
Un buffetto di incoraggiamento
arriva all’Italia da Strasburgo appena poche ore dopo che uno sconsolato Garante
per le persone private della libertà Mauro Palma lascia l’incarico dopo sette
anni lanciando l’ennesimo allarme sul carcere e il permanente
tragico sovraffollamento. L’Italia, dice il Consiglio d’Europa, è uno dei sette
Paesi che hanno registrato un “aumento significativo” dell’uso della libertà
vigilata. La misura di sicurezza è infatti aumentata del 6% tra il 2020 e
il 2021, tanto che al 31 dicembre scorso il numero di persone sottoposte a
libertà vigilata (93.415) superava di 40.000 unità il numero dei detenuti. Il
dato è derivato dalla ricerca “Space II” condotta ogni anno dall’Università di
Losanna sulle misure alternative al carcere adottate dagli Stati membri del
Consiglio d’Europa.
Numeri che, presi in sé,
paiono davvero confortanti. Anche se poi la stessa ricerca osserva che tra
il 2019 e il 2020 l’aumento del ricorso alla libertà vigilata era stato del 10%.
E anche se occorre ricordare che stiamo parlando dei due anni appena trascorsi,
che sono stati un periodo veramente anomalo per tutti, cittadini liberi o
detenuti. L’emergenza per l’epidemia da Covid è stata affrontata in modo sensato
prima di tutto dal procuratore generale della cassazione Salvi, che aveva
invitato i magistrati ad arrestare di meno, e poi dallo stesso ministro della
giustizia Bonafede con il progetto “Cura Italia”, e infine dal capo del
Dap Basentini con la famosa circolare in cui sollecitava la sospensione
dell’espiazione della pena per detenuti anziani o malati, provvedimento che alla
fine gli costerà il posto. E poi la situazione è cambiata e si è tornati ai
numeri precedenti. Tutto quel che è accaduto nel biennio che sta alle nostre
spalle va dunque letto e riletto senza gli occhiali dell’emergenza. Facendo però
anche una semplice constatazione: se Salvi, se l’attuale ministro della
giustizia, se l’attuale capo del Dap rendessero permanenti quegli allarmi e
soprattutto quel modo di ragionare, i numeri delle persone recluse sarebbero ben
diversi.
Sempre che sia poi così
rilevante stare attaccati a numeri e percentuali per valutare che cosa è
il carcere oggi. Perché bisognerebbe prima di tutto afferrare il bandolo da cui
parte il filo rosso che percorre le vite delle persone cui viene tolta la
libertà. Parliamo della giustizia e del processo, che sono la nuova violenza di
Stato, quella che ha preso il posto
della tortura, dello squartamento, della pena di morte. È un problema culturale.
Nessuno, o quasi, oggi potrebbe dirsi d’accordo sull’amministrazione della
giustizia come veniva esercitata nel seicento, così come sulle pene corporali o
sulla schiavitù. Però, se alle stesse persone chiediamo di pronunciarsi
sull’abolizione dell’ergastolo, e prima di tutto su quello
cosiddetto “ostativo”, cioè quello che impedisce a determinati soggetti di
fruire dell’applicazione di misure alternative, ecco che sotto sotto vedremmo
rispuntare quel desiderio di chiudere la cella e buttare la chiave che è poi la
cultura del “monopolio del carcere” come applicazione prevalente se non unica
della pena.
Ma aiutiamoci ancora con i
numeri per constatare come questa cultura del “monopolio del carcere” sia quella
prevalente nel corpo della magistratura. L’ostilità da parte dei dirigenti
sindacali delle toghe nei confronti di un quesito referendario che cercava di
porre limiti alla custodia cautelare. E la constatazione, rilevata dai dati
forniti due giorni fa dal Garante, che un terzo della popolazione carceraria è
tuttora composta da persone non ancora processate e innocenti secondo
la Costituzione. Due elementi espliciti di questa mentalità, che esplode ogni
volta in cui, davanti a clamorose assoluzioni, ascoltiamo l’ipocrita lamento di
chi chiede le scuse degli avversari politici. Ma la questione non riguarda gli
innocenti e i colpevoli. Riguarda il diritto all’integrità del proprio corpo, al
suo bisogno di essere libero. Soprattutto in assenza di condanna.
Ha qualche senso il fatto che
ci siano in questo momento nelle prigioni italiane 1.319 persone che sono
rinchiuse perché condannate a una pena inferiore a un anno e altre 2.473 a meno
di due? Mauro Palma nella sua relazione ha giustamente definito
“superfluo…chiedersi quale possa essere stato il reato commesso che il giudice
ha ritenuto meritevole di una pena detentiva di durata così contenuta”.
È vero, perché quel che conta
è il fatto che il giudice che ha preso la decisione sa perfettamente che quei
pochi mesi di prigionia non potranno che cambiare in peggio la vita di quel
condannato, destinato non certo alla rieducazione prevista
dalla Costituzione. Ma nel migliore dei casi destinato alla noia, alla perdita
di minuti, ore e giorni che una misura alternativa al carcere avrebbe potuto far
utilizzare in modo migliore. Per non parlare dei famosi “residui di pena”.
Parliamo di persone perfettamente reinserite nella società e nel mondo del
lavoro, chiamate improvvisamente, nel momento in cui una sentenza diviene
definitiva o viene perfezionato un ricalcolo, a consegnarsi a un cancello che si
apre su un mondo separato, che non è più violento in senso letterale, ma
violento nella sua inutilità e nocività.
Ecco perché i dati sul
carcere, il suo perenne sovraffollamento, i suicidi, le patologie
psichiche sempre trascurate, la tossicodipendenza volutamente ignorata, vanno
giustamente sempre raccontati e segnalati con un certo allarme nel quadro del
loro punto di partenza, il processo. Pur senza nascondere nessun dato di realtà.
Anche perché, se i posti per “alloggiare” dignitosamente i prigionieri sono
cinquantamila e ne devi stipare quattromila in più, si sta stretti e scomodi. E
se sei malato o comunque fragile, diventi una persona a rischio. E ventinove
suicidi (con altre diciassette morti da accertare) dall’inizio dell’anno sono un
dato pazzesco, una cosa da strapparsi i capelli dalla disperazione. E
aggiungiamo anche che sono tante le persone di buona volontà che ogni giorno si
adoperano per migliorare il carcere e la vita di chi vi alloggia. A partire
dalla ministra Cartabia, che si appresta a inaugurare con il collega Colao due
laboratori per attività nel settore delle telecomunicazioni nelle carceri
di Torino e Cagliari, con importanti progetti per il reinserimento sociale
attraverso il lavoro.
Così come riteniamo
fondamentale il fatto che nelle carceri italiane si dedichi del tempo allo
studio, specialmente nel settore dei giovani adulti e degli stranieri. Anche se
è sconvolgente apprendere dalla relazione del Garante che nell’anno passato ben
3.385 reclusi, di cui oltre 300 italiani, hanno seguito corsi di
alfabetizzazione. Cioè non sapevano leggere né scrivere. Ma altri 4.000 hanno
frequentato corsi delle scuole elementari e medie, e poi 6.000 sono andati alle
superiori e circa 1.200 all’università. Cui vanno aggiunti coloro che hanno
frequentato corsi professionali che hanno aperto loro la strada verso un futuro
da uomini e donne liberi e possibilmente reinseriti con un lavoro. In trentanove
si sono persino laureati! Ma stiamo parlando sempre di buona volontà, cioè di
aggiustamenti sul punto terminale di quel filo rosso che parte dal processo e da
quella cultura del “monopolio del carcere” come unica forma non solo di
applicazione della pena ma anche come soluzione della devianza e dei conflitti
sociali. È lì che andrebbe invece affondato il bisturi di una vera rivoluzione
copernicana, oggi più che mai indispensabile.
Tiziana Maiolo. Politica e
giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e
XIII legislatura.
Carcere di Lecce, Garante:
«Detenuto di 250 kg non può stare in cella». Ciambriello, 'trasferito da
Lecce a Poggioreale, inconcepibile'. La Gazzetta del Mezzogiorno il 22 Luglio
2022
Un detenuto di 250 kg è stato
trasferito dalla casa circondariale di Lecce al Carcere di Poggioreale. Una
decisione «inconcepibile» la definisce il Garante campano dei detenuti, Samuele
Ciambriello.
«Non capisco la logica di
questo trasferimento - spiega - Già è per me inconcepibile che Francesco, un
uomo di 48 anni, che pesa 250 chili, ha diverse fratture, è cardiopatico ed ha
già avuto quattro infarti, stia ancora in carcere e non in detenzione
domiciliare in una struttura sanitaria o ospedaliera. Ancor più inaccettabile è
che adesso stia in un istituto di pena come Poggioreale».
Il caso di Francesco si somma
ad altri casi, primo tra tutti quello di Mario, l’uomo di 270 chili che da
Poggioreale, proprio nei giorni scorsi, è stato mandato ai domiciliari.
«Troppi ammalati, anziani,
detenuti con disturbi psichiatrici che riempiono le nostre carceri. Per loro
dovrebbero essere pensate soluzioni diverse, misure alternative, anche in
ragione del fatto che nelle carceri campane mancano medici, sia generici che
specialistici, infermieri, psichiatri e psicologi - sottolinea il garante - Lo
Stato non può rimanere inerme davanti a storie come quelle di Francesco, che
merita di scontare la sua pena in maniera dignitosa e soprattutto avendo le
necessarie cure e non lontano da casa, da sue familiari, sapendo, per esempio,
che la Casa circondariale di Bari ha un reparto Sai ben attrezzato e già anche
collegato con il locale ospedale e con la facoltà di Medicina dell’Università
barese. Le strutture carcerarie, così come Poggioreale, non possono farsi carico
di un caso clinico così delicato. Si corre un rischio troppo alto».
"Si corre un rischio troppo
alto". Detenuto obeso (250 kg), cardiopatico e infartuato, nuovo caso clinico a
Poggioreale: “Perché trasferirlo qui?”
Redazione su Il Riformista il 22 Luglio 2022
Pesa 250 chili, ha diverse
fratture, è cardiopatico e ha già avuto quattro infarti. E’ il profilo del
detenuto arrivato nelle scorse ore nel carcere di Poggioreale a Napoli. Prima
era ristretto nella Casa circondariale di Lecce e, su disposizione del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, adesso allocato nel reparto Sai
(Servizio di assistenza intensificato) del carcere di Poggioreale.
“Non capisco la logica di
questo trasferimento – dichiara il Garante campano, Samuele Ciambriello – Già è
per me inconcepibile che Francesco, un uomo di 48 anni, che pesa 250 chili, ha
diverse fratture, è cardiopatico ed ha già avuto quattro infarti, stia ancora in
carcere e non in detenzione domiciliare in una struttura sanitaria o
ospedaliera. Ancor più inaccettabile è che adesso stia in un istituto di pena
come Poggioreale”.
Il caso di Francesco è solo
l’ultimo di una serie episodi analoghi, primo tra tutti quello di Mario, l’uomo
di 270 chili che da Poggioreale, proprio nei giorni scorsi, è stato mandato ai
domiciliari dopo vari appelli e ben tre anni in cella.
“Troppi ammalati, anziani,
detenuti con disturbi psichiatrici che riempiono le nostre carceri. Per loro
dovrebbero essere pensate soluzioni diverse, misure alternative, anche in
ragione del fatto che nelle carceri campane mancano medici, sia generi che
specialistici, infermieri, psichiatri e psicologi. Lo Stato non può rimanere
inerme davanti a storie come quelle di Francesco, che merita di scontare la sua
pena in maniera dignitosa e soprattutto avendo le necessarie cure e non lontano
da casa, da sue familiari, sapendo -per esempio – che la Casa circondariale di
Bari ha un reparto Sai ben attrezzato e già anche collegato con il locale
ospedale e con la facoltà di Medicina dell’Università barese. Le strutture
carcerarie, così come Poggioreale, non possono farsi carico di un caso clinico
così delicato. Si corre un rischio troppo alto”.
I drammi dietro le sbarre.
La storia di Francesco, 250 kg e 4 infarti. Il regalo del Dap: “Mandatelo nel
carcere di Poggioreale”.
Viviana Lanza su Il Riformista il 24 Luglio 2022
La settimana scorsa era stato
il caso di Mario a destare scalpore e indignazione tra i garantisti e tra coloro
che davvero credono nei diritti e nei principi della Carta costituzionale. E la
“giustizia” era subito corsa ai ripari provando a salvare il salvabile. Il caso
era quello di Mario, detenuto obeso di 41 anni, con un anno e quattro mesi di
pena da scontare, tenuto in carcere nonostante i suoi 270 chili e la cardiopatia
e messo ai domiciliari solo da alcuni giorni. Non era un caso isolato. E lo
conferma la storia di Francesco, un detenuto di 250 chili che proprio ieri è
stato trasferito nel carcere di Poggioreale.
«Il carcere non è un luogo per
obesi e ammalati, ancor meno un carcere che non ha una struttura sanitaria
adeguata per questi casi», tuona il garante dei detenuti della Campania, Samuele
Ciambriello, denunciando l’ennesimo episodio che mette in evidenza distorsioni,
incoerenze, criticità del sistema penitenziario che finiscono molto spesso per
mortificare i più elementari diritti. È infatti di ieri la notizia del
trasferimento del detenuto di 250 chili e con una serie di problemi di salute
non da poco. Il detenuto, dapprima recluso nella casa circondariale di Lecce, è
stato portato, su disposizione del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, nel reparto Sai del carcere di Poggioreale. «Non capisco la
logica di questo trasferimento – aggiunge il garante campano – Già è per me
inconcepibile che Francesco, un uomo di 48 anni, che pesa 250 chili, che ha
diverse fratture, è cardiopatico ed ha già avuto quattro infarti, stia ancora in
carcere e non in detenzione domiciliare in una struttura sanitaria o
ospedaliera. Ancor più inaccettabile è che adesso stia in un istituto di pena
come Poggioreale».
Già, Poggioreale, il carcere
vetusto e sovraffollato dove già un detenuto in salute incontra mille e una
difficoltà, immaginarsi un detenuto obeso e con un quadro sanitario precario.
Poggioreale, il carcere, inoltre, dove il personale sanitario scarseggia quanto
quello che garantisce la rieducazione e dove anche gli agenti della polizia
penitenziaria non sono in numero sufficiente a far fronte al surplus di reclusi
e al deficit di personale educativo e di assistenza. Come si farà, per esempio,
a garantire l’ora d’aria a un detenuto nelle condizioni di Francesco? Come si
farà a coinvolgerlo in percorsi di riabilitazione? Come si farà ad assisterlo e
curarlo? Quante domande aperte lascia questa storia. Ma davvero è questo il
carcere con cui pensiamo di risolvere i problemi della società, ripristinare la
legalità e garantire il rispetto della legge e dei diritti? Il caso di Francesco
si somma a chissà quanti altri. Il fatto è che il problema è annoso e rientra
tra le aberrazioni del sistema carcere da anni mai risolte.
«Troppi ammalati, anziani,
detenuti con disturbi psichiatrici che riempiono le nostre carceri. Per loro
dovrebbero essere pensate soluzioni diverse, misure alternative, anche in
ragione del fatto che nelle carceri campane mancano medici, sia generi che
specialistici, infermieri, psichiatri e psicologi. Lo Stato – sottolinea il
garante Ciambriello – non può rimanere inerme davanti a storie come quella di
Francesco, che merita di scontare la sua pena in maniera dignitosa e soprattutto
avendo le necessarie cure e non lontano da casa, dai suoi familiari, sapendo,
per esempio, che la casa circondariale di Bari ha un reparto Sai ben attrezzato
e già anche collegato con il locale ospedale e con la facoltà di Medicina
dell’università barese. Le strutture carcerarie, così come Poggioreale –
conclude il garante – , non possono farsi carico di un caso clinico così
delicato. Si corre un rischio troppo alto»
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Bimba di sei mesi deve
essere operata, ma il padre non può registrarla all’anagrafe.
L’uomo è detenuto in Alta
sicurezza a Cosenza e la piccola non ha ancora né Codice fiscale né medico,
entrambi necessari per prenotare l’intervento. Damiano Aliprandi su Il Dubbio
l'8 giugno 2022.
C’è una bambina di sei
mesi che deve fare una operazione urgente. Per avere il riconoscimento di
paternità è necessaria la presenza del padre, ma l’uomo è detenuto in Alta
sicurezza e da circa sette mesi è in attesa della concessione del permesso per
recarsi all’anagrafe: per ben tre volte, le richieste sarebbero state
rigettate. Per poter programmare l’intervento, tramite il centro unico di
prenotazione (Cup), è necessario che la piccola abbia un medico di base, ma
senza la registrazione all’anagrafe la piccola non è ancora in possesso neanche
del Codice fiscale e quindi per lo Stato italiano non esiste.
Una vicenda denunciata
dall’Associazione Yairaiha Onlus e segnalata al ministero della Giustizia, al
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Garante nazionale delle
persone private della libertà. L’associazione denuncia che il diritto alla
salute di una minore ancora in fasce non possa essere pregiudicato da ulteriori
lungaggini burocratiche e, per tale ragione, «portiamo alla vostra attenzione la
seguente segnalazione». Segnala che a M. L., detenuto in Alta sicurezza presso
la Casa Circondariale di Cosenza “S. Cosmai”, da circa 7 mesi non viene concesso
di potersi recare all’anagrafe di Casali del Manco (Cs) per il riconoscimento di
paternità della figlia, nata il 30 novembre del 2021.
«La bambina – scrive Yairaiha
Onlus – necessita di un delicato intervento al più presto ma, a causa del
mancato riconoscimento di paternità, non dispone del Codice fiscale e non esiste
agli occhi dello Stato!». Il detenuto, che teme per l’aggravarsi delle
condizioni di salute della piccola, ha presentato per ben tre volte regolare
istanza sia alla Corte d’Appello che al Magistrato di Sorveglianza competente,
ma – come segnala l’associazione – tutte le richieste sono state rigettate.
Nella segnalazione, Yairaiha Onlus rileva che tale situazione di stallo si pone
di certo in contrasto con il superiore interesse del minore, tutelato da
Convenzioni nazionali e internazionali: la posizione giudiziaria del padre,
infatti, «non dovrebbe costituire un pregiudizio per diritti costituzionalmente
garantiti di chi non ha commesso alcun reato, soprattutto se si tratta di una
bambina in tenera età».
“D’estate il carcere è
rovente, i nostri cari trattati come bestie in 10 in una stanza”, la protesta
dei familiari dei detenuti a Poggioreale.
Rossella Grasso su Il
Riformista il 7 Giugno 2022
“L’estate è senza dubbio il
momento peggiore per i detenuti: in 12 o 13 persone in celle strettissime, fa
caldissimo, non ci sono ventilatori o frigoriferi. Non c’è aria, è
come l’inferno. E io che sono stato un detenuto lo so bene. Per questo sono
sceso in piazza per protestare, per dare voce a chi sta in carcere e non può
dire niente”. E questo che ha detto un ragazzo di 30 anni, arrivato fuori al
carcere di Poggioreale per protestare contro le condizioni che definisce
“disumane” in cui vivono i detenuti. Suo padre è attualmente ristretto nel
carcere napoletano e lui non si dà pace: conosce bene cosa significa essere
ristretto nel carcere più sovraffollato d’Europa. Ed è proprio lì che si è
radunato un gruppo di altri familiari dei detenuti delle carceri di tutta Italia
sono accorsi al grido di “dignità” per i detenuti i tutte le carceri. Al loro
fianco, in marcia, il Garante dei detenuti della regione Campania, Samuele
Ciambriello e quello del Comune di Napoli, Pietro Ioia.
“Famiglie dei ristretti in
movimento – siamo la voce dei detenuti”, è lo striscione che ha aperto il corteo
che dai cancelli del carcere si è spostato lungo tutto il perimetro del
penitenziario. Una protesta pacifica per far accendere i riflettori sulla tutela
dei diritti umani delle persone ristrette in tutta Italia perché “uno ha
sbagliato, ha fatto un reato e deve pagare per questo, ma con
dignità”. “D’estate stanno in mezzo alle blatte e ai topi”, dice una mamma
preoccupata per il figlio ristretto in un carcere del nord. “Ieri mio marito mi
ha chiamata dal carcere e mi ha detto che faceva un caldo micidiale, non si può
vivere così…è dura”, dice un’altra signora arrivata da Brindisi per protestare
senza riuscire a trattenere le lacrime.
“In carcere petto di pollo a
peso d’oro”
“Abbiamo diritto solo a una
chiamata di 10 minuti che se hai protestato o fatto qualcosa non ti fanno
nemmeno fare – continua la signora di Brindisi – Hanno sbagliato e devono
scontare una pena ma umanamente. Qui invece vivono come gli animali”. C’è anche
un altro problema che scalda gli animi dei familiari: i costi in carcere. “Un
pacco di piatti di plastica in carcere costa 7 euro – dice la mamma di un altro
detenuto – Hanno comprato di tasca loro i ventilatori, pagandoli 20 euro e poi
devono pagare 3 euro al mese per la corrente”. “Mio figlio è detenuto in un
carcere al Nord Italia – continua un’altra mamma – un petto di pollo è arrivato
a costare 17 euro. Poi dicono che un detenuto costa allo Stato 150 euro al
giorno. Ma da mangiare è sempre poco”.
“Non c’è più l’essere umano
nel carcere – dice una ragazza ventenne con uno striscione in mano – è solo un
numero di matricola”. “Anche noi familiari lo diventiamo – le fa eco un’altra
ragazza – Sappiamo che la penitenziaria sta in affanno però ogni volta per fare
1 ora di colloqui arriviamo in carcere alle 8 e andiamo via alle 3. Ore e ore in
attesa. Anche la distanza materiale fa il suo nel rendere la vita di detenuti e
i loro familiari sempre più difficile. La territorialità della pena in Italia
sembra un lusso per pochi. Succede così che la signora Paola di Catania debba
percorrere ogni mese 580 chilometri per andare a trovare per un ora il marito
ristretto in Calabria: “Porto con me i nostri figli piccoli per salutare il
padre, anche questo trauma devo fargli subire – dice – Poi lo stress di dover
stare chiusi in quella stanza…per i bambini è una grossa sofferenza”.
“Per un detenuto è impossibile
trovare lavoro una volta uscito dal carcere”
“In carcere li tengono in
brandina, giornate intere seduti senza far nulla – dice la mamma anziana di un
detenuto – Che riabilitazione è questa? Usciranno e nessuno gli vorrà dare un
lavoro perché hanno precedenti penali. E che faranno? Hanno famiglie, per vivere
dovranno andare a delinquere nuovamente?”. C’è anche chi invece ha deciso di
investire il tempo della prigione per migliorarsi e laurearsi. “Mio figlio a
Genova frequenta l’Università – racconta una mamma – gli abbiamo portato un pc
che gli serviva mesi fa. Gli hanno disattivato tutte le connessioni e quello che
va disabilitato. Ma ancora non glielo danno. Perché? È una persona che sta
facendo di tutto per cambiare”.
“In cella niente frigoriferi e
ventilatori”
Alcuni dei familiari dei
detenuti denunciano che nelle roventi celle affollate di Poggioreale non ci sono
né ventilatori né frigoriferi. “I familiari portano ai loro cari il cibo –
dice Pietro Ioia – ma poi va quasi tutto buttato perché in assenza di
frigorifero va tutto a male. Abbiamo organi8zzato una raccolta e presto
consegneremo frigoriferi e ventilatori”. “Da qui, da Poggioreale, abbiamo
lanciato un messaggio per attirare l’attenzione su tutte le carceri – ha
detto Samuele Ciambriello – Pochi spazi di vivibilità, poche misure alternative,
pochi spazi di lavoro. Il Governo almeno facesse la liberazione anticipata di 70
giorni e 70 giorni. Noi che siamo liberi abbiamo avuto i ristori, loro
niente. La politica rifiuta la parola indulto, dovrebbe recuperare la parola
dignità”.
Rossella Grasso. Giornalista
professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate
nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato
la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie
testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos,
Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli.
Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’
autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio
mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.
L’inferno dietro le sbarre.
In dodici in una cella, questo carcere non è umano: “Da qui si esce più
criminali di prima”.
Viviana Lanza su Il Riformista l'8 Giugno 2022.
La cella 55bis è
nel carcere di Poggioreale. Si trova nel reparto dei cosiddetti sex offender,
cioè dei detenuti che si trovano in carcere per reati a sfondo sessuale.
La descrivono come una cella
da cui il cielo è ridotto a uno spazio di pochi centimetri quadrati. Lo si vede
a stento, il cielo. In alcuni giorni si fa quasi fatica a capire se sia giorno o
sera. La luce, dentro la cella 55bis, non riempie mai lo spazio tra le quattro
mura. C’è una sola finestra. Una sola. Mentre all’interno della cella 55bis si
arriva a stare anche in dodici. Sì, dodici persone. Di notte dormono in letti
sistemati uno sull’altro. Di giorno provano a resistere e convivere fra
equilibri delicatissimi. Non ci vuole molto a comprendere che trovarsi in dodici
in uno stanzone rende la vivibilità sempre ai limiti. Con questo caldo, poi, può
diventare un inferno.
Ma a chi interessa? Intorno a
queste storie calano silenzio e indifferenza. Un muro che il garante regionale
dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, con il garante della città
metropolitana di Napoli, Pietro Ioia, cercano di rompere. Ieri a Napoli i
garanti hanno partecipato al corteo e alla manifestazione che i parenti dei
detenuti hanno organizzato nella cittadella giudiziaria del Centro direzionale,
tra la sede del Tribunale di Napoli e il carcere di Poggioreale. Parliamo delle
due realtà giudiziarie più grandi d’Italia: il Tribunale con la Procura sono gli
uffici giudiziari con i numeri di processi e inchieste più alti a livello
nazionale, il carcere è la struttura penitenziaria più grande che c’è e arriva a
contare oltre duemiladuecento detenuti. Ha la popolazione di un paese di
provincia. È come una piccola città chiusa tra quattro mura. «Chiediamo carceri
più umane in grado di produrre cittadini votati alla legalità e non alla
criminalità», ripetono i parenti dei detenuti.
Al corteo partecipano anche
persone provenienti da altre regioni d’Italia. Marciano attorno alle mura grigie
del carcere di Poggioreale, fino a uno dei varchi del Tribunale di Napoli,
quello che si apre su piazza Cenni. «Queste famiglie – dice il garante dei
detenuti della Campania, Samuele Ciambriello – non vogliono altro che attirare
l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema delle carceri. Domenica c’è
un referendum importante sulla giustizia. Il tema del carcere è un tema
centrale». Eh già, il 12 giugno gli italiani sono chiamati a esprimere il
proprio voto ai cinque quesiti referendari che affrontano nodi delicati del
sistema giustizia. In questi mesi, in queste settimane, soltanto poche voci
hanno informato i cittadini sul contenuto dei quesiti referendari e
sull’importanza del voto, per il resto sull’argomento è calato un silenzio
vergognoso, un silenzio voluto da una buona parte della politica e dalla
magistratura contraria alle proposte di riforma contenute nei quesiti del
referendum. Uno dei cinque quesiti tocca il tema del carcere, perché riguarda i
limiti agli abusi della custodia cautelare.
Le statistiche degli ultimi
anni dicono che ogni anno nel solo distretto di Napoli si contano circa cento
casi di ingiusta detenzione. «Molte persone entrano in cella da innocenti –
aggiunge Ciambriello -, parecchie da persone sane per poi uscire ammalate. Uno
dei temi che solleviamo oggi è quello della sanità. Tante aggressioni ai danni
degli agenti vedono protagoniste persone con problemi psichici.
A Poggioreale c’è un Sert per i tossicodipendenti ma le condizioni sono
disumane: anche 8-10 persone in una stanza. Nella sezione dei cosiddetti sex
offender c’è una stanza, la 55bis, che ospita 12 detenuti e ha solo una
finestra». Per Pietro Ioia le carceri, sono diventate «scuole di criminalità».
«Da questi posti – dice parlando delle carceri – ormai si esce più criminali di
prima». Bisognerebbe invertire questa tendenza, puntando sulla rieducazione,
sulle misure alternative, su percorsi di legalità.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Il lavoro in carcere. Chi
era Carlo Smuraglia, il padre della legge per il reinserimento dei detenuti.
Rita
Bernardini su Il Riformista il 7 Giugno 2022.
Partigiano, avvocato,
accademico, Carlo Smuraglia, è stato senatore prima del PCI, poi
del PD. Comunque la si pensi sui temi affrontati con passione nel corso della
sua vita, è impossibile non riconoscergli un attaccamento viscerale ai principi
della nostra Costituzione unito ad una grande intelligenza e lucidità di
pensiero. Nell’archivio di Radio Radicale, per esempio, ritroviamo un suo
intervento di un anno e mezzo fa, quando di anni il Presidente emerito
dell’Anpi ne aveva 97, contro quello che definiva il referendum truffa sul
taglio dei parlamentari. Lamentava soprattutto la mancanza di dibattito sui
media, vitale se si vogliono portare i cittadini ad un voto consapevole. Ci
risiamo oggi con il silenzio sui 5 referendum di prossima votazione per almeno
avviare una improcrastinabile riforma della giustizia.
Chi si occupa di esecuzione
penale e di carcere, il nome di Carlo Smuraglia lo ha sentito pronunciare
infinite volte quale padre della buona e giusta legge, la n. 193 del 2000, che
prevede importanti agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono
persone detenute. Una legge che, se fosse veramente utilizzata, contribuirebbe a
far vivere e non languire (come accade oggi) l’art. 27 della Costituzione. «Cara
Bernardini, a te che chiedi di raddoppiare i fondi della legge Smuraglia per
incrementare il lavoro in carcere, rispondo che lo scorso anno non sono stati
nemmeno spesi tutti quelli stanziati in bilancio!». Rimasi basita quando l’ex
capo del Dap Dino Petralia mi diede questa notizia rispondendo ad una delle
tante sollecitazioni radicali volte a migliorare le drammatiche condizioni di
detenzione.
È incredibile, ma in Italia
accade che le nostre imprese, pur in presenza di sgravi fiscali inimmaginabili
soprattutto in un periodo di crisi economica come l’attuale, non approfittino
dei vantaggi previsti dalla legge. Si dirà: i detenuti non hanno voglia di
lavorare, non sono affidabili. Non è così! Ricordo quando incontrai
l’ingegner Silvio Scaglia, ex AD di Fastweb, detenuto ingiustamente in carcere
quale vittima di uno dei tanti processi finiti nel nulla con la completa
assoluzione dell’imputato. Da imprenditore e dirigente d’azienda che di lavoro
se ne intendeva, mi disse «qui, reclusi con me, scopro che ci sono tante
potenzialità, tanti talenti, persone intelligenti e capaci: se si desse loro
l’opportunità di lavorare anziché stare a disperarsi senza fare niente tutto il
giorno, io credo che le condizioni di detenzione migliorerebbero molto e queste
persone, una volta finito di scontare la pena, non tornerebbero a delinquere».
Silvio Scaglia, un uomo di successo internazionale che ha dovuto pagare il
prezzo della ingiusta giustizia italiana, la pensava esattamente come il
senatore Carlo Smuraglia.
Un altro illuminato manager ha
avuto un’idea brillantissima durante i due appena trascorsi anni di pandemia,
anni che nelle carceri sono stati devastanti anche in termini di vite umane
perse. Davide Rota, AD di Linkem (e da poco di Tiscali), durante
il lockdown, con il blocco del commercio internazionale, aveva l’esigenza di
rimpiazzare i modem rotti, necessari per i collegamenti veloci alla rete
Internet. Trovò subito la disponibilità della bravissima direttrice del carcere
di Lecce Rita Russo (ora promossa a Provveditore del Piemonte) e, mentre tutto
era fermo, organizzarono la formazione di una ventina di detenuti per il riciclo
dei modem. Al termine del corso, 15 di loro furono assunti con un regolare
contratto di lavoro rivelandosi bravissimi. Ho avuto modo di vedere con i miei
occhi cosa sono capaci di fare, dallo smontaggio, alla igienizzazione fino alla
riprogrammazione e all’inscatolamento. Il fatto miracoloso è che ognuno dei 15
“ragazzi” è in grado di svolgere qualsiasi fase della lavorazione. Il “modello
Lecce” è stato poi esportato in altri istituti italiani. Lavoro vero, spendibile
una volta finita di scontare la pena.
Ma allora, cos’è che blocca il
lavoro esterno che le imprese o le cooperative potrebbero portare dentro
gli istituti penitenziari? La fotografia ad oggi ci dice che circa duemila
detenuti svolgono questo tipo di lavori qualificanti, cioè meno
del 4% della popolazione ristretta. Perché? I motivi sono tantissimi, ma occorre
tenere presente che ogni penitenziario è una repubblica a sé, nel senso che
molto dipende dalla bravura e determinazione del direttore nel ricercare le
collaborazioni esterne, dalla disponibilità della polizia penitenziaria e
dall’impegno degli educatori. La carenza di personale in ogni settore delle
professionalità certo non aiuta. Basti pensare che i direttori, cioè coloro che
dovrebbero essere un po’ manager del carcere, sono una categoria in via di
estinzione: in Sardegna, su dieci istituti ci sono solo tre direttori titolari.
Il primo scoglio da superare è
però quello del sovraffollamento, con migliaia di detenuti vicinissimi al fine
pena sui quali è difficile investire, visto che non lo si è fatto prima.
Purtroppo, le proposte di Nessuno Tocchi Caino e del Partito Radicale non
vengono nemmeno vagliate dalla politica istituzionale italiana. Basterebbe
quella della liberazione anticipata speciale, già adottata all’epoca
della sentenza Torreggiani, per far “respirare” gli istituti penitenziari e
trovare gli spazi fisici necessari per insediare le lavorazioni. Infine, c’è il
problema dei problemi in un’amministrazione che storicamente dimostra di non
funzionare. Mi riferisco alla mai attuata parte dell’Ordinamento
Penitenziario del 1975 riguardante la costituzione presso ogni circondario di
Tribunale dei “Consigli di aiuto sociale” che hanno (avrebbero) come finalità
istituzionale proprio quella del reinserimento sociale e lavorativo della
persona detenuta.
Si tratterebbe di trovare nel
tessuto economico locale gli imprenditori che, risparmiando, intendano investire
sugli ultimi, i dimenticati. Tutti ne trarrebbero beneficio anche dal punto di
vista della tanto sbandierata sicurezza sociale. Finora solo il Presidente del
Tribunale di Palermo, il dott. Antonio Balsamo, ha risposto all’appello e il
prossimo 20 giugno si terrà una riunione del costituito Consiglio di aiuto
sociale dentro il carcere dell’Ucciardone, alla presenza delle persone detenute.
Che sia la volta buona? Spes contra spem, rispondo. Per onorare – non solo a
parole – l’indimenticabile senatore Carlo Smuraglia. Rita Bernardini
"Fu
innovazione legislativa importante". Smuraglia, la legge per dare lavoro ai
detenuti che da quando è nata ha sempre pochi fondi.
Redazione su Il
Riformista il 31 Maggio 2022.
Avvocato e
presidente dell’Anpi, Carlo Smuraglia, morto oggi a Milano all’età di 98 anni, è
stato anche senatore dal 1992 al 2001 e, un anno prima della fine del suo
mandato, fu promotore della legge, che porta il suo nome, che prevede sgravi
contribuitivi per chi assume persone in stato di esecuzioni penali. “Fu la sua
determinazione a consentire un’innovazione legislativa importante”
spiega Patrizio Gonnella dell’associazione Antigone, da sempre in prima linea
per la tutela e la dignità del mondo detenuto. “Il lavoro è fonte
di reddito nonché di emancipazione dai circuiti dell’illegalità e Carlo
Smuraglia, partigiano e uomo delle istituzioni, lo aveva capito”.
La
cosiddetta legge Smuraglia (193 del 22 giugno 2000) promuove l’attività
lavorativa dei detenuti con agevolazioni contributive in favore dei datori di
lavoro che impiegano persone detenute o internate, ed ex degenti di ospedali
psichiatrici giudiziari. ”Si onori la memoria di Smuraglia facendo funzionare al
meglio la sua legge, ossia dotandola di fondi che ne consentano il
funzionamento” aggiunge Gonnella. ”Oggi il numero di persone detenute che lavora
è purtroppo non alto. La legge Smuraglia aveva invece l’obiettivo di favorire
opportunità di impiego qualificato. Sarebbe bello se la si dotasse di fondi
adeguati per raggiungere gli obiettivi che voleva Carlo Smuraglia”, conclude il
presidente di Antigone.
Una legge quella
di Smuraglia, che da avvocato negli anni ’50 difese numerosi partigiani dopo la
seconda guerra mondiale, che tuttavia nel corso di questi 22 anni è stata
applicata parzialmente a causa della carenza di fondi che impediscono
all’amministrazione penitenziaria di pagare i contributi a favore
di cooperative e imprese che hanno assunto detenuti dentro il carcere o detenuti
fuori dal carcere.
La legge prevede
la riduzione del 95% delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale dovute per i detenuti o internati assunti
all’interno degli Istituti penitenziari da parte di imprese private e
cooperative o ammessi al lavoro all’esterno presso cooperative. L’agevolazione
trova applicazione anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato
detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno
beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che
l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al
lavoro all’esterno; per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato
detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della
semilibertà o del lavoro all’esterno, a condizione che il rapporto di lavoro sia
iniziato mentre il soggetto era ristretto.
Nel XVIII
rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, il quadro che emerge in
materia di lavoro e formazione professionale è assai variegato. “Da un lato – si
legge – troviamo situazioni virtuose in cui i detenuti svolgono tutti
un’attività lavorativa (che sia alle dipendenze dell’amministrazione
penitenziaria o per datori di lavoro diversi dal carcere), e all’estremo opposto
istituti in cui le poche attività lavorative presenti sono quelle cosiddette
domestiche alle dipendenze dell’amministrazione, come le pulizie, la cucina e la
spesa. Discorso più complesso è quello che riguarda la formazione professionale
che appare essere davvero carente in linea generale”
“Dai dati da noi
raccolti nel 2021 è risultato anzitutto che il budget medio annuale previsto per
le mercedi sia di 645.049,6 euro ad istituto, per un totale medio annuo a
dipendente, ovviamente lordo, di 7.414,2 euro. In media – spiega Antigone – nei
96 istituti visitati il 33% dei detenuti presenti era impiegato alle dipendenze
dell’amministrazione penitenziaria; di questi buona parte è impiegato sempre in
mansioni di tipo domestico. Solo il 2,2% dei presenti era invece in media
impiegato alle dipendenze di altri soggetti. Il dato è peraltro molto
disomogeneo. In Emilia-Romagna questa percentuale era del 4%, in Campania dello
0,3%. In 37 istituti visitati, più di un terzo del totale, non abbiamo trovato
alcun detenuto impiegato per un datore di lavoro diverso dal carcere stesso”.
Ecco la vera pena
corporale, la galera uccide i cinque sensi.
ISABELLA DE SILVESTRO su Il
Domani il 06 giugno 2022
Uno dei primi effetti della
detenzione è l’acutizzarsi dell'udito, che cresce insieme ad un senso di paura.
Dopo mesi sopraggiunge una sordità difensiva. Poi l’insieme di stimoli
angoscianti viene appiattito nella quotidianità.
«Era rimasta senza grata una
finestra. Sembrava un televisore, anche se dava su un paesaggio orripilante».
Una delle conseguenze della prigionia è il precipitoso calo della vista, che
continua a peggiorare durante tutta la durata della carcerazione.
La prigione ti condanna a
essere solo un corpo. Ma di questo corpo perdi il controllo. Nonostante il
passaggio dalla pena come supplizio alla pena come rieducazione sia avvenuto,
teoricamente, da ormai due secoli, in Italia la galera infligge ancora pene
corporali.
Il primo rumore che si sente
la mattina è quello insopportabile delle chiavi. Grandi chiavi appese alle
cinture dei secondini che attraversano i corridoi e aprono le celle una a una.
Il risveglio carcerario è fatto di rumori metallici, porte blindate che si
aprono e si chiudono, battitura delle sbarre per accertarsi che i detenuti non
le stiano segando per evadere. Si alza poco dopo il brusio televisivo o
radiofonico, telegiornali, talk show, voci che si fondono con quelle dei
residenti nelle celle. Richiami, cognomi gridati, “buongiorno appuntà!”. Sono i
rumori della galera, sempre gli stessi, pochi ma costanti e pervasivi.
UDITO
«In carcere non c’è mai un
vero silenzio: ci sarà sempre un generatore, un lamento, una televisione accesa
che funge da anestetico. Quando entri fai caso a tutto in maniera ossessiva, ma
dopo qualche tempo diventa solo rumore di fondo», racconta un ex detenuto. Uno
dei primi effetti della detenzione è l’acutizzarsi dell'udito, che cresce
insieme ad un senso di paura. Dopo mesi sopraggiunge una sordità difensiva. La
reazione emotiva ai suoni si attenua quando l’insieme di stimoli angoscianti
viene appiattito nella quotidianità.
GUSTO
Sono le otto del mattino, il
portavitto si avvicina con il suo carrello per distribuire la colazione. Al
caffè sbiadito o al tè si aggiunge parecchio zucchero. Sul pane, spesso di bassa
qualità, mal cotto e insapore, si spalma tutto ciò che si può per renderlo più
saporito. Essendo uno dei pochi stimoli sensoriali che il detenuto può gestire
in autonomia, il consumo di zucchero nelle celle è molto alto. «In una cella di
due persone è facile che si faccia fuori un chilo di zucchero a settimana»,
racconta un altro detenuto. «Per quanto riguarda il corpo, si hanno due
atteggiamenti estremi: c’è chi si lascia del tutto andare e chi invece si cura
ossessivamente. Chi smette di mangiare e chi si butta sul cibo cercando
consolazione». Quando l’alimentazione diventa uno strumento di compensazione
psicologica non sono rare patologie come il diabete e l'ipertensione.
VISTA
D’altronde il movimento fisico
garantito si riduce ai passi che si possono fare “all’aria”, ovvero i giri
intorno a cortili spesso claustrofobici a cui si ha diritto per qualche ora al
mattino e al pomeriggio. Il detenuto esce dalla cella di 8 metri quadrati che
deve condividere con qualcun altro, dato l’affollamento delle carceri italiane
che in alcune regioni raggiunge il 134 per cento della capienza, secondo
l’ultimo rapporto dell’associazione Antigone. Prima di uscire butta uno sguardo
alla finestra per capire che tempo ci sia, se serva la giacca o basti il
maglione. Ma la finestra non permette di vedere granché. Ci sono le sbarre, e
oltre le sbarre una fitta grata metallica che chiude lo sguardo. Da qui la
vertigine di cui molti ex detenuti parlano quando tornano a guardare fuori da
finestre senza sbarre dopo la liberazione. In cella, oltre i fori di due
centimetri, la vista è tagliata dalle alte mura di cemento che delimitano la
struttura penitenziaria.
Il detenuto infila la giacca e
attraversa il lungo corridoio illuminato artificialmente. Scende le scale.
Raggiunta l’aria si guarda intorno e ciò che vede è ancora cemento. A terra, a
destra, a sinistra. In alto il cielo con le sue nuvole e forse qualche uccello.
«Nel carcere di Cremona avevano messo le grate su tutte le finestre. Era rimasta
senza grata una finestra in corridoio. Ci fermavamo lì dopo l’aria per guardare
fuori a turno. Sembrava un televisore. Dava su un paesaggio orripilante ma ci
sembrava una grandissima cosa. La gente diceva che se non avesse avuto la grata
in cella sarebbe stata mezza giornata a guardare dalla finestra». C’è uno
sguardo lungo e uno sguardo corto. Lo sguardo del prigioniero è forzatamente
accorciato e mutilato, scriveva Adriano Sofri dopo lunghi anni di esperienza
detentiva. Una delle conseguenze più comuni e immediate della prigionia è il
precipitoso calo della vista, che continua a peggiorare durante tutta la durata
della carcerazione. L’oscurità delle celle non aiuta. Chi riesce cerca di fare
qualche esercizio per la vista, ma gli stimoli rimangono scarsi.
OLFATTO
È ora di pranzo. Il detenuto
cucina con il suo compagno di cella. Gli odori del cibo invadono la stanza
impregnando le pareti, ma chi la abita li sente poco. Anche l’olfatto è
regredito nel tempo. La galera è un luogo di odori grevi e compositi che
ristagnano. Il ricambio d’aria è scarso, il cemento sigilla. Finito il pranzo la
cella viene presto ripulita. L’alto livello di stress psicologico a cui i
carcerati sono sottoposti genera spesso la necessità di esercitare un forte
autocontrollo sulle poche attività su cui si ha libertà, tra cui la pulizia. Si
fa largo uso di candeggina e detersivi per la sanificazione di quello spazio
ristretto che ospita ogni funzione vitale e in cui molti detenuti passano più di
venti ore al giorno. Gli odori chimici sono i più comuni e persistenti, si
respirano per anni, fino a non sentirli più. Un detenuto racconta di essere
passato da un carcere dove era permesso bruciare dell’incenso. Il profumo forte
e penetrante era uno stimolo stupefacente, del tutto diverso dai soliti e
ripetuti odori. Come quello della muffa che ricopre le pareti scrostate di
strutture fatiscenti. In galera sono molto comuni le malattie respiratorie,
aumentano i casi d’asma e si nota subito fra i reclusi un raffreddore costante
dovuto al malfunzionamento del riscaldamento e alle infiltrazioni di umidità in
cella.
TATTO
Che cosa si tocca nel tempo in
cui si sconta la pena? Di certo il cemento e il metallo. Per il resto poco
altro, la plastica delle posate con cui si mangia, se si è fortunati la carta di
un libro. Pochi i contatti con altri corpi, forse qualche stretta di mano.
Addirittura la propria nudità diventa evento raro, dal momento che la doccia si
fa rigorosamente in mutande e gli spazi privati non esistono. Anche per la
percezione del proprio corpo c’è un declino evidente. L’orto è una delle
attività più ambite perché permette di entrare in contatto con odori e
consistenze dimenticate. Non è un caso che fra i detenuti siano frequenti le
patologie dermatologiche: irritazioni, pruriti, scabbia. Tre coimputati
raccontano di essere stati presi contemporaneamente da un prurito incessante e
al quale i medici non riuscivano a trovare una spiegazione. Tutti e tre sono
guariti pochi giorni dopo la scarcerazione. «Mi fa pensare che non fosse un
problema solo fisico, forse eravamo entrati nello stesso loop tutti e tre,
eravamo isolati insieme da 40 giorni», ipotizza uno di loro.
Malattie del corpo e della
mente si confondono. I disturbi depressivi e d’ansia agiscono sulla
sensorialità, estremizzandola o spegnendola. Quando i sensi sono così
violentemente compressi la mente cerca di compensare: si viene assaliti da
allucinazioni visive, auditive, tattili, del gusto e dell’olfatto; ne risentono
i ritmi del sonno e della veglia, diventa difficoltosa la digestione, il sistema
nervoso si deteriora in maniera costante e le difese immunitarie calano, ancora
una volta per mancanza di stimoli.
Ciò che i corpi dei detenuti
ci raccontano è che il carcere è un luogo pensato per la loro gestione
disciplinata in termini esclusivamente securitari, di isolamento e repressione.
Questi corpi mangeranno qui, dormiranno qui, uno sopra l’altro, qui passeranno
per andare all’aria, qui verranno guardati senza poter vedere.
Tutti gli aspetti qualitativi
della vita corporale che vanno oltre la sopravvivenza biologica saltano.
Quest’idea, inscritta nell’architettura delle galere, rende difficile mettere in
atto cambiamenti, anche quando le direzioni ne hanno l’intenzione. Per alcuni
corsi e laboratori, che sarebbero di estrema importanza per il recupero e lo
stimolo della sensorialità, non ci sono gli spazi. Se ci sono è probabile che
siano pochi e quindi già occupati.
LE PENE CORPORALI
La prigione ti condanna a
essere solo un corpo. Ma di questo corpo perdi il controllo. Nonostante il
passaggio dalla pena come supplizio alla pena come rieducazione sia avvenuto,
teoricamente, da ormai due secoli, in Italia la galera infligge ancora pene
corporali. ISABELLA DE SILVESTRO
Guido Mariani per Tag43 il 31
maggio 2022.
Qualche anno fa il World
Travel Awards, quello che qualcuno definisce il premio Oscar del turismo, nominò
Spike Island, una fortezza ed ex prigione al largo delle coste meridionali
dell’Irlanda, la maggiore attrazione turistica europea dell’anno, riservandole
anche la nomination in ambito internazionale accanto alla Muraglia Cinese e al
Pan di Zucchero di Rio de Janeiro.
Considerare una prigione una
“attrazione turistica” può lasciare un po’ perplessi, ma in realtà quello che
dovrebbe lasciarci perplessi è l’accezione, gioiosa e vacanziera, che noi
associamo ormai quasi sempre alla parola “turismo”. Il turismo è spesso
un’esplorazione di altre culture e di luoghi del passato, che non
necessariamente dobbiamo legare al divertimento e alla dimensione ludica del
viaggio.
Quelli che in diverse epoche
furono istituti di pena o centri di detenzione, rappresentano momenti di storia
e di memoria che possono benissimo rientrare in una meta di una vacanza senza
che questo significhi banalizzare il dolore a cui questi posti sono associati. È
anche per questo che le vecchie prigioni stanno oggi vivendo una nuova vita come
luoghi che attirano sempre più viaggiatori curiosi che vedono il “turismo” come
l’immersione più autentica in una cultura locale.
Spike Island e Kilmainham
Gaol: un tuffo nella storia dell’Irlanda
Spike Island è aperta al
pubblico dal 2010, è un’isola, a 15 minuti dalla costa nei pressi di Cork, che
ha un’estensione di poco inferiore alla Città del Vaticano ed è in gran parte
occupata da una grossa fortezza-penitenziario. Sede di un antico monastero,
divenne alla metà del XVII secolo un punto di raccolta per i prigionieri
dell’esercito inglese di Oliver Cromwell che avevano conquistato l’Irlanda. La
prima tappa di un viaggio di deportazione diretto nelle colonie inglesi al di là
dell’Oceano.
Alla fine del 700 vennero
erette delle fortificazioni e all’inizio del secolo successivo venne costruito
Fort Mitchell, la struttura che si visita oggi. L’imponente complesso di
edifici, ispirato ai castelli medievali italiani, era capace di ospitare fino a
3 mila soldati, ma divenne anche un penitenziario nell’epoca vittoriana che
rinchiudeva i condannati irlandesi nell’era della grande carestia. In quegli
anni fu il carcere più grande del mondo.
In Irlanda si può anche
visitare, a Dublino, Kilmainham Gaol, aperta nel 1796 e destinata in un primo
tempo a delinquenti comuni, migliaia dei quali vennero poi mandati ai lavori
forzati in Australia. Fu, successivamente, uno dei principali luoghi di
detenzione per i nazionalisti irlandesi. Venne chiusa, dopo l’indipendenza, nel
1924; uno dei suoi ultimi detenuti fu proprio Eamon de Valera destinato a
diventare Primo Ministro irlandese.
Dai Piombi all’Asinara: le ex
prigioni italiane
Senza partire per l’isola
verde, in Italia diversi ex luoghi di detenzione di varie epoche sono oggi
visitabili. Tra i più noti ci sono ovviamente i Piombi, le carceri di Palazzo
Ducale a Venezia. Costruiti alla fine del 500 furono chiusi due secoli più
tardi, il detenuto più celebre che ospitarono fu Giacomo Casanova.
Il Carcere Mamertino o
Tullianum è il più antico di Roma con costruzioni che risalgono fino al VII
secolo a. C. Divenne per molti secoli luogo di reclusione per condannati
all’esecuzione e per i nemici di Roma catturati in guerra come il re numida
Giugurta e il condottiero gallico Vercingetorige. La tradizione lo ricorda come
ultima dimora degli apostoli Pietro e Paolo prima del martirio e per questa
ragione divenne poi luogo di culto. È stato restaurato e aperto ai visitatori
dal 2016.
A Procida, capitale italiana
della cultura 2022, è possibile visitare il cinquecentesco Palazzo D’Avalos. Nel
1830 l’edificio fu trasformato in carcere per essere chiuso definitivamente nel
1988. Vi furono imprigionati personaggi come Luigi Settembrini e Cesare
Rosaroll, oltre a diversi generali di matrice fascista come Junio Valerio
Borghese, Graziani Rodolfo e Attilio Teruzzi che vi trascorsero gli ultimi
giorni della loro vita. Nel cortile si trova ancora la camionetta che
accompagnava i prigionieri al porto, fedele alla descrizione che Elsa Morante fa
ne L’isola di Arturo.
In Sardegna si può visitare il
carcere dimesso dell’Asinara che ha ospitato tra i suoi ultimi residenti il boss
dei boss Totò Riina. Oggi è parte del Parco Nazionale dell’Isola dell’Asinara.
Rocca Albornoz, oggi è il
Museo Nazionale del Ducato di Spoleto. Edificata nel XV secolo come fortezza
dello Stato Pontificio diventò bagno penale nel 1817 e mantenne il suo uso
carcerario fino al 1982. Durante il periodo fascista fu anche utilizzato per
rinchiudere prigionieri politici e antifascisti jugoslavi, alcuni dei quali
furono protagonisti di una rocambolesca fuga.
Alcatraz, attrazione da 1
milione di turisti l’anno
La prigione più visitata al
mondo è però quella sull’isola di Alcatraz nella baia di San Francisco, uno dei
primi luoghi carcerari contemporanei a essere aperti al turismo di massa. Prima
della pandemia era meta di più di un milione di turisti all’anno, un flusso che
ha giustificato nel 2015 un piano di restauro e di ammodernamento costato 3
milioni di dollari.
In realtà una delle carceri
più celebri del mondo ebbe una vita brevissima, meno di 30 anni. Il carcere
federale infatti venne inaugurato nel 1934, dove prima sorgeva una base militare
che ospitò anche prigionieri della guerra ispano americana e altri detenuti
sottoposti alla corte marziale. La struttura chiuse nel 1963. La gestione era
diventata economicamente insostenibile.
Nel frattempo Alcatraz si era
guadagnata la fama di penitenziario spietato e aveva accolto nelle proprie celle
alcuni dei più celebri criminali americani, tra cui il boss Al Capone. I
tentativi di evasione dall’isola-prigione costituiscono una mitologia a sé
stante. Il più noto, avvenuto nel 1962, è stato raccontato nel film Fuga da
Alcatraz di Don Siegel con Clint Eastwood: tre galeotti si scavarono con dei
cucchiai una via di fuga dalle celle, ma nessuno ha mai saputo nulla di certo
sulla loro sorte.
Negli Stati Uniti, a
Philadelphia, è diventata museo anche l’Eastern State Penitentiary, fortezza
edificata nel 1829 e che ai tempi fu l’edificio pubblico più costoso mai
realizzato in America. L’aspetto imponente, cupo e neo-gotico, fu scelto
appositamente per incutere timore nei reclusi che fino al 1913 furono tenuti in
isolamento.
Le celle in origine erano
state concepite con un’unica finestra sul soffitto per simboleggiare “l’occhio
di Dio” e invitare al pentimento. Charles Dickens e Alexis de Tocqueville vi
fecero tappa nei loro viaggi americani. La prigione, antiquata e sovraffollata,
chiuse definitivamente nel 1971.
Tra il mito e la storia: lo
Chateau d’If e la Conciergerie di Parigi
Ci sono fortezze note anche
per detenuti che in realtà vi sono stati rinchiusi solo nelle pagine di un
romanzo. È il caso del leggendario Chateau d’If, fortezza cinquecentesca che
sorge su una piccola isola dell’arcipelago delle Frioul, nel golfo di Marsiglia
e che fu prigione per quattro secoli. Oggi viene visitata soprattutto da chi si
immagina nelle sue celle il condannato Edmon Dantes, Il Conte di Montecristo
nato dalla fantasia di Alexandre Dumas.
Ma in Francia una delle tappe
d’obbligo è la Conciergerie di Parigi, originariamente costruita come parte del
palazzo reale, ma celebre per essere stato luogo di detenzione durante la
Rivoluzione francese. Le celle erano solo una stazione di transito verso la
ghigliottina, destino che toccò ai prigionieri più celebri: la regina Maria
Antonietta, e i rivoluzionari Danton e Robespierre.
Robben Island e il Memoriale
Hohenschönhausen: luoghi della memoria
In giro per il mondo diversi
centri di detenzione sono diventati luoghi di storia e di memoria. Robben Island
è un’isola a mezz’ora di traghetto da Città del Capo, in Sudafrica. Fu per tre
secoli utilizzato come luogo di confino e carcere e oggi è un sito riconosciuto
dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Qui Nelson Mandela fu privato della
libertà per 18 dei suoi 27 anni da carcerato. Nel 1964 fu condannato
all’ergastolo. Trent’anni dopo divenne il presidente del Paese.
A Berlino il Memoriale
Hohenschönhausen è l’ex prigione della Stasi, il servizio segreto della Germania
dell’Est. Nelle stanze i prigionieri venivano sottoposti agli interrogatori del
ministero per la Sicurezza di Stato. In Senegal, al largo di Dakar, l‘isola di
Goreé conserva ancora la Maison des Esclaves, il centro di raccolta in cui erano
rinchiusi gli schiavi destinati ad essere venduti per lavorare nelle piantagioni
delle Americhe.
Carceri diventate hotel di
lusso e ostelli
Alcuni ex istituti di pena
hanno trovato un’altra vocazione. È il caso di Het Arresthuis, casa
circondariale di Roermond, cittadina dei Paesi Bassi più vicina a Düsseldorf che
ad Amsterdam. Ha rinchiuso criminali dal 1863 al 2007 ma dal 2011 è un albergo
di pregio da 200 euro a notte. Le celle sono state riconvertite in eleganti
suite, ma la struttura interna e le porte delle stanze, così come le sbarre
sulla facciata, ricordano che il relax tra quelle mura è storia assai recente.
A Karosta, cittadina Lettone
sul Baltico, quella che fu una prigione nazista prima e sovietica poi è
diventata un ostello. Qui si è voluto conservare però l’aspetto opprimente di
una galera e, scivolando nel cattivo gusto, si può anche aderire all’iniziativa
“notte estrema” in cui i visitatori vengono accolti e (mal)trattati come dei
veri prigionieri
Oggi nel mondo ci sono circa
10 milioni e mezzo di persone incarcerate. Un quarto delle quali solo negli
Stati Uniti, il paese con il più alto numero, percentuale e assoluto, di
reclusi. Innumerevoli studi, e il caso americano ne è la prova, hanno dimostrato
che le prigioni di oggi non servono a prevenire i reati.
«Sono solo il centro di
reclutamento per l’esercito del crimine» disse il filosofo francese Michel
Foucault che dedicò una parte importante dei suoi studi ai sistemi di pena.
L’auspicio è quello che un giorno gran parte delle carceri possano diventare dei
musei.
Il silenzio degli
innocenti. Il carcere è una tortura e colpisce anche chi non ha fatto niente.
Iuri
Maria Prado su L'Inkiesta il 31 Maggio 2022.
La definizione non è
esagerata: la privazione della libertà è una delle cose più crudeli che possano
essere inflitte all’uomo. Chi lo sottovaluta (o, peggio, considera la prigione
una soluzione ottimale) dovrebbe pensarci due volte.
Quanto vedete un
Dio-Patria-Galera (ma Manipulite-Onestà-Galera è lo stesso) che alza il
sopracciglio perché sente dire che il carcere è una tortura, domandategli
questo: «Prova a immaginare che qualcuno più forte di te, esercitando un potere
inoppugnabile, sequestri la tua libertà e ti impedisca di fare una per una tutte
le cose che quotidianamente integrano le ore della tua vita, che magari giudichi
malandata. Prova a immaginare che in forza di quel potere ti si impedisca di
vedere la moglie, il marito, i figli, gli amici. Che in forza di quel potere ti
si imponga la solitudine che non desideri o una compagnia coatta. Che a causa di
quell’imposizione tu non possa leggere quel che vuoi, ascoltare la musica che
vuoi, mangiare quel che vuoi. Che tu non possa camminare, lavorare, studiare,
preparare la colazione a tuo figlio, festeggiare il suo compleanno, far visita a
un parente moribondo, partecipare al funerale di una persona a te cara, insomma
che tu non possa fare nulla di tutto ciò che consideri un’acquisizione
irrevocabile della tua esistenza. E prova a immaginare che questa somma di
privazioni si squaderni nei luoghi in cui sei costretto, tanto angusti e malsani
che perfino per il bestiame sarebbe troppo, e dove sei esposto a ogni genere di
sopraffazione, di violenza, di degradazione, per soprammercato
nell’indifferenza, quando non nel compiacimento, della comunità di cui facevi
parte. Ebbene, come considereresti questo trattamento ai tuoi danni, questo
accanirsi di un potere più forte di te sulla tua vita sino a svuotarla di tutto,
come lo considereresti se non per quel che è, e cioè tortura? E dunque: che
altro è se non questo, il carcere? Non è forse fatto delle stesse cose, delle
stesse angherie, della stessa brutalità, della stessa ignominia che tu, se
toccasse a te, chiameresti tortura?».
Se l’interrogato in tal modo
rispondesse che basta non delinquere per non subire quel trattamento, non
varrebbe la pena di obiettare che nemmeno al delinquente più incallito sarebbe
legittimo infliggerlo. Basterebbe ricordargli che uno su due, in carcere, è
innocente quanto lui. Non gli si chiede – sarebbe troppo – di immedesimarsi nel
colpevole. Gli si chiede di mettersi nei panni dell’innocente.
«Per decidere sul carcere
bisogna aver visto. Per questo la Consulta ha iniziato il suo viaggio».
Intervista al
giudice costituzionale Francesco Viganò: «Non si può continuare a pensare al
carcere come un luogo in cui si spediscono gli autori di reato per farli sparire
per un po’ dalla circolazione, pensando così di proteggere efficacemente la
società». Valentina Stella su Il Dubbio il 20 giugno 2022.
Il professor Francesco Viganò,
giudice della Corte Costituzionale dal 2018, ha redatto alcune delle più
importanti decisioni della Consulta degli ultimi anni. Dalla nota sentenza
18/2022 con cui è stata dichiarata illegittima la censura sulla corrispondenza
del detenuto in 41 bis con il difensore, alla 22/2022 che ha ammonito il
legislatore affinché elabori al più presto una legge per superare le criticità
dell’attuale sistema delle Rems. Dalla 150 del 2021 che ha ritenuto
incostituzionale l’obbligo del carcere per punire il reato di diffamazione a
mezzo stampa, alla 260 del 2020 per cui l’esclusione del rito abbreviato per i
delitti punibili con l’ergastolo non è irragionevole né arbitraria. Con lui oggi
ragioniamo di carcere ed esecuzione penale.
Cosa le ha lasciato il recente
incontro avuto con detenuti e detenenti al carcere di San Gimignano?
Ogni visita in carcere mi
lascia, più di ogni altra cosa, il ricordo degli sguardi delle persone che
incontro. Dei detenuti, ma anche degli agenti, degli educatori, dei volontari, e
naturalmente dei direttori e dei comandanti. Il carcere è una comunità chiusa, e
tutti coloro che ne fanno parte hanno un grande bisogno di parlare, di trovare
qualcuno che ascolti i loro bisogni, i loro problemi, le loro ansie quotidiane.
Passare del tempo con loro crea sempre dei canali di umanità e di empatia anche
in una realtà difficile come quella del carcere. Ed è fondamentale, io credo,
che le istituzioni nel loro complesso dedichino più attenzione a tutti i
protagonisti di quella comunità: non dimenticando gli agenti della polizia
penitenziaria, che sono pur sempre in prima linea nella gestione dei problemi
del carcere. San Gimignano, poi, è un carcere complicato, anche perché popolato
da condannati a lunghe pene detentive, a volte ergastolani, per lo più in regime
ostativo. Ripetere, in quel contesto, ciò che la Corte ha scritto nelle proprie
sentenze – e cioè che la Costituzione scommette sul cambiamento, qualunque sia
il reato che sia stato commesso, foss’anche il più orribile – è lì più difficile
che altrove, dal momento che le prospettive di uscire dal carcere sono oggi, per
quei detenuti, drammaticamente limitate.
Luigi Manconi ha parlato del
‘paradigma bidet’: “come è possibile che, nell’anno di grazia 2022, nemmeno
nelle sezioni femminili delle prigioni italiane vi sia quell’indispensabile
apparecchio igienico?”. Di cosa ha bisogno il carcere ora affinché possa
concretizzarsi l’art. 27 della Costituzione?
Ha bisogno, prima di tutto, di
molta più cura da parte dell’opinione pubblica e della politica, e ha bisogno di
maggiori investimenti. Non si può continuare a pensare al carcere come un luogo
in cui si spediscono gli autori di reato per farli sparire per un po’ dalla
circolazione, pensando così di proteggere efficacemente la società. Perché
quelle persone, prima o poi, usciranno e ricominceranno a minacciare la società
attraverso i loro reati. Per spezzare il circolo, occorrerebbe credere molto di
più nel grande progetto di rieducazione disegnato dalla Costituzione:
immaginando e realizzando carceri non solo provviste dei servizi igienici
indispensabili, ma in generale più rispettose della dignità umana di ogni
detenuto e capaci di offrire percorsi reali di cambiamento. Carceri più
“aperte”. Perché se questi percorsi non possono che iniziare dentro il carcere,
attraverso lo studio, lo sport, il teatro, il lavoro intramurario, devono poi
necessariamente svilupparsi al di fuori delle sue mura, per accompagnare il
condannato – con gradualità e prudenza – all’interno della società.
Assicurandogli, soprattutto, adeguate opportunità lavorative, anche dopo che la
pena sia stata interamente eseguita.
È sottovalutato il problema
dei detenuti con malattie psichiatriche e quello dei suicidi?
In ogni nostro incontro nelle
carceri il tema dei detenuti con disagio psichico viene sempre indicato come uno
dei problemi più difficili da gestire per l’amministrazione e, naturalmente, per
la polizia penitenziaria. E il dramma dei suicidi – dei troppi suicidi che
continuano a verificarsi nelle carceri italiane – non è che la punta di un
iceberg, in questo contesto. Nella recente sentenza sulle REMS, la Corte
costituzionale ha ribadito, all’unisono con la Corte europea dei diritti
dell’uomo, che le persone affette da patologie psichiatriche non devono stare in
carcere. La loro collocazione in carcere lede i loro diritti fondamentali,
traducendosi in un trattamento inumano e degradante, e assieme crea enormi
difficoltà per la polizia penitenziaria e gli altri detenuti. Se una persona che
ha commesso un fatto di reato soffre di un disagio psichico ed è al tempo stesso
pericolosa per la collettività, il suo posto non è il carcere, ma una struttura
in grado di avviare un serio percorso terapeutico, contenendone al tempo stesso
la pericolosità. Ma, anche qui, occorre che la società divenga consapevole della
necessità di investire adeguate risorse, umane e finanziarie, per affrontare
questo problema. Se necessario – come ha sottolineato ancora la Corte – anche
realizzando nuove REMS, le cui attuali disponibilità di posti sono enormemente
inferiori rispetto al numero delle persone che vi sono state teoricamente
assegnate in base ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Nel 2011 il professor Marco
Ruotolo ricordò: «A quanto mi consta Valerio Onida è stato il primo ad avvalersi
della facoltà riservata ai giudici costituzionali di visitare, senza necessità
di autorizzazione, gli istituti penitenziari». Condivide l’idea per cui chi deve
decidere delle vite dei detenuti, a partire dai magistrati di sorveglianza,
dovrebbe trascorrere sempre più tempo dei luoghi di privazione della libertà?
Certamente. Solo chi ha visto
il carcere dovrebbe decidere sul carcere. Anche per questo la Corte
costituzionale ha sentito il bisogno di intraprendere un viaggio nelle carceri
italiane: non una passerella ma un incontro vero con questa realtà, che fosse
uno scambio di conoscenze ed esperienze. Tutto il Viaggio è documentato sul sito
della Corte, tappa per tappa e in modo dettagliato, e in parte anche da un film
prodotto dalla RAI. Da lì poi sono nati altri incontri che in molti di noi hanno
continuato a compiere. Io stesso, dopo l’intensa visita a Marassi documentata
nel film, sono stato a Torino, a Milano, e ora – dopo la pausa forzata dovuta
alla pandemia – a San Gimignano. Più in generale, ho sempre pensato che chi si
occupa di diritto penale, a ogni livello, dovrebbe conoscere a fondo la
normativa e la prassi penitenziaria, e avere un’idea precisa di come si vive
quotidianamente nelle carceri. Per questo sono un convinto sostenitore dell’idea
che i magistrati in formazione trascorrano un periodo del loro tirocinio in
carcere, avendo contatti diretti con i detenuti, ma anche con l’amministrazione,
con gli agenti di polizia, con i formatori, con i volontari. Mandare una persona
in prigione, e stabilire quanto debba essere lunga la sua pena, è una grande
responsabilità, che richiede piena consapevolezza delle conseguenze delle
proprie decisioni.
Carmelo Musumeci da due mesi,
dopo 27 anni di carcere, è finalmente libero. In una intervista ci ha detto: «se
sai che devi morire in carcere, non metti un calendario sulla parete come gli
altri detenuti. Desideri solo che ti venga applicata la pena di morte». Anche il
Papa aveva parlato dell’ergastolo come di «pena di morte nascosta». Ma già Anton
Cechov nel 1890 scriveva che «la pena capitale, sia in Europa che da noi, non è
stata abolita, bensì camuffata sotto altre vesti, meno scandalose per la
sensibilità umana». Pensa che abbiano ragione?
Diciamo anzitutto che
l’ergastolo è, oggi, ritenuto compatibile con la Costituzione – e con l’art. 3
della Convenzione europea – solo a condizione che ci siano concrete possibilità
per il condannato di ottenere la liberazione condizionale dopo un congruo
periodo di espiazione della pena. Una pena detentiva senza questa prospettiva
sarebbe frontalmente contraria alla dignità umana, e per questo illegittima: lo
ha da ultimo affermato a chiare lettere, nel panorama internazionale, anche una
bella sentenza della Corte Suprema canadese del marzo scorso. Ciò posto, credo
che la sfida reale per l’ordinamento italiano sia quella di assicurare
effettività alla prospettiva di uscire dal carcere per gli ergastolani,
attraverso un percorso graduale che passi attraverso i permessi premio, il
lavoro all’esterno, la semilibertà, e infine sfoci nella liberazione
condizionale. Le relazioni del Garante ci restituiscono purtroppo un quadro in
cui questo obiettivo è troppo spesso estremamente difficile da raggiungere per
gli ergastolani: anche per quelli non ‘ostativi’. Occorre interrogarsi sulle
cause di tutto ciò, e lavorare perché il diritto alla speranza non si riduca a
una mera proclamazione di principio.
In una recente intervista al
Dubbio abbiamo discusso con il professor Fiandaca di abolizione del carcere. Per
lui occorre ‘promuovere forme di pedagogia collettiva che pongano e diffondano
le basi culturali per una drastica riduzione dell’utilizzo del carcere,
spiegando alla maggioranza dei cittadini che il carcere quasi mai è la medicina
e che in non pochi casi funziona come un veleno e che perciò può risultare non
solo inutile ma anche controproducente’. Che ne pensa?
Purtroppo, credo che si dovrà
ancora convivere molto tempo con il carcere. Chi critica la pena detentiva – con
mille ragioni, intendiamoci – non sempre si fa carico dell’onere di indicare
precise alternative in grado di tutelare efficacemente la società contro la
pericolosità espressa, in particolare, da talune categorie di condannati, per i
quali è difficile pensare ad una radicale rinuncia allo strumento della
privazione della libertà personale. La grande sfida, allora, è quella di
lavorare per rendere più efficiente il carcere rispetto alla finalità di
risocializzazione e quindi di riduzione della recidiva, minimizzandone al tempo
stesso gli effetti negativi sulla persona. Il che passa per un’idea di carcere
completamente diversa da quella oggi dominante, ma che già i Costituenti avevano
già tracciato nell’art. 27, con un’intuizione allora rivoluzionaria rispetto al
panorama delle costituzioni nazionali contemporanee. E al tempo stesso
occorrerebbe investire, con coraggio e fantasia, su percorsi esecutivi sin
dall’inizio alternativi al carcere, per tutta una fascia di reati di bassa e
media gravità. Percorsi che sarebbero certamente più efficaci in termini di
prevenzione della recidiva, e assieme meno gravosi per le finanze pubbliche.
Secondo Erving Goffman le
caserme e le carceri sono strutture chiuse, sottratte allo sguardo esterno e al
controllo dell’opinione pubblica e della rappresentanza democratica. Conosciamo
i fatti accaduti in molte carceri. La giustizia sta facendo il suo percorso.
Cosa bisognerebbe fare affinché certi episodi non si ripetano? Sarebbe d’accordo
a porre un codice identificativo sugli strumenti utilizzati dagli agenti
penitenziari?
Per fortuna, nell’ordinamento
italiano le carceri non sono sottratte al controllo dell’opinione pubblica,
principalmente grazie al lavoro svolto dal Garante nazionale e dai Garanti
regionali, oltre che all’impegno dei volontari e degli stessi avvocati che
meritoriamente si occupano sempre più della difesa dei diritti dei detenuti,
compresi i condannati in via definitiva. Inoltre, sempre più spesso accade che
la magistratura reagisca con prontezza ed efficacia agli abusi di potere
commessi in carcere. Ma a me pare che nell’ottica di una migliore prevenzione di
simili episodi – che letteralmente violentano la Costituzione – sia soprattutto
necessaria un’opera di formazione dell’amministrazione e della polizia
penitenziaria. Non solo per diffondere in modo più capillare una cultura dei
diritti e del rispetto della dignità dei detenuti; ma anche nel senso di una
formazione sulle best practices relative alla gestione di situazioni critiche
all’interno del carcere, incluse quelle in cui non può essere evitato un uso
proporzionato della forza fisica.
Il concetto di giustizia
riparativa è praticamente sconosciuto nella nostra cultura, improntata più alla
vendetta semmai. Eppure la Ministra Cartabia ha più volte ripetuto: “La
giustizia riparativa può diventare il pilastro della giustizia di domani”. Crede
che il nostro Paese sia culturalmente pronto ad accettare questo importante
cambio di paradigma?
Mentre sono scettico, come
dicevo, sulla possibilità di un superamento del carcere a breve o medio termine,
sono molto più ottimista sulle prospettive di un maggiore ricorso alla giustizia
riparativa, di cui oggi finalmente si parla intensamente nel dibattito pubblico
sulla pena. Ma su questo punto bisogna essere chiari: la giustizia riparativa
presuppone il coinvolgimento delle vittime, assieme ai rei, nel processo di
risanamento della ferita provocata dal reato. Il che impone anche alla dottrina
penalistica e processualpenalistica, così come all’avvocatura, un ripensamento
profondo sul ruolo della vittima nell’orizzonte della penalità e dello stesso
processo penale.
Nel suo ultimo saggio
“Giustizia mediatica – Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul
giusto processo”, il professor Vittorio Manes scrive, prendendo in prestito una
definizione di Filippo Sgubbi, che la vittima è «l’eroe moderno, ormai
santificato», istituita come tale «ante iudicium, ma anche fortemente
protagonizzata a scapito del presunto reo». Condivide questo suo pensiero?
Non c’è dubbio che la
discussione politica tenda a privilegiare le istanze di tutela della vittima su
quelle dell’imputato e poi del condannato, con effetti distorsivi che la
dottrina ben conosce e da tempo denuncia. Ma bisogna guardarsi dal demonizzare
le giuste aspirazioni delle vittime del reato, che non sempre cercano vendetta,
ma – questo sì – pretendono di essere ascoltate e di essere aiutate a superare
la sofferenza provocata dal reato. La stessa Corte costituzionale ha più volte
riconosciuto che il processo penale ha un particolare significato per le vittime
del reato, che hanno il diritto di parteciparvi in modo attivo e informato; e ha
altresì sottolineato, proprio nella sentenza sulle REMS, come l’ordinamento
abbia un preciso dovere di tutelare i diritti fondamentali delle potenziali
vittime dei reati che autori di reato pericolosi potrebbero nuovamente
commettere. Ma anche la giustizia riparativa, cui Lei faceva cenno poc’anzi,
presuppone un percorso che prenda sul serio il dolore della vittima, e che la
coinvolga assieme all’autore verso un esito diverso, e in definitiva più utile
per l’intera collettività, dalla mera vendetta.
"Il contatto diretto con
questa realtà è molto importante". “Colleghi magistrati entrare in carcere vi fa
bene, l’ergastolo ostativo ci lega le mani”: intervista a Marco Puglia, giudice
che scoprì la mattanza.
Viviana Lanza su Il Riformista il 24 Maggio 2022.
«Bisogna vedere, onorevoli
colleghi. Viverci in quelle celle. In certe carceri italiane bisogna starci per
rendersene conto», diceva Piero Calamandrei. Oggi a vedere cosa accade in
carcere ci vanno sempre meno politici, persino meno magistrati di sorveglianza.
Eppure sarebbe così utile, così costituzionalmente giusto. «Sarebbe opportuno
che la conoscenza del carcere non si arrestasse al magistrato di sorveglianza,
che istituti di pena entrino anche altri operatori del diritto, pm, giudici
avvocati, per avere una conoscenza immediata di cosa significhi lo spazio del
carcere», afferma Marco Puglia, magistrato di sorveglianza a Santa Maria Capua
Vetere.
Fu lui il primo ad entrare nel
reparto dei pestaggi dopo quel pomeriggio del 6 aprile 2020. A sorpresa bussò
alle porte della casa circondariale per verificare con i propri occhi quello che
timidamente qualcuno gli aveva riferito. La storia delle violenze è ora al
centro di un processo. Ed è solo la punta dell’iceberg in un sistema che è un
mare di casi e norme che faticano a seguire una corrente realmente garantista.
Perché è importante che un
magistrato conosca il carcere nella sua cruda realtà, che lo visiti, che si
renda conto con i propri occhi del luogo a cui destina indagati, presunti
innocenti?
«Il contatto diretto con
questa realtà è molto importante. Il magistrato di sorveglianza entra nelle
carceri come è normativamente previsto, dotato di un potere di ispezione da
esercitare, entra per conoscere quello spazio e quell’ambiente e verificare che
all’interno siano correttamente applicate le norme dell’ordinamento
penitenziario e della Costituzione. Entrare in carcere significa entrare in
contatto con la quotidianità di tanti soggetti: agenti penitenziari, direttori,
operatori giuridico pedagogici e popolazione detentiva che vive l’ingresso del
magistrato di sorveglianza con grande partecipazione. Diventa un momento di
confronto e di colloquio. Il magistrato di Sorveglianza in quel momento è lo
Stato che cammina all’interno dell’istituto penitenziario, è il potere
giurisdizionale che entra in un luogo che ha una sua sacralità legata alla
compressione di un bene fondamenta quale la libertà personale, ed è quindi
giusto che tutti i magistrati di sorveglianza entrino all’interno degli istituti
per segnare questo momento. Ma anche tutti gli altri operatori del diritto».
Mitterad in Francia abolì la
pena di morte. Qui in Italia si fa fatica ad abolire l’ergastolo ostativo, un
fine pena mai che equivale a una condanna fino alla morte.
«L’ergastolo ostativo è la
fotografia incancellabile, scolpita nel tempo e imperturbabile dei fatti che
hanno generato la condanna, un istituto insensibile ai percorsi trattamentali di
rinnovamento che la persona condannata può fare. Sono tanti i soggetti che pur
condannati per reati feroci, grazie al percorso fatto in carcere, hanno
dimostrato di essere persone nuove, ma si sono viste chiuse le vere porte di un
rinnovamento proprio dall’ergastolo ostativo che è condanna di un peso tale che
svilisce quello che è l’obiettivo costituzionale. Perché l’ergastolo ostativo è
legato a una valutazione lontana nel tempo che non richiede una
riattualizzazione della valutazione di pericolosità. Tutto ciò che è ostativo
nell’ordinamento penitenziario mette a dura prova la magistratura di
sorveglianza che ha le mani legate, salvo adire la Corte costituzionale, anche
davanti a percorsi che anelano un passo avanti, un’apertura trattamentale».
Si parlava di persone nuove.
Diventare persone nuove si può, meritare una seconda opportunità appartiene a
uno Stato di diritto, a una giustizia giusta. Va riconosciuta, no?
«Certo. E di persone nuove ne
ho conosciute tante. Una mi ha colpito particolarmente. C’era un condannato per
traffico internazionale di droga, aveva una condanna importante per fatti che lo
vedevano coinvolto sin da quando era adolescente. Questa persona era detenuta a
Carinola e quando si prospettò la possibilità di una misura alternativa, con la
cooperativa “Al di là dei sogni” di Sessa Aurunca, decisi di sperimentare. La
misura alternativa prevedeva che quel ragazzo lavorasse, regolarmente
retribuito, coltivando la terra nei possedimenti di questa coop che fa parte del
circuito di Libera. Questo detenuto iniziò così un percorso di totale
rinnovamento per cui oggi con la famiglia si è trasferito a Cellole e lavora con
la coop, lavora anche la moglie, e lui con Libera racconta la sua storia, dalla
scelta iniziale di essere un ragazzino di Scampia che guadagnava con la droga
alla decisione di ricalcolare la propria vita dedicandosi alla legalità e al
lavoro. Questa storia mi ha colpito perché io e questo detenuto siamo coetanei:
io sono di Secondigliano e lui di Scampia, siamo cresciuti a distanza di pochi
chilometri, l’uno inconsapevole dell’altro, scegliendo percorsi diametralmente
opposti. Mentre io studiavo giurisprudenza lui diventata elemento di spicco del
clan, mentre io mi laureavo lui entrava in carcere, poi grazie ai percorsi
magici della legalità ci siamo incontrati: io ho dato un’alternativa a lui e lui
ha dato a me il coraggio di credere negli altri come magistrato di sorveglianza
e di credere che non sempre tutto sia perduto».
Ci vuole il coraggio delle
scelte, il coraggio del garantismo.
«Concedere una possibilità a
chi è in un momento del percorso adeguato significa dare a quella persona
l’opportunità di uscire dal circuito criminale, ma significa anche far del bene
alla società che riaccoglie una persona rinnovata. Solo la criminalità potrebbe
giovarsi della volontà di chi è stato in carcere di tornare a commettere reati,
far sì che chi è in esecuzione di pena torni a noi nel migliore dei modi è un
bene per tutti».
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Parla la dottoressa
Donatella Ventra. “Non guardate con sospetto noi magistrati di sorveglianza,
venite in carcere”, intervista a Donatella Ventra.
Francesca Sabella su Il
Riformista il 7 Settembre 2022
La strage silenziosa in
carcere, giudici che non conoscono la realtà dove troppo spesso e con troppa
facilità spediscono chi siede sul banco degli imputati. Un sistema penitenziario
da rivedere e una cultura da cambiare. Ne abbiamo parlato con Donatella
Ventra, magistrato di sorveglianza presso la Corte d’Appello di Salerno.
Dottoressa Ventra, in carcere
ci sono stati 59 suicidi in otto mesi, 14 solo nel mese di agosto e vale a dire
più di uno ogni due giorni: è una strage. Un paese nel quale si muore in carcere
e di carcere può definirsi civile?
«Sono dati veramente
allarmanti, abbiamo già superato il numero dei casi totali del 2021 (quando ce
ne furono 57) con la differenza che siamo a settembre. Un altro dato che mi ha
colpito molto è che i detenuti di origine straniera che si sono suicidati in
carcere sono stati 28, costituiscono quindi il 47,5% dei casi. Questi sono dati
molto preoccupanti, ma che purtroppo tristemente non mi sorprendono. Andando
oltre i numeri, ci accorgiamo che ci sono tre categorie di soggetti a rischio
suicidario: gli stranieri, i tossicodipendenti e soggetti con problemi di
infermità psichiatrica».
Mi scusi, ma tossicodipendenti
e persone con problemi di salute psichiatrica non sono due categorie di detenuti
che in carcere non dovrebbero proprio starci?
«Eh… Questa è una questione
molto lunga. Purtroppo oggi i soggetti in cella che hanno queste problematiche
trovano una struttura carceraria inadeguata sia a livello strutturale che
organizzativo. Mancano i mediatori culturali per gli stranieri, manca
un’adeguata assistenza sanitaria per la salute mentale. I mediatori culturali
per gli stranieri, per esempio, sono importantissimi e la stessa cosa vale per i
detenuti tossicodipendenti e con problemi di salute mentale: così la pena assume
connotati afflittivi enormi. E non dimentichiamo che il carcere, anche nei
soggetti che non hanno fragilità, crea di per sé un trauma. A tutto questo si
aggiunge il sovraffollamento e la mancanza di agenti della polizia
penitenziaria».
Eppure, il carcere non è
affatto considerato come extrema ratio come invece dovrebbe essere per sua
stessa natura, anzi vige una smania di manette a fronte di una società sempre
più giustizialista. Lei cosa pensa?
«Da anni si pensa di
affrontare il problema del sovraffollamento come se fosse un’emergenza
momentanea e invece è un problema strutturale. Il legislatore nel corso degli
anni ha sempre pensato di apporre dei rimedi che si sono rivelati ben presto
fallaci. In realtà ci sono state misure che hanno finito per sostituirsi alle
misure alternative, in primis alla semilibertà che invece si basa su tutt’altro:
principio rieducativo della pena e principio della gradualità del trattamento».
La soluzione troppo spesso,
però, è “servono nuove carceri”, quando in realtà si dovrebbe cambiare questa
cultura manettara…
«No, non servono nuove
carceri. Bisognerebbe innanzitutto migliorare le condizioni di vita all’interno
del carcere e poi bisognerebbe incrementare l’accesso alle misure alternative.
Per fare questo sarebbe necessario un cambio di orientamento culturale che
purtroppo non c’è, perché bisognerebbe finalmente iniziare a considerare la fase
dell’esecuzione della pena non come un’inutile appendice di un processo da
liquidare in fretta e in modo semplicistico, ma come la fase più importante:
quella in grado di attribuire un reale significato in termini di giustizia a
tutto ciò che la precede. Capisco che l’appeal del carcere a livello politico è
prossimo allo zero perché parlare di carcere non porta voti, però bisognerebbe
invece invertire questa tendenza facendo capire che un sistema penitenziario
efficiente, con maggiore accesso alle misure alternative al carcere, non
soltanto consentirebbe di dare concreta attuazione ai principi di pari dignità
umana e uguaglianza sostanziale che sono previsti dalla nostra Costituzione, ma
consentirebbe anche di ab bassare il tasso di recidiva. La stessa figura del
magistrato di sorveglianza oggi viene guardata quasi con sospetto, come se
fossimo quelli che quasi distruggono le condanne, ma non è così. Io penso che
per ogni magistrato bisognerebbe prevedere un periodo obbligatorio di lavoro in
carcere. Ci sono colleghi che in carcere non ci sono mai entrati e questo è
profondamente sbagliato».
Quanto sarebbe importante per
un magistrato conoscere da vicino la realtà carceraria?
«Sarebbe importantissimo. Noi
abbiamo una Costituzione bellissima e ci dice che la pena deve essere
rieducativa e non contraria al senso di umanità, ma questa funzione rischia di
rimanere una formula astratta e priva di contenuti. Per un giudice che applica
le leggi e in primis la Costituzione, ritengo che sia una carenza grave non
conoscere le carceri.
Dottoressa, mi dice una frase
garantista…?
«Direi ai miei colleghi di
entrare in carcere almeno una volta perché altrimenti si ha una visione monca
del sistema giustizia. Dobbiamo pensare che tutto ciò che precede la fase
dell’esecuzione della pena e quindi indagini preliminari, processo di primo
grado, appello, Cassazione, viene vanificato se dopo la condanna non ci si
interessa più di quello che succede. Tutto quello che accade prima ha un senso
se poi la pena viene eseguita in modo da darle un senso, altrimenti è tutto
inutile».
Francesca Sabella. Nata a
Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole ha deciso, non
senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro. Giornalista
pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi
protagonisti.
Alessandro Stomeo su
L'Inkiesta il 18 Maggio 2022.
La pena di morte è stata
abolita definitivamente in Italia con l’entrata in vigore della Costituzione, il
gennaio del 1948, mentre ha resistito nel Codice Penale Militare fino ai primi
anni del 1990, cedendo poi il passo all’ergastolo. Io abolirei anche
l’ergastolo, ma sarebbe velleitario solo parlarne nel contesto in cui viviamo.
L’idea di fondo che domina la
Costituzione rispetto alla pena quale sanzione per l’autore di reati, è quella
della cosiddetta «rieducazione», ma non mi sembra che l’anelito contenuto
nell’art. 27 costituzionale si sia mai tradotto in realtà, con ciò scontentando
tutti.
La realtà, comunque, ci dice
che la detenzione in carcere, per come vissuta, è probabilmente uno dei più
visibili e nefasti errori della società moderna, che non ha saputo cogliere ed
approfondire la grande innovazione e la lucida prospettiva che i grandi
giuristi, filosofi ed intellettuali avevano introdotto con l’umanizzazione delle
pene corporali, della tortura, della pena di morte.
Ma cosa è diventata e come si
è evoluta la pena della detenzione in carcere, quanto è aderente al dettato
della Costituzione e, soprattutto, quale è lo scopo condiviso della pena
detentiva al nostro tempo? Lo Stato che irroga le pene detentive e le esegue in
che modo affronta i nodi problematici che gravitano intorno al carcere ed alla
funzione della pena?
Purtroppo i dati e le
oggettive evidenze dicono che il carcere (ed anche la pena) rimangono argomenti
demagogici da utilizzare a scopo elettorale. C’è chi vorrebbe «gettare le
chiavi» per i corruttori e i corrotti, chi per i ladri d’appartamento, chi per
gli «zingari» e gli immigrati irregolari, chi per gli stupratori o gli
spacciatori, molte volte sulla scia di freschi fatti di cronaca.
Intanto, però, il carcere è
diventato un luogo di morte, senza pena di morte, oramai appunto abolita. Si
muore perché si sceglie di farlo, per suicidio; l’ultimo nel carcere di Foggia
il 12 maggio 2022, che si aggiunge ad altri 22 suicidi solo nell’anno in corso,
oltre a 50 decessi per altre cause. I suicidi in carcere nell’anno passato sono
stati 54, mentre 62 nel 2020 con 68 e 90 decessi per altre cause negli stessi
anni. Il tasso percentuale di suicidi in carcere è circa 10 volte superiore che
all’esterno, più o meno 10 suicidi ogni 10.000 detenuti.
L’idea iconoclastica del
carcere come luogo di isolamento dei pericolosi e come luogo di «redenzione» per
i deviati, si è rivelata falsamente rassicurante e fallimentare, lasciando il
posto ad una realtà ben diversa nella quale gli istituti di pena sono luoghi
vuoti di speranza di reinserimento sociale, approssimativi nella architettonica,
fatiscenti, con carenze di organico sia tra le Forze di Polizia Penitenziaria
che, soprattutto, tra gli operatori sanitari, sociali e di supporto
amministrativo.
Il carcere, insomma, con i
problemi che porta, è diventata una patata bollente che si vuole accollare tra
le mani del primo che passa, visto che non è neanche un affare economico tanto
che con il PNRR Italia pare che gli stanziamenti siano di 132,9 milioni di euro,
utilizzabili dal 2022 al 2026 per la «costruzione e il miglioramento di
padiglioni e spazi per le strutture». Solo pochissime strutture in tutta Italia
ne potranno usufruire.
Nessun Governo ha avuto ed ha
una progettualità condivisa su come uscire da una impasse che riguarda decine di
migliaia di individui. Il lavoro della Commissione «Ruotolo», voluta dal
Ministro Cartabia, e il progetto di riforma della stessa Cartabia sono buone
intenzioni che dovranno fare i conti con un assetto parlamentare tutt’altro che
stabile.
Lo Stato
spende ogni giorno 164 euro per ogni detenuto. Il carcere non vale la pena e
costa sempre di più ma il 60% delle spese è per polizia e magistrati.
Viviana Lanza su Il Riformista il 12 Maggio 2022.
Il carcere non
consente alcuna sicurezza sociale. Pensare che chiudere nelle strutture
penitenziarie chi è accusato di reati possa rendere la comunità più sicura è
soltanto un’illusione. Fior di studi hanno dimostrato che la recidiva è bassa
tra coloro che hanno scontato una condanna con misure alternative ed è invece
alta (anche fino al 70%) tra coloro che hanno vissuto la reclusione in carcere
fine a se stessa, con pochi e sporadici percorsi di rieducazione. Basterebbero
questi numeri, e gli esempi di sistemi penitenziari europei come quelli
della Norvegia o della Spagna, per rendersi conto che il nostro sistema carcere
è fallito. Eppure questo “fallimento” ci costa ogni anno milioni di euro. E ogni
anno sempre di più.
Per il 2022 la
bozza del bilancio del Ministero della Giustizia aumenta di 124,4 milioni di
euro i fondi a disposizione per l’Amministrazione penitenziaria, che passano da
3,1 a 3,2 miliardi. Nell’annuale rapporto sulle carceri l’Associazione
Antigone affronta, tra gli altri, il tema dei costi del sistema penitenziario,
un argomento sul quale nei dibattiti pubblici e politici si tende molto spesso a
sorvolare. Leggendo, invece, i dati nel dettaglio ogni facile entusiasmo, di
quelli su cui la politica punta quando ha interesse a fare colpo sull’opinione
pubblica, si spegne. Più fondi per le carceri non significa affatto più
investimenti per rendere finalmente le carceri un luogo più umano (e sarebbe
pure ora, visto che l’Italia è stata condannata dall’Europa per il trattamento
inumano e degradante dei suoi istituti di pena).
Più euro per
l’amministrazione penitenziaria non si tradurranno in maniera proporzionale in
iniziative per fare più manutenzione delle strutture fatiscenti e per potenziare
le attività di reinserimento?. Non è detto. Quel che è certo è che la spesa
giornaliera per detenuto è in aumento rispetto agli anni scorsi: ammontava a
128,28 euro nel 2017 ed è salita a 164,33 euro nel 2022. Il carcere, quindi,
costa alla collettività sempre di più, ma per non svolgere la sua funzione
sociale e costituzionale. Assurdo, no? Di questi 3,2 miliardi che il Ministero
mette in campo, 2 (quindi più del 60%) sono destinati al corpo di polizia
penitenziaria. Cioè si continua ad investire sulla repressione, sulla reclusione
finalizzata a se stessa.
In particolare si
investe anche su personale amministrativo e magistrati (quasi 30 milioni, +14,5%
secondo i dati del report Antigone). Ora, è vero che ci sono nuove assunzioni di
personale da fare ma perché far diminuire i fondi dedicati alla manutenzione
ordinaria degli immobili e prevedere un incremento dei fondi per l’edilizia
penitenziaria (passati da 127, 3 milioni del 2021 ai 203 milioni
del 2022, sicuramente anche grazie al Pnrr ma per costruire qualche nuovo
padiglione)? E ancora, perché far diminuire di quasi 6 milioni (-1,8%) il
capitolo dedicato all’accoglienza, al trattamento penitenziario e di
reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, come emerge dal
report di Antigone?
A fronte di due
milioni in più alla voce “Spese di ogni genere” riguardanti la rieducazione dei
detenuti e quattro milioni per generiche “Altre spese” relative a mantenimento e
assistenza dei detenuti, si trovano 15 milioni in meno destinati alla
riqualificazione di impianti e attrezzature per le lavorazioni penitenziarie
all’interno degli istituti di pena. «Una diminuzione che desta qualche
preoccupazione», commenta Antigone. Forse sui bilanci relativi alla giustizia in
generale, e su quelli relativi al sistema penitenziario in particolare,
bisognerebbe fare delle riflessioni in più. Basti pensare che la spesa legata ai
ricorsi dei detenuti per le condizioni di detenzione in violazione dell’articolo
3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel 2020 è stata di 617,5
milioni. Che le somme per i risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi
di errori giudiziari ammontano a 50 milioni di euro mentre le somme per la
riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, quindi per
le lungaggini processuali, ammontano a 64 milioni di euro. Soldi della
malagiustizia che gravano sulle tasche della comunità. soldi che potrebbero
essere spesi per rendere tutto migliore. Anche le carceri.
Viviana Lanza.
Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Il carcere tra
la privazione di tutto e l’espropriazione di sé stessi.
COSIMA BUCCOLIERO su Il Domani
il 10 maggio 2022
Il carcere è soprattutto
privazione, non è solo perdita della libertà personale: una duratura condizione
di privazione totale. In carcere per qualunque situazione, esigenza, bisogno, si
deve chiedere il permesso a qualcuno.
Tutto quello che qui si muove,
si inventa, si immagina è regolato dalla pratica della scrittura su svariate
tipologie di moduli. Ho bisogno di una sveglia diventa: “Alla cortese attenzione
ecc. avrei bisogno di una sveglia ecc”. Stesura, rilettura. Firma.
Il carcere è anche un luogo di
espropriazione. Se io ho mal di testa apro un cassetto, frugo, prendo una
scatola di analgesici ed è fatta. Se un detenuto ha mal di testa, la gestione
del suo dolore diventa collettiva. Cosima Buccoliero è l’autrice del
libro: Senza sbarre. Storia di un carcere aperto.
COSIMA BUCCOLIERO dirige la
Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. In precedenza ha ricoperto la
vicedirezione della Casa di reclusione di Opera a Milano, la più grande in
Italia, mantenendo anche la guida dell’Istituto penale minorile di Milano Cesare
Beccaria. È stata vicedirettrice e poi direttrice della II Casa di reclusione di
Milano Bollate. In questi anni ha rivoluzionato l’approccio alla detenzione,
contribuendo a trasformare Bollate in un carcere modello ove si incontra
«l’umanità che non ti aspetti»
Celle ancora
strapiene, ma il carcere non doveva essere l’extrema ratio?
Viviana Lanza su Il Riformista il 7 Maggio 2022.
Basta con
questa visione carcerocentrica. Le celle scoppiano, i diritti sono mortificati,
la detenzione non ha altra funzione se non quella di rendere la condanna una
vendetta. «Il carcere deve essere integrativo, deve essere rete», dice Fra’
Giuseppe Pulvirenti, cappellano di Poggioreale, parlando da Scampia dove si
presenta il libro “Carcere” del garante Samuele Ciambriello. L’incontro si
svolge nell’Officina delle Culture “Gelsomina Verde”, organizzato da Ciro
Corona, presidente dell’associazione “Resistenza”. Carcere come extrema ratio,
dunque.
Non si tratta di
uno slogan da garantisti, lo prevede la legge. Il direttore del carcere di
Poggioreale Carlo Berdini, intervenendo al dibattito, afferma che «bisogna
capire in che misura e come il carcere possa essere necessario». «Ritengo –
aggiunge – che il carcere debba essere considerata una misura residuale. Deve
far sì che le persone non escano peggiori e il miglioramento dei detenuti deve
passare necessariamente dal lavoro, dalla cultura, da tutto ciò che prevede
l’ordinamento penitenziario». Lavoro, parola che dice tutto ma che spesso si
traduce in niente. Eppure quanto il lavoro sia importante nel percorso di
riscatto di chi vive la privazione della libertà personale è cosa nota, lo
ricorda Pietro Ioia, garante della città metropolitana di Napoli. «Il carcere si
dovrebbe reggere su tre pilastri: diritti, lavoro e inclusione territoriale
– aggiunge Enzo Vanacore, rappresentante della cooperativa L’uomo e il legno –
Tre obiettivi difficili ma vanno perseguiti».
Il percorso passa
per il reinserimento sociale. Adriana Sorrentino, referente Uepe Campania,
spiega come «il discorso sull’inserimento territoriale dei nostri ragazzi è il
motivo per il quale spesso sono in giro per il mondo per progettare interventi
che si possono fare». Servono ponti. «È necessario che prima di tutto si crei
una coscienza civica – conclude Ciambriello – . Non bisogna continuare a pensare
che il carcere sia una risposta certa e immediata, che ci è dovuta per la
sicurezza sociale. Carcere è l’anagramma di cercare. Cercare per ricostruire.
Siamo qui a Scampia con diverse associazioni, cooperative e detenuti in
affidamento in prova. Il Terzo settore è una “zattera” che può remare
controcorrente nel mare dell’indifferenza e della repressione».
Viviana Lanza.
Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è
giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed
economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del
quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il
Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Viviamo in una bara
nell’attesa di essere sepolti.
Giuseppe Grassonelli su Il Riformista il 6 Maggio 2022.
Alla fine di marzo è “evaso”
dal carcere di Opera un altro detenuto, morto di – come si dice – “morte
naturale”. Ma nessuna morte in galera può essere detta “naturale”. Alfio Laudani
aveva settantasei anni ed era gravemente malato. Stava scontando diverse
condanne all’ergastolo e ogni mese partecipava in stampelle al laboratorio di
Nessuno tocchi Caino. All’ultimo, a metà aprile, non si è presentato. I suoi
compagni detenuti lo hanno commemorato con parole commosse che riecheggiano in
questo scritto.
Quando Virginia
Woolf scrisse Al faro, aveva in mente un’elegia che portasse con sé il sapore
della vita che si perde. Dopo trent’anni di carcere, io sono giunto alla
conclusione che noi tutti riusciamo davvero a raccontare solo quello che
perdiamo, affidando alla parola il tentativo di trattenere il tempo. Si tratta
di un tentativo disperato, affermerebbe qualcuno, ma noi siamo Spes contra spem
e con questo nome, sotto l’egida di Nessuno tocchi Caino, ci incontriamo da anni
nel Carcere di Opera. Ci narriamo di un tempo che non ci appartiene più, un
passato dal quale ci siamo emancipati, e a questo sovrapponiamo i decenni di
reclusione, tirando le somme con i giorni appena trascorsi.
L’ultimo laboratorio si è
aperto con la commemorazione di un nostro caro compagno, venuto a mancare a
marzo. Sergio D’Elia, il nostro Segretario, ha aperto le riflessioni dicendo che
il cuore si ferma quando non c’è l’amore, perché non gli è concesso di amare ed
essere amato. Si può, infatti, essere vivi solo nel rapporto con l’altro e
ognuno è delegato a rappresentare la vita solo nella misura in cui ama ed è
riamato. In altre parole, l’unica obiezione che possiamo muovere al tempo che se
ne va è l’amore, che è come un calco capace di imprimere con il ricordo una
pergamena che scorre inesorabile. Il nostro racconto si allunga dei giorni
trascorsi e con essi cresce il numero dei compagni che in carcere hanno perso la
vita e che vogliamo ricordare. Ciò che più ci rattrista è che in noi sia
subentrata una certa abitudine alla morte, consapevoli di abitare in un cimitero
vivente, pronti alla bisogna, sapendo che domani l’ennesimo sacco nero
accompagnato da sguardi vuoti attraverserà il corridoio della sezione, portando
via nel silenzio assordante un altro detenuto. Noi non abbiamo nulla e siamo
privati anche del possesso del tempo: non possiamo fare programmi per domani,
non sappiamo quando ci sarà una lezione o un laboratorio, gli incontri li
sappiamo quando accadono.
Viviamo in regime di completa
espropriazione del tempo, eppure abbiamo una certezza: domani il sepolcreto
tornerà ad animarsi della morte e la sua porta si spalancherà per un’altra
vittima. A ogni gesto, la prigione recita al detenuto il suo memento mori con la
negazione degli utensili più banali, con l’impossibilità di una vita affettiva e
sentimentale, col divieto di umanità. È un’impresa sbucciare una mela o trovare
una superficie che rifletta per radersi senza tagliarsi con un rasoio in
momentanea concessione. In carcere non ci si specchia in nessun modo. La
filosofia mi ha insegnato che noi ci specchiamo negli amici e negli affetti,
attraverso quelle relazioni di cui parlava Sergio. L’immagine che di noi vediamo
nell’altro, diverso da noi, ci consente di evadere dalla prigione del nostro
essere. «Non siamo forse tutti prigionieri?», diceva Virginia Woolf attraverso
Mrs Dalloway.
Sì, siamo tutti prigionieri –
rispondo io – ed è per questo che abbiamo un vitale bisogno di amare, ma in
carcere un detenuto può solo guardarsi negli occhi di un altro uomo recluso come
lui e lì trovare il riflesso della sua stessa prigionia: viviamo in una bara.
Dalla parte opposta, si dice che la giustizia debba preservarsi dalle emozioni e
dai sentimenti, essere asettica e razionale come una scienza. Ma – vi domando –
come può dirsi giusta una giustizia che disconoscendo la pietas si veste della
freddezza che nel linguaggio quotidiano si attribuisce agli omicidi? Portare
testimonianza sulle morti dei compagni detenuti è un nostro dovere morale, lo
abbiamo sempre fatto nel modo migliore che ci era dato e non avremmo potuto non
farlo.
Noi detenuti siamo i
superstiti, i testimoni di una conoscenza di cui siamo diventati consapevoli a
poco a poco. Siamo una minoranza insolita e minuscola, quelli che per capacità o
per una strana sorte sono ancora vivi perché non hanno raggiunto il fondo o
forse, banalmente, perché siamo stati arrestati giovanissimi. Dice un verso
di Cristina Campo che «non si può nascere ma si può restare innocenti». Quei
ragazzi criminali arrestati trent’anni fa hanno appreso che colpevoli si può
diventare, ma qualche verso dopo Cristina scrive: «Non si può nascere ma si può
morire innocenti». Ecco noi non sappiamo ancora credere che la colpa si possa
perdere e si possa morire innocenti. Giuseppe Grassonelli. Ergastolano detenuto
a Opera
Dopo la mattanza di Santa
Maria, spazio alla fantasia. Detenuto telefona a carabinieri e garante, la
penitenziaria continua a sfornare fake: “Affermazioni ridicole”.
Ciro Cuozzo su Il
Riformista il 25 Agosto 2022
Un detenuto avrebbe utilizzato
un cellulare per lanciare una richiesta di aiuto all’esterno
del carcere di Poggioreale a Napoli. Avrebbe telefonato “dalla cella
ai carabinieri e al garante dei detenuti per segnalare di aver subito minacce,
non si sa bene da chi”. Un caso “eclatante e gravissimo” quello denunciato nella
mattinata di mercoledì 24 agosto da Aldo Di Giacomo, segretario generale del
Sindacato di Polizia Penitenziaria, e relativo alla sera precedente. Un caso
che però, come spesso capita quando a denunciare sono i sindacati di polizia
penitenziaria, non ha avuto alcun riscontro effettivo. Il fantomatico detenuto
non ha telefonato né ai carabinieri né al garante del comune di Napoli, Pietro
Ioia, né a quello regionale, Samuele Ciambriello.
Di Giacomo, da giorni
in sciopero della fame per protestare contro l’organico sempre più eseguo degli
agenti penitenziari presenti nelle carceri campane e dopo l’escalation di
suicidi di detenuti registrata ad agosto, è stato smentito da tutte le parti
chiamate in causa. All’ufficio stampa del Comando provinciale dei Carabinieri di
Napoli non risulta alcuna chiamata al 112 o ad altri militari dell’Arma da parte
di un detenuto di Poggioreale. Stesso discorso vale per i due garanti. “Anche
io, come il mio collega Samuele Ciambriello, non ho avuto nessuna telefonata da
un detenuto dal carcere di Poggioreale. Affermazione fatta da un sindacalista
della polizia penitenziaria. Affermazione priva di fondamento e ridicola in un
momento molto delicato per la questione carcere” taglia corto Ioia.
Duro anche il commento di
Ciambriello: “Poiché mi è stato chiesto da più giornalisti, vorrei chiarire, per
quanto mi riguarda, di non aver ricevuto alcuna telefonata cellulare dal carcere
di Poggioreale in cui mi siano state segnalate violenze. Se l’avessi ricevuta
avrei immediatamente informato le autorità competenti. Aggiungo che trovo
davvero molto triste che ci sia chi affronta i temi delicati del mondo
penitenziario (che comprende non solo i detenuti, ma anche operatori, educatori,
agenti, personale amministrativo, familiari) facendone sempre occasione di
polemiche pretestuose. Sono certo che meritiamo tutti di meglio“.
Nella sua nota-fake, Di
Giacomo ripropone la sola retorica: “Si pensi all’uso dei cellulari che ne fanno
i capo clan e i più pericolosi criminali per impartire ordini agli uomini dei
clan sui territori oppure come riprovano tanti episodi di cronaca per minacciare
cittadini e persino compiere estorsioni. È il caso di ricordare che nel 2020
nelle carceri italiane sono stati rinvenuti 1.761 telefoni cellulari. Erano
stati 1.206 nel 2019 e 394 nel 2018. Solo una piccola parte arriva attraverso
droni contro i quali non credo serva a molto la “schermatura” delle carceri come
pure qualcuno ha proposto tenuto conto che, come è stato accertato la
“consegna”, avviene in tanti altri modi”.
“E’ del tutto evidente che non
basta aver inserito, dall’ottobre 2020, il reato per chi introduce o detiene
all’interno di un istituto penitenziario telefoni cellulari o dispositivi mobili
di comunicazione, a differenza del passato quando era derubricato a semplice
illecito disciplinare. Servono pene più severe perché chi introduce il cellulare
se la cava con una sanzione amministrativa o con pene irrisorie e chi lo usa non
ha nulla perdere – conclude – Sarebbe sufficiente innalzare nel minimo a quattro
anni la pena in modo da disincentivare seriamente il fenomeno. L’alternativa per
lo Stato è dotare di ogni cella di un comodo impianto telefonico tanto per
contribuire al clima, per boss e capi clan, da albergo a quattro stelle”.
Non è la prima volta che i
sindacati di polizia penitenziaria forniscono ricostruzioni assai fantasiose di
quanto accade in carcere. Dopo l’orribile mattanza di Santa Maria Capua Vetere,
il cui processo inizierà a breve (oltre 100 gli imputati appartenenti alla
penitenziaria), sono state diverse le segnalazioni di presunte risse con il
coinvolgimento di decine e decine di detenuti puntualmente smentite.
Ciro Cuozzo. Giornalista
professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport
prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in
Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola
di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le
esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a
VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del
Riformista.
Il caso nel carcere di
Santa Maria Capua Vetere. Violentato e abbandonato in cella senza cure, il
dramma di Michele: “Ha tentato il suicidio”.
Andrea Aversa su Il Riformista
il 25 Agosto 2022
Ha solo 31 anni ma la sua vita
è stata praticamente segnata. Una cosa purtroppo normale per chi è detenuto.
Michele (nome di fantasia per tutelarne la privacy) è recluso
nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Quello della mattanza, quello della
mancanza di acqua. Infatti, proprio in una cella del reparto “Nilo”, è stata
consumata l’ennesima violenza.
Michele è stato abusato
sessualmente. Il presunto aggressore sarebbe un altro detenuto impegnato in
attività lavorative di manutenzione nei vari reparti. Michele ha denunciato i
fatti e per questo è stato bollato come un “infame”. È in isolamento nel reparto
di accoglienza. A 31 anni Michele è detenuto e traumatizzato – a causa della
violenza subita – e anche solo, perché isolato dagli altri reclusi. Ma cosa ben
più grave, pare che a Michele sia stato negato il diritto alla salute. «Non
sarebbe stato sottoposto al protocollo clinico previsto per le vittime di abusi
sessuali – ha spiegato a Il Riformista la Garante per i diritti dei detenuti
della provincia di Caserta, Emanuela Belcuore – Non avrebbe fatto un tampone
anale, un test nè per l’Hiv, nè per l’epatite, non avrebbe fatto una visita
urologica, non sarebbero stati fatti accertamenti volti a individuare possibili
tracce di sperma rilasciate dall’aggressore e non sarebbe stato neanche
trasferito al pronto soccorso».
Michele è in attesa di alcune
risposte da parte dell’amministrazione penitenziaria e dell’autorità
giudiziaria. Perché nonostante i solleciti, né lui, né il presunto carnefice
sono stati trasferiti. «Michele andrebbe trasferito, eppure la prima richiesta è
stata inspiegabilmente rigettata – ha detto la Belcuore -. Dovrebbe andare in
un’altra struttura che gli consenta di stare vicino alla famiglia». Ma come ben
sappiamo la burocrazia ha i suoi tempi e le sue procedure. Prassi che spesso
sono in contrasto con l’affermazione dei diritti individuali. E così la pratica
di Michele pare sia stata rallentata da un cavillo: il 31enne non avrebbe
indicato nella denuncia il nome e cognome del suo aggressore. Cornuto e
mazziato, “infame” solo a metà. Per questo motivo non ci sarebbe stato un deciso
intervento delle autorità competenti.
La storia di Michele è
drammatica come quelle di tante altre persone finite dietro le sbarre. Lui è
finito in cella per reati legati alla droga. Probabilmente è uno dei tanti in
attesa di giudizio. Spesso di detenzione si muore. A dimostrarlo i dati sui
suicidi: ben 54 i detenuti che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno. Sei
solo in Campania. Un 2022 da record per un primato di morte. Una carneficina
rispetto alla quale lo Stato e le istituzioni restano indifferenti. La politica
ha deciso di tenere da parte il tema carceri. Meglio rimuoverlo in tempi di
campagna elettorale. Gli ultimi non portano voti ma levano consensi. E Michele
sarebbe potuto essere uno di quei numeri, una cifra che avrebbe aumentato questa
infernale statistica. Il 31enne ha infatti più volte tentato il suicidio.
Un modo per farla finita, per
dire basta a una vita da incubo. L’unica soluzione per mettere fine ad una vita
di degrado e disumanità. E lui ha messo tutto nero su bianco, in una lettera
che Il Riformista ha avuto la possibilità di leggere. «Il mondo carcerario è
complesso – ha affermato la Belcuore – È un contesto che ha le sue situazioni,
di fatto estremamente complesse e incomprensibili per chi non le conosce. I
politici dovrebbero visitare più spesso i penitenziari per potersene rendere
conto». Infine, sul capitolo sanità, la Belcuore ha dichiarato: «Il sistema
sanitario delle carceri, da quando è passato di competenza alle Asl, non
funziona in modo efficiente. Per quanto mi riguarda l’area sanitaria dei
penitenziari della provincia di Caserta andrebbe commissariata. Non per le
professionalità delle singole persone che ci lavorano ma per la mancanza di
risorse, personale e per l’enorme dispendio di energie che va a discapito dei
detenuti». Andrea Aversa
"Mi hanno detto che se
voglio impiccarmi per loro è uguale". La lettera del detenuto violentato in
carcere: “Coltello alla gola e mi hanno penetrato, sono morto dentro”.
Andrea Aversa su Il
Riformista il 26 Agosto 2022
«Il direttore e il comandante
non si sono fatti vivi per parlare con me. Ho tentato il suicidio perché per me
non c’è più vita, mi hanno tolto tutto, sono morto dentro. Non sto ricevendo
nessun supporto morale. Anzi sono in accoglienza, nascosto come se fossi stato
io ad aver fatto del male a qualcuno» e ancora: «Mi hanno detto che se voglio
impiccarmi per loro è uguale perché chi piange è solo la mia famiglia. Mi hanno
costretto a pulire il bagno due volte al giorno, a cucinare come uno schiavo».
Sono alcune delle parole che Michele (nome di fantasia per tutelarne la privacy)
ha scritto lo scorso 4 agosto in una lettera.
Parole di dolore e angoscia
che hanno descritto l’incubo che il giovane detenuto ha vissuto. Ieri Il
Riformista ha pubblicato un articolo proprio in merito a questa vicenda. Oggi il
31enne è stato “magicamente” trasferito dopo che l’istanza era stata
inspiegabilmente respinta. Il caso è stato segnalato dalla Garante per i diritti
dei detenuti della provincia di Caserta, Emanuela Belcuore. Michele avrebbe
subito una violenza sessuale in cella: «Mi hanno messo un coltello alla gola, mi
hanno costretto a fare sesso orale e mi hanno penetrato. Io voglio ancora amare
ma ad oggi solo il pensiero di andare a letto con qualcuno mi fa vomitare. Ho
paura, ho sbagliato ma voglio la mia vita, voglio anche io una famiglia. In
questo buco sto perdendo la testa, non voglio più pensare alla morte.
Aiutatemi».
La lettera, di cui
pubblichiamo alcune parti, è un cazzotto allo stomaco. Un testo che dovrebbero
leggere le massime istituzioni dello Stato italiano per cercare di comprendere
un minimo ciò che può accadere dietro le sbarre di un penitenziario. Cosa ben
più grave, pare che a Michele non sia stato garantito neanche il diritto alla
salute. Al giovane detenuto non è stato applicato il protocollo clinico
previsto per gli abusi sessuali. Al 31enne non è stato fatto un tampone anale,
né un test per l’epatite, né per l’Hiv, non è stata fatta una visita urologica e
non è stato neanche portato al pronto soccorso. Se tutto dovesse essere
confermato ci troveremmo di fronte ad un caso più che di tortura. Altro che
comportamenti disumani e degradanti.
Michele ha avuto l’onore di
parlare solo con una psicologa: «Una visita di 30 secondi. La dottoressa viene
una volta a settimana. Non ne posso più, sto impazzendo. Mi stanno riempiendo di
gocce e tranquillanti, ma io non voglio impazzire qua dentro. Non li prendo gli
psicofarmaci, voglio restare lucido. Meglio morto che zombie». Michele sa di
aver sbagliato ma sa anche di non sentirsi a suo agio in un contesto come quello
del carcere. Lui vorrebbe solo indietro la sua dignità, la sua vita. Vorrebbe
riabbracciare la madre che «non mi ha insegnato ad essere un criminale, mamma mi
ha insegnato ad aiutare le persone a condividere il dolore o un pezzo di
pane». Per Michele non è stato affatto facile denunciare la violenza subita, non
solo per la difficoltà nel rivelare questa tipologia di trauma ma anche perché
da allora è stato bollato come un “infame”. Gli auguriamo, dalla nuova struttura
nella quale è stato trasferito, di riprendere a sognare perché fino ad oggi, di
notte ha pianto e pregato, «Dio di farmi morire e farmi andare nelle sue dolci
braccia».
Del resto Michele sarebbe
potuto diventare il 55esimo suicidio avvenuto in un carcere italiano dall’inizio
dell’anno. In Campania sarebbe stato il settimo. Un’altra mattanza ma di Stato.
Numeri che farebbero impallidire qualsiasi democrazia. Ma non quella italiana,
le cui istituzioni continuano a calpestare sia la Costituzione che lo Stato di
Diritto. Per rendersi contro dello scempio, basta assistere all’attuale campagna
elettorale: per i partiti il sistema penitenziario non esiste. Andrea Aversa
Il caso. Detenuto morto in carcere, due
agenti indagati per “l’omicidio” di Vittorio: aveva pochi mesi da scontare.
Viviana Lanza su Il Riformista il 14 Maggio 2022.
Le notizie che arrivano da Salerno, dopo la morte,
l’altro giorno, di un detenuto nel carcere di Fuorni, sono un’ennesima
testimonianza di quanto a rischio sia la tenuta del sistema penitenziario e di
quanto complicato e inumano sia viverlo. Questo vale sia per i detenuti sia per
chi in carcere ci lavora. Vittorio, detenuto con problemi di salute mentale, è
morto tre giorni fa stroncato da un malore per il quale non è servito nemmeno il
tentativo del 118 di rianimarlo e portarlo in ospedale. Due agenti della polizia
penitenziaria, gli ultimi ad avere avuto contatto con lui, sono ora iscritti nel
registro degli indagati con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Da
qualunque prospettiva la si guardi, questa storia testimonia le criticità di un
sistema che non funziona come dovrebbe, in cui i cortocircuiti sono frequenti e
spesso drammatici.
Ancora un morto in cella, ancora agenti indagati.
Di nuovo un’indagine della Procura a puntare la lente su quello che accade nei
padiglioni, nelle celle, nel vecchio e inadeguato sistema penitenziario. Di
nuovo dubbi e domande su questo sistema in rovina. Un anno fa parlavamo di Santa
Maria Capua Vetere, della mattanza di Stato, dei pestaggi organizzati da una
squadra di cento agenti contro un centinaio di detenuti. Adesso parliamo di un
detenuto poco più che trentenne morto a causa di un malore dopo una
colluttazione con due agenti della penitenziaria. Secondo gli agenti, si sarebbe
trattato invece di “un’azione di contenimento” come risposta all’aggressione da
parte del detenuto. Una versione che al momento non è stata sufficiente a far
chiudere il caso. Anzi.
La Procura di Salerno ha deciso di aprire
un’inchiesta e indagare sulla dinamica dei fatti. La versione degli agenti è al
vaglio e sarà confrontata con le varie testimonianze che nel frattempo si stanno
raccogliendo. Bisognerà aspettare innanzitutto i risultati dell’autopsia sul
cadavere del povero detenuto: questo esame, previsto per lunedì, darà dettagli
sulle cause della morte utili poi per ricostruirne le circostanze. È il primo
step dell’inchiesta, poi ci saranno l’esame delle testimonianze e l’analisi dei
filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Non si sa quanti e quali
scene della colluttazione tra Vittorio e gli agenti siano state catturate dagli
occhi elettronici presenti all’interno del carcere. I due agenti della polizia
penitenziaria risultano indagati per omicidio preterintenzionale: sono stati gli
ultimi a vedere in vita Vittorio, gli ultimi ad avere un contatto con lui. Gli
altri dettagli sono nodi da sciogliere. Mentre sullo sfondo iniziano a
delinearsi episodi e circostanze che hanno segnato gli ultimi giorni e le ultime
ore di vita in cella di Vittorio. Classe 1986, nato ad Aversa, Vittorio aveva
solo pochi mesi da scontare, a ottobre sarebbe uscito di prigione.
Detenuto psichiatrico aggredisce due agenti e
muore stroncato da infarto, che ci faceva in carcere?
Cosa ci faceva in cella? Viene da chiederselo
visto che è emerso che era un detenuto fragile, con problemi psichiatrici. Una
situazione che aggrava una piaga del sistema penitenziario. E che sommata alle
carenze di professionalità adeguatamente formate all’interno degli istituti di
pena diventa un male incurabile. Due giorni prima di morire Vittorio aveva
rifiutato il colloquio con il suo avvocato che era andato in carcere a
incontrarlo. «Perché era nella sesta sezione? Aveva o no provvedimenti di grande
o grandissima sorveglianza come previsto?» sono le domande che si pone adesso
anche il Sappe, sindacato della penitenziaria, scendendo in difesa degli agenti
indagati. «I nostri colleghi vivranno le pene dell’inferno, ma ci domandiamo se
si parla di detenuto psichiatrico perché era dimesso dall’articolazione
mentale?». Le stesse domande le poneva il garante regionale Ciambriello già
immediatamente dopo la notizia del decesso del detenuto. Ma in quel caso erano
in ballo solo i diritti di un detenuto e nessun sindacato si era schierato a
sostenerle.
Viviana Lanza. Napoletana, laureata in Economia e
con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal
2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca
nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli
per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie
di stampa (TMNews, Askanews).
Regime di celle chiuse nel
carcere della mattanza. Carcere di Santa Maria, dopo le violenze detenuti chiusi
in gabbia come gli animali.
Andrea Aversa su Il Riformista
il 2 Agosto 2022
Ci sono alcuni messaggi finiti
nell’occhio del ciclone. Parte della corrispondenza sequestrata dagli inquirenti
durante le indagini. Stiamo parlando dell’ormai purtroppo nota “mattanza”.
Quella avvenuta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020 e per
la quale il prossimo 7 novembre avrà inizio un processo. Il procedimento vedrà
sul banco degli imputati 105 persone, tra poliziotti, medici e personale
amministrativo. Secondo quanto spiegato dalla delegazione dell’osservatorio
campano di Antigone a Il Riformista, in quei messaggi traspariva uno degli
obiettivi di quelle violenze: costringere i detenuti da un regime di celle
aperte a uno di celle chiuse. Lo scopo è stato raggiunto considerato che da
allora i reclusi del “reparto Nilo” sono segregati in gabbia per 20 ore al
giorno. Come i detenuti del reparto di massima sicurezza, solo che il “Nilo”
sarebbe quello di prima accoglienza.
«Durante l’ultima
visita (avvenuta lo scorso 20 luglio, ndr), abbiamo dovuto constatare che
nonostante gli sforzi della nuova direzione di investire in nuovi percorsi di
reinserimento, in tutti i reparti – tranne che per il “Volturno” – vige questa
tipologia di regime detentivo». Sono state queste le parole dell’avvocato Gaia
Tessitore, a capo di quella delegazione. Con lei l’avvocato Paolo Conte: «Una
situazione drammatica, considerata anche la piaga del sovraffollamento e le
elevate temperature che d’estate trasformano le carceri in un inferno». Persino
il Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria (Sappe), in seguito ad alcuni
episodi di violenza avvenuti all’interno del carcere casertano, ha denunciato
tale situazione. «Così non si può andare avanti – ha dichiarato il Segretario
regionale Emilio Fattorello – Il lassismo che caratterizza il penitenziario di
S.Maria Capua Vetere è imbarazzante ed intollerante. Da mesi il Sappe denuncia
che non ci sono un direttore ed un Comandante di Reparto titolari, fissi, in
pianta stabile, eppure i vertici regionali e nazionali del Dap (Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, ndr) non assumono provvedimenti urgenti».
Anche per gli agenti della penitenziaria, in costante sotto organico, la vita in
carcere è dura: eppure nulla lo Stato ha fatto fino ad oggi per risolvere il
problema della mancanza di personale.
«In carcere quello che manca è
il lavoro – ha affermato il Segretario generale del Sappe Donato Capece – che
dovrebbe essere obbligatorio per tutti i detenuti dando quindi anche un senso
alla pena ed invece la stragrande maggioranza dei ristretti sta in cella venti
ore al giorno, nell’’ozio assoluto. E farli stare fuori dalle celle dodici ore
al giorno senza fare nulla non risolve i problemi, anzi!». E c’è dell’altro:
venti dei poliziotti imputati sono ancora in servizio all’interno del
penitenziario di Santa Maria. «Manca il numero sufficiente di educatori e del
personale sanitario – ha detto Emanuela Belcuore, Garante per i diritti dei
detenuti per la provincia di Caserta – E questo causa due gravi problematiche:
da una parte una difficile assistenza sanitaria, dall’altra l’assenza delle
attività trattamentali. Inoltre non dimentichiamo i tanti casi di covid
riscontrati in cella».
Ma c’è una “buona” notizia.
Dopo 26 anni, ovvero da quando il carcere di Santa Maria Capua Vetere è stato
costruito, dovrebbe essere presto concluso il processo di allaccio del
penitenziario alla rete idrica cittadina. Perché purtroppo nel 2022, in Italia,
questa è una novità positiva: il fatto che all’interno di una struttura
detentiva ci sia l’acqua corrente. Andrea Aversa
Dal ritorno in
libertà al suicidio, il giallo della morte in carcere di Erasmo.
Viviana
Lanza su Il Riformista l'1 Giugno 2022.
Erasmo aveva 47
anni. Lo hanno trovato morto in cella. Impiccato, con un lenzuolo intorno al
collo. Eppure, appena quarantotto ore prima aveva ricevuto la notizia di essere
stato ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali. Un provvedimento che
gli avrebbe consentito di lasciare il carcere, avere la possibilità di un lavoro
e con esso una prospettiva di futuro diversa da quella da recluso, dietro le
sbarre. Perché ha deciso di farla finita? Come è potuto accadere che nessuno sia
riuscito a intervenire in tempo?
Si tinge di
mistero la morte di Erasmo, trovato senza vita in una cella del carcere di Santa
Maria Capua Vetere. Nuove ombre si allungano sul mondo penitenziario. Morire in
carcere di carcere: succede ancora. Su questo caso è stata aperta un’inchiesta.
Il garante regionale Samuele Ciambriello mostra di avere dubbi sulle circostanze
di questo decesso. Sicuramente ci sono interrogativi a cui bisognerà dare
risposta. «Il detenuto – afferma il garante – si sarebbe impiccato con un
lenzuolo a poche ore dalla notizia di aver ottenuto l’affidamento in prova che
gli avrebbe consentito di riprendere a lavorare. La sua morte è chiaramente
avvolta da numerose ombre. Troppi interrogativi che necessitano di risposte
immediate che restituiscano verità e giustizia». Così, in una nota, il garante
campano delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale
interviene sul suicidio del detenuto 47enne nel carcere di Santa Maria Capua
Vetere. Si tratta, prosegue il garante, di una «morte inaspettata che lascia
sgomento dentro e fuori il carcere» e sulla quale «ci sarebbero delle
incongruenze».
Per questo
la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’autopsia
sul corpo del detenuto, l’esame si terrà oggi pomeriggio e servirà ad avere
qualche dato in più su circostanze e cause del decesso. Impossibile archiviare
frettolosamente il caso come suicidio. «La sua morte è stata classificata come
suicidio, ma dietro al folle gesto si celano dubbi – aggiunge Ciambriello – : il
detenuto, con problemi di tossicodipendenza, nella giornata di venerdì, avrebbe
ricevuto dalla compagna la notizia di aver ottenuto un provvedimento di misura
alternativa al carcere, quella dell’affidamento in prova ai servizi sociali,
tanto che avrebbe ricominciato a lavorare presso una cooperativa di Caserta. A
quarantott’ore da quella notizia, però, si è tolto la vita», riepiloga il
garante. Solo quarantotto ore prima Erasmo era al telefono con la compagna e si
mostrava felice di poter finalmente uscire dal carcere. «Invece da quella cella
è sì uscito, ma senza vita», tuona Ciambriello.
«Non si può
rimanere inermi davanti a storie come queste. Non si può continuare a morire di
carcere. In Campania nel 2022, c’è stato un suicidio nel carcere di Salerno,
altre morti sono ancora sospette e ci sono in corso indagini della magistratura,
e un detenuto è morto per Covid – aggiunge – . Restare insensibili davanti al
suicidio di un detenuto significa non ammettere che il sistema carcere ha
fallito. La politica, a vari livelli, si preoccupa di trovare soluzioni che
evitino queste morti? Come si previene? Penso che l’indifferenza sui temi del
carcere sia una concausa a». Nell’ultima relazione sullo stato delle carceri
in Campania è emerso il dato allarmante sugli eventi critici all’interno degli
istituti di pena e in particolare, in quello di Santa Maria Capua Vetere, un
aumento delle infrazioni disciplinari (622 casi nel 2021, quasi il doppio di
quelle costatate nell’anno precedente) e un preoccupante aumento degli atti di
autolesionismo (196 casi in un anno), oltre a un suicidio. Il caso di Erasmo,
dunque, è il secondo suicidio nel carcere samaritano nell’arco di un breve
periodo di tempo, e il terzo nella regione se si considera che un mese fa un
altro detenuto, nel carcere di Salerno, è stato colto da malore ed è morto in
circostanza da chiarire. Di carcere si muore ma sembra non importi quasi a
nessuno.
Viviana Lanza.
Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è
giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed
economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del
quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il
Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Ombre sul
presunto suicidio. “Esci dal carcere, vai a lavorare in cooperativa”, dalla
gioia al dramma: detenuto trovato morto in cella.
Redazione su Il
Riformista il 31 Maggio 2022.
Un detenuto di 47
anni è morto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. A
darne notizia è il garante campano Samuele Ciambriello secondo cui l’uomo, che
si chiamava Erasmo, “si sarebbe impiccato con un lenzuolo, dopo appena 48 ore
dalla notizia di aver ottenuto un provvedimento di affidamento in prova ai
servizi sociali, che gli avrebbe consentito di riprendere a lavorare. La sua
morte – riconosce il garante – è chiaramente avvolta da numerose ombre; troppi
interrogativi che necessitano di risposte immediate che restituiscano verità e
giustizia”.
Una morte
inaspettata, che lascia sgomento dentro e fuori il carcere, su cui ci sarebbero
delle incongruenze. Per questo, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua
Vetere ha disposto l’esame autoptico sul corpo del detenuto, in programma domani
pomeriggio. La sua morte è stata classificata come suicidio, ma dietro al folle
gesto si celano dubbi: il detenuto, con problemi di tossicodipendenza, nella
giornata di venerdì, avrebbe ricevuto dalla compagna la notizia di aver ottenuto
un provvedimento di misura alternativa al carcere, quella dell’affidamento in
prova ai servizi sociali, tanto che avrebbe ricominciato a lavorare presso
una cooperativa di Caserta. A quarantott’ore da quella notizia, però, si è tolto
la vita.
“È necessario
indagare sulle cause che hanno spinto Erasmo a compiere l’estremo gesto –
commenta Ciambriello – Al telefono con la compagna era felice di poter
finalmente uscire dal carcere e, invece, da quella cella è sì uscito, ma senza
vita. Non si può rimanere inermi davanti a storie come queste. Non si può
continuare a morire di carcere. In Campania nel 2022, c’è stato un suicidio nel
carcere di Salerno, altre morti sono ancora sospette e ci sono in corso indagini
della magistratura; un detenuto è morto per Covid. Restare insensibili davanti
al suicidio di un detenuto significa non ammettere che il sistema carcere ha
fallito. La politica, a vari livelli, si preoccupa di trovare soluzioni che
evitino queste morti? Come si previene? Penso che l’indifferenza sui temi del
carcere sia una concausa”.
Massimiliano Peggio
per “la Stampa” l’11 novembre 2022.
Di fronte al
giudice, tre giorni fa, si è era dimostrato sereno, collaborativo: accusato di
stalking dall'ex compagna, aveva spiegato di aver violato i divieti di
avvicinamento per fare un regalo al figlio minorenne. «Ho sbagliato, lo so:
volevo solo consegnare una busta di denaro a mio figlio per il suo compleanno,
non volevo importunare la mia ex».
Antonio, 56 anni,
autotrasportatore torinese, era in carcere dall'agosto scorso, in una cella del
padiglione C del Lorusso e Cutugno. Detenuto sottoposto a misura cautelare. Tra
pochi giorni, grazie a quella buona impressione fatta in udienza, sarebbe
sicuramente uscito. L'altra notte, dopo aver strappato le lenzuola a
striscioline per ricavarne una corda, si è impiccato alla grata della porta. Un
agente della polizia penitenziaria ha trovato il cadavere al mattino, durante il
controllo di routine. Prima di togliersi la vita, Antonio ha lasciato sul
tavolino una lettera-testamento. «Scusatemi».
Ieri sera c'è stata
una protesta dei carcerati torinesi poi rientrata. Dall'inizio dell'anno sono 77
i suicidi avvenuti nelle carceri italiane, il numero più alto di sempre. Nel
2009 erano stati 72. «I suicidi - afferma Stefano Anastasìa, portavoce della
Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà -
costituiscono il 51% dei casi di morte registrati in carcere nel corso
dell'anno, anche questa percentuale mai così alta da inizio secolo ».
Pochi giorni fa un
detenuto, di 22 anni, originario della Repubblica Dominicana, si era tolto la
vita nel carcere di Udine, in attesa di giudizio per tentato di omicidio, dopo
una rissa a Trieste. A Torino, dall'inizio dell'anno si sono registrati quattro
casi: il precedente, meno di un mese fa. Un giovane di origine africana, Tecca
Gambe, si era tolto la vita nello steso modo, annodando strisce di tessuto
strappate dalle lenzuola. Era in cella per un piccolo furto.
Antonio era accusato
di atti persecutori. «A luglio era stato arrestato una prima volta, su ordine di
custodia cautelare, a seguito della denuncia della sua ex compagna - spiega il
suo legale, Margherita Pessione - Dopo tre settimane trascorse dietro le sbarre
era uscito ma aveva l'obbligo di non avvicinarsi alla donna. Ad agosto aveva
violato il divieto presentandosi sotto casa della madre di lei: così era
scattato un secondo provvedimento cautelare.
«Ormai eravamo in
dirittura d'arrivo, sarebbe stato scarcerato a breve: in sede di udienza
preliminare avevano definito la situazione, chiarendo i motivi di quel
comportamento. Il mio assistito poteva sembrare assillante ma, a detta della
stessa donna, non si è mai dimostrato violento, testualmente non le ha mai torto
un capello».
Nelle carceri,
stando alle continue denunce dei sindacati della polizia penitenziaria, la
mancanza di personale è cronica: non solo per tenere a bada la violenza dei
detenuti, ma anche per proteggere le loro vite in preda alla disperazione.
«Salvo poche,
ammirevoli, esperienze di sostegno e accompagnamento al reinserimento sociale la
grande maggioranza dei detenuti e delle detenute vive la carcerazione come un
periodo più o meno lungo di abbandono e di disperazione - aggiunge Anastasìa -
Il numero di suicidi ne è una drammatica testimonianza».
Stroncato da un malore nel
corso di un scontro con due agenti (ora indagati). Detenuto morto in carcere,
l’autopsia: sul corpo segni di percosse che andavano avanti da giorni. E’ caduto
dalle scale?
Ciro Cuozzo su Il Riformista il 17 Maggio 2022.
Segni di violenza,
riconducibili a percosse subite da giorni, sul corpo di Vittorio Fruttaldo, il
detenuto di 35 anni stroncato da un malore dopo uno scontro fisico con gli
agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Fuorni a Salerno. E’ quanto
emerge da un primo esame esterno sul cadaere dell’uomo deceduto lo scorso 10
maggio durante il trasporto in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona. L’autopsia, iniziata ieri, verrà completata oggi e il quadro
sarà più chiaro.
Nel frattempo emergono
dettagli raccapriccianti che smentiscono la versione fornita dal sindacato di
polizia penitenziaria secondo cui il detenuto, affetto da problemi di natura
psichiatrica (circostanza smentita dai referti medici), avrebbe aggredito due
agenti con un coltello rudimentale e, nel corso della colluttazione, sarebbe
stato stroncato da un malore.
In realtà, stando a quanto
appurato dal professore di medicina legale dell’Università di Salerno incaricato
dell’autopsia, sul corpo di Vittorio sono presenti lividi e segni di violenza
riconducibili a percosse che andavano avanti da giorni, da tempo, non relative
alla sola giornata del 10 maggio. Vittorio, secondo quanto appreso
dal Riformista, era un detenuto che aveva problemi di tossicodipendenza. Avrebbe
finito di scontare la sua pena a ottobre 2022 e necessitava di una terapia per
disintossicarsi.
Che ci faceva dunque in
carcere? E perché gli agenti penitenziari lo ritengono un soggetto affetto da
problemi di natura psichiatrica pure in assenza di un referto medico che
cristallizzi il tutto? Il 35enne, originario di Aversa, sarebbe stato
‘rieducato‘ dai poliziotti dopo essersi reso protagonista di un’aggressione
avvenuta a inizio maggio. Fruttaldo avrebbe rifilato uno schiaffo a un agente in
seguito a un alterco e da quel giorno, sempre secondo quanto appreso
dal Riformista, sarebbe stato sistematicamente picchiato.
Una circostanza che saranno le
indagini della procura di Salerno a dover confermare. Tuttavia restano i segni
di violenza risalenti anche ai giorni precedenti il decesso e la richiesta,
nella prima perizia mandata ai pm (ieri però in scipero), di acquisire anche
le telecamere di videosorveglianza relative ai giorni precedenti, in modo tale
da far luce sui presunti pestaggi che il detenuto subiva.
Oggi nel frattempo verrà
completata l’autopsia che fornirà ulteriori dettagli sul decesso del 35 anni. Al
momento i due agenti “aggrediti” (secondo il sindacato) sono indagati
per omicidio preterintenzionale (quando dall’azione od omissione deriva un
evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente). Accusa che
potrebbe cambiare dopo l’esito dell’autopsia.
Fondamentali saranno anche le
testimonianze degli altri detenuti che dovrebbero essere ascoltati dagli
investigatori per far luce su quanto accaduto nel carcere di Salerno ed evitare
che si ripetano episodi analoghi alla mattanza di Santa Maria Capua Vetere
quando, prima delle misure cautelari e delle devastanti immagini che sconvolsero
l’opinione pubblica, i detenuti, impauriti di subire ulteriori ripercussioni,
derubricavano le percosse subite con l’oramai celebre “sono caduto dalle scale“.
Ciro Cuozzo. Giornalista
professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport
prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in
Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola
di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le
esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a
VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del
Riformista.
Ida Artiaco per fanpage.it il
9 agosto 2022.
“So che avrei potuto fare di
più per lei, non so cosa, ma so che avrei potuto fare di più". È questo uno dei
passaggi della lettera firmata dal giudice di Sorveglianza Vincenzo Semeraro del
Tribunale di Verona e letta durante il funerale di Donatella, la detenuta 27enne
nel carcere di Montorio che si è suicidata la scorsa settimana.
Durante le esequie, che si
sono tenute nella Chiesa Parrocchiale di Castel d’Azzano, un'amica della giovane
ha letto la missiva del magistrato: "Se in carcere muore una ragazza di 27 anni
così come è morta Donatella, significa che tutto il sistema ha fallito. E io ho
fallito, sicuramente", è un altro passaggio del testo. "Inutile dire che la
sensazione che provo è quella di sgomento e dolore. So che avrei potuto fare di
più per lei".
Presente al funerale di
Donatella anche il fidanzato Leo, a cui aveva inviato una lettera di addio prima
di compiere il drammatico gesto. "Leo amore mio, mi dispiace. Sei la cosa più
bella che mi poteva accadere e per la prima volta in vita mia penso e so cosa
vuol dire amare qualcuno ma ho paura di tutto, di perderti e non lo sopporterei.
Perdonami amore mio, sii forte, ti amo e scusami". aveva scritto la 27enne, che
si trovava in carcere per una serie di furti.
"Parlare di lei, al passato,
mi riesce difficile – ha detto il ragazzo alla Gazzetta del Sud, incredulo – Al
momento, posso dire poche cose, perché tanti sono i pensieri che affollano la
mia mente. Io voglio che passi il messaggio giusto. Dona era una ragazza solare
e spensierata, che sognava di tornare a fare l’estetista. Ci conosciamo da
quando eravamo ragazzini. E io avevo anche preso una casa per lei. Ma poi, negli
ultimi 8 mesi, non so cosa sia successo".
E poi ancora: "Era triste. Il
suo sorriso è stato spento e oggi mi chiedo cosa sia successo in quei minuti. In
cui, probabilmente, si poteva fare qualcosa. Oggi mi faccio tante domande, ma
spero che la sua morte lasci una traccia nella nostra società. E che non si dica
che si è suicidata una drogata e non si discuta frettolosamente del suo passato.
Spero davvero che nessuno si dimentichi di lei".
Donatella, 27enne suicida
in cella. Il giudice: «Anch’io ho fallito, il carcere non è per le donne».
Laura Tedesco su Il Corriere della Sera il 10 Agosto 2022
Il magistrato di Sorveglianza
Vincenzo Semeraro seguiva Donatella da 6 anni: «Ho pianto abbracciando il
padre... Mi chiedo cosa avessi potuto fare di più per lei? Non ho capito che il
malessere era divenuto profondo»
«Siamo persone prima che
giudici. E io, come magistrato ma soprattutto come uomo, sento di aver fallito
adesso che una ragazza di 27 anni di cui mi occupavo dal 2016, si è tolta la
vita in carcere».
Vincenzo Semeraro è il giudice
di Sorveglianza del Tribunale di Verona che ha scosso le coscienze scrivendo una
lettera che è stata letta in chiesa durante i funerali di Donatella Hodo,
giovane che lottava contro problemi di dipendenza da stupefacenti e una grande
fragilità. Usciva e rientrava in cella di continuo per alcuni furti legati alla
droga, si è lasciata morire la notte del 2 agosto inalando del gas dal
fornelletto in cella.
Perché si sente in colpa,
giudice Semeraro?
«È da una settimana, da quando
Donatella ha attuato il suo tragico gesto, che continuo a pormi mille
interrogativi. Dove ho sbagliato, in che cosa? Ogni volta che una persona
detenuta in carcere si toglie la vita, significa che tutto il sistema ha
fallito. Nel caso di Donatella, io ero parte del sistema visto che seguivo il
suo caso da sei anni. Quindi, come il sistema, anche il sottoscritto ha
fallito».
In che cosa crede di aver
sbagliato?
«Sono proprio questi i dubbi
che mi affliggono. Cosa avrei potuto fare di più per questa ragazza? Forse
l’ultima volta che sono andato a farle visita nel penitenziario, a giugno, avrei
potuto dirle due parole in più? Perché, nonostante la conoscessi da quando aveva
21 anni, non ho captato che il malessere era divenuto così profondo?».
Donatella aveva un passato
difficile.
«Alle spalle aveva
vicissitudini pesanti come macigni. Per andare avanti si era costruita una
corazza, voleva sembrare forte ma in realtà celava una sensibilità estrema. Era
fragile come un cristallo».
Ne parla come uno psicologo,
non solo come un giudice...
«Il punto secondo me è proprio
questo. Quando sei magistrato dell’Esecuzione e gestisci le varie vicende
carcerarie e detentive, non hai a che fare solo con un detenuto ma innanzitutto
con una persona. Uomini, donne con storie diverse. Non vanno trattati come
numeri, come pedine di un ingranaggio, ma come individui differenti l’uno
dall’altro. Sono persone, certo recluse in cella, ma pur sempre persone».
Donatella che persona era?
«Mi crede se le confesso che
ho impiegato anni prima di instaurare con lei un vero dialogo? Sembrava
invalicabile dietro quel muro che si era eretta, solo a marzo di quest’anno
credo di aver installato con lei una connessione, in quel momento Donatella ha
capito di potersi fidare di me».
A marzo era stata trasferita
in comunità.
«Infatti, avevo fatto in modo
che uscisse dal carcere perché la cella non era il posto idoneo per lei.
Purtroppo poi era scappata, tornando quindi lì. A breve era in arrivo per lei
una misura alternativa con affidamento terapeutico al Sert, doveva solo
pazientare un po’. Purtroppo la sua fragilità ha preso il sopravvento nella
solitudine di quella cella».
Perché «il carcere non era il
posto idoneo» per questa giovane donna?
«Aveva bisogno di un adeguato
sostegno psicologico, un servizio di supporto che l’intero sistema non riesce a
garantire non solo nel carcere di Verona ma in tutti i penitenziari d’Italia. Le
strutture detentive non sono a misura di donna, le detenute vanno approcciate in
modo totalmente diverso, hanno un’emotività che non ha nulla a che fare con
quella maschile. Vanno seguite in modo specifico e del tutto peculiare. Per
Donatella ciò non è avvenuto».
Dopo i funerali lei ha voluto
incontrare privatamente il papà di Donatella.
«Ci siamo abbracciati,
piangevamo entrambi. Tutti e due ci sentiamo in colpa, io come giudice, lui come
genitore. Ciascuno ha detto all’altro di farsi forza, è stato toccante. Ma il
momento più lacerante è stato quando il papà di Donatella mi ha ringraziato,
perché sua figlia gli parlava di me come di un secondo padre. Da brividi».
La lettera del giudice:
«Quel suicidio è anche colpa mia…».
Le parole di Vincenzo
Semeraro, magistrato di sorveglianza del Tribunale di Verona, al funerale della
giovane morta suicida in carcere. Simona Musco su Il Dubbio il 10 agosto 2022.
«Se in carcere muore una
ragazza di 27 anni così come è morta Donatella, significa che tutto il sistema
ha fallito. E io ho fallito, sicuramente…». Le parole di Vincenzo Semeraro,
magistrato di sorveglianza del Tribunale di Verona, suonano come un monito e,
insieme, un’autocritica lucida. La sua lettera, letta ad alta voce da un’amica
di Donatella, ha rotto il silenzio della chiesa di Castel d’Azzano, dove lunedì
è stato celebrato il funerale della 27enne, morta suicida in carcere lo scorso 2
agosto. Il suo nome è uno dei tanti sulla triste lista che, ormai, viene
aggiornata ogni giorno. Nomi che non fanno notizia, generalmente. Ma la storia
di Donatella, sintetizzata da una straziante lettera d’addio indirizzata al
fidanzato Leo, ha squarciato il velo, mettendo a nudo le storture di un sistema
che la politica tende a ignorare, salvo invocare regole più rigide, più dure.
Regole che vogliono i detenuti solo come numeri e non come persone, con storie e
fragilità. Un sistema non piace nemmeno a chi ci vive dentro per mestiere. «So
che avrei potuto fare di più per lei – ha scritto il magistrato che l’ha seguita
negli ultimi sei anni -, non so cosa, ma so che avrei potuto fare di più».
Semeraro, in Veneto dal 2009,
ha conosciuto Donatella nel 2016, quando la giovane ha iniziato ad entrare ed
uscire dal carcere per via dei suoi problemi di tossicodipendenza. Una storia
personale molto difficile, la sua, «per ragioni privatissime», spiega al Dubbio
il magistrato, che non riesce ad accettare che questa storia sia finita così.
«Facendo questo tipo di lavoro si hanno ovviamente contatti con i detenuti,
contatti che devono essere molto frequenti: per mestiere io devo godere della
fiducia dei detenuti e devo avere fiducia in loro, dovendo decidere se concedere
benefici o misure alternative. Ed è quasi inevitabile che a qualche detenuto ci
si affezioni di più», racconta. Negli ultimi 13 anni Semeraro ha sempre avuto a
che fare con detenute donne, prima nel carcere di Venezia e ora a Verona.
«Quello di Donatella era un caso che avevo preso particolarmente a cuore, perché
nell’arco di sei anni l’ho vista finire in carcere più volte. Aveva un carattere
particolare: era fragile come un cristallo di Boemia e al tempo stesso aveva
paura di mostrare agli altri questa sua fragilità. Per questo si era costruita
intorno una corazza e il suo carattere, al primo approccio, poteva risultare
particolarmente difficile – racconta -. Io ho dovuto sudare le proverbiali sette
camicie, forse anche di più, per riuscire a conquistare la sua fiducia e ad
avere fiducia in lei. All’inizio dell’anno l’ho inviata in comunità, un
esperimento che, purtroppo, è finito male, perché forse lì non ha trovato
l’ambiente adatto per lei». Da quella comunità, infatti, Donatella è scappata,
motivo per cui è finita di nuovo in carcere, dove si è tolta la vita. «Credo
davvero a ciò che ho scritto in quella lettera – aggiunge Semeraro -: quando si
muore così vuol dire che il sistema dell’esecuzione penale, così come è
concepito in Italia, ha fallito. E tra i primi soggetti che hanno fallito io
metto me stesso». Ma cosa poteva fare di più un singolo magistrato? «Non lo so.
So che avrei potuto. Magari parlandoci 10 minuti in più, magari dicendole due
parole di conforto in più o tenendola mezz’ora di più a colloquio quando veniva
da me. Non lo so, credo che avrei potuto fare mille cose. Ed è vero, è il
sistema che ha fallito, io però sono un ingranaggio del sistema», aggiunge.
In Italia, però, c’è una certa
difficoltà a guardare l’esecuzione della pena in un’ottica costituzionalmente
orientata. E così il carcere diventa un non-luogo, un posto in cui i diritti,
spesso, vengono sospesi e il fine rieducativo della pena messo in soffitta. E se
ciò è vero normalmente, quando a finire in carcere è una donna i problemi
raddoppiano. «Il carcere come istituzione è pensato per gli uomini – sottolinea
Semeraro -, perché è un’istituzione che ha come scopo primario quello di
contenere la violenza e l’aggressività, che sono caratteristiche tipicamente
maschili. Un carcere che dia modo alla emozionalità, caratteristica tipicamente
femminile, di esprimersi, in Italia non c’è. Trattare la detenuta come se fosse
un detenuto è un errore marchiano. Poi i risultati sono questi». Ma più in
generale, a non convincere il magistrato è la filosofia del “chiuderli dentro e
buttare la chiave”. «Tutto ciò è sicuramente in contrasto con l’articolo 27
della Costituzione, che non parla di pena, ma di pene. È chiaro che il
legislatore del 1948 non poteva pensare alle misure alternative alla detenzione,
forse erano troppo in là da venire – aggiunge -, però già da allora non si
pensava alla reclusione o all’arresto come unica forma di esecuzione della pena.
E questo è molto importante. Ora, al di là del fine costituzionale della pena,
fingiamo che le misure alternative non esistano e che la pena vada scontata
interamente in carcere. Chi paga? Noi tutti, con le tasse. Ma se il condannato,
anziché stare in carcere, sta in misura detentiva, ai domiciliari o meglio
ancora in affidamento in prova al servizio sociale e lavora, guadagna e paga le
tasse, c’è una ricaduta migliore per la società tutta. Basterebbe riflettere su
questo, al di là dell’adesione ai principi della rieducazione, che sono
fondamentali». Principi più volte ribaditi dalla Corte costituzionale, che non
più tardi di due o tre anni fa, ha riconosciuto che la pena ha una natura
polifunzionale. «C’è l’aspetto preventivo, quello retributivo – aggiunge -, ma
quello rieducativo non può mai mancare e deve essere prevalente su tutti gli
altri».
Ma c’è anche un altro aspetto
da considerare: la piaga della tossicodipendenza in carcere, problema che la
politica aveva iniziato ad affrontare con gli istituti a custodia attenuata per
i tossicodipendenti, salvo poi far finire tutto in un nulla di fatto. «La
questione è stata ripresa in mano con i tavoli della riforma penitenziaria, che
però hanno sortito poco, perché il governo gialloverde ha fermato le riforme
prospettate – spiega Semeraro -. Pochissimo di ciò che era previsto è stato
tradotto in legge. E non dobbiamo nasconderci: la droga in carcere purtroppo
circola, soprattutto grazie ai detenuti che – più o meno direttamente – sono
legati alle organizzazioni criminali e che si avvalgono dei più deboli per lo
spaccio». Di fronte a questi problemi si invocano, in genere, pene più severe.
Ma tutto questo «non servirebbe a nulla», spiega il magistrato. «Andrebbero
colpite le organizzazioni criminali – conclude -, soprattutto con le confische,
che consentono di disarticolare l’organizzazione. Ma se dopo la confisca i beni
e i patrimoni rimangono sotto sequestro senza essere utilizzati con uno scopo
sociale, chi vince non è lo Stato, ma l’organizzazione criminale».
La 27enne si è tolta la
vita nel carcere di Verona. Donatella morta suicida in carcere, il papà incontra
il giudice: “Ci siamo chiesti perdono”.
Elena Del Mastro su Il
Riformista il 10 Agosto 2022.
“Se in carcere muore una
ragazza di 27 anni così come è morta Donatella, significa che tutto il sistema
ha fallito. E io ho fallito, sicuramente…”. Sono queste le parole di Vincenzo
Semeraro, giudice di Sorveglianza del Tribunale di Verona, in una lettera letta
durante il funerale di Donatella, la 27enne che si è tolta la vita in
carcere. Il papà di Donatella ha deciso di incontrarlo. Si sono abbracciati e
hanno pianto insieme.
“Io e il giudice piangevamo
tutti e due. Ci sentiamo sconfitti e perdenti, ci siamo chiesti perdono. Avevo i
brividi, la mia Donatella mi parlava sempre di questo magistrato come di un
secondo padre, diceva che era l’unico ad aver preso a cuore la sua
situazione. All’inizio nessuno trovava la forza di parlare, solo lacrime”, ha
detto il papà, come riportato in un’intervista rilasciata al Corriere della
Sera. La storia di Donatella, il 47esimo suicidio in Italia stringe il
cuore. Pochi giorni dopo il numero è salito ancora, il 10 agosto se ne contano
49 solo da gennaio.
La lettera del magistrato alla
famiglia ha colpito molto. “Conoscevo Donatella dal 2016 – continua la lettera –
avevo lavorato con lei e per lei in tante occasioni, ultima delle quali nel
marzo scorso, allorché la inviai in comunità a Conegliano. Inutile dire che la
sensazione che provo è quella di sgomento e dolore… So che avrei potuto fare di
più per lei, non so cosa, ma so che avrei potuto fare di più!”. Il giudice ha
chiesto all’amica di “portare le mie condoglianze ai familiari, anche se in
questo momento ho pudore, perché è ragionevole che chi era vicino a Donatella
possa provare rabbia nei confronti delle istituzioni e di chi, più o meno
degnamente, le rappresenta”.
Invece poi c’è stato
l’incontro tra i due in un momento di commozione e condivisione del dolore. Due
padri che piangono la morte di una figlia. “Ecco, quando ci siamo visti ho
proprio voluto dire al magistrato che non deve sentirsi in colpa, perché
Donatella mi raccontava sempre l’impegno che lui ci metteva nel seguire la sua
vicenda. Questo giudice seguiva il caso di mia figlia con vera dedizione, le
faceva visita in carcere, cercava soluzioni. Certe volte ho avuto la sensazione
che la seguisse di più lui di me. Lei me lo descriveva come un secondo padre”.
Il papà ha raccontato al
Corriere del passato burrascoso di Donatella, quel vortice buio che per lei era
la droga. Di tutte quelle volte che la figlia è caduta e con fatica ha cercato
di rialzarsi. Il papà era sempre al suo fianco ma non riesce a esimersi
dall’avere un grosso senso di colpa in cuor suo: “L’ho detto prima anche al
giudice Semeraro: lui non ha fallito perché ha fatto il massimo, sono io che
probabilmente ho fallito come genitore. Potevo fare di più? Forse ho sbagliato a
rimproverarla quando era scappata dalla comunità? Le avevo parlato in modo
rigido perché aveva sbagliato ad allontanarsi da quella struttura, però l’avevo
fatto per il suo bene…”.
Il papà non si sarebbe mai
aspettato un gesto estremo dalla figlia. “Soltanto Donatella sa cosa ho fatto io
per lei negli ultimi dieci anni, volevo a ogni costo aiutarla a uscire dalla
dipendenza. L’ho accompagnata dappertutto, anche in vari centri specializzati
fuori dall’Italia per guarire dalla droga, tutte strutture private a pagamento,
avrei fatto qualsiasi cosa per salvare mia figlia dalla micidiale eroina, ho
provato qualunque tentativo”.
Donatella voleva davvero
disintossicarsi. Il papà racconta di averla accompagnata in Spagna, Croazia e
Belgio, era lei stessa che trovava le cliniche private su internet. “Salvarla
era diventata la mia ragione di vita”, continua il papà. E non si dà pace:
“Quando lei mi chiedeva una mano non ho mai detto di no, l’ho sempre aiutata per
qualsiasi cosa. L’avrei fatto anche stavolta, perché non mi ha cercato? Forse
dovevo cercarla io? Io sono sempre stato a sua disposizione per aiutarla.
Qualche volta mi faceva arrabbiare, ma io volevo soltanto che Dona stesse bene,
lo desideravo più della mia stessa vita”.
Racconta di tutte quelle volte
che a notte fonda è sceso per cercarla, di quando la trovava stesa a terra quasi
morta per l’eroina assunta e di quella volta che la ritrovò i Spagna in
condizioni paurose. Pesava appena 24 chili. Lui, la riportò a casa e la curò
senza lasciarla mai da sola finchè non stette meglio. Poi però ci è ricascata di
nuovo ma lui non ha mai smesso di esserci per lei. “Ora che l’ho persa per
sempre, sento che la mia vita senza Dona non vale più niente, sono io che ho
fallito, non il giudice”, dice.
E resta amarissima la sua
conclusione e la voglia di giustizia. “Su mia figlia non ho sbagliato solo io.
Tutto il sistema ha fallito, e secondo me anche i controlli in carcere non sono
stati adeguati. Per questo ho sporto denuncia, mia figlia purtroppo non tornerà
però merita verità e giustizia”.
Elena Del Mastro. Laureata in
Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di
Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie
delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.
Disperazione carcere: ecco
chi la contrasta. Chi sono i giudici di sorveglianza e cosa fanno i veri ‘eroi’
della giustizia italiana.
Tiziana Maiolo su Il Riformista l'11 Agosto 2022
Siamo a quarantanove, sette
suicidi nei primi dieci giorni di agosto. L’ emergenza carcere andrebbe trattata
come quella del contagio da covid, per non trasformare gli istituti di pena, che
sono già pattumiere, in lazzaretti, luoghi dove si va solo a morire. Altro che
rieducazione! Le ultime due persone a essersi tolte la vita erano a Napoli,
rispettivamente a Poggioreale e Secondigliano. Colpisce la storia di Francesco,
malato di anoressia, pesava 43 chili, detenuto per piccoli reati e con un fine
pena al 2024. E l’interrogativo è ormai uno stanco ritornello: perché l’ltalia,
paese di eroi e di santi, non può essere come la Svezia, dove negli scorsi anni
molte carceri sono state chiuse per carenza di detenuti? O come la Norvegia,
dove l’80% delle pene è alternativo alla privazione della libertà?
Ci vorrebbe proprio un grande
piano di giustizia sociale che parta dal carcere. Che sappia cogliere le
occasioni delle due grandi ondate di calore di questo agosto, quella del meteo e
l’altra della politica e delle elezioni anticipate. Che sappia trasformare
l’emergenza di questi 49 suicidi in una corsa ai ripari almeno quanto lo fu,
all’inizio del 2020, l’allarme per l’epidemia da covid. Quando, a dispetto di
quel che andava dicendo il procuratore Gratteri (“le carceri sono il luogo più
sicuro”), ci fu una vera mobilitazione per lo svuotamento di luoghi che sono già
patogeni in tempi normali, e figuriamoci con un’epidemia in corso. Ma, mentre
nessuno esitava a chiamare “eroi” i medici e tutto il personale sanitario in
lotta contro il virus assassino, in pochi si sono accorti di un’altra forma di
eroismo, quella dei giudici di sorveglianza. Erano stati loro per primi, e prima
ancora che il governo e il procuratore generale si rendessero conto della strage
che era già sulle porte delle carceri, a destare scandalo con i loro
provvedimenti di alternativa alla prigione. Si, furono “scandalosi”, quei
giudici e quei tribunali di sorveglianza. E lo pagarono caro, con dileggi,
insulti e richieste di interventi disciplinari nei loro confronti. Tanto che un
giorno tre di loro furono costrette a chiedere al Csm una pratica a tutela.
Agirono a mani nude, prima ancora che l’ineffabile ministro Bonafede facesse il
proprio dovere con i decreti “Cura Italia” e “Ristori”, per mandare a casa
almeno tutti coloro che avevano ancora da scontare meno di 18 mesi di pena. Non
proprio tutti, a dire il vero, perché quelli del 4 bis ne erano esclusi, proprio
come coloro che avessero avuto un procedimento disciplinare, che in genere erano
gli stranieri e i poveri. Ma i giudici e i tribunali di sorveglianza avevano
tenuto duro sui principi costituzionali. E li avevano applicati a tutti,
indistintamente. E poi, seguendo anche la decisione della Consulta che aveva
esteso la possibilità di permessi premio anche ai condannati al cosiddetto
ergastolo ostativo, avevano interpretato in modo diverso il concetto di
“pericolosità sociale”. Senza lasciarsi intimidire dalla forsennata campagna di
stampa sulle scarcerazioni facili di boss e delinquenti abituali. Lì era anche
saltata la testa del direttore del Dap Francesco Basentini, per la famosa
circolare, sollecitata proprio dagli interventi dei giudici, per la concessione
di provvedimenti di sospensione della pena per le persone anziane e malate. Il
capo del Dap perse il posto, Bonafede fu messo alla gogna e i giudici esposti a
processi popolari in cui venivano chiamati con nome e cognome come “amici dei
mafiosi”. La Repubblica, peggio ancora del Fatto quotidiano, strillava che tre o
quattrocento boss erano in libertà, quando in realtà, tra sospensioni della pena
e detenzioni domiciliari, non più di tre usciti dalle mura carcerarie erano
detenuti per reati connessi alla mafia. Ma la primavera del diritto e della
salute durò poco.
Decreti e circolari furono
presto ritirati e nell’ottobre i detenuti in carcere erano già passati da 52.800
54.800, duemila in più. Nessuno era scappato, tutti si erano fatti ri-arrestare,
docili come agnellini. Ma i problemi sono rimasti. E’ facile dire
“sovraffollamento”, senza domandarsi come nasce. Perché basterebbe sommare quel
quarto di detenuti in attesa di giudizio che poi verrà assolta a quell’altro
quarto che è fatto di soggetti fragili, cioè tossicodipendenti, anziani, malati
(soprattutto psichici), portatori di handicap, per ridurre in modo considerevole
l’affollamento. E salvare molte vite. Che senso aveva il carcere per Donatella?
Crediamo che i giudici abbiamo fatto tutto il possibile per lei, anche se il
dottor Vincenzo Semeraro ha ripetuto con angoscia “So che avrei potuto fare di
più per lei, non so cosa, ma so che avrei potuto fare di più”. No, dottor
Semeraro, probabilmente lei ha fatto tutto quello che le competeva. Ma Donatella
non doveva stare in prigione, proprio come l’anoressico Francesco.
Ma che cosa si può fare,
adesso? Certo, possiamo continuare a denunciare che ci sono tutte le carenze di
personale, in particolare di psicologi e psichiatri, soggetti fondamentali per
il trattamento dei detenuti. E mancano 18.000 agenti, come denunciano da tempo i
sindacati, e lo hanno ripetuto ancora ieri, dopo i due suicidi a ridosso della
circolare del Dap dell’8 agosto. Ma, ironizza Gennarino De Fazio, segretario
generale Uilpa polizia penitenziaria, che pure quella circolare condivide nei
contenuti, “mentre il medico studia, il paziente muore”. Che cosa fare dunque
nell’immediato? Prima di tutto quel che abbiamo già detto e ripetuto, lasciare
grande spazio all’affettività, con ampliamento di possibilità di visite e
telefonate con i parenti. Poi quel che aveva raccomandato l’ex procuratore
generale Salvi ai suoi colleghi pm e gip: meno ricorso alla custodia cautelare
in carcere. E poi un appello ai tribunali e ai giudici di sorveglianza: siate
ancora “scandalosi”, come ai tempi dell’epidemia. Perché 49 suicidi in poco più
di sette mesi sono uno scandalo. Siate voi dunque i primi protagonisti di questo
grande piano di giustizia sociale che parta dal carcere. Non possiamo
aspettarcelo dalla politica. Soprattutto in questo momento.
Tiziana Maiolo. Politica e
giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e
XIII legislatura.
«Non ho nulla di cui
scusarmi per il suicidio di Donatella».
Parla Andrea Mirenda, il
magistrato del tribunale di sorveglianza di Verona a cui era affidata Donatella
Hodo, la ventiseienne di origine albanese suicidatasi nel carcere di Montorio
questa settimana inalando il gas di una bomboletta. Giovanni M. Jacobazzi su Il
Dubbio il 13 agosto 2022.
«Io non ho nulla, ma veramente
nulla, di cui scusarmi. Ho fatto tutto quello che in questi casi andava fatto».
A dirlo è Andrea Mirenda, il magistrato del tribunale di sorveglianza di Verona
a cui era affidata Donatella Hodo, la ventiseienne di origine albanese
suicidatasi nel carcere di Montorio questa settimana inalando il gas di una
bomboletta.
La triste fine di Donatella è
balzata agli onori delle cronache non per il fatto in sé, in quanto – purtroppo
– i suicidi dei detenuti continuano a essere all’ordine del giorno, ma per
una lettera di scuse da parte dell’attuale facente funzione dell’ufficio di
sorveglianza di Verona, il giudice Vincenzo Semeraro.
Nella lettera, letta durante i
funerali della giovane ragazza, il dottor Semeraro si era scusato pubblicamente
per quanto accaduto, affermando che avrebbe “potuto fare di più per Donatella,
non so cosa, ma so che avrei potuto”. Parole che, ovviamente, avevano avuto una
coda polemica, facendo finire sul banco degli imputati tutto il personale
penitenziario e il sistema di sorveglianza nel suo complesso. In alcune
interviste all’indomani della tragedia, il padre e il fidanzato avevano poi
dichiarato che Donatella era stata “lasciata sola” in carcere, annunciando
quindi di voler denunciare gli eventuali responsabili.
Dottor Mirenda, si sente
responsabile di questa morte? C’era qualcosa che si sarebbe potuto fare e non è
stato fatto?
Guardi, quando qualcuno in
carcere decide di togliersi la vita è sempre un dramma che scuote le nostre
coscienze. Ci sarebbe bisogno da parte di tutti di rispetto, di silenzio, e
soprattutto di evitare strumentalizzazioni di alcun tipo. Fatta questa premessa,
che ritengo doverosa, nel caso di Donatella è stato fatto tutto quanto era
possibile. Donatella aveva un passato molto complicato, dall’età di 21 anni
entrava ed usciva dal carcere in particolare per reati legati agli stupefacenti
e contro il patrimonio. Sì. La ragazza stava scontando una condanna definitiva
presso una comunità di recupero per soggetti con questo genere di problemi. Il
22 maggio scorso, però, aveva deciso autonomamente di lasciare la comunità ed
era tornata in carcere.
Cosa è successo allora?
Appena ritornata in carcere,
il direttore, conoscendo bene i suoi problemi, l’aveva subito ammessa al lavoro
interno, la produzione di marmellate e prodotti simili. Ed è un fatto molto
raro.
Perché?
Come sanno tutti coloro che si
occupano di esecuzione della pena, è molto difficile che a colui il quale è
stata revocata una misura alternativa alla detenzione venga poi concesso di
poter subito lavorare in carcere. Una concessione che, invece, era stata fatta
dal direttore proprio per la sensibilità che aveva nei confronti di Donatella e
dei suoi problemi personali.
Non è stata mai lasciata sola?
Assolutamente no. E gli è
stato subito consentito di avere dei colloqui con il suo fidanzato.
E con il difensore?
Io ho avuto rapporti costanti
con l’avvocato Simone Bergamini. E lo dico senza tema di smentita. Nonostante
quello che era successo, l’abbandono della comunità da parte di Donatella,
stavamo lavorando per un nuovo affidamento terapeutico, da porre in essere
appena superati i limiti previsti dall’articolo 58 quater dell’ordinamento
penitenziario. Sinceramente non so proprio cosa altro bisognasse fare.
La lettera del suo collega ha
fatto discutere.
Io ritengo che si sia trattato
di un lettera dal valore sentimentale e affettuoso che però non può
assolutamente mettere in discussione la qualità professionale e umana del
trattamento che è stato assicurato a Donatella in questi mesi.
Si sente amareggiato? Non si
aspettava tutte queste polemiche?
Un po’ sono amareggiato,
certo. Però vorrei farmi portavoce di tutti coloro che lavorano ogni giorno, e
fra mille difficoltà, in carcere: dal direttore fino agli agenti della polizia
penitenziaria, chiamati “guardie” in maniera sprezzante dal fidanzato di
Donatella. Ecco, ci vorrebbe un po’ più di rispetto, evitando di lasciarsi
andare a facili polemiche senza neppure conoscere i fatti realmente accaduti.
Il fidanzato di Donatella,
27enne suicida in carcere: «Lei abbandonata da tutti. Le scuse del giudice?
Facile parlare adesso».
Laura Tedesco su Il Corriere della Sera l'11 Agosto 2022.
Il fidanzato della 27enne che
la settimana scorsa si è tolta la vita nel penitenziario veronese di Montorio:
in cella piangeva
Leonardo Di Falvo, 24 anni,
era fidanzato di Donatella Hodo, 27 anni, morta nel carcere di Montorio (Verona)
nella notte tra l’1 e il 2 agosto
«Non è stato il suicidio in
carcere di una drogata. Donatella, la mia Dona, era pulita da un anno. Ora che
non c’è più, leggo e sento commenti al veleno. In troppi stanno dando giudizi
senza sapere nulla di lei. Sono arrabbiato... ». Leonardo Di Falvo è il
fidanzato della 27enne che settimana scorsa, inalando del gas dal fornelletto in
cella, si è tolta la vita nel penitenziario veronese di Montorio, lasciandogli
un’ultima dichiarazione d’amore: «Sei la cosa più bella che mi è capitata, Leo,
perdonami». Per la prima volta dopo la tragedia, il 24enne rompe il silenzio.
Perché è arrabbiato? E con
chi?
«Ce l’ho col mondo intero, con
il sistema, il carcere, i magistrati, le guardie, la sua famiglia, i suoi amici.
Ma sono inc... anche con lei, con Dona, perché doveva solo pazientare un altro
po’. Presto sarebbe uscita, avevo preparato tutto per lei».
A cosa è dovuta la sua rabbia,
il tuo rancore?
«L’avevano lasciata sola, ero
solo al suo fianco. La ascoltavo, la calmavo, le stavo vicino, le telefonavo,
andavo a farle visita. Soprattutto nell’ultimo periodo dopo che l’avevano
rimessa in cella perché era scappata dalla comunità, l’avevano abbandonata.
Tutti tranne me».
Quando l’ha vista l’ultima
volta?
«La mattina del primo agosto,
il suo ultimo giorno di vita perché poi nella notte se n’è andata per sempre.
Con il suo gesto ha bloccato anche la mia vita. Il tempo per me si è fermato,
minuto dopo minuto, ora dopo ora, continuo a chiedermi perché. Cosa le è
scattato? È forse accaduto qualcosa che non so?»
Come l’aveva trovata la
mattina prima della tragedia?
«Era la solita Dona... con i
suoi alti e bassi, aveva avuto anche quel giorno i suoi soliti cinque minuti in
cui era partita per la tangente, ma poi l’avevo riportata sui binari. La
conoscevo da quando eravamo adolescenti, almeno da dieci anni, ero l’unico che
riusciva a rassicurarla».
Come vi siete salutati?
«Ci siamo detti ti amo, ci
siamo baciati abbracciandoci. Uscendo le ho assicurato che le avrei telefonato e
sarei tornato da lei la settimana dopo, come sempre. Non mancavo mai, avrei
fatto tutto per lei, qualsiasi cosa».
Appena lei fosse stata
scarcerata, sareste andati a convivere.
«Ho preso una casa apposta per
stare insieme, lei sognava di fare l’estetista e io le avevo trovato un primo
lavoretto per quando sarebbe uscita. L’avrei aspettata per sempre, perché ha
rotto così il nostro sogno? Ci eravamo promessi amore per sempre, perché ha
distrutto tutto? Cos’è successo?».
Il papà di Donatella ha sporto
denuncia contro il carcere.
«Anch’io mi chiedo cosa sia
accaduto quella notte maledetta. Qualcuno in serata l’aveva sentita piangere,
sapevano quanto lei fosse fragile. Perché nessuno è andato a parlarle? Magari
sarebbe bastata una parola, un consiglio, una pacca sulla spalla per farle
passare la tristezza di un attimo e salvarle la vita. Invece l’hanno lasciata
tutti sola, nessuno escluso».
Il giudice di Sorveglianza
sente di «aver fallito».
«Devo essere franco, è facile
adesso parlare. Ora tutti dicono qualcosa, ma dov’erano quando Dona poteva
essere salvata? Cos’hanno fatto per aiutarla?».
Irene Famà per “La Stampa” il
17 agosto 2022.
«Come sta mamma? Sono
dispiaciuto per quello che ho fatto, per aver deluso i miei genitori». No,
queste non sono le parole che un bandito rivolge a un giudice. E infatti
Alessandro Gaffoglio non lo era. Ventiquattro anni e un'infanzia complessa,
affetto da disturbi psichici, talvolta faceva uso di droghe. Il 2 agosto, a
Torino, coltello alla mano, ha rapinato due supermercati. La polizia l'ha
arrestato ed è finito davanti al giudice per la convalida del fermo.
Il primo arresto, il primo
giorno in carcere. Una misura cautelare, non una condanna. In cella Alessandro
ha resistito due settimane, poi si è tolto la vita soffocandosi con un sacchetto
di nylon.
Alessandro Gaffoglio non era
un bandito, era un ragazzo fragile. Come Donatella Hodo, di tre anni più grande,
che nella sua cella a Moriondo, nel veronese, il 2 agosto si è uccisa inalando
del gas da un fornelletto. Lottava contro la dipendenza da stupefacenti, usciva
ed entrava dal carcere di continuo. Piccoli furti, i suoi. Come quelli di
Alessandro. Difficoltà che la detenzione ha acuito, solitudini che ha reso
insostenibili, paure e fragilità che non hanno lasciato scampo. Dalle loro
celle, quei due ragazzi non hanno visto possibilità di riscatto, ma solo
fallimento.
«È un'estate davvero
drammatica» dice la ministra della Giustizia Marta Cartabia, dati alla mano:
cinquantadue suicidi da inizio anno nelle carceri italiane, nove nei primi
quindici giorni di agosto. «Il ministero, l'amministrazione penitenziaria stanno
facendo molto per migliorare complessivamente la qualità di vita e di lavoro nei
nostri istituti, ma il dramma dei suicidi riguarda tutti».
Le carceri sono sovraffollate,
d'estate non ci sono attività, il supporto psicologico non basta. Come
sottolinea Cosima Buccoliero, la direttrice del carcere Lorusso e Cutugno di
Torino: «Si interviene sulle situazioni in cui si crea allarme, quelle evidenti.
Le altre non si riesce a individuarle». E la richiesta di cambiamenti del
sistema carcercario arriva da più voci, dal sindacao Osapp della polizia
penitenziaria, dai garanti dei detenuti.
Alessandro Gaffoglio era nato
in Brasile. Poi era stato adottato e in Italia, a Torino, studiava. E lavorava.
Lavoretti qua e là, come un periodo in uno dei tanti girarrosti. «Solare, dolce,
attento alla famiglia». Chi lo conosceva, lo descrive così: «Proprio la persona
che speri non faccia quella fine. Doveva essere aiutato». Aiutato ad affrontare
la dipendenza dagli stupefacenti, che l'ha spinto, così pare, ad assaltare due
supermercati e a tentare la fuga con un bottino intorno a un migliaio di euro. E
forse, questo il sospetto degli inquirenti, a compiere altre rapine nei mesi
scorsi.
Seguito e monitorato per quei
disturbi pischici. Entrato in carcere, è stato inserito nel cosiddetto
"Sestantino", l'area nella sezione dei "Nuovi giunti" per chi ha problemi
psichiatrici. Poi è stato trasferito, sempre sotto osservazione, in un altro
padiglione. «Stiamo cercando di capire come sono andati i fatti», dichiara
l'avvocata Laura Spadaro.
La procura ha aperto
un'inchiesta: al momento non ci sono indagati né ipotesi di reato. È stato
sequestrato il fascicolo che riguarda Alessandro Gaffoglio, si cerca di capire
se il ventiquattrenne è stato seguito e monitorato adeguatamente. L'indagine
torinese riguarda Alessandro. A Verona si riflette sul suicidio di Donatella.
Volti e storie differenti, simbolo, entrambi, della sconfitta di un sistema.
Dramma carcere femminile,
in 15 in una cella.
Viviana Lanza su Il Riformista l'11 Agosto 2022
Il carcere e le donne. Nei
giorni scorsi il Riformista si era occupato di questo aspetto, evidenziando
come la stragrande maggioranza degli istituti penitenziari non siano a misura di
donne, rendendo la reclusione delle detenute una condanna aggiuntiva. Quando poi
si arriva a stare in sei, sette o addirittura in quindici, sì quindici, in una
cella la situazione diventa molto più critica. D’estate ancor di più. L’aria
filtra piano, la disponibilità di acqua non è illimitata, lo spazio vitale è
ridotto al minimo, forse anche meno del minimo. In Campania il sovraffollamento
è un problema anche nel carcere femminile, quello di Pozzuoli, l’unico della
regione organizzato per ospitare donne. Sorge nella sede di un convento
risalente al XV secolo, che nel corso della sua storia è stato manicomio
criminale e successivamente carcere femminile. La struttura è composta di tre
reparti, 26 celle in tutto.
Delle tre sezioni, una è
destinata alle detenute affette da problemi di salute mentale e un’altra è
destinata alle semi-libere e alle lavoratrici. Attualmente la popolazione
detenuta è di 146 donne, a fronte di una capienza regolamentare di 102 posti. Il
sovraffollamento, quindi, è una realtà anche qui, il che si traduce in una più
difficile gestione di tutta la struttura e di chi la vive. In ogni cella sono
presenti letti a castello per un numero che varia dalle sei alle quindici
persone per cella. Inoltre, in tutte le celle, a causa di disfunzioni
dell’impianto, ci sono problemi per la fornitura di acqua corrente e acqua
calda. Le criticità sono state rilevate dalle osservatrici campane
dell’associazione Antigone anche durante la loro recente visita all’interno
della casa circondariale femminile.
Il sovraffollamento si
trascina dietro tutta una serie di altre criticità. «Oltre al sovraffollamento
abbiamo riscontrato un elevato numero di detenute che fanno uso di
benzodiazepine al bisogno. Molto alto anche il numero di detenute con doppia
diagnosi (psichiatrica e di dipendenza)». Eccolo il quadro che emerge, ecco lo
scenario dei tanti drammi che si consumano dietro le sbarre. Nel carcere di
Pozzuoli sono presenti psichiatri a turnazione per un numero complessivo di 38
ore settimanali, fa sapere Antigone. Da novembre 2020 la nuova direzione si è
impegnata nella realizzazione e nell’approvazione di vari progetti, anche di
ristrutturazione della struttura sebbene si tratti comunque di un edificio
costruito intorno al ‘500 e pertanto difficile da ammodernare. La costante,
quindi, resta sempre la stessa: carceri vecchie e sovraffollate.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Il dramma delle donne
detenute: rinchiuse in strutture pensate solo per gli uomini.
Viviana Lanza su Il Riformista il 9 Agosto 2022
Le donne detenute aumentano ma
le carceri sono ancora in prevalenza concepite per soli uomini. Ci sono carenze
che finiscono per diventare una sorta di aggravamento della reclusione, una
sorta di pena aggiuntiva. La questione è stata riproposta dall’associazione
Antigone in occasione del rapporto di metà anno, una relazione stilata a
conclusione di visite nei vari istituti di pena del nostro Paese. In Italia si
contano 2.314 donne detenute, pari al 4.2% del totale della popolazione
detenuta. Una percentuale stabile nel tempo, di poco inferiore alla media dei
paesi europei che si attesta sul 4,7%. La Campania è terza per numero di donne
detenute (324), dopo il Lazio (405) e la Lombardia (370). «Negli ultimi dodici
mesi l’Osservatorio di Antigone ha visitato 84 istituti e in 23 di questi erano
presenti donne – si legge nel rapporto -. Nel 30,4% delle celle ospitanti donne
non c’era il bidet, nonostante sia previsto dal regolamento penitenziario già
dal 2000. Nel 17,4% degli istituti visitati ospitanti donne non era garantito un
servizio di ginecologia e nel 30,4% mancava un servizio di ostetricia. Non
ovunque, nelle carceri ospitanti bambini, era presente un pediatra, così come
volontari che si occupavano di accompagnare all’esterno i bambini che dormivano
in istituto.
Forti tassi di autolesionismo
hanno riguardato le sezioni femminili degli istituti di Bologna e Palermo, con
3,6 atti di autolesionismo in un anno ogni 10 detenute». Numeri che descrivono
drammi silenziosi, crepe di un sistema penitenziario non in grado di rispettare
quella funzione costituzionale di recupero e reinserimento del detenuto. Donne
detenute in carcere concepiti per soli uomini: sembra una descrizione da
medioevo, non certo di uno Stato di diritto nell’anno 2022. Eppure, è realtà.
Come è realtà il numero crescente di donne recluse insieme ai figli in tenera
età. Sei mesi fa la ministra Cartabia aveva detto mai più bambini dietro le
sbarre e in questi mesi il numero delle donne detenute con figli al seguito è
salito da diciotto a venticinque. E la politica cosa fa? Praticamente nulla,
visti i dati e i numeri che periodicamente confermano i drammi silenziosi del
popolo detenuto, soprattutto della fascia debole di quel popolo, donne e
bambini.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Quei suicidi spie delle
carceri fuorilegge.
Di Luigi Ferrarella su Il Corriere della Sera il 12 Agosto 2022.
Dall’inizio dell’anno 51
detenuti si sono uccisi in cella, non solo la ragazza di Verona. E questo è solo
una segnale delle irregolarità che spesso rendono invivibili i penitenziari
Sessantamila italiani che si
sono uccisi in un anno: fantascienza? Eppure accadrebbe se la proporzione di chi
si sta togliendo la vita in carcere (10,6%) si replicasse nella popolazione in
libertà (suicida 16 volte meno). Da quando a Verona è morta Donatella, la 27enne
detenuta il cui suicidio ha spinto il suo giudice di sorveglianza a interrogarsi
sul fallimento proprio e del sistema, già altre tre persone si sono tolte la
vita: 51 da inizio anno, quasi già quanto le 54 dell’intero 2021 accomunate da
disagi psichiatrici, dipendenze (1 detenuto su 3 ma solo tre carceri hanno
programmi mirati), e sovraffollamento medio al 120% ma con picchi locali anche
al 150%.
Ecco perché, sotto
l’intermittente commozione per l’eccezione statistica dei suicidi, stride
l’ipocrisia del tollerare invece l’ordinaria eccezione alla legalità in carcere,
quale registrata dalle visite dei Radicali e dell’associazione Antigone in 85
istituti: 5 minuti e 20 secondi alla settimana in media di servizio psichiatrico
per detenuto, psicologi per 10 minuti e mezzo settimanali a cranio, quasi 6
celle su 10 senza docce (benché una norma le imponga dal 2000), quasi un terzo
senza i minimi 3 metri quadrati calpestabili, carceri non allacciate alla rete
idrica che suppliscono con 4 litri potabili a detenuto, 10 minuti alla settimana
di telefonate ammesse dal regolamento del 1975. Ancora non cambiato
(introducendo i telefoni in cella anche in chiave anti-suicidi) da una politica
che, per calcolo di dividendo nelle urne o per paura di pedaggio elettorale,
lascia sul binario morto pure le più complessive riforme proposte in questi anni
dalle commissioni Giostra e Ruotolo. E tace agli elettori quanto intanto questa
fuorilegge fabbrica-carcere nemmeno riesca a consegnare la supposta
merce-sicurezza al consumatore-collettività, se 62 detenuti su 100 sono già alla
seconda carcerazione e 18 persino alla quinta o più.
Marcello, Giovanni, Alessio
e quella seconda chance che cambia la vita di un detenuto.
Dopo anni in cella e storie
difficili hanno un lavoro all’esterno per merito degli incentivi previsti dalla
legge Smuraglia. E ora, forse per la prima volta, vedono anche un futuro. Silvia
Perdichizzi su L'Espresso il 29 Agosto 2022.
«Calati junco chi passa la
china», così Marcello riassume la sua storia, perché in questo proverbio
siciliano c’è il senso della sua vita: «Piegati giunco che la piena del fiume
passa». Adattati, non opporre resistenza, che poi ti rialzerai più forte di
prima.
Marcello è uno dei detenuti
che grazie al progetto “Seconda Chance” sta avendo la sua seconda occasione, la
possibilità di riscatto da una vita «segnata».
«Qui dentro non lascereste
neppure il vostro cane»: i detenuti denunciano perché ci si ammazza in cella.
Il numero dei suicidi nelle carceri sfiora già il totale dello scorso anno e
il sovraffollamento tocca punte vicine al 200 per cento. Le voci dei reclusi di
Sollicciano arrivate all’Espresso raccontano l’inferno dei nostri
istituti. Simone Alliva, Tommaso Gasperini, Massimo Sestini su La Repubblica il
29 Agosto 2022.
L’ultimo, al momento in cui
scriviamo, è un trentenne di Cerignola morto a Foggia nel giorno del suo
compleanno. Si è impiccato, come l’italiano di 52 anni che l’ha fatta
finita all’interno del reparto di osservazione psichiatrica del carcere di
Piacenza. Arrestato per reati comuni, era in attesa di una decisione del
magistrato di sorveglianza e delle autorità sanitarie.
Le prigioni in
Italia. Colonia penale per poveri ed emarginati: ecco cos’è il carcere.
Marco
Chiavistrelli su Il Riformista l’11 Novembre 2022
Il carcere non è per
il popolo italiano ma per una minoranza precisa, con una reiterazione del
prelievo “delinquenziale” costante nel tempo e nello spazio sociale. Il carcere
è una colonia penale per poveri e altre minoranze emarginate. I detenuti oggi
sono circa 56.000. Credo che i più pensino che andare in carcere sia un fatto
casuale, di tendenza soggettiva, per cui – per esempio – se in un Paese ci sono
20 persone di cui 10 coi capelli neri e 10 coi capelli rossi in carcere troverai
2 coi capelli neri e 2 coi capelli rossi. Poi negli anni a venire ci sarà magari
qualche oscillazione, 3 e 1, e così via. La delinquenza sarebbe soggettiva,
quindi casuale e colpirebbe in modo similare più o meno tutti i colori dei
capelli, i ceti sociali. Ma ci accorgiamo che non è così, in carcere trovi quasi
sempre una maggioranza schiacciante di cittadini coi capelli neri e non un anno
a caso, ma sempre. Mistero? No.
Secondo le
statistiche il 90% dei carcerati è povero, cioè è assunto da quella fetta di
popolazione italiana che vive sotto la soglia di povertà (Istat) che,
attenzione, è solo il 6%, cioè 5 milioni di poveri che forniscono il 90% dei
carcerati, cioè 50.400 persone che dovrebbero essere 3.300 per percentuale
effettiva. Ma dei 5 milioni, 3 e mezzo sono italiani, mentre 1 milione e mezzo
sono immigrati irregolari e stranieri, che sono l’8% della popolazione che vive
in Italia ma incidono, con circa 17.800 presenze, al 32,4% sulla popolazione
carceraria. Ma, attenzione, potremmo pensare che gli stranieri, gli africani
delinquono di più ma la percentuale di povertà in loro è del 30% per cui se
usiamo la povertà come base, la percentuale di delinquenza è sempre il famoso
glaciale 1%. Per i 3 milioni e mezzo di italiani, poveri al 6%, e per il milione
e mezzo di stranieri, poveri al 32,4%, esce lo stesso 1% di carcerazione, cioè
abbiamo una legge matematica: qualsiasi gruppo povero delinque all’1%. Non
c’entra il colore della pelle ma della povertà, che accomuna tutti in un simile
destino. È dimostrato che gli immigrati se accolti delinquono meno degli
italiani, felici del risultato raggiunto.
Nella parte di
popolazione superiore alla soglia di povertà, la probabilità nella propria vita
di impattare il carcere è di 1 su 12.000! Mentre 5 milioni di nati male hanno
una probabilità di 1 su 100 di finire dentro e forniscono 50.400 detenuti su
56.000. I restanti 55 milioni di italiani “comodi”, non ricchi ma nemmeno
disgraziati, forniscono solo 4.600 detenuti o poco più, 1 su 12.000! Ma vi
sembra normale? Non bisognerebbe fare qualcosa? Quindi, a parte un 10% di
detenuti casuali per provenienza in cui è più alto il contenuto soggettivo del
crimine perché non motivato dall’indigenza, il carcere non è per il popolo
italiano, è una colonia penale per poveri, per indigenti. Perché se il crimine
fosse soggettivo, di indole, i 5 milioni di poveri cristi fornirebbero
pochissimi carcerati, poco più di 3.000 mentre superano quota 50.000! Quasi
tutti!
Passiamo ora a
un’analisi che ci spieghi l’origine dei detenuti per condizione scolastica. Uno
pensa che cosa c’entra la scuola? Se sei cattivo, se propendi a delinquere, in
carcere troverò un po’ di tutti secondo percentuale. Ma, statistiche
ministeriali alla mano, l’83% dei detenuti italiani, 45.650, ha una formazione
scolastica bassissima: medie o solo elementari o senza aver mai studiato o
analfabeta. Ma come percentuale di popolazione dovrebbero essere solo 9.900 in
carcere. Attenzione: su 56.000 detenuti i laureati sono solo 1.100, il 2%, ma in
Italia sono il 20% e per logica dovrei trovarne 11.000 in carcere. E i
diplomati? Sono 8.250 in galera, il 15%, ma dovrebbero essere 34.100 se il
crimine fosse casuale e soggettivo, perché sono il 62% della popolazione. Quindi
c’è un nesso catastrofico tra livello di istruzione e carcere che è una colonia
penale per pochi milioni di poveri e non istruiti. Allora, se si aiutasse la
povertà e l’istruzione i carcerati sarebbero pochissimi.
Ancora, uno
pensa: Nord e Sud saranno rappresentati in carcere secondo la loro percentuale
di abitanti. Ma no: il 46% dei detenuti, 25.300, è meridionale, anche se quelle
stesse regioni hanno solo il 25% della popolazione italiana; quindi, forniscono
un contributo di 11.500 detenuti in più alla comunità carceraria. Sono più
delinquenti? No, sono più poveri in percentuale (gli indicatori mostrano più
povertà al Sud) e riempiono di più le galere rispettando quel famoso 1% dei
poveri che delinquono ovunque nella stessa maniera: una legge matematica.
Quindi, il carcere non è per tutti, e per i poveri, non istruiti e soprattutto
meridionali. Un incubo.
Marco Chiavistrelli
Il numero più
alto di sempre. Dramma suicidi in carcere: 77 in un anno è il record del secolo.
Stefano Anastasia su Il Riformista l’11 Novembre 2022
Secondo i dati
raccolti da Ristretti orizzonti nel suo dossier Morire di carcere, con gli
ultimi tragici casi di Torino e Reggio Calabria, siamo a 77 suicidi accertati
nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno, il numero più alto di sempre (solo
nel 2009 a fine anno i suicidi superarono le 70 unità, fermandosi però a 72). I
suicidi costituiscono il 51% dei casi di morte registrati in carcere nel corso
dell’anno, e anche questa è una percentuale mai così alta dall’inizio del secolo
(non era mai arrivata al 50%, solo il 2018 registrò un 45% di suicidi sul totale
dei morti in carcere nel corso dell’anno). Ogni caso è caso a sé, con la storia
di quella persona e della sua disperazione, ma il dato generale è impressionante
ed è indice di una generale mancanza di speranza nelle nostre carceri.
Salvo poche,
ammirevoli, esperienze di sostegno e accompagnamento al reinserimento
sociale, la grande maggioranza dei detenuti e delle detenute vive
la carcerazione come un periodo più o meno lungo di abbandono. Se le stelle non
si allineano in cielo (una forte motivazione personale e una solida rete di
sostegno familiare fuori, personale penitenziario quantitativamente adeguato e
qualitativamente capace e motivato in istituto, un territorio ricco e capace di
accogliere e accompagnare una persona proveniente dal carcere, una magistratura
di sorveglianza sensibile e determinata a scommettere sulle alternative alla
detenzione e l’ufficio di esecuzione penale esterna che ce la fa), senza questa
congiunzione astrale favorevole, la gran parte dei detenuti e delle detenute
sono costrette ad aspettare l’ultimo giorno di pena per venirne fuori, spesso
avendo perso legami affettivi e familiari, talvolta un lavoro, sempre un po’ di
salute e di fiducia in se stessi.
In quel momento,
quando il “liberante” si affaccia sulla soglia del portone del carcere, con la
sua busta di masserizie residue di anni o mesi di detenzione, spesso senza
sapere dove andare, in ognuno di quei momenti si consuma una sconfitta dello
Stato, incapace di attuare l’articolo 27 della Costituzione che obbliga le
istituzioni, con il concorso della società esterna, ad accompagnare il
condannato nel reinserimento sociale, avendogli offerto mezzi e strumenti per
una vita diversa. Invece sappiamo che il 30 giugno scorso, 7.658 dei 38.959
condannati in via definitiva scontavano pene inferiori ai tre anni, generalmente
ammissibili ad alternative alla detenzione, e addirittura 6.996 avevano un
residuo pena inferiore a un anno, prossimi quindi a raccogliere le proprie
masserizie per andarsene, eppure ancora in carcere.
Paradossalmente,
l’emergenza pandemica dava più stimoli a sopravvivere, facendo sentire i
detenuti, seppure chiusi in carcere, parte della società esterna, anch’essa alle
prese con la prevenzione e la cura del virus. Ma oggi il carcere è tornato a
essere un luogo di isolamento e di disperazione, e il numero di suicidi ne è una
drammatica testimonianza. Sulla carta, quel che andava fatto è stato fatto: un
piano nazionale di prevenzione del rischio suicidario, decine di piani
regionali, centinaia di piani per ogni singolo istituto. Ma la carta non basta,
e neanche l’abnegazione degli operatori, a cui non è possibile imputare, a
ciascuno di essi singolarmente, la responsabilità di una morte scelta
volontariamente da una persona disperata. Se non vogliamo rassegnarci a questa
tragedia, o scaricarne la responsabilità sugli operatori
penitenziari e sanitari in trincea, bisogna veramente ridurre il carcere
a extrema ratio e aprirlo alle attività e al mondo esterno. In questo modo, solo
in questo modo il sistema penitenziario può farsi carico di chi debba
effettivamente scontare una pena in carcere, e magari – con il concorso della
società civile e degli enti territoriali – offrirgli le condizioni per un
migliore reinserimento sociale.
Ancora nei giorni
scorsi abbiamo risentito la solita litanìa: bisogna costruire nuove carceri per
ridurre il sovraffollamento. Ma perché? Per tenere in carcere anziani malati
condannati a pochi mesi di carcere, o giovani soli o indisciplinati? Il carcere
in Italia è un grande ospizio dei poveri. Gli autori di gravi reati contro la
persona o in associazione con organizzazioni criminali non arrivano a 30mila
unità. Perché tenerne in carcere 56mila, e domani 60 e dopodomani 70, come
qualcuno pensa sia giusto prevedere? Per dare al carcere la funzione che fu dei
manicomi, di custodire la devianza e la marginalità sociale, allora etichettata
come folle, oggi come criminale (quando non l’una e l’altra cosa insieme)?
30mila o 70mila detenuti? Che società vogliamo essere? Extrema ratio o ospizio
dei poveri? Investire nel reinserimento sociale o nella costruzione di nuove
carceri? Dalla risposta a queste domande vengono tutte le scelte politiche
successive, e anche la chance di restituire ai detenuti la speranza in un futuro
degno di essere vissuto. Stefano Anastasia
La mattanza di
Stato. La mattanza in carcere, l’ultimo suicida migrante e l’assenza di
mediatori e psicologi.
Andrea Aversa su Il Riformista il 28 Agosto 2022
Non ha fine la mattanza di Stato. Un altro
suicidio avvenuto tra le mura di un penitenziario. Questa volta è successo
nel carcere di Terni. Lo ha annunciato il segretario generale del Sindacato
Polizia Penitenziaria (SPP) Aldo Di Giacomo. L’ultima vittima della strage è un
giovane di origini marocchine. «Un’altra terribile faccia della medaglia dei
suicidi – ha spiegato Di Giacomo – Per i detenuti extracomunitari, circa 12mila,
l’assenza di mediatori culturali e psicologi è ancora più pesante».
Dei 55 suicidi, questo ha rappresentato il
22esimo che ha avuto per vittima una persona extracomunitaria. «Lo sciopero
della fame che ho iniziato la scorsa settimana insieme al tour tra le carceri
italiane, tra cui quelle in Umbria dove ci sono alcune centinaia di detenuti
extracomunitari (tunisini e marocchini in maggioranza) è ormai l’ultima
possibilità per riaccendere l’attenzione sul fenomeno dei suicidi, la spia
estrema del profondo malessere che vive la popolazione carceraria. Si pensi solo
che l’età media è notevolmente abbassata con un numero maggiore di giovani», ha
affermato Di Giacomo che ha poi continuato: «Purtroppo, l’emozione provocata
nell’opinione pubblica, grazie alla grande attenzione di giornali e media e
della sensibilità dei giornalisti che ringraziamo, non basta. Come non basta una
circolare del Dap o una task force istituita dal Ministero ad intercettare il
grave disagio, soprattutto psicologico, diffuso in particolare tra detenuti
tossicodipendenti e con problemi psichici trasferendo ogni responsabilità ai
Provveditori e ai direttori di istituto».
Di Giacomo ha inoltre dichiarato: «Ringrazio
quanti da giorni mi fanno pervenire messaggi di solidarietà e sostegno.
Purtroppo è troppo facile il classico ‘scarica barile’ delle responsabilità pur
sapendo che né provveditori né direttori dispongono di risorse umane
(psichiatri, psicologi) e finanziarie, strumenti e strutture per intervenire.
Così come è troppo facile, come fa il capo del Dap, invitare i provveditori a
garantire una particolare attenzione alla formazione specifica del personale,
attraverso cicli di incontri a livello centrale e locale, destinati a tutti gli
attori del processo di presa in carico dei detenuti». Ha concluso il
Segretario: «L’estate si conferma dunque stagione problematica da gestire nelle
carceri, mentre l’unica Regione che ha attivato, sia pure solo di recente,
un piano di prevenzione suicidi è la Regione Lombardia che ha provveduto in
questi giorni ad un aggiornamento. Come sostengono gli esperti, la pandemia se
in generale ha accentuato situazioni di disagio mentale, apprensione ed ansia,
ha avuto e continua ad avere ripercussioni ancora più gravi nelle carceri dove
il personale di sostegno psicologico come quello sanitario in generale ha numeri
ridotti e non riesce a far fronte all’assistenza ancor più necessaria negli
ultimi due anni di Covid».
La comunità penitenziaria è allo stremo.
Il sovraffollamento continua ad essere una piaga per detenuti ed agenti.
L’assenza di personale sanitario e di risorse per i tribunali di sorveglianza,
rende il contesto ancora più complesso e difficile. È difficile accedere alle
pene alternative e al lavoro. Ci sono ritardi per i pronti interventi clinici e
per consentire ai reclusi di poter fare delle visite mediche. La burocrazia su
questo è nemica del Diritto. Pratiche ferme per mesi, mentre la salute delle
persone peggiora giorno dopo giorno. La mancanza di educatori preclude ai
detenuti la possibilità di poter svolgere le attività
trattamentali e rieducative. Le istituzioni sono lontane anni luce
dalla Costituzione e continuano a mortificare lo Stato di Diritto. E la politica
è indifferente: a quale dei partiti in campo interessa davvero riformare il
carcere? Quasi a nessuno, basta assistere a questa vergognosa campagna
elettorale. Andrea Aversa
La lettera a Capece. In
carcere non ci sono buoni contro cattivi.
Maria Brucale su Il Riformista
il 9 Settembre 2022
Caro dottor Capece, il carcere
è un mondo difficile, di straordinaria complessità, quella che connota le
innumerevoli sfaccettature dell’essere umano. Non è un luogo all’interno del
quale si contrappongono buoni e cattivi, diritti tutelabili e diritti da
calpestare. È, soprattutto, un luogo che appartiene alle istituzioni e le
rappresenta, un pezzo dell’ingranaggio chiamato Stato, all’interno del quale le
esigenze di sicurezza dei cittadini, tutti, anche quelli reclusi, devono essere
curate affinché la società sia più ordinata, sicura. È, ancora, un luogo dove le
persone che hanno commesso reati espiano una pena che deve essere utile a
reintrodurle produttivamente nel consesso civile. È, infine, un luogo dove
talvolta, non così raramente, sono private della libertà in attesa di giudizio
persone che verranno assolte da tutte le accuse, che patiranno un’ingiusta
interruzione di vita e subiranno le tragiche conseguenze del disdoro e della
mutilazione di relazioni connesse alla reclusione.
È, quindi, necessario che ci
si doti di risorse umane e materiali dentro e fuori le carceri che consentano a
ogni persona che voglia riabilitarsi di poterlo fare senza subire la violenza di
una punizione fine a sé stessa che sottrae dignità, priva di autonomia di
pensiero e azione, lede il decoro del vivere, annienta gli affetti, nega la
speranza. Non possiamo entrare nel cuore e nella mente di chi ha sentito che la
propria esistenza non avesse più nulla da offrire, di chi ha pensato che la
morte fosse la sola occasione di sollievo per sé e per i propri cari. Sappiamo
però che il disinteresse della collettività per la persona che finisce nel
circuito stigmatizzante del carcere determina una percezione di abbandono che
può risultare insuperabile. Sappiamo che il carcere impone un marchio di infamia
indelebile che scalfisce la credibilità personale e pregiudica il ritorno al
mondo del lavoro. Che in carcere manca tutto quello che dovrebbe esserci, che la
comunità penitenziaria tutta vive in disperante disagio.
Tutti – agenti, educatori,
personale sanitario e amministrativo – patiscono il disinteresse dello Stato e
una carenza endemica di risorse. Sono assurde, insensate, nocive le
contrapposizioni. Ci dice, dott. Capece, che gli agenti di polizia penitenziaria
“nel solo primo semestre 2022 hanno sventato 814 tentativi di suicidio da parte
di altrettanti detenuti”. Certo, a loro va tutta la nostra gratitudine perché
esercitano la professione in condizioni lavorative estremamente penalizzanti, ma
il dato su cui tutti, insieme, dobbiamo soffermarci è che 814 persone fossero
arrivate a decidere che per loro ogni speranza fosse inutile, morta. La
sicurezza sociale passa per il benessere delle persone che stanno in carcere,
tutte, quelle che espiano la loro pena, quelle che lo Stato pone quali custodi e
garanti che quella pena sia orientata ai suoi scopi costituzionali. Il benessere
del carcere inteso come comunità e come parte integrante dello Stato è possibile
solo se ogni suo anello è coeso saldamente a tutti gli altri.
L’azione politica nonviolenta
di Rita Bernardini, Presidente di Nessuno tocchi Caino, di quanti di noi la
sostengono con il digiuno a staffetta è tesa proprio al recupero della tenuta
sociale, è rivolta alle Istituzioni perché attraverso segnali di ristoro
dimostrino in concreto alla comunità penitenziaria tutta l’interesse dello Stato
e il proposito di includere finalmente quella comunità negletta tra gli
obiettivi politici. È chiaro che senza riforme strutturali e senza aiuti
adeguati il problema non può essere risolto. Se amnistia e indulto non sono
obiettivi perseguibili nell’immediato, va detto però che le situazioni di
emergenza a volte richiedono provvedimenti di urgenza tesi a ridimensionare la
portata di fenomeni drammatici, ingovernabili e insopportabili in uno Stato di
Diritto.
Bisognerebbe anche guardare
alla realtà e vedere, ad esempio, che i tribunali non sono in grado di gestire
il carico processuale che hanno e rinviano a tempi lontanissimi la trattazione
dei processi relativi ai reati più gravi comportando di fatto la malagestio
della giustizia, la disattenzione alle attese di chi l’ha invocata,
l’impossibilità di pervenire a pene giuste perché inflitte quando hanno ancora
una utilità sociale, quando ancora la persona che ha commesso il reato può
percepire il senso dell’impeto punitivo dello Stato. Certezza della pena è
concetto completamente travisato. Il senso di questa espressione è una pena
mite, coerente alla gravità del reato, dinamica, non fissa, che assecondi il
fine di un rientro nella vita libera. Nessuno tocchi Caino vuole oggi con il
digiuno di Rita e da sempre con la sua azione politica unicamente che sia
rispettata la legge nelle carceri e che ogni diritto umano trovi nello Stato il
giusto ristoro e la giusta attenzione. Maria Brucale
Il precedente drammatico
primato fermo a 72 perone nel 2009. La strage in carcere, 74 detenuti si sono
tolti la vita nel 2022: mai così tante.
Redazione su Il Riformista l'1 Novembre 2022
L’ultimo a togliersi la vita è
stato un detenuto del carcere Antonio Burrafato a Termini Imerese. Era disabile,
aveva una protesi e ha avuto problemi con la droga. Dopo due giorni
dall’arresto, si è chiuso in bagno e si è tolto la vita con la cintura dei
pantaloni. Pochi giorni prima a Torino, Tecca Gambe, 36 anni, originario del
Gambia, l’ha fatta finita nemmeno 48 ore dopo il suo arresto, mentre aspettava
la decisione del giudice che avrebbe stabilito se trattenerlo in cella o no.
Aveva rubato delle cuffiette da 24 euro. Quella nelle carceri sembra una strage
senza fine e il 2022 che ancora non è finito presenta numeri da triste primato.
Secondo quanto riportato da Antigone, dall’inizio dell’anno 74 persone si sono
tolte la vita all’interno di un istituto di pena. Mai così tante da quando si
registra questo dato. Il precedente drammatico primato era del 2009, quando al
31 dicembre si erano suicidate 72 persone. Oggi, a fine anno, mancano ancora due
mesi.
Scrive Antigone in una nota:
“Oltre al valore in termini assoluti, l’indicatore principale per valutare
l’andamento del fenomeno è il cosiddetto tasso di suicidi, ossia la relazione
tra il numero dei casi e la media delle persone detenute nel corso
dell’anno. Non essendo ancora terminato il 2022, possiamo oggi calcolare il
tasso di suicidi solo tra il mese di gennaio e settembre, ossia a quando risale
l’ultimo aggiornamento sulla popolazione detenuta. Con un numero di presenze
medie pari a 54.920 detenuti e 65 decessi avvenuti in questi nove mesi, il tasso
di suicidi è oggi pari circa a 13 casi ogni 10.000 persone detenute: si tratta
del valore più alto mai registrato. In carcere ci si uccide oltre 21 volte in
più che nel mondo libero. Quando nel 2009 si suicidarono 72 persone, i detenuti
erano circa 7.000 in più”.
Un altro dato drammatico è
quello dei suicidi nella popolazione detenuta femminile. Finora sono stati
cinque. Con un tasso superiore a quello degli uomini, pari a quasi il 22%. Nel
2021 e nel 2020 “solo” due si erano tolte la vita. Nessuna nel 2019. Quasi il
50% dei casi di suicidi sono poi stati commessi da persone di origine straniera.
Se circa un terzo della popolazione detenuta è straniera, vediamo quindi come
l’incidenza di suicidi è significativamente maggiore tra questi detenuti. Dalle
poche informazioni a disposizione, sembrerebbe che circa un terzo dei casi di
suicidi riguardava persone con un patologia psichiatrica, accertata o
presunta, e/o una dipendenza da sostanze, alcol o farmaci.
Le Case Circondariali
di Foggia e di Milano San Vittore restano i due istituti con il maggior numero
di suicidi nel corso dell’anno, con quattro decessi ognuna. Seguono con tre
decessi, gli istituti di Roma Regina Coeli, Monza, Firenze Sollicciano, Torino e
Palermo Ucciardone.
“Ovviamente non è possibile
ricondurre l’accelerazione del fenomeno di quest’anno a delle ragioni precise –
continua la nota di Antigone – Ogni storia è a sé, frutto di personali dolori e
personali considerazioni. Quello che però possiamo sicuramente dire è che la
maggior parte delle persone che entrano in un istituto di pena hanno alle spalle
situazioni già di ampia complessità: marginalità sociale ed economica, disagi
psichici e dipendenze caratterizzano gran parte della popolazione detenuta. In
questi ultimi anni, Antigone nelle sue visite ha raccolto un numero sempre
crescente di segnalazioni relative all’aumento di persone detenute con patologie
psichiatriche e alla difficoltà di intercettare e gestire tali situazioni,
spesso per mancanza di risorse adeguate e per l’inadeguatezza del carcere come
luogo per la loro collocazione”.
“A tutto questo si è aggiunto
negli ultimi anni la pandemia e i vari effetti che essa ha avuto su tutta la
popolazione, contribuendo in molti casi ad ampliare e acuire situazioni di
solitudine e sofferenza. Per chi era già in carcere e ha subito la chiusura di
attività e dei contatti dell’esterno per un lungo periodo, ma anche per chi era
fuori e arriva alla detenzione con un affaticamento mentale maggiore di quanto
non avvenisse presumibilmente in passato”.
Dopo aver analizzato i
drammatici dati Antigone fa delle proposte per uscire da questo tunnel buio in
cui sono precipitate le carceri italiane. “Oltre a favorire percorsi
alternativi alla detenzione intramuraria, soprattutto per chi ha problematiche
psichiatriche e di dipendenza, è necessario migliorare la vita all’interno degli
istituti, per ridurre il più possibile il senso di isolamento, di
marginalizzazione e l’assenza di speranza per il futuro. Vanno in questo senso
favoriti interventi che hanno in generale un impatto positivo su tutta la
popolazione detenuta e che possono ovviamente avere un effetto ancora più forte
su persone con profonde sofferenze”.
Antigone, in questo senso, un
anno fa aveva presentato un documento avanzando alcune proposte di riforma del
regolamento penitenziario, al fine di sostenere la necessità di dedicare
maggiore attenzione ad alcuni aspetti della vita penitenziaria, affinché il
rischio suicidario possa essere controllato e ridimensionato. “Il regolamento
dovrebbe a tal fine prevedere in primis una maggiore cura e apertura ai rapporti
con l’esterno: più telefonate (da poter effettuare in qualunque momento,
direttamente dalla propria stanza detentiva, non solo ai familiari e alle
persone terze che rappresentano legami significativi, ma anche alle autorità di
garanzia) e allo stesso modo più colloqui”.
“Andrebbe poi
garantita particolare attenzione al momento dell’ingresso e dell’uscita dal
carcere, entrambe fasi particolarmente delicate e durante le quali anche
quest’anno sono avvenuti numerosi casi di suicidio. L’introduzione alla vita
dell’istituto deve avvenire in maniera lenta e graduale, affinché la persona
abbia la possibilità di ambientarsi alla nuova condizione e il personale il
tempo necessario ad identificare eventuali problematiche e fattori di
rischio. Ogni istituto dovrebbe avere reparti ad hoc per i nuovi giunti, un
servizio di accoglienza strutturato in cui vengono informati sui diritti e le
regole all’interno del penitenziario, la fruizione di colloqui con psicologi e/o
psichiatri e maggiori contatti con l’esterno. Maggiore attenzione andrebbe
prevista anche per la fase di preparazione al rilascio a fine pena, affinché
soprattutto per le persone che non dispongono di una rete solida all’esterno,
esso non costituisca un momento traumatico da affrontare in totale assenza di
supporto. La persona deve essere accompagnata al rientro in società e dotata dei
principali strumenti necessari. Gli istituti devono così dotarsi di un vero e
proprio servizio di preparazione al rilascio”.
Torino, giovane detenuto
suicida in carcere. Aveva rubato un paio di cuffiette bluetooth. Massimo
Massenzio su Il Corriere della Sera il 28 Ottobre 2022.
Era stato arrestato mercoledì
ed era in attesa dell’udienza di convalida
Ancora un suicidio nel carcere
di Torino. Un giovane detenuto, 22 anni, di origini africane si è tolto la vita
intorno alle 8 di questa mattina impiccandosi nella cella del padiglione B,
nella sezione «nuovi giunti» del carcere Lorusso e Cutugno di Torino.
Era stato arrestato mercoledì
per il furto di un paio di cuffiette bluetooth in un centro commerciale ed era
in attesa dell’udienza di convalida. Gli agenti hanno provato a rianimarlo
utilizzando più volte il defibrillatore, ma è stato tutto inutile.
Si tratta del 72esimo caso di
suicidio in carcere in Italia dall’inizio dell’anno. «Ogni suicidio rappresenta
il fallimento non solo della comunità penitenziaria ma di tutta la collettività
- le parole di Monica Gallo garante dei detenuti del comune di Torino. Giovani,
spesso soli sul territorio con storie faticose e vite ai margini, spesso alla
prima carcerazione per reati bagatellari verso i quali si aprono con troppa
facilità le porte del carcere per non riaprirsi mai più alla via».
È il 72esimo dall’inizio
dell’anno. La strage senza fine, giovane detenuto si toglie la vita nel carcere
di Torino: “Era in attesa di convalida”.
Elena Del Mastro su Il Riformista il 28 Ottobre 2022
Ancora un suicidio in carcere,
il 72esimo dall’inizio dell’anno. Un giovane detenuto di origine africana si è
tolto la vita intorno alle 8 nella sua cella del padiglione B, nella sezione
“nuovi giunti” del carcere ‘Lorusso e Cutugno’ di Torino. Secondo quanto
riportato dall’Ansa, era stato arrestato mercoledì per un furto ed era in attesa
dell’udienza di convalida. Gli agenti hanno provato a rianimarlo ma non c’è
stato nulla da fare.
Il giovane era arrivato in
carcere da due giorni dopo essere stato fermato per il furto di un paio di
cuffie bluetooth. Il giudice avrebbe deciso se trattenerlo in carcere ma lui non
ha aspettato e si è impiccato nella sua cella dopo il passaggio degli operatori
che al mattino consegnano la terapia ai detenuti che ne hanno bisogno.
Secondo quanto riportato da
Repubblica, l’allarme è scattato subito. Gli agenti della penitenziaria hanno
provato a rianimarlo ma per il giovane detenuto non c’è stato nulla da fare. Tra
gli agenti c’era anche un volontario della Croce rossa che ha tentato di
rianimarlo con le manovre opportune ma purtroppo per il giovane detenuto non c’è
stato altro da fare che dichiarare il decesso poco dopo le 8.
“Sono sconfortata – ha detto a
Repubblica la direttrice del carcere Lorusso e Cutugno, Cosima Buccoliero – Il
detenuto era appena arrivato, la visita all’ingresso non aveva rilevato
criticità: non c’è stato neanche il tempo di accorgersi di qualche problema e di
intervenire”.
Elena Del Mastro. Laureata in
Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di
Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie
delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.
Ruba delle cuffiette e
viene arrestato, si toglie la vita a 22 anni: il carcere va abolito!
Piero Sansonetti su
Il Riformista il 29 Ottobre 2022
Un ragazzino di 22 anni,
africano, si è ucciso nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Impiccato. Non
conosciamo il suo nome e neppure il modo nel quale è riuscito a suicidarsi.
Sappiamo solo un paio di cose. La prima è che è il suicidio numero 72 nel corso
di quest’anno. È un numero record. Pazzesco. Una media di circa un suicidio ogni
4 giorni. Quasi due a settimana. È un’emergenza assoluta.
La seconda cosa che sappiamo è
il motivo per il quale questo ragazzo era stato chiuso in carcere: aveva rubato
al supermercato delle cuffiette per lo smartphone. Lo hanno beccato e trascinato
il prigione. La polizia ha proceduto all’arresto che deve essere stato
autorizzato da un magistrato. A quanto si è saputo, ieri si è tenuta l’udienza
di convalida dell’arresto e il giudice si è riservato di prendere una decisione
nei prossimi giorni. Noi non sappiamo se il Pm che aveva disposto l’arresto, in
sede di udienza di convalida abbia o no chiesto che il ragazzino restasse in
prigione. È abbastanza probabile, altrimenti il giudice di fronte a una
richiesta unanime di scarcerazione da parte del Pm e dell’avvocato d’ufficio,
avrebbe sicuramente disposto la scarcerazione.
Se le cose non fossero andate
così, e cioè se il Pm che aveva disposto l’arresto ha poi chiesto la
scarcerazione, capendo, seppure con qualche ora di ritardo, la follia della sua
decisione, ci troveremo di fronte a una situazione ancora più paradossale: un
giudice che di fronte a delle cuffiette rubate, a un ragazzino arrivato
dall’Africa e a due richieste convergenti di scarcerazione, dovesse riservarsi ,
incerto, la decisione, sarebbe un giudice dai criteri di giudizio molto
singolari. Avete letto fin qui che toni soft stiamo tenendo? Beh, sono un errore
i toni soft. La morte di questo ragazzo grida vendetta al cielo. Chi è stato
responsabile del suo arresto per il furto di cuffiette in un supermercato è
certamente una persona poco equilibrata.
Esiste tra i lettori nostri o
di qualunque altro giornale, qualcuno disposto a dire che se un ragazzino ruba
delle cuffiette va messo in prigione? Perché allora a un magistrato è permesso
compiere un gesto così assurdo di violenza e di sopraffazione? Aveva
ragione Berlusconi quando chiedeva una visita psichiatrica periodica per i
magistrati che hanno nelle loro mani un potere così sconfinato e assurdo? Si,
aveva ragione. Stavolta, se dio vuole, la notizia ha provocato qualche reazione.
Innanzitutto nei giornali, che in genere non sono molto interessati ai suicidi
in carcere. Ieri invece le informazioni su questo delitto, seppure molto
frammentarie, erano nelle home page di molti giornali on line, a partire dai due
principali, Repubblica e il Corriere. E questo ha spinto anche i politici a
reagire. Il commento fondamentale riguarda la condizione di sovraffollamento e
di fatiscenza in moltissime carceri italiane. Denuncia giusta. Ripetuta nei
giorni scorsi dal nuovo ministro e anche dalla nuova premier.
In questo caso però
sovraffollamento e fatiscenza non c’entrano niente. I commenti sono sbagliati.
Il ragazzo era in prigione solo da due giorni e non si è ucciso per via
del sovraffollamento ma perché la sua mente e il suo orgoglio non hanno
resistito alla violenza inaudita che una prigione esercita per sua natura sui
detenuti. La prigione è un luogo estraneo a ogni idea di civiltà, è una
istituzione che demolisce le persone, privandole della libertà, sottoponendole a
un potere incontrastabile, annientandone il morale e la reputazione, radendone
al suolo il morale e la dignità. Bisogna avere una forza morale eccezionale per
resistere a questa infamia, della quale, misteriosamente, la modernità e la
civiltà non sono ancora riuscite a liberarsi.
Le prigioni sono un insulto al
buonsenso e all’umanità. Sono inutili, dannose, sadiche, servono soltanto ad
esagerare il potere di alcune piccole categorie di persone, in particolare i
magistrati. Vanno abolite. Ha un senso mantenerne un piccolissimo numero, con
pochissimi detenuti, solo per ragioni di sicurezza della comunità.
Essenzialmente per assicurarsi che gli assassini, o i violentatori, siano messi
in condizioni di non nuocere e di raggiungere dei traguardi di ripensamento e di
rieducazione. Basta.
L’idea che costruire nuove
carceri – come ha detto tra gli appalusi Giorgia Meloni alla Camera – serva a
rendere civili le carceri, è fuori dal mondo. Costruire nuove carceri serve solo
a moltiplicare i luoghi di tortura e di affossamento del diritto. Se in Italia
ci fossero state cento carceri in più, il ragazzo africano che si è ucciso ieri
si sarebbe ucciso lo stesso. E se le nuove carceri fossero servite ad aumentare
il numero dei detenuti, sarebbe proporzionalmente aumentato il numero dei
suicidi. Dopodiché si pongono due problemi ineludibili.
Il primo riguarda la politica.
Senza una formidabile depenalizzazione i problemi della giustizia sono
irrisolvibili. Perché? Perchè questo codice penale è profondamente ingiusto e
repressivo, e con un codice penale ingiusto la giustizia è condannata.
Depenalizzazione vuol dire cancellazione di moltissimi reati e riduzione
drastica delle pene. Ci sono reati non violenti, e che non prevedono vittime
individuali, puniti con dieci o quindici o vent’anni di prigione. È da pazzi.
Il secondo problema riguarda
la magistratura. Se vuole riconquistare il prestigio perduto deve fare
moltissime cose. Ma la cosa principale che deve fare è smetterla di arrestare la
gente senza ragione. Ricchi e poveri. C’è in giro un magistrato che giurerebbe
sul fatto che è stato giusto sbattere in cella quel ragazzo? Non credo. Se c’è
si alzi in piedi e lo dica a voce alta. Voglio vederlo in faccia.
Piero Sansonetti. Giornalista
professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di cui è stato
vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004 al 2009, poi
di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per poi approdare
alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre 20
Scatta l’allarme suicidi in
carcere: sono 62 da gennaio. «Quei disagi dei detenuti».
Chiara Daina su Il Corriere
della Sera il 03 ottobre 2022.
Il tasso di chi si toglie la
vita nel 2022 sarà il più alto del ventennio. La causa va cercata nell’enorme
disagio delle condizioni detentive. Urgente incentivare le misure alternative e
di recupero
Sesantadue. Dietro a questa
cifra ci sono le storie delle persone che si sono tolte la vita in carcere dal
primo gennaio al 19 settembre di quest’anno. In neanche nove mesi è stata già
superata la quota dei suicidi in cella di tutto il 2021. A denunciarlo in un
dossier l’associazione Antigone, impegnata nella tutela dei diritti dei detenuti
e delle garanzie del sistema penale. «I numeri di quest’anno generano un vero e
proprio allarme, non avendo precedenti negli ultimi anni» si legge nel
documento. Nel 2018 il tasso di suicidi ogni 10mila persone detenute era di 10,4
casi, sceso a 8,7 nel 2019 per poi risalire a 11 nel 2020 (il decimo più alto
del continente secondo l’ultimo rapporto disponibile del Consiglio d’Europa,
riferito a quell’anno) e 10,6 nel 2021. Nel 2022, considerato il trend dei
decessi in aumento, potrebbe toccare il valore più alto dell’ultimo ventennio.
In Italia i detenuti si
uccidono 16 volte in più rispetto ai liberi cittadini. Ma «il carcere non è una
condanna a morte» ha ricordato Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. Le
morti in prigione si possono prevenire. «In presenza di fragilità e segni di
allarme - spiega Michele Miravalle, coordinatore dell’Osservatorio di Antigone
sulle condizioni di detenzione - occorrono degli interventi mirati di supporto e
accompagnamento, per diminuire il senso di abbandono e risvegliare gli stimoli
verso la vita. Oggi, invece, le situazioni a rischio vengono gestite in
un’ottica di sicurezza, disponendo una sorveglianza a vista continua. Ma la
rigida logica del controllo non è la soluzione e va appunto superata con quella
flessibile dell’ascolto e dell’accoglienza della persona detenuta da parte degli
operatori».
La circolare del Dap
L’impatto dell’arresto e della
carcerazione è traumatico. «Avere la possibilità di sentire i familiari nei
momenti di maggiore angoscia - sottolinea Miravalle - può essere di vitale
importanza, allontanando il detenuto dall’intento suicidario. Per questo in
estate abbiamo lanciato la campagna “Una telefonata allunga la vita”, in cui
chiediamo di riformare il regolamento del 2000, che stabilisce una telefonata
alla settimana di massimo dieci minuti, liberalizzando i colloqui telefonici nei
casi in cui la persona possa contare su una rete sociale esterna e in assenza di
particolari esigenze di sicurezza». Vista l’emergenza, il capo del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria (dap) Carlo Renoldi ha messo a punto una
circolare per adottare la videochiamate come strumento ordinario in aggiunta ai
sei colloqui in presenza al mese concessi. I più giovani e di sesso maschile
sono la categoria più colpita. L’età media dei suicidi avvenuti finora è di 37
anni. La maggior parte aveva tra i 30 e 39 anni, seguiti dai ragazzi tra i 20 e
29 anni. Solo otto i casi over 50. Quasi la metà erano di origine straniera. Le
case circondariali di Foggia e San Vittore a Milano sono gli istituti con più
decessi registrati al momento.
«Il suicidio nella quasi
totalità dei casi - chiarisce Giuseppe Nese, coordinatore della rete regionale
di sanità penitenziaria della Campania - non è mai l’espressione di una
patologia psichiatria e, pertanto, i comportamenti a rischio non vanno
medicalizzati e trattati con psicofarmaci, né la persona che li manifesta va
trasferita nella sezione psichiatrica del carcere. Le scelte autolesive e
suicidarie sono piuttosto da inquadrare come conseguenza delle condizioni
detentive che determinano un disagio intollerabile. La pena non deve essere una
punizione ma una rieducazione. Per prevenire i gesti estremi bisogna migliorare
la qualità di vita ordinaria dei detenuti, offrendo attività che diano senso
alle loro giornate e al loro futuro, dallo sport al lavoro, il teatro e lo
studio, e che rispondano il più possibile alle esigenze e inclinazioni
personali. Per un padre che ha necessità di far campare i suoi figli e non vuole
sentirsi un peso - fa un esempio Nese - sarà utile avere un impiego lavorativo.
Come già accade in tanti altri Paesi europei, andrebbero poi allestite le
cosiddette “camere dell’amore” per le relazioni sentimentali e sessuali».
Altrettanto prioritario,
esorta Nese, è «il monitoraggio dei momenti potenzialmente più stressanti, che
potrebbero gettare la persona reclusa in un grave sconforto: dall’ingresso in
carcere ai colloqui con i familiari, le reazioni in aula di giustizia e al
rientro, la comunicazione di un lutto o di un evento drammatico che coinvolge
amici e parenti, la separazione dal coniuge, la tendenza all’autoisolamento in
sezione e all’aggressività verso gli altri. Tutti gli operatori, compresi gli
agenti, devono e possono cogliere i segnali di pericolo, non spetta soltanto al
personale sanitario farlo». L’attenzione costante per i traumi che si trova a
vivere la persona detenuta è raccomandata anche dal piano nazionale di
prevenzione al suicidio in carcere del 2017, che in una circolare dell’8 agosto
il capo del Dap invita i direttori degli istituti ad applicare.
La condizione degli spazi e
del tempo all’interno del carcere è determinante dunque. «Il suicidio -
ribadisce Miravalle - è legato al malessere della struttura e al
sovraffollamento. Su oltre 55mila reclusi, circa 10mila sono sottoposti al
regime di 41 bis e di alta sicurezza per reati di criminalità organizzata, il
resto è gente che ha alle spalle storie di marginalità sociale e povertà. Per
queste persone afflitte da fragilità la risposta doveva essere un welfare più
forte e invece sono finite in galera. È fondamentale incentivare le misure
alternative alla detenzione. Quelle 62 persone molto probabilmente fuori dal
carcere non si sarebbero mai ammazzate», conclude Miravalle.
Il dossier di Antigone.
Dramma carceri, in 8 mesi 59 suicidi: le storie.
Sofia Antonelli su Il
Riformista il 8 Settembre 2022
Mai così tanti suicidi nei
primi due terzi dell’anno. Cinquantanove in totale, più di uno ogni quattro
giorni. In soli otto mesi non erano mai stati registrati così tanti decessi. In
tutto il 2021 erano stati 57. Se questi numeri fanno impressione già di per sé,
il paragone con quanto avviene nella società esterna desta ancora più clamore:
in carcere ci si uccide 16 volte di più rispetto a quanto non avvenga nel mondo
libero. Mentre l’Italia in generale è considerato un Paese con un basso tasso di
suicidi a livello europeo, se si guarda alle sue carceri la posizione in
classifica cambia notevolmente, attestandosi al decimo posto tra i paesi
del Consiglio d’Europa.
Questo è
quanto Antigone racconta in un dossier realizzato per non far cadere nel
silenzio il dramma che sta colpendo le carceri italiane nel 2022. Un documento
voluto per raccontare i numeri, ma anche i luoghi e alcune delle storie di
quelle 59 persone che hanno deciso di togliersi la vita. Se si guardano le
biografie di queste 59 persone si scopre che quasi la metà era di origine
straniera. Quattro le donne, una percentuale particolarmente alta rispetto agli
anni precedenti. Molte le persone affette da disagi psichici o da dipendenze.
Ma, come dicevamo, il dossier di Antigone non parla solo di numeri, ma
soprattutto di vite e di storie. Storie di grande dolore, storie di marginalità.
Storie di persone che in carcere si trovavano da poco o che avrebbero dovuto
lasciarlo a breve. Storie anche di persone che in carcere non ci sarebbero
dovute nemmeno essere.
È questo il caso di G.T., un
giovane ragazzo di 21 anni arrestato per il furto di un cellulare. A causa delle
sue patologie psichiatriche, il Tribunale di Milano lo aveva dichiarato
incompatibile con il regime carcerario chiedendo il suo trasferimento
in Rems (Residenza per le misure di sicurezza). Dopo diversi mesi da quella
pronuncia e un primo tentato suicidio, a fine maggio G.T. si è tolto la vita in
una cella di San Vittore. Pochi giorni prima un altro ragazzo si era ucciso a
poche celle di distanza. Il dossier riporta poi la storia di A.G., anche lui
ventenne, anche lui affetto da disagio psichico, anche lui con un tentato
suicidio alle spalle. Neanche due settimane dopo il suo ingresso in carcere si è
tolto la vita al Lorusso Cotugno di Torino. Non aveva precedenti penali e quello
era il suo primo arresto. C’è poi la storia di D.H., la giovane donna che prima
di togliersi la vita nel carcere di Verona ha lasciato un biglietto d’addio al
fidanzato.
Il magistrato che da anni
seguiva il suo caso, dopo il decesso della donna ha ammesso con dolore che con
lei tutto il sistema aveva fallito. Tramite la testimonianza di un signore che
ha contattato Antigone abbiamo poi saputo la triste storia di un uomo detenuto
per aver rubato una pecora e chiesto il riscatto al proprietario. Affetto da
disagio psichico, si è tolto la vita nel carcere di Castrovillari. Nessuno ne ha
mai reclamato il corpo e dopo qualche settimana è stato sepolto nel cimitero
della città a spese del comune. Queste sono solo alcune delle storie raccolte
nel dossier, ognuna frutto di personali trascorsi e sofferenze. Non possiamo
però non guardarle nel loro insieme come indicatore di malessere di un sistema
da cambiare, in cui il profondo isolamento e l’assenza di speranza la fanno da
padrone. Gli interventi da apportare sarebbero molti, c’è bisogno di importanti
riforme che andavano però fatte nei mesi scorsi. Oggi, a pochi giorni delle
elezioni, non c’è più tempo. Ma c’è tempo per fare due cose.
La prima è quella
che Antigone ha chiesto attraverso la sua campagna “Una telefonata allunga la
vita”, ovvero la liberalizzazione delle telefonate. Il regolamento attualmente
in vigore ne prevede oggi solo una a settimana da 10 minuti, ma la sua entrata
in vigore risale al 2000. Si tratta di un intervento semplice ma con un grande
impatto sulla vita delle persone, soprattutto nei momenti di difficoltà, quando
una voce cara può fare tanto. La seconda è chiedere a tutti i protagonisti della
campagna elettorale di impegnarsi per portare avanti quelle riforme necessarie e
urgenti per dare un senso alla pena, renderla meno afflittiva, in linea con il
dettato costituzionale e la tutela della dignità umana. Sofia Antonelli
Emergenza carceri, in 8
mesi 59 suicidi: mai così tanti. "Persone fragili, tossicodipendenti e malati
psichiatrici che non dovevano essere lì".
Giulia Torlone su La
Repubblica il 2 Settembre 2022.
Donatella, "delicata come un
cristallo di Boemia". Simone, 44enne con problemi psichici che aveva rubato un
telefonino. Alessandro, che si è tolto la vita al secondo tentativo: non era più
sorvegliato. L'appello del Garante, di Antigone e del sindacato degli agenti:
"Pochi medici, celle sovraffollate, l'isolamento dovuto al Covid tra le ragioni
dell'impennata. Le regole vanno ripensate". E da Villa Maraini le voci di chi ce
l'ha fatta
"Ho fallito, so che avrei
potuto fare di più" scrive in una lettera aperta Vincenzo Semeraro, magistrato
di sorveglianza del Tribunale di Verona. Sente addosso la colpa di non aver
impedito a Donatella Hodo di togliersi la vita inalando gas da un fornelletto
nella notte tra l'1 e il 2 agosto, nel carcere di Montorio. Di lei, ragazza
ventisettenne, il giudice ha ricordato il suo essere "fragile, fragilissima,
come un cristallo di Boemia", con un passato di dipendenza dalla droga e una
serie di furti.
In pochi mesi
superato il record dell'intero 2021. Dramma carceri, 57 suicidi in 8 mesi: 14
solo ad agosto, più di uno ogni 2 giorni.
Redazione su Il Riformista il
27 Agosto 2022
Quello che sta succedendo nelle carceri
italiane è una silenziosa mattanza. Nel 2022 si contano già 57 suicidi, lo
stesso numero registrato in tutto il 2021, anno di un drammatico primato. “Il
carcere non è una condanna a morte. È necessario intervenire affinché il dramma
che sta interessando gli istituti di pena italiani in questo 2022 si possa
fermare”, ha detto Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. I numeri ricordati
dall’associazione sono drammatici: nei primi 8 mesi di quest’anno sono stati 57
i detenuti che si sono tolti la vita nelle carceri. Gli ultimi due in Sicilia,
uno a Caltanissetta e l’altro a Siracusa. Ad agosto abbiamo registrato 14
suicidi, più di uno ogni due giorni. Furono 57 le persone che si suicidarono in
carcere in tutto il 2021. Un dramma che è la fotografia della terribile
situazione delle carceri.
“Proprio in questo mese così drammatico la
nostra associazione – prosegue Gonnella – ha lanciato la campagna ‘Una
telefonata allunga la vita’, chiedendo una riforma urgente del regolamento del
2000 che porti ad una liberalizzazione delle telefonate per i detenuti. In un
momento di sconforto, sentire una voce familiare, può aiutare la persona a
desistere dall’intento suicidario. I 10 minuti a settimana previsti attualmente
non hanno più nessun fondamento, né di carattere tecnologico, né economico, né
securitario. Cambiare quel regolamento non comporta alcun atto legislativo e il
Governo potrebbe farlo anche in questa fase transitoria”.
“Dell’importanza dell’affettività per i
detenuti – continua il presidente di Antigone – ci parla anche la relazione
finale della Commissione ispettiva del Dap, chiamata ad indagare sulle ragioni
delle rivolte che scoppiarono nelle carceri nel marzo 2020”. Secondo questa, ad
innescare le proteste non fu infatti una cabina di regia criminale. Il motivo va
invece ricercato nell’insoddisfazione della popolazione detenuta per la poco
dignitosa qualità della vita penitenziaria e, soprattutto, nella sospensione dei
colloqui in presenza con i familiari.
“All’indomani di quelle chiusure – sottolinea
Patrizio Gonnella – la nostra associazione chiese che a tutti i detenuti fossero
concesse chiamate e videochiamate in più rispetto a quanto previsto dai
regolamenti. Quella richiesta fu accolta e nel giro di pochi giorni nelle
carceri di tutto il paese arrivarono oltre 1.000 tra cellulari e tablet, senza
che ci fossero problemi dal punto di vista organizzativo e della sicurezza.
Questa iniziativa servì a riportare la calma negli istituti di pena e constì ai
detenuti di mantenere il rapporto con i propri affetti anche in quel periodo di
chiusure parziali o totali”.
“Oggi il dramma che sta attraversando il
carcere non è il Covid ma sono i suicidi. La risposta, oggi come allora, passa
anche dalla possibile vicinanza affettiva. Oggi come allora è urgente che il
governo prenda provvedimenti e si liberalizzino le telefonate” conclude Patrizio
Gonnella, che auspica che a settembre, alla ripresa dei lavori parlamentari,
Deputati e Senatori osservino un minuto di silenzio per commemorare tutte le
persone che si sono tolte la vita mentre erano sotto la custodia dello Stato.
Estratto dell’articolo di
Federica Angeli per “la Repubblica” l'11 agosto 2022.
[…] Al 10 di agosto, su 54.000
detenuti, 49 si sono tolti la vita: venti volte di più rispetto alla media
esterna. Un mese fa è toccato a una trentenne nel braccio femminile di Rebibbia,
madre di due bambine […] tossicodipendente con doppia diagnosi, sia psichiatrica
che di consumi. Non ha retto, le misure alternative non sono state trovate per
lei e si è suicidata in infermeria dove era ricoverata.
[…]sono i numeri a spiegare la
disumanità del sistema carcerario che sembra non avere più la sua missione
iniziale ovvero […] "vigilando redimere". «A fronte dei 54mila detenuti oggi in
Italia […] almeno un terzo, 18mila, avrebbe bisogno di essere trasferito in
centri di recupero per tossicodipendenti o in centri psichiatrici». E invece
sono chiusi nelle celle in attesa che la loro pena scenda sotto i quattro anni.
[…] «La valutazione si basa
sulla pena e sulla condotta, non sulla necessità - spiega Gabriella
Stramaccioni, garante dei detenuti di Roma - Devi avere una pena al di sotto dei
4 anni per andare in comunità terapeutica, ed è molto raro che ciò avvenga
[…]».
E via con altri numeri. «Sa
quante sono oggi le persone detenute che si trovano in carcere con una pena
inflitta di un anno? […] Sono 1.344. E sa quante sono quelle con una pena
residua da scontare di un anno? 7.067. Il carcere è diventato una discarica
indifferenziata. La recidiva reale è al 90%: chi esce delinque più di prima. In
termini di costi indiretti (i soli costi diretti sono 4 miliardi) non sappiamo
quanti miliardi si spendono, cifre astronomiche».
[…] ci sono un educatore e un
magistrato ogni 200 detenuti, alcuni attendono 6-7 mesi per un colloquio. Quanto
ai direttori di carceri ne mancano 200 su 500 totali: il concorso è stato fatto
da poco e non prima della fine del 2023 entreranno in servizio […]
Altri due suicidi: uno a
Monza e l’altro a Rimini. Da gennaio sono 51.
Il capo del Dap, Carlo
Renoldi, e gli altri vertici dell’amministrazione penitenziaria nel giorno di
Ferragosto saranno in visita in molti istituti tra i quali l’Ucciardone e il
Pagliarelli di Palermo, Poggioreale a Napoli, Santa Maria Capua Vetere e
Rebibbia. Francesco De Felice su Il Dubbio il 12 agosto 2022.
L’ultimo suicidio, speriamo, è
di ieri mattina presto nel carcere di Monza. Il pomeriggio prima un altro
detenuto si era tolto la vita a Rimini. Ormai sembra una escalation
inarrestabile che interessa tutti gli istituti penitenziari italiani. In
Campania se sono registrati tre in soli cinque giorni. L’ultimo martedì a
Secondigliano, dove si è impiccato, nella sua cella Dardou Gardon, detenuto
algerino di 33 anni condannato per rapina. In Campania, evidenziano i garanti
della Campania e di Napoli, Samuele Ciambriello e Pietro Ioia, è «il terzo
suicidio in soli cinque giorni; la morte di martedì a Secondigliano si somma a
quelle di un detenuto di Arienzo e di un detenuto di Poggioreale». I due garanti
chiedono che «le parole messe nero su bianco nell’ultima circolare del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria per prevenire gli eventi
suicidari diventino buone prassi negli istituti di pena» e invitano il Capo del
Dipartimento e il ministro della Giustizia «a visitare le carceri del
circondario napoletano, Poggioreale in primis, l’Istituto più sovraffollato
d’Italia, e a partecipare ad una tavola rotonda con magistrati di sorveglianza,
Amministrazione penitenziaria, Garanti regionali e territoriali e Terzo
settore».
Sono 51 le persone che si sono
tolte la vita da gennaio
Con queste ultime morti è
salita a 51 la triste statistica dei suicidi dall’inizio dell’anno, basti
pensare che l’anno scorso, nello stesso periodo, erano a 32 e furono 55 alla
fine del 2021. Il dossier “morire di carcere”, curato da Ristretti Orizzonti,
racconta come da dieci anni a questa parte i suicidi avvenuti tra il mese di
gennaio e quello di giugno siano stati un minimo di 19 e un massimo di 27. Solo
nel 2010 e nel 2011 si era arrivati rispettivamente con 33 e 34 suicidi.
L’associazione Antigone, nel suo ultimo rapporto, aveva lanciato l’allarme: un
tasso di sovraffollamento al 112%, troppo caldo, troppi problemi invisibili e
irrisolti, come quelli legati allo stato di salute mentale di chi finisce in
cella e che oltre a scontare una pena avrebbe diritto a cure sanitarie
specifiche, oltre alla violenza e all’esasperazione dietro le sbarre sono una
miscela esplosiva. Lo stesso garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, nel
corso della sua ultima relazione in Parlamento, aveva descritto la situazione e
sollecitato degli interventi.
Antigone fa anche il confronto
con quanto accade fuori dagli istituti di pena: con 0,67 casi di suicidi ogni
10.000 abitanti, l’Italia è in generale considerato un Paese con un tasso di
suicidi basso, uno tra i più bassi a livello europeo. Secondo gli ultimi dati
del Consiglio d’Europa, l’Italia si colloca invece al decimo posto tra i paesi
con il più alto tasso di suicidi in carcere. A fine 2021, tale tasso era pari a
10,6 suicidi ogni 10.000 persone detenute.
Gennarino De Fazio (Uilpa):
«L’ultima circolare del Dap non serve quasi a nulla»
Per Gennarino De Fazio,
segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, la circolare a firma del
Capo del Dap, Carlo Renoldi, di pochi giorni fa è «di per sé condivisibile nei
principi e negli obiettivi. Crediamo, peraltro, rappresenti il massimo che si
potesse fare a livello amministrativo. Tuttavia, a nostro avviso, non serve
quasi a nulla per le stesse ragioni già accennate. Da tempo diciamo che la grave
emergenza penitenziaria, connotata pure da sovraffollamento detentivo, non è
affrontabile, se non marginalmente, per via amministrativa, ma che servono
interventi legislativi investendo le risorse necessarie. Sarebbero stati
indispensabili un decreto-legge per affrontare le urgenze e, parallelamente, una
legge delega per le riforme strutturali. Adesso non rimane che attendere il
prossimo esecutivo, sperando che si dimostri all’altezza delle attese, senza
sottovalutare che in autunno l’eventuale recrudescenza dei contagi da Covid-19 e
possibili tensioni sociali si andrebbero a sommare alle pesantissime criticità
preesistenti e potrebbero innescare nuove proteste e disordini generalizzati.
Speriamo di sbagliarci».
I vertici del Dap a Ferragosto
in visita nelle carceri
Ieri si è fatto sentire anche
il capo del Dap, Carlo Renoldi, con una nota del ministero della Giustizia:
«L’estate, come spesso accade, si dimostra il momento più critico dell’anno per
gli istituti penitenziari. In questo 2022 è reso ancora più doloroso dal
drammatico incremento dei suicidi: ciascun episodio interroga le nostre
coscienze di uomini e di operatori del sistema penitenziario su quanto è stato
fatto finora e su quanto sia ancora necessario fare. Per questo, insieme ai miei
più stretti collaboratori, al Vice Capo, ai Direttori generali del Dap e ai
Provveditori regionali abbiamo avvertito l’esigenza di visitare degli istituti
penitenziari anche nel giorno di Ferragosto. Vogliamo portare un segnale di
vicinanza all’intera comunità penitenziaria e ribadire riconoscenza al personale
in servizio». Il capo del Dap lunedì, dopo aver partecipato al tradizionale
Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica, visiterà la Casa circondariale
femminile e la Casa di reclusione di Roma Rebibbia. Gli altri vertici
dell’Amministrazione saranno a Viterbo, Palermo Ucciardone, Genova Marassi,
Lecce, Taranto, Palermo Pagliarelli, Terni, Napoli Poggioreale e Santa Maria
Capua Vetere, Bologna, Modena, Ancona, Pesaro, Aosta, Udine, Oristano e Ariano
Irpino. E sempre il 15 agosto il vicepresidente del Csm, David Ermini, e il
sindaco di Firenze, Dario Nardella visiteranno il carcere di Sollicciano
insieme al Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma.
È il 49esimo suicidio in
carcere dall’inizio dell’anno, il 3 in Campania in pochi giorni.
Voleva avvicinarsi alla
famiglia ma lo hanno allontanato di più: così si è tolto la vita in carcere a 33
anni. Rossella Grasso su Il Riformista il 10 Agosto 2022
Aveva solo 33 anni Dardou
Garrdon, di origine algerina, detenuto nel carcere di Secondigliano di Napoli.
La sua è l’ennesima storia di disperazione e marginalità che lo hanno portato a
compiere il gesto estremo. Dardou nel pomeriggio del 9 agosto ha stretto il
lenzuolo intorno al collo e si è lasciato cadere mentre era nella sua cella.
Inutili sono stati i soccorsi da parte del compagno di cella che si è presto
accorto di quello che stava succedendo e ha sciolto il nodo del lenzuolo attorno
al suo collo. Inutile il pronto intervento degli agenti che hanno tentato di
salvargli la vita. Inutili sono stati i soccorsi del 118 arrivati a stretto
giro. Per Dardou non c’era già più niente da fare. Poche ore prima, nel carcere
di Poggioreale, a pochi chilometri da Secondigliano, un altro detenuto si è
tolto la vita: si chiamava Francesco Iovine, aveva 43 anni e soffriva di
anoressia. Sono 5 i detenuti che si sono tolti la vita in carcere dall’inizio
dell’anno in Campania, 3 nel giro di pochi giorni ad agosto, 49 in tutta Italia.
Una strage silenziosa e agghiacciante. Un agosto tremendo che è lo specchio
della disumanità delle carceri e del totale fallimento del suo scopo
rieducativo.
Dardou il 7 agosto ha compiuto
33 anni. Era stato arrestato a Milano il 7 agosto 2018. Il 5 agosto 2023 sarebbe
terminata la sua pena. A dare notizia di questo ennesimo suicidio in carcere il
garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello e il garante dei
detenuti di Napoli Pietro Ioia, che subito sono corsi a Secondigliano. Dardou
aveva origini algerine e la sua famiglia viveva a Marsiglia. Aveva anche una
figlia probabilmente una bambina vista la giovane età del padre. Ha girato tante
carceri per poi arrivare a quello di Benevento. Se ne stava sempre solo e in
disparte. Parlava poco e male l’italiano, non faceva colloqui con la famiglia
che era troppo lontana e per loro era impossibile venire in Italia per vederlo.
Dal suo ingresso in carcere non aveva avuto mai colloqui e non aveva nemmeno
notizie della figlia. Un uomo solo al mondo rinchiuso in una gabbia in cui era
ancora più solo. L’inferno in terra.
Il garante Ciambriello
racconta che dal carcere di Benevento aveva più volte chiesto il trasferimento
in un altro carcere della Liguria o del Piemonte per potersi avvicinare alla
famiglia che con un treno avrebbe potuto raggiungerlo più agevolmente. Già in
passato aveva tentato il suicidio per ben 3 volte nel giro di pochi giorni. Il 5
maggio scorso Ciambriello aveva scritto a Carlo Renoldi, capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, e a Gianfranco De Gesu, Direttore Ufficio
Detenuti e Trattamento Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria per
segnalare la grande sofferenza del 33enne con cui era spesso in contatto.
Durante l’ultimo tentativo di suicidio Ciambriello aveva parlato al telefono con
Dardou, lo aveva calmato. Ma pochi giorni dopo lui aveva minacciato di buttarsi
da un piano alto dell’Istituto.
“Mi sono confrontato con il
Direttore del carcere di Benevento, che è favorevole a tale trasferimento –
scriveva Ciambriello nella lettera – anche perché si tratta di un detenuto con
fine pena il 5 agosto 2023. Vi chiedo di considerare, quanto prima possibile,
tale richiesta”. La risposta arrivava il 18 maggio fredda e netta: “In data 6
maggio il competente Ufficio di questa Direzione Generale ha invitato la
Direzione della Casa Circondariale di Benevento a comunicare al detenuto
il mancato accoglimento delle sue istanze di trasferimento per mancanza di
motivazioni”. Gli comunicavano anche la novità: il 7 maggio si sarebbe dovuto
trasferire nel carcere di Secondigliano “per esigenze di
istituto”. Dunque Dardou che voleva essere avvicinato a casa si è ritrovato in
un blindato che invece lo portava ancora più lontano. Chissà con quanta
disperazione deve aver appreso la notizia. Tutto questo per scontare una pena di
appena 5 anni.
Pietro Ioia racconta che il
detenuto era ben seguito a Secondigliano perché non stava bene. “Lo avevano
messo nella sezione migliore dell’Istituto, quella con le celle aperte proprio
perché così stesse meglio. Il 2 agosto aveva avuto la sua ultima visita
psichiatrica. Ma la sua sofferenza ha prevalso. Questa è una sconfitta per
tutti. Un omicidio istituzionale”.
“Noi più che garanti siamo
diventati becchini – dicono Ioia e Ciambriello – Ormai corriamo in carcere più
per i morti che per i vivi. In pochi giorni già 3 suicidi. Non dovrebbe
succedere in un paese civile. Chiediamo che il capo del Dap e la Ministra
Cartabia vengano qui nelle nostre carceri della Campania. Questa è un’emergenza
nazionale”. “Quella di Dardou è una storia di disperazione – continua
Ciambriello – Il carcere è come una condanna a morte per chi è completamente
solo o ha partenti lontani. Lo Stato in ogni caso dovrebbe evitare che succeda
che qualcuno decide di morire. È come un omicidio questo”.
“La cosa più inquietante è che
già quando uno entra in carcere diventa un numero – conclude Ciambriello
– Quando muore scompare completamente dagli archivi. Non solo in carcere le
persone diventano un numero ma poi scompaiono pure”. È questa l’ “umanità” del
carcere che non tutela i diritti di persone, esseri umani, che sono di carne,
ossa e anima.
Rossella Grasso. Giornalista
professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate
nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato
la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie
testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos,
Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli.
Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’
autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio
mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.
Boom di suicidi in carcere,
la rabbia dei penalisti: “Cosa state facendo?!”
Tiziana Maiolo su Il Riformista il 10 Agosto 2022.
Due giorni fa si sono svolti i
funerali di Donatella, ventisette anni, suicida nel carcere di Montorio Verona,
detenuta per reati legati a piccole cessioni di sostanze psicotrope. Una persona
che non avrebbe dovuto stare rinchiusa. Ce ne sono tanti, e alcuni di loro non
ce la fanno più, in questa estate del caldo e di una campagna elettorale da cui
è esclusa la giustizia, e figuriamoci il carcere. Raccontata in numeri,
Donatella era uno dei 47 che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno nelle
prigioni italiane, uno dei cinque dei primi sette giorni di agosto. Il
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è intervenuto finora solo con
un’operazione di tipo progettuale e preventivo. Ma nessun provvedimento
“salvavita”, cioè quello che servirebbe da subito per spezzare l’angoscia, la
solitudine e i tanti problemi materiali quotidiani che producono
l’insopportabilità del “malvivere” da prigionieri. Il capo del Dap Carlo
Renoldi ha emanato una circolare, indirizzata a tutti i provveditori regionali e
ai direttori degli istituti di pena. Un gesto di buona volontà, un progetto per
il futuro. Che cozza però da subito, come è stato fatto notare da qualche
operatore, con le criticità croniche delle carceri. Il problema del personale,
sempre insufficiente, prima di tutto, e anche quella chimera dei corsi di
specializzazione professionale di cui si parla molto nei convegni. E che poi
rimangono lettera morta.
La circolare si chiama “Linee
guida per la prevenzione dei suicidi”, e già questo è singolare. Vuol dire che
prima dell’arrivo del dottor Renoldi questi indirizzi non esistevano? Il
documento si rivolge allo staff multidisciplinare composto in ogni istituto dal
direttore, il comandante degli agenti di polizia penitenziaria, oltre al medico,
l’educatore e lo psicologo. Sono questi i soggetti incaricati di esplorare le
situazioni a rischio, quelli in grado di far emergere gli “eventi sentinella”
del disagio per poi costruire le pratiche operative della prevenzione in ogni
situazione. Cioè si spiega agli operatori non tanto quello che dovrebbero fare
d’ora in avanti per capire e quindi lanciare il segnale di allarme, ma quello
che avrebbero già dovuto fare. L’ovvio, insomma. E infatti insorgono gli
avvocati delle Camere penali e anche l’Ordine degli psicologi, cioè tutti quei
soggetti che conoscono, al contrario dei magistrati, che cosa significhi per una
persona, qualunque sia stata la sua vita fino al giorno precedente, l’ingresso e
poi la vita in un carcere.
È indirizzata al capo
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Carlo Renoldi e al suo vice
Carmelo Cantone e firmata dal Presidente Giandomenico Caiazza e dai responsabili
dell’osservatorio carceri, gli avvocati Gianpaolo Catanzariti e Riccardo
Polidoro, la lettera con cui l’Unione delle Camere penali chiede un incontro
urgente per “essere messa a conoscenza della modalità con cui viene affrontata
questa emergenza, che sta rendendo ancor più la detenzione in Italia contraria
alle più elementari regole della vita in un Paese civile”. Gli avvocati
penalisti chiedono e si chiedono anche in che cosa consisterebbe, concretamente,
questo approccio multidisciplinare al grave problema, a questo allarme
drammatico. Il che ci fa tornare al punto di partenza. Tutti i dirigenti del Dap
che hanno preceduto quelli di nomina recentissima, come hanno affrontato la
situazione, visto che non è proprio una novità il fatto che la detenzione
produca morte e autolesionismo? Per non parlare delle gravi patologie
psichiatriche che hanno ormai raggiunto il 13% dell’intera popolazione
carceraria, il che significa parlare di 7.000 detenuti che stanno male, anzi
malissimo. Che non dovrebbero essere lì dove sono stati rinchiusi, che sono già
di per sé delle “sentinelle” del disagio, e lo gridano a voce alta, prima ancora
che di loro si accorga qualunque staff multidisciplinare.
Dalle colonne di Avvenire, uno
dei pochissimi quotidiani (insieme al Riformista e al Dubbio) che mostra
sensibilità nei confronti di chi soffre, e particolarmente di chi è privato
della libertà, si sente anche la voce del dottor David Lazzari, Presidente del
Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, che ci informa del fatto che “i
presidi sanitari nelle carceri sono sguarniti di professionisti della salute
mentale”. Il che va a sommarsi alla cronica carenza di personale di ogni tipo,
mentre la dirigenza del Dap esorta i provveditori a dare particolare attenzione
alla formazione specifica di quegli operatori che proprio non ci sono. Non
vogliamo infierire, sono questioni antiche e non sarebbe giusto scaricarne le
responsabilità su chi è arrivato da poco al vertice del Dap. Ma siamo concreti.
E lo diciamo anche ai giudici. Ma è possibile che a nessuno venga in mente che
concedere qualche telefonata in più, qualche contatto supplementare a quelli
canonici con la famiglia, un po’ di umanità, insomma, per fare qualche passo in
avanti e magari salare qualche vita? Tirate fuori il naso dalle scartoffie, per
favore. Per la salute mentale di tutti.
Tiziana Maiolo. Politica e
giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e
XIII legislatura.
Chissà se qualche leader politico alzerà
un dito...La strage ignorata delle carceri, 44 suicidi da inizio anno.
Tiziana Maiolo su Il Riformista il 4 Agosto 2022
Una strage. Una strage voluta. Quattro suicidi in
quattro giorni, e siamo a quarantaquattro dall’inizio dell’anno. Si chiama
morire di carcere, morire di voglia di libertà, di assenza di giustizia. Il
cappio al collo non è solo quello che ti stringe e ti soffoca fino all’ultimo
goccio di respiro. È anche il simbolo di quella vita che ti sta stretta, della
giustizia che rinchiude il tuo corpo perché non sa in quale altro modo
sanzionare le tue trasgressioni. E lo stringe, lo stringe fino a quando non c’è
più l’aria né la vita. Donatella e le altre e gli altri non ci sono più. Un
cappio al collo nella sezione femminile di Rebibbia. Darsi la morte ad Ascoli
Piceno o a Verona a soli 27 anni. O ancora la pena dell’impiccagione data a se
stesso a Brescia, a Canton Mombello, mentre stai già un po’ morendo perché sei
in un reparto di massima sicurezza, dove dovrebbe esserci anche la massima
sorveglianza, e sei spaventato perché ti ritrovi in isolamento causa covid, e
stringere il tuo collo, a soli 47 anni, ti sembra la soluzione di tutto, in quel
momento. E così, giorno dopo giorno, a Sassari, a Pavia, a Viterbo, e persino a
Bollate, il carcere di minima sorveglianza.
Eppure era stato chiaro e perentorio il
Presidente Sergio Mattarella, nel giorno del suo secondo insediamento, quando
aveva scelto di parlare di giustizia e di carcere. Quando si era impegnato, e
aveva impegnato il Parlamento a fare qualcosa, qualunque cosa perché questa
strage avesse termine. Invano. E chissà se almeno lui si renderà conto di questa
strage in corso. Ma che cosa sta succedendo, se il sovraffollamento ha superato
il livello di guardia già alto dell’anno scorso, e se il numero dei suicidi
aumenta vorticosamente, e ha già superato di dieci unità i 34 morti del 2021?
Certo, fa molto caldo, e le carceri italiane sono sotto ogni standard di dignità
umana. Certo, abbiamo tutti sofferto, e in particolare coloro che sono reclusi,
lo stress e la paura per l’epidemia da covid. Ma c’è qualcosa di più. C’è la
consapevolezza della totale disattenzione del mondo politico, del mondo intero,
forse, per le questioni di giustizia, per quelle vere di coloro che, dopo aver
strappato il patto con la propria comunità, non riescono più a ritrovare il
bandolo che possa portare alla ricucitura. Perché non solo nessuno li aiuta, ma
si ha la sensazione che molte forze politiche abbiano un certo godimento a
cacciarli sempre più giù, a tenerli costantemente con la testa sotto il pelo
dell’acqua. E allora, tanto vale andare giù del tutto. In tanti modi. Con il
suicidio esplicito, con il cappio al collo. Ma anche in altri modi. Con l’abuso
di farmaci, per esempio. O anche con il lasciarsi morire lentamente, perché se
hai una grave patologia, come quelle oncologiche, per esempio, sai già che non
ti lasceranno comunque andare a morire in un luogo dignitoso, e quindi ti
suicidi in carcere lasciandoti andare. Perché sai che di te, di te numero prima
che persona, non importa a nessuno, a parte i tuoi cari. Ma a nessuno delle
istituzioni, tanto per dire.
Forse quel discorso di Mattarella aveva dato
qualche speranza. Forse l’impegno della ministra Cartabia era parso come un
semaforo verde che aprisse qualche porta, e la caduta del governo Draghi proprio
mentre il Parlamento stava attuando importanti riforme sulla giustizia, certo
non ha giovato. Tra l’altro pare particolarmente preoccupante, come ha ricordato
il presidente dell’associazione Antigone, Patrizio Gonnella, il fatto che con
l’ultimo suicidio di ieri siamo arrivati a un numero così elevato “che non trova
uguali negli ultimi anni. Un numero elevatissimo di suicidi superiore a quello
riscontrato nel periodo di maggiore sovraffollamento, quando l’Italia fu
condannata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per le condizioni inumane e
degradati delle sue galere”.
Viene rabbia e un certo furore, a pensare che
basterebbe così poco. Non c’è bisogno di pensare in grande, per cominciare a
salvare qualche vita. Cominciamo a svuotare, come prima cosa. Se lo si è potuto
fare nei giorni del Covid e con un ministro non certo garantista come Bonafede,
che cosa si aspetta, per esempio, a trasformare la detenzione in carcere in
domiciliare per tutti coloro che stanno scontando l’ultimo anno di pena? Ci sono
le leggi, a dirlo, ultima quella del 2015, che occorre privilegiare le forme
alternative alla reclusione. E poi, i magistrati, soprattutto quelli che si
definiscono ”democratici”, potrebbero dare una bella regolata alla custodia
cautelare, e anche lì trovare altri strumenti di tutela. E infine, ci appelliamo
ai bravi giudici di sorveglianza, e ai direttori degli istituti di pena (ce ne
sono tanti, di illuminati) e ai dirigenti del Dap, e a chiunque abbia titolo per
aiutare: l’affettività! Sono ammassati nelle celle come animali da allevamento,
non c’è l’acqua, in estate ci sono anche pochi educatori e poche attività
culturali e ricreative, fa un caldo come non mai. Ma accidenti, e fagli fare
qualche telefonata in più. Ripristinate per tutti, anche nei reparti di massima
sicurezza e di regime 41 bis, le videochiamate! Di che cosa avete paura, che
qualcuno contatti Matteo Messina Denaro e prepari con lui l’evasione di massa?
Ricordate che quando, su iniziativa di tanti magistrati di sorveglianza nei
giorni dell’epidemia, tanti detenuti furono mandati ai domiciliari, nessuno
scappò. Una bella lezione quando, a decreto ritirato, tutti tornarono nelle loro
celle. Compresi i malati gravi.
Chissà se la notizia di queste 44 persone che non
ci sono più, di queste ultime quattro che l’una dopo l’altra sono rotolate via,
scuoterà qualche coscienza. Se altri media, oltre a noi, se ne sarà accorto. Se
qualche leader politico, pur a Camere sciolte, alzerà un dito da qualche parte,
se non in Parlamento almeno di fronte alle telecamere che sempre abbondano
davanti al Senato, a Montecitorio e Palazzo Chigi. Chissà se quel qualcuno
griderà che è una vergogna e che lui stesso è pronto a impegnarsi per salvare
qualche vita. Esistono ancora i garantisti Berlusconi e Renzi e Calenda e Bonino
e il referendario Salvini? Se nessuno se ne vuole occupare, se nessuno vuole
afferrare quel bandolo salvavita, allora ciò significa una cosa sola, che siamo
davanti a una strage voluta. E andatevene al diavolo, voi e i vostri piccoli
mercanteggiamenti. Non siete degni dei nostri voti.
Tiziana Maiolo. Politica e giornalista italiana è
stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e XIII legislatura.
Pena di morte,
morte per pena. Le chiamate carceri ma sono patiboli: la strage dei suicidi in
cella.
Piero Sansonetti su Il Riformista il 6 Agosto 2022
Non conosco il
suo nome, so che aveva 26 anni. Era un ragazzino. Stava in cella in un carcere
di Frosinone e aspettava che lo trasferissero a Rebibbia. Tra la prigione e la
morte ha scelto la morte, non ce la faceva più di stare rinchiuso. S’è ucciso.
Come pochi giorni fa si era uccisa, nella prigione di Verona, una sua coetanea,
accusata di piccoli furti e tossicodipendente.
È una strage
quella dei tossicodipendenti. Che sono un terzo dei prigionieri. Li acciuffano e
li sbattono dentro. Lo sanno che sono soggetti debolissimi? Le conoscono le loro
sofferenze? Sono al corrente della fragilità, della possibilità che non reggano
dietro le sbarre? Chissà. Del resto la legge è legge e non puoi farci niente. Se
hai sbagliato paghi. Anzi, paghi anche se non hai sbagliato ma il Pm pensa che
tu sia colpevole. Magari, invece, potresti anche farci qualcosa, ma nel clima
politico instaurato negli ultimi quindici anni in Italia, tra partito dei Pm e
Cinque Stelle e giornali alla coda di Travaglio, è meglio che non ci provi
nemmeno a far prevalere ragione e coscienza , sennò ti mettono nel tritacarne.
Qualche giudice
di sorveglianza onesto e coraggioso ha provato qualche volta a ragionare, gli
hanno dato del mafioso. Poche ore dopo la morte del ragazzo a Frosinone c’è
stato un altro suicidio. Nel carcere di Arienzo, provincia di Caserta. Un uomo
di cinquantanni. Credo che sia addirittura il suicidio numero 47 dall’inizio
dell’anno. E noi lo sappiamo solo grazie al lavoro di vigilanza del Garante dei
detenuti e di Antigone. Altrimenti il silenzio sarebbe assoluto.
LEGGI ANCHE
Sossio si è tolto
la vita in cella ad Arienzo, è il 46esimo: “Il carcere è un luogo senza senso,
bisogna riflettere”
La strage
ignorata delle carceri, 44 suicidi da inizio anno
“Amore mio mi
spiace ma ho paura di tutto”, il biglietto di una detenuta suicida in carcere
Nessuno se ne
frega delle carceri, e intanto c’è un suicidio ogni 5 giorni e 25mila sono in
cella senza processo
47 morti suicidi,
più o meno è il numero delle esecuzioni capitali in un anno in tutti gli Stati
Uniti. Chiamatele pure carceri, se volete, prigioni, reclusori. Sono bracci
della morte, sono patiboli. Il carcere così non ha nessun senso. È solo uno
strumento di vendetta, per dare un po’ di gusto ai “buoni”, alle persone legali,
per soddisfare i forcaioli, per mettere al sicuro le pulsioni repressive dei
partiti. Ma la civiltà? Il diritto? Si faccia fottere la civiltà. Specie sotto
elezioni. Ora bisogna raccogliere voti, non scherziamo, mica si raccolgono voti
coi principi di civiltà. Lasciate che si suicidino, che poi se lo fanno ne
avranno qualche ragione, no?
Piero Sansonetti.
Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di
cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004
al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per
poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre
2019.
Due psicologi per oltre
2mila detenuti, dietro le sbarre addio umanità.
Viviana Lanza su Il Riformista
il 10 Agosto 2022
Cinque psicologi sulla carta,
due quelli in servizio (che talvolta si alternano). Diciannove educatori sulla
carta, nove quelli effettivamente presenti. Facciamo questi due esempi per
indicare la voragine negli organici, e di conseguenza nella gestione, del
sistema penitenziario. Sono esempi che fotografano la situazione nel carcere di
Poggioreale denunciata dal garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello.
Due psicologi in un carcere che conta più di duemila reclusi. «Come fanno a
incontrare i detenuti? È umanamente impossibile», osserva il garante
sottolineando la grande sproporzione tra popolazione detenuta e personale dedito
all’assistenza e alla guida dei detenuti. «Chi deve assumere queste figure
professionali? Perché non lo fa? – aggiunge Ciambriello, sollevando spunti di
riflessione – . Vi sembra normale che in un carcere con duemila detenuti ci
siano solo due psicologi e nove educatori? Con chi parlano i detenuti?»,
conclude evidenziando che l’unica presenza in carcere è quella dell’agente di
turno nei vari padiglioni. Un agente che si ritrova a fare, a seconda delle
esigenze del momento, il medico, lo psicologo, il cappellano, il mediatore
culturale. E facendolo male ovviamente, perché non ne ha la formazione, senza
colmare i vuoti che ci sono all’interno del sistema penitenziario e che con il
tempo si acuiscono fino a diventare voragini. Il sistema carcere frana sotto
l’indifferenza della politica, il populismo giustizialista degli ultimi decenni,
sotto i mancati interventi, le carenze e le disfunzioni, i ritardi e il mancato
tempismo, l’assenza di progetti e più spesso di iniziative. Questo continua a
essere il carcere che punisce più severamente i “poveri cristi”, il carcere
della condanna preventiva, il carcere dove finiscono i presunti innocenti in
attesa di processi che durano anni, il carcere dove rinchiudere gran parte di
quelli di cui la società non riesce ad occuparsi, quelli di cui non riesce ad
averne cura o che non riesce ad assistere (tossicodipendenti, senza fissa
dimora, extracomunitari, giovani delle periferie degradate, affiliati di
camorra, malati psichici). Ad oggi in Campania ci sono 6.660 detenuti, 2.168 dei
quali sono reclusi a Poggioreale. Su questa popolazione detenuta una percentuale
tutt’altro che rivelante (1,122 reclusi) riguarda i detenuti in attesa di
giudizio, il popolo dei sospesi alle lungaggini processuali. Quasi tutti sono
lasciati soli nelle celle, senza aiuti ma nemmeno senza alcuna finalità
rieducativa della pena. Colpa di croniche carenze, di problemi mai risolti:
basti pensare che nelle varie carceri della Campania ci vorrebbero 105 educatori
ma ce ne sono solo 70, mancano medici di reparto, mancano figure sociali,
mancano psicologi.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Carcere, 44 suicidi: senza psicologi e
psichiatri prevenzione impossibile. Un altro recluso
si è tolto la vita dopo sei tentativi in tre mesi e mezzo: negli ultimi 4 giorni
è il quarto. C’è un’assenza cronica di psicoterapeuti. Antigone: in media uno
psichiatra per 10 ore settimanali ogni 100 reclusi. Damiano Aliprandi su Il
Dubbio il 5 agosto 2022.
Troppi suicidi, il sovraffollamento persiste ma a
incidere è anche la grave assenza nei penitenziari di un supporto per la salute
mentale. E ciò è un vero handicap per la prevenzione di questi eventi tragici
che quest’anno sono in una crescita esponenziale. L’ultimo suicidio, il quarto
negli ultimi 4 giorni, riguarda un detenuto di Ascoli Piceno. Siamo così
arrivati a 44 reclusi che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno. Il
garante nazionale delle persone private della libertà ne ha dato notizia,
rilevando che l’uomo aveva tentato il suicidio almeno sei volte in tre mesi e
mezzo. Ogni storia è a sé ed è sbagliato ricondurre questi eventi tragici al
solo problema di salute mentale, ma c’è un dato che non va sottovalutato ed è
sempre Antigone, tramite il rapporto di metà anno, a farlo emergere: in alcune
carceri dove è risultato un alto tasso di suicidi, risulta carcere l’assistenza
psichiatrica.7
Il triste primato: tre casi a Foggia Regina Coeli
e San Vittore
Tenendo a mente la sistematicità del problema,
Antigone ha dato un breve sguardo agli istituti dove sono avvenuti più suicidi
dall’inizio dell’anno. Con tre casi ognuno, al primo posto si collocano le Casa
Circondariali di Roma Regina Coeli, Foggia e Milano San Vittore. Seguono con due
casi la Casa di Reclusione di Palermo Ucciardone, la Casa Circondariale di
Monza, la Casa Circondariale Genova Marassi e la Casa Circondariale di Pavia. In
questo istituto nel 2021 si erano tolte la vita altre tre persone in poco più di
30 giorni. Con due decessi avvenuti tra il mese di giugno e luglio, si arrivano
così a contare cinque casi di suicidi nel carcere di Pavia in soli nove mesi.
Senza voler ricondurre un fenomeno così complesso
alle carenze del singolo istituto, Antigone può però osservare come soprattutto
le cinque Case Circondariali siano tutti istituti con situazioni piuttosto
complesse. Tutte soffrono da anni di una situazione cronica di sovraffollamento,
che nel caso di Foggia, Regina Coeli e Monza si aggira addirittura intorno al
150% della loro capienza. A San Vittore, Pavia e Regina Coeli più della metà
della popolazione detenuta è di origine straniera. A Monza in particolar modo vi
è un’elevata presenza di detenuti affetti da patologie psichiatriche e il 50%
della popolazione è tossicodipendente. A Foggia vi è un educatore ogni 190
detenuti. Dai dati raccolti dall’Osservatorio, emerge poi come tranne a Pavia
negli altri cinque istituti via sia una carenza, più o meno elevata, di
specialisti psichiatri e psicologi rispetto alla media nazionale.
Partendo da questo dato, Antigone sviscera la
questione della cura mentale in carcere e l’assenza cronica di supporto. Sia nel
2021 che nel 2022, la media si attesta intorno alle 10 ore settimanali ogni 100
detenuti per gli psichiatri e intorno alle 20 ore settimanali ogni 100 detenuti
per gli psicologi. Gli ultimi dati disponibili mostrano che Palermo Ucciardone,
Monza e Foggia hanno una presenza molto inferiore rispetto alla media sia di
psichiatri che di psicologi (Palermo: 5,14 ore psichiatri, 5,14 ore psicologi;
Monza: psichiatri 6,4, psicologi 6,6; Foggia: psichiatri 3,4; psicologi 10).
Regina Coeli ha una presenza molto inferiore alla media di psicologi (6,8 ore).
San Vittore ha una presenza inferiore alla media per quanto riguarda gli
psichiatri (8,4 ore). A Pavia la presenza di psichiatri è di 10,24 ore
settimanali ogni 100 detenuti, mentre degli psicologi di 35,84 ore.
Tante le storie tragiche raccolte nel rapporto di
Antigone
Antigone, nel suo recente rapporto, narra alcune
storie tragiche di detenuti suicidi che avevano forme di disagio psichico. Dalle
storie di queste persone emerge come vi fossero alcune situazioni di probabili
disagi psichici. Su un giovane ragazzo di 25 anni morto all’Ucciardone era stata
effettuata, proprio per presunto rischio suicidario, una perizia psichiatrica
che non aveva però portato a nulla.
A un uomo di 54 anni in custodia cautelare a Terni
era stata da poco rigettata la richiesta di scarcerazione, presentata a causa di
una forte depressione. Un uomo di 36 anni, detenuto da poco nel carcere di
Foggia e a solo due mesi dal fine pena, pare soffrisse di problematiche
psichiatriche. L’uomo di 70 anni si trovava invece da poche ore nel carcere di
Genova in stato di fermo come detenuto con disagio psichico. Era stato arrestato
in stato di shock e aveva già tentato di togliersi la vita pochi mesi prima.
Oltre a queste storie, se ne aggiungono altre di particolare gravità,
riguardanti persone con problematiche psichiatriche note e diagnosticate.
Un 21enne in carcere per il furto di un cellulare
ha atteso 8 mesi il trasferimento in una Rems
Tra queste, Antigone rivela quella di G.T., un
giovane ragazzo di 21 anni che secondo il Tribunale di Milano in carcere non
doveva stare. Detenuto a San Vittore dall’agosto del 2021 per il furto di un
cellulare, nel mese di ottobre il giudice aveva disposto il suo trasferimento in
Rems (Residenza per le misure di sicurezza) in quanto una perizia psichiatrica
dimostrava la sua incompatibilità con il regime carcerario, a causa di un
disturbo borderline della personalità. Nella notte del 31 maggio, a otto mesi da
quella pronuncia, G. T. si è tolto la vita. Nelle settimane precedenti ci aveva
già provato altre due volte. Pochi giorni prima, il 26 maggio, in una cella
dello stesso reparto di San Vittore, si era suicidato un altro giovane ragazzo.
Si chiamava Abou El Maati, aveva 24 anni, era un cittadino italiano di origine
egiziana.
Altra storia tragica riportata da Antigone è
quella di G.P., un uomo di 30 anni con problemi psichiatrici toltosi la vita il
28 giugno nel carcere di Bari, dove si trovava da appena due giorni. Dopo il suo
arresto era stato condotto nella ex sezione femminile dell’istituto, inagibile
da anni e adibita a inizio pandemia a luogo per svolgere i periodi di
isolamento. Da tempo la sezione era però utilizzata di fatto come reparto per
detenuti con patologie psichiatriche, nonostante non fosse in alcun modo adatta
a tale funzione per carenze di spazi e di personale.
Antigone riporta infine la storia di una donna, di
cui il nome ad oggi è però sconosciuto. Si sa solo che era di origine romena,
aveva 36 anni ed era detenuta da poco tempo all’interno dell’Articolazione per
la tutela della salute mentale (ATSM) del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto,
in provincia di Messina. Nel pomeriggio del 10 aprile è stata ritrovata senza
vita nel cortile dell’ex Ospedale psichiatrico giudiziario, al termine dell’ora
d’aria.
La salute mentale resta il capitolo più
problematico
Nell’ambito della questione delle condizioni di
salute della popolazione detenuta, quello della salute mentale rimane il
capitolo più significativo nei numeri e più problematico nelle risposte date
dalle aziende sanitarie e dall’amministrazione penitenziaria. I numeri anzitutto
continuano a fotografare il carcere come “psico-patogeno” dove il disagio
psichico, diagnosticato e non, è diffuso, capillare e omogeneo sul territorio
nazionale. I “disturbi psichici” rappresentano la metà delle patologie rilevate
nella popolazione detenuta. Per avere un’idea della consistenza di questo dato,
basti pensare che gli altri due gruppi di patologie più diagnosticate in
carcere, che sono quelle del sistema cardiocircolatorio e delle malattie
endocrine, del metabolismo e immunitarie, sono entrambi al 15% del totale delle
patologie rilevate. Dunque il disturbo psichico è di gran lunga la prima
categoria diagnostica nelle carceri italiane. Antigone, raccogliendo i dati
direttamente dagli operatori sanitari delle singole carceri visitate nell’ultimo
anno, ha rilevato che il 13% del totale della popolazione detenuta ha una
diagnosi psichiatrica grave, in numeri assoluti significa oltre 7 mila persone.
Solo per una piccola parte, dalla diagnosi è seguita una misura di tipo
giudiziario. Una rilevazione statistica relativa alla sola Toscana presenta
numeri ancora più significativi, sottolineando come su 1.744 persone sottoposte
a visita medica in un anno, 610 avessero almeno un disturbo psichiatrico, pari
al 34,5% delle persone sottoposte a controllo medico.
La strage senza fine. Sossio si è tolto
la vita in cella ad Arienzo, è il 46esimo: “Il carcere è un luogo senza senso,
bisogna riflettere”. Rossella Grasso su Il Riformista
il 5 Agosto 2022.
Sossio, 50 anni, di Frattamaggiore, ha deciso di
togliersi la vita impiccandosi. Lo ha fatto mentre era in carcere ad Arienzo, in
una notte di mezza estate, solo nella sua cella. La sua morte si aggiunge
a quella di altri 44 detenuti che dall’inizio del 2022 hanno deciso di togliersi
la vita. Una vera strage che sta avvenendo dietro le sbarre: in soli sette mesi
sono già 46 le persone che hanno deciso di farla finita nelle carceri italiane.
E potrebbero essere ancora di più se si contano anche le morti in carcere su cui
sono ancora in corso le indagini. Ancora un suicidio in queste calde carceri
italiane. In mattinata si è tolto la vita un giovane di 26 anni recluso
nell’istituto penitenziario di Frosinone. Lo riferisce l’associazione Antigone
che ricorda come quello di oggi sia il quarantaseiesimo suicidio in carcere
dall’inizio dell’anno. Il ragazzo era in attesa di essere trasferito nel carcere
romano di Rebibbia.
La morte di Sossio è avvolta nel mistero. A darne
notizia è Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Campania. “È il terzo
suicidio in Campania dall’inizio dell’anno, in Italia si è arrivati a 46 – ha
detto il garante dei detenuti della Campania – Ci potremmo domandare il perchè
il detenuto Sossio di 50 anni ha deciso di togliersi la vita in un carcere
piccolo di dimensioni, in una cella singola. Qui era arrivato il 9 luglio da
Poggioreale. Ci potremmo fermare alle responsabilità di singoli o responsabilità
collettive, ma occorre andare oltre. Il carcere, luogo senza senso e a volte
senza elementi relazionali per riprendersi la vita, subisce i rumori populisti
delle persone e il populismo politico, alla rincorsa del consenso. E se ci
aggiungiamo che non sono evidenti nemmeno i timidissimi provvedimenti deflattivi
disposti dal Governo, allora la frittata è fatta”.
Un suicidio avvolto nel mistero perché il carcere
di Arienzo è più piccolo, meno affollato e lì ci sono tante attività. “Sossio
doveva scontare un reato piccolo, su di lui c’era attenzione. Ma forse la sua
fragilità ha prevalso”. La salma, posta sotto sequestro, su disposizione
dell’autorità giudiziaria è stata oggi trasportata all’obitorio dell’ospedale di
Caserta, dove lunedì prossimo avverrà l’autopsia. In Italia, dall’inizio
dell’anno ad oggi, sono 79 i decessi all’interno delle carceri; 8 di questi sono
avvenuti in Campania e per due di questi la magistratura ha aperto un’inchiesta
per accertarne le cause. “Non sappiamo cosa sia successo e perchè Sossio abbia
deciso di togliersi la vita – dice Emanuela Belcuore, garante dei detenuti di
Caserta – Potrebbe aver avuto dei problemi personali. Poi il caldo toglie
l’aria. Certo è che d’estate i suicidi in carcere aumentano”.
Conclude così il Garante Ciambriello: “Proprio ad
Arienzo, insieme al Garante della provincia di Caserta, Emanuela Belcuore,
abbiamo potuto apprezzare buone prassi trattamentali sia all’interno
dell’Istituto che all’esterno, attraverso la possibilità di lavoro per i
detenuti. Noi Garanti volgiamo la nostra azione non solo per denunziare quello
che non va, le compressioni dei diritti e delle garanzie dei detenuti, ma
incoraggiamo e a volte promuoviamo azioni di prevenzione, progetti di
solidarietà, di inclusione sociale per una pena costituzionalmente orientata. e
per un carcere dove tutti i presenti, compresa la polizia penitenziaria, le
direzioni, gli operatori socio-sanitari e i volontari si sentano uniti da un
patto di responsabilità. Intanto si continua a morire di carcere e in carcere”.
Rossella Grasso. Giornalista professionista e
videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali
occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di
Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha
collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di
stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana,
si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo
Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al
Napoli Film Festival.
Carcere: 24 suicidi da inizio anno,
l’ultimo a Foggia. Negli ultimi due anni il tasso di
suicidi è in crescita. Le proposte di Antigone per controllare il fenomeno.
Damiano Aliprandi su Il Dubbio il 15 maggio 2022.
Secondo la redazione di Ristretti Orizzonti, siamo
a 23 suicidi in carcere dall’inizio dell’anno. Ma arriviamo a 24 con l’ultimo
suicidio avvenuto al carcere di Foggia. Si tratta del secondo, nell’istituto
stesso, nel giro di due settimane. Il detenuto avrebbe finito di scontare la
pena nel 2027. Secondo il documento sulla prevenzione del suicidio in carcere
realizzato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il suicidio è spesso una
delle cause più comuni di morte in carcere.
Il rapporto Antigone
Per capire meglio la dimensione del problema,
ancora una volta bisogna ricorrere al XVIII rapporto di Antigone che parte dai
dati dell’anno scorso. Seppur in leggero calo rispetto all’anno precedente,
nel 2021 il numero di suicidi in carcere rimane molto alto. Secondo i dati
pubblicati dal Dap, sono state 57 le persone detenute ad essersi tolte la
vita. Se questo numero viene messo in relazione con le persone mediamente
presenti negli istituti di pena nel corso dell’anno otteniamo il tasso di
suicidi, ossia il principale indicatore per analizzare l’ampiezza del fenomeno.
Nel 2021, a fronte di una presenza media di 53.758 detenuti, tale tasso si
attesta a 10,6 casi di suicidi ogni 10.000 persone detenute. Guardando
all’andamento del dato nell’ultimo decennio, Antigone osserva come nei due anni
passati il tasso di suicidi in carcere sia particolarmente alto. Purtroppo tale
crescita sembra confermarsi anche nel 2022, essendo, come riportato, già
numerosi i casi di suicidi avvenuti nei primi mesi dell’anno.
Secondo i dati del Dap, nel 2021 sono decedute 148
persone detenute. Come visto, 57 sono le persone che si sono tolte la vita
mentre le restanti 91 sono generalmente indicate come morti avvenute per cause
naturali. I casi di suicidi sono pertanto pari al 38,5% dei decessi
totali. L’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) ha reso noto come i
detenuti – se considerati come gruppo – abbiano tassi di suicidio più elevati
rispetto alla comunità in quanto non solo all’interno degli istituti di pena vi
è un numero maggiore di comportamenti suicidari, ma gli individui che subiscono
il regime di detenzione presentano frequenti pensieri e comportamenti suicidari
durante tutto il corso della loro vita.
Antigone osserva che le ragioni per cui in carcere
i suicidi sono molto più frequenti, sono probabilmente dovute alla più densa
presenza di gruppi vulnerabili, di persone in condizioni di marginalità, di
isolamento sociale e di dipendenza. Oltre a fattori personali, numerosi possono
essere gli elementi esterni che contribuiscono ad acuire situazioni di pregressa
sofferenza soprattutto in un ambiente complesso come quello carcerario. Per
questo motivo, tra le proposte di riforma del regolamento penitenziario
presentate a dicembre 2021, Antigone sostiene la necessità di dedicare maggiore
attenzione ad alcuni aspetti della vita penitenziaria, affinché il rischio
suicidario possa essere controllato e ridimensionato.
A tal fine, come propone Antigone, il regolamento
dovrebbe prevedere in primis una maggiore apertura nei rapporti con l’esterno,
tramite la possibilità di svolgere più colloqui e soprattutto più telefonate e
in qualsiasi momento. Grande attenzione va posta al momento dell’ingresso e
dell’uscita dal carcere, entrambe fasi particolarmente delicate e durante le
quali avvengono numerosi casi di suicidi. L’introduzione alla vita dell’istituto
deve avvenire in maniera lenta e graduale, affinché la persona abbia la
possibilità di ambientarsi. Maggiore attenzione andrebbe prevista anche per la
fase di preparazione al rilascio a fine pena, facendo in modo che la persona
venga accompagnata al rientro in società. Oltre alle fasi iniziali e conclusive
dei periodi di detenzione, particolare attenzione andrebbe dedicata a tutti quei
momenti della vita penitenziaria in cui le persone detenute e internate si
trovano separate dal resto della popolazione detenuta perché in isolamento o
sottoposti a un regime più rigido e con meno contatti con altre persone.
Ai sucidi, si aggiungono i casi di autolesionismo:
costituiscono un importante elemento per raccontare il clima all’interno di un
istituto penitenziario, oltre che le caratteristiche della sua popolazione
detenuta e delle risorse disponibili. Dalle informazioni raccolte tramite le
visite effettuate da Antigone nel corso del 2021, emerge una media di 19,9 casi
di autolesionismo registrati in un anno ogni 100 persone detenute.
Il report
annuale dell’associazione Antigone. Inferno carcere, in cella si muore 13 volte
più che fuori.
Viviana Lanza su
Il Riformista l'1 Maggio 2022.
«A Carinola, nel
reparto destinato ai protetti, manca qualsivoglia divisorio tra il water, il
lavabo e il letto», si legge nella relazione annuale dell’associazione
Antigone sullo stato delle carceri. Sembra un dettaglio, invece non lo è. Dà la
misura di cosa sia realmente il carcere e di quanto i bisogni elementari e i
diritti fondamentali siano ancora mortificati e non tutelati. Pensate a cosa
voglia dire dividere con degli sconosciuti una cella in cui non è possibile
avere un minimo di privacy nemmeno quando si va in bagno. Immaginate la
mortificazione della dignità quando si è costretti a mangiare e dormire nello
stesso luogo in cui c’è water o toilette alla turca, quindi a vista. Come si può
uscire migliori da posti del genere? Come si può parlare
di rieducazione e rispetto della Costituzione?
«Per quanto
appaia incredibile e anacronistico – si legge nel rapporto di Antigone sulla
situazione all’interno degli istituti di pena di tutta Italia – nel 5% degli
istituti visitati ci sono ancora celle in cui il wc non è in un ambiente
separato, isolato da una porta ma in un angolo della cella». Eppure basterebbe
poco per ripristinare un minimo, ma veramente un minimo di dignità. Basterebbe
una porta. Invece, ci sono solo sbarre e poco altro. In Campania nello scorso
anno si sono contati sei suicidi in cella su 57 a livello nazionale. Guardando
all’andamento del dato nell’ultimo decennio, Antigone osserva come nei due anni
appena trascorsi il tasso dei suicidi in carcere sia particolarmente alto. E la
crescita sembra confermarsi anche nel 2022.
L’età media delle
persone che si sono tolte la vita in carcere nel 2021 è stata di 42 anni. I più
giovani erano due ragazzi di 24 e 25 anni, morti entrambi nel maggio 2021, uno
nel carcere di Novara e l’altro nel carcere di Poggioreale a Napoli. Dopo
l’istituto penitenziario di Pavia c’è quello di Avellino tra le carceri in cui
sono avvenuti più casi di suicidio, tanto per tenere la lente puntata sulla
situazione in Campania. L’Organizzazione mondiale della sanità ha accertato che
il suicidio è una delle cause più comuni di morte all’interno delle carceri.
Secondo statistiche recenti, i casi di suicidio nella popolazione detenuta sono
di oltre 13 volte superiori a quelli registrati nella popolazione libera.
Accanto a fattori personali, le cause sono da ricercarsi nel fatto che in
carcere è più densa la presenza di gruppi vulnerabili, di persone in condizioni
di marginalità, di isolamento sociale e di dipendenza. «Per questo motivo – si
legge nel report – tra le proposte di riforma del regolamento penitenziario
presentate a dicembre 2021, Antigone sostiene la necessità di dedicare maggiore
attenzione ad alcuni aspetti della vita penitenziaria».
Una proposta
riguarda la necessità di dare più attenzione al momento dell’ingresso e
dell’uscita dal carcere, entrambe fasi particolarmente delicate e durante le
quali avvengono numerosi casi di suicidi. «L’introduzione alla vita
dell’istituto deve avvenire in maniera lenta e graduale – si spiega nel report –
affinché la persona abbia la possibilità di ambientarsi. Maggiore attenzione
andrebbe prevista anche per la fase di preparazione al rilascio a fine pena,
facendo in modo che la persona venga accompagnata al rientro in società». Un
altro aspetto da potenziare è quello relativo alle attività che i detenuti
possono svolgere in carcere. La rieducazione non può essere privilegio di pochi,
la formazione e il lavoro dovrebbero essere percorsi più diffusamente
accessibili. In Italia il panorama è variegato: ci sono alcune situazioni
virtuose dove i detenuti svolgono tutti un’attività lavorativa alle dipendenze
dell’amministrazione penitenziaria o di datori di lavori privati, e poi ci sono
istituti in cui le poche attività lavorative presenti sono quelle domestiche,
pulizie, cucina, spesa alle dipendenze dell’amministrazione. A Poggioreale, per
esempio, lavorano solo 280 detenuti sui 2.190 presenti.
Viviana Lanza.
Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è
giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed
economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del
quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il
Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
ESCLUSIVO: LO SCANDALO DI
MODENA. Scandalo al carcere di Modena: «Detenuti pestati a sangue».
NELLO TROCCHIA su
Il Domani il 16 agosto 2022.
«Quel giorno i detenuti sono
stati picchiati, chi di noi non voleva partecipare restava fuori dal casermone»,
rileva un agente della polizia penitenziaria parlando del più grande scandalo
della storia carceraria italiana.
Sequestri di persona,
violenze, saccheggi e nove morti. Questo è successo nel carcere di Modena, l'8
marzo 2020.
Considerando il numero di
detenuti che hanno perso la vita, la distruzione del carcere, le botte nel
casermone, denunciate dai reclusi e non solo, si tratta di una pagina nera della
nostra repubblica, la più grave avvenuta dietro le sbarre.
Carcere Modena, nove morti,
incendi e violenze. Ma è giallo sui video segreti.
NELLO TROCCHIA su Il Domani il
17 agosto 2022
I fatti accaduti l’8 marzo,
nel carcere Sant’Anna di Modena, sono episodi che trasformano quella giornata
nella più buia della storia penitenziaria della repubblica italiana.
Un carcere in fumo, detenuti
liberi di distruggere l’istituto, di strafarsi, in nove muoiono per overdose
mentre altri si premurano, sollecitati dal vertice del carcere, di liberare il
personale imprigionato.
E lo stato? Le istituzioni? Il
ministero? Ci sono due questioni. La prima riguarda le violenze denunciate che
sarebbero avvenute nel casermone prima dei trasferimenti dei detenuti in altri
istituti. La seconda questione riguarda il ministero e il dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria. La relazione è stata pubblicata oggi dopo la
prima inchiesta di Domani sul caso Modena.
NELLO TROCCHIA. È inviato di
Domani, autore dello scoop sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua
Vetere. Ha firmato inchieste e copertine per “il Fatto Quotidiano” e
“l’Espresso”. Ha lavorato in tv realizzando inchieste e reportage per Rai 2
(Nemo) e La7 (Piazzapulita). Ha scritto qualche libro, tra gli
altri, Federalismo Criminale (2009); La Peste (con Tommaso Sodano,
2010); Casamonica (2019) dal quale ha tratto un documentario per Nove e Il
coraggio delle cicatrici (con Maria Luisa Iavarone). Ha ricevuto il premio Paolo
Borsellino, il premio Articolo21 per la libertà di informazione, il premio
Giancarlo Siani. È un giornalista perché, da ragazzo, vide un documentario su
Giancarlo Siani, cronista campano ucciso dalla camorra, e decise di fare questo
mestiere. Ha due amori, la famiglia e il Napoli.
Pestaggi nel carcere di
Modena, il sindacato degli agenti replica a Domani.
Il Domani il 17 agosto 2022
Se chi ha rivelato le violenze
non denuncia agli organi competenti «non solo non è credibile, ma rischia di
commettere molteplici reati» dice il segretario della Uilpa polizia
penitenziaria sull’anonimo agente che ha raccontato a Domani l’episodio
«Chi ha notizie in merito a
quanto successo nel carcere di Modena, tanto più se agente o ufficiale di
polizia giudiziaria, dunque con specifico obbligo di farlo, riferisca
immediatamente agli inquirenti. Altrimenti, non solo non è credibile, ma
rischia di commettere molteplici reati». Lo ha detto oggi Gennarino De
Fazio, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria a proposito dell’inchiesta
sui pestaggi nel carcere di Modena pubblicata oggi e firmata da Nello Trocchia.
Nell'articolo, un agente
anonimo aveva dichiarato: «Quel giorno i detenuti sono stati picchiati, chi di
noi non voleva partecipare restava fuori dal casermone. I miei colleghi hanno
percosso uomini già resi precedentemente inoffensivi». Si tratterebbe di
un episodio simile a quello avvenuto negli stessi giorni nel carcere di Santa
Maria Capua Vetere e ripreso dalle telecamere di sicurezza.
Ma il leader del sindacato De
Fazio ritiene che queste testimonianze non siano sufficienti. «Pensiamo che ci
si debba affidare alle responsabilita' e alla perizia degli organi inquirenti e
di quelli che eventualmente saranno chiamati a giudicare e non trarre
conclusioni affrettate e alimentate da dichiarazioni estemporanee, tutte da
verificare».
«Così noi detenuti abbiamo
salvato medici e poliziotti».
NELLO TROCCHIA su Il Domani il
18 agosto 2022
L'8 marzo 2020, a Modena,
viene scritta la pagina più buia, per morti e saccheggio, nella storia
penitenziaria dell'Italia repubblicana. Ma c'è una data che precede quel giorno
di lutti, incendi e violenze, un giorno che segna un passaggio chiave in questa
storia, finora ignorato.
Ma alla situazione
emergenziale si arriva con un istituto di pena senza guida e questo è il punto
decisivo. La nuova direzione non è stabile, la direttrice, Maria Martone,
deve dividersi tra due istituti e, a Modena, si reca due volta a settimana.
La testimonianza choc dei
carcerati: «Gli agenti da fuori ci hanno chiesto di aiutare anche le
detenute». Il caos della prigione e le scelte del Dap: la storica direttrice era
stata rimossa due mesi prima degli scontri
NELLO TROCCHIA. È inviato di
Domani, autore dello scoop sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua
Vetere. Ha firmato inchieste e copertine per “il Fatto Quotidiano” e
“l’Espresso”. Ha lavorato in tv realizzando inchieste e reportage per Rai 2
(Nemo) e La7 (Piazzapulita). Ha scritto qualche libro, tra gli
altri, Federalismo Criminale (2009); La Peste (con Tommaso Sodano,
2010); Casamonica (2019) dal quale ha tratto un documentario per Nove e Il
coraggio delle cicatrici (con Maria Luisa Iavarone). Ha ricevuto il premio Paolo
Borsellino, il premio Articolo21 per la libertà di informazione, il premio
Giancarlo Siani. È un giornalista perché, da ragazzo, vide un documentario su
Giancarlo Siani, cronista campano ucciso dalla camorra, e decise di fare questo
mestiere. Ha due amori, la famiglia e il Napoli.
Quelle rivolte nelle
carceri ridotte a uno stereotipo.
Luigi Manconi su La Repubblica
il 30 Agosto 2022.
Libertà/illibertà del 30
agosto 2022
Era il marzo del 2020 e, a
seguito delle intollerabili condizioni di vita nelle carceri italiane,
esasperate dalla diffusione del covid, in numerosi istituti penitenziari vi
furono forme di protesta che vennero immediatamente classificate come “rivolte”.
In effetti, in più di un caso vi furono violenze e distruzioni e i detenuti si
appropriarono di sostanze stupefacenti custodite (malamente, come è evidente)
nelle infermerie.
Azioni profondamente sbagliate
e pericolose che portarono, in alcuni casi, a una repressione indiscriminata e
feroce. La «orribile mattanza» (la definizione è del gip Sergio Enea) nel
carcere di Santa Maria Capua Vetere non fu, certo, un episodio isolato.
Ma qui non importa tanto
evidenziare le molte responsabilità del corpo della polizia penitenziaria
nell’imporre un ordine fondato sulla violenza e talvolta sull’esercizio della
tortura. Mi interessa sottolineare altro. Il fatto, cioè, che secondo uno schema
ricorrente quelle proteste verificatisi in una ventina di istituti furono
attribuite pressoché unanimemente a una “strategia occulta” e a un “disegno
premeditato”.
I detenuti avrebbero eseguito
gli ordini e applicato le direttive provenienti dalla criminalità organizzata e,
specificatamente, dalla Camorra. Presentare una simile versione dei fatti
rispondeva, non solo al riflesso condizionato della cospirazione come chiave
interpretativa dei fatti del mondo, ma anche ad alcune finalità immediate: a)
dimostrare che le carceri italiane sarebbero totalmente fuori controllo e che,
in esse, dominerebbero le diverse fazioni del crimine organizzato; b) screditare
le ragioni dei detenuti e occultare le cause, spesso motivatissime, delle loro
proteste; c) legittimare la repressione nei confronti dei contestatori che,
assimilati tutti al grande crimine, meritavano la più severa delle punizioni.
Ulteriore obiettivo di questa opera di disinformazione, quello di presentare le
grandi organizzazioni criminali come potenze capaci di condizionare in
profondità la vita degli italiani.
Di conseguenza, quello delle
“rivolte organizzate dalla Camorra” è diventato in un batter d’occhio uno
stereotipo generalizzato. Dopodiché, qualche giorno fa è stata resa nota la
relazione finale della commissione ispettiva del Ministero della Giustizia
costituita dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nel luglio del
2021, che ha analizzato attentamente i fatti accaduti in quel marzo di due anni
fa.
La ricostruzione è dettagliata
e puntuale ed è uno strumento utile per l’osservazione del sistema penitenziario
italiano: e costituisce la possibile premessa di una politica di prevenzione. Ma
c’è un passaggio che va immediatamente evidenziato. È laddove si legge che
l’attribuzione della responsabilità delle rivolte alla mafia sarebbe stata
motivata dal fatto che «la sospensione dei colloqui in presenza avrebbe
danneggiato la catena di comunicazioni tra penitenziario e mondo esterno
compromettendo gli interessi del crimine organizzato»; e dal fatto che «la
contemporaneità degli eventi e le comuni modalità organizzative delle sommosse
avrebbero deposto per una 'strategia occulta orchestrata a tavolino'».
Bene, secondo la relazione
della commissione ispettiva non si è rilevato nulla di tutto ciò e non è stata
riscontrata in alcun modo la minima traccia di una regia della «criminalità
organizzata e nemmeno una matrice politica anarchica o insurrezionalista».
E si aggiunge che, a
determinare le proteste, sarebbero stati la «paura della pandemia, il rifiuto
delle misure limitative della socialità e, tranne la rivolta di Salerno, lo
spirito di emulazione delle altre rivolte alimentato dall'aspettativa dei
benefici penitenziari».
Tuttavia, la relazione non
nasconde il «sospetto che detenuti, loro familiari e gruppi antagonisti abbiano
concordato il momento in cui dare l’avvio alle rispettive manifestazioni di
protesta dentro e fuori le strutture penitenziarie».
Questo è il massimo di
“complotto” che la commissione del Ministero della Giustizia è riuscita a
individuare. Come si vede, è il ribaltamento totale di una interpretazione
fondata tutta su una concezione dei detenuti quali strumenti passivi nelle mani
del crimine organizzato e funzionali ai disegni di quest’ultimo. In sintesi, è
quanto scrive Gaia Tessitore sul sito di informazione napolimonitor.it,
«l’impossibilità di mettere in relazione la risposta scomposta e violenta degli
agenti di polizia penitenziaria con la presunta esistenza di un piano
preordinato palesa la preoccupante incapacità dell’amministrazione di una
lettura efficace della realtà e dei fenomeni che si sviluppano dentro e intorno
al carcere». Un giudizio molto severo, ma che troppe vicende tendono a
confermare.
I veleni nel carcere di
Modena, le due agenti e la denuncia contro il comandante (che nega tutto).
NELLO
TROCCHIA su Il Domani il 19 agosto 2022
Dopo l’8 marzo 2020, dopo i
nove morti per overdose mentre i detenuti erano sotto la tutela dello stato,
dopo la distruzione del carcere, l’abbandono, la trattativa con i reclusi, il
ministero non ha assunto provvedimenti. Il comandante della polizia
penitenziaria del carcere Sant’Anna è rimasto al suo posto.
Mauro Pellegrino, per molti
agenti, ha affrontato con professionalità quella situazione e nessuno avrebbe
potuto fare meglio di fronte alla rivolta violenta scatenatasi in carcere.
Le relazioni di Mauro
Pellegrino sostanziano il lavoro della procura. I magistrati hanno aperto tre
fascicoli, chiesto e ottenuto l’archiviazione per i nove morti, mentre indagano,
da oltre due anni, sul saccheggio e sulle torture in due fascicoli separati. Ma
proprio dall’8 marzo nel carcere di Modena i veleni si sommano alla conta dei
danni. Veleni che riempiono pile di carte che Domani ha letto.
Violenze nel carcere di
Modena, un sindacalista tra gli agenti indagati per tortura (tutti in servizio).
NELLO
TROCCHIA su Il Domani il 09 giugno 2022
La procura di Modena ha
iscritto nel registro degli indagati cinque agenti della polizia
penitenziaria che rispondono dei reati di tortura e lesioni aggravate per i
fatti accaduti nel carcere di Modena, il giorno 8 marzo 2020.
Domani ha letto la richiesta
di proroga del termine per le indagini preliminari, presentata dalla locale
procura e firmata dal procuratore Luca Masini e dalla magistrata Lucia De
Santis.
Tra gli indagati c’è anche un
sindacalista. Sono sette, invece, le persone offese, destinatarie delle presunte
violenze e che hanno presentato l’esposto dal quale si è originata l’indagine.
Rivolta e botte: l’inferno
nel carcere di Modena tra morti e saccheggi.
NELLO TROCCHIA su Il Domani il
17 maggio 2022
A Modena la procura indaga su
quattro agenti della polizia penitenziaria per lesioni e tortura. Il fascicolo
di Modena si incrocia con quello aperto ad Ascoli Piceno, rivelato proprio da
Domani, dove la procura locale procede contro ignoti.
Un dato emerso dalla lettura
degli atti relativi alla morte nel carcere marchigiano di uno dei detenuti,
Salvatore Piscitelli, anche lui oggetto di violenza secondo alcuni testimoni.
Nel fascicolo sono state
raccolte le testimonianze ci cinque detenuti in merito alle violenze subite l’8
marzo 2020. Hanno deciso di parlare nonostante la paura di ritorsioni.
Pestaggi in carcere,
l’altra indagine di Ascoli. Botte «soprattutto contro gli stranieri».
NELLO TROCCHIA su
Il Domani il 17 maggio 2022
«Individuate gli
eventuali responsabili delle violenze che sarebbe state commesse da alcuni
agenti della polizia Penitenziaria a danno di alcuni detenuti».
È la richiesta che arriva
dall’associazione Antigone, in un esposto presentato in questi giorni alla
procura marchigiana alla luce delle testimonianze rese dai detenuti reclusi
nella casa circondariale, nel marzo 2020.
Un fascicolo è già aperto
contro ignoti e prende l’abbrivio proprio dal racconto degli ospiti del carcere
nel periodo iniziale dell’emergenza pandemica, tutti detenuti che erano stati
trasferiti ad Ascoli da Modena dove, nel carcere Sant’Anna, c’era stata una
violenta rivolta.
L’istituzione totale
che non rieduca ma fa tornare bambini.
ISABELLA DE SILVESTRO E LUIGI MASTRODONATO su Il Domani il 28 aprile 2022
Si sa dei grandi scandali ma
non della apatica quotidianità che tortura i detenuti con una serie ininterrotta
di piccoli soprusi e drammatici disagi.
L’8 marzo 2020 nel carcere di
Modena si è consumata quella che un detenuto ha descritto come “la più grande
macelleria della mia vita”. Durante una sommossa carceraria e nei momenti
successivi sono morti in nove per overdose da metadone ed è stata la peggiore
strage del dopoguerra in un penitenziario italiano. Nelle stesse ore altre
quattro persone hanno perso la vita in circostanze simili nelle prigioni di
Rieti e Bologna.
Qualche mese dopo Domani ha
rivelato che il 6 aprile 2020 nel carcere casertano di Santa Maria Capua
Vetere era avvenuta quella che il gip Sergio Enea ha definito «un’orribile
mattanza» nei confronti dei detenuti, in risposta a una rivolta del giorno
prima. Decine di agenti sono finiti a processo con l’accusa di tortura, un fatto
senza precedenti in Italia. Nel gennaio 2021 a Ferrara c’è stata la prima
condanna definitiva per tortura in Italia nei confronti di un agente, ritenuto
colpevole di aver agito con crudeltà e violenza grave contro un detenuto. Un
mese dopo la stessa pena in primo grado ha riguardato altri agenti per fatti
simili nel penitenziario di San Gimignano.
Nel 2020 le carceri italiane
hanno fatto registrare il record di suicidi dell’ultimo decennio: secondo i dati
dell’associazione Antigone, 61 detenuti si sono tolti la vita in cella. Bisogna
tornare al 2009 per trovare numeri simili. Nel gennaio 2022 la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo (Cedu) ha condannato l’Italia per trattamenti inumani e
degradanti, per aver trattenuto nel carcere di Rebibbia un 28 enne affetto da
disturbi psichici negandogli le cure di cui aveva bisogno.
PUNTO DI NON RITORNO
Violenze, torture, suicidi,
privazione del diritto alla salute, condanne nazionali e internazionali. Quelli
citati sono alcuni degli episodi avvenuti nelle carceri italiane nell’ultimo
biennio e raccontano bene le criticità che sta vivendo il sistema penitenziario.
«Io un punto così basso per le carceri italiane non l’avevo mai registrato», ha
detto Rita Bernardini, esponente del Partito Radicale e presidente di Nessuno
Tocchi Caino. Sicuramente la pandemia ha avuto un ruolo in questo deterioramento
ma non è che prima andasse tutto bene.
Problemi storici a cui ci si
era drammaticamente abituati sono solo tornati di attualità. Per esempio il
sovraffollamento. Nel 2013 l’Italia è stata condannata dalla Cedu nella sentenza
Torreggiani perché non garantiva ai detenuti uno spazio dignitoso, ma negli anni
successivi il numero dei carcerati ha continuato ad aumentare.
Quando è arrivato il Covid-19
e certe precauzioni come il distanziamento sociale e l’areazione degli ambienti
si sono imposte nella quotidianità del mondo esterno, è apparso evidente che lo
stesso non potesse accadere in un luogo come il carcere, in quel momento
popolato da 61.230 detenuti contro una capienza di 50.931.
Con il passare dei mesi si è
riusciti ad alleggerire la densità penitenziaria, ma ora che la fase
emergenziale più dura è passata le carceri italiane sono tornate ad accogliere
ben più persone di quante potrebbero, con istituti come quello di Taranto o
Brescia che fanno registrare tassi di riempimento vicini al 200 per cento.
La pandemia ha anche sconvolto
la quotidianità già precaria dei detenuti. Per ridurre al minimo i contatti con
l’esterno sono stati sospesi i colloqui, interrotte le lezioni universitarie e
scolastiche, annullati i laboratori. La quasi totalità delle attività interne,
fondamentali per i detenuti dal punto di vista psicologico, si sono dissolte da
un giorno all’altro. E la popolazione carceraria si è trovata ancora più sola di
quanto già non fosse.
Il malessere crescente ha
fatto scoppiare nuove rivolte che sono state anche l’occasione per ricordarsi di
come in Italia ci sia un problema di abuso di potere, lo stesso che sporcava di
sangue le strade di Genova nel 2001 e che poi è passato dalla Ferrara di
Federico Aldrovandi e dalla Roma di Stefano Cucchi.
TROPPI SILENZI
Per quanto di tutte queste
problematiche carcerarie legate al malessere e agli abusi si stia finalmente
iniziando a parlare, intorno a esse rimane un grande silenzio. Si sa dei grandi
scandali che riguardano il sistema penitenziario italiano e non si sa di tutto
il resto, del modo in cui scorre la quotidianità dei detenuti anche quando le
cose vanno, più o meno, come dovrebbero andare. Ed è invece proprio qui, in
questa apatica normalità, che si ritrova il livello di disagio maggiore quando
si osserva il carcere in Italia.
L’inchiesta “Carcere, inferno
quotidiano”, che chiediamo ai lettori di sostenere attraverso il nostro sito
editorialedomani.it, indagherà in profondità per raccontare quello che, giorno
per giorno, le sbarre nascondono.
GLI EFFETTI DELLA DETENZIONE
Il carcere non ha smesso di
essere una pena corporale, nonostante il passaggio da pena come supplizio a pena
come rieducazione sia avvenuto, teoricamente, da ormai due secoli. La detenzione
abbrutisce, il corpo decade, l’incarcerazione provoca un’involuzione precipitosa
di tutta la sensorialità.
Si abbassano le difese
immunitarie e la vista cala perché lo sguardo del detenuto è tagliato dalla
vicinanza delle mura esterne e delle pareti divisorie. La messa a fuoco è corta,
si perde la distanza, la linea dell’orizzonte, svaniscono i colori. Anche
l’olfatto è anestetizzato dall’aria stagnante.
L’udito in un primo momento si
acutizza - la prigione è un luogo di rumori incessanti tra porte blindate che
sbattono, chiavi che girano, urla, lamenti - ma in alcuni casi può
sopraggiungere la sordità come difesa.
Del corpo si perde presto la
percezione totale: gli specchi a disposizione di un carcerato bastano appena a
vedersi il viso, quando mancano anche quelli ci si rade con il retro dei cd, uno
degli strumenti di svago che insieme alle radioline, ai dvd e alle lettere con
francobolli sempre più difficili da trovare sul mercato, relegano la popolazione
carceraria a un tempo irreale, fermo agli anni ’90. Da qui anche il senso di
vertigine e spaesamento che spesso segue la scarcerazione.
QUOTIDIANITÀ MALSANA
Il carcere non è solo un luogo
dove si tenta il suicidio o ci si dedica all'autolesionismo. È più spesso un
luogo dove il dolore assume forme opache, simili a un sonno cosciente. La vita
quotidiana di un detenuto è fatta di piccoli sforzi di resistenza al tempo che
scorre vuoto e sempre uguale: la televisione è il più potente anestetico insieme
alla “terapia”, ovvero gli psicofarmaci che vengono distribuiti la sera, prima
della chiusura delle celle. Un detenuto su due in Italia ne fa uso, non solo per
tenere a bada disturbi psichici, ansia e depressione, ma anche per far scorrere
le giornate.
Il fine settimana e l’estate
sono i periodi in cui se ne assumono di più perché l’isolamento si acuisce, i
volontari non entrano, le attività vengono sospese. E allora si dorme, si resta
a letto per giorni interi, ci si ribella così alla formula, ripetitiva e presto
soffocante pronunciata dagli agenti tre volte al giorno al detenuto che vuole
lasciare la cella: «Aria, saletta o doccia?» - i tre vettori della fuga dagli
spazi angusti di quelle celle spesso sovraffollate. E aria vuol dire
“passeggio”, che a sua volta indica un cortile claustrofobico in cui girare in
tondo, ogni giorno, per anni. Il lessico carcerario è fatto di “domandine”, le
richieste interne dei detenuti agli agenti, frequenti e totalizzanti come quelle
di un bambino alla maestra.
Il detenuto è infantilizzato,
deresponsabilizzato, riportato allo stadio infantile della vita. Deve aspettare
che si aprano le porte, che venga accolta o negata una richiesta, non ottiene
spiegazioni sui dinieghi. In carcere si sente spesso dire che meno chiedi e
meglio è, più accondiscendi alle rodate logiche di spoliazione della personalità
e più simpatico risulterai a chi può decidere se farti avere o meno ciò che ti
spetterebbe di diritto. È difficile immaginare cosa voglia dire poter parlare al
telefono con i figli solo dieci minuti a settimana, dover scegliere le parole da
dire, che cosa omettere e che cosa raccontare o come spartire un tempo così
limitato tra le persone care. Più facile forse è immaginare il fastidio di
mangiare con le posate di plastica, come in un picnic al parco quando inizia la
primavera, e la tortura di dover mangiare sempre così per anni, per decenni,
colazione, pranzo e cena.
Il carcere è, insomma, un
luogo di piccoli soprusi quotidiani. L’espropriazione di ogni riservatezza ed
intimità, l’azzeramento della sfera sessuale e le continue privazioni e
umiliazioni fanno crescere nei detenuti rabbia e frustrazione, a discapito del
fine rieducativo.
Sembra che alla pena definita
dal dettato costituzionale si aggiunga la pena supplementare inflitta
quotidianamente per mezzo di piccole torture spesso legalizzate, altre volte
fuori da ogni regola. Il fatto che oggi il tasso di recidiva sia al 70 per cento
racconta il fallimento di un’istituzione che reclude e non reinserisce.
Un’istituzione caratterizzata
da piccoli abusi, ripicche, complicazioni burocratiche, imposizioni securitarie
che fanno meno rumore delle storie di Santa Maria Capua Vetere e di Modena ma
sono parte dello stesso racconto e forse aiutano a comprenderlo meglio. Drammi
che esistono da sempre e che la pandemia ha solo aggravato.
Il rapporto di Antigone.
Rapporto carceri, in Italia sistema in tilt: calano i reati ma crescono
ergastolani e recidivi.
Federica Brioschi su Il Riformista il 29 Aprile 2022.
Oltre 2.000 in 24 anni. Un
monitoraggio costante che ha permesso ad Antigone di fotografare lo stato
del sistema penitenziario nella sua complessità, analizzandolo con spirito
critico ma anche costruttivo. Da questa attività parte la realizzazione del
rapporto annuale dell’associazione sulle condizioni di detenzione. Ieri, a Roma,
è stato presentato il diciottesimo, frutto delle circa 100 visite effettuate nel
2021, dal Nord al Sud del paese, dalle carceri più grandi agli istituti più
piccoli.
Il monitoraggio degli
osservatori restituisce un’immagine delle carceri italiane non molto
lusinghiera. Nel 17% di quelle visitate da Antigone c’erano sezioni prive di
ogni ambiente comune, che sono invece fondamentali per organizzare attività
volte al reinserimento dei detenuti nella società. In oltre il 30% degli
istituti le persone non avevano accesso regolare alla palestra, un modo per
mantenersi in salute in un ambiente sedentario. Nel 35% degli istituti visitati
mancava l’area verde per i colloqui all’aperto con i familiari prevista dal
regolamento, mentre nell’85% non c’erano spazi di culto per i detenuti non
cattolici. In varie carceri si trova ancora il water a vista accanto al letto e
al fornelletto per cucinare. Infine nel 74% degli istituti visitati le persone
non avevano alcuna forma di accesso a Internet.
A fine marzo sono 54.609 le
persone private della libertà nel sistema penale italiano, mentre un anno fa
erano circa un migliaio in meno. Ufficialmente il tasso di affollamento medio è
del 107,4%, tuttavia, se si considerano i posti realmente disponibili, a fronte
di reparti e sezioni chiuse o celle inagibili, il tasso supera il 115%. Un dato
su cui pesano sempre meno gli stranieri che al 31 marzo 2022 sono il 31,3% sul
totale della popolazione detenuta, con un calo del 5,8% rispetto al 2011. Il
loro tasso di detenzione (calcolato nel rapporto tra popolazione straniera
residente in Italia e stranieri presenti nelle carceri) ha visto una decisiva
diminuzione, passando dallo 0,71% del 2008 allo 0,33% del 2021. Stabile la
percentuale di donne, che rappresentano il 4,2% della popolazione detenuta, così
come i detenuti in custodia cautelare, il 31,1% del totale, un dato sempre
superiore alla media europea e su cui non si riesce ad intervenire in maniera
ampia.
Se lo scopo principale della
pena dovrebbe essere il reinserimento sociale ed evitare che le persone
condannate tornino a delinquere, il carcere non sembra riuscire ad adempiere al
dettame costituzionale. Infatti al 31 dicembre 2021 solo il 38% dei detenuti
presenti nelle carceri italiane era alla prima carcerazione. Il restante 62% in
carcere c’era già stato almeno un’altra volta. Il 18% c’era già stato in
precedenza 5 o più volte. Aumenta anche il numero di reati medio commesso da
ogni detenuto. In media vi si tratta di 2,37 reati per detenuto mentre nel 2008
il numero di reati per detenuto era dell’1,97. Dunque diminuiscono i reati in
generale, diminuiscono i detenuti in termini assoluti ma aumenta il numero medio
di reati per persona. Ciò è indice dell’aumento del tasso di recidiva. Dati
centralizzati sulla recidiva non vengono raccolti e invece sarebbe utile lo si
faccia. Per capire quali sono i percorsi che realmente consentono a chi ha
scontato una pena a non commettere altri reati una volta fuori. Certamente, da
questo punto di vista, aiutano le misure alternative, che consentono al detenuto
di riprendere i legami con il mondo esterno prima della fine della pena.
Come ha ricordato durante la
conferenza di presentazione del rapporto il Garante dei detenuti della Regione
Lazio, Stefano Anastasìa, non esiste alcuna ragione – che guardi ad un orizzonte
risocializzante – per tenere una persona in cella fino all’ultimo giorno della
sua pena. Nonostante il calo dei reati che si registra ormai da anni (-12,6%
rispetto al 2019), le persone detenute si trovano a scontare pene sempre più
lunghe. Al dicembre 2021 fra i detenuti definitivi, il 50% stava scontando una
condanna definitiva uguale o superiore a 5 anni e il 29% aveva subito una
condanna a 10 o più anni. Dieci anni fa queste percentuali erano rispettivamente
il 40% e il 21%. Aumentano anche gli ergastolani: erano 408 nel 1992, 990
nel 2002, 1.581 nel 2012 e oggi sono 1.810. Un aumento impressionante
considerando il calo degli omicidi in Italia. Infine, venendo proprio alle
misure alternative, ben 19.478 detenuti dovevano scontare una pena residua pari
o inferiore a 3 anni.
Una gran parte di loro
potrebbe usufruire di alternative alla detenzione ma, alla difficoltà di
ottenerli in alcuni casi, spesso si aggiungono anche problemi di carattere
esterno, come ad esempio l’assenza di un domicilio che consenta di accedere alla
detenzione domiciliare. Di fronte a questi numeri appare evidente la necessità
di riformare il sistema e su questo insiste con forza l’associazione
Antigone. “I tassi di recidiva ci raccontano di un modello che non funziona e ha
bisogno di importanti interventi, aprendosi al mondo esterno, puntando sulle
attività lavorative, scolastiche, ricreative e abbandonando la sua impronta
securitaria” ha commentato Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. “A
dicembre 2021 – ha ricordato Gonnella – la Commissione per l’innovazione del
sistema penitenziario nominata dalla Ministra Cartabia e presieduta dal
prof. Marco Ruotolo, ha elaborato e consegnato un documento con tutta una serie
di riforme che si potrebbero fare in maniera piuttosto rapida.
Inoltre la recente nomina
di Carlo Renoldi alla guida del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria apre una prospettiva importante da questo punto di vista. Ci
auguriamo che si sappia cogliere quest’occasione e si portino avanti tutte le
riforme di cui il carcere italiano ha urgente bisogno”. Un ultimo passaggio è
stato dedicato al diritto di voto delle persone recluse. In Francia, al primo
turno delle politiche, ha votato circa il 15% dei detenuti grazie ad una nuova
modalità via posta che ha incentivato la partecipazione (prima votava solo il
2%). “Anche in Italia – è stato l’appello di Gonnella – si trovino degli
strumenti per incentivare la partecipazione dei detenuti al voto in vista delle
prossime elezioni politiche e i prossimi referendum”. Garantire il diritto al
voto significa garantire la partecipazione dei detenuti alla vita sociale,
fondamentale in un’ottica risocializzante. Federica Brioschi
Vitto e
sopravvitto, Garante del Mercato: «Le aziende alterano le gare d’appalto».
L’autorità della Concorrenza ipotizza che le parti si mettano d’accordo alterano
le gare, provocando inevitabilmente la riduzione della quantità e qualità del
cibo per i detenuti. Damiano Aliprandi su Il Dubbio il 2 Dicembre 2022
Ipotesi di possibile
sussistenza di condotta collusiva e del fatto che le parti potrebbero aver
alterato sensibilmente la libera formazione dei prezzi e la selezione
dell’operatore più efficiente, con conseguente effetto peggiorativo del servizio
complessivo offerto ai detenuti. Dopo la sentenza della Corte dei Conti, arriva
il bollettino dell’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che affronta
l’affidamento dei servizi di vitto e sopravvitto degli istituti penitenziari.
L’autorità, in
premessa, spiega che il 23 febbraio 2022 è pervenuta una segnalazione relativa a
comportamenti anticoncorrenziali adottati da alcuni partecipanti a una procedura
di gara finalizzata alla conclusione dell’affidamento del servizio per il vitto
dei detenuti e internati ristretti nelle carceri della Regione Campania
(Gazzetta Ufficiale, 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 130 del 10- 11-
2021). Considerato che tale procedura si è svolta parallelamente ad altre
indette in distinte aree regionali e/ o aventi ad oggetto il servizio di
sopravvitto, la segnalazione risultava incompleta specialmente con riguardo
all’estensione e alla consistenza delle condotte, oltre che all’individuazione
dei possibili responsabili ai fini dell’avvio dell’istruttoria.
IL GARANTE HA
CHIESTO INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE SEGUITE DAI PROVVEDITORATI
Pertanto, il 9
maggio 2022, il Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso una
richiesta di informazioni al ministero della Giustizia, con cui venivano
domandati i dettagli di tutte le procedure relative ai servizi di vitto e
sopravvitto indette dagli undici Provveditorati regionali dell’Amministrazione
Penitenziaria (PRAP) dal 2019 in poi, specificando gli esiti delle stesse e
l’indicazione dei punteggi attribuiti a tutti i partecipanti, nonché i ribassi
offerti e i nominativi dei partecipanti e degli aggiudicatari. A propria volta,
il ministero ha inoltrato la richiesta agli undici PRAP competenti per
territorio. Già il successivo 23 maggio il PRAP Veneto, Trentino Alto- Adige e
Friuli Venezia- Giulia rendeva nota la difficoltà di reperire tempestivamente
quanto richiesto, considerata la mole di informazioni da collezionare.
Dopodiché, hanno risposto.
Sempre nel
bollettino viene specificato che la notevole quantità di informazioni trasmesse
dai PRAP, tuttavia, non si è rivelata sufficiente ad apprezzare compiutamente la
complessità e l’estensione delle condotte in esame. Conseguentemente, è stato
necessario integrare la documentazione agli atti con quanto reperibile sul sito
web del ministero della Giustizia, concernente non solo dati ulteriori a quelli
forniti dai PRAP nelle risposte alla richiesta di informazioni, ma anche dati
relativi alle procedure di gara aperta o negoziata in corso nel periodo estivo.
Infatti, l’ultima procedura considerata nel presente provvedimento di avvio è
stata definita con la determina di approvazione della proposta di aggiudicazione
del 28 settembre 2022, pubblicata sul sito internet il 30 settembre successivo.
IPOTIZZATE CONDOTTE
ANTI- COMPETITIVE PER CONDIZIONARE L’ESITO DELLE GARE
L’autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, arriva direttamente al punto. Nel bollettino
denuncia che le vicende in esame concernono ipotesi di condotte anti-competitive
volte a condizionare l’esito di molteplici procedure comparative pubbliche
relative all’affidamento dei servizi di vitto e sopravvitto bandite da
vari PRAP dal 2020 in poi. In particolare, i comportamenti anomali hanno
riguardato prima facie l’area centro- meridionale e insulare del territorio
nazionale, ovvero le procedure di gara aperta e le procedure negoziate indette
dai seguenti PRAP: Lazio/ Abruzzo/ Molise, Campania, Puglia/ Basilicata,
Calabria, Sardegna e Sicilia. «Le condotte anti- competitive considerate –
scrive l’autorità Garante – consistono in una serie di anomalie riscontrate
nell’analisi degli esiti delle procedure imputabili a Ventura, Saep, Guarnieri,
Pastore e D’Agostino.
In particolare,
l’anomalia più ricorrente risiede nella presentazione di offerte estremamente
eterogenee tra i vari lotti della medesima procedura, tali da favorire di volta
in volta una delle sodali nell’aggiudicazione (c. d. "scacchiera")». A tale
anomalia, prosegue il bollettino, si accompagnano altre condotte, come la
presentazione di offerte c. d. "di appoggio" o le astensioni volte ad
avvantaggiare altri concorrenti, che possono essere lette come compensazioni
rispetto ad altre contestuali procedure.
RISCONTRATO IL
SISTEMA A "SCACCHIERA" NELLE GARE PER VITTO E SOPRAVVITTO
Non solo. Viene
sottolineato che, nell’ambito di alcune procedure relative al sopravvitto, si è
riscontrata l’assenza di offerte dei sodali che presentano uno sconto esiguo per
la procedura per il vitto proprio al fine di favorire l’affidamento della
concessione all’operatore favorito per l’aggiudicazione del corrispondente
servizio di vitto o già aggiudicatario dello stesso. «Tale comportamento appare
idoneo a consentire agli aggiudicatari del vitto di compensare il notevole
sconto praticato in alcuni casi, in quanto dal sopravvitto è possibile ricavare
maggiore utili», viene sottolineato nel bollettino.
Dopo una lunga e
dettagliata analisi, il Garante arriva a ipotizzare che le aziende, in pratica,
si mettono d’accordo per la gara d’appalto. «Il pattern partecipativo che pare
emergere risulta caratterizzato da: presentazione di offerte estremamente
eterogenee tra i vari lotti della medesima procedura tali da favorire di volta
in volta una delle sodali nell’aggiudicazione (c. d. "scacchiera"); formulazione
di offerte c. d. "di appoggio" o l’astensione dalla procedura allo scopo di
avvantaggiare altri concorrenti da interpretare come compensazioni rispetto ad
altre contestuali procedure; astensione dalle procedure di sopravvitto al fine
di favorire l’affidamento della concessione all’operatore favorito per
l’aggiudicazione del corrispondente servizio di vitto o già aggiudicatario dello
stesso», denuncia il Garante attraverso il bollettino.
Attraverso
l’ipotizzata condotta concertata, sempre secondo il Garante, le parti potrebbero
aver alterato sensibilmente la libera formazione dei prezzi e la selezione
dell’operatore più efficiente nell’ambito delle gare pubbliche in esame. Nel
caso di specie, anche là dove si osservano sconti elevati, questi potrebbero
essere compensati dall’esercizio del remunerativo servizio di sopravvitto da
parte dello stesso operatore aggiudicatario del servizio di vitto. Tale effetto
è riscontrabile non solo nell’ambito delle procedure unitarie del 2020, in cui
appunto vitto e sopravvitto venivano affidati contestualmente, ma anche
successivamente, «posto che frequentemente gli affidatari del servizio di vitto
coincidono con i medesimi aggiudicatari delle pressoché contestuali procedure
volte all’affidamento della concessione del servizio di sopravvitto».
LA STRATEGIA
POTREBBE PEGGIORARE IL SERVIZIO PER IL NOTEVOLE RIBASSO
Il risultato? Tale
strategia esaminata dal bollettino, potrebbe appunto produrre effetti
peggiorativi del servizio complessivo offerto ai detenuti, considerato che un
notevole ribasso dell’importo a base d’asta (oscillante tra 5,70 a 5,90 euro per
i tre pasti giornalieri) può ripercuotersi in una minore qualità e quantità
delle forniture, tale da rendere necessario l’acquisto tramite il sopravvitto a
spese dei detenuti stessi di alimenti indispensabili per compensare la scarsità
dei pasti offerti. «Sarà sufficiente tutto questo a fare capire
all’amministrazione penitenziaria che deve adottare provvedimenti immediati?»,
si chiede Gabriella Stramaccioni, la garante dei detenuti del comune di Roma che
si è battuta molto – attraverso denunce pubbliche e segnalazioni alle autorità –
per il problema del vitto e sopravvitto.
AFFARE INFINITO IN
CAMPANIA. Il cibo in carcere è un affare. Vince la stessa azienda a cifre
stracciate.
NELLO TROCCHIA su Il Domani il 18 aprile 2022
Nonostante le promesse di
cambiamento, gli interventi della magistratura contabile e amministrativa, la
presa di posizione della ministra Marta Cartabia, il cibo in carcere continua a
essere un affare per pochi e soprattutto a basso costo.
Le ultime assegnazioni
riguardano i pasti “offerti” ai detenuti e alle detenute campane. Il vitto è
stato aggiudicato dalla società Ventura con un ribasso di circa il 40 per cento.
Soli 3,29 euro per garantire
colazione, pranzo e cena. Già in passato i detenuti avevano lamentato la scarsa
qualità del cibo. L’azienda non parla, il dipartimento risponde nel merito e
promette verifiche. «Su entrambi i contratti saranno garantiti stringenti
controlli», dice Lucia Castellano, provveditore regionale della Campania.
NELLO TROCCHIA. È inviato di
Domani, autore dello scoop sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua
Vetere. Ha firmato inchieste e copertine per “il Fatto Quotidiano” e
“l’Espresso”. Ha lavorato in tv realizzando inchieste e reportage per Rai 2
(Nemo) e La7 (Piazzapulita). Ha scritto qualche libro, tra gli
altri, Federalismo Criminale (2009); La Peste (con Tommaso Sodano,
2010); Casamonica (2019) dal quale ha tratto un documentario per Nove e Il
coraggio delle cicatrici (con Maria Luisa Iavarone). Ha ricevuto il premio Paolo
Borsellino, il premio Articolo21 per la libertà di informazione, il premio
Giancarlo Siani. È un giornalista perché, da ragazzo, vide un documentario su
Giancarlo Siani, cronista campano ucciso dalla camorra, e decise di fare questo
mestiere. Ha due amori, la famiglia e il Napoli.
Flaminia Savelli per “il
Messaggero” il 21 aprile 2022.
«Mi hanno minacciato con un
coltello, se racconti quello che ti abbiamo fatto ti uccidiamo. Poi mi hanno
legato e violentato a turno». Inizia così il racconto dell'orrore di un
detenuto, romano di 65 anni tossico dipendente e in carcere per reati legati
allo spaccio. È l'uomo che sta scontando la pena nel carcere di Regina Coeli e
che per due giorni è stato violentato dai compagni di cella: due stranieri di
origine bosniaca che approfittando della scarsa sorveglianza, hanno sequestrato
e abusato sessualmente del detenuto. I tre erano infatti stati trasferiti in una
cella del reparto Covid del penitenziario, nella Settima Sezione, dove vengono
reclusi i detenuti contagiati. Per ragioni sanitarie, non ci sono celle aperte e
non viene applicata la vigilanza dinamica.
Così come è stato già
confermato, la violenza è avvenuta la scorsa settimana nella camera di
pernottamento in cui i tre erano ristretti. La procura di Roma ha aperto un
fascicolo per sequestro e violenza sessuale. Gli agenti della polizia
penitenziaria stanno ora procedendo con accertamenti. Infatti i poliziotti dopo
aver accompagnato la vittima prima in infermeria e poi in ospedale dove i medici
hanno confermato le violenze subite.
Quindi, hanno inviato una
prima informativa. I compagni di cella invece, accusati di violenza sessuale,
sono ora in isolamento. Ma nei prossimi giorni si procederà con provvedimenti
disciplinari: la misura più frequente adottata in casi analoghi è quella del
trasferimento in altri istituti penitenziari.
«Un episodio vergognoso e
raccapricciante certamente favorito dall'allentamento della sicurezza interna
dovuto alla vigilanza dinamica» ha commentato Maurizio Somma, segretario per il
Lazio del Sappe, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che ha denunciato
quanto avvenuto.
«La situazione è drammatica e
quanto emerso in queste ore ci preoccupa. Il sospetto è che non si tratti di un
caso isolato. La vigilanza, a causa del ridotto numero di agenti di polizia è
ridotta all'osso. Rischiamo che i detenuti prendano il controllo del carcere»
denuncia Donato Capece, segretario generale del Sappe. Sono i numeri a
confermare la carenza del personale carcerario: a Regina Coeli si contano 143
unità in meno: «La vigilanza può essere garantita con un poliziotto ogni 10
detenuti. La media che registriamo da due anni a questa parte è molto più bassa,
disponiamo di un agente ogni 70 carcerati» specifica il segretario Capece.
Al numero ridotto di unità, si
somma l'allarme scattato per la pandemia con i focolai che a più riprese si sono
registrati nelle diverse sezioni del penitenziario. L'ultimo, il più grosso che
si registra nelle carceri italiane in questo momento è proprio a Regina Coeli
con 211 positivi con un numero di detenuti pari a quasi 300 in più rispetto ai
posti disponibili. e insieme una carenza di 143 poliziotti penitenziari rispetto
quelli previsti in organico. E solo il 4% dei reclusi svolge un'attività
lavorativa.
Rosario&Ordine. La politica
reazionaria dei sovranisti sui diritti umani dei detenuti.
Iuri Maria Prado su L'Inkiesta
il 30 Maggio 2022.
La destra ha contestato il
governo per aver finanziato la realizzazione di luoghi dove i detenuti possano
stare insieme al loro partner per un giorno al mese. Una misura di civiltà che
non piace a chi rivendica il carcere quale esclusiva ignominia afflittiva.
Nel competere in oscenità con
la sinistra manettara e con l’armata forcaiola, quella che si compiace se un
vecchio malato resta per sempre in carcere e ne esce soltanto «chiuso in una
cassa» (così, testualmente, l’altra sera, l’ex magistrato e deputato
progressista Giuseppe Ayala), la presunta controparte di destra si è
recentemente esercitata nella contestazione dei propositi di stanziamento
governativo per finanziare la realizzazione di luoghi in cui i detenuti, per un
giorno al mese, possano stare in intimità con il partner.
Ripugna alla destra moderna e
cristiana (Rosario&Ordine, per capirsi) anche la sola idea che ai detenuti sia
consentito di “sfogare i propri istinti” a spese dei contribuenti, e quindi essa
si aduna nella protesta contro il governo per cui (così, ancora testualmente, si
bercia dai ranghi di Fratelli di Italia): «La priorità è garantire ai detenuti
il massimo comfort e una brillante vita sessuale».
Non c’è neppure, a sorreggere
questa requisitoria, la improbabile esigenza sicuritaria evocata da un altro bel
campione della giustizia piombata, quel Nicola Gratteri specializzato in
rastrellamenti e nella prefazione di libri negazionisti firmati da autori di
propaganda neonazista: c’è proprio, e soltanto, la rivendicazione del carcere
quale esclusiva ignominia afflittiva, e il solito vellicamento della reazione
plebea al lassismo oltraggioso che si preoccupa del sollazzo dei condannati.
Se dovessimo fare ironia
potremmo indugiare sulle abitudini di chi considera “brillante vita sessuale” il
convegno di ventiquattro ore al mese (discutiamo di questo) in qualche ridotta
di una prigione: chissà che tanta acrimonia, tanto risentimento, tanto ribollire
di rabbia, non trovino causa in qualche insoddisfazione cui un po’ di esercizio
offrirebbe salutare rimedio. Ma non c’è proprio nulla su cui scherzare, perché
qui si tratta della disperante dimostrazione (Donna Giorgia perdonerà se usiamo
il maschile) che il meglio fico del bigoncio di destra rimane sempre il frutto
pessimo dell’eterno albero reazionario e illiberale. Quello che, per quanto la
stampa coi fiocchi lo inzuccheri per adibirlo a punto di riferimento fortissimo
delle affascinanti avventure alternative, va di traverso a chiunque chieda a
qualsiasi leader del 2022 il minimo sindacale di un pizzico di civiltà.
Affettività in carcere,
Gratteri non ci sta: «Al governo non interessa la mafia».
Il Dubbio il 28 maggio 2022.
Il procuratore di Catanzaro: «Hanno trovato più di 28 milioni di euro per
costruire le Case dell’Amore. Avete idea dei messaggi che possono essere mandati
all’esterno grazie a questa idea?»
«Nel suo discorso di
insediamento Draghi non ha detto una sola volta la parola mafia. Ha un piano?
Una visione? Vorremmo sapere se ha delle proposte per contrastare le mafie, ma
credo che la giustizia e la sicurezza non interessino a questo Governo e che
Cartabia non sia il Ministro che serviva all’Italia. Appena nominata ha
incontrato il Garante dei detenuti e Nessuno tocchi Caino, i magistrati li ha
incontrati dopo un mese. Non cambia nulla? Forse. Ma la forma è sostanza. E
questo fa capire l’indirizzo di questo Governo». Inizia così l’intervento di
Nicola Gratteri, Procuratore di Catanzaro, al corso «Le mafie ai tempi dei
social», organizzato da Fondazione Magna Grecia e ViaCondotti21 con il Gruppo
Pubbliemme, Diemmecom, LaC Network e l’Università LUISS, andato in onda in
diretta streaming su LaCNews24.
Nel mirino del procuratore di
Catanzaro, in particolare, i fondi per l’applicazione della legge
sull’affettività in carcere, che però non è ancora stata discussa in commissione
Giustizia del Senato. «Hanno trovato più di 28 milioni di euro per costruire le
Case dell’Amore, un luogo dove i detenuti possono incontrarsi per 24 ore con
moglie, marito e amanti», ha polemizzato Gratteri. «Avete idea dei messaggi che
possono essere mandati all’esterno grazie a questa idea? Questo abbiamo portato
a Palermo nel 30esimo anniversario della strage di Capaci, quando tutta la
politica è andata a onorare Falcone, le Case dell’Amore».
Il procuratore ha parlato
quindi dell’evoluzione delle mafie e dalla ricerca del consenso: «Le mafie oggi
sono mimetizzate nel tessuto sociale ed economico, ma non esisterebbe la mafia
senza la relazione con le classi dirigenti, sarebbe criminalità comune. La mafia
ha bisogno del territorio e del consenso popolare, il boss ha bisogno di
pubblicità, è un imprenditore. Così la ’ndrangheta si è presa la Calabria e un
quarto di Milano. Certe cose bisogna dirle. Io mi sono creato una vita da
recluso, ma sono libero di dire quello che voglio perché non appartengo a
nessuna corrente. Il silenzio è complicità».
La bufala
sulle “casette dell’amore” è l’ennesima disinformazione dei media.
Damiano Aliprandi su Il Dubbio il 2 giugno 2022.
Ha ragione
Ornella Favero, direttrice della redazione Ristretti Orizzonti ad indignarsi dei
giornalisti che non hanno verificato la falsa notizia dei 28 milioni stanziati
per le “casette dell’amore”, tra l’altro rilanciata puntualmente dal magistrato
Nicola Gratteri. Il 24 maggio scorso, Il Dubbio ha pubblicato
un articolo rilevando che la proposta di legge sull’affettività è purtroppo
ancora nel mondo dei sogni visto che la commissione Giustizia del Senato ancora
non l’ha messa all’ordine del giorno, così come gli eventuali fondi serviranno
in previsione di tale proposta rimasta nel limbo.
Quando la
politica diventa ostaggio della disinformazione
Dalle famose
“scarcerazioni” durante il covid alle “casette dell’amore”, il tema carcere
affrontato dai giornali si presta a numerose bufale per creare indignazioni e
quindi con la conseguenza di regredire sempre di più. La politica diventa così
ostaggio della disinformazione. Accade con altri temi dove le persone non
possono avere sempre gli strumenti per capire. Basti pensare alle tesi sulle
stragi di mafia. Quasi tutti i giornalisti, tranne questo giornale che tenta di
approfondire e scavare a fondo, copiano e incollano le tesi evocate e si crea un
danno enorme.
Il ministero
della Giustizia «non ha assunto alcuna iniziativa»
Ritornando al
tema penitenziario, il gioco è ancora più facile perché si cavalca e si
amplifica il cosiddetto populismo penale. Vale la pena riportare anche su Il
Dubbio, ciò che ha denunciato Ornella Favero. La direttrice di Ristretti
Orizzonti spiega come stanno le cose: la Regione Toscana ha presentato nel 2020
un disegno di legge sull’affettività delle persone detenute (e anche la Regione
Lazio) e, spiegano fonti del ministero della Giustizia in un comunicato, «nello
scorso mese di marzo la 5a commissione del Senato (Bilancio) ha richiesto al
ministero della Giustizia tramite il Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento una relazione tecnica su una stima di massima dei costi di
realizzazione». I tecnici del ministero, chiamati a rispondere, hanno trasmesso
una valutazione orientativa dell’eventuale impatto economico dell’intervento, ma
il ministero della Giustizia «non ha assunto alcuna iniziativa né ha espresso
valutazioni politiche, ma è stato chiamato ad esprimere un doveroso supporto
tecnico ad attività di tipo parlamentare».
La direttrice di
Ristretti Orizzonti: «Possibile che nessun giornalista o politico abbia pensato
di fare delle verifiche?»
A quel punto, la
direttrice di Ristretti, giustamente si indigna e si domanda retoricamente: «È
possibile che nessun giornalista o politico abbia pensato di fare delle
verifiche di notizie, che apparivano veramente sconclusionate al limite del
ridicolo? Il fatto è che siamo abituati, nel nostro Paese, a ridicolizzare nel
modo più triste e squallido quello che ha a che fare con gli affetti e con la
sessualità delle persone detenute, e riteniamo lecito dire qualsiasi schifezza
in materia, a partire dalla solita definizione di “celle a luci rosse”, mentre
negli altri Paesi, evidentemente più civili del nostro, si pensa a fare leggi
sensate e si capisce che in carcere ci stanno persone, che come tali vanno
trattate».
Ristretti
Orizzonti si “candida” a gestire la comunicazione
Ornella Favero
denuncia anche che il ministero della Giustizia e il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria non sono riusciti a fare una comunicazione
attenta, tempestiva, precisa, esauriente su questa vicenda. «Ci candidiamo
allora – scrive sempre Favero -, con la nostra Rassegna Stampa quotidiana,
Ristretti News, a fare noi questo lavoro, e magari a essere riconosciuti e
sostenuti, perché sappiamo che tanta parte dell’Amministrazione Penitenziaria
legge il nostro Notiziario, e sappiamo anche che per sopravvivere dobbiamo fare
i salti mortali».
La redazione è
composta da giornalisti detenuti “dilettanti”
Sottolinea che
dirige Ristretti Orizzonti, un giornale di giornalisti detenuti “dilettanti”, e
che per giunta, se sono finiti in carcere, «è perché spesso nella vita non si
sono distinti per il rispetto delle regole, quindi gli dovrei poter portare come
esempio i professionisti dell’informazione che fanno questo mestiere da anni, e
invece spesso succede il contrario, che siamo noi che stiamo molto più attenti
di loro alle parole, ai contenuti, al rispetto dei lettori». E conclude:
«Rispetto dei lettori significa rispetto dei lettori “liberi”, e noi lo abbiamo
perché le persone in carcere sanno mettersi in discussione, confrontarsi con le
vittime, assumersi le loro responsabilità, e rispetto dei lettori detenuti e
delle loro famiglie, che in tutta questa storia si sono visti trattati con
disprezzo, volgarità, miserabili bugie».
Affettività e sessualità in
carcere: «Ce lo chiede l’Europa».
Lo spiega l’avvocata Annamaria
Alborghetti, responsabile commissione carcere Camera Penale di Padova,
organizzatrice del convegno di martedì “Il cuore oltre le sbarre, affettività e
sessualità in carcere: diritti negati”. Damiano Aliprandi su Il Dubbio il 28
maggio 2022.
“Il cuore oltre le sbarre,
affettività e sessualità in carcere: diritti negati”, è il titolo del convegno
organizzato dalla Commissione Carcere della Camera Penale di Padova “Francesco
de Castello”. Si svolgerà martedì 31 maggio alle ore 15, presso il Centro
Culturale San Gaetano. Una iniziativa che ritorna di attualità grazie alle
recenti polemiche provenienti da alcune parti politiche, principalmente Lega e
Fratelli d’Italia, totalmente avulse dalla realtà, senza minimamente prendere in
considerazione che siamo tra i pochissimi paesi al mondo a rimanere indietro
rispetto ai diritti già acquisiti altrove da molto tempo.
«Le relazioni affettive devono
avere uno “spazio riservato” e un “tempo disteso”. Vale per tutti. Anche per chi
è privato della libertà ma non dovrebbe essere privato dei suoi diritti
fondamentali, e quindi del diritto all’affettività e alla sessualità, la “salute
sessuale” come la definisce l’Oms», così spiega l’avvocata Annamaria
Alborghetti, la responsabile Commissione Carcere Camera Penale di Padova e che
concluderà i lavori del convegno. Sottolinea che «ce lo chiede l’Europa» con la
raccomandazione 134/ 1997 del Consiglio d’Europa, invitando gli Stati membri a
mettere a disposizione dei detenuti luoghi per incontrare la famiglia. Così come
c’è la raccomandazione del Parlamento Europeo n. 2002/ 2188 del 2004 secondo cui
i detenuti devono avere «una vita affettiva e sessuale attraverso la
predisposizione di misure e luoghi appositi».
Chi ha risposto all’appello?
Ben 31 paesi su 47 del Consiglio d’Europa senza distinzione di sistemi politici
e con soluzioni diverse: dal colloquio prolungato non sorvegliato, come in
Croazia o in Romania, alla predisposizione di stanze, come in Spagna, o di veri
e propri appartamenti, a volte immersi nel verde e dotati di ogni comfort, dove
il detenuto può incontrare il partner, ma anche i figli o gli amici, come in
Norvegia, Danimarca e Olanda. O in Francia dove le Unités de Vie Familiale sono
piccoli appartamenti con una o due stanze da letto, un bagno e una zona cucina
separati dalle sezioni detentive ma all’interno del penitenziario. Nel Canton
Ticino c’è il “congedo interno” per incontrare il partner, familiari e amici in
una casetta, la c. d. “Silva”, o il “colloquio gastronomico”, un pasto in
compagnia di parenti e amici.
«Vivere l’affettività e la
sessualità – spiega l’avvocata Alborghetti fa bene a tutti, sicuramente al
detenuto, ma anche alla società nella quale il detenuto si reinserisce». Eppure,
sottolinea sempre la responsabile Commissione Carcere Camera Penale di
Padova, da oltre 25 anni si tenta di adeguare l’Italia agli altri 31 Paesi del
Consiglio Europeo: ci aveva provato nel 1997 il dr. Coiro, capo del DAP, con una
circolare che invitava a trovare spazi adeguati, e ancora, fino all’eccezione di
costituzionalità sollevata nel 2012, fino alle proposte di legge che attendono
fiduciose in Commissione Giustizia.
Qualcuno ha tentato di
affermare che il diritto a consumare il matrimonio è garantito dalla
Costituzione e ha invocato la concessione di un permesso di necessità ma la
Cassazione ha detto che «tra gli eventi di particolare gravità può rientrare
tutto ciò che ha il carattere dell’eccezionalità e non il diritto ad avere
rapporti sessuali, che per sua natura, non ha alcun carattere di eccezionalità».
Magari per chi è detenuto anche sì. Il convegno di Padova vuole discutere sullo
stato dell’arte e sulle proposte in discussione (forse), ma anche sui danni
fisici e psicologici della privazione affettiva e sessuale, sul senso del tempo
dell’affettività reclusa e, in concreto, come si progettano e realizzano gli
spazi degli affetti dentro un luogo di detenzione.
Da leggo.it il 24 Maggio 2022.
Sesso in carcere per i
detenuti: i ministri della Giustizia e dell’Economia hanno approvato lo
stanziamento di 28 milioni di euro che servirà alla nuova legge sulle “relazioni
affettive dei detenuti. La proposta va nella direzione di riservare stanze
specifiche nelle carceri per consentire ai detenuti - sono oltre 50mila quelli
presenti nelle carceri della Puglia - di fare sesso con le persone esterne.
Un'ipotesi che fa discutere e contro la quale si è già schierato il Sappe
(Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria). «Gli agenti di polizia
penitenziaria non sono dei guardoni di Stato. Meglio i permessi premio» tuona
Donato Capece, segretario del Sappe.
La protesta: «I nostri agenti
non sono guardoni di Stato»
"Ciclicamente, viene fuori la
proposta di destinare stanze o celle in carcere per favorire il sesso ai
detenuti. Noi ribadiamo quel che diciamo da tempo, con fermezza ed altrettanta
chiarezza: per il SAPPE, i nostri penitenziari devono assicurare il mandato
costituzionale dell’esecuzione della pena e i nostri Agenti di Polizia
Penitenziaria non devono diventare ‘guardoni di Stato! - si legge nella nota
- Il sesso in carcere è una proposta inutile e demagogica, che offende anche chi
ha subìto un reato anche molto grave.
Si ricorra, piuttosto, alla
concessione di permessi premio a quei detenuti che in carcere si comportano
bene, che non si rendono cioè protagonisti di eventi critici e che durante la
detenzione lavorano e seguano percorsi concreti di rieducazione. E allora, una
volta fuori, potranno esprimere l’affettività come meglio credono”.
La vera emergenza? «Episodi di
violenza e atti di autolesionismo»
“Altri sono gli interventi
urgenti per fronteggiare la costante situazione di tensione che si vive nelle
carceri italiane: Nel 2021 abbiamo contato nelle carceri italiane 11.295 atti di
autolesionismo, 1.669 tentati suicidi sventati in tempo dalla Polizia
Penitenziaria, 8.063 colluttazioni, 1.087 ferimenti: numeri altissimi, i più
alti degli ultimi vent’anni. E sorveglianza dinamica e regime penitenziario
aperto sono stati concausa di questo pazzesco numero di eventi critici, questa
folle spirale di tensione e violenza che ogni giorno coinvolge, loro malgrado,
appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria nelle carceri italiane, per
adulti e minori. Sospendiamo allora vigilanza dinamica e regime aperto se i
detenuti non lavorano, non studiano o non sono impegnati in altre attività”.
Il dibattito sul diritto
all’affettività per i detenuti. Abusi in carcere, sesso in cambio di abiti e
vino: “Celle dell’amore come in Spagna”.
Viviana Lanza su Il Riformista
il 23 Aprile 2022.
Il sindacato di polizia
penitenziaria S.p.p lancia un allarme sugli abusi sessuali all’interno delle
carceri dopo il caso del detenuto violentato da due compagni di cella nel
carcere di Regina Coeli a Roma. «La regione che sembra avere il numero più alto
di violenze è la Campania con 20 casi denunciati all’anno, seguita
dalla Sicilia con 14 casi», si legge nella nota diffusa dal segretario generale
del sindacato, Aldo Di Giacomo, in cui si fa riferimento a una percentuale di
denunce comunque bassissima rispetto alla realtà. «Forse solo l’1% delle
violenze sessuali in carcere viene denunciato», perché per paura di ritorsioni o
per vergogna in molti altri casi si subirebbe invece in silenzio. «Le
conseguenze per i detenuti che subiscono violenza – aggiunge Di Giacomo – sono
devastanti soprattutto a livello psichico sino a tentativi di suicidio e altre
forme di autolesionismo». Il sindacato denuncia, inoltre, episodi di sesso in
cambio di abiti, di vino, di droga, di merce varia all’interno delle celle e
segnala la necessità di «rivedere il sistema della sorveglianza dinamica».
Insomma uno scenario a tinte molto fosche.
In Campania il garante
regionale e quello cittadino dicono di non aver mai ricevuto personalmente
segnalazioni su violenze di questo tipo da parte dei reclusi a cui fanno visita
periodicamente nei vari istituti della Campania, tuttavia non negano che esista,
nelle carceri, un problema legato alla gestione dell’affettività e della
sessualità. «In carcere la violenza è sempre esistita», afferma Pietro
Ioia, garante cittadino con un passato da detenuto. «In carcere viene consentito
ai trans di accoppiarsi con i fidanzati detenuti, non vedo quindi perché non si
possa consentire anche agli altri detenuti di vivere momenti di intimità con le
proprie mogli – aggiunge Ioia – Nessuno finora mi ha mai raccontato di essere
stato prelevato con la forza e costretto a subire atti sessuali, in tal caso
avrei denunciato senza esitare». «Che esista poi un problema legato alla
sessualità questo sì, posso confermarlo – aggiunge – Così come non stento a
credere che possano verificarsi atti di violenza perché nelle carceri italiane
non c’è affettività». In Spagna e in altri PAesi europei invece sì. Ioia ha
vissuto in prima persona l’esperienza del carcere spagnolo dove l’affettività è
un diritto riconosciuto ai reclusi.
«Quando ero detenuto
in Spagna avevo la possibilità di incontrare mia moglie una volta al mese per
quattro ore. Era una possibilità riconosciuta a tutti i detenuti e veniva tolta
se non si aveva una buona condotta – racconta Ioia – Questo dava al detenuto un
incentivo positivo, perché si viveva aspettando il giorno dell’incontro con la
propria moglie. Questi incontri avvenivano nelle stanze di un padiglione
allestito come una specie di albergo. Si avevano quattro ore a disposizione per
vivere gli affetti, la propria intimità, senza essere disturbati. Ed era una
cosa naturalissima». «Del resto – aggiunge – anche gli animali in cattività
possono accoppiarsi. Non capisco perché quando si parla di questo argomento con
riferimento al carcere ci sono tanti tabù». Gli ostacoli, di fatto, non sono
soltanto logistici, benché nelle carceri ci sia una tale carenza di spazi che
sarebbe complicato immaginare luoghi dedicati esclusivamente all’intimità dei
reclusi, ma sono soprattutto culturali. «È ancora diffusa la cultura in base
alla quale il detenuto non deve vivere alcun affetto – spiega il garante
cittadino -, invece sarebbe una soluzione a tanti problemi e consentirebbe al
detenuto di essere più tranquillo psicologicamente. L’ho sperimentato
in Spagna, lì non c’erano mai episodi di violenza di nessun genere».
«Non serve mettere sotto
accusa la vigilanza dinamica, il sistema delle celle aperte, la mancanza di
personale – sottolinea il garante campano Samuele Ciambriello – È una violenza
tenere tante persone in una stanza, bisognerebbe stigmatizzare la convivenza
coatta di decine di persone e denunciare il fatto che ai detenuti non si
consente di vivere una sessualità libera né alcuna relazione affettiva con i
propri cari». «Inoltre – aggiunge – i dati dicono che nelle carceri della
Campania ci sono attualmente più persone accusate di femminicidio che di
omicidio, questo indica che si vivono le relazioni in maniera tossica e alterata
già fuori, nel mondo dei cosiddetti normali. Quindi non è la vigilanza sulla
socialità a incidere sui casi di abusi e violenze». Del resto anche lo stesso Di
Giacomo, come segretario del sindacato di polizia penitenziaria, sottolinea che
il fenomeno delle violenze sessuali in carcere ha come vittime detenuti che
subiscono dai compagni di cella.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Franco Bechis
per “Verità&Affari” il 21 maggio 2022.
All'improvviso il via libera è
arrivato in contemporanea sia dal ministero della Giustizia che dal ministero
dell'Economia e delle finanze. Grazie allo sblocco di Marta Cartabia e Daniele
Franco ora ci sono i 28,3 milioni di euro che serviranno alla nuova legge sulle
“relazioni affettive dei detenuti” che potrà marciare spedita in commissione
giustizia del Senato.
La somma è importante, e certo
sarà difficile capirne l'urgenza nel bel mezzo di una guerra in Europa, con
imprese italiane e cittadini che soffrono la crisi energetica che ne è derivata
e il PNRR che sta mostrando tutti i suoi limiti e lentezze.
Ma evidentemente anche per il
governo di Mario Draghi è importante in questo momento pensare alle relazioni
affettive dei detenuti. Ed è un pensiero costoso a luci rosse. Perché l'ok che
si sta dando è a un provvedimento che punta già nel 2022 a porre un
prefabbricato (tipo quelli in cui vivono ancora i terremotati del centro Italia)
all'interno di una casa circondariale in ogni regione, ristrutturando
rapidamente ove già esistano alcuni fabbricati trasformabili in appartamento.
Venti casette dell'amore entro
fine anno, perché questa sarà la loro funzione: ospitare detenuti in regime di
carcerazione duro e che quindi non possano godere di permessi premio, fino a un
massimo di 24 ore consecutive al mese per fare sesso con la propria consorte,
fidanzata, amante (anche per quella sola notte) ammessa per questo motivo alla
visita nella casa circondariale.
Con tutto il rispetto per le
relazioni familiari stabili e la loro esigenza di carnalità, più che una casetta
in ogni carcere dunque arriverà qualcosa di più simile a un casino, perché la
sua funzione principale era proprio quella esercitata nelle case chiuse prima
della legge Merlin. Nel “modulo abitativo” (così viene definito dal ministero
Giustizia) infatti potranno esserci in contemporanea tre detenuti con la propria
o il proprio partner. Il costo 2022 dell'operazione è 3,6 milioni di euro nel
2022 cui però si aggiungeranno altri 24,7 milioni di euro in un biennio per
pagare 100 casette nuove e ristrutturare allo scopo altri 90 fabbricati
esistenti in tutte le altre 190 carceri italiane.
Nella relazione tecnica il
governo scrive che “nell'ambito del panorama italiano lo strumento attraverso il
quale meglio si realizza la soddisfazione dei bisogni affettivi e sessuali del
detenuto e attualmente ancora quello del permesso premio, di cui all’art. 30 ter
O.P., che la legge prevede anche al fine di coltivare interessi affettivi. Tale
beneficio, tuttavia, non costituisce una soluzione al problema, non essendo
fruibile dalla generalità dei detenuti: esso infatti e riservato ai soli
condannati che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge”.
Il testo che ora si sblocca
dunque innova e ha come suo fine “garantire l’esercizio del diritto
all’affettività e alla sessualità dei soggetti in stato di detenzione
conformandosi agli indirizzi europei richiamati (…) indirizzi che trovano nel
dettato costituzionale riconoscimento e forza nel riferimento al diritto alla
salute e al suo mantenimento garantito dall’articolo 32 della Costituzione,
considerando che la salute psico-fisica viene compromessa da forzati e
prolungati periodi di astinenza sessuale”.
Per risolvere questa astinenza
dunque si procede con la costruzione dei “casini” dell'amore, e via con i 28,3
miliardi che sbloccano ora un testo all'esame del parlamento su corsie
preferenziali, ma che porta la firma del consiglio regionale della Toscana dove
fu approvato fra lunghe battaglie del centrodestra dal solo Pd che da quelle
parti però ha la maggioranza assoluta.
Il caso a regina Coeli.
Detenuto stuprato, come si può prevenire la violenza in cella.
Stefano Anastasia su Il
Riformista il 21 Aprile 2022.
Un’altra terribile notizia che
non avremmo voluto avere da un istituto penitenziario: la violenza sessuale di
cui è stata vittima una persona detenuta nel carcere romano di Regina Coeli ad
opera di due suoi compagni di stanza. Una persona – come ha sottolineato il
Garante nazionale dei detenuti – che peraltro non avrebbe dovuto essere lì,
essendo prossimo alla fine della pena per reati non ostativi e che quindi
avrebbe potuto essere in misura alternativa alla detenzione. Se le alternative
alla detenzione non si possono avere neanche a tre mesi dal fine pena, allora
diciamolo che c’è anche qui un doppio binario, tra quelli che in alternativa ci
vanno dalla libertà e quelli che in galera ci devono stare fino all’ultimo
giorno, mostrando platealmente il fallimento dell’ideale rieducativo in quella
pena scontata fino all’ultimo giorno in carcere.
Il Sindacato autonomo della
polizia penitenziaria mette ancora una volta sotto accusa il sistema di
vigilanza dinamica con le sezioni a stanze aperte vigente a Regina Coeli, e la
carenza del personale. A parte che, se è vero che gli aggressori erano compagni
di stanza dell’aggredito, la chiusura in stanza dei detenuti sarebbe stato
ancora peggio per la vittima, se il problema fosse quello reale della carenza
del personale sarebbe come a dire che la violenza è colpa del sovraffollamento,
problema anch’esso reale, ma che nulla c’entra con il fatto commesso e la
violenza perpetrata. In realtà il grave fatto di ieri apre uno squarcio su un
aspetto del mondo della detenzione troppo spesso rimosso: la convivenza coatta
di decine di persone private (tra le altre cose) di una sessualità libera e
consapevole. Certo la possibilità di avere una vita sessuale libera, attraverso
incontri riservati con il/la propria/o partner, non avrebbe cambiato la cultura
predatoria della sessualità che le due persone denunciate probabilmente hanno,
come quella che tanti di noi, maschi italiani, mostriamo ogni giorno fuori dal
carcere, in abusi, violenze e relazioni affettive tossiche che arrivano fino a
quell’impressionante numero di femminicidi da anni registrati nel nostro Paese
(mentre diminuiscono a livelli mai raggiunti prima gli omicidi per altre cause).
La cultura predatoria della
sessualità non si cancella né con una legge repressiva fuori, né con una legge
permissiva dentro il carcere, ma se la sessualità in carcere uscisse dal cono
d’ombra in cui è nascosta e repressa, sarebbe più facile prevenire ed evitare la
sessualità coatta e violenta dentro le comunità dei ristretti. È tema antico,
ormai, quello della sessualità in carcere, affrontato e risolto in molti Paesi
europei, ma che qui da noi resta soggetto a un tabù perbenista. Dopo una norma
di regolamento cassata per motivi formali vent’anni fa dal Consiglio di Stato,
una sentenza della Corte costituzionale e le proposte degli Stati
generali dell’esecuzione penale, se ne discute in Senato, su iniziativa del
Consiglio regionale della Toscana, cui si è aggiunta un’analoga proposta di
quello del Lazio. Perché non dargli seguito in quest’ultimo scampolo di
legislatura? Stefano Anastasia
Il dramma degli stupri in
carcere: una legge sull’affettività può limitarli.
Quello di Regina Coeli è solo
l’ultimo episodio. L’ultimo studio risale al 2010 e rileva che erano 3.000 ogni
anno. Tante le iniziative legislative, l’ultima della Conferenza dei garanti
presentata in Parlamento dal Lazio. Damiano Aliprandi su Il Dubbio il 22 aprile
2022.
Ristretto nel carcere di
Regina Coeli, secondo quanto ricostruito, un uomo di sessant’anni sarebbe
stato abusato da due giovani compagni di cella mentre tutti e tre si trovavano
isolamento in quanto positivi al Covid-19. La procura ha aperto l’inchiesta,
mentre il sindacato di polizia penitenziaria Sappe approfitta per dare la colpa
alla sorveglianza dinamica che però c’entra ben poco.
L’ultimo dato utile sugli
stupri in carcere risale al 2010
Si tratta dell’ennesimo caso
riguardante un tema poco affrontato: gli stupri in carcere. Non esistono dati
ufficiali sulla violenza sessuale dietro le sbarre, l’ultimo dato utile risale
addirittura nel 2010, ricavato da una associazione sui diritti umani che si
chiamava “EveryOne”. In quell’anno, risultata che lo stupro e la schiavitù
sessuale sono stati la concausa del 40 per cento dei suicidi in carcere. Lo
studio ha rilevato che erano 3.000 i casi di stupri in carcere ogni anno. I casi
non vengono sempre denunciati, e le strutture mediche carcerarie non sono
adibite al controllo dei sintomi come abrasioni anali o rettali. Non vengono
fatte visite specifiche. Non solo. La mancanza di educazione sessuale e
l’assenza di strumenti di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale –
in primis, i preservativi – hanno causato il proliferare di infezioni
sessualmente trasmissibili, dall’epatite all’HIV.
Ma ritornando agli stupri in
carcere, una soluzione per aiutare a limitare o a contenere i casi di stupro o
schiavitù sessuale è da ritrovarsi nella legge – mai ancora approvata – sul
diritto all’affettività in carcere. Nel 2015, grazie alla proposta di legge
presentata dal deputato del Pd Alessandro Zan sembrava fatta. Invece rimase
congelata alla Commissione Giustizia. Poi c’è stata la volta degli Stati
generali dell’esecuzione penale che, grazie al tavolo 6 coordinato da Rita
Bernardini del Partito Radicale, è stata elaborata una proposta sul
riconoscimento e all’esercizio del diritto all’affettività del detenuto.
Attenzione. La definizione è molto ampia relativamente al termine affettività:
non si tratta solo di rapporti sessuali con mogli, mariti e fidanzati, ma la
possibilità di veder rispettato il diritto alla territorializzazione della pena,
i permessi, aumentare i colloqui sia visivi che telefonici. Non è solo il sesso,
dunque, ma la necessità di garantire ai detenuti la possibilità di passare del
tempo con la famiglia come una qualsiasi persona fuori dal carcere. Ma tutto
questo non è stato poi recepito dalla riforma dell’ordinamento penitenziario,
rimasta tutto incompleta.
Il tema della sessualità,
però, è una parte importante dell’uomo e della donna, e deve essere quindi
espressa. Una legge che contempli tale diritto, potrebbe far venir meno un
elemento di tensione e quindi limitare i casi di stupro. L’ Italia, però, rimane
uno dei pochi paesi in Europa (tale diritto esiste in 31 stati su 47 componenti
del Consiglio d’Europa) che non prevede alcuna disposizione in merito
all’affettività in carcere. Eppure, ricordiamo, che c’è l’articolo 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo dove stabilisce il “diritto di
stabilire relazioni diverse con altre persone, comprese le relazioni sessuali”;
“il comportamento sessuale è considerato un aspetto intimo della vita privata”.
C’è anche il diritto di creare
una famiglia, stabilito dall’articolo 12 della stessa Convenzione. Il consiglio
dei Ministri europeo ha raccomandato agli Stati membri di permettere ai detenuti
di incontrare il/la proprio/a partner senza sorveglianza visiva durante la
visita. (Raccomandazione R (98)7, regola n. 68). Anche l’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa ha raccomandato di mettere a disposizione dei detenuti
dei luoghi per coltivare i propri affetti (Raccomandazione 1340 /1997 relativa
agli effetti della detenzione sui piani familiari e sociali). Inoltre, si è
stabilito che questi luoghi per la vita familiare debbano essere accessibili a
tutte le persone incarcerate e per tutti i tipi di visite: coniuge, figli e
tutte le persone con permesso di visita, senza alcuna discriminazione (Consiglio
d’Europa: Raccomandazione R (98)7 relativa agli aspetti etici e organizzativi
nei luoghi di detenzione Consiglio dei Ministri).
Da più di due anni c’è
l’ennesimo disegno di legge, questa volta elaborato dalla Conferenza dei Garanti
Oramai più di vent’anni fa, in
un articolo intitolato “Il sesso del prigioniero mandrillo”, Adriano Sofri
l’aveva spiegato bene che «la privazione sessuale non ha bisogno neanche di
essere presa in conto nei codici, nominata nei regolamenti, per essere imposta
come costitutiva della prigionia. Essa appartiene alla necessaria afflizione: di
più, essa è il cuore dell’afflizione. Tutto ciò ha fatto dimenticare che la
privazione sessuale è una barbarie che si aggiunge alla privazione della libertà
e al dolore: e fa apparire l’ipotesi della possibilità regolata di una relazione
sessuale come un cedimento spericolato e lussurioso fatto al piacere, cioè alla
peccaminosa superfluità, dell’animale umano in gabbia. Vi si svela il fondo
sessuofobico di ogni reclusione e di ogni castigo». Da oramai più di due anni
c’è l’ennesimo disegno di legge, questa volta elaborato dalla Conferenza dei
Garanti territoriali delle persone private della libertà. È stato sottoposto ai
consigli regionali perché lo portassero in Parlamento. Detto, fatto. L’ultima in
ordine di tempo è stata la regione Lazio. Naufragherà anche questa legge?
"Ho imparato un mestiere
grazie a un’associazione, non certo allo Stato che non esiste".
Raffaele, da rapinatore a
pizzaiolo: “Ho rivisto la luce, in carcere ci facevano fare tanti corsi, fuori
ci abbandonano”. Francesca Sabella su Il Riformista il 20 Aprile 2022.
Un figlio non voluto. Raffaele
Criscuolo nasce in una famiglia che non lo aspettava con il fiocco azzurro tra
le mani, cresce solo e ben presto l’azzurro che vede è quello del mare del golfo
di Nisida. Lui è dietro le sbarre. Rapina. Entra ed esce dal carcere. Raffaele
oggi ha 26 anni e due vite: prima e dopo Nisida.
Raffaele, tu hai conosciuto la
realtà del carcere da adolescente. Come sei finito in cella?
«Nasco ai Quartieri Spagnoli
in una famiglia che non mi voleva. Mia madre aveva già un figlio ed era
giovanissima. Mio padre non voleva assolutamente un secondo figlio, cioè non
voleva me. Loro si lasciano e lui ci abbandona. Così andammo a vivere con i
nonni materni, mia mamma non era in grado di mantenerci e garantirci un tetto
sopra la testa. Ma mentre mio fratello è sempre stato il prediletto ed erano
tutti in prima linea per lui, io mi sono sentito sempre abbandonato: ero un
figlio unico senza genitori e senza nonni. Né mia madre né i miei nonni si
accorgevano se tornavo a dormire a casa o passavo la notte in strada. La mattina
andavo a scuola e vedevo tutti i bimbi mano nella mano con i genitori e io
andavo da solo, ero sempre solo, questi eventi mi hanno segnato la vita. Tutto
nella vita si supera ma niente si cancella, ancora oggi combatto con questi
pensieri, con questi ricordi e mi chiedo il perché?»
Quel vuoto lo riempi con
“cattive amicizie” e la solitudine ti è stata quasi fatale…
«Sì, è così. Inizio a
frequentare cattive amicizie e a entrare in brutti giri già a 13 anni. Volevo
che si accorgessero di me, volevo dare un segnale per dire: ci sono anche io,
esisto. Ho scelto il modo sbagliato per dimostrare la mia esistenza: iniziai a
rubare. Iniziai a commettere i primi reati, la prima rapina la feci quasi per
gioco, poi continuai a rubare perché non volevo chiedere soldi alla mia
famiglia, mi sentivo rifiutato, abbandonato a me stesso. Non avevo nessuna
guida, ero solo».
Vieni arrestato e portato a
Nisida, mi racconti la tua esperienza nel carcere minorile?
«Pensavo solo alla mia
libertà. Da Nisida potevo vedere il mare, ma non potevo toccarlo, vedevo volare
un gabbiano ed io ero rinchiuso in una gabbia. Pensavo sempre a quello che avevo
fatto ma purtroppo quando sei in carcere pensi “non ci rientrerò mai più” ma ti
prendi in giro, appena esci ti ritrovi come prima e torni a delinquere. Perché
Nisida più che un istituto è una scuola criminale. A Nisida ho fatto altre
“brutte” amicizie, ho conosciuto persone poco raccomandabili e ho iniziato
perfino a fumare le canne, cosa che fuori non avevo mai fatto. A Nisida ci entri
per sbaglio ma esci da lì che hai una professione. Vieni promosso. Vieni assunto
in una scuola criminale, così non ho fatto altro che peggiorare».
Perché hai questa opinione del
carcere minorile?
«Perché non è normale che una
volta arrestato e portato a Nisida, hanno iniziato a farmi fare mille corsi:
corsi di ceramica, corsi per diventare pizzaiolo o barman. Perché questi corsi
non si possono fare prima? Perché non ci danno la possibilità di scegliere prima
di commettere un reato? Invece no, prima vieni arrestato e dopo ti fanno fare i
corsi e ti fanno conoscere un’alternativa. Accorgetevi prima di noi che siamo a
rischio e in difficoltà, prima che arriviamo in carcere. E invece in quartieri
degradati non c’è niente. Mancano centri sociali e culturali, ci sono le
associazioni ma è tutto un dare e avere per interesse, ci sono poche
associazioni che lo fanno con il cuore e davvero per i giovani».
Cosa è successo, invece,
quando hai lasciato il carcere di Nisida?
«Dopo un anno e qualche mese,
esco con una pena sospesa, dopo cinque mesi di libertà ero di nuovo dentro. Sono
stato arrestato di nuovo».
Perché hai commesso di nuovo
un reato?
«Perché quando sono uscito
nessuno mi ha seguito. Mi hanno preso e buttato letteralmente per strada, non
era cambiato niente, ero libero e solo, padrone di sbagliare ancora. Questa cosa
la trovo assurda, gli assistenti sociali dovrebbero seguirti anche dopo, finito
il programma carcerario se è opportuno, devono continuare a seguirti e devono
lasciarti solo quando sei una persona avviata, inserita nell’ambiente
lavorativo, quando sei arrivato a certi livelli di coscienza e di sapere, quando
sei parte integrante della società. Solo allora deve terminare il percorso
iniziato in carcere. Ma se mi porti a Nisida, mi fai fare cento corsi e poi mi
lasci solo, non cambia nulla. Io uscii un giorno prima di iniziare il corso da
barman, esco e chiedo di poterlo seguire lo stesso, mi hanno detto che non era
possibile. Così iniziai a lavorare nella pasticceria dei miei nonni, ma
continuavo a sentirmi rifiutato. Dopo qualche mese ero di nuovo in carcere».
Poi la svolta.
«Sì. Sono stato in tv, il
dottor Catello Maresca ascoltò la mia storia, mi cercò e tramite la sua
associazione mi offrì di fare un corso da pizzaiolo. Accettai. Così imparai un
lavoro, oggi faccio il pizzaiolo».
Tu sei riuscito a cambiare
strada, cosa diresti a un ragazzo che non riesce a vedere che un’altra vita è
possibile?
«Gli direi che oggi ciò che lo
nutre, lo distruggerà. Gli direi di dedicare più tempo a sé stesso, di amarsi di
più. E poi vorrei dirgli che non è vero che se nasci a Napoli non hai scelta, è
dura ed è difficile ma volendolo un’alternativa c’è. Un’altra strada è
possibile».
E allo Stato cosa diresti?
«Che la sua assenza è
fortissima, che si dovrebbe impegnare molto di più nei quartieri difficili. E
soprattutto gli direi che deve essere in grado di offrire un’alternativa ai
ragazzi che non vanno a scuola, e che non hanno un lavoro, gli direi di
sistemare le strutture sportive e i parchi, e di realizzare centri sociali e
culturali. La dispersione scolastica e la disoccupazione sono alle stelle, così
impugnare un’arma e fare una rapina diventa spesso l’unica strada per
sopravvivere».
Francesca Sabella. Nata a
Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole ha deciso, non
senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro. Giornalista
pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi protagonisti.
Storia di Flavio Patriarca,
dal carcere Beccaria alla laurea in Legge con 110 a Milano: «E ora sogno la
politica».
Federica Cavadini su Il Corriere della Sera il 30 Maggio 2022 su Il Giornale.
Mostra la foto della laurea e
inizia così a raccontare la sua storia che poi sono due e una inizia dove
finisce l’altra. La storia dell’adolescente che entra al Beccaria perché
comincia a commettere reati finché una giudice non firma un ordine di custodia
cautelare e lo ferma, e la storia del giovane neolaureato in Giurisprudenza che
ha scelto di studiare per diventare avvocato dopo il passaggio in carcere e in
comunità ed è andato spedito fino al giorno del diploma, 21 aprile,
all’università Cattolica.
Cinque anni di studi: voto 110
«Sono uscito con 110 e in
cinque anni», dice con orgoglio Flavio Patriarca, 25 anni, da una settimana
praticante in uno studio legale. Nella foto è in primo piano e con lui c’è chi
lo ha traghettato dalla prima alla seconda storia. C’è Claudia Mazzucato,
relatrice della sua tesi sulla giustizia riparativa: «L’incontro che mi ha
cambiato la vita — dice emozionato —. Con il suo supporto e la sua umanità ha
incarnato lo spirito più alto dell’insegnamento». Silvia Sacerdote, assistente
sociale: «Ha sempre avuto per me le parole giuste». Rosanna Calzolari, giudice:
«La intervistai per la tesina di maturità sulla “messa alla prova” che avevo
superato da poco». Marilena Chessa: «La giudice che mi ha seguito nel programma
fino all’estinzione del reato». E Anna Zappia: «Fu lei a firmare l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere».
La storia di Flavio Patriarca
Era il 2013. Nove anni dopo
Flavio Patriarca, che vuole diventare penalista «e sogno anche un futuro in
politica» decide di raccontare tutta la storia: «La conoscono in pochi. Qualcuno
mi giudicherà ma voglio dare speranza a chi si trova in situazioni difficili».
«Si può cambiare — ripete più volte —. Dipende dalle persone che incontri. Tante
mi hanno trasmesso fiducia e stima e c’erano tutte il giorno della laurea». È
arrivato il preside del liceo Fermi, Giuseppe d’Arrigo: «Scrisse una bella
lettera per farmi uscire dal Beccaria ed entrare in comunità e permettermi di
andare a scuola». E il responsabile della comunità Arimo, Alberto dal Pozzo:
«Sempre vicino». E l’avvocato Sergio Nesti: «È stato per me anche educatore».
«Tutti insieme — dice guardando la foto — abbiamo attuato l’articolo 27 comma 3
della Costituzione sulla funzione rieducativa della pena».
Avere 15 anni alla Barona
Il suo percorso,
dall’adolescenza nel quartiere Barona, Patriarca lo ha raccontato nelle scuole
superiori e ai detenuti di Opera. «Spiego come ci si può perdere e poi
ritrovare. Avevo 15 anni, cercavo figure e ambienti che sembravano affascinanti,
volevo soldi facili, così sono finito in carcere. Sono ripartito grazie a chi mi
ha dato fiducia. Sono cambiato, ho capito che è ingiusto creare sofferenza agli
altri». Poi la scelta di studiare legge. «Al Beccaria e in comunità ho visto
giovani con vite rovinate. Ho sentito la responsabilità di provare a cambiare le
cose e mi impegnerò per costruire un sistema giuridico migliore». Dice ancora
che il suo messaggio è anche «per chi ha un figlio, o fratello come ero io a
quindici anni»: «La famiglia mi è sempre stata vicina, senza giudicare e senza
chiedere. Zia Marcella aveva 90 anni e mi scriveva in carcere, solo parole di
conforto e nessuna domanda. Senza loro non sarei arrivato sin qui».
Quarta laurea e 110 e lode
per il salentino Giuseppe Perrone, all'ergastolo per omicidio.
Redazione online su La
Gazzetta del Mezzogiorno il 29 Maggio 2022.
Giuseppe Perrone nel giorno
della discussione della sua quarta laurea. Il 56enne di Trepuzzi, da trent'anni
in carcere, l'ha discussa all'università Tor Vergata di Roma grazie a un
permesso speciale.
Da ergastolano a dottore.
Giuseppe Perrone, 56 anni di Trepuzzi, in carcere da trent'anni con l'accusa di
omicidio, si è laureato per la quarta volta.
Il 23 maggio scorso, proprio
nel giorno della strage di Capaci, si è laureato all'università Tor Vergata di
Roma in «Editoria e comunicazione» con la tesi «Gli abissi di una pena: a
partire da Primo Levi». Un'emozione per lui. Ottenuto un permesso speciale l'ha
discussa in presenza ottenendo il massimo dei voti, 110 e lode. E per la prima
volta ha potuto avere accanto a sé la moglie.
Quello di Perrone è stato un
percorso di riscatto e riconciliazione con la vita. Arrestato nel 1993 e
condannato all’ergastolo nel 1996, per un omicidio del quale si è sempre
dichiarato innocente, Giuseppe, ritenuto vicino alla Sacra corona unita, con lo
studio ha cercato di dare un senso ai suoi giorni dietro le sbarre. Prima cinque
anni in regime di 41 bis sull'isola di Pianosa, poi il trasferimento nel carcere
di San Gimignano e la passione per il teatro e la pittura. E naturalmente lo
studio.
In carcere Giuseppe Perrone ha
conseguito il diploma di maturità commerciale, poi è arrivata la laurea in
«Istituzioni di Regia» al Dams di Bologna con una tesi dal titolo «L'impiccato
parlante», e successivamente la specializzazione in «Discipline Teatrali». Ha
sostenuto anche alcuni esami di Teologia, all'università di Parma, ma la terza
laurea è quella di Lettere e filosofia all'università di Bologna. Pochi giorni
fa quella in «Editoria», nella Capitale. Un motivo di orgoglio non solo per
Perrone e per la sua famiglia ma anche per lo stesso Ateneo che ha istituito un
programma specifico «Università in carcere» che favorisce proprio
l'avvicinamento della popolazione carceraria allo studio.
Giuseppe è il fratello minore
di Antonio Perrone, recentemente scomparso, ritenuto boss della Scu e
protagonista del film «Fine Pena Mai» di Davide Barletti e Lorenzo Conte, con
Claudio Santamaria nei panni di Antonio Perrone. Il racconto della sua vicenda è
anche un documentario, «Diario di uno scuro».
La testimonianza.
Io non sono il mio reato, non sono il male che ho fatto. Giuseppe
Perrone su Il Riformista il 15 Aprile 2022.
La mia storia detentiva è
lunga trent’anni, per questo va raccontata “bene”. Comincio dall’ultimo
capitolo, perché sia nota non più e solo la mia biografia criminale, bensì la
biografia culturale, famigliare e delle mie relazioni umane. L’identità di una
persona non è un monolite. Non siamo statue di sale, immutate e immutabili
socialmente o geneticamente. So bene che conta “chi sono stato”, ma credo valga
la pena scoprire anche chi sono diventato, e se rappresento ancora un pericolo
per la società. In fondo è questo ciò che conta. Il nostro ordinamento giuridico
è laico, non moralistico e le carceri non sono istituti di correzione. È
opportuno che uno abbia una sua moralità, ma ai fini della libertà non è la
morale a fare la differenza. Per essere arrestato devo commettere un reato, per
riottenere la libertà devo smettere di commettere reati. Bene! Io non commetto
reati da trent’anni. Ho sradicato ogni rapporto con gli ambienti criminali. Non
mi passa per l’anticamera del cervello riprendere l’attività delinquenziale. E
ripudio ogni forma di violenza in piena sintonia con lo spirito dei
laboratori Spes contra Spem di Nessuno tocchi Caino.
È da qui che inizia la mia
nuova vita: dalla nonviolenza, dalla legalità, dalla cultura. Nel dicembre 2021,
Castelvecchi ha pubblicato un mio romanzo, Sofia aveva lunghi capelli. Per il
critico Filippo La Porta è “scritto in una lingua tesa, vibrante, sia riflessiva
che fortemente narrativa”. Andrebbe letto per capire che la sofferenza è il
viatico molecolare della resipiscenza. Scrivere è la mia passione. La
pubblicazione di un libro è un fatto culturale, legale e sociale importante che
andrebbe forse considerato nelle decisioni inerenti al mio destino. Alla
scrittura unisco la creatività. Ho ideato due giochi di società, non ancora
pubblici. Ho quattro lauree e sono titolare di borse di studio. Dal carcere,
essere l’82° in graduatoria nell’Ateneo bolognese non è scontato. È frutto della
tenacia con cui mi sono dedicato allo studio: otto, dieci, dodici ore al giorno
indicano un isolamento detentivo volontario. Ho praticamente consumato il culo
sullo sgabello dell’amministrazione, consapevole che la cultura mi avrebbe
liberato dalla croce della pena, anche fisica, e mi avrebbe risvegliato la
mente… assopita dal male di pensieri e azioni non “banali”.
Dopo la prima laurea, nel
2007, al DAMS di Bologna, l’Alleanza Assicurazioni mi offrì un lavoro, ma allora
non mi si volle dare fiducia. Nel 2009, per la seconda laurea, il magistrato di
sorveglianza di Parma mi ha concesso un permesso di necessità di due giorni,
libero nella persona e affidato a Don Umberto Cocconi. Scaduto il permesso, sono
rientrato in carcere. Quel permesso non è caduto dal cielo. La manna, nella mia
riabilitazione, non è mai esistita. Proprio come Adamo, per aver “peccato”, ogni
frutto mi è costato sacrificio. Il parere favorevole a esperienze di permesso
premio non è stato improvvisato. Prima di esprimersi, il carcere mi ha assegnato
per un anno alle cure della criminologa. Adesso sto a Rebibbia. Nonostante siano
passati trent’anni, ho una moglie che mi ama e siamo genitori di un bambino che
non abbraccio dall’inizio della pandemia. Quanta sofferenza in questa assenza.
Con Sonia abbiamo deciso di non far entrare più in carcere il bambino, sperando
in un beneficio che invece mi è stato negato, malgrado l’ottimo percorso
rieducativo. Il 23 marzo scorso, la direttrice Rosella Santoro aveva proposto
che io presenziassi a un evento all’Università di Tor Vergata, ateneo nel quale
mi sono laureato. Il magistrato di sorveglianza ha prima approvato la proposta,
poi ha cambiato idea. Saputo dell’approvazione, Sonia ha preso le ferie, ha
comprato i biglietti del treno Lecce-Roma, ha prenotato l’albergo e “preparato”
il bambino dicendogli che “sarebbero andati da papà”. Col diniego tutto è
svanito. Inevitabile il danno affettivo del bambino, non dico di mia moglie.
Ho scontato 40 anni tra
liberazione anticipata e indulto. Nel mio curriculum universitario si contano 80
esami e uno splendido rapporto umano con professori e tutor. In quello teatrale
molti spettacoli e la partecipazione al film Rebibbia Lockdown di Fabio
Cavalli. Ho seguito un corso di giornalismo. Ho partecipato al laboratorio di
pratica filosofica. Sono autore con altri delle seguenti opere: La ferita della
pena e la sua cura; Naufraghi in cerca di una stella; Parola e rappresentazione
nel teatro antico; Il Senso della Pena. È vero che ho l’ergastolo e che alla
collaborazione esteriore con la giustizia ho preferito la strada lunga del
cambiamento interiore. Questa categoria del cambiamento dà frutti che non si
possono raccogliere né subito né dopo, giacché il cambiamento è un processo
inarrestabile che non finisce mai. Ho commesso reato, ma io non sono il mio
reato. Ho fatto del male, ma io non sono il male. Giuseppe Perrone
Ergastolano ottiene la
quarta laurea in trent'anni di reclusione. Permesso speciale per discutere la
tesi a Tor Vergata.
Biagio Valerio su La Repubblica il 28 Maggio 2022.
Giuseppe Perrone protagonista
negli anni '80 dell'ascesa della Sacra Corona in Salento, si è laureato in
Editoria e Comunicazione. La tesi? “Gli abissi di una pena a partire da Primo
Levi" e gli è valsa il massimo dei voti.
Entra in carcere da
ergastolano ma se ne uscirà, prima o poi, sarà da umanista e letterato. Giuseppe
Perrone, da trent’anni rinchiuso in una cella, consegue la quarta laurea. Questa
volta in presenza, nell’ateneo di Tor Vergata, grazie ad un permesso speciale
per discutere la tesi che è stato rilasciato per la prima volta in assoluto
nell'ateneo romano.
Perrone, che oggi ha 56 anni,
è originario di Trepuzzi, grosso centro del nord di Lecce, e come diversi suoi
conterranei si trovò ad essere protagonista, negli anni Ottanta, nel turbine che
portò ad affermarsi la cosiddetta “quarta mafia”, la Sacra corona unita.
È la prima volta che viene
rilasciato un permesso per una discussione di laurea.
In carcere da 30 anni,
Giuseppe si laurea nelle aule della Facoltà: la tesi dal titolo “Gli abissi
della pena”. Elena Del Mastro su Il Riformista il 23 Maggio 2022.
“Giuseppe Perrone da
trent’anni in carcere, proprio nel giorno della strage di Capaci ottiene il
permesso per discutere la sua tesi di laurea magistrale nel nostro Ateneo in
Scienze della informazione, della comunicazione della editoria. È il momento
della riconciliazione attraverso lo studio e la cultura. Questa è la parola
chiave del lavoro di tesi.”. Così Fabio Pierangeli, associato di Letteratura
italiana e Letteratura di viaggio contemporanea della Facoltà di Lettere a “Tor
Vergata” ha raccontato la straordinaria storia di riscatto di un detenuto di
Rebibbia che finalmente corona un sogno: la laurea.
Giuseppe si laurea il 24
maggio alle ore 15 con una tesi di laurea magistrale in Editoria dal titolo “Gli
abissi della pena. A partire da Primo Levi”. Ha studiato sodo mentre era in
cella grazie al progetto di “Tor Vergata” “Università in carcere”. L’attività
formativa predisposta dall’Ateneo di Roma “Tor Vergata” all’interno della Casa
Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, da oltre un decennio, va oltre la
sola presenza all’interno del carcere: rende accessibile alle persone recluse
un’offerta formativa universitaria e necessariamente apre un dibattito su
questioni di ordine sociale, che vanno oltre la didattica. Interrogativi sul
diritto allo studio, e di conseguenza sul diritto al lavoro.
La sua seduta di laurea
avverrà nella sede dell’ateneo romano. Giuseppe infatti ha eccezionalmente
ottenuto il permesso di discutere la tesi alla Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Roma “Tor Vergata”. È un evento importante per l’ateneo, da
momento che è la prima volta che viene rilasciato un permesso per una
discussione di laurea presso l’università.
“Attraverso grandi pagine
della letteratura, con un focus importante, su Primo Levi- ha detto il relatore
Pierangeli, intervistato dall’Ansa – la tesi ricostruisce la metafora della
detenzione. Ma non sono solo parole: Giuseppe Perrone, anche attraverso alcune
poesie, ricostruisce la sua esperienza detentiva con profondità e ironia“.
Elena Del Mastro. Laureata in
Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di
Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie
delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.
Dal 41bis al 110 e lode: il traguardo di
Alessio dopo un percorso ad ostacoli. Veronica
Manca su Il Riformista il 20 Maggio 2022.
Nessuno tocchi Caino, con il suo viaggio della
speranza senza fine, ha appena fatto il giro delle carceri sarde. Per la prima
volta dopo tanti anni è stato consentito di visitare anche le sezioni del 41-bis
a Bancali e Badu e Carros. Un segno tangibile del corso che il Presidente Carlo
Renoldi intende seguire nella amministrazione penitenziaria e del “carcere duro”
dove nonostante tutto il cambiamento è possibile.
L’inferno dei regimi differenziati è il titolo del
libro di Alessio, un detenuto al 41-bis, da oltre vent’anni, che lo scorso 10
maggio si è laureato in giurisprudenza, in diritto penitenziario, con una tesi
dal titolo “I regimi differenziati nel sistema penitenziario”, ottenendo il
massimo dei voti e la lode. Il merito è sicuramente dovuto alla straordinaria
competenza e professionalità con cui il Polo Universitario Penitenziario
dell’Università degli Studi di Sassari affianca gli studenti detenuti, anche
quelli sottoposti al regime del 41-bis, con infinite e rigidissime preclusioni
e, appunto, differenziazioni, come dice Alessio, all’esercizio del diritto allo
studio. Una tra tutte, la gestione della seduta di laurea, il coronamento del
percorso di studi.
La relatrice, la Prof.ssa Paola Sechi e tutta la
commissione, istituita regolarmente, per la seduta di laurea, hanno dovuto
assistere alla discussione in videocollegamento dal carcere di Bancali-Sassari,
con il laureando invece presente nel diverso carcere di Milano-Opera. L’impegno
del PUP e di tutti gli operatori penitenziari ha consentito il regolare
svolgimento degli esami finali e della seduta di laurea: una impresa non facile
dato che il detenuto, durante la sua espiazione pena al 41-bis e specie negli
ultimi mesi, aveva subito diversi trasferimenti:
dalla Sardegna a Parma, a Rebibbia, a Spoleto, a Novara, fino a Milano-Opera.
Come racconta Maria Teresa Pintus, suo difensore e
anche consigliera di Nessuno tocchi Caino, la storia di Alessio mette in luce
tutte le difficoltà di gestione dei più elementari diritti delle persone
ristrette al regime del 41-bis. Al detenuto non è consentito infatti avere
diretto accesso con terze persone, siano esse anche tutor o docenti
universitari. L’unico contatto consentito, che peraltro si svolge con le stesse
modalità di incontro con i familiari (vetro divisorio a tutta altezza e
citofono), è previsto in concomitanza degli esami finali e nelle discussioni,
tutti momenti sempre vissuti rigorosamente in videocollegamento. Durante tutto
il percorso di studi, quindi, il detenuto è lasciato a sé, privato di qualsiasi
possibilità di un confronto con i propri docenti.
Allo stesso modo, per i libri e il materiale
didattico: l’Avvocata Pintus evidenzia tutte le difficoltà di accesso di libri
di testo e la preclusione di ingresso di materiale digitale, oltre all’assenza
di supporti economici per l’acquisto – sempre e comunque per il tramite
dell’Amministrazione penitenziaria – di libri e materiali. Nel caso di Alessio,
anche grazie all’impegno dei docenti e del legale, si sono forniti
gratuitamente, in comodato d’uso, tutti i materiali per gli esami, previa
autorizzazione e controllo da parte della Direzione del carcere. Un vero e
proprio percorso a ostacoli che, tuttavia, non ha impedito con determinatezza,
professionalità e negli stretti limiti consentiti dalla legge, di perseguire, in
cooperazione con l’Amministrazione penitenziaria, l’obiettivo dell’effettività
del diritto allo studio. Veronica Manca
La scomparsa dell'attore e
l'eredità che lascia. La lezione di Cosimo Rega, l’ex camorrista rinato in
carcere: “La ricerca della libertà ci rende liberi”.
Viviana Lanza su Il Riformista
il 2 Settembre 2022
«Ho capito che non esiste la
libertà. Esiste la ricerca della libertà e questa ricerca ci rende liberi». Era
la frase che amava ripetere nei suoi tour nelle scuole, ai dibattiti, durante
ogni sua testimonianza. Cosimo Rega, ex camorrista, ex detenuto, ex ergastolano
e attore, era l’esempio di come il carcere debba servire a riabilitare chi ha
commesso un reato, non a sottoporlo a una reclusione fine a sé stessa quando non
diventa addirittura inumana e degradante. Cosimo Rega è morto il 30 agosto.
Aveva 69 anni e un passato che racchiudeva in sé più di una vita.
«Ho studiato, ho scritto, ho
tradotto in napoletano Shakespeare e recitato. Ho portato sulle tavole del
palcoscenico Eduardo De Filippo, Danti e tanti altri ancora. Ho avuto la fortuna
e l’onore di far parte del cast di “Cesare deve morire” dei fratelli Taviani.
Ero Cassio. L’arte, la cultura, l’amore dei miei, il dialogo con le istituzioni
hanno completamente cambiato e schiarito i miei orizzonti. Ho la consapevolezza
di cosa è il male, e di quello che ho inflitto», diceva. La sua storia ha
colpito il magistrato Tullio Morello, attuale coordinatore del settore penale
del Tribunale di Napoli. «Rega è morto da uomo libero e soprattutto rieducato.
Una testimonianza (certamente rara) di quello che prevede la Costituzione sulla
rieducazione dei condannati», commenta il giudice sulla sua pagina social.
Al Riformista spiega: «Purtroppo il mondo del carcere interessa a pochi. Io l’ho
conosciuto avendo iniziato la mia carriera da magistrato di Sorveglianza».
Funzione rieducativa della
pena. «Quando lo Stato fa qualcosa in questa direzione i risultati ci sono –
aggiunge Morello – Occorrono risorse per farlo e investimenti di tempo e di
uomini». Originario di Angri, Rega trascorse l’ultimo periodo di reclusione nel
carcere romano di Rebibbia e il teatro fu per lui la mappa verso il
riscatto. «Non posso dimenticare – diceva di sé – di essere stato un camorrista.
Oggi, guardandomi indietro, vorrei prendere quel ragazzo e dirgli di fermarsi ma
non posso. E oggi è giusto che conviva con il rimorso delle mie azioni». Un
rimorso trasformato in impegno, grazie a un percorso in carcere che è stato
diverso da quello che viene invece riservato ai più. Un percorso di reale
responsabilizzazione, di riscatto, di riabilitazione.
«La sua – dicono i referenti
di Antigone – è stata una grande storia di emancipazione dalla criminalità e dal
carcere. Lui è l’esempio che la cultura, il teatro sono più forti della camorra.
In suo nome lotteremo perché sia sempre garantita a tutti una chance di recupero
sociale». Attualmente solo il 33,61% dei detenuti è impegnato in attività
lavorative e per attività che ammontano a circa 85 giorni all’anno per ciascun
detenuto. Anche studio e percorsi di formazione non riescono a coinvolgere tutta
la popolazione detenuta ma soltanto una minima parte con il risultato che, per
la maggior parte del giorno, i detenuti ciondolano tra i corridoi e le celle in
un ozio forzato che alimenta depressioni e violenza.
Il numero di suicidi, in
questi primi otto mesi dell’anno, è stato impressionantemente alto (57 casi) e
se si considerano anche le centinaia di atti di autolesionismo sventati nelle
carceri è chiaro che la vita dietro le sbarre è più un inferno che un luogo di
rieducazione. E tutto questo, in barba alla Costituzione che invece invita a
puntare sulla risocializzazione, attribuendo alla condanna un valore non
vendicativo ed esclusivamente punitivo e immaginando (con una convinzione che
il populismo giustizialista di questi ultimi decenni ha scardinato generando
soltanto altra violenza e nuovi drammi) che un detenuto possa diventare altro
rispetto a quello che era quando ha commesso il reato per il quale c’è stata la
condanna. Risultato: abbiamo carceri ridotte a discariche sociali e celle piene
di detenuti presunti innocenti e che ancora attendono un processo.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Viaggio tra luci e ombre
nel sistema giudiziario e penitenziario militare.
L’unico istituto è a Santa
Maria Capua Vetere ed è un carcere modello con un numero esiguo di ristretti. Ma
pesa il conflitto tra giurisdizione Militare e Ordinaria e la mancanza di una
riforma. Damiano Aliprandi Il Dubbio il 10 aprile 2022.
Ha un elevatissimo standard
delle condizioni di detenzione, è una struttura considerata di assoluta
eccellenza dal punto di vista delle condizioni sanitarie, infrastrutturali e per
l’elevato livello tecnologico. Da poco, i due carabinieri condannati dalla
Cassazione a 12 anni per l’omicidio di Stefano Cucchi, hanno varcato la soglia
di questo carcere modello: il penitenziario militare di Santa Maria Capua
Vetere.
Parliamo di una struttura che
fa parte della giustizia militare. Si tratta di un sistema penitenziario e
giudiziario parallelo. Ha il suo carcere, la sua amministrazione penitenziaria,
i suoi tribunali, magistrati e Consiglio superiore della magistratura
annesso. Ad occuparsi di tutta l’organizzazione non è però il ministro della
Giustizia ma quello della Difesa.
L’Organizzazione Penitenziaria
Militare (Opm), gestisce l’amministrazione
Come ogni sistema
penitenziario si rispetti, anche quello militare ha il suo Dap. Però si chiama
diversamente: Opm e sta per Organizzazione Penitenziaria Militare. Quest’ultima
è inquadrata nell’Organizzazione di Vertice della Forza Armata, e rappresenta
l’unica realtà del genere in tutto il territorio nazionale ed europeo, con
competenze interforze e molteplici relazioni interministeriali, che assolve il
delicatissimo compito di assicurare la detenzione del personale militare e di
quello appartenente ai Corpi Armati dello Stato a disposizione dell’Autorità
Giudiziaria Militare e di quella Ordinaria.
La ragione di tale particolare
collocazione organica è da individuare nell’eccezionalità e assoluta unicità
delle funzioni svolte dall’Organizzazione che può essere definito l’Organo di
vertice nella gestione del trattamento penitenziario e dei detenuti ristretti
presso gli Istituti penitenziari militari. Il 5 giugno 2008 lo Stato Maggiore
dell’Esercito ha istituito il distintivo di appartenenza per il personale
effettivo all’Organizzazione Penitenziaria Militare. A forma di scudo sannitico
ha il bordo dorato su fondo bianco e una banda rossa nel mezzo quali colori
tradizionali della Regione Campania. In cuore alla banda rossa è inserita
l’Aquila color oro quale simbolo di appartenenza allo Stato Maggiore
dell’Esercito.
L’unico carcere militare è a
Santa Maria Capua Vetere
Oggi ne esiste solo uno di
istituto di pena militare e si trova in Santa Maria Capua Vetere, provincia di
Caserta. Fino al 2005 esistevano diverse carceri militari. Si trovavano a Gaeta,
Pescheria del Garda, Forte Boccea, Cagliari, Sora, Palermo, Bari, Torino e
Pizzighettone. A dispetto di tutti gli altri istituti penitenziari ordinari,
quello militare risulta un carcere modello e ha un numero esiguo di ristretti.
Molto al di sotto della capienza regolamentare.
I detenuti sono pochi perché
le sentenze sono diminuite grazie all’abolizione, dal 2005, della leva
obbligatoria nell’esercito, che ha drasticamente abbattuto i reati militari un
tempo più diffusi, dalla diserzione alla mancanza alla chiamata.
Il carcere militare può essere
posto ad esempio: ha un elevatissimo standard delle condizioni di detenzione, è
una struttura considerata di assoluta eccellenza dal punto di vista delle
condizioni sanitarie, infrastrutturali e per l’elevato livello tecnologico. Di
detenuti militari ce ne sono pochi, paradossalmente la maggior parte sono
poliziotti e carabinieri. Parliamo di un carcere dove non esiste un clima di
distacco che solitamente avviene nei penitenziari italiani “civili”: pur nel
rispetto dei ruoli, il comandante fa anche da padre, consigliere, a volte amico.
Si lavora, esiste la possibilità di coltivare, partecipare a laboratori di
cucina e falegnameria. La riabilitazione funziona.
Il garante campano
Ciambriello: «Una struttura a misura d’uomo»
A confermarlo è stato il
garante regionale Samuele Ciambriello che vi ha fatto visita l’anno scorso.
Accompagnato dal tenente colonnello Rosario del Prete, comandante/ direttore del
carcere ha visitato le celle (singole, doppie o triple) con bagni dotati di
doccia, la mensa collettiva e i vari laboratori di bricolage, pittura,
ceramica. «Ho trovato una struttura a misura d’uomo, nella quale le persone
“diversamente libere” vivono la privazione della libertà nel rispetto della
dignità umana, sia negli spazi (singoli e comuni), che sono funzionali al
trattamento, alla rieducazione e al rispetto delle norme di sicurezza. Ho potuto
visitare l’area verde, che consente ai detenuti di svolgere attività di
giardinaggio, una palestra, la sala colloqui, che è un ambiente familiare e
confortevole», ha raccontato Ciambriello.
Almeno nel momento della
visita c’erano 52 persone ex appartenenti alle Forze armate che scontano pene
detentive a seguito di condanne per reati propri e comuni. «Parliamo di un
carcere – come conferma anche il garante regionale – dove non esiste un clima di
distacco che solitamente avviene nei penitenziari italiani “civili”», ha
confermato il Garante. Nel passato, più volte si è detto di sopprimerlo, ma
forse, viste le gravi criticità degli istituti penitenziari, bisognerebbe
estenderlo e replicarlo anche ai “civili”.
Da anni la giustizia militare
attende una riforma
Ma ritornando, più in generale
alla giustizia militare in tempo di pace, bisogna ricordare che da molti anni
attende di essere riformata. Correva l’anno 2013 quando l’allora ministro della
Difesa Mario Mauro si impegnava di fonte all’apposita commissione della Camera a
mettere mano alla giustizia militare, organo a parte della magistratura italiana
con un’attività di lavoro irrisoria e impossibile da scalfire, ma con un peso
non indifferente sui conti dello Stato.
Parliamo di un totale di 58
magistrati, tra giudicanti e inquirenti, con uno stipendio medio di 150mila
euro, che in totale ci costano 20 milioni di euro all’anno. Hanno un loro organo
di autocontrollo, il Consiglio della magistratura militare (Cmm) equivalente del
Consiglio superiore della magistratura (Csm). Il Cmm è, infatti, competente a
deliberare su ogni provvedimento di stato riguardante i magistrati militari e su
ogni altra materia ad esso devoluta dalla legge.
Il doppio binario: la
giustizia ordinaria e quella militare
La giustizia militare risulta
iper efficiente semplicemente perché la mole di lavoro è bassissima. In sostanza
è una grande macchina, con posti d’oro, ma con pochi oneri per chi vi opera. Dai
dati emerge che la produttività nell’ambito della giurisdizione militare è al
limite dell’insignificanza statistica per la pochezza numerica e qualitativa del
contenzioso penale.
Per questo c’è necessità di
una riforma che però è rimasta nel limbo. Sono due le scuole di pensiero che si
scontrano: una ritiene che la magistratura militare abbia esaurito la sua
funzione e debba essere soppressa e assorbita dentro i ranghi della magistratura
ordinaria perennemente sotto organico, magari in una sezione specializzata;
l’altra è quella di non sopprimerla, ma di aumentare la rosa di reati su cui
hanno competenza, sgravando in questo modo gli ordinari di una parte – seppur
minima – del contenzioso di cui sono carichi.
A questo si aggiunge un altro
problema. Facciamo l’esempio di Walter Biot, Capitano di Fregata della Marina
Militare italiana. Le accuse contro l’Ufficiale sarebbero quelle di spionaggio
per aver ceduto, in cambio di denaro, documenti riservati a un militare Russo.
La prima udienza sarà innanzi al Tribunale Militare di Roma. I legali di Biot
hanno sollevato il tema del conflitto tra giurisdizione Militare e quella
Ordinaria; condizione questa, che allo scopo di ottenere una pronuncia
definitiva, li ha indotti ad interessare la Corte di Cassazione.
Cosa significa? Il personale
con le stellette, come ha affermato ultimamente anche il Procuratore Generale
Militare, si trova ad affrontare doppie spese legali poiché, la stragrande
maggioranza delle violazioni, a causa di una confusione stratificata di regole,
approda sia alla Procura Ordinaria, sia a quella Militare.
Racconti dal carcere. Lo
studio, il teatro, i libri: non sono quello di 30 anni fa.
Filippo Rigano su Il
Riformista l'8 Aprile 2022.
Sono stato tratto in arresto
nel lontano 1993 e condannato in via definitiva alla pena dell’ergastolo di tipo
ostativo per reati di criminalità organizzata. Pertanto, sono detenuto
ininterrottamente da quasi 29 anni. Al momento dell’arresto avevo lasciato a
casa una moglie e due figlie ancora bambine. Pensando proprio a loro, ho
incominciato a riflettere sul mio passato e sul mio futuro e, dopo alcuni anni,
ho deciso di dare una svolta alla mia vita. Ho sentito dentro di me che quel
malefico passato altro non era stato che fumo, null’altro che una notte buia e
triste. Ho compreso che se volevo veramente cambiare, per prima cosa, dovevo
trovare la forza e il coraggio di uscire da quella spirale di violenza figlia
snaturata dell’ignoranza beata navigante in questa palude infetta e malefica che
è il carcere. Attraverso una profonda e dolorosa introspezione, mi sono reso
conto che la vera libertà consiste nell’obbedire alle leggi che ci siamo dati.
Non mi vergogno di dire che
quando 29 anni fa ho varcato le porte del carcere, come titolo di studio avevo
solo la seconda elementare, sapevo a malapena leggere e scrivere.
Nel carcere di Catania Bicocca, ho incominciato a frequentare la scuola e,
giorno dopo giorno, sono arrivato a conseguire la licenza di terza media.
Nel carcere di Fossombrone, dopo cinque anni di scuola superiore mi sono
diplomato come ragioniere. Nel 2011 sono stato trasferito
nel carcere di Rebibbia e mi sono iscritto alla facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Tor Vergata. Il 23 ottobre 2019, a 63 anni, sono diventato
dottore in legge nella sala teatro del carcere di Rebibbia, davanti ai miei
professori, ai compagni di sventura dell’Alta Sicurezza, a mia moglie Giuseppina
che da 29 anni aspetta il mio ritorno a casa e davanti a Venera e Cristina, le
mie adorate figlie che sono state la mia forza per andare avanti. Con una tesi
di laurea in Diritto costituzionale dal titolo “Sopra la Costituzione…
l’ergastolo ostativo: per chi ha sete di diritti”, ho preso 110 e anche una
“lode” che considero il mio personale riscatto dall’infamia del “fine pena mai”
che mi aveva tolto il sonno e cancellato il futuro.
Oltre all’università, per
cinque anni ho frequentato insieme ad altre persone detenute un corso di pratica
filosofica dal quale è nato il libro Naufraghi in cerca di una stella, un
profondo lavoro di scavo interiore che ha fatto emergere il mio essere autentico
seppellito sotto le macerie della mia prima vita. Ho frequentato anche un corso
di giornalismo e da sette anni sono attore di teatro nella compagnia di Fabio
Cavalli, che ha realizzato Rebibbia Lockdown, un film documentario che racconta
il carcere ai tempi della pandemia. Da ultimo, ho dato il mio contributo alla
stesura di un altro libro, La ferita della pena e la sua cura, pubblicato di
recente. Ho completato gli studi e portato avanti la mia revisione interiore.
Così, in questi anni passati in carcere in cui mi sono abbeverato e nutrito di
cultura, ho conquistato la mia personale “liberazione”. E, vi assicuro, non è
stato facile nella prospettiva di una pena che non finisce mai. Se penso alla
mia vita passata in “libertà”, neanche con la fantasia più felice avrei potuto
mai immaginare un futuro come quello che vedo oggi, che è di una luce e uno
splendore indicibili.
Nessun uomo è uguale a quello
di venti o trent’anni prima, perciò è doveroso che il giudizio su di lui sia
oggi diverso. Si dice: tanto questi non cambiano mai, sempre delinquenti sono.
Non è vero, anche la scienza dice che il tempo è un grande scultore, che il
cervello si evolve e le persone cambiano. Io non ho nessun contatto con nessuna
criminalità, ho avuto il coraggio di recidermi totalmente dalle logiche di un
passato maledetto. Sarebbe bello e giusto ascoltarci, perché se nessuno ci
ascolta si può pensare che siamo sempre quelli del passato. Mi rivolgo
soprattutto ai nostri giudici di sorveglianza: non siate sempre ancorati al
passato della persona, guardate alla persona quale essa è oggi, abbiate il
coraggio di metterci alla prova.
Io non sono più un ragazzino,
ho compiuto da poco 65 anni, la mia vita sta finendo. Ma qui si pena sempre e
non si vede mai uno sbocco di libertà. Perciò ascoltateci, solo cosi potete
capire il nostro cambiamento, come hanno fatto in questi anni tutti gli
operatori dell’area educativa, i nostri professori e le nostre tutor di Tor
Vergata. Un aiuto non si nega a nessuno, specialmente quando uno ha capito gli
errori del passato e dal male si è convertito al bene. Io, personalmente,
ringrazio tutte quelle persone che mi hanno aiutato e che continuano a darmi
fiducia, una fiducia che – vi prometto – non deluderò.
Filippo Rigano. Ergastolano,
detenuto a Rebibbia
Il pentito: “Nel carcere di
Bari entra tutto, i parenti portano fumo e telefoni”.
Giampiero Casoni il 10/04/2022
su Notizie.it.
Il verbale di un collaboratore
di giustizia coincide con le deduzioni della Dia: “Nel carcere di Bari entra
tutto, i parenti portano fumo e telefoni”.
Il pentito Domenico Milella:
“Nel carcere di Bari entra tutto, i parenti portano fumo e telefoni”. Le
dichiarazioni del collaboratore di giustizia schiudono un mondo già
attenzionato dall’Antimafia nella sua relazione annuale sulla malavita
organizzata in Italia. Il 38enne Milella, arrestato nel 2018 e diventato poi
collaboratore della magistratura, è stato indicato come braccio destro del boss
japigiano Eugenio Palermiti.
Ed è proprio Milella a
denunciare una situazione che, per il teatro specifico a cui è riferita, ha
dell’inverosimile.
“Nel carcere di Bari entra
tutto”
Ha detto l’uomo: “In
carcere entrano telefoni e fumo, cocaina poca. A Bari di fumo ce n’era una
valanga e pure i cellulari li avevano in tanti. Io penso che il 30% dei
detenuti ce li ha”. Poi Milella dà una spiegazione a quella inverosimile
permeabilità: “Per quel che mi risulta sia la droga che i telefoni non li
portano gli agenti ma i familiari che vanno ai colloqui.
Al di là degli episodi
specifici Milella ha confermato un teorema: a suo avviso la criminalità
organizzata è riuscita a portare riti e protocolli delle “male” all’interno del
carcere di Bari e di altri istituti. E con essi le specifiche gerarchie dei
clan, che nell’ambiante carcerario vengono poi accentuate dal regime del
detenzione.
La relazione annuale della Dia
E questa realtà appare anche
sottolineata dalla Direzione investigativa antimafia nella relazione sul 2021:
“I clan hanno la consolidata prassi di effettuare affiliazioni e innalzamenti di
grado perfino all’interno degli ambienti penitenziari, dove svolgono
un’instancabile attività di proselitismo soprattutto nei confronti delle giovani
generazioni“.
E in tema di pervasività delle
male negli istituti penitenziari italiani il racconto che Milella, depositato
agli atti di un processo in corso dopo un interrogatorio del 2020, è
dettagliato. Lo è perché Milella vi cita anche circostanze relative alla sua
permanenza negli istituti di Taranto, Roma, Pescara.
Questa
ingiustizia non può passare inosservata. Luigi Melino, l’ex detenuto modello
arrestato perché suoi social denunciava le violenze in carcere: “E’
diffamazione…”
Umberto Baccolo su Il Riformista l'1
Aprile 2022.
Quando arrivò
il Covid nelle carceri e Rita Bernardini iniziò il primo di una serie di
scioperi della fame per chiedere un atto di clemenza, a sostegno della sua
iniziativa, con Elisa Torresin creammo un programma su Facebook. In diretta
tutte le sere per un anno, abbiamo dato voce a ex detenuti, familiari, avvocati,
cappellani, agenti della penitenziaria, volontari… Ci contattò anche Luigi
Melino di Foggia. Era stato appena scarcerato e affidato in prova ai servizi
sociali. Detenuto modello, autore di poesie, innamoratissimo della moglie
Carmela, nonviolento, animo sensibile, aveva capito i suoi errori e voleva
rifarsi una vita.
Luigi, però,
aveva un “problema”: voleva sensibilizzare sul tema carcere, denunciare
ingiustizie e violenze che aveva visto o subito. Lui era a Foggia quando ci fu
la rivolta i primi di marzo del 2020 e, a suo dire, anche lì ci fu una
spedizione punitiva come quella di Santa Maria Capua Vetere con
cui Foggia condivideva la direttrice. Luigi ci raccontò come andarono le cose:
non aveva prove, aveva paura a parlare, ma era molto credibile. Poi scoppiò il
caso del carcere campano, uscirono i video, le testimonianze e, sorpresa, era
tutto esattamente uguale a quello che Luigi ci aveva privatamente descritto
molto prima che fosse di dominio pubblico. Fino a quel momento Luigi si era
“trattenuto”: aveva partecipato al nostro programma, alla tombola di capodanno
di beneficienza per i detenuti, a tutti i digiuni a staffetta che coordinavamo a
supporto di Rita Bernardini. Ogni volta che qualche parente di detenuto gli
parlava di un abuso, lui lo metteva in contatto con noi. Il lavoro umile che
faceva grazie ai servizi sociali lo teneva in indigenza economica, il suo
impegno però era pieno di cuore ed esemplare il suo percorso di reinserimento e
di aiuto al prossimo.
Sembrerebbe una
storia a lieto fine, ma non lo è. Pochi giorni fa Luigi è stato arrestato, ha
perso il suo affidamento in prova per un motivo assurdo. Gli hanno contestato
reati come diffamazione e istigazione a delinquere, che sarebbero stati
consumati tramite video sui social nei quali faceva solo quello che noi facciamo
sempre, cioè denunciare gli abusi sui detenuti, invitare al rispetto della
Costituzione! Perché, dopo Santa Maria Capua, Luigi non si è più trattenuto, e
in un paio di video su tiktok ha raccontato le botte che pure lui ha preso
dai GOM a Foggia. Ho paura, diceva, temo ripercussioni, ma qualcuno lo deve
fare, se no, queste cose non smetteranno. Questa, quindi, sarebbe la
diffamazione: raccontare le violenze subite perché altri non le subiscano più. E
l’istigazione a delinquere? Ancora più assurdo: Luigi avrebbe usato i social per
chiedere ai detenuti che subivano abusi di denunciarli alla giustizia, per
invitare i loro familiari ad aderire agli scioperi della fame di Rita. Stava
anche provando a organizzare una manifestazione pacifica per i diritti dei
detenuti. Le cose che fa chi si occupa di carcere.
Ma noi possiamo,
anche se diamo fastidio: siamo incensurati, politici, giornalisti, avvocati,
persone perbene. Lui non può: è un detenuto, e deve stare zitto. Non si deve
permettere. Il primo giudice al quale fu portata la richiesta di carcerazione
fatta dalla direttrice del carcere di Foggia, letta la memoria difensiva
dell’avvocato Michele Sodrio, disse che non si ravvisava nessun reato, che il
comportamento di Luigi stava dentro il legittimo diritto di critica. Peccato che
l’incartamento sia poi passato a un collega, che invece ha deciso l’arresto di
una persona che sul lavoro era stimata, che si stava rifacendo una vita onesta e
aveva in programma un figlio con la sua Carmela. Questa ingiustizia non può
passare inosservata, perché se Luigi deve stare in carcere per aver denunciato
le condizioni inumane dei detenuti e invitato al rispetto della Costituzione e
alla partecipazione a iniziative nonviolente, allora in carcere dobbiamo starci
tutti noi. Umberto Baccolo
Processo “Cella zero”,
prescrizione sempre più vicina: così muore la verità sulle umiliazioni in
carcere.
Viviana Lanza su Il Riformista il 13 Maggio 2022.
Dieci anni di indagini e
processo non saranno sufficienti per avere una risposta dalla giustizia. Cosa
realmente accadeva nella famigerata cella
zero del carcere di Poggioreale rischia di rimanere per sempre in bilico tra due
verità: quella dei detenuti che denunciarono le umiliazioni, le botte e le
punizioni subite in quella stanza al piano terra del più grande penitenziario di
Napoli e d’Italia e quella degli agenti accusati di aver commesso quelle
violenze che hanno negato ogni cosa. Si rischia di non avere alcuna verità
processuale, nessuna risposta dalla giustizia se non quella del tipo: ci
dispiace, il processo è durato troppo, i reati sono prescritti. Sì, per ora tre
su cinque sono prescritti. Che le lungaggini eccessive del dibattimento
potessero affossare questo processo era evidente già dallo scorso anno.
Inizialmente era sembrato che
si potesse imprimere un’accelerazione per vincere la corsa contro il tempo.
Illusione. Più della metà dei reati al centro del processo, e relativi ai
presunti maltrattamenti denunciati da quattro ex detenuti
del carcere di Poggioreale nel lontano 2012-2014, sono prescritti. Forse alcuni
degli imputati potrebbero fare richiesta di rinuncia alla prescrizione sperando
in una assoluzione nel merito: sostengono di non aver commesso abusi né lesioni.
In ogni caso la prescrizione piomberà come una pietra tombale sul processo. E
sulla verità. Dodici gli agenti della polizia penitenziaria imputati, cinque gli
episodi oggetto delle accuse: si va dall’abuso di potere nei confronti di
persone detenute al reato di maltrattamenti. Tutto, stando alla denuncia di
quattro ex detenuti, sarebbe avvenuto nella cella zero, la stanza più temuta del
carcere di Poggioreale. Un locale spoglio e grigio, senza arredi, con un letto
ancorato al pavimento con delle viti, nessun lenzuolo, nessuna coperta.
Si finiva lì se si osava
rispondere a qualche agente della penitenziaria, se si usavano sguardi o parole
di troppo. «Era il metodo Poggioreale», racconta chi ha vissuto il carcere di
Poggioreale più di dieci anni fa. La stessa definizione – il metodo Poggioreale
– che alcuni degli agenti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, accusati
della mattanza del 6 aprile 2020, evocano commentando l’aggressione di massa
compiuta ai danni dei detenuti del reparto Nilo del carcere sammaritano. Sta di
fatto che «Cella zero» è stato il primo processo che ha puntato un faro su quel
che accade nel chiuso di un istituto di pena. Quando dieci anni fa, dopo le
prime denunce, fu avviata l’inchiesta l’argomento carcere era un tabù vero e
proprio, nessuna particolare attenzione politica, nessuna indignazione
collettiva. Non fecero clamore le dichiarazioni degli ex detenuti, il racconto
delle notti da incubo vissute quando la “squadretta” di agenti piombava nella
cella a regolare i conti della giornata. I passi pesanti rompevano il silenzio
della notte, le mazze di ferro battute contro le sbarre della cella annunciavano
il detenuto su cui si sarebbe abbattuta la punizione.
In genere, secondo il racconto
di ex reclusi, la scelta ricadeva su chi nella giornata aveva avuto da ridire su
qualcosa, aveva avuto un battibecco con qualche agente o tra detenuti, aveva
fatto un commento di troppo o alzato i toni. Una volta entrati nella cella
zero si era costretti a spogliarsi, a fare flessioni con le mani appoggiate al
muro della stanza, incassare schiaffi, calci e pugni tra un insulto e un altro,
in un caso botte sulla testa con un mazzo di chiavi, per poi restare in
isolamento fino a quando i lividi non fossero andati via. Era l’1 giugno
2017 quando i pm, sollecitati ad indagare dalla denuncia dell’allora garante dei
detenuti, chiusero le indagini preliminari con una richiesta di rinvio a
giudizio a carico di dodici agenti allora in servizio
nel carcere di Poggioreale. A dicembre di quello stesso il giudice dell’udienza
preliminare accolse la richiesta e fissò il processo. Da allora dibattimento è
in corso. E la prescrizione ora incombe sui reati. Fine.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Violenze nel carcere di
Modena, ecco tutti i punti irrisolti sulla morte di Piscitelli.
Nell’opposizione alla
richiesta di archiviazione, l’avvocata di Antigone Simona Filippi evidenzia le
testimonianze di alcuni detenuti sulle condizioni critiche dell’uomo già prima
del trasferimento e alcuni punti non chiariti dalla procura. Damiano Aliprandi
su Il Dubbio il 2 aprile 2022.
La morte di Salvatore
Piscitelli, uno dei nove detenuti deceduti durante (e dopo) le rivolte dell’8
marzo 2020 avvenute al carcere di Modena, non può finire archiviata. Non solo
per l’oggettivo ritardo nel soccorrerlo, ma anche per il contesto dove
emergerebbe una indicibile violenza e torture dove sarebbe rimasto coinvolto
anche Piscitelli stesso. Per questo motivo, e non solo, l’avvocata Simona
Filippi, nella qualità di difensore di fiducia dell’Associazione Antigone onlus
rappresentata legalmente dal presidente Patrizio Gonnella, “persona offesa” nel
procedimento penale, ha depositato l’opposizione alla richiesta di archiviazione
presentata dalla procura di Ascoli Piceno.
Per la procura non sono
ravvisabili profili di responsabilità degli indagati
Come già riportato da Il
Dubbio, secondo il Pubblico ministero, il procedimento deve essere archiviato in
quanto non sono ravvisabili profili di responsabilità in capo agli indagati per
la morte di Piscitelli poiché la eventuale anticipazione dei soccorsi anche di
due ore avrebbe garantito delle “possibilità” di sopravvivenza «ma non concrete
ed effettive probabilità di sopravvivenza, essendo la situazione del detenuto
compromessa». In sintesi, per la procura ascolana è accertato che c’è stato un
oggettivo ritardo nel soccorrerlo, ma non è possibile effettuare un giudizio
prognostico in termini di concrete probabilità di sopravvivenza se i soccorsi si
fossero attivati con maggiore tempestività. Non può essere liquidata così la
questione.
Nella richiesta di
opposizione, l’avvocata Filippi di Antigone sottolinea che bisogna innanzitutto
soffermarsi sull’analisi di questi aspetti: «La gravità delle condizioni di
salute in cui versava Piscitelli già al carcere di Modena al momento del
trasferimento e dell’arrivo presso la Casa circondariale di Ascoli Piceno, le
lesioni riscontrate in sede di esame autoptico e la ricostruzione degli orari in
cui si sono sviluppati i fatti».
Il racconto del compagno di
cella a Modena
Infatti, come già riportato in
esclusiva su Il Dubbio, sono stati ascoltati diversi detenuti che hanno tutti
confermato la gravità delle condizioni fisiche di Piscitelli già dal momento
della partenza dal carcere Sant’Anna di Modena. In particolare c’è la
dichiarazione di un detenuto che condivideva la cella con Piscitelli presso
Modena e che con lui starà nel corso della rivolta e che, infine, con lui
condividerà la cella anche presso il carcere di Ascoli Piceno. Cosa racconta?
Parte dal famigerato stanzone della caserma attigua al carcere di Modena dove
sarebbero stati ammassati una ottantina di detenuti e dove sarebbero, appunto,
avvenute violenze e abusi da parte di alcuni agenti provenienti anche da altri
penitenziari come quelli di Bologna e Reggio Emilia.
Secondo la ricostruzione
offerta da questo detenuto, quando lo stesso si trovava presso la caserma del
carcere di Modena a seguito della rivolta, trascorsa circa una mezz’ora giungeva
anche Piscitelli che «tremava» e che gli aveva detto «mi hanno picchiato».
Durante il tragitto per il carcere marchigiano, ha condiviso con Piscitelli la
cella all’interno del furgone e ha evidenziato che le condizioni di salute del
compagno erano già compromesse in maniera evidente: «Durante il viaggio,
Piscitelli non c’era più, era con la testa per terra, non rispondeva e faceva
solo un piccolo verso; ho chiamato l’assistente e gli ho detto che non stava
bene e lui ha detto testuali parole “quando arriviamo lo sistemiamo”».
Ad Ascoli il Capo posto gli
avrebbe risposto «lasciatelo morire»
Una volta giunti a
destinazione, il detenuto sentito dalle pm di Modena, racconta che è stato prima
messo in una cella differente per poi essere spostato, dietro sua richiesta, ed
essere portato nella cella n.52 dove appunto si trovava Piscitelli. Quando è
entrato nella cella, testimonia di aver trovato il compagno con delle “chiazze”
in testa, lo chiamava ma lui non rispondeva. Specifica poi che, tra le 8.30 e le
10.30, ha più volte chiesto aiuto sia all’assistente che al lavorante e il Capo
posto gli avrebbe risposto «lasciatelo morire». Alle 10.30, sempre secondo la
ricostruzione offerta, Piscitelli era diventato «pallido e freddo e si sentiva
puzza di cacca e pipì».
C’ è anche un altro detenuto,
sempre sentito dalle pm, che era presente durante la visita medica effettuata a
Piscitelli al momento dell’ingresso in carcere e ha riferito che lo stesso
«camminava come una persona ubriaca», «barcollava» e «biascicava». Sempre lui è
il detenuto al quale un agente ha chiesto di rifare il letto a Piscitelli in
quanto il detenuto non era in grado di provvedere. Conferma che, nel corso della
notte, l’altro detenuto si era lamentato e aveva chiesto aiuto. Un altro recluso
ancora, anche lui trasferito da Modena ad Ascoli Piceno, ricorda di aver visto
Piscitelli che non riusciva a camminare «tanto era fatto di farmaci e metadone».
Parliamo sempre dello stesso detenuto che ha raccontato di aver visto picchiare
Piscitelli nel famigerato stanzone della caserma attigua al carcere di Modena.
L’opposizione: non si è tenuto
conto di circostanze e spunti investigativi
Nell’opposizione alla
richiesta di archiviazione, viene evidenziato che dalla consulenza disposta
dalla Procura per accertare la causa della morte di Piscitelli sono emersi dei
segni di lesioni. Di fatto, la Procura non ha tenuto conto di alcune circostanze
emerse dagli atti di indagine e di alcuni spunti investigativi che necessitano
di approfondimento. «A partire – si legge nell’opposizione all’archiviazione –
dall’accertamento delle condizioni di salute di Piscitelli al momento del suo
arrivo e dell’intera permanenza presso il carcere di Ascoli Piceno sino ad una
più attenta valutazione del comportamento tenuto dal medico al momento della
visita effettuata nel corso della mattinata del 9 marzo 2020».
Non solo. Emerge un’errata
valutazione delle condizioni di salute di Piscitelli al momento del suo arrivo
al carcere di Ascoli Piceno. Dagli atti delle indagini – come già riportato da
Il Dubbio – emerge che, già dal momento dell’ingresso nel carcere marchigiano,
le condizioni di salute di Piscitelli erano compromesse e che, pertanto, la
visita medica cosiddetta di “primo ingresso” appare effettuata in maniera
approssimativa e superficiale. Non solo. Emerge che le sue condizioni fisiche
erano compromesse non soltanto per l’avvenuta assunzione di metadone ma anche
per le presunte violenze subite nel carcere modenese come rappresentato dai
detenuti ascoltati e come emerso anche in sede di esame autoptico.
Resta la speranza di un
intervento della Corte Europea dei Diritti Umani
Ci sono molti punti da
chiarire ancora. Tutti messi nero su bianco dall’opposizione all’archiviazione:
«Accertare, con integrazione di consulenza, se la terapia (“Narcan”) praticata a
Salvatore Piscitelli nel primo intervento in cella da parte del medico poteva
essere effettuata con modalità differenti; accertare, con integrazione di
consulenza, se, sulla base di tutti gli elementi di indagine raccolti,
Piscitelli doveva essere ricoverato presso il nosocomio già al momento della
visita di primo ingresso; accertare quali erano le condizioni di salute di
Piscitelli al momento della partenza dalla Casa circondariale di Modena; sentire
il detenuto “Nadar” il quale, nel corso della mattinata del 9 marzo 2020,
avrebbe visto il Piscitelli emettere gemiti e, per questo, avrebbe chiesto
all’appuntato di chiamare un medico e quest’ultimo gli avrebbe riferito di
“lasciarlo morire”». La morte di Piscitelli, “Sasà” per gli amici compagni di
cella, grida ancora vendetta. Così come le altre morti, che però sono state
definitivamente archiviate. Rimane, in questo caso, aperta la speranza di un
intervento da parte della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo.
Carcere di Modena, violenze
e torture da “macelleria messicana”.
Nelle testimonianze raccolte
dalla Procura si parla di detenuti ammassati in uno stanzone, ammanettati, presi
a manganellate e alcuni denudati. Tra loro persone semi coscienti per l’abuso di
metadone. Era l’8 marzo 2020. Damiano Aliprandi su Il Dubbio il 30 marzo 2022.
Ammassati in una stanza
vengono obbligati con lo sguardo a terra, alcuni sarebbero stati denudati con la
scusa della perquisizione, e via a una violenta scarica di manganellate e
ceffoni. Emerge un vero e proprio massacro che ha luogo in un locale situato in
un casermone attiguo al carcere di Modena, prosegue durante il viaggio notturno
in pullman e non si esaurisce quando i detenuti giungono al penitenziario di
Ascoli Piceno.
Tanti di quei reclusi denudati
e picchiati nel casermone dell’istituto carcerario Sant’Anna di Modena erano già
in stato di alterazione dovuto da mega dosi di metadone assunte durante la
rivolta dell’8 marzo 2020. Sono soprattutto reclusi stranieri a essere stati
picchiati, tanti di loro – com’è detto -, in stato di incoscienza dovuto
dall’assunzione elevata dose di droga e psicofarmaci.
Ma tra loro c’era anche
Salvatore Piscitelli, l’uomo che in seguito – trasferito nella notte al carcere
di Ascoli Piceno assieme agli altri – morirà dopo essere stato trasportato di
urgenza in ospedale con un oggettivo ritardo rispetto alla richiesta di aiuto da
parte dei suoi compagni di cella. Come già riportato da Il Dubbio, la procura di
Ascoli Piceno ha presentato la richiesta di archiviazione. L’associazione
Antigone, tramite l’avvocata Simona Filippi, ha avanzato opposizione.
E l’agente minacciò: «Adesso
facciamo un altro G8!»
Ma dagli atti della vicenda
Piscitelli emergono altri dettagli che, se confermati dalle indagini tuttora in
corso, dipingono un vero e proprio “sistema” di abusi e torture attuato da
alcuni agenti penitenziari di almeno tre istituti penitenziari diversi: oltre a
quelli di Modena, anche di Bologna e di Reggio Emilia giunti come rinforzo.
E questo, sottolineiamo,
riguarda la presunta mattanza avvenuta nel carcere Sant’Anna a fine rivolta. Il
Dubbio ha potuto visionare in esclusiva gli atti. Sono diverse testimonianze di
detenuti raccolte dalle Pm della procura modenese e tutte convergono su una vera
e propria “macelleria messicana”, tanto che – come testimonia un detenuto – c’è
stato un agente penitenziario, una volta entrato nella stanza del casermone, che
avrebbe urlato: «Adesso facciamo un altro G8!». Il ricordo va inevitabilmente ai
terribili fatti della scuola Diaz avvenuti a Genova nel 2001, quando la polizia
fece irruzione e al grido «Adesso vi ammazziamo», picchiò i ragazzi del
coordinamento del Genoa Social Forum.
Dopo la rivolta le violenze
inaudite su circa ottanta detenuti
Ritorniamo ai fatti di Modena
emersi dalla ricostruzione delle testimonianze raccolte dalla procura. L’8 marzo
2020 scoppia una violenta rivolta, prendono fuoco alcune sezioni, compreso
l’ufficio di comando. Scene apocalittiche. Alcuni detenuti riescono a prendere
le chiavi lasciate dagli agenti, mettendo così in salvo altri reclusi rimasti
chiusi in cella. Man mano gli agenti hanno indirizzato i detenuti nel campo
dicendo loro di rimanere lì, tranquillizzandoli perché non sarebbe successo
niente. Dopodiché, man mano, sarebbero stati ammanettati e costretti a rimanere
con la testa abbassata. Hanno attraversato due porte carraie, fino a giungere in
un specie di casermone e ammassati dentro una stanza.
Dalle testimonianze raccolte
in atti emerge che diversi detenuti sarebbero stati manganellati, insultati e
riempiti di sputi lungo il corridoio che portava al locale. Alcuni detenuti,
soprattutto stranieri, entravano nello stanzone già con la testa sanguinante.
All’interno c’erano agenti penitenziari che provenivano sia da Bologna che da
Reggio Emilia. Alcuni testimoni li hanno riconosciuti perché precedentemente
erano stati reclusi in quei penitenziari. A tutti i detenuti ammassati nello
stanzone, circa una ottantina, sono state fatte togliere le scarpe e costretti a
rimanere seduti per terra.
Ed è in quel momento che
diversi reclusi avrebbero ricevuto ulteriori manganellate in faccia, nei
fianchi, sulle gambe. «Ad esempio c’era un ragazzo straniero – racconta alle Pm
un testimone -, non so se tunisino o marocchino. Si vedeva che era in condizioni
pietose, al livello di… non so cosa avesse assunto, e gli hanno dato un sacco di
manganellate a questo qua, in faccia, in testa, questo ha fatto uno, due, tre,
quattro metri e si è accasciato a terra».
Salvatore Piscitelli stava già
male ed è stato manganellato
Altri detenuti, come dicono
più testimoni ascoltati, sono stati fatti completamente spogliare con la scusa
della perquisizione. In quella caserma giunse anche Salvatore Piscitelli.
Secondo un altro testimone sentito dalle Pm, era già in condizioni particolari.
«Quando lui è entrato già nella stanza lui tremava, tremava – racconta il
detenuto –, io l’ho guardato e lui mi fa: “Mi hanno picchiato”». Testimonia che
tremava così tanto, che un agente ha chiamato un’infermiera dell’ambulanza, che
gli ha dato delle gocce. Un altro testimone racconta che avrebbero manganellato
Piscitelli anche dentro quella famigerata stanza.
Nel trasferimento uno di loro
è stato lasciato a Rimini e rianimato
Non sarebbe finita lì. Nella
notte diversi detenuti sono stati fatti salire nei pullman per trasferirli nel
carcere di Ascoli Piceno. Durante il tragitto, un detenuto testimonia di aver
visto agenti manganellare alcuni reclusi. Diversi di loro si sentivano male, uno
in particolare gli usciva la schiuma dalla bocca e per questo motivo è stato
portato al carcere di Rimini, quello più vicino. Giunti sul posto lo hanno messo
sull’asfalto, è venuta l’ambulanza, gli hanno fatto una siringa e lo hanno
rianimato con il defibrillatore. Ricordiamo che nel tragitto c’era anche
Piscitelli che, a detta di alcuni testimoni, stava già visibilmente male.
Giunti al carcere di Ascoli
Piceno, l’inferno non sarebbe finito
Sempre tutti i testimoni
ascoltati convergono con il fatto che la visita medica effettuata appena sono
entrati, sarebbe stata fatta superficialmente. Non solo. Un detenuto testimonia
che, nonostante fosse visibilmente pieno di segni dovute dalle percosse, il
medico di guardia gli avrebbe soltanto chiesto: «Hai qualche patologia? Prendi
farmaci particolari?». A riposta negativa, «A posto, vai!». Tutto qui. Anche
Piscitelli stava male, tanto è vero – come raccontano i detenuti -, gli agenti
l’avrebbero fatto scendere dal pullman prendendolo per i capelli, perché lui non
riusciva a camminare da solo. Un testimone racconta che alla visita medica,
Piscitelli ha lasciato bisogni fisiologici sulla sedia. Scene indegne per un
Paese civile.
Le violenze sarebbero
proseguite anche nel carcere di Ascoli Piceno
Come risulta dalle
testimonianze raccolte dalle Pm di Modena, al carcere di Ascoli sarebbero
proseguite le violenze da parte degli agenti. Nella notte, i detenuti trasferiti
hanno infatti avuto il sentore che potesse accadere di nuovo. Un testimone
racconta di come il suo compagno di cella, un serbo, gli ha detto di ripararsi
dietro di lui nel caso di una spedizione punitiva. Tutto tace. Ma è stata la
quiete prima della tempesta. Il mattino seguente, una squadra di agenti
sarebbero entrati nelle celle a manganellare. In seguito, per quasi 15 giorni,
avrebbero proseguito la violenza senza manganelli, ma con gli schiaffi. Per
quasi un mese sono rimasti scalzi e con gli stessi vestiti e biancheria intima.
Emerge una omertà che avrebbe coinvolto non solo gli agenti, ma anche altre
figure penitenziarie. Solo grazie all’esposto fatto da sette detenuti, è emerso
tutto questo Sistema di torture e lesioni aggravate.
Resta il dubbio: tra i morti
c’era qualcuno di quelli picchiati?
Attualmente il fascicolo sulle
violenze al carcere di Modena è ancora aperto. Alcuni agenti sarebbero stati
identificati grazie al riconoscimento dei detenuti. Nove però sono le morti
archiviate. Molti sono detenuti stranieri deceduti per overdose. Rimane il
dubbio atroce: alcuni di loro sono quelli picchiati nella caserma del carcere
Sant’Anna? Sappiamo che Piscitelli, per la cui morte Antigone ha fatto
opposizione all’archiviazione, era tra quelli come dicono più testimoni. Su
queste morti sarà investita la Corte Europea dei Diritti umani. Sulle violenze,
ancora si attende l’esito delle indagini. Sullo sfondo c’è la commissione
ispettiva del Dap istituita per le rivolte del 2020, ed è composta da un
magistrato, tre direttori, due comandanti e due dirigenti. Darà risposte su
questa ennesima mattanza che emerge dagli atti?
Parla il fondatore di A
Buon Diritto. Intervista a Luigi Manconi: “Polemiche su ergastolo e Dap, no alla
burocrazia dell’antimafia”.
Angela Stella su Il Riformista il 25 Marzo 2022.
A Buon Diritto, la Onlus per i
diritti umani fondata da Luigi Manconi e diretta da Valentina Calderone, compie
vent’anni e li celebra domani presso il MAXXI di Roma. Ci saranno artisti e
personalità del mondo della cultura, attivisti e rappresentanti delle
istituzioni: i messaggi di Roberto Fico e Liliana Segre e del presidente della
Federazione delle Chiese Evangeliche italiane Daniele Garrone, e Valerio
Mastandrea e Valentina Carnelutti; e poi Jorit, Cinzia Leone, Makkox, Alessandro
Bergonzoni, Sergio Staino, Ascanio Celestini e tanti altri e altre. Inoltre il
22 maggio in libreria arriva una nuova edizione di Abolire il carcere, scritto
da Manconi con Stefano Anastasia, Federica Resta e la stessa Valentina
Calderone.
Presidente Manconi, mercoledì
sul Riformista abbiamo pubblicato uno stralcio dell’introduzione di Stefano
Ceccanti al volume I cristiani e la pace di Emmanuel Mounier, secondo cui “Non
esiste diritto che non sia stato plasmato da una forza, che non si sostenga
senza una forza”. È d’accordo?
Sono incondizionatamente
d’accordo. E vorrei introdurre una ulteriore distinzione che è quella tra il
pacifico profetico e quello politico. Chiunque operi nella sfera pubblica, in
qualunque ruolo, – sia un giornalista, un parlamentare, un militante politico o
un volontario di un’associazione di soccorso – agisce nel mondo e quindi deve
tener conto delle contraddizioni che il mondo rivela e che la politica deve
ricomporre. In questo senso non ci sono categorie che possano essere
interpretate in maniera integralista. Senza tener conto della loro finitezza e
del fatto che devono misurarsi con la scarsità delle risorse, con l’asprezza
delle condizioni materiali di vita e con la violenza del male. E questo impone
mediazioni e compromessi. Poi c’è il pacifismo profetico che annuncia una
utopia, un messaggio di largo respiro, una visione. Io ho bisogno di questo
pacifismo per ricordarmi i fini della mia azione, che tuttavia sono diversi
dalla profezia. L’azione politica non può essere mai indifferente alle
conseguenze degli atti che si compiono e di quelli che si omettono. Deve essere
sempre responsabile. E allora io pacifista vado in Ucraina: porto aiuti
umanitari, soccorro i bambini e gli anziani, assisto le donne, curo i feriti.
Fatto questo devo convincere i contendenti a trattare e promuovere occasioni di
confronto e di scambio tra i popoli. Compio così il mio dovere di pacifista.
Poi, però, arriva un soldato russo che alza la sua spada per colpire quella
donna, quel bambino, quel vecchio. E io come reagirò? Credo che, per essere
coerente con le premesse, dovrò fare tutto il possibile, come so e come posso,
per rendere inoffensivo l’aggressore. Fino a ucciderlo, se non ci sono altre
possibilità.
Con la vostra associazione vi
occupate anche di migranti e richiedenti asilo. In questi giorni qualche
commentatore ha sollevato la polemica: “E allora lo Yemen?”, “E allora la
Siria?”. Esistono guerre e profughi di serie A e di serie B?
L’Ucraina è collocata nel
cuore dell’Europa, al centro della sua storia e della sua cultura. E quindi è
comprensibile che si avvertano quelle persone come più prossime a noi. Questo è
il primo dato. Ovviamente c’è dell’altro: altre guerre e altri milioni di
profughi, li sentiamo lontani perché effettivamente lo sono: persone con un
colore della pelle diverso e con un’identità estranea e sconosciuta. Se da
questo si ricava una teoria e una politica che privilegiano un gruppo etnico a
scapito di un altro, siamo di fronte a una manifestazione di xenofobia.
A Buon Diritto si occupa, tra
le tante cose, del tema carcere. Il capo del Dap Carlo Renoldi si è insediato
due giorni fa. Tra poco verrà approvata una legge sull’ergastolo ostativo. Ma la
polemica che accomuna questi due eventi è la stessa: chi vuole un carcere più
umano è nemico dell’antimafia.
Mi sembra una polemica tanto
vecchia da risultare stucchevole. Io, per esempio, non sono contro una durissima
lotta alla criminalità organizzata, figuriamoci, ma sono contro la retorica
dell’antimafia e la burocrazia dell’antimafia, nel senso che tutti i fenomeni,
compresi i più nobili, tra cui appunto il contrasto alle mafie, possono produrre
escrescenze. Ci sono ottimi magistrati, alcuni dei quali indulgono in quei vizi,
altri che pur essendo assai competenti talvolta compiono errori. Ma criticare le
responsabilità dei magistrati e alcune tendenze culturali regressive non vuol
dire mica delegittimarli.
Tra le vostre battaglie
ricordiamo quelle contro gli abusi a opera delle forze di polizia. Proprio poco
fa si è aperto un processo a carico di un carabiniere accusato di abuso di
autorità contro arrestati o detenuti, avendo bendato all’interno della sua
caserma uno dei due americani accusati dell’omicidio del vicebrigadiere
Cerciello Rega. Dagli atti sono emerse chat dei colleghi: ‘Ammazzateli di botte
– fategli fare la fine di Cucchi”.
Intanto il 7 aprile ci sarà la
sentenza relativa ai depistaggi per la morte di Stefano Cucchi. Non è la prima
volta che il suo nome viene evocato come una minaccia per persone che si trovano
in stato di fermo. È un segnale terrificante che all’interno degli apparati
dello Stato possa ancora circolare un certo senso comune. Ignoro se riguardi una
gran parte dei membri dei corpi di polizia o solo una piccola minoranza, ma è
indubbio che quell’umore sia diffuso e si riproduca. Quello che per una parte
dell’opinione pubblica è stato l’accertamento della verità su un gravissimo caso
di abuso contro un fermato, è vissuto e rivendicato da parte di alcuni militari,
come un modello di giustizia esemplare. E ciò perché all’interno dei corpi di
polizia, continua a mancare uno spirito costituzionale e una formazione
culturale e legale adeguata all’educazione di coloro che sono chiamati tutori
dell’ordine e detengono il monopolio legittimo della forza.
Ultima domanda: si discute in
questi giorni del ritardo dell’approdo in Aula della riforma del Csm. Secondo
lei la politica è ancora subalterna alla magistratura o è cambiato qualcosa?
È cambiato tantissimo ma temo
non abbastanza. Non c’è solo un fattore di subalternità psicologica, ma anche il
peso di culture politiche che giocano un ruolo negativo. Culture antigarantiste
e illiberali che impediscono una seria riforma dell’ergastolo ostativo, una
ulteriore limitazione del ricorso alla custodia cautelare, la separazione delle
carriere tra magistratura requirente e magistratura giudicante. Posso aggiungere
una cosa?
Prego.
Tutto quello che ha fatto A
Buon Diritto non sarebbe stato possibile senza la direttrice Valentina
Calderone. Lavora con me da più di quindici anni, mentre io ne combinavo in giro
di tutti i colori (senatore, ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali,
scrivevo libri e articoli…) lei ostinatamente e pazientemente ha guidato con
grande ingegno l’associazione. Angela Stella
«Lo Stato mi obbliga a
cercare un lavoro, ma poi me lo toglie…».
Disposta la sorveglianza
speciale con obbligo di dimora per l'ex capo delle cooperative condannato nel
processo "Mondo di mezzo". Così Buzzi rischia di perdere il suo lavoro al pub.
Valentina Stella su Il Dubbio il 14 marzo 2022.
«Come temevo è giunta la
notifica per le misure di prevenzione personali. Due anni e mezzo di
sorveglianza speciale che hanno i seguenti obblighi: dimora in casa dalle 21
alle 7 del mattino, obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, presentazione
una volta a settimana alla stazione dei Carabinieri, ritiro della patente e
obbligo di cercarsi un lavoro»: è amareggiato Salvatore Buzzi quando ci racconta
di questo nuovo provvedimento a suo carico emesso dal Tribunale per le misure di
prevenzione di Roma.
«Quanto mi è stato notificato
fa emergere l’ottusità della legge», in quanto «siamo dinanzi ad un
incomprensibile paradosso: vengo obbligato a ricercare immediatamente
un’attività lavorativa lecita, ma la prescrizione di questa misura
incredibilmente mi fa perdere il lavoro che già ho. Come è noto anche i
magistrati – perché l’ho fatto mettere a verbale -, io lavoro, assunto
regolarmente, in un pub di cui sono il frontman, per usare una terminologia
rock, e la mia attività lavorativa si svolge di sera e notte con chiusura del
pub che va fino alle 2 del mattino nei giorni di venerdì e sabato e all’una
negli altri giorni».
Buzzi ci spiega che è riuscito
«a conservare comunque la patente perché una sentenza della Corte Costituzionale
del 2021 ne vieta il ritiro se può inficiare l’attività lavorativa e io ho
facilmente dimostrato che ne avevo bisogno per recarmi al lavoro». L’uomo ci
tiene a precisare: «Non voglio passare per vittima, ma evidenziare la
limitatezza del nostro sistema giudiziario eccessivamente burocratico e
punitivo». Un’altra prescrizione del provvedimento che gli provoca sconcerto è
quella per cui non può partecipare – leggiamo nell’atto – «a pubbliche riunioni
senza autorizzazione dell’Autorità giudiziaria». Per questo Buzzi si dice «molto
dispiaciuto perché non potrò prendere parte alle assemblee del Partito Radicale,
a cui sono iscritto, se non mi danno il permesso».
Per lui, prosegue, «la ratio
di questa misura risale all’epoca fascista, quando si era soliti dire che di
notte girano ladri e puttane. Da quando sono uscito ho intrapreso un percorso,
ho sempre rispettato quanto impostomi dall’autorità. Fino ad ora non potevo
allontanarmi dal comune di Roma. Adesso neanche posso uscire la sera: sono tutte
misure afflittive accessorie, imposte ad una persona che sta ricominciando a
vivere». Buzzi poi precisa: «Le misure di sicurezza personali non sono altro che
un addentellato delle misure di sicurezza patrimoniali, quelle necessarie per
espropriarti il tuo patrimonio. Nel mio caso: le cooperative che avevano un
patrimonio di oltre 30 milioni di euro e davano lavoro a 1300 persone,
miseramente fallite, come noto, e due appartamenti e altre proprietà con la
motivazione che i redditi derivanti dagli stipendi percepiti dalle cooperative
fossero tutti illegittimi. Misura questa, ovviamente, applicata soltanto a me».
Come ci spiega l’avvocato Pier
Gerardo Santoro, che assiste Buzzi insieme all’avvocato Alessandro Diddi, «pur
essendo caduta l’accusa di mafia, le condanne per alcuni reati sono passate in
giudicato. Quindi, venute meno le misure cautelari, è stata applicata quella di
sorveglianza speciale. A parere nostro si tratta di una misura che ad oggi non
ha più senso: Buzzi ha già scontato cinque anni di carcere, i collegamenti con
possibili attività criminali sono recisi, ha rispettato tutte le prescrizioni e
limitazioni fino ad ora disposti da parte dell’Autorità giudiziaria. Noi
chiederemo al Tribunale di poterlo autorizzare a lavorare, come fatto fino a
questo momento. L’attività lavorativa è sintomo di un reinserimento sociale e
della ricostruzione della propria vita».
Parallelamente, «ci sarà la
richiesta di un nuovo incidente di esecuzione per valutare oggi la posizione di
Salvatore Buzzi che non può essere ritenuto un soggetto socialmente pericoloso a
cui applicare misure di sorveglianza speciale». Il loro assistito «è stato
arrestato nel lontano 2014. Ha scontato 5 anni, ha ammesso le sue
responsabilità, si sta reinserendo e ricollocando in questa società. Che senso
ha sottoporlo a tutta una serie di limitazioni che confliggono con la finalità
rieducativa della pena? Si tratta di prescrizioni prettamente punitive».
Tuttavia sul presente pende
anche una prossima decisione della Cassazione che potrebbe addirittura riportare
nuovamente l’uomo in carcere. Infatti il 9 marzo 2021 la sentenza d’Appello bis
sul “Mondo di Mezzo” rideterminò le pene per alcuni imputati: Buzzi fu
condannato a dodici anni e dieci mesi, mentre per Massimo Carminati la pena è
stata di dieci anni. «Se venisse accolto il nostro ricorso dalla Suprema Corte –
ci racconta ancora Santoro – si annullerebbe la precedente sentenza di appello
bis di determinazione della pena. E si potrebbe chiedere per Buzzi l’istanza di
affidamento in prova per fargli svolgere lavori socialmente utili, anche alla
luce dei nuovi orientamenti della ministra della Giustizia Marta Cartabia, volta
a favorire istituti alternativi alla pena del carcere».
Giuseppe Legato per “La
Stampa” il 21 aprile 2022.
Botte, umiliazioni,
vessazioni. In una parola, torture. Condite da silenzi e omertà per coprire il
(presunto) scempio che tra il 2017 e i 2019 si sarebbe consumato all'interno del
carcere Lorusso e Cutugno di Torino.
Ventidue tra agenti e
ispettori del penitenziario sono stati rinviati a giudizio ieri dal giudice
Maria Francesca Abenavoli. Una delle (poche) prime volte in Italia in cui questo
titolo di reato viene ipotizzato dietro le sbarre di una casa circondariale. Il
processo - nella forma del classico dibattimento - inizierà fra un anno e mezzo:
luglio 2023.
Ma tra poche settimane - nel
troncone che si celebra con rito abbreviato - compariranno di fronte al giudice
l'ex direttore della struttura Domenico Minervini e l'allora comandante della
polizia penitenziaria Giovanni Battista Alberotanza accusati di favoreggiamento
e omessa denuncia.
Vertici o semplici agenti che
siano, lo spaccato che emerge dall'inchiesta del pm Francesco Pelosi nel periodo
compreso tra il 2017 e il 2019, è inquietante, inquadrato dal magistrato come
«trattamento degradante e inumano».
Con una «squadra di
picchiatori», un «battesimo per i nuovi giunti nel penitenziario», e le
«spedizioni punitive» nelle celle dei detenuti del padiglione riservato ai sex
offenders (imputati o condannati per reati sessuali).
Nelle migliaia di pagine di
atti risuonano intercettazioni e frasi captate dagli investigatori: «Devi morire
qui, pezzo di merda. Ti faremo passare la voglia, non ne uscirai vivo». Ancora:
«Quando sono arrivato in carcere a Torino mi hanno portato ammanettato al
casellario. Mi hanno chiesto di spogliarmi, ho tolto tutto tranne le mutande. In
4 allora hanno indossato dei guanti, mi hanno sbattuto per terra e mi hanno
strappato gli slip di dosso. Ho sbattuto la faccia contro il pavimento e mi sono
spaccato un dente, mi è caduto. E l'ho nascosto in cella» ha detto piangendo una
vittima di fronte al magistrato.
Altra vicenda: «Ero entrato
alla matricola, avevo fatto le foto mi avevano preso le impronte digitali, gli
agenti hanno cominciato a colpirmi con schiaffi, pugni e calci. In particolare
mi dicevano di salire le scale e mentre le affrontavo gli agenti, da dietro, mi
colpivano con schiaffi pugni e calci. E ridevano».
Infine: «L'altra sera ci siamo
divertiti - confessa un agente alla fidanzata -, sembrava Israele degli anni
Cinquanta». Undici detenuti oggetto di violenze si sono costituiti parte civile.
Vale lo stesso per la città di Torino attraverso il suo garante Monica Gallo
(autrice della prima denuncia) e i garanti regionali e nazionali. Il giudice ha
disposto la citazione del ministero della Giustizia come responsabile civile.
Ma la prima udienza sarà a
luglio 2023. Torture nel carcere di Torino, a processo 22 agenti e l’ex
direttore Minervini: “squadre di picchiatori” nelle celle per pestare i
detenuti.
Carmine Di Niro su Il Riformista il 21 Aprile 2022.
Una mattanza avviata, secondo
le indagini, nell’aprile del 2017, e continuata fino all’ottobre di due anni
dopo. Sono le torture, le botte, le vessazioni e le umiliazioni alle quali sono
stati sottoposti nei confronti di alcuni detenuti del carcere ‘Lorusso e
Cutugno’ di Torino.
Per questo scempio
democratico, condito da silenzi e omertà per coprire i fatti,
verranno processati 22 agenti della polizia penitenziaria coinvolti
nell’inchiesta coordinata dal pm Francesco Pelosi. Indagine nata grazie alle
segnalazioni da parte del garante comunale dei detenuti Monica Gallo.
Tra gli indagati figurano
anche alcune figure apicali del carcere, tra cui l’ex direttore della casa
circondariale Domenico Minervini, rimosso dall’incarico dopo l’apertura
dell’inchiesta, e l’ex comandante Giovanni Battista Alberotanza. I due, accusati
di omessa denuncia e favoreggiamento, hanno scelto il rito abbreviato: Minervini
e Alberotanza compariranno davanti a un giudice tra poche settimane.
A processo anche due
sindacalisti della polizia penitenziaria, accusati di rivelazione di segreto e
favoreggiamento.
Gli episodi di tortura
contestati si sarebbero verificati all’interno del Settore C del
penitenziario torinese. Il processo, che vede dodici detenuti come parti civili
assieme alla città di Torino (tramite il garante Gallo), avrà la prima udienza
soltanto il 4 luglio 2023, tra più di un anno. Il giudice ha disposto la
citazione del ministero della Giustizia come responsabile civile
Nelle migliaia di pagine di
atti che compongono l’inchiesta, emergerebbe secondo il pm Pelosi il modus
operandi all’interno del carcere, un trattamento nei confronti dei detenuti
“degradante e inumano”, scrive il pubblico ministero.
In particolare, scrive il
quotidiano di Torino La Stampa, nel Settore C del ‘Lorusso e Cutugno’ ci sarebbe
stata una “squadra di picchiatori” specializzata in “spedizioni punitive”
all’interno delle celle del padiglione destinate ai cosiddetti ‘sex offenders’,
ovvero quei detenuti imputati o condannati per reati sessuali.
Contro gli indagati ci sono
anche intercettazioni, frasi captate dagli inquirenti che dimostrerebbero il
regime di terrore all’interno della casa circondariale. “Devi morire qui, pezzo
di merda. Ti faremo passare la voglia, non ne uscirai vivo”, dice un agente. Un
secondo, parlando alla fidanzata, confessa che “l’altra sera ci siamo divertiti,
sembrava Israele degli anni Cinquanta”.
“Quando sono arrivato in
carcere a Torino mi hanno portato ammanettato al casellario. Mi hanno chiesto di
spogliarmi, ho tolto tutto tranne le mutande. In 4 allora hanno indossato dei
guanti, mi hanno sbattuto per terra e mi hanno strappato gli slip di dosso. Ho
sbattuto la faccia contro il pavimento e mi sono spaccato un dente, mi è caduto.
E l’ho nascosto in cella”, ha invece raccontato piangendo una vittima di fronte
al magistrato.
Carmine Di Niro. Romano di
nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di
politica, sport e tecnologia
Cartabia: «Nel carcere di
Torino ho visto un reparto inguardabile per la sua disumanità».
Ieri la visita della
guardasigilli al Lorusso e Cotugno. Il reparto a cui si fa riferimento è lo
stesso di cui il Garante chiede la chiusura dal 2017. Il Dubbio il 12 marzo
2022.
Nel carcere di Torino ho visto
«un reparto inguardabile per la sua disumanità». Queste le parole della ministra
della Giustizia, Marta Cartabia, dopo la visita al reparto cosiddetto «filtro»
del Lorusso e Cotugno, riprese in una nota del Garante nazionale dei diritti
delle persone private della libertà personale. «Fin dal 2017 il Garante
nazionale chiede la sua chiusura senza che le autorità penitenziarie e sanitarie
abbiano adottato azioni risolutive: il Garante auspica che l’intervento della
ministra dia un chiaro impulso per la chiusura del reparto», ha scritto il
Garante.
Accompagnata dalla
neodirettrice della casa circondariale Cosima Buccoliero, dal vice comandante
della Polizia penitenziaria, Maurizio Contu, dalla Provveditrice Rita Monica
Russo e dalla Garante dei detenuti Monica Gallo, la Guardasigilli ha visitato
ieri alcuni padiglioni del carcere e ha incontrato il personale della casa
circondariale. Un viaggio che come definito dalla direttrice Buccoliero “rimane
uno tra gli Istituti italiani più difficili ma che va considerato anche ”
finestra sulle opportunità”, al cui interno, se pur presenti urgenti criticità
vi sono sono anche eccellenze. La ministra ha attraversato i padiglioni di alta
sicurezza (A-B-C) ma anche avuto modo di vedere gli spazi di camminamento e le
aule universitarie dove si tengono le lezioni.
«Non è tempo di distinzioni né
contrapposizioni inutili in carcere. Le difficoltà in questo carcere sono
tangibili ma se c’è una forza, una sinergia, una collaborazione, una
cooperazione e uno spirito di unità come quello che mi è stato segnalato,
facciamo in modo che diventi il paradigma per il cammino che ci attende», ha
detto la ministra. «Il nesso tra educazione, rieducazione e sicurezza è un nesso
fortissimo e se invece che rieducare investissimo di più sull’educazione avremmo
bisogno meno di rieducare», ha sottolineato la guardasigilli incontrando i
ragazzi del Sermig di Ernesto Olivero ai quali ha parlato, sollecitata da una
domanda, della sua visita al carcere torinese. «Non possiamo negarci che ci sono
condizioni che rendono davvero difficile che la pena raggiunga davvero il suo
scopo che è quello di dare una seconda opportunità a chi ha sbagliato – ha detto
Cartabia – ci sono in quel carcere delle esperienze bellissime che accompagnano
i detenuti in quella direzione ma ci sono dei bracci in quel carcere in cui
credo sia veramente difficile che quel tempo passato reclusi senza una proposta
possa raggiungere quell’obiettivo costituzionale». «Ho visto un reparto A
inguardabile per la disumanità tanto per le condizioni in cui deve operare la
polizia penitenziaria quanto per quelle in cui si trovano i detenuti ma ho anche
visto il volto di un ragazzo che il 30 marzo si laurea dopo aver svolto un
percorso di studio proprio all’interno del carcere. La speranza è allargare lo
sguardo per vedere gli aspetti positivi – ha concluso la guardasigilli – e sono
fiduciosa che il carcere possa diventare ciò che la costituzione prevede che
sia».
Le statistiche. Chi c’è in
carcere: aggressori e pusher, pochissimi i mafiosi.
Viviana Lanza su Il Riformista il 3 Marzo 2022.
Ha un’età compresa tra i 40 e
i 60 anni, ha figli. Nella maggior parte dei casi ha anche una moglie o una
convivente, e ha un titolo di studio medio alto. E si trova in carcere per reati
contro la persona o contro la pubblica amministrazione. Eccolo il ritratto del
detenuto medio, il profilo di chi compone la maggioranza della popolazione
detenute nelle carceri della Campania, e più in generale di tutto il Paese. È di
queste persone che dovrà occuparsi il nuovo capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria. Altro che mafiosi, a stare in carcere sono
soprattutto uomini violenti o truffatori, ladri e spacciatori. Eccolo
l’identikit di chi vive dietro le sbarre.
Certo ci sono anche quelli
condannati per reati di criminalità organizzata, ma sono una minoranza rispetto
alla popolazione che vive nelle celle. Lo dicono le statistiche ministeriali con
cui periodicamente il Ministero della Giustizia traccia un bilancio sullo stato
del sistema penitenziario. Ebbene, se è vero che i numeri sono utili per
descrivere certe realtà, è dai numeri indicati nelle statistiche ministeriali
che viene fuori un ritratto del detenuto medio che non è solo e sempre il
ritratto dello spietato e potente boss della criminalità organizzata rispetto al
quale diventa difficile, come sostengono i meno garantisti, intavolare discorsi
su misure alternative e provvedimenti svuotacarceri. Su una popolazione detenuta
di oltre 54mila persone, sono 7.274 quelli reclusi per reati di associazione a
delinquere di stampo mafioso.
La maggior parte dei detenuti
è dietro le sbarre per reati contro il patrimonio, cioè furti e rapine. E per
reati contro la persona, quindi aggressioni e lesioni. Nella prima sfera di
reati rientrano 31.009 detenuti, nella seconda 23.611 detenuti. E allora come
mai, quando si parla di carcere, ci si concentra sempre ed esclusivamente sui
boss della camorra? Ragionare su misure alternative al carcere e sulla
possibilità di ricorrere al carcere solo come extrema ratio può essere possibile
per più della metà della popolazione detenuta. Cosa significherebbe?
Innanzitutto la fine di carceri-inferno, e poi di celle strapiene, di diritti
mortificati, di spazi inadeguati, di attività di rieducazione non a singhiozzo e
non per pochi, di tutela della salute, di tutela dei diritti anche di chi lavora
in carcere perché le risorse non saranno inadeguate a gestire il numero di
detenuti che sarebbe realmente presente nelle celle.
In due parole, sicurezza e
diritti. Di tutti. Di chi vive all’interno delle strutture penitenziarie e di
chi vive nel mondo fuori. I numeri, dicevamo. Sono stati, nel 2021, più di 8mila
i detenuti per reati contro la pubblica amministrazione e oltre 9mila quelli
dentro per possesso di armi. I numeri descrivono anche un altro aspetto della
questione carcere tanto dibattuto quanto nei fatti ignorato: i detenuti
problematici, quelli per esempio tossicodipendenti. Sono molto numerosi.
Nel 2021 si sono contati 18.942 detenuti per reati legati allo spaccio di
sostanze stupefacenti. Rispetto al passato sono in numero più contenuto (erano
più di 23mila nel 2005 e più di 21mila nel 2019), ma sono pur sempre ancora
moltissimi, se si considera che più della metà oltre a trafficare in droga ne
sono anche assuntori. Sono dunque troppi per le strutture di cui il sistema
penitenziario dispone, inadeguate a gestire detenuti con dipendenze e patologie.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Viaggio nel disastro della
sanità in carcere: medici precari e gravi carenze di personale.
La riforma della sanità
penitenziaria è incompleta, liste di attesa infinite, troppo lavoro sulle spalle
dei pochi infermieri. Pesa la precarietà dei medici. Casi a Bologna, Sulmona e
penitenziari campani. Damiano Aliprandi su Il Dubbio il 2 marzo 2022.
Troppi sono i detenuti che
attendono di essere ricoverati o per visite specialistiche o per interventi
chirurgici. L’attesa a volte è più lunga della pena. Una vera e propria
emergenza sanitaria che coinvolgono diversi penitenziari. C’è il caso dei
penitenziari campani, così come la questione del carcere della Dozza di Bologna
dove c’è penuria di medici, o a Sulmona dove a fine marzo ( come in tutta
Italia) vanno via gli Oss e l’organico sanitario rimane scoperto.
IL CASO EMBLEMATICO DELLA
DOZZA DI BOLOGNA
Partiamo dalla questione
bolognese, un caso emblematico. Non si trovano medici che vogliano assumere
incarichi nel carcere. Il motivo principale è perché sono precari, li pagano
poco e fanno turni pesanti. Accade quindi che tutta la mole di lavoro e
soprattutto la responsabilità, cade sugli infermieri. Ciò ha provocato un grave
episodio di disorganizzazione registrato fra il 19 e il 20 febbraio nella casa
circondariale della Dozza: il penitenziario si è infatti ritrovato privo di
personale medico per l’intero turno notturno, con la gestione di qualunque
genere di emergenza sanitaria affidata esclusivamente al personale
infermieristico in forza al carcere.
«Non è possibile ritrovarsi a
lavorare in queste condizioni: la probabilità che nella notte fra sabato e
domenica non ci fossero medici a disposizione era già stata prospettata da
inizio settimana dalla direzione sanitaria, eppure, in tutti questi giorni, non
è stato fatto nulla per cercare una soluzione – ha denunciato Antonella
Rodigliano, segretaria territoriale del sindacato Nursind di Bologna -. L’unica
comunicazione giunta è stata quella che, poche ore prima dell’inizio del turno,
avvisava gli infermieri di dover affrontare la nottata da soli. Si tratta di una
cosa gravissima». La situazione all’interno del carcere, come denuncia il
sindacato, è al limite: i medici in organico sono appena sedici e la carenza di
personale è evidente. Mai però si era giunti ad una situazione simile, con la
totale assenza di una figura medica all’interno della struttura per un intero
turno. Gli atti di autolesionismo da parte dei detenuti e le aggressioni al
personale infermieristico sono spesso all’ordine del giorno alla Dozza, rendendo
già di per sé complicato il servizio nella struttura. «Non si può continuare
così», ha rimarcato quindi Rodigliano.
UN EPISODIO CHE È RICADUTO
TUTTO SULLE SPALLE DEGLI INFERMIERI
Poco prima dell’inizio del
turno fra il 19 e il 20 febbraio, gli infermieri in servizio nel carcere sono
stati messi al corrente della situazione, senza nessuna possibilità di porvi
rimedio o trovare delle altre soluzioni per tempo. Sono state invece fornite
indicazioni operative straordinarie, come il potenziamento della continuità
assistenziale della guardia medica in condizioni di necessità e la prassi da
seguire in caso di nuovi accessi, dando per scontata la disponibilità degli
infermieri ad accettare tutto quanto. «Chiaramente non ci tiriamo mai indietro
perché siamo dei professionisti che amano il proprio lavoro e lo fanno sempre
con grande passione e serietà – ha concluso la segretaria regionale del Nursind
– ma non possiamo rischiare di ritrovarci di nuovo in una situazione del genere.
È il momento che qualcuno si assuma le proprie responsabilità».
IN CAMPANIA L’ATTESA DI UNA
VISITA PUÒ ESSERE PIÙ LUNGA DI UNA PENA
Veniamo ora al caso delle
carceri campane. A segnalare l’emergenza è il garante regionale Samuele
Ciambriello. In visita all’Ospedale Cardarelli di Napoli ha puntato l’attenzione
sull’assistenza sanitaria a chi sconta una pena in carcere. «Al Cardarelli ci
sono 12 posti – denuncia il garante-, oggi solo nove perché una stanza con tre
posti è inutilizzabile. A Benevento, per volere della direzione sanitaria
dell’Ospedale San Pio, non ci sono posti riservati ai detenuti. Perché solo così
pochi posti? Tantissimi detenuti attendono di essere ricoverati o per visite
specialistiche o per interventi chirurgici. L’attesa a volte è più lunga della
pena. Nel pieno rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e della
tutela della salute, credo che la nostra società e le nostre Istituzioni non
siano rispettose dei diritti umani dei detenuti».
Per il garante la riforma
sanitaria in carcere è ancora una chimera: «Tarda ad avere piena e
incondizionata applicazione. Tale diritto deve essere riconosciuto conciliabile
e non contradditorio con le esigenze di sicurezza. L’irragionevole incertezza, a
volte gelosie tra l’area sanitaria e le direzioni delle carceri sono
un’afflizione aggiuntiva per i detenuti. Le aggravanti nelle carceri sono poi
gli aumenti dei detenuti con un problema in più: quello mentale e quello delle
tossicodipendenze».
A SULMONA SI RISCHIA IL
COLLASSO PER MANCANZA DI OPERATORI SOCIO- SANITARI
C’è il caso del carcere
abruzzese di Sulmona denunciato da Mauro Nardella, Segretario generale
territoriale della Uilpa polizia penitenziaria. In sostanza, non solo carenza di
medici ma anche di Operatori socio sanitari ( Oss) dietro le sbarre. Per questo
la Uil non esulta sulla fine dell’emergenza pandemica fissata per il prossimo 31
marzo. Alla precarietà dei sanitari ( 4 in servizio sui 7 previsti in organico),
si aggiungerà, a partire dal 31 marzo, quella degli Oss ( operatori socio
sanitari) che, durante la pandemia, sono stati fondamentali nell’evitare il
collasso del sistema dietro le sbarre.
«Con il venire meno dello
stato di emergenza gli Oss non sarebbero più contemplati dalla Protezione civile
e quindi non più utilizzabili in carcere – scrive Nardella -. La sanità
abruzzese non può non farsi carico di questo potenziale e pericoloso scenario
futuro. Per questo motivo la Uil invita l’assessore alla sanità Nicoletta Veri e
tutta la dirigenza Asl a farsi carico della situazione e a porvi subito
rimedio». Il sindacalista offre dei suggerimenti: «A tal proposito può essere
utile invitare loro a destinare, con le modalità che la Asl saprà adottare,
un’aliquota degli Oss facendo permanere le unità attuali impegnate in loco e che
ben sanno cosa fare per continuare a soddisfare le esigenze
dell’Amministrazione. Il tutto, nelle more dell’espletamento della procedura
concorsuale aggregata ( in corso di svolgimento) per le Asl di Teramo, Lanciano-
Vasto- Chieti e Avezzano- Sulmona- L’Aquila gestita dalla Asl di Teramo dalla
quale sarebbe auspicabile l’assegnazione di unità presso gli istituti di pena di
Sulmona ( 4 per 420 detenuti), L’Aquila ( 3 per 200 detenuti) ed Avezzano ( 2
per 60 detenuti)».
Il problema sanitario è
evidente e deve interessare soprattutto il ministro della Salute Roberto
Speranza. Ricordiamo che dal primo aprile 2008 la salute delle persone detenute
è divenuta formalmente una competenza del Servizio sanitario nazionale e si è
venuta così a sanare una delle tante anomalie normative che riguardano la
gestione della vita penitenziaria. Calandoci sul piano del diritto vivente,
tuttavia, questa anomalia è stata adeguatamente superata esclusivamente sul
piano formale. Nella materialità della detenzione permangono le criticità che
ostacolano una piena affermazione dell’equivalenza delle cure, principio cardine
della riforma stessa. Il trasferimento del personale, strumentazioni e
responsabilità alle Aziende sanitarie locali è stato generalmente vissuto come
un ulteriore “peso” scaricato sulle spalle già fragile della sanità regionale (
e dei suoi bilanci). Non a caso, come detto inizialmente, c’è il discorso della
precarietà che coinvolgono anche i medici, difficilmente disposti a sacrificare
la loro vita per pochi soldi rispetto ai colleghi che lavorano nel mondo libero.
Ma non solo. La difficoltà principale è quella di riuscire a valutare la
questione sanità penitenziaria da un punto di vista nazionale e quindi si creano
forti disparità tra territori. Accade nel mondo libero, ma nel carcere tutto si
amplifica.
La decisione
del Tribunale di Sorveglianza. Scarcerato il detenuto più anziano d’Italia: a 88
anni e con 17 patologie rischiava di morire ogni giorno.
Viviana Lanza su
Il Rifromista il
25 Febbraio 2022.
Umanità e
giustizia possono incrociarsi senza che l’una annulli l’altra. La notizia della
scarcerazione di Carmine Montescuro, il detenuto più anziano d’Italia,
restituisce un po’ di umanità al senso e alla funzione della pena. Montescuro è
un vecchio boss della malavita napoletana. Ottantotto anni li compirà a luglio
ed ridotto in pessime condizioni di salute a causa di diciassette patologie che
lo hanno reso cieco, sordo, costretto su una sedie a rotelle, incapace di essere
autonomo e bisognoso di cure e assistenza che in carcere era difficile
garantire. Un altro detenuto lo piantonava ventiquattro ore su ventiquattro. E
rischiava di morire ogni giorno, anche in considerazione dell’aumento dei
contagi da Covid registrati nelle carceri negli ultimi mesi.
Da
ieri Montescuro è agli arresti domiciliari. Il Tribunale di Sorveglianza ha
accolto l’istanza presentata dai difensori di Montescuro. L’anziano detenuto ha
quindi potuto lasciare il carcere di Secondigliano dove era recluso da due anni.
Finì in cella, infatti, nel 2020, nel pieno della pandemia. Nonostante fosse un
ultraottentenne. Nonostante le pattuglie, una sfilza di diciassette voci sulla
cartella clinica. Nonostante fosse ridotto a una larva umana, per usare
l’espressione utilizzata da chi, tra garanti e politici, si è recato in questi
mesi in carcere a visitare il detenuto e constatare con i propri occhi le
condizioni sue e della sua reclusione. L’ultima visita c’era stata pochi giorni
fa. Il 19 febbraio scorso, il garante di Napoli Pietro Ioia era stata nel
penitenziario di Secondigliano insieme alla senatrice del M5S Cinzia Leone e
alla criminologa Patrizia Sannino, vice presidente dell’associazione Carcere
vivo.
«Stare in carcere
a 88 anni non è giustizia ma vendetta, è come una condanna a morte» aveva
commentato Ioia al termine della visita. «Finalmente un po’ di umanità», ha
aggiunto ieri il garante cittadino alla notizia della scarcerazione di
Montescuro. «La dignità di un essere umano è stata rispettata – ha affermato – .
Montescuro non poteva più restare in carcere, rischiava di morire da un momento
all’altro. Voglio ringraziare il garante regionale Samuele Ciambriello e tutte
le persone che si sono attivate con il sottoscritto», ha concluso Ioia
ringraziando anche il Riformista per le sue battaglie in nome del garantismo e
di una giustizia giusta. La storia di Carmine Monrescuro riaccende i riflettori
su uno degli aspetti più delicati e difficili del sistema penitenziario, quello
dei detenuti anziani. Nel nostro Paese la percentuale di reclusi over 70 è
aumentata negli ultimi quindici anni.
Secondo le
statistiche ministeriali, se nel 2005 nelle carceri si contavano 350 detenuti
con un’età superiore ai 70 anni, nel 2021 se ne contano 993. Quasi il triplo.
Negli anni, infatti, la popolazione detenuta è stata sempre più composta da
anziani. Basti pensare che dai 350 detenuti ultrasettantenni del 2005 si è
passati a 594 nel 2014, 776 nel 2017, 986 nel 2019. Nel 2020, anche a causa
della pandemia, il numero dei detenuti anziani rinchiusi in carcere era sceso a
851 per poi risalire nel 2021 a 993. La Campania segue questo trend, nel senso
che è in aumento da alcuni anni anche l’età media della popolazione rinchiusa
nelle celle delle carceri di Poggioreale e Secondigliano. Lo avevano segnalato i
garanti Ciambriello e Ioia nell’ultimo rapporto sulle carceri: troppi detenuti e
troppo anziani era il dato. Numeri che si traducono in una serie di criticità se
si considera che in carcere ci sono molte barriere architettoniche e poche
risorse per garantire assistenza a un detenuto che si muove sulla sedia a
rotelle, che non è autosufficiente, che ha bisogno di visite mediche
specialistiche frequenti. criticità che si traducono in diritti mortificati e in
una giustizia che rischia di perdere di vista l’umanità.
Viviana Lanza.
Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è
giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed
economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del
quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il
Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Il carcere è un inferno, lo
dicono anche gli agenti.
Viviana Lanza su Il Riformista il 24 Febbraio 2022.
Il carcere è un luogo
invivibile, che esaspera gli animi e schiaccia ogni diritto della persona, anche
i più elementari. Ora lo dicono a voce alta anche gli agenti della polizia
penitenziaria, quelli che all’interno degli istituti di pena rappresentano lo
Stato, lo stesso Stato che lascia che le carceri continuino ad essere un
inferno. Ieri a Napoli gli agenti della polizia penitenziaria hanno organizzato
una protesta. Con striscioni e bandiere delle più rappresentative sigle
sindacali, si sono riuniti davanti alla sede dell’amministrazione penitenziaria
della Campania. «Non siamo torturatori ma torturati da un sistema penitenziario
poco dignitoso per uno Stato che si definisce civile. Diciamo basta!», hanno
affermato gridando i loro i disagi, i loro problemi.
Certo, la loro, è una
battaglia di categoria. ma si spera che possa servire per accendere un faro in
più nel buio dell’indifferenza con cui i più guardano al sistema carcere e alle
condizioni inumane nelle quali sono lasciati i detenuti, in particolare i più
soli nella società, gli ultimi. Sventolando bandiere dei sindaci Osapp, Sinappe,
Uilpa, Uspp, Fns Cisl, Cnpp, Cgil, agenti della polizia penitenziaria e
rappresentanti sindacali hanno partecipato al sit-in di protesta «contro vertici
politici e un Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria silente», «che –
accusano i sindacati della penitenziaria – intende disporre degli uomini e di
donne in divisa come meglio crede». Cosa chiedono i sindacati, che giorni fa
hanno anche indetto lo stato di agitazione? «Il ripristino delle non più
sostenibili condizioni lavorative del personale di polizia penitenziaria in
servizio presso gli istituti per adulti e minorenni e un miglioramento delle
relazioni sindacali con i l provveditorato regionale dell’amministrazione
penitenziaria della Campania». «Siamo qui, tutti i sindacati della polizia
penitenziaria riuniti perché da anni c’è uno stato di abbandono. Soltanto in
Campania mancano 600 agenti, serve una riforma del sistema penitenziario», ha
affermato Ciro Auricchio, segretario regionale Uspp.
«Il Governo è assente, le
norme non sono più adeguate e le carceri sono vetuste e non più in grado di
garantire sicurezza sociale», ha aggiunto Lorenza Sorrentino, segretario
regionale Fns Cisl. Una battaglia di categoria, dicevamo. Al difficile quadro
descritto dai sindacati della penitenziaria aggiungiamo noi, occorre non
dimenticare le condizioni spesso invivibili nelle quali si trova a vivere una
gran parte dei detenuti della Campania. Il sovraffollamento ne è la principale
causa, a cui vanno aggiunti gli scarsissimi investimenti nelle attività di
rieducazione dei detenuti, le carenze negli organici di figure come educatori e
psicologi, una mancata attenzione per anni all’edilizia e all’architettura
penitenziaria, e il fallimento della sanità penitenziaria e della tutela della
salute delle persone private della libertà, il fallimento delle Rems, cioè delle
strutture sanitarie di accoglienza per autori di reato affetti da disturbi
mentali e ritenuti socialmente pericolosi. Fallimenti di cui parlano anche gli
agenti della polizia penitenziaria, denunciando la mancanza di figure
specializzate all’interno degli istituti di pena e le difficoltà riscontrate
dagli agenti stessi nell’improvvisarsi psicologi o operatori nella gestione di
detenuti con problemi psichiatrici.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Non c’è più tempo: bisogna
fermare la strage. Detenuti o agenti, il carcere è una fabbrica di suicidi:
quali sono le cause.
Alessandro Capriccioli su Il Riformista il 16 Febbraio 2022
Se c’è una cosa utile che
la pandemia ci ha regalato, tra tanti aspetti negativi e spesso tragici, è un
minimo di dimestichezza in più con un approccio basato sui numeri, che permetta
di interpretare la realtà prescindendo dalle sensazioni soggettive e basandosi
sull’obiettività dei dati. Si tratta di un metodo che, epidemie a parte, può
essere applicato a qualsiasi fenomeno della nostra società, e che forse è
opportuno adottare anche per affrontare la questione dei suicidi in carcere,
visto che le sole notizie in merito, ancorché drammatiche, non sembrano
sufficienti a destare la giusta attenzione.
Andiamo per ordine, e diamo
un’occhiata ai numeri che abbiamo a disposizione. Dall’inizio dell’anno nelle
carceri del nostro paese si sono tolte la vita dodici persone detenute (undici
uomini e una donna), corrispondenti alla media (spaventosa) di un suicidio ogni
tre giorni e mezzo. Naturalmente si tratta di un lasso di tempo troppo ristretto
per trarre conclusioni generali. Per costruire una visione d’insieme più solida
dobbiamo prendere in esame un periodo più significativo, ad esempio quello che
va dal 2000 al 2021: ventidue anni in cui nelle nostre carceri si sono tolte la
vita 1.222 persone, pari a una media di 55,5 suicidi l’anno. Poiché dagli inizi
degli anni duemila il numero dei detenuti nei nostri istituti penitenziari si è
mantenuto relativamente stabile, attestandosi su un livello medio pari a
circa 58mila unità (stiamo trattando i numeri in modo approssimativo, ma più che
sufficiente a ottenere una stima di massima), si ricava con facilità che la
media di suicidi nell’ambito della nostra popolazione carceraria è pari a circa
nove suicidi ogni diecimila persone.
Già a prima vista non è
difficile comprendere che si tratta di un numero molto alto. Ma per apprezzare
appieno la sua entità sarà utile raffrontarlo col tasso di suicidi nella
popolazione generale. Grazie ai dati elaborati dall’Istituto superiore di
sanità sappiamo che in Italia si registrano ogni anno circa 4.000 morti per
suicidio. Prendendo in esame la popolazione con età superiore a 15 anni (non
solo perché il suicidio è un evento statisticamente molto raro nell’infanzia, ma
anche perché questa operazione ci aiuta a comparare il dato con quello degli
istituti penitenziari, nei quali accedono quasi esclusivamente gli adulti)
questo dato corrisponde grosso modo a un tasso di 10 suicidi ogni 100mila
abitanti, che riportato alla stessa scala utilizzata per i detenuti equivale
circa a un suicidio ogni diecimila individui. Dal raffronto tra i due indici si
può concludere che il tasso suicidario nella popolazione carceraria è pari a
circa nove volte quello riscontrabile nella popolazione generale.
Questo risultato, al di là del
modo rudimentale con cui l’abbiamo ottenuto, ci dice in modo molto chiaro che il
numero dei suicidi negli istituti penitenziari non è grande: è enorme. La
reclusione in carcere rappresenta un gigantesco fattore di rischio in relazione
all’eventualità del suicidio, perché chi viene recluso ha una probabilità di
togliersi la vita quasi decuplicata rispetto a chi conduce una vita libera.
Tutto ciò senza contare i tentativi di suicidio sventati o semplicemente non
andati a buon fine, di cui non è materialmente possibile tenere il conto (ma che
chi frequenta il carcere sa essere molto numerosi), e la frequenza degli episodi
di suicidio tra gli agenti di polizia penitenziaria, anch’essa ampiamente
superiore alla media nazionale.
Le cause di questa
macroscopica differenza tra probabilità di suicidio in carcere e probabilità di
suicidio fuori dal carcere sono ormai arcinote, perché formano oggetto di
analisi e studio da decenni. Si tratta di cause sistemiche, più che puntuali: se
da un lato è evidente che determinate condizioni (l’abuso della custodia
cautelare, il sovraffollamento, le condizioni strutturali dei singoli istituti,
la ridotta quantità di attività lavorative e ricreative in determinate realtà)
fanno aumentare la possibilità di eventi critici, dall’altro è ormai acclarato
che il grosso del rischio si deve alla privazione della libertà in quanto tale,
che determina con grande frequenza stati di ansia, di depressione e
di disperazione.
Il carcere, insomma, è una
fabbrica di suicidi. E meraviglia, perfino al di là del disinteresse endemico
che la nostra classe politica nutre nei confronti del mondo penitenziario, che
un dato così allarmante non sia sufficiente a indurre un complesso di iniziative
che investa almeno due fronti: da un lato gli interventi che sarebbe possibile
operare da subito per migliorare le condizioni di vita delle persone detenute,
per incrementare il ricorso alle misure alternative e per ridurre ai minimi
termini l’istituto della carcerazione preventiva; dall’altro un ripensamento
profondo della funzione e dell’effettiva utilità dell’istituzione carceraria,
nell’ottica della sua progressiva riduzione al campo dell’extrema ratio e
perciò, nella maggior parte dei casi, del suo superamento. Non c’è più tempo da
perdere. Perché si tratta, numeri alla mano, di fermare una strage.
Alessandro Capriccioli.
Consigliere regionale del Lazio di +Europa Radicali
Carcere di Taranto
stracolmo: 700 detenuti su 350 posti disponibili.
La denuncia del Sappe:
«Inesistenti per i detenuti i progetti lavorativi all’interno e all’esterno del
carcere, propedeutici al reinserimento così come sancisce l’articolo 27 della
carta costituzionale». Il Dubbio il 15 febbraio 2022.
«Taranto è sicuramente tra le
carceri più affollate della nazione con circa 700 detenuti a fronte di 350 posti
disponibili e con un organico di polizia penitenziaria totalmente
insufficiente». Così il segretario nazionale del Sappe (Sindacato autonomo di
polizia penitenziaria), Federico Pilagatti, nel documento che oggi sarà
consegnato al sottosegretario alla Giustizia, Anna Macina, a conclusione della
visita nel carcere di Taranto. «In ogni sezione detentiva sono ospitati circa 70
detenuti senza spazi nelle stanze, con grave carenza di attività trattamentali,
rieducative e sportive», si legge nel documento.
«Praticamente inesistenti per
i detenuti i progetti lavorativi all’interno e all’esterno del carcere,
propedeutici al reinserimento così come sancisce l’articolo 27 della carta
costituzionale. Noi riteniamo che dare la possibilità di impiegare i detenuti in
attività lavorative e rieducative, sia l’unico modo per evitare disordini,
proteste, pericoli nonché situazioni di degrado», prosegue il Sappe.
«Denunciamo l’insufficiente
assistenza sanitaria ai detenuti di cui moltissimi affetti da patologie molto
serie e la presenza di un altissimo numero di detenuti con problemi psichiatrici
a cui l’Asl risponde con un numero di ore assegnate agli specialisti inadeguato.
Da due mesi un detenuto con problemi psichiatrici è dimenticato presso ospedale
di Taranto, poiché non si trova una Rems, con enormi costi economici di mezzi e
uomini», va avanti il sindacato.
«La sicurezza non può essere
garantita né dai poliziotti e nemmeno dalle apparecchiature elettroniche
considerata che presso la sala regia si riscontra inefficienza di
strumentazioni, con monitor e apparecchi di videosorveglianza e sistemi di
sicurezza attivi, assenti o non funzionanti», sottolinea il Sappe. «Vogliamo
anticipare che il prossimo 22 febbraio, il Sappe manifesterà davanti al carcere
per denunciare tutta la situazione sin qui raccontata, che purtroppo non investe
solo il carcere di Taranto ma l’intera regione, considerato che in 20 anni si è
ridotto l’organico della polizia penitenziaria nelle carceri pugliesi di circa
600 unità, con centinaia di detenuti in più», conclude il sindacato.
La Consulta: troppi 250
euro al giorno per tramutare il carcere in pena pecuniaria.
La Corte costituzionale ha
dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 53, secondo comma, della
legge n. 689 del 1981, per la violazione dei principi di eguaglianza e finalità
rieducativa. Damiano Aliprandi su Il Dubbio l'1 febbraio 2022.
La pena pecuniaria è una seria
alternativa a quella carceraria, ma il tasso minimo di 250 euro al giorno
previsto dalla legge trasforma la possibilità di sostituire il carcere in un
privilegio per i condannati abbienti. Questo, in sintesi, ha affermato la Corte
costituzionale nella sentenza n.28 (redattore Francesco Viganò), con la quale ha
dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 53, secondo comma, della
legge n. 689 del 1981, per violazione dei principi di eguaglianza e finalità
rieducativa della pena.
La Corte ha perciò ritenuto
che ai 250 euro debbano essere sostituiti i 75 euro già previsti dalla normativa
in materia di decreto penale di condanna, fermo restando l’attuale limite
massimo giornaliero di 2.500 euro. Peraltro, poiché il Parlamento ha
recentemente delegato il governo per modificare la disciplina della sostituzione
della pena detentiva, la Corte ha sottolineato che il legislatore può, nella sua
discrezionalità, individuare soluzioni diverse e, in ipotesi, ancor più aderenti
ai principi costituzionali definiti nella sentenza.
La norma censurata dal
Tribunale di Taranto prevede che il giudice può sostituire le pene detentive non
superiori a sei mesi con una pena pecuniaria, il cui ammontare si ottiene
moltiplicando i giorni della pena da sostituire per un importo a carico
dell’imputato, stabilito tenendo conto delle sue condizioni economiche. Importo
che però, nella formulazione dichiarata incostituzionale, non può essere
inferiore a 250 euro al giorno. La Consulta ha rilevato che, se l’impatto di
pene detentive della stessa durata è, in linea di principio, uguale per tutti i
condannati, non altrettanto può dirsi per le pene pecuniarie: una multa di mille
euro, ad esempio, può essere più o meno afflittiva secondo le disponibilità di
reddito e di patrimonio del singolo condannato.
Nella prospettiva di
un’eguaglianza “sostanziale” e non solo “formale”, allora, la sentenza
sottolinea la necessità che il giudice possa sempre adeguare la pena pecuniaria
alle reali condizioni economiche del reo, per evitare che risulti
sproporzionatamente gravosa. Una quota giornaliera minima di 250 euro, ha
proseguito la Corte, è ben superiore alla somma che la gran parte delle persone
che vivono oggi nel nostro Paese sono ragionevolmente in grado di pagare.
Moltiplicata poi per il numero di giorni di pena detentiva da sostituire, una
simile quota conduce a risultati estremamente onerosi per molte di queste
persone.
Emblematico il caso esaminato
dal Tribunale di Taranto: una persona condannata per violenza privata, per il
parcheggio dell’auto davanti a un passo carraio, aveva patteggiato la
sostituzione della pena di tre mesi di reclusione e quindi, in base alla norma
censurata, avrebbe dovuto pagare ben 22.500 euro, molto più dei suoi redditi
annui. Un coefficiente di conversione così elevato ha determinato, nella prassi
dei Tribunali, una drastica compressione della sostituzione della pena
pecuniaria, che è invece uno strumento prezioso per evitare che, per un reato di
modesta gravità, si finisca in carcere, con effetti più criminogeni che
risocializzanti. La Corte costituzionale ha concluso che solo una disciplina
della pena pecuniaria in grado di garantirne una misura proporzionata alla
gravità del reato e alle condizioni economiche del reo, nonché la sua effettiva
riscossione, può costituire una seria alternativa alla pena detentiva, così come
di fatto accade in molti altri Paesi.
Chi sono i
“liberi sospesi”, 80 mila in attesa di misure alternative per più tempo della
pena…Valentina
Manchisi su Il Rifromista il
25
Febbraio 2022.
Il dibattito
sull’irragionevole lentezza del processo penale in Italia è, purtroppo, sempre
attuale. Altrettanto tristemente attuale è il dramma del carcere ogni qual volta
esso venga applicato. Famiglie, affetti, psiche di chi finisce nelle maglie del
sistema penale vengono tragicamente devastati. Nell’alveo delle risposte del
nostro sistema sanzionatorio esiste poi una zona grigia, tanto consistente
quanto poco dibattuta se non per motivi meramente organizzativi: la fase di
concessione delle misure alternative alla detenzione, applicabili quando le pene
non sono eccessivamente elevate e se non riguardano condanne per reati ostativi.
Sarebbero risposte sanzionatorie da far invidia a qualsiasi sistema special
preventivo, se non fosse per una grave falla del sistema: vengono applicate a
distanza di parecchi anni non solo dal fatto commesso, ma anche dal momento in
cui vengono richieste.
I Tribunali di
Sorveglianza scoppiano, e si è tentato di alleggerirne il carico attribuendo al
singolo Magistrato di Sorveglianza la competenza per le pene di minore entità,
peraltro con una decisione priva di precedente contraddittorio che quindi viene
fortemente ridotto seppur in un momento tanto delicato perché direttamente
incisivo sulla libertà della persona. Sono anni che Rita Bernardini solleva la
questione delle circa ottantamila persone che attendono una risposta alla
propria istanza di espiazione della pena in misura
alternativa al carcere: ottantamila “liberi sospesi”, persone che in molti casi
hanno sì commesso reati nel passato, ma che nei lunghi anni del processo penale
a loro carico e dell’attesa del procedimento in Sorveglianza hanno ripreso
autonomamente in mano la propria vita, ripagato i danni civili e morali causati
con le proprie condotte, trovato lavoro stabile, creato una famiglia. Persone
che improvvisamente si ritrovano a temere che un Tribunale o un Magistrato possa
applicare loro una misura più o meno privativa della libertà personale, carcere
compreso.
Il numero di anni
che trascorre tra il momento dell’istanza di misura alternativa del condannato e
il momento in cui viene emessa la decisione non di rado supera moltissimo
l’entità della pena stessa. Un tempo in cui tante persone, ben prima
dell’intervento dello Stato educatore, possono dare concretamente prova di aver
ricostruito autonomamente una vita risocializzata. Non esiste nel nostro sistema
– penale e penitenziario – un meccanismo che possa avallare un’avvenuta
riconciliazione di questi soggetti con la società, quand’anche essi abbiano già
restituito e ricostruito. Così, quella di tanti “liberi sospesi” diviene
un’espiazione ben più lunga rispetto a quella prevista dalla sentenza di
condanna, creando una condizione disumana e che riporta indietro di anni il
positivo percorso di vita di costoro. È un’afflizione aggiuntiva, una pena oltre
alla pena. Qualcosa di più della sanzione, che però non trova fondamento in una
norma di legge bensì solo nell’inerzia, nel malfunzionamento, nella carenza di
risorse e di personale: un sistema colabrodo in cui ciclicamente si cerca di
salvare il salvabile tra un rattoppo legislativo e un protocollo organizzativo.
Vien da
domandarsi se, a tali condizioni, non sia da ridiscutere il concetto di
esigibilità della pena quando quest’ultima non risponda più alla primaria
esigenza di rieducazione del condannato sancita dall’articolo
27 della Costituzione. La certezza della pena, intesa ciecamente quale risposta
automatica e a prescindere dalla realtà fattuale e personale del singolo
individuo a cui è stata comminata, nei fatti si traduce in una mera prassi
burocratica: deve avere il suo corso perché la legge così stabilisce e anche
perché la società non può accettare che un condannato non sconti la sua
condanna. Una riflessione va fatta anche in relazione al principio di
uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, secondo il quale, con una
lettura a contrario, situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso e
che, perciò, non viene rispettato se la pena viene applicata a prescindere dai
profili rieducativi, quand’anche essa non ne abbia.
Esiste la
prescrizione della pena, controbatteranno i puristi del codice Rocco. Ma il
presupposto di tale istituto è che l’esecuzione non sia in corso e così le
richieste di misure alternative alla detenzione finiscono affollate in
quell’imbuto chiamato Tribunale. Servirebbe che il legislatore intervenisse per
modificare tutte le norme rilevanti sul sistema sanzionatorio e per prevedere,
in caso di tardiva trattazione delle richieste di misura alternativa, una
valutazione sull’esigibilità della pena in ogni singolo caso concreto, nel pieno
rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e di rieducazione, poiché in
una società che possa dirsi rispettosa dei diritti umani fondamentali non è
ammissibile un meccanismo automatico ove le falle burocratiche minano ogni
giorno la vita di chi, invece, nello Stato dovrebbe trovare una maggiore tutela.
Valentina Manchisi
Sono un migliaio i detenuti
privati del diritto alla misura alternativa.
Le istanze di misura
alternativa vengono rigettate perché i detenuti con una pena totale o residua
inferiore a 3 anni non hanno casa e lavoro. Damiano Aliprandi su Il Dubbio il 31
gennaio 2022.
Il nostro sistema
penitenziario tende a far scontare la pena carceraria anche per reati minori,
contribuendo quindi all’idea che il carcere possa e debba essere la soluzione
unica e definitiva. Una parte di loro, hanno un doppio svantaggio. Nonostante ne
abbiano il diritto, non posso usufruire della misura alternativa per via delle
loro condizioni di marginalità sociale. La possibilità è offerta a coloro che si
trovano a dover scontare una pena totale o residua inferiore a 3 anni.
Ma tanti di loro non possono
per mancanza di casa, lavoro e legami familiari. Viene meno, per loro, la
volontà di creare un ponte verso l’esterno al fine di garantire un inserimento
sociale a tutti coloro che hanno affrontato il percorso rieducativo.
Il Garante nazionale delle
persone private della libertà, nell’ultima presentazione della relazione annuale
al Parlamento, ha sottolineato la presenza di più di un terzo di persone
detenute che hanno una previsione di rimanere in carcere per meno di tre anni.
«È un tema – ha relazionato il presidente Mauro Palma – che chiama alla
responsabilità anche il territorio perché il carcere da solo non può rispondere
ad altre carenze».
Ed è il territorio che non si
prende a carico del problema. Emblematico l’esempio di un recente progetto degli
“Avvocati di strada”, proprio sul tema dei senza fissa dimora che finiscono in
carcere. Fa l’esempio di una persona condannata a 1 anno e 5 mesi, che a seguito
delle vicissitudini legate alla precarietà del lavoro, dei rapporti familiari e
relazioni che caratterizzano la nostra società, ha perso la casa, magari dopo un
mutuo pagato per 10 anni su 20 e che ora vive in strada e quando è fortunato
riesce a passare qualche notte in dormitorio e garantirsi una doccia calda.
Ecco, questa persona vedrà
rigettarsi la domanda di misura alternativa: alla voce “residente” o
“domiciliato in” avrà difficoltà. Qualora sia un minimo fortunato e abbia una
residenza da dichiarare, sarà sicuramente difficile compilare la voce attività
lavorativa svolta, attività di volontariato svolta, percorso di rieducazione
svolto. Soprattutto se da solo di fronte a quel modulo. Per il nostro senza
dimora si apriranno, quindi, le porte dell’istituto penitenziario, ma
soprattutto si apriranno tutte le porte dei rischi che il carcere oggi comporta
in Italia.
«Così un giudice ha salvato
un ragazzino dal baratro».
Annalisa Costanzo su Il Dubbio il 4 febbraio 2022.
La nuova vita del 17enne che
diede fuoco all’auto di un clochard, che rimase ucciso. Un giudice che ha deciso
di interpretare alla lettera l’articolo 27 della Costituzione.
Ha pianto e si è anche
disperato in questi anni, al ricordo di quella vita spezzata. Uno stupido e
dannato scherzo iniziato «per noia», insieme all’amico13enne, costato però la
vita ad Ahmed Fdil, clochard marocchino di 64 anni. Non la dimenticherà mai
quella fredda e cupa serata del 13 dicembre del 2017, quando le fiamme si
levarono alte nel piccolo centro di Santa Maria di Zevio, nel veronese, e che
per colpa sua uccisero “il baffo”.
Dopo l’omicidio, il processo è
stato sospeso ed è stata disposta la messa in prova. L’allora 17enne, unico
imputato per l’omicidio Ahmed, si è rimboccato le maniche ed ha lavorato sodo,
su se stesso soprattutto, per non sprecare quell’unica possibilità di redenzione
che il giudice gli ha concesso. Un giudice che ha deciso di interpretare alla
lettera l’articolo 27 della Costituzione: le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato e non alla sua espulsione dalla società. Proprio
come la stessa procura aveva richiesto.
In questi ultimi quattro anni
di «messa alla prova», ha lavorato al servizio della comunità, si è occupato
anche dei disabili, li ha fatti sorridere qualche volta, si è affezionato a
loro. Ha proseguito gli studi. Si è diplomato e adesso vorrebbe diventare uno
chef. Ha poi seguito il percorso di psicoterapia così come disposto dal giudice,
ha portato avanti la massa in prova e le relazioni dei servizi sociali su di lui
sono state un fiume d’inchiostro positivo.
I sensi di colpa lo
accompagneranno per il resto della sua vita, ma adesso è un uomo libero. Oggi ha
21 anni, ma in quella comunità protetta che lo ha visto diventare uomo ci è
entrato quando aveva appena 17 anni, pochi giorni dopo che per noia, con un
fazzoletto «rubato» da una pizzeria, insieme ad un amico 13enne, diede fuoco
alla vecchia Fiat Bravo dove Ahmed stava riposando. Ahmed – come dirà in
processo uno dei periti – è stato arso vivo, morendo inghiottito dalle fiamme.
Anche se, ancora, non è chiaro come un fazzoletto incendiato abbia potuto
scatenare quel fuoco mortale.
Quando nel 2017 per noia
bullizzava il 64enne, l’allora 17enne non era di certo un ragazzo facile da
gestire. Proveniente da uno stato dell’Europa orientale, non era riuscito ad
integrarsi nella comunità veronese. Aveva stretto amicizia con un altro
straniero, quel 13enne proveniente dal nord Africa con cui passava molte ore
della giornata, compresa quella del 13 dicembre 2017. Un omicidio, due colpevoli
e «nessun giorno di carcere per quei ragazzi», dice il nipote della vittima. Il
13enne, infatti, era troppo piccolo per essere imputabile. L’unico ad essere
processato fu dunque il 17enne. Maria Teresa Rossi, giudice di quel difficile
processo, tenendo conto della giovane età dell’imputato, ha deciso però di
escludere la misura detentiva in carcere ed ha scelto di applicare la legge
dell’ordinamento italiano che prevede l’affidamento in prova ai servizi sociali.
Il tribunale di Verona ha
dunque puntato sul recupero del reo e, viste le positive relazioni dei servizi
sociali, non ha fallito. «Chapeau a chi ha capito che poteva tentarci ed a chi
dopo, assistenti sociali e comunità, ha lavorato con e sul ragazzo», dichiara
al Dubbio il suo avvocato, Giovanni Bondardo, raccontando la storia di un
processo minorile in cui «la messa alla prova ha funzionato». Grazie alla parte
pubblica, «che ha lavorato – dice – bene e salvato un ragazzo. Gli assistenti
sociali hanno fatto un buon lavoro. La struttura che lo ha avuto in affidamento
ha lavorato molto bene. Il ragazzo si è impegnato e adesso è cambiato
completamente – conclude l’avvocato Bondardo -. È un’altra persona». Non è stato
facile per il ragazzo. Gli incontri con la madre venivano monitorati dagli
assistenti sociali. Ogni respiro veniva rivelato, ogni passo valutato.
Due volte alla settimana
faceva volontariato in una struttura che si occupa di pet therapy. Niente
cellulari, niente vita sociale fuori dalla comunità. E, dopo gli anni trascorsi
dentro quella zona protetta, il ventunenne, mesi fa, ha potuto riabbracciare la
madre, con la quale adesso vive, sempre nel veronese. Da uomo libero ha ripreso
a sognare. Vuole una vita normale. Non dimentica e non dimenticherà mai quel che
ha fatto. Nessun abitante di quel piccolo centro dell’hinterland veronese,
d’altronde, ha mai dimenticato l’orribile morte toccata a Ahmed Fdil. Si era ben
ambientato nella comunità veronese il 64enne marocchino, capelli brizzolati e
quei baffoni neri per i quali si era aggiudicato il dolce soprannome de «il
baffo».
Una vita dignitosa la sua,
fino alla perdita del lavoro che l’ha costretto a vivere in macchina. Era così
diventato un senzatetto e aveva scelto la sua Fiat Bravo come nuova abitazione,
non immaginando però che per la noia di due ragazzini quell’auto sarebbe
divenuta la sua tomba. Per giorni, dopo quel 13 dicembre, procura e
investigatori sono stati convinti che si trattasse di un incidente.
Nell’immediatezza l’omicidio
non era stato preso in considerazione. Santa Maria di Zevio, però, è un piccolo
centro e, come in tutte le piccole comunità, la verità ha preso velocemente a
passare di bocca in bocca, spingendo i carabinieri ad indagare. E a capire che
Ahmed era benvoluto da tutti, tranne che da un gruppo di ragazzetti che in lui
vedevano la valvola di sfogo della loro noia.
La verità poi scoperta dai
militari dell’Arma fu agghiacciante. «Abbiamo preso le salviette, poi siamo
andati nel parcheggio dove c’era il baffo», raccontarono i due ragazzini ormai
smascherati, per poi iniziare a rimpallare le accuse su chi avesse acceso e
lanciato dentro la macchina quel fazzoletto infuocato. «L’ha lanciato lui», «no,
lui». Fino ad ammettere: «Siamo andati lì perché non avevamo niente da fare»,
con l’intenzione, dissero, di fare uno scherzo a baffo. Uno scherzo che ha
ucciso un uomo e cambiato per sempre le loro vite.
Caso Ahmed Fdil, quel
ragazzino in libertà può indignare: ma così vince il diritto.
Un delitto atroce quello del
clochard arso vivo nell'auto che era diventata la sua casa. Ma all'orrore non si
ripara con l'orrore. Il commento di Maria Brucale, avvocato di Nessuno Tocchi
Caino. Maria Brucale Il Dubbio il 05 febbraio 2022.
Sono trascorsi quattro anni da
quando Ahmed Fdil, una persona di 64 anni divenuta senza tetto per aver perso il
lavoro, è stata uccisa dal fuoco in una vecchia auto che era diventata la sua
casa. Ad accendere l’incendio erano stati due adolescenti annoiati, uno di 13 e
uno di 17 anni, che avevano lanciato accanto all’auto due pezzi di carta presi
da una pizzeria da asporto e dati alle fiamme, “per scherzo”, così avevano detto
confessando il crimine, senza rendersi conto delle conseguenze atroci di quel
terribile gesto. Il tredicenne non era allora imputabile.
Per il diciassettenne non si
sono aperte le porte del carcere perché il tribunale dei minori ha ritenuto,
conformemente alla legge, che il profilo personale del reo e la sua giovanissima
età consentissero ampie possibilità di reinserimento e di emenda e che il
carcere non avrebbe giovato a quel giovane quanto un percorso serio e
responsabile di riparazione condotto in una località protetta prestando
assistenza ad anziani e disabili. Oggi il ragazzo ha concluso la prova decisa
dai giudici e i servizi sociali danno conto di una concreta utilità del
trattamento disposto che ha prodotto una piena maturazione e una fattiva presa
di coscienza del crimine commesso. Ove il tribunale, a breve nuovamente
interpellato, ravviserà, come appare prevedibile, il buon esito della c.d.
“messa alla prova”, l’autore di quel gesto indicibile sarà completamente libero.
Comprensibili tutti i
sentimenti di disagio e di sdegno accesi da una condotta che in sé palesa un
disadattamento intimo e profondo, indifferenza sprezzante verso la condizione di
solitudine e di miseria dignitosa e composta di un clochard, disprezzo della
vita. Comprensibili ed empaticamente del tutto condivisibili e, tuttavia, c’è
una ragione superiore che deve governare l’agire dello Stato quale tutore della
sicurezza sociale e garante di un concetto più alto, esule dalle spinte
emozionali, di Giustizia: l’utilità sociale, il risanamento di uno strappo con
una visione lungimirante di prospettiva. E allora lo Stato dovrà tenere conto
delle necessarie diversificazioni richieste dalla particolare fragilità dei
minori che commettono reati, e dalla opportunità di rispondere alle condotte
criminose con strumenti che traducano la tensione punitiva in aspirazione
educativa e di recupero.
In tale ottica, del rispetto
di una particolare condizione di vulnerabilità, della necessità di educare la
persona che sia incorsa da minorenne nel crimine e di determinarne la adesione a
modelli sociali alternativi e positivi, di sanzionare con intelligenza
prospettica ed indulgenza il minore il cui ricorso al crimine può essere stato
determinato da condizionamenti esterni – sociali o familiari – cui non è stato
in grado di contrapporre una resistenza matura e consapevole, il carcere deve
essere considerato davvero come extrema ratio e rispondere a criteri di assoluta
inevitabilità. Gli studi ed i progetti di legge elaborati negli ultimi anni, le
indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale – troppo spesso costretta a
vestire i panni di un indolente legislatore – dalle direttive europee, dalle
circolari ministeriali, tutti assecondano tale medesima intenzione: relegare la
pena in carcere ad un ambito del tutto residuale e prediligere l’esecuzione
penale “aperta” o extramoenia tesa alla integrazione sociale ed alla
responsabilizzazione di soggetti ancora da educare, non da rieducare. E, allora,
la pena detentiva appare del tutto inutile quando non dannosa mentre risponde ad
un’ottica concreta di tutela della collettività e tende a prevenire la
commissione di ulteriori reati la scelta di favorire la responsabilizzazione,
l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minore, la preparazione alla
vita libera, l’integrazione.
La tutela della società
impone, insomma, la declinazione di un nuovo e più sensato e costruttivo
concetto di sicurezza sociale. A fronte di una condotta orribile non è utile una
pena orribile. La logica della protezione sociale pone a interrogarsi
pragmaticamente su quale sia da parte dello Stato la condotta più feconda per
sanare una ferita ormai inferta e a volte tragicamente irrimediabile. Non può
non tornare in mente il motto fatto bandiera da Marco Pannella e divenuto icona
della azione nonviolenta dell’associazione Nessuno Tocchi Caino: Spes contra
Spem. Il posto di Caino è in società. Caino rappresenta l’umanità intera e la
sua inclinazione all’errore e alla violenza ma la estrinsecazione della ferocia
rappresentativa della stessa natura umana non deve essere repressa con pari
ferocia. Caino deve avere un’altra opportunità. Abele è morto e su di lui si
versano la pietà e il dolore di quanti lo hanno amato e di chiunque abbia subito
la lacerazione di una morte cruenta, terribile, ingiustificabile. La punizione
di Caino non la ripara, non sana le ferite, non recupera, non restituisce, non
offre ristoro alla società se non quello del tutto umano del volere la
sofferenza di chi ha determinato la nostra, del bisogno di vendetta, figlio
anch’esso della stessa passione umana che conduce all’orrore della violenza.
Un impulso intimamente del
tutto condivisibile e, tuttavia, socialmente non utile, determinato dal bisogno
di ferire non di sanare, costituzionalmente ammesso solo laddove serva a
contenere, a tutelare la società dalla reiterazione del delitto. La punizione
fine a sé stessa, quella che ognuno di noi vorrebbe feroce ed estrema a colpire
chi ci ha ferito, chi ci ha privato di un affetto, chi ci ha procurato un dolore
incancellabile non è ammessa se è socialmente inutile. Se quel giovane ha
compreso, se ha tradotto quell’orrore in consapevolezza del valore della vita,
se ha maturato empatia per chi soffre e rispetto dei suoi simili e di ogni
condizione di vulnerabilità lo Stato di Diritto ha vinto senza procurare nuove
ferite.
Le promesse e le proposte
di legge dimenticate. La vergogna infinita dei bambini in carcere, uno scandalo
che la politica non riesce a evitare.
Giulio Cavalli su Il
Riformista il 28 Gennaio 2022.
«Entro il 2015 nessun bambino
sarà più detenuto». Era il 2015 e l’allora ministro della giustizia Andrea
Orlando nel penitenziario di Rebibbia, di fronte a otto mamme incarcerate con i
loro figli aveva promesso «la fine di questa vergogna contro il senso di
umanità»: «non possiamo privare un bambino della libertà, è innocente ma allo
stesso tempo ha diritto di vedere sua madre. – aveva detto Orlando – Abbiamo tre
obiettivi da realizzare prima possibile: il primo è la fine della detenzione per
questi piccoli, il secondo è quello di rivedere le modalità con cui avvengono i
colloqui tra genitori e figli.
Abbiamo firmato un protocollo
d’intesa con l’associazione “Bambini senza sbarre” e con il Garante per
l’Infanzia per ridefinire l’accoglienza in carcere». Il 15 luglio del 2015 nei
penitenziari italiani c’erano 33 donne che stavano scontando la pena con i loro
bambini: 15 accolte negli Icam (gli istituti a custodia attenuata per detenute
madri) di Milano, Torino e Venezia e le altre 19 in normali carceri. Sono
passati 7 anni e i dati ci dicono che al 31 dicembre scorso nel sistema
penitenziario italiano si trovavano 18 bambini reclusi. Un anno fa erano 29 e,
al 31 dicembre del 2018, 52. La “vergogna” è rimasta tale, le promesse pure. La
legge in vigore è la 62 del 2011 e prevede misure alternative al carcere per le
madri con figli fino ai sei anni di età, gli ICAM e le case famiglia protette.
Nonostante le premesse e i principi che hanno ispirato la legge, la carcerazione
non è stata eliminata: l’accesso alle case famiglia protette è molto limitato
perché gli oneri di spesa finora non sono stati a carico dello Stato.
Un esempio? Nel secondo
rapporto semestrale dell’Ausl di Bologna (dal titolo “Carcere Bologna: il
disastro permanente”) Vito Totire nell’agosto 2020 scriveva: «Irrisolto il
problema dello spazio per una persona detenuta con bambino; irrisolto nel senso
che, dopo tanti anni, ancora non paiono esecutive le norme che vietano la
detenzione in carcere di bambini piccoli che devono invece essere ospitati, con
le loro mamme, negli ICAM e/o comunque in una struttura alternativa al carcere e
diversa a seconda della posizione giuridica della madre; di recente, ancora una
volta, la Dozza ha ospitato una bambina di 4 anni, sia pure per pochi giorni!
Comunque, fino a quando esiste lo spazio per donna con bambino, lo spazio
“rischierà” di essere occupato a discapito delle strutture alternative
extracarcerarie». Pochi mesi dopo la direzione del penitenziario annuncia che al
reparto femminile del carcere sarà inaugurato un nido per ospitare di volta in
volta fino a due donne con i loro figli. Il garante regionale Marcello
Marighelli ricorda che il nido in carcere è una misura che risale al 1975. No,
non si tratta di una soluzione: i bambini devono uscire dal carcere.
La differenza l’ha
sintetizzata perfettamente il deputato Paolo Siani (PD): «Ho visitato
personalmente l’Icam di Avellino e una casa famiglia protetta di Roma. Sono due
mondi completamente diversi: il primo è un carcere, il secondo è il luogo adatto
a far crescere un bambino quando rimane con la madre detenuta», commenta. Per
questo il deputato aveva depositato a dicembre del 2019 la proposta di legge
2298 per superare i “profili problematici” della legge 62/2011, la norma che
dieci anni fa ha istituito gli Istituti a custodia attenuata per detenute
madri (Icam) per “impedire che bambini varchino la soglia del carcere”.
Inizialmente sembrava che ci fosse una larga convergenza ma poi tutto si è
arenato in Commissione giustizia. La proposta di legge Siani prevede l’obbligo
per lo Stato a finanziare le case famiglia protette per detenute madri e
l’obbligo per il ministero delle Giustizia di stipulare convenzioni con gli enti
locali per individuare le strutture idonee ad accogliere le mamme detenute con i
loro bambini.
Il testo della proposta di
legge prevede anche alcune modifiche al codice di procedura penale finalizzate a
rendere la custodia cautelare delle detenute madri all’interno degli Icam solo
nel caso in cui sussistano “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”. La
proposta, se venisse approvata, eviterebbe che per le madri si aprano le porte
del carcere ma individuerebbe nelle case famiglia protette la soluzione
ordinaria, relegando gli Icam come estrema soluzione.
A dicembre del 2020 con un
emendamento alla legge di bilancio era stato previsto un fondo con una dotazione
di 1,5 milioni di euro all’anno per il triennio 2021-2024 (4,5 milioni in tutto)
per creare un numero di posti sufficiente per accogliere le madri in carcere con
bambini.
Si attendeva il decreto
attuativo e la ripartizione dell’importo tra le regioni. È arrivato solo 10 mesi
dopo (a settembre del 2021) e a oggi le uniche case famiglia protette
attualmente attive sono solo a Roma e Milano. Una cosa è certa: in Italia
finiscono in carcere bambini che sono innocentissimi perché la politica fatica a
trovare una soluzione. C’è una categoria di persone che è condannata a scontare
in carcere pene mai commesse, inconsapevoli del destino che gli è stato
rilevato.
Giulio Cavalli. Milano, 26
giugno 1977 è un attore, drammaturgo, scrittore, regista teatrale e politico
italiano.
Il nodo irrisolto delle
detenute con figli al seguito. Cartabia non vuole bambini in carcere, ma in
Campania ce ne sono 11 dietro le sbarre.
Viviana Lanza su Il Riformista
il 4 Dicembre 2021.
Ci sono undici i bambini
“reclusi” in Campania. Hanno dai pochi mesi di vita a qualche anno di età. Il
loro mondo è chiuso nel perimetro dell’Icam di Lauro, istituto a custodia
attenuata per detenute madri. Nella nostra regione è l’unica struttura
attrezzata per ospitare donne detenute con figli piccoli al seguito. Secondo i
dati ministeriali aggiornati al 30 novembre, nell’Icam campano ci sono
attualmente dieci detenute madri e undici bambini, dei quali la metà di etnia
rom o proviene dai Paesi dell’Est o del Nordafrica.
Vivono in un contesto che
prova a non essere un grigio e desolato vero e proprio carcere, ma che nella
realtà resta un luogo di restrizione della libertà personale. Rispetto allo
scorso mese una novità c’è: un neonato di due mesi è stato “scarcerato” insieme
alla sua mamma e un altro bimbo, la cui nascita è prevista tra pochi giorni,
potrà vivere in un luogo diverso dall’Icam di Lauro perchè anche la sua mamma è
stata scarcerata. Per il resto, quante battaglie, quanti proclami, quante parole
si sono spese in questi anni su questo aspetto del regime penitenziario. E
quante volte abbiamo sentito dire che in carcere i bambini non ci dovrebbero
stare, per poi constatare che negli istituti di pena i bambini non solo
continuano a viverci ma alcuni addirittura ci nascono. «Anche un solo bambino in
carcere è di troppo», ha affermato la ministra della Giustizia Marta
Cartabia intervenendo ieri alla Quarta Conferenza nazionale sulla famiglia.
«L’obiettivo primario della riforma – ha spiegato – è realizzare gli interessi
superiori del minore. L’espressione anglosassone primigenia di best interests of
the child è non a caso declinata al plurale.
Gli stessi interessi che mi
hanno già portato ad occuparmi anche dei bambini in carcere con le loro madri e
di cui, anche insieme al garante dell’infanzia, presto tornerò ad occuparmi
concretamente». «Non è possibile – ha aggiunto la ministra – che bambini di
tenerissima età, innocenti per definizione, scontino la pena che è stata
inflitta alla madre. Occorre trovare una soluzione definitiva a questo problema,
che grazie a Dio riguarda ormai pochissimi casi anche per la generosa
disponibilità di tanti operatori del terzo settore». Grazie all’iniziativa del
deputato Paolo Siani, il Governo ha previsto fondi da destinare alle Regioni per
la realizzazione di case protette in cui ospitare le donne detenute con i propri
figli al seguito. Per la Campania sono stati previsti 240mila euro all’anno per
i prossimi tre anni ma al momento non c’è alcuna casa famiglia avviata.
Il garante campano Samuele
Ciambriello ha sottolineato la carenza di case protette nella nostra regione. In
Italia ce ne sono a Roma e a Milano. Sarebbe quindi ora di passare davvero dalle
parole ai fatti ed evitare che d’ora in poi anche un solo bambino debba vivere i
suoi primi anni di vita in un luogo di reclusione. Quanta strada c’è ancora da
percorrere per la piena tutela dei diritti dei bambini. In Campania il 17,4 %
della popolazione è minorenne eppure per bambini e ragazzi si fa ancora troppo
poco in termini di opportunità di studio, di sport, di salute, di diritti. Ieri
il Riformista si è occupato dell’ultimo report stilato dal gruppo di lavoro per
la Convenzione sui diritti per l’infanzia e l’adolescenza, un bilancio dal quale
la Campania ne esce piuttosto male con un alto tasso di mortalità infantile,
bassi livelli di servizi legati al mondo dei più piccoli e disuguaglianze
territoriali. «Sarebbe molto utile – ha commentato Siani – avere un’agenzia che
si occupi di infanzia, in grado di monitorare gli interventi a livello nazionale
e locale così da poter meglio comprendere la condizione dei bambini a livello
territoriale e organizzare politiche di reale tutela e garanzia dei loro
diritti».
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
"Innocenti assoluti": quei
18 bambini in carcere con le loro madri. Luigi Manconi su La Repubblica il
25 gennaio 2022.
Mentre la politica rivela,
ancora una volta, la sua torpida impotenza e la maggioranza dei “grandi
elettori” si comporta come se avesse appena scoperto che: oddio, oggi c’è da
votare il Presidente! e cerca un qualche accordo, si susseguono gli esempi di
questa drammatica crisi del sistema democratico. E la crisi si mostra con
maggiore brutalità proprio nelle situazioni estreme, laddove le contraddizioni
sono più acute e dolorose e la mediazione più difficile e delicata. E ciò emerge
con tanta maggiore chiarezza quanto più le soluzioni possibili sembrano davvero
possibili e quasi a portata di mano. Ecco due casi particolarmente
significativi.
Al 31 dicembre scorso, nel
sistema penitenziario italiano, si trovavano 18 bambini, “innocenti assoluti”
reclusi con le proprie madri: uno scandalo e un oltraggio, prima ancora che per
il livello di civiltà giuridica del nostro paese, per il comune buon senso.
Una riforma della materia
giace alla Camera dei Deputati ed è richiesta da tanti. Ma anche solo un
provvedimento amministrativo sarebbe in grado di cancellare, o quasi, un simile
obbrobrio. Una legge del 2011 prevede, infatti, in alternativa alla reclusione
in cella, l’istituzione di case famiglia protette destinate alle madri con figli
minori, in presenza di una serie di condizioni. Proprio a causa di queste
ultime, spesso interpretate in maniera macchinosa e restrittiva, l’applicazione
della legge è stata assai complessa: ne è conseguito che, nell’ultimo decennio,
alcune centinaia di minori hanno trascorso in una cella i primi anni della loro
vita. Un anno fa erano 29 e, al 31 dicembre del 2018, 52. Come si vede, numeri
che, se si considera l’intero territorio nazionale, sono esigui: eppure, a
fronte di questo, le case famiglia protette attualmente attive in Italia sono
appena due: una a Roma e una a Milano.
Certo, è comunque necessaria
una riforma della legge che renda più agevole l’accesso a queste strutture
alternative, ma ciò che colpisce è anche altro. È proprio il fatto che non vi
siano posti disponibili a sufficienza. Eppure, calcoli recenti molto affidabili
dimostrano che con una cifra complessiva intorno al milione e mezzo di euro è
possibile - concretamente e fattivamente - realizzare, attraverso adeguate opere
di ristrutturazione, il numero di case famiglia protette (cinque-sei) necessarie
a “liberare” quei bambini.
Non troppo diversa è la
situazione dei detenuti affetti da disturbi psichici. A settembre del 2021, le
persone illegittimamente recluse in un carcere, nonostante lo stato di salute
mentale, erano 12, anche se a queste vanno sommati quei pazienti che si trovano
“scaricati” nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (Spdc).
Consideriamo una vicenda,
seguita dalle avvocate Valentina Cafaro e Giulia Borgna dello studio
Saccucci&Partners, che ha avuto un esito positivo. Un paziente psichiatrico
affetto da un disturbo bipolare è rimasto a lungo nel carcere di Rebibbia, a
Roma, nonostante il magistrato di sorveglianza avesse applicato nei suoi
confronti una misura di sicurezza, che tuttavia non aveva trovato esecuzione.
Due giorni fa, l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani
(CEDU), per aver protratto per due anni la detenzione del ricorrente in regime
carcerario ordinario senza garantirgli un adeguato trattamento psichiatrico, in
violazione del diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti garantito
dall’art. 3 della Convenzione europea.
Inoltre, l’Italia è stata
condannata per illegittimità della detenzione in carcere in violazione del
diritto alla libertà personale e alla sicurezza personale previsti dall’art. 5
della stessa Convenzione. Ciò in ragione delle condizioni materiali degradate
vissute in cella, della mancata somministrazione di cure adeguate alla
situazione personale e in ragione del mancato trasferimento in una Residenza per
l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), dovuto alla ingiustificabile
mancanza di posti disponibili.
Almeno in questa circostanza è
forse utile astenersi dai discorsi generali e “di sistema” e fermarsi sul dato
numerico. Nel caso dei pazienti psichiatrici reclusi in carcere, si tratta di 12
persone e, pure se probabilmente arrivano al doppio o più, il fenomeno è di
dimensioni ridotte. Anche qui, secondo valutazioni attendibili, la spesa
richiesta per ovviare alla carenza di posti non supera i due milioni di euro. È
chiaro: per sottrarre gli “innocenti assoluti” e i “matti” al carcere è
necessaria una politica intelligente e razionale; e sono necessari interventi
normativi e investimenti economici, decisioni pubbliche e misure istituzionali.
Ma alla resa ultima dei conti, servono tre milioni e mezzo di euro. È questo il
costo di due riforme semplici semplici che potrebbero cancellare due ingiustizie
assolute.
Nuovi sviluppi
nell'inchiesta su Santa Maria, imbarazzanti le parole dei sindacati di polizia.
Mattanza in carcere, altri 41 poliziotti indagati: il protocollo diceva
ammazzateli di botte? Francesca Sabella su Il Riformista il 7 Ottobre 2022.
Carcere di Santa Maria Capua
Vetere, carcere della mattanza. Fu tortura vera e propria ma c’è chi ancora
parla di protocolli. Tra le scale e le celle il 6 aprile del 2020 andò in scena
un pestaggio violentissimo da parte degli agenti ai danni dei detenuti, i
magistrati scriveranno: tortura. Ci sono altri 41 indagati tra la polizia
penitenziaria.
Una violenza inaudita
raccontata dai video delle telecamere di sorveglianza, una crudeltà degna del
peggiore film sulla prigione di Alcatraz. E invece no, siamo in Italia, siamo
a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ed è tutto vero. I 41 nuovi
indagati sono poliziotti intervenuti ma finora mai identificati in quanto muniti
di caschi protettivi e mascherine anti-Covid. Erano almeno un centinaio i
pubblici ufficiali che mancavano all’appello tra i tanti ripresi dalle
telecamere interne del carcere mentre pestavano i detenuti a mani nude o
servendosi di manganelli, facendoli passare anche in un “corridoio” di agenti
pronti a sferrare colpi.
La Procura di Santa Maria
Capua Vetere (procuratore aggiunto Alessandro Milita, e i sostituti
procuratori Alessandra Pinto e Daniela Pannone) ne ha identificati con
difficoltà per ora 41, tutti indagati per atti di tortura, e ha così chiesto e
ottenuto dal Gip la proroga delle indagini per poter identificarne altri. Pare
infatti che al pestaggio presero parte in tutto circa 250 agenti. Dei 41
poliziotti penitenziari indagati, 27 sono attualmente in servizio nel carcere
napoletano di Secondigliano, quattro ad Avellino e dieci a Santa Maria Capua
Vetere. Si avvicina intanto la data di inizio dibattimento per i 105 tra agenti,
funzionari del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e dell’azienda
sanitaria locale, accusati a vario titolo di responsabilità in ordine alle
violenze ai danni dei detenuti avvenute nel carcere sammaritano.
Il processo partirà infatti il
7 novembre prossimo davanti ai giudici togati e popolari della Corte
d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, mentre nei prossimi giorni
ci sarà davanti al giudice per l’udienza preliminare, Pasquale D’Angelo, il
processo con rito abbreviato per tre agenti che hanno deciso di non andare al
dibattimento. Le accuse sono gravissime: abuso di autorità, tortura, lesioni e
falso in atto pubblico. Per 12 di loro c’è anche l’omicidio colposo per la morte
di un detenuto (il 28enne algerino Lamine Hakimi) avvenuta circa un mese dopo i
fatti. E sono ottanta i detenuti che hanno subito calci, pugni,
manganellate e umiliazioni e che si sono costituiti parte civile nel processo
contro gli agenti. 292, invece, i detenuti che subirono violenze quella sera.
Una pagina tristissima delle
prigioni italiane, un episodio gravissimo che ancora una volta sottolinea la non
idoneità delle carceri ad accogliere essere umani e a rispettarne i diritti e la
dignità. Saranno i magistrati a fare chiarezza e a stabilire le colpe, quel che
è certo è che le immagini parlano e raccontano di un massacro. Nel frattempo,
dal carcere casertano si dicono tranquilli e fiduciosi. «Ribadiamo la piena
fiducia nell’operato della magistratura inquirente, non senza ricordare però che
a pagare per quanto accaduto quel giorno, non sono solo gli agenti tutt’oggi
sospesi, ma anche le loro famiglie, mogli e figli, che dall’estate dello scorsa
versano in gravi difficoltà in quanto senza sostegno e per un tempo indefinito
viste le lungaggini dei processi, il cui esito non sarà così scontato come si
vuole far credere». Così, in una nota, il segretario regionale dell’Uspp Ciro
Auricchio.
Noi vorremmo, invece,
sottolineare che anche quei detenuti barbaramente pestati hanno una famiglia che
ha assistito inerme al pestaggio dei propri cari. Entrambe le parti coinvolte in
questa storia hanno famiglia. Non è una gara a chi soffre di più. E
ancora: «Attendiamo – ricorda ancora Auricchio – la definizione di precisi
protocolli di intervento da adottare quando accadono eventi critici come quelli
che hanno visto protagonista l’istituto penale casertano, che metta al riparo in
modo chiaro e preciso la Polizia Penitenziaria da strumentali accuse rispetto
alle reali difficoltà che donne e uomini dello Stato sono chiamati ad affrontare
ogni giorno». Ma di quali protocolli si sta parlando precisamente?
I detenuti erano tutti disarmati e non stavano mettendo in atto nessuna rivolta
e quella dei giorni prima era stata pacifica. Fu una mattanza bella e buona,
nessuna emergenza e nessun protocollo mai potrà autorizzarvi a massacrare di
botte un detenuto. In questo caso quasi trecento. NESSUN PROTOCOLLO.
Francesca Sabella. Nata a
Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole ha deciso, non
senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro. Giornalista
pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi protagonisti.
(ANSA il 12 luglio 2022) –
Sono stati tutti rinviati a giudizio i 105 imputati, tra poliziotti
penitenziari, funzionari del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e
dell'azienda sanitaria locale, accusati a vario titolo di responsabilità in
ordine alle violenze ai danni dei detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria
Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020.
La decisione è stata emessa
dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Pasquale D'Angelo, che ha rinviato tutti al dibattimento che inizierà il 7
novembre prossimo davanti alla Corte d'Assise del tribunale sammaritano.
Il giudice per le indagini
preliminari di Santa Maria Capua Vetere ha fissato per il 25 ottobre prossimo
l'udienza in cui si terrà il processo con rito abbreviato (davanti allo stesso
gup) per due imputati che ne hanno richiesta, tra cui il commissario capo della
polizia penitenziaria Anna Rita Costanzo, ritenuta tra gli organizzatori delle
violenze.
Torture ai detenuti nel
carcere di Santa Maria Capua Vetere, 105 rinviati a giudizio.
I reati ipotizzati dalla
Procura sono, a vario titolo, tortura, lesioni, violenza privata, abuso di
autorità e, per 12 imputati, l’omicidio colposo per la morte di un detenuto
alcuni giorni dopo le violenze. Il Dubbio il 12 luglio 2022.
Il gip di Santa Maria Capua
Vetere Pasquale D’Angelo ha disposto il rinvio a giudizio per 105 imputati per
le violenze sui detenuti nel carcere sammaritano avvenute ad aprile 2020. È
stata così accolta la richiesta presentata lo scorso 26 aprile dal pm Alessandro
Milita di rinviare a giudizio 105 imputati tra appartenenti al corpo della
Polizia penitenziaria e funzionari dell’amministrazione penitenziaria. La
Procura sammaritana non aveva chiesto il rinvio a giudizio per uno solo dei 108
imputati dell’udienza preliminare, che ha dimostrato di non essere presente
all’interno del carcere nel giorno delle violenze, mentre altri due imputati
hanno chiesto e ottenuto il rito abbreviato, che sarà celebrato il 25 ottobre.
I reati ipotizzati dalla
Procura sono, a vario titolo, tortura, lesioni, violenza privata, abuso di
autorità e, per 12 imputati, l’omicidio colposo per la morte di un detenuto
alcuni giorni dopo le violenze. La prima udienza sarà celebrata il 7 novembre
davanti alla Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere. L’inchiesta della
Procura di Santa Maria Capua Vetere, culminata il 28 giugno 2021 con
l’esecuzione di 52 misure cautelari, è stata avviata a seguito delle
segnalazioni di violenze avvenute all’interno del carcere nel giorno successivo
a una protesta dei detenuti dopo l’emersione di alcuni casi di positività
al Covid-19.
Tra i primi a depositare una
denuncia è stato l’avvocato Carmine D’Onofrio, che nel processo difende tre
detenuti. Lo stesso caso è stato sollevato anche dal garante dei detenuti della
Campania, Samuele Ciambriello, che si è costituito parte civile nell’udienza
preliminare. Nei giorni seguenti l’esecuzione delle misure cautelari hanno
trovato ampia diffusione sui media le immagini registrate dalle telecamere di
videosorveglianza all’interno del carcere, nelle quali si vedono numerosi
episodi di violenza ai danni dei detenuti. Il 14 luglio 2021 hanno visitato il
carcere di Santa Maria Capua Vetere il presidente del Consiglio Mario Draghi e
il ministro della Giustizia Marta Cartabia.
Violenze in carcere a S.
Maria Capua Vetere: 105 agenti e funzionari a processo.
Redazione CdG 1947 su Il
Corriere del Giorno il 12 Luglio 2022.
Tutti rinviati a giudizio gli
accusati tra poliziotti penitenziari, funzionari del Dap e dell'azienda
sanitaria locale per le violenze ai danni dei detenuti del 6 aprile 2020. Dodici
gli imputati che dovranno rispondere di omicidio colposo per la morte di Lakimi
Amine
Tutti rinviati a giudizio i
105 imputati, poliziotti penitenziari, funzionari del Dap (Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria) e dell’azienda sanitaria locale, accusati a vario
titolo di responsabilità in ordine alle violenze ai danni dei detenuti avvenute
nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020. La decisione
è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere Pasquale D’Angelo, che ha rinviato tutti al dibattimento che
inizierà il 7 novembre prossimo davanti alla Corte d’Assise del tribunale
sammaritano.
Il giudice per le indagini
preliminari di Santa Maria Capua Vetere ha fissato per il 25 ottobre prossimo
l’udienza in cui si terrà il processo con rito abbreviato (davanti allo stesso
gup) per due imputati che ne hanno richiesta, tra cui il commissario capo della
polizia penitenziaria Anna Rita Costanzo, ritenuta tra i principali
organizzatori delle violenze in carcere.
Tra le accuse contestate a
quasi metà degli agenti c’è quella di tortura, fattispecie introdotta pochi anni
fa e contestata per la prima volta a così tanti funzionari pubblici; c’è
anche l‘omicidio colposo del detenuto algerino Lakimi Hamine, addebitato a 12
imputati. Uno degli imputati, su richiesta della Procura, accolta dal Gup, è
stato prosciolto: si tratta dell’agente 50enne della Penitenziaria Luigi Macari.
Andranno a processo di
novembre davanti alla giuria popolare, tra gli altri l’ex provveditore regionale
del Dap Antonio Fullone e gli ufficiali della penitenziaria Pasquale Colucci,
Gaetano Manganelli, Tiziana Perillo e Nunzia Di Donato. Insieme a loro decine di
agenti, e due medici del carcere, che il 6 aprile 2020 erano in servizio
all’istituto di reclusione casertano, mentre restano non ancora identificati gli
oltre 100 poliziotti provenienti soprattutto dal carcere di Secondigliano i
quali durante le violenze, alle quali parteciparono attivamente, indossavano
caschi e mascherina protettiva e quindi non riconoscibili dai detenuti.
Oltre cento parti civili si
sono costituite al processo, tra i quali una novantina di reclusi vittime dei
pestaggi, il garante nazionale e quello regionale dei detenuti, alcune
associazioni (Antigone, Carcere possibile, Agadonlus, Abusi in divisa), ed enti
come l’Asl di Caserta ed il Ministero di Grazia e Giustizia, che compariranno
anche nelle vesti di responsabile civile per le condotte dei propri dipendenti.
Le torture nel
penitenziario. Mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, 105 a processo
tra poliziotti e funzionari: restano sconosciuti cento agenti.
Carmine Di Niro su Il
Riformista il 12 Luglio 2022
Saranno 105 gli imputati del
maxi processo per la mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Questo il
numero di agenti, funzionari dell’amministrazione penitenziaria e medici che
andranno a giudizio all’inizio di novembre dinanzi alla Corte d’Assise del
tribunale sammaritano presieduta dal giudice Roberto Donatiello.
A disporlo oggi il gup
Pasquale D’Angelo del tribunale sammaritano al termine di una udienza
preliminare fiume celebrata all’aula bunker, ironia della sorte, proprio
all’interno della Casa Circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua
Vetere.
Processo che vede
costituite oltre cento parti civili, soprattutto i reclusi vittime dei pestaggi
avvenuti il 6 aprile 2020 nel carcere in provincia di Caserta, ma anche alcune
associazioni come Antigone, Carcere possibile, Agadonlus, Abusi in divisa, oltre
ad enti come l’Asl di Caserta e il Ministero della Giustizia.
I nomi più importanti tra i
105 a processo sono quelli dell’ex provveditore regionale del Dap Antonio
Fullone e degli ufficiali della penitenziaria Pasquale Colucci, Gaetano
Manganelli, Tiziana Perillo e Nunzia Di Donato. Con loro decine di agenti che
picchiarono selvaggiamente i detenuti, ma anche due medici del carcere
sammaritano.
Ma ad oggi restano sconosciuti
circa un centinaio di agenti che parteciparono alle violenze, una ‘vendetta’
della penitenziaria contro le rivolte scoppiate il 5 aprile dopo l’emergere di
casi di positività al Covid-19 di alcuni detenuti del reparto Nilo: si tratta in
particolare di poliziotti arrivati dal carcere di Secondigliano per ‘sedare’ le
proteste, muniti di casco e mascherina e per questo non riconoscibili. Quella
che doveva essere una “perquisizione straordinaria” si tradurrà in una mattanza:
i detenuti vennero fatti inginocchiare e picchiati con manganellate, fatti
sfilare tra due ali di agenti e percossi. Le telecamere inquadrarono anche il
brutale pestaggio di un detenuto in carrozzina, di recente deceduto dopo la
scarcerazione.
Agli imputanti vengono
contestati, a vario titolo, i reati di tortura (introdotta pochi anni fa e
contestata per la prima volta a così tanti funzionari pubblici), maltrattamenti
pluriaggravati, lesioni personali pluriaggravate, abuso di autorità contro
detenuti, perquisizioni personali arbitrarie, falso in atto pubblico, calunnia,
frode processuale, depistaggio, favoreggiamento personale. Nel lungo elenco c’è
anche quello di omicidio colposo in relazione alla morte del detenuto algerino
Lakimi Hamine, deceduto in carcere il 4 maggio 2020, addebitato a 12 imputati.
Il giudice per le indagini
preliminari di Santa Maria Capua Vetere ha fissato invece per il 25 ottobre
prossimo l’udienza in cui si terrà il processo con rito abbreviato (davanti allo
stesso gup) per due imputati che ne hanno richiesta, tra cui il commissario capo
della polizia penitenziaria Anna Rita Costanzo, ritenuta tra gli organizzatori
delle violenze. Unico prosciolto è stato Luigi Macari per il quale lo stesso
procuratore aggiunto Alessandro Milita – titolare dell’inchiesta con i pm Pinto
e Pannone – aveva invocato il non luogo a procedere avendo l’indagato dimostrato
di non essere in carcere durante la mattanza.
Importanti anche
le ripercussioni politiche di quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere. Se da
una parte il leader della Lega Matteo Salvini non esitò a sfilare davanti al
carcere per dimostrare la sua vicinanza alla polizia penitenziaria, il ministro
della Giustizia Marta Cartabia e il premier Mario Draghi visitarono la Casa
Circondariale per chiedere scusa.
Carmine Di Niro. Romano di
nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di
politica, sport e tecnologia
"Rinvio a giudizio
scontato, ora vogliamo giustizia". Mattanza in carcere, l’urlo di una madre:
“Mio figlio urinava sangue, ferite scolpite sul corpo e nessuna cura”.
Andrea Aversa su Il
Riformista il 15 Luglio 2022
«A causa della mattanza un
ragazzo ha perso la vita, poteva essere mio figlio. O il figlio di qualsiasi
altra mamma», stiamo parlando di Hakimi Lamine, giovane di origini algerine
deceduto in carcere il 4 maggio 2020. A dire queste parole a Il Riformista è
stata Gianna Scialdone, figlia di Pasquale Scialdone detenuto nel penitenziario
di Santa Maria Capua Vetere. Anche lui è stato una vittima delle violenze
avvenute nel penitenziario casertano, il 6 aprile 2020. Immagini che hanno
scandalizzato l’opinione pubblica e mobilitato il governo, nella veste del
premier Mario Draghi e del ministro della Giustizia Marta Cartabia. La vicenda
ha sollevato diverse obiezioni anche in sede europea. Ma questa non è una
novità. L’Italia è già stata sanzionata in passato dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo (Cedu) per le condizioni disumane e degradanti in cui versano
le carceri del Belpaese.
Proprio tre giorni fa,
il Giudice per l’udienza preliminare (Gup) del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere Pasquale D’Angelo, ha rinviato 105 persone a giudizio. Agenti della
polizia penitenziaria, funzionari del Dap e dell’Asl, imputati in un processo
che avrà inizio il prossimo 7 novembre dinanzi la Corte d’Assise. Per due di
essi, invece, il prossimo 25 ottobre ci sarà l’udienza con rito abbreviato
stabilita dal Giudice per le indagini preliminari (Gip). Tra loro c’è il
Commissario capo Annarita Costanzo. Le accuse sono gravi: tortura, lesioni,
violenza privata e abuso di autorità. Ad alcuni imputati è stato attribuito
anche il reato di omicidio colposo per la morte di Lamine. Quest’ultimo, dal
pestaggio al decesso, ha trascorso 28 giorni in agonia e secondo le
testimonianze, senza ricevere cure adeguate. Barbarie nella barbarie.
Nel procedimento il Garante
nazionale per i diritti dei detenuti, insieme a quello della regione
Campania, della città metropolitana di Napoli e della città di Caserta, si è
costituito parte civile. Con loro diverse associazioni, tra cui Antigone. «Per i
video che abbiamo visto trovo strana l’idea di un processo – ha spiegato Gianna
Scialdone – È talmente chiaro quello che è avvenuto che non possiamo non avere
giustizia». Per il papà oltre al danno la beffa: «Mio padre è uscito dal carcere
di Santa Maria sei giorni dopo la mattanza. Era il 12 aprile. Aveva lividi
ovunque e anche psicologicamente non stava bene. Poiché doveva scontare altri 5
mesi, è stato portato di nuovo in carcere. Ed ora si trova ancora a Santa Maria.
L’ho sentito sabato e giorni prima ha avuto un colloquio con la
garante Belcuore. Purtroppo quel penitenziario è un inferno, non c’è neanche
l’acqua potabile. Per ogni detenuto sono messe a disposizione due bottiglie. Se
non hai i soldi per fare la spesa muori di sete».
Francesca Cosmo, madre di
Emanuele Irollo, è un’altra delle mamme che ha denunciato i fatti accaduti a
Santa Maria: «Sono vedova, mio marito è morto nel carcere di Poggioreale. Quando
ho saputo delle violenze e non riuscivo a parlare con mio figlio, ho avuto
paura. Ho rischiato di ammalarmi. Emanuele urinava sangue ed era pieno di
lividi. Per fortuna dopo 15 giorni l’hanno trasferito a Benevento. Quando ci
siamo visti con una video chiamata mi ha mostrato le ferite scolpite sul corpo.
Non ha ricevuto cure, è stato letteralmente abbandonato». Un altro detenuto
vittima della mattanza ha perso la vita lo scorso 18 giugno. Si tratta
di Vincenzo Cacace, 60 anni e deceduto per cause naturali nonostante le diverse
patologie pregresse di cui era affetto. Cacace suo malgrado è stato uno dei
simboli di quelle ore terribili: nelle immagini pubblicate dai giornali era il
detenuto sulla sedia a rotelle che veniva percosso e picchiato.
«Il processo servirà ad
accertare le responsabilità penali degli imputati – ha dichiarato l’avvocato
della famiglia Cacace, Paolo Conte – C’è soddisfazione da parte nostra per la
decisione del rinvio a giudizio anche se l’avevamo data per scontata. Non posso
escludere che la lunga detenzione del signor Cacace, anche se frammentata ma
culminata con la mattanza di Santa Maria, abbia in qualche maniera inciso in
modo determinante sulla sua salute, fisica e psichica. Ci auguriamo che alla
fine del dibattimento sarà fatta giustizia e che soprattutto siano accertate le
responsabilità politiche della mattanza. Chi l’ha voluta, chi l’ha organizzata e
perché». Andrea Aversa
Dopo l’“orribile mattanza”
era profondamente cambiato. È morto Enzo Cacace, ex detenuto in carrozzina che
denunciò i pestaggi a Santa Maria: “Lotteremo per lui”.
Rossella Grasso su Il Riformista il 18 Giugno 2022.
“Lo hanno ammazzato
fisicamente e psicologicamente. Dopo 30 anni di carcere era uscito da 2 anni e
da allora non era più lo stesso”. Gino Cacace, figlio di Enzo, è disperato per
la morte del papà. Napoletano, originario del Rione Traiano, aveva 60 anni. È
stato tra i primi a denunciare quella che il Gip ha definito “orribile
mattanza”, le violenze che il 6 aprile 2020 si sono consumate nel carcere
di Santa Maria Capua Vetere. Enzo era in sedia a rotelle. Nelle immagini
restituite dalle telecamere di videosorveglianza del carcere c’era anche la
brutale aggressione che subì Vincenzo e che lui stesso raccontò a volto scoperto
davanti alle telecamere di tutta la stampa nazionale.
Appena uscito dal carcere, un
anno dopo quel drammatico aprile, denunciò tutto quello che gli era successo:
“Sono stato il primo ad essere tirato fuori dalla cella insieme con il mio
piantone perché sono sulla sedia a rotelle – raccontò – Ci hanno massacrato,
hanno ammazzato un ragazzo. Hanno abusato di un detenuto con un manganello. Mi
hanno distrutto, mentalmente mi hanno ucciso. Volevano farci perdere la dignità
ma l’abbiamo mantenuta. Sono loro i malavitosi perché vogliono comandare in
carcere. Noi dobbiamo pagare, è giusto ma non dobbiamo pagare con la nostra
vita. Voglio denunciarli perché voglio i danni morali”.
Dal carcere di Santa Maria
Capua Vetere era uscito cambiato, profondamente prostrato nel fisico e nella
mente. Lui che tutti chiamavano “il gigante buono”, già con qualche acciacco,
era rimasto profondamente turbato da quanto gli accadde in carcere. “Era in
stato confusionale, non era più il mio papà – racconta Gino – Voglio giustizia
per come lo hanno ridotto loro, lo hanno rovinato, non era più lui. Non riusciva
più a dormire la notte. Se riusciva un pochino a prendere sonno diceva ‘amputato
spegnete la luce’, poi urlava e piangeva. Mi chiamava nel cuore della notte, era
inquieto”.
La nuora racconta che Enzo già
da qualche tempo non stava bene ed entrava e usciva dagli ospedali. “All’inizio
ci dissero che i suoi reni non funzionavano più bene e aveva bisogno di dialisi
– racconta – gli misero una cannetta alla gola per la dialisi. Lui con la testa
già non ci stava più. Usciva dall’ospedale e ce lo ritrovavamo qui da noi che
voleva mangiare e non voleva stare in ospedale. Il figlio doveva riportarlo in
ospedale perché non stava bene. Se si staccava la cannoletta alla gola poteva
morire dissanguato. Poi qualche giorno fa dall’ospedale ci hanno detto che aveva
avuto un blocco respiratorio e da quel momento si è aggravato. Negli ultimi
giorni è stato in coma farmacologico. Ci hanno detto che i reni non
funzionavano. Poi hanno iniziato a dirci a giorni alterni che stava meglio o
peggio. Ieri mio marito è andato a trovarlo e aveva gli occhi aperti ma aveva
ancora la ventola. Poi mi hanno chiamato e mi hanno detto che aveva avuto un
arresto cardiaco. Ho sperato fino all’ultimo che riuscissero a salvarlo, perché
aveva già sofferto di cuore, ma non ce l’ha fatta”.
Gino è stato l’ultimo a
vederlo prima che spirasse. “Diceva il nome di mio figlio e di mia madre –
racconta senza riuscire a trattenere le lacrime – Mi ha detto che non ce la
faceva più eppure aveva una forza da leoni mio padre”.
“Ha lottato troppo a lungo,
l’ultima carcerazione per lui è stata fatale – racconta una delle sorelle di
Enzo – Non si sentiva più una persona dignitosa e rispettata dopo essere stato
picchiato da chi doveva badare a lui. Mi diceva che non ce la faceva più a
vivere perché aveva perso tutta la sua dignità. Ha cercato lui la morte negli
ultimi momenti. Pregava di morire perché era stanco. Era in sedia a rotelle
quando lo hanno pestato. Quando in televisione ho visto le immagini di quello
che era successo nel carcere non potevo credere ai miei occhi: non potevo
credere che quello fosse mio fratello. Al telefono ce lo diceva che lo stavano
malmenando e minacciando. Io non è che non ci credevo ma ho vissuto anche io il
carcere e queste cose non succedevano. Al femminile c’era una sorta di
fratellanza ed eravamo seguite”.
Quasi tutti i 107 imputati
della mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta)
affronteranno la fase finale dell’udienza preliminare, attesa per il 28 giugno,
e l’eventuale dibattimento. La decisione sul rinvio a giudizio è attesa per
l’udienza in programma il 28 giugno (potrebbe saltare per l’astensione nazionale
degli avvocati), quando sarà passato un anno esatto dal blitz che portò i
carabinieri a notificare ad agenti e funzionari del Dap 52 misure cautelari
emesse dal giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere per
reati gravi, tra cui la tortura.
Enzo ha continuato fino
all’ultimo a seguire gli aggiornamenti di quel processo. Si è spento senza
conoscerne gli esiti. Ma tra le sue ultime volontà riportate a Gino c’è quella
di continuare a combattere per lui. “Mi disse: ‘Se mi succede qualcosa voglio
che stai tu dietro al processo e devi combattere’ – ha detto Gino – E io per lui
combatto fino infondo. Non mollerò mai, voglio solo giustizia per mio padre, per
quello che gli hanno fatto. Mio padre si è vero che ha sbagliato, però aveva il
diritto di scontare la sua pena normalmente non con i poliziotti che picchiavano
i detenuti. Doveva pagare ma non con la vita”.
“Spero che paghino per quello
che gli hanno fatto come facciamo noi quando commettiamo qualche errore –
continua la sorella di Enzo – Deve pagare chi gli ha distrutto la vita e gli ha
fatto perdere denti, dignità e personalità”. Nel procedimento in corso il
garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello, quello del comune di
Napoli, Pietro Ioia, e la casertana Emanuela Belcuore sono parte civile insieme
al garante nazionale Mauro Palma, all’associazione Antigone, ad altre
associazioni che si occupano dei diritti dei detenuti e molti dei reclusi che
subirono le violenze messe in atto dagli uomini della penitenziaria il 6 aprile
2020.
“Lotteremo per far avere
giustizia a Enzo – ha detto Ioia – Quello che ha subito sicuramente lo avrà
segnato. Siamo accanto alla famiglia di Enzo, saremo solidali anche dopo la sua
morte. Non ci fermiamo e chiederemo giustizia. Quello che Enzo ha subito non è
una cosa da paese democratico. Il carcere deve essere un luogo rieducativo e non
deve ridurre così le persone. Il carcere continua a uccidere e la politica fa
orecchie da mercante e si dovrebbe svegliare. Quello che è successo a Santa
Maria Capua Vetere non è un caso isolato, ne stanno uscendo altri fuori.
Speriamo di ottenere giustizia”.
Rossella Grasso. Giornalista
professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate
nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato
la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie
testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos,
Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli.
Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’
autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio
mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.
Mattanza in carcere, Enzo è
morto senza sapere chi lo ha picchiato: “Codici sui caschi della penitenziaria”.
Viviana Lanza su Il Riformista il 21 Giugno 2022.
Vincenzo Cacace, 60 anni,
napoletano del rione Traiano ed ex detenuto del carcere di Santa Maria Capua
Vetere, è morto sabato per cause naturali. La notizia della sua morte ha
inevitabilmente fatto compiere un salto indietro nel passato, al 6 aprile 2020,
nei corridoi del reparto Nilo trasformati per alcune ore in un vero e proprio
inferno. Vincenzo è stato una delle vittime dei pestaggi in carcere per cui ora
pende l’udienza preliminare. «Sono stato il primo ad essere tirato fuori dalla
cella insieme con il mio piantone perché sono sulla sedia a rotelle – raccontò
un anno dopo quella mattanza, una volta uscito dal carcere – . Mi hanno
distrutto, mentalmente mi hanno ucciso».
L’immagine di Vincenzo sulla
sedia a rotelle mentre si piegava su se stesso per parare i colpi che gli agenti
gli scaricavano sulla testa è stata un pugno nello stomaco per chiunque abbia
visto i filmati ripresi dalle telecamere del circuito di videosorveglianza del
carcere. Vincenzo è morto senza avere giustizia per quel pestaggio, senza sapere
tutta la verità sui responsabili della mattanza. Le indagini si sono fermate ai
soli agenti che è stato possibile identificare attraverso l’esame dei video, ma
ce ne sono tanti altri che ancora non sono stati identificati perché avevano i
volti coperti dai caschi scuri con le visiere abbassate. Ed ecco, quindi,
l’appello del garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello: «Invoco che
vengano messi sui caschi degli agenti della polizia penitenziaria dei codici
identificativi, e che valga anche per le altre forze dell’ordine che si occupano
di ordine pubblico nelle manifestazioni di piazza dove avvengono scontri, come
recentemente accaduto sia in occasione delle manifestazioni di studenti sia in
quella dei pescatori».
Dotare ogni agente di un casco
con codice identificativo consentirebbe, in occasione di interventi
antisommossa, di non perdere il controllo della situazione, di poter sempre
identificare chi fa cosa. Questo per colmare una lacuna e a garanzia di tutti.
Del resto, i fatti di Santa Maria Capua Vetere lo hanno dimostrato: è stato
difficile dare un nome a ogni volto ripreso dalle telecamere, ci sono volti
nascosti dai caschi senza codici e senza alcun carattere distintivo che non sono
stati finora identificati. Questo significa che alcuni presunti autori della
mattanza rimarranno impuniti. Chi sono? Tra questi c’è anche chi partecipò al
pestaggio di Vicenzo Cacace. «Siamo stati carne da macello», ripeteva Vincenzo
Cacace ripercorrendo le ore della mattanza. «Ero sulla sedia a rotelle, provavo
ad abbassarmi mentre mi colpivano in faccia, sulla fronte. Mentre gli altri
scendevano per le scale io fui portato giù in ascensore, mi picchiarono anche in
ascensore».
La mattanza fu organizzata
dalle squadre della penitenziaria come risposta alla protesta non violenta che
il giorno prima alcuni detenuti del reparto Nilo avevano inscenato per
manifestare il proprio disappunto di fronte allo stop dei colloqui per
l’emergenza Covid e sollecitare mascherine e tamponi. La risposta della
penitenziaria fu esagerata, violenta ed è finita al centro di un’inchiesta da
oltre cento indagati, fra agenti e dirigenti. Tra qualche giorno il giudice
dell’udienza preliminare di Santa Maria Capua Vetere deciderà se e per chi
disporre il processo. In questi mesi quasi tutti gli indagati raggiunti da
misura cautelare hanno ottenuto la revoca delle misure e la piena libertà.
«A quasi un anno
dall’emissione dell’ordinanza che sottopone gli indagati all’obbligo di dimora,
appare normale che il Tribunale del Riesame ritenga non più attuali le esigenze
cautelari – commenta il garante dei detenuti dalla cui denuncia partì due anni
fa l’inchiesta – Durante quest’anno, alcuni indagati sono stati nel carcere
militare di Santa Maria Capua Vetere, altri agli arresti domiciliari e altri
sottoposti ad obbligo di firma o dimora; tutti sono stati sospesi dal servizio,
sia agenti che amministrativi. Per molti di loro i giudici del Riesame hanno
dovuto revocare per legge la misura cautelare, non certo per atto di “clemenza”.
Io spero – aggiunge il garante – che giustizia venga fatta, che gli agenti
coinvolti vengano rinviati a giudizio, e ritengo giusto che arrivino al processo
da liberi. Mi auguro però che il processo ci concluda in fretta senza che,
nemmeno lontanamente, cali su di esso l’ombra della prescrizione».
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Accusato da uno degli
imputati per la mattanza a Santa Maria.
Fu un innovatore, lo
demolirono con l’accusa di maltrattamenti: assolto l’ex direttore dell’Opg di
Aversa. Viviana Lanza su Il Riformista il 18 Giugno 2022.
Fu un innovatore, lo
osteggiarono fino a puntargli il dito contro. Ne nacque un’accusa –
maltrattamenti – che per chi dirige un istituto psichiatrico giudiziario è
un’accusa pesante. Fu assolto in primo grado e ora anche in Appello. La Corte di
Appello di Napoli ha infatti ribadito l’assoluzione di Adolfo Ferraro, all’epoca
direttore dell’ex Opg di Aversa, e di sedici tra psichiatri e sanitari in
servizio presso la struttura. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della
sesta sezione della Corte di Appello e accoglie in pieno la tesi difensiva
sostenuta dall’avvocato Domenico Ciruzzi e dall’avvocato Alessandro Motta e la
richiesta del sostituto procuratore generale.
È un verdetto che chiude un
lungo capitolo giudiziario e restituisce giustizia a Ferraro, da tutti descritto
come un innovatore, che aveva introdotto in una struttura difficile come l’ex
manicomio giudiziario attività proiettate verso una visione diversa della
detenzione, incrociando però la resistenza di quella parte del mondo carcerario
legata alla istituzione totale. Tra gli accusatori di Ferraro c’era uno degli
attuali imputati per i pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Questo
per evidenziare lo scontro tra due visioni opposte di detenzione e di gestione
della popolazione detenuta. La magistratura deve averlo colto, infatti dopo
l’iniziale rinvio a giudizio le accuse contro Adolfo Ferraro si sono sgonfiate
in dibattimento fino a portare ad una prima assoluzione e si sono completamente
volatilizzate ora, con il processo in secondo grado che ha messo un punto
definitivo a questa vicenda.
Adolfo Ferraro assolto; del
tutto Infondata l’ipotesi secondo la quale nella struttura aversana erano stati
compiuti maltrattamenti e illecite contenzioni degli internati. «Il processo –
sottolinea l’avvocato Domenico Ciruzzi – ha dimostrato l’assoluta correttezza
della condotta degli psichiatri che, pur chiamati ad operare in una situazione
difficilissima quale era quella degli Opg, hanno sempre agito nel pieno rispetto
delle norme penali e deontologiche e nell’interesse esclusivo dei pazienti
internati». «Il dottor Ferraro – prosegue l’avvocato Ciruzzi – è stato un
grandissimo innovatore nella cura dei pazienti psichiatrici ristretti negli Opg.
Ha eliminato gradualmente tutti i letti di contenzione, ha coinvolto i pazienti
in numerose attività trattamentali quali il teatro, la gestione dell’orto e
dell’area verde, la cura degli animali. Ha cercato, in parte riuscendovi, ad
aprire alla società luoghi e istituzioni per loro natura chiusi quali erano gli
ex manicomi giudiziari ed ha partecipato attivamente alla rivoluzionaria
chiusura degli Opg e al passaggio alle Rems. Tutto ciò lo ha portato ad entrare
talvolta in frizione con l’apparato penitenziario che continuavano ad avere una
visione meramente carceraria dell’Opg e che hanno opposto una dura resistenza
alle innovative proposte da Ferraro. L’assoluzione a ristabilisce la verità dei
fatti e pone termine al tentativo di mistificare una storia, personale, umana e
professionale interamente dedicata alla cura, all’ascolto ed al sostegno di
quelli che il dottor Ferraro definisce – con amore e tenerezza – “i matti
reclusi”».
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Il caso di Santa Maria
Capua Vetere. In libertà gli agenti sotto accusa per la mattanza in carcere.
Viviana
Lanza su Il Riformista il 17 Giugno 2022.
Seguiranno il processo da
liberi gli agenti accusati dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
A un anno dalla svolta dell’inchiesta sulle violenze del 6 aprile 2020, il
tribunale del Riesame di Napoli ha revocato la misura dell’obbligo di dimora per
i poliziotti penitenziari Gaetano Manganelli, Giacomo Golluccio e Angelo
Iadicicco.
Nei giorni scorsi i giudici
avevano revocato la stessa misura per l’agente penitenziario Raffaele Piccolo,
mentre il gup di Santa Maria Capua Vetere, Pasquale D’Angelo, dinanzi al quale è
in corso l’udienza preliminare che deciderà sul rinvio a giudizio di 105
imputati, tra poliziotti e funzionari del Dap (altri tre imputati hanno scelto
la strada dell’abbreviato), aveva disposto la revoca degli obblighi per gli
agenti Rosario Merola, Oreste Salerno e Raffaele Piccolo e per gli
agenti Alessandro Biondi, Gabriele Pancaro, Gennaro Loffreda, Antonio Di
Domenico, Pasquale De Filippo, Felice Savastano, Michele Vinciguerra. Quasi
tutti gli imputati affronteranno, dunque, da liberi la fase finale dell’udienza
preliminare e l’eventuale dibattimento. Restano in undici gli imputati ancora
sottoposti a obbligo di dimora. Quanto all’iter giudiziario, la decisione sul
rinvio a giudizio è ormai agli sgoccioli.
Il 28 giugno (salvo rinvii a
causa dell’astensione nazionale degli avvocati) è prevista l’udienza decisiva,
quella in cui il giudice deciderà se disporre o meno il processo e per chi. Si
tratterebbe del primo processo su una delle pagine più tristi e dolorose dalla
storia penitenziaria. Era esattamente giugno di un anno fa quando la Procura di
Santa Maria Capua Vetere arrivò a una svolta nell’inchiesta sui pestaggi messi
in atto nel reparto Nilo da un centinaio di agenti della penitenziaria contro
altrettanti detenuti. Un’orribile mattanza.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
La decisione del giudice.
Processo mattanza in carcere, la duplice veste di Ministero e Asl: sia
danneggiati che responsabili.
Viviana Lanza su Il Riformista
il 16 Febbraio 2022.
Quello dei pestaggi avvenuti
il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere continua ad essere un
caso giudiziario più unico che raro. Ieri una nuova singolarità: il Ministero
della Giustizia e l’Asl di Caserta, che si erano già costituiti parte civile,
sono stati ammessi anche come responsabili civili, il che significa che
compariranno nel processo nella duplice veste sia di danneggiati sia di
responsabili con riferimento ai danni procurati ai detenuti dai loro dipendenti.
Potranno quindi chiedere un
risarcimento ai propri dipendenti nel caso di condanna di questi ultimi per il
comportamento violento o omissivo assunto il giorno dei pestaggi in carcere e
contemporaneamente potrebbero, nello stesso processo, essere condannati a
risarcire in sede civile i danni provocati ai detenuti da agenti o funzionari
dell’amministrazione penitenziaria, o dai due medici, tutti finiti sotto accusa,
a vario titolo, per i brutti fatti di Santa Maria. Il nodo sui responsabili
civili lo ha sciolto ieri il giudice dell’udienza preliminare Pasquale
D’Angelo dopo settimane di riflessione e basandosi anche su una sentenza
della Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite. Una vittoria per i circa cento
detenuti che si sono già costituiti parte civile nel processo. In totale si
ritiene che le vittime dei pestaggi siano 178, è dunque probabile che altri si
facciano avanti nelle prossime udienze, c’è tempo fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento.
Intanto l’udienza preliminare
è aggiornata al 29 marzo. La Procura aveva presentato proposta di patteggiamento
a pene intorno a un anno e mezzo per 32 agenti imputati che avrebbero avuto un
ruolo più marginale, ma non si è raggiunto per ora alcun accordo; per gli altri
imputati è probabile che i pm chiedano il rinvio a giudizio sempre che qualche
imputato non chieda a sua volta di accedere al rito abbreviato. Nel complesso si
parla di 108 fra agenti della polizia penitenziaria e funzionari del Dap (quindi
del Ministero) e di due medici del carcere (per questo il riferimento all’Asl)
imputati a diverso titolo per i pestaggi e le umiliazioni avvenute quel 6 aprile
2020 nel reparto Danubio del carcere sammaritano e per i tentativi compiuti dopo
la mattanza per occultarne le tracce e tenere tutto sotto silenzio.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Il caso. Non
indagarono sugli abusi nel carcere di Viterbo, Pm finiscono sotto inchiesta.
Angela Stella su Il Riformista il 31 Maggio 2022.
La Procura di
Perugia dovrà «procedere ad approfondimenti di indagine» nei confronti dei
colleghi di Viterbo per capire chi e perché non ha dato seguito a un esposto
presentato l’8 giugno 2018 dal Garante dei detenuti del Lazio, Stefano
Anastasia, sui pestaggi che alcuni detenuti avrebbero subìto nel carcere
Mammagialla. A deciderlo il gip di Perugia Valerio D’Andria. L’ipotesi di reato
è quella di rifiuto d’atti d’ufficio. Nella sua ordinanza si fa riferimento a
plurimi pestaggi che sarebbero avvenuti nel penitenziario viterbese e, in
particolare, quello che avrebbe visto coinvolto Hassan Sharaf. Il giovane
egiziano morì il 30 luglio 2018, a seguito di un tentativo di suicidio per
impiccagione nella cella di isolamento, dopo avere ricevuto alcuni schiaffi dal
personale di polizia penitenziaria.
Eppure il
Garante Anastasia aveva chiesto per lui il trasferimento perché il ragazzo aveva
detto di essere stato maltrattato da alcuni agenti. Su quanto accaduto
ad Hassan pendono due procedimenti a Roma e Viterbo. Comunque è stato proprio il
legale della famiglia di Hassan, l’avvocato Michele Andreano, a presentare una
denuncia ai magistrati di Perugia. Pochi mesi prima dell’estremo gesto, Hassan
aveva raccontato al Garante «di essere stato picchiato da alcuni agenti
di polizia penitenziaria che gli avrebbero provocato lesioni per tutto il corpo
e con molta probabilità gli avrebbero lesionato il timpano dell’orecchio
sinistro in quanto non riusciva più a sentire bene e sentiva il rumore “come di
un fischio”. Mentre raccontava quanto aveva subìto Sharaf velocemente si
spogliava così da mostrare i segni sul corpo».
Nell’esposto
depositato alla magistratura viterbese dal Garante dei detenuti si farebbe
riferimento ad almeno otto episodi di violenza. Un detenuto ha raccontato di
essere stato picchiato con calci e pugni da dieci agenti nelle scale del
carcere. «Dagli atti – scrive il gip perugino – emerge che in relazione a quanto
rappresentato nell’esposto del Garante è stato aperto nel luglio 2018 un
procedimento per fatti non costituenti reato e tale procedimento è stato
definito con trasmissione degli atti in archivio. Deve però rilevarsi che
l’esposto presentato dal Garante faceva riferimento ad una pluralità di episodi
violenti che avevano interessato numerosi detenuti e per i quali era quantomeno
ipotizzabile il delitto di cui all’articolo 571 c.p.», ossia abuso dei mezzi di
correzione o di disciplina.
In pratica,
secondo il gip di Perugia la Procura di Viterbo non avrebbe fatto il suo dovere,
ossia non avrebbe iscritto nel registro le notizie di reato apprese dal Garante.
«Si tratta in ipotesi del rifiuto di un atto che si sarebbe dovuto compiere
senza ritardo e per il quale non è riconoscibile in capo al magistrato alcun
margine di discrezionalità tenuto conto della chiara rappresentanza nell’esposto
di una pluralità di notizie di reati perseguibili d’ufficio». Ma c’è altro: il
gip ha ordinato indagini anche su un altro episodio, ossia la fissazione al 2024
dell’udienza di opposizione all’archiviazione del fascicolo sulla morte
di Hassan.
«Qualsiasi
iniziativa possa andare nella direzione dell’accertamento dei fatti – ci ha
riferito Anastasia – è benvenuta, sia nell’interesse delle persone che hanno
denunciato i maltrattamenti che della stessa amministrazione penitenziaria, che
ha interesse a essere trasparente e ad accertare eventuali responsabilità. Come
ho detto al Procuratore generale di Perugia, ho fatto degli esposti di cui non
ho saputo nulla fino a quando non mi ha convocato la stessa Procura generale di
Perugia. Nonostante l’enormità dei casi, ho avuto qualche traccia dei miei
esposti quando mi è stato detto che erano citati nel fascicolo processuale
aperto per la morte di Hassan Sharaf. Tuttavia dalla Procura di Viterbo nessuno
ha ritenuto di volermi sentire o anche solo di informarmi per dirmi che fine
avessero fatto questi esposti». Mentre ci riferisce l’avvocato Andreano: «Noi
come parti offese non abbiamo mai fatto un can-can mediatico. Riteniamo che le
nostre azioni siano fondate, pian piano ci sono dei magistrati che concordano
sulla necessità di fare chiarezza nell’interesse di tutti». Angela Stella
Riflettori su Ariano Irpino
e Santa Maria Capua Vetere. “Fake news sulle rivolte in carcere”, il garante dei
detenuti contro agenti e stampa.
Viviana Lanza su Il Riformista
il 15 Febbraio 2022.
Nei giorni scorsi alcuni
sindacati della polizia penitenziaria avevano diffuso comunicati stampa in cui
si faceva riferimento a presunte “rivolte” in carcere. In particolare
nelle carceri di Ariano Irpino e Santa Maria Capua Vetere. Proprio l’allarme sul
penitenziario casertano aveva destato grande preoccupazione in chi si era
trovato a leggere quelle note dei sindacati. Perché Santa Maria è stato teatro
della mattanza del 6 aprile 2020 che vede imputati oltre un centinaio di agenti
penitenziari per torture e lesioni ai danni di detenuti e perché l’allarme dei
giorni scorsi era legato a presunte rivolte dei detenuti, si temeva quindi una
nuova spirale di violenza per fortuna non c’è stata.
Purtroppo, però, da parte di
alcune testate giornalistiche c’è stata scarsa attenzione alla verifica delle
voci su presunte “rivolte”. Di qui il duro atto d’accusa del garante regionale
dei detenuti, Samuele Ciambriello: «Vorrei stigmatizzare i contenuti
allarmistici e da fake news in riferimento a presunte rivolte fatte dai detenuti
sia nel carcere di Ariano Irpino che nel carcere di Santa Maria Capua Vetere –
ha affermato – . Comunicati stampa diffusi dai sindacati di polizia
penitenziaria e pubblicati, incautamente e senza adeguate verifiche, sia da
quotidiani che da siti di informazione, persino dalla Rai che ha mandato sul
posto due inviati». A detta del garante regionale i fatti avvenuti in quelle
carceri non potevano definirsi “rivolte”.
«A Santa Maria Capua Vetere un
detenuto ha distrutto il corridoio del reparto Danubio e ha ferito due agenti, a
cui è stata data una prognosi di dieci giorni. Ad Ariano Irpino, invece, un
gruppo di detenuti ha distrutto le telecamere di videosorveglianza all’interno
di un solo reparto, così da poter forzare il cancello e quindi accedere ad
un’altra sezione per punire un detenuto – ha spiegato Ciambriello -. Insomma, mi
indigno sia per il procurato allarme sociale, sia per il fatto che la stampa non
ha controllato la veridicità di ciò che è avvenuto in questi istituti». Un atto
d’accusa duro, quello che il garante dei detenuti rivolge a due interlocutori
importanti nel panorama collettivo. Sullo sfondo, c’è poi tutta la complessità
di un tema, quello che riguarda il mondo penitenziario, che in questo momento
più che nel passato è sotto i riflettori.
Dovrebbe esserlo per porre
fine alle annose criticità, non per alimentare inutili o infondati allarmi. Ed è
da questa considerazione che nasce la riflessione che il garante
Ciambriello propone, chiedendo l’impegno a stemperare le tensioni e a
collaborare per il fine comune di garantire diritti e dignità a tutti, non solo
a chi lavora ma anche a chi vive nelle carceri. Di qui l’ennesimo appello
rivolto alla politica. «Proprio ieri ho portato
nel carcere di Poggioreale 3mila mascherine Ffp2 e materiale sanitario vario
(saturimetri, compresse per ipertensioni e cardiopatie, glucometro e strisce per
glicemia). Materiale che si aggiunge alle 13mila mascherine chirurgiche, alle
due sedie a rotelle, ai pannoloni e alle coperte per i detenuti ammalati del
reparto San Paolo consegnate nei giorni scorsi», ha raccontato Ciambriello. «Il
volontariato non può avere un ruolo subalterno – ha sottolineato -. Chiedo alla
politica un’assunzione di responsabilità di fronte a una situazione
insostenibile».
«Interventi del privato
sociale e del volontariato sono piccole gocce nel mare dell’oceano, rispetto al
carcere, alla sua dimensione disumana, al sovraffollamento – ha poi aggiunto
all’uscita da Poggioreale – È facile dire che le carceri scoppiano e che
Poggioreale è il carcere più sovraffollato d’Europa. Sulle carceri non si
intravede una via d’uscita: ci sono troppi problemi, situazioni insostenibili,
non vengono applicate le leggi esistenti e non si vive con dignità la dimensione
detentiva. Occorre subito un decreto svuota carceri. La politica deve attuare
una svolta: chiedo al Ministro della giustizia un’assunzione di responsabilità».
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Nuove indagini
dopo i pestaggi del 6 aprile 2020. Pestaggi in carcere, minacce a due detenuti
per indurli a ritrattare.
Viviana Lanza su
Il Riformista il 5 Febbraio 2022.
Santa Maria Capua
Vetere, pestaggi in carcere, una storia infinita. Sembrava che l’inchiesta sulle
violenze avvenute ai danni di centosettantotto detenuti del reparto Nilo il 6
aprile 2020 avesse chiuso il cerchio, che la sequenza benché terribile si fosse
esaurita in quelle tre ore di inferno che alcuni dei reclusi hanno poi avuto il
coraggio di denunciare e che le telecamere del circuito interno di
videosorveglianza dello stesso carcere sammaritano avevano inquadrato.
Sembrava tutto
messo nero su bianco nelle pagine dell’ordinanza di custodia cautelare con cui
la Procura di Santa Maria Capua Vetere, nel giugno scorso, aveva chiesto misure
cautelari per gli agenti più compromessi dai capi di imputazione contestati
(arresti poi in larga parte revocati) e sembrava tutto definito in quel pugno di
accuse ora al vaglio del giudice dell’udienza preliminare e che è stato un colpo
nello stomaco di tutti quelli che credono nelle istituzioni. «Una mattanza
orribile» la definì il gip al termine della lettura di tutti gli elementi di
indagine, una «mattanza di Stato» l’hanno ribattezzata i garanti e le
associazioni in difesa dei detenuti che si sono presentati all’udienza
preliminare al fianco dei detenuti picchiati (circa un centinaio) chiedendo e
ottenendo di essere parte civile nel processo che ci sarà sui pestaggi del 6
aprile 2020.
Sembrava di aver
visto abbastanza orrore, abbastanza abusi, abbastanza violenza. E invece la
notizia di un’ordinanza che dispone la sospensione dal servizio, per i prossimi
sei mesi, di un vice ispettore della polizia penitenziaria aggiunge un altro
tassello a quella drammatica ricostruzione. Il vice ispettore in questione ha
svolto fino a ieri il ruolo di coordinatore della sorveglianza generale proprio
all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere dove ad aprile 2020
avvennero i maltrattamenti e le umiliazioni, le botte e gli isolamenti di buona
parte dei detenuti affinché non raccontassero a nessuno del pestaggio e i lividi
sul loro corpo diventassero meno visibili. Secondo i recenti sviluppi
investigativi, questo vice ispettore avrebbe minacciato ripetutamente due
detenuti per spingerli a ritrattare il racconto di quel 6 aprile 2020 o a
modificare le dichiarazioni rilasciate agli investigatori sul suo conto.
Insomma, voleva
che i due reclusi cambiassero versione a suo favore in modo da farlo uscire
indenne dal processo per i pestaggi. Sulla base di questi sospetti investigativi
al vice ispettore è stato contestato il reato di intralcio alla giustizia.
L’agente non era stato raggiunto nel giugno scorso dalle 52 misure cautelari
emesse dal gip di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di poliziotti e
funzionari del Dap, ed essendo solamente indagato aveva continuato a lavorare
nel carcere dove l’anno prima avrebbe preso parte alle violenze, a stretto
contatto con alcuni dei detenuti che poi avevano denunciato i pestaggi. Un
cortocircuito, ancora uno, segnale di un sistema, quello penitenziario, che ha
mostrato tutte le sue criticità. L’udienza preliminare su quel che accadde il 6
aprile 2020 intanto va intanto avanti.
Giovedì sono
state ammesse 88 parti civili e la Procura ha fatto richiesta di patteggiamento
per 32 agenti fra i 108 che sono finiti sotto accusa. Tortura, uno dei reati più
gravi fra quelli contestati a vario titolo: introdotto in Italia nel 2017, è
contestato per la prima volta proprio in questo procedimento. E poi la
cooperazione nell’omicidio colposo di Lakimi Hamine, il detenuto algerino
affetto da schizofrenia morto in cella un mese dopo il pestaggio e dopo essere
stato messo per giorni in isolamento. E ancora lesioni e ipotesi di falso. Sì,
perché alcuni tentativi di depistaggio erano già emersi nella prima fase
dell’inchiesta. E ieri si è aggiunto un nuovo episodio alla lista delle ipotesi
al vaglio dell’accusa. Si attendono ulteriori sviluppi.
Viviana Lanza.
Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è
giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed
economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del
quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il
Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
La storia di una società
non è scritta solo sui muri delle prigioni, ma anche sui loro servizi igienici.
Luigi Manconi su La Repubblica l'11 gennaio 2022.
Ho sempre diffidato di quello
che in genere viene considerato un antico proverbio cinese.
Ma vitaepensiero.it precisa che sarebbe piuttosto “di discussa origine”. Quando
il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Devo dire che, in realtà,
avverto costantemente la tentazione di osservare con la più scrupolosa
attenzione proprio il dito indicante, perché potrebbe rivelare più cose di
quanto si creda. E perché quel motto rivela un notevole disprezzo per dettagli e
particolari, dove - ancora secondo una massima - si nasconderebbe il diavolo
oppure Dio.
Dunque, quando nella mia
precedente rubrica ho parlato di “paradigma del bidet”, attribuendo
doverosamente il copyright all’avvocata Maria Brucale, sapevo di andare incontro
a guai. La totale assenza di bidet, specialmente nelle celle delle sezioni
femminili, esprime un notevole disprezzo per la salute e la dignità delle
persone recluse, oltre a misurare il degrado generalizzato del sistema
penitenziario nazionale. Apriti cielo: la cosa non è passata inosservata e ha
scatenato numerose reazioni.
Il riferimento a
quell’apparecchio igienico sembra richiamare una immagine del carcere che
costituisce una sorta di ossessione paranoide per le fantasie di vendetta che si
scaricano su di esso. In altre parole, la richiesta del bidet sembra connotare
quel presunto “hotel a 5 stelle”, fornito di “televisione a colori” contro cui
si indirizzano tutti i livori, i rancori e le pulsioni più torve del
giustizialismo nazionale. Ecco un altro dettaglio interessante: se invece che “a
colori”, volessimo che in ogni cella vi fosse un più severo e afflittivo
apparecchio in bianco e in nero (non più prodotto in alcun paese al mondo),
dovremmo aprire una nuova fabbrica di televisori destinati esclusivamente alla
prigione. Ma torniamo al bidet. Tutti gli aspiranti cosmopoliti de’ noantri e i
globalisti da Touring Club si sono affrettati a ricordare che il bidet “esiste
solo in Italia”. E, addirittura, una lettrice residente in Francia ha voluto
spiegare che “come altri 65 milioni di francesi”, lei “non soffre di questa
mancanza”.
Che dire? Tutti critici che
non vogliono guardare il dito, ovvero il bidet: e, pertanto, preferiscono non
sapere che, in gran parte delle celle, un uomo - e tanto più una donna, per
ragioni che forse è superfluo richiamare - può trovarsi a usare lo stesso
rubinetto e lo stesso limitato spazio per bere, lavarsi viso, mani e ascelle,
per il bucato, per riempire d’acqua una pentola e farla bollire e, infine, per
pulirsi genitali e culo. Io mi fermo qui perché, davvero, mi mancano gli
argomenti; davvero, se ciò che ho scritto non viene inteso è certamente colpa
mia, ma non ho che da arrendermi; davvero, non penso di poter ricorrere a
ulteriori motivazioni razionali, se finora non sono riuscito a trasmettere il
senso di quella situazione.
Anche per questa ragione è
quanto mai preziosa l’attività, così spesso ignorata e denigrata, di quelle
migliaia di volontari che operano in carcere, silenziosamente e faticosamente.
Non perché sono “buoni”, ma perché hanno un profondo spirito civico e sanno che
offrire ai detenuti una opportunità significa offrirla a tutti noi. Penso al
lavoro che fanno da decenni associazioni come Ristretti Orizzonti di Ornella
Favero e Francesco Morelli, Antigone di Susanna Marietti e Patrizio Gonnella, A
Buon Diritto di Valentina Calderone e Federica Graziani, L’altro Diritto di
Emilio Santoro e Sofia Ciuffoletti, A Roma insieme di Leda Colombini e Giovanna
Longo e numerosi gruppi e comitati locali. E preti, suore, militanti politici,
avvocati, filosofi e sociologi, tutti convinti che “la storia di una società è
scritta sui muri delle prigioni”.
Il paradigma del bidet e la
vita nelle carceri congestionate.
Luigi Manconi su La
Repubblica il 4 gennaio 2022.
"Con una suora portiamo dei
vestiti a un detenuto, delle coperte ai dializzati del reparto san Paolo e do un
passaggio a casa a Gino che ha avuto un permesso premio di sette giorni". Così
racconta Samuele Ciambriello, Garante dei diritti delle persone private della
libertà per la regione Campania. E già questo dà la misura di cosa sia
effettivamente il carcere, se lo osserviamo dal punto di vista dei bisogni
elementari non soddisfatti e dei diritti fondamentali non tutelati.
Necessari nuovi modelli.
Giustizia e carcere, la pena non può più essere solo sequestro del tempo.
Domenico Alessandro
De Rossi su Il Riformista il 27 Gennaio 2022.
Tra i tanti argomenti
interessanti il (mal)funzionamento della Giustizia ogni giorno di più emerge per
la gravità delle condizioni in cui si trova proprio l’esecuzione penale. Non è
più rinviabile un’ampia riflessione riguardante cosa significhi oggi, ma
segnatamente per il domani, la funzione della detenzione alla luce del dettato
costituzionale. Urgente oggi è anche un’ampia valutazione su come realizzare
tale scopo.
Il ragionamento è ovviamente
legato ai problemi dell’edilizia penitenziaria, della gestione del patrimonio
preesistente e dei possibili nuovi istituti, oltre al suo eventuale rapporto col
territorio. Recentemente Franco Corleone, che di carceri se ne intende, senza
tanti giri di parole su Il Manifesto viene al punto: «Non sopporto più
l’ipocrisia di chi lamenta il fenomeno senza indicare le cause». In sostanza si
dice stanco, anche lui, di questo strano rapporto tra fittizie intenzioni di
cambiamento e conseguenti apparenti doglianze per i risultati mai raggiunti che
non individuino le responsabilità. Tra le ultime iniziative assunte dal ministro
Bonafede nel 2021, poi ereditate dalla Guardasigilli Cartabia (non sappiamo in
che termini e con quale entusiasmo), c’è la notizia dell’ennesima istituzione
della Commissione per l’architettura penitenziaria.
Titolo altisonante quello del
tavolo, promosso in prima persona non si sa da chi. Richiamando in nome
dell’arte del costruire la Commissione, l’operazione sembrerebbe essere stata
più un assicurare la presenza alle future decisioni che non quello di risolvere
quanto di attuale, urgente e necessario pretende la gravissima situazione.
Costruzioni complesse sono le carceri. Per lo stato disastroso in cui si trovano
oggi, è più rispettoso annoverarle nel campo dell’edilizia penitenziaria, ben
lontana questa dimensione dall’architettura. Le Commissioni sono formate in
buona parte sempre dagli stessi professionisti che, nonostante puntualmente
vengano chiamati per le doverose dissertazioni, ostinandosi a parlare di
architettura permangono nei fatti comodamente fuori dalla più semplice
discussione edilizia che riguarda gli impianti mal funzionanti, i tetti rotti,
gli arredi fatiscenti, gli spazi inadeguati, laboratori inesistenti, celle
sottodimensionate.
Pensiamo che al massimo le
Commissioni, per dovere istituzionale, l’esistenza dell’ancora non
abrogato articolo 27 della Costituzione, accomodandosi così nei più sicuri
binari di stretta osservanza formale. Di fatto l’ultima commissione Bonafede, i
cui risultati dei lavori svolti sono poco noti, sembrerebbe essere niente di più
che il solito auspicio di quanto sarebbe bello se si potesse avere un carcere a
misura dei diritti umani, in regola col dettato costituzionale e costruito
secondo canoni rispettosi della buona architettura. A detta di chi è meglio
informato di me, questo risultato della Commissione sarebbe l’«ennesimo atto
della rappresentazione della “stagione dei proclami architettonici” in tema di
carcere». Lacrime di coccodrillo? Può darsi. Ma questa affermazione rivela se
non altro una coazione a ripetere dei partecipanti riuniti nei soliti riti
ministeriali dei tavoli e delle commissioni. Ben sapendo che i risultati non ci
saranno. In compenso subito dopo si affretteranno a lamentarsi della loro
inconcludenza.
Data la suddetta coazione,
sono da escludere debite distanze dalla accertata inutilità
delle Commissioni, dei convegni e dei tavoli tecnici. Almeno per coltivare la
propria immagine, il partecipare può essere cosa utile, non certo alle carceri,
ma sicuramente alla persona. Qui Franco Corleone ha visto giusto. Insomma è
veramente necessario che la ministra Cartabia muova verso nuovi modelli
interpretativi in concorso con altre competenze ministeriali sulla vera funzione
dell’esecuzione penale. Il futuro della riflessione sull’esecuzione della
condanna e del suo significato deve passare per la riduzione drastica della
recidiva, proponendo nuovi modelli organizzativi destinati a supportare le
istituzioni, trasformandosi in servizi per il territorio. Insomma il sequestro
del tempo come condanna e vendetta surrettizia deve cambiare nella civile
opportunità di recupero e reinserimento nel corpo sociale. Nell’interesse non
solo del detenuto. Domenico Alessandro De Rossi
Sul carcere, un muro di
gomma. Non so più come parlarne. Troppa la voglia di dimenticare.
Roberto Saviano su Il
Corriere della Sera il 14 Gennaio 2022.
La foto che ho deciso di
mostrarvi questa settimana ritrae una donna che mostra a sua volta una foto,
quella del figlio, Antonio Raddi, il ragazzo di 28 anni morto il 30 dicembre
2019 nel carcere delle Vallette a Torino, dopo aver perso 25 chili in pochi
mesi. Antonio era tossicodipendente e aveva un’infezione polmonare.
Nell’immagine di Jessica
Pasqualon, la madre di Antonio Raddi, Rosalia Federico, il 30 dicembre 2021, nel
secondo anniversario della morte del figlio in carcere a Torino, mostra una sua
foto. Antonio aveva 28 anni e aveva perso 25 chili.
Non più edilizia carceraria,
ma meno detenuti. Non l’introduzione di nuovi reati o l’inasprimento delle pene
per quelli già esistenti, ma educazione alla responsabilità. Oggi, più che in
ogni altro momento della storia, chi fa informazione ha una responsabilità
enorme, quella di ragionare insieme a chi legge; quella di non cedere alla
scorciatoia del generare panico, dell’accrescere la preoccupazione per rendere
il proprio ruolo “fondamentale”. Chi fa informazione fa servizio pubblico anche
se per conto di un privato e non gli è richiesta tanto oggettività, ma
un’opinione espressa con conoscenza, con cognizione di causa e — si spera —
anche con onestà. Non sono molti i giornalisti e i quotidiani che ogni giorno si
occupano di carcere. In realtà sono pochi — tra questi Il Dubbio, Il
Riformista e il Manifesto — e lo fanno con competenza perché sanno di essere un
punto di riferimento. Eppure non riescono, e non per propria responsabilità, a
segnare una strada che altri sentano la necessità impellente di dover seguire.
MI SENTO DIRE CHE GIÀ LA VITA
NON È FACILE PER CHI NON COMMETTE REATI, PERCHÉ OCCUPARSI DI CHI È IN PRIGIONE?
Si sbatte il mostro in prima
pagina senza dare conto delle archiviazioni, delle assoluzioni. Si parla di
prescrizione come fosse un regalo all’imputato e non il diritto negato a essere
giudicati in tempi umani. E siccome il carcere viene raccontato solo per mappare
gli arresti, ci si accontenta di sapere che dentro finisce chi ha un debito con
la comunità, chi deve pagare, scontare, essere privato della libertà - e in
fondo anche di molto, molto altro - senza preoccuparsi mai di come viene
impiegato il tempo che dovrebbe servire al reinserimento. Nemmeno so più in che
termini parlarne, di carceri. Trovo un muro di gomma inconcepibile spesso anche
tra gli interlocutori più attenti. Come se il solo parlarne potesse
compromettere qualcosa, allontanare lettori, telespettatori, finanche amici in
una conversazione informale.
Spesso la risposta che ottengo
è: la vita non è facile per me che non ho commesso alcun reato, perché mi dovrei
preoccupare di chi sta in carcere? E così mi accorgo che manca non tanto e non
solo la cultura del diritto, ma la cultura dei diritti e cioè la consapevolezza,
che dovrebbe essere un dato condiviso, che di diritti non si occupa solo chi non
ha preoccupazioni proprie, chi ha una vita agiata e quindi può concedersi il
lusso di pensare agli altri. La cultura dei diritti dovrebbe appartenere a tutti
e da tutti essere condivisa, perché un diritto negato diventa automaticamente un
privilegio per pochi o, peggio, una concessione; perché siano chiari, una volta
per tutte, i ruoli: chi è incudine e chi martello.
La foto che ho deciso di
mostrarvi questa settimana ritrae una donna che mostra a sua volta una foto,
quella del figlio, Antonio Raddi, il ragazzo di 28 anni morto il 30 dicembre
2019 nel carcere delle Vallette a Torino, dopo aver perso 25 chili in pochi
mesi. Antonio era tossicodipendente e aveva un’infezione polmonare che lo ha
portato alla morte. Una morte che doveva essere evitata, una morte avvenuta
mentre era affidato allo Stato che non ha saputo prendersi cura di lui. Ho
voluto ricordare Antonio Raddi perché la famiglia si è opposta alla richiesta di
archiviazione del Gip per quattro medici dell’istituto penitenziario indagati
per omicidio colposo. E quindi la vicenda ha richiamato l’attenzione dei pochi
che si occupano di queste vicende nell’indifferenza generale.
L’indifferenza del rimosso, il
rimosso della piaga enorme della tossicodipendenza, il rimosso della sofferenza
che questa porta con sé. Il rimosso del disagio e del nulla che lo Stato e la
comunità fanno per fornire aiuto concreto. Ho letto le parole che sul caso ha
pronunciato la garante dei detenuti di Torino, Monica Gallo, la quale si è
occupata a fondo di questa tristissima e inaccettabile vicenda. In un’intervista
sul manifesto, Gallo afferma che Antonio Raddi è stato visitato in carcere «ma
con sguardo assuefatto». Assuefatto perché tossicodipendente, assuefatto perché
troppi detenuti e poco personale, assuefatto perché ormai sentiamo parlare
continuamente di sofferenza tanto da non riuscire più a riconoscerla quando ci
troviamo davanti quella vera, profonda e che non lascia scampo.
Quando Netflix ha
trasmesso Sanpa ho creduto, ho sperato, mi sono augurato potesse aprirsi un
dibattito sul disagio e il crimine legato alle tossicodipendenze. Macché! Se ne
è parlato per quanto? Un paio di settimane, forse. Poi silenzio. Meglio
dimenticare.
Le lettere dal carcere.
Stare chiusi in galera costa un occhio della testa…Rita
Bernardini su Il Riformista il 14 Gennaio 2022.
Due lettere dal carcere con un
unico comune denominatore. Tutti e due i detenuti hanno perso l’occhio sinistro.
Uno ha paura di perdere anche quello destro, l’altro chiede di essere trasferito
in un centro clinico penitenziario perché dopo mesi non si è ancora venuti a
capo della malattia “rara” che lo colpisce.
Personalmente sono sommersa
dalle disperate segnalazioni che arrivano da tutta Italia e così immagino lo
siano tutti coloro che si occupano di carcere, a partire dai garanti e dalle
associazioni. La diffusione del Covid ha aggravato all’inverosimile le
condizioni di detenzione strutturalmente “fuorilegge” da decenni. Da qui lo
sciopero della fame che ho ripreso e che coinvolge decine di persone; da qui
l’essere speranza: per se stessi e per gli altri.
La detenzione si paga con… un
occhio della testa.
F. G. è un quarantunenne ed è
in carcere per scontare 2 anni e 8 mesi. Nel settembre 2019, mentre era detenuto
nel carcere di Lecce, avverte l’area sanitaria di avere un occhio gonfio e molto
arrossato. Dopo 37 giorni, arriva l’oculista che gli fa la diagnosi:
“congiuntivite”, e gli prescrive un collirio al cortisone. Prende le prime due
gocce e la mattina dopo da quell’occhio non ci vede più. Il detenuto chiede di
essere portato in ospedale, ma ciò avviene solo dopo 17 giorni grazie alla
protesta dei compagni di cella e a una dottoressa del carcere che si
impietosisce. I medici dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce si arrabbiano:
nell’occhio era finita una piccola scheggia che aveva provocato un piccolo foro:
bastava andare subito in ospedale per toglierla e, invece, con il ritardato
ricovero e con il cortisone prescritto, quel piccolo foro è diventato molto
ampio provocando un ascesso corneale.
All’ospedale di Lecce il
detenuto rimane ricoverato per due mesi, con i medici che fanno di tutto per
salvargli l’occhio, ma l’impresa appare impossibile. A dicembre gli viene
sospesa la pena e lui può andare da “libero” al policlinico di Bari e
successivamente al Careggi di Firenze per tentare un trapianto di cornea. Poi
arriva il Covid, il detenuto ritorna in carcere e ora si trova ad Ascoli Piceno.
Avrebbe bisogno di un monitoraggio costante (impossibile in carcere) perché
l’occhio è ancora infetto e può coinvolgere l’altro dove gli mancano già 4 gradi
e mezzo. Mi scrive “vivo con ansia e paura di diventare completamente cieco”. Il
giudice gli ha concesso i domiciliari per potersi curare, ma il suo problema è
che non ha una casa, un posto dove andare e chiede aiuto alle istituzioni. “Vi
prego aiutatemi, sono solo senza genitori, non ho nessuno.”
G. M. è un ex
tossicodipendente di 34 anni e come molti è in carcere (a Pavia) per scontare
una condanna di 5 anni e mezzo per reati legati alla sua condizione di
dipendenza da sostanze vietate. Mi scrive: «incoscientemente facevo reati per
drogarmi e così ho lasciato a casa moglie e figlio di tre anni. È da due anni
che sono in carcere e in tutta la mia vita sono stato detenuto per circa 11
anni. Oggi ho capito i miei errori e ho deciso di cambiare radicalmente la mia
vita perché amo mia moglie e il mio bambino. Mi sono anche avvicinato alla
Chiesa e prego spesso Dio che stia vicino a me e ai miei cari. Purtroppo, tutte
queste preghiere non sono bastate e mi sta capitando una sorta di castigo divino
e questa è la ragione per cui le scrivo sperando in un suo aiuto. La mattina del
18 ottobre 2021 mi sono svegliato e ho scoperto che non ci vedevo più
dall’occhio sinistro.
Sono stato subito portato al
Pronto Soccorso e, da quel giorno, è iniziato il mio calvario. Sono afflitto da
una malattia rara che nessuno sa cosa sia: l’unica certezza è una lesione del
nervo ottico che mi ha portato alla completa cecità dell’occhio sinistro, dolori
muscolari diffusi, forti mal di testa e perdita frequente di sangue dal naso. Il
Dirigente sanitario del carcere afferma che quello che mi sta capitando è
anomalo alla mia età e pertanto mi sta sottoponendo a vari esami. La stessa
comprensione che ho trovato nel dirigente sanitario e nel personale
penitenziario spesso non la riscontro però nei medici di turno e negli
infermieri che tardano nei soccorsi nei casi di emergenza. Uno di questi, un
medico, un giorno mi ha detto “venite in galera e state male, poi una volta
fuori state tutti bene!”. Ma ti rendi conto? Eppure, sa che ho perso un occhio e
solo da un anno sono uscito da una forte depressione che mi ha portato più volte
a tentare il suicidio».
G.M. racconta poi
dettagliatamente tutti gli episodi che gli sono accaduti con tanto di date e
chiede aiuto perché a Pavia, nel carcere, non sono in grado di curarlo. «Mi può
stare anche bene rimanere in carcere, ma almeno mi trasferiscano in un centro
clinico! Qui a Pavia ti fanno morire e ne ho visti qui morire o stare molto
male, qui è una vera valle di lacrime…» Rita Bernardini
La realtà dietro le sbarre.
Non solo i magistrati, tutti dovrebbero vivere un giorno in cella.
Riccardo
Polidoro su Il Riformista il 5 Gennaio 2022. «Per ogni magistrato sarebbe utile
vivere per qualche settimana la vita del carcere» è una frase che ricorre
ciclicamente in quei rari casi in cui i media si occupano di detenzione che,
invece, da sempre – non ciclicamente – vive un’insopportabile, ingiusta ed
incivile quotidiana emergenza. Oggi più che mai, con il virus che si
autoalimenta in ambienti ristretti e priva i detenuti anche di quel poco che
avevano. La citazione, questa volta, è di Bernardo Petralia, capo
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in un’intervista al
quotidiano La Repubblica.
Egli ci confida che, quando
vinse il concorso in magistratura, fu suo suocero, penalista, a dirglielo e che
adesso capisce il significato di quelle parole. All’incirca, quindi, 40 anni fa
quest’indicazione fu data, non a caso, da un avvocato ad un neo-magistrato. Il
periodo storico è quello della recente entrata in vigore dell’ordinamento
penitenziario del 1975, che prevedeva e prevede, all’articolo 69, che proprio un
magistrato – quello di Sorveglianza – deve visitare costantemente gli istituti
di pena per vigilare sulla loro organizzazione e prospettare al Ministro della
Giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all’attuazione
del trattamento rieducativo. Deve esercitare, inoltre, la vigilanza diretta ad
assicurare che l’esecuzione della pena sia attuata in conformità delle leggi e
dei regolamenti. Quanto previsto dall’ordinamento, nella maggior parte dei casi,
non avviene. Sono pochissimi i magistrati di Sorveglianza che rispettano tale
norma e quelli che lo fanno non prospettano al ministro le innumerevoli e
gravissime carenze strutturali, organizzative, sanitarie e igieniche che
affliggono le nostre carceri. Una malattia cronica contro la quale coloro che
dovrebbero combatterla si sono, da tempo, arresi.
Non ci sfugge che il senso
delle parole di Petralia non riguarda i magistrati di Sorveglianza, ma le toghe
in generale che non conoscono affatto la realtà del carcere. Egli stesso,
infatti, nel riportare le parole del suocero-avvocato, ammette che ora ne
capisce fino in fondo il significato, perché, solo dopo la sua nomina dello
scorso anno, ha iniziato a visitare gli istituti di pena. Nel febbraio del 2012,
su iniziativa dell’allora garante dei detenuti della Campania, Adriana
Tocco, ben 21 pubblici ministeri visitarono l’istituto di Napoli-Poggioreale,
tra questi l’attuale procuratore della Repubblica Giovanni Melillo, all’epoca
procuratore aggiunto, che in più occasioni ha sostenuto la necessità, da parte
della magistratura tutta, di conoscere la realtà detentiva. Non a caso
la Procura di Napoli, sotto la sua direzione, ha istituito una sezione
specializzata in reati commessi in carcere ed ha sottoscritto un protocollo
d’intesa con l’Ufficio del garante nazionale dei diritti delle persone detenute
o private della libertà personale. Atti che non hanno inciso sulla drammatica
realtà delle carceri napoletane, ma che, se non altro, sono il segnale di una
particolare sensibilità che, purtroppo, deve fare i conti con un mondo – quello
detentivo – chiuso in se stesso, autoreferenziale e che non suscita alcun
interesse da parte della classe politica.
Non so se sia davvero
importante che i magistrati entrino o meno in carcere. Potrebbe non essere
necessario in quanto basterebbe che facessero il loro lavoro nel rispetto di
quanto previsto dalle norme, considerando, ad esempio, la custodia
cautelare effettivamente l’extrema ratio e non una pena prima del processo, che
non di rado, si conclude con un’assoluzione. Le ingiuste detenzioni sono, in
media, tre al giorno. Va promossa, invece, nell’opinione pubblica, la conoscenza
di come è oggi il carcere e come, invece, dovrebbe essere. Va indicata
l’importanza della pena scontata secondo i principi costituzionali e non in loro
violazione. Alcuni anni fa, l’Osservatorio Carcere dell’Unione camere penali si
fece promotore dell’iniziativa “Carceri porte aperte” e molti cittadini ebbero
l’opportunità di visitare i luoghi detentivi, conoscendone il bene ma anche
l’enorme male che essi fanno alla comunità tutta. Visitiamole le carceri,
magistrati e cittadini e vergogniamoci di quanto tolleriamo. Riccardo Polidoro
Dopo la proposta del capo
del Dap ai magistrati.
La prigione di Halden in Norvegia come Poggioreale negli anni
’80: la migliore del mondo. Viviana Lanza su Il Riformista il 5 Gennaio 2022.
Prima di diventare il migliore del mondo, anche quello norvegese era un sistema
penitenziario in cui molti detenuti avevano problemi psichiatrici, nelle celle
circolava droga, i detenuti organizzavano proteste ed evasioni, tre guardie
penitenziarie furono uccise e il tasso di recidiva era del 70%. Erano gli anni
Ottanta e accadeva quello che più o meno accade ancora oggi nelle nostre
prigioni, con la differenza che in Norvegia in questi quarant’anni sono riusciti
a rendere possibile la rivoluzione del sistema penitenziario al punto da
trasformare Halden e, da struttura di reclusione simile alle nostre grandi
prigioni (pensiamo a Poggioreale), portarla ad essere il carcere più umano e
vivibile del mondo, mentre da noi ancora si discute di come far arrivare l’acqua
potabile in un carcere aperto da metà anni Novanta e con una media di circa
mille detenuti (parliamo di Santa Maria Capua Vetere).
Certo, alla base della
rivoluzione norvegese ci sono stati investimenti di soldi (il carcere migliore
del mondo è costato 250 milioni di dollari nel 2010) ma la spinta più forte ed
efficace è arrivata dalla svolta culturale. «Quando sono entrato nel sistema
penitenziario, mi è stato detto che non dovevamo parlare con i detenuti dei loro
problemi e che il nostro dovere era solo di sorvegliarli, per cui l’interazione
degli agenti con i detenuti era minima. Oggi invece gli agenti lavorano e
mangiano con i detenuti, fanno sport e passeggiate insieme a loro. Questo è il
concetto di sorveglianza dinamica che applichiamo. L’agente è diventato, oltre
che una guardia, un operatore sociale», raccontò il direttore del carcere Are
Høidal alla delegazione dell’Helsinki Vommitee, associazione per la difesa dei
diritti umani in Romania, durante una visita nel carcere norvegese. È il senso
di comunità il punto di forza di questo sistema penitenziario, il principio alla
base del concetto di sorveglianza dinamica di cui parlava il direttore Høidal.
Il carcere non è un mondo a
parte, come dalle nostre parti. In Norvegia, dal 2008, è in vigore una Carta
bianca in base alla quale il sistema della giustizia deve essere incentrato
sull’idea di normalità e sulla riabilitazione dei detenuti e per rendere questo
possibile c’è un protocollo firmato da cinque ministri: Giustizia, Istruzione,
Cultura, Salute e Autonomie locali. Un altro fattore cruciale è legato
all’organizzazione della vita in carcere: i detenuti di Halden non oziano in
cella per quasi l’intera giornata (eppure vivono in una stanza di 12 metri
quadrati, da noi ce ne sono otto, persino dieci, in molti meno metri quadrati) e
le attività trattamentali non sono centellinate fra la popolazione dei reclusi.
I detenuti di Halden devono scegliere tra il lavoro e la scuola, possono
specializzarsi in uno dei sette corsi di formazione professionale offerti con il
rilascio del titolo di studio a fine corso, o imparare a suonare uno strumento
in uno dei tre studi di registrazione del carcere. Purché si tengano impegnati.
La struttura resta un luogo di reclusione, ma gli spazi della pena sono
concepiti a misura d’uomo e soprattutto rispettando l’uomo in quanto persona in
tutti i suoi diritti. Il concetto seguito è quello per cui la vita in cella non
deve essere diversa da quella fuori le mura carcerarie e che la pena non deve
privare il detenuto di ciò di cui ha bisogno per vivere in maniera dignitosa.
Sin dal primo giorno di reclusione, il detenuto in Norvegia viene preparato alla
sua liberazione intraprendendo un percorso di responsabilizzazione, per cui deve
lavorare, pagare le tasse, coltivare gli affetti e trovare una motivazione. Chi
non rispetta le regole viene isolato, ma in genere la convivenza tra i detenuti,
e tra loro e gli agenti penitenziari, scorre più serena. E i risultati sono nel
tasso di recidiva: solo il 20%. Non ci sono studi su studi, commissioni su
commissioni, proclami su proclami. Si applica nel concreto quello che prevede
anche la nostra Costituzione.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Il caso rischia
l'archiviazione. Antonio muore dopo aver perso 30 chili in carcere, famiglia
chiede processo: “Mai avute risposte, non deve succedere più”.
Carmine Di Niro su Il
Riformista il 30 Dicembre 2021. “Mio figlio l’hanno lasciato morire, non è la
prima volta che succede e non deve più accadere”. Sono le parole, rotte da
emozione e rabbia, pronunciate da Rosalia Federico, madre di Antonio Raddi, il
ragazzo di 28 anni detenuto al carcere delle Vallette di Torino morto il 30
dicembre di due anni fa per sepsi, 17 giorni dopo essere entrato in coma.
Una storia dalle tante ombre
secondo la famiglia, che chiede che il caso non venga archiviato dal Gip, come
richiesto nei giorni scorsi dalla Procura di Torino che aveva aperto un
fascicolo per omicidio colposo.
Come ricordato dal legale
della famiglia Raddi, Gianluca Vitale, la Procura di Torino ha disposto una
prima consulenza medico-legale “che si è chiusa con l’affermazione ‘Antonio e’
morto perché doveva morire’“.
Quindi l’incidente probatorio
chiesto dal pm titolare del caso è stato negato dal gip, seguito da una seconda
consulenza in cui vi era scritto che il progressivo calo di peso “avrebbe dovuto
essere contrastato diversamente, anche con l’ausilio di approfondimenti
clinico-specialistici e di laboratorio”.
Antonio, è l’accusa
dell’avvocato Vitale, “è stato accusato di non mangiare perché sperava di essere
scarcerato, ma in realtà non riusciva più ad alimentarsi. Antonio è morto per
un’infezione da batterio, che se contratta in condizioni diverse, senza una
perdita di peso significativa, forse avrebbe potuto superare”.
LA STORIA DI ANTONIO – Antonio
è morto all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove era arrivato in condizioni
disperate e sopratutto dopo aver perso 30 chili in pochi mesi di reclusione,
entrando alle Vallete col peso di 80 chili e uscendone praticamente cadavere
facendo segnare sulla bilancia 50 chili.
La sua storia la racconta in
una conferenza stampa tenuta oggi, a due anni dal decesso, la Garante dei
detenuti di Torino Monica Gallo, che ha seguito personalmente il caso: “Antonio
entra in carcere il 28 aprile 2019 e già il 15 luglio il padre esprime grande
preoccupazione per un evidente dimagrimento. Ad agosto dall’Asl mi dicono che
non c’è alcuna criticità, ma a settembre le condizioni peggiorano. Il 3 dicembre
chiedo allora un ricovero urgente. Antonio è in sedia a rotelle, ha le labbra
viola, quando lo incontro mi dice che non riesce a mangiare e vomita sangue“.
“Il 10 dicembre – prosegue la
garante Gallo – Antonio viene ricoverato con urgenza all’ospedale Maria
Vittoria, ma il giorno dopo riceviamo una rassicurazione dall’Asl e dalla
direzione del carcere, dicono che la situazione è sotto controllo. Visitiamo
ancora il ragazzo ma sta sempre peggio. Il 12 dicembre il Garante nazionale
spiega che va assolutamente ricoverato, ma ormai è troppo tardi. Il 13 dicembre
Antonio entra in coma e ci resta fino al 30 dello stesso mese, quando morirà per
un’infezione”.
L’APPELLO DELLA FAMIGLIA – Il
padre di Antonio, Mario Raddi, spiega quindi che il figlio “non ha mai fatto uno
sciopero della fame”, semplicemente “in carcere non gli è mai stato proposto di
andare in un reparto sanitario. Dopo l’ultimo ricovero, il primario di
Rianimazione del Maria Vittoria ci ha chiamati in ufficio e ci ha detto che in
quarant’anni di servizio non aveva mai visto nulla di simile. In quei
diciassette giorni di coma, funzionavano solo cuore e cervello, gli altri organi
erano tutti compromessi”.
Mario Raddi racconta anche un
episodio che fa ben capire le condizioni in cui è morto il figlio: “Gli
operatori delle onoranze funebri non sono neppure riusciti a vestirlo, così lo
hanno avvolto in un lenzuolo bianco”.
Anche da parte sua l’appello è
quello di ottenere la verità sulla morte del figlio 28enne, finito in carcere
per condanne per rapine, maltrattamenti ed evasione. ”Speriamo che si dica come
sono davvero andate le cose, senza falsità. Antonio stava male da mesi, beveva
caffè e fumava tantissimo, l’acqua gli procurava dei fortissimi mal di stomaco.
Un ragazzo detenuto con Antonio ci ha detto che l’intera sezione del carcere
quando mio figlio stava male, ha protestato affinché lo curassero, ma nessuno li
ha ascoltati. Io non potevo fare nulla eppure lui me l’aveva detto ‘papa’ fammi
uscire che mi fanno morire qui dentro‘“.
Carmine Di Niro. Romano di
nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di
politica, sport e tecnologia
Quei troppi detenuti
lasciati morire perché sospettati di “simulare” un malessere inesistente.
Nelle carceri
italiane muoiono in media 150 detenuti l’anno, dei quali un terzo circa per
suicidio e un terzo per “cause da accertare”. Damiano Aliprandi su Il Dubbio il
31 dicembre 2021. Erano detenuti che avevano tumori, leucemie, distrofie
muscolari, ulcere sanguinanti, anoressia, ma non curati in tempo perché gli
operatori credevano che simulassero. Non è un caso raro quello di Antonio Raddi,
detenuto al carcere le Vallette di Torino, che morì il 30 dicembre 2019 a 28
anni per una infezione polmonare dopo avere perso 25 chili di peso, ma che
nessuno l’ha curato in tempo perché gli operatori credevano che simulasse.
Nelle carceri italiane muoiono
in media 150 detenuti l’anno, dei quali un terzo circa per suicidio, un terzo
per cause immediatamente riconosciute come “naturali”, e il restante terzo per
“cause da accertare”, che indicano tutti i casi nei quali viene aperta
un’inchiesta giudiziaria. È difficile credere che in tutti questi casi la morte
sia stata un evento improvviso, inatteso e imprevedibile; più probabilmente ha
rappresentato l’epilogo di una malattia che progressivamente si aggrava, con
segni clinici e sintomi via via più evidenti che avrebbero dovuto allarmare i
sanitari, far disporre il ricovero in ospedale e, quanto meno, dare l’avvio alle
procedure per l’ottenimento del rinvio della pena o della detenzione
domiciliare.
Perché questo non accade?
Spesso non viene prestata sufficiente attenzione ai sintomi della malattia, ai
detenuti non sempre vengono creduti quando lamentano un malessere. Tanti,
tantissimi sono casi del genere.
Roberto Jerinò, detenuto nel
carcere calabrese di Arghillà, morì nel 2014
Il caso emblematico,
denunciato già da Il Dubbio, riguarda la morte di Roberto Jerinò, detenuto al
carcere calabrese di Arghillà e morto dopo dolori lancinanti a dicembre del 2014
presso l’ospedale di Reggio Calabria. L’allora sessantenne Jerinò, durante la
detenzione, cadde per terra perché la sua gamba perse la memoria dei movimenti,
poi il braccio e infine la bocca. Venne portato di corsa in ospedale: ischemia,
fu la diagnosi, con paresi facciale degli arti. L’avvocato, come logico, chiese
la concessione dei domiciliari. Rigettato. Subito riportato in carcere,
nonostante la diagnosi.
Secondo la testimonianza di
alcuni detenuti, alle 3 di notte del 12 dicembre del 2014, Jerinò sentì
assottigliarsi e allargarsi una vena in testa; era un movimento continuo,
lievemente doloroso. Chiamò un suo compagno di cella chiedendogli una camomilla;
credeva avesse bisogno di tranquillizzarsi. Non riuscì a dormire quella notte.
La mattina si segnò in elenco per l’infermeria: gli misurarono la pressione,
nessuna anomalia. Fu così per l’intera giornata: un dolore costante, ritmato; la
pressione era stabile. Il 13, tutto uguale: dolore e pressione, stabili. Non
facevano altro che misurargli la pressione e riportarlo in cella. Stava
impazzendo Jerinò, sentiva quella vena come se fosse una sanguisuga. Lamentava
dolore. Dopo aver trascorso tre giorni di lamenti, e richieste di soccorso,
rimase paralizzato nel letto. Lo portarono in ospedale che era già in coma. Non
si risvegliò più. Morì il 23 dicembre del 2014.
Ripeschiamo un altro caso
lontanissimo nel tempo, ma particolarmente emblematico. Si chiamava Uzoma Emeka,
detenuto nigeriano di 32 anni, il quale muore nel carcere di Teramo il 18
dicembre 2009 per un tumore al cervello mai diagnosticato. Dalla relazione
dell’avvocato Alessandro Gerardi, che ha potuto visitare il carcere di Teramo e
raccogliere la testimonianza dei compagni di cella di Emeka al seguito di una
delegazione di parlamentari radicali, si legge che venti giorni prima di morire,
aveva già cominciato ad avvertire alcuni forti capogiri: perdeva i sensi
all’improvviso, sveniva in cella e nelle docce, vomitava, non riusciva ad
alzarsi dal letto, non mangiava, deperiva a vista d’occhio.
Ogni volta che perdeva i
sensi, i compagni di cella lo conducevano in infermeria sulle spalle, ma il
medico di guardia, dopo pochi minuti, senza fare né disporre ulteriori
accertamenti, lo rimandava in cella prescrivendogli tutt’al più qualche
“pillola” per dormire. Anche la notte prima di morire Emeka era stato rispedito
dall’infermeria nella cella, ma stava talmente male da non riuscire a rimanere
nemmeno steso sul letto e cadeva continuamente a terra. Dopo alcuni tentativi è
stato lasciato privo di sensi per terra, con un lenzuolo, per l’intera nottata,
nonostante avesse vomitato più di una volta e gli altri detenuti ne chiedessero
l’immediato ricovero in infermeria. Risultato: la mattina seguente lo hanno
trovato con la bava alla bocca, rigido e privo di coscienza. Solo dopo qualche
ora è stata finalmente chiamata l’ambulanza, ma ormai i medici non hanno potuto
fare altro che constatarne il decesso.
Nelle carceri italiane quando
si verificano casi di mancato ascolto del paziente, esami clinici non
effettuati, diagnosi sbagliate, in definitiva cure non prestate, il vero motivo
è spesso lo stereotipo che vuole il detenuto manipolativo e falso, che simula un
malessere (o ne esagera i sintomi) allo scopo di ottenere dei “benefici”.
Inoltre i medici sono consapevoli che per un detenuto la libertà vale più della
salute, quindi spesso “sospettano” che possa aver messo in atto pratiche
autolesionistiche per auto- provocarsi i disturbi che lamenta e che, comunque,
non seguirà le terapie prescritte in quanto gli “conviene” lasciare che la
malattia si aggravi, nella speranza di ottenere l’incompatibilità con il regime
detentivo. Tutto ciò porta a un’amara conclusione: tante morti in carcere
potevano ( e possono) essere evitate.
Fa delinquere, fa uccidere
e uccide. Perché il carcere è un pericolo per la nostra società e va abolito.
Luigi
Manconi su Il Riformista il 31 Dicembre 2021. Carissimi, sono tentato di fare
mio quel “sono un detenuto” di Totò Cuffaro perché convinto, come lui, che chi è
stato recluso lo è in qualche modo per sempre. Nel senso che chi ha conosciuto
la prigione ne subisce gli effetti e i condizionamenti per tutta la vita.
Anch’io sono stato in cella per sette mesi, ma richiamare una durata tanto breve
suona quasi ridicolo quando si parla davanti a “lungodegenti”: persone che il
carcere lo patiranno per anni e per decenni.
D’altra parte, cinquant’anni
fa, io ero un detenuto politico, arrestato a seguito di gravi scontri con
militanti neofascisti. Questo è un dato importante perché io, quei sette mesi,
non solo li ho trascorsi in diverse carceri italiane il cui livello di decoro
era superiore a quello attuale, ma perché vivevo la reclusione con un
atteggiamento di tranquillità operosa; e perché, soprattutto, la prigionia era
conseguenza di una consapevole scelta politica e ciò dava al carcere un suo
senso: un effetto collaterale, non voluto ma non sorprendente della militanza
politica. All’opposto, è mia convinzione che oggi il carcere non abbia alcun
senso. Nessuna razionalità e nessuna utilità. Un sistema totalmente fallimentare
rispetto allo scopo indicato dalla Carta costituzionale. Una macchina insensata:
criminogena e patogena. Criminogena perché il suo effetto principale è quello di
riprodurre all’infinito crimini e criminali. La sola ricerca attendibile sulla
recidiva ci dice che, per chi sconta interamente la pena in carcere, la
reiterazione del reato sfiora il settanta percento. Patogena in quanto genera
malattia, autolesionismo, morte.
Il tasso di suicidi, secondo
uno studio condotto insieme al professor Giovanni Torrente, è superiore di
sedici-diciassette volte rispetto a quello registrato nella corrispondente
fascia d’età tra le persone libere. Da qui la convinzione profonda che il
carcere vada abolito. Nel 2015, con Stefano Anastasia, Valentina
Calderone e Federica Resta, abbiamo scritto un libro con questo titolo: Abolire
il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini, pubblicato
da Chiare Lettere, di cui stiamo curando una nuova edizione per i primi mesi
dell’anno. Dico subito che la nostra non è una provocazione né un palpito
profetico. È, invece, un programma politico e una strategia normativa. Abolire
il carcere significa, cioè, mettere in atto una serie di misure e provvedimenti
capaci progressivamente ma concretamente di rendere la cella superflua, di
ridurre la sua apparente necessità e ineludibilità: e di lavorare affinché
costituisca davvero l’extrema ratio.
Quando, qualche tempo fa, mi
capitò di essere Sottosegretario alla Giustizia con delega al carcere, insieme
al magistrato Sebastiano Ardita, responsabile dell’ufficio Detenuti e
trattamento del DAP, commissionammo un’indagine che evidenziò come la quota
di reclusi “socialmente pericolosi” superasse di poco il dieci percento
dell’intera popolazione detenuta. Per quella minoranza il carcere rappresenta,
probabilmente, la sola possibile misura di contenimento. Ma per tutti gli altri?
Un programma alternativo è possibile, secondo i seguenti
punti. Depenalizzazione. Va prevista una depenalizzazione generale, che
sostituisca la sanzione penale con quella amministrativa o civile rispetto a
reati non espressione di una particolare pericolosità dell’autore, e per il
contrasto dei quali l’adozione di misure alternative non penali possa ritenersi
sufficientemente dissuasiva. Decarcerizzazione. Il ricorso al carcere dev’essere
limitato ai delitti di gravità e pericolosità tali da far temere il “pericolo
della libertà” del loro autore. In sostituzione vanno previste la detenzione
domiciliare o sanzioni interdittive, prescrittive e pecuniarie. In alcuni
ordinamenti, quali quello tedesco, greco e danese, l’ambito di applicazione
della multa è talmente ampio (si stima dell’85% delle pene irrogate
in Germania), da limitare le pene detentive ai soli condannati socialmente
pericolosi (stimati al 15% nella stessa Germania). Va da sé che le sanzioni
pecuniarie debbano essere modulate in rapporto alla capacità economica dei
condannati.
Una ulteriore e drastica
riduzione della popolazione detenuta si può ottenere attraverso misure che
riguardino tre “gruppi” vulnerabili, particolarmente numerosi nelle carceri:
tossicomani, pazienti psichici, stranieri che, privi di regolari titoli di
ingresso e soggiorno in Italia, finiscono col precipitare, per varie ragioni,
nell’illegalità e nel circuito penale. Se questi provvedimenti e la prospettiva
nella quale vanno inseriti appaiono irrealizzabili è solo perché manca la
volontà politica di tradurli in concreti progetti di riforma. E manca la
consapevolezza di un dato generalmente trascurato, eppure rivelatore:
la Costituzione non parla mai di carcere, né di pena detentiva. Anche se i
costituenti conoscevano solo il carcere, forse l’avevano conosciuto tanto bene
sulla propria pelle da non voler aggettivare le pene, lasciando campo libero a
un legislatore che volesse cambiare radicalmente la fisionomia delle sanzioni.
Siamo dunque autorizzati a osare. O, almeno, a sperare. Auguro un grande
successo a Nessuno Tocchi Caino. (Ha collaborato Lucrezia Fortuna)
Luigi Manconi. Intervento al
Congresso di Nessuno tocchi Caino
Chiesta l’archiviazione per
14 reclusi dopo le denunce degli agenti: fu calunnia.
Violenze in carcere, i pm:
“nessuna rivolta a Santa Maria Capua Vetere prima dei pestaggi”. Elena Del
Mastro su Il Riformista il 31 Dicembre 2021. All’indomani dell’esplosione del
caso dell’ “orribile mattanza” nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, gli
agenti penitenziari giustificarono quella che definirono una “perquisizione
straordinaria” in risposta a una protesta violenta fatta dai detenuti. La
Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiesto l’archiviazione per 14
detenuti che erano stati denunciati dal personale della polizia penitenziaria in
servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere per le proteste del 5 aprile
2020, che portarono il giorno successivo ai pestaggi da parte di circa 300
agenti della Penitenziaria e violenze ai danni di quasi trecento detenuti del
Reparto Nilo.
Lo scenario che viene fuori al
momento è tremendo: non ci furono lesioni e minacce ai danni degli agenti della
polizia penitenziaria e per questo le loro accuse sono oggetto di una richiesta
di archiviazione da parte della Procura. Una violenza che sarebbe dunque
scattata senza alcun motivo. Le prove e i tentativi di depistaggio da parte
degli agenti sarebbero state costruite ad arte con foto e dichiarazioni che poi
i video avrebbero smentito.
Secondo la ricostruzione fatta
dall’Ansa la perquisizione straordinaria, che il Gip di Santa Maria Capua Vetere
definì nell’ordinanza di arresto emessa il 28 giugno scorso “un’orribile
mattanza”, fu motivata dai vertici del carcere e del Dap come una risposta alle
proteste avvenute il giorno prima, quando alcuni detenuti del Reparto Nilo
occuparono i corridoi dopo aver saputo della positività al Covid di un recluso;
la protesta rientrò dopo alcune ore, e il giorno dopo nelle celle dei detenuti
furono ritrovate, a detta degli agenti, pentolini con olio bollente e spranghe.
Ma secondo la Procura quegli
oggetti furono messi apposta lì dagli agenti, per giustificare il ricorso alla
violenza contro i detenuti. Dopo la protesta furono individuati 14 detenuti
quali capi della rivolta e denunciati per resistenza e minaccia a pubblico
ufficiale e lesioni personali; questi, tra cui l’algerino Hakimi Lamine, furono
portati in isolamento. Secondo quanto riportato dal Mattino gli agenti per
creare un precedente, per giustificare la violenza, chiesero “le teste” dei capi
della rivolta e, scegliendo tra i detenuti “ultimi tra gli ultimi”, gli
esecutori di quell’ordine andarono a pescare dalla psichiatria, tra gli
ergastolani, e tra gli stranieri. Dodici “predestinati” furono messi in
isolamento. E furono “liberati” solo dopo l’arrivo in carcere del magistrato di
sorveglianza Marco Puglia. Avevano ancora i vestiti insanguinati. Era l’8 aprile
2020, due giorni dopo la rappresaglia nel Nilo.
Uno dei detenuti indicato tra
i capi della rivolta era l’algerino Hakimi Lamine. Secondo la Procura l’uomo
morì stroncato dai farmaci ad inizio maggio 2020 dopo un mese di isolamento e
per la sua morte sono indagati in 12 tra ufficiali e sottufficiali della polizia
penitenziaria e funzionari del Dap. Per la Procura quella morte fu “causata
delle torture”. Agli atti anche i racconti dei detenuti che erano con lui negli
ultimi istanti di lucidità quando, ormai in agonia, chiamava la madre. Lamine
compare in alcuni video mentre durante le proteste mangiava crackers sotto la
porta della sua cella. Ed era in una sezione diversa da quella interessata dai
disordini, ma la Penitenziaria lo indicò falsamente tra i leader della protesta.
Per la Procura (Procuratore
Aggiunto Alessandro Milita e sostituti Daniela Pannone e Alessandra Pinto)
quella protesta del 5 aprile non diede luogo a reati, come denunciato dalla
penitenziaria; anzi la Procura ha contestato anche il reato di calunnia ad
agenti e funzionari che denunciarono i detenuti, e ora il Gip di Santa Maria
Capua Vetere dovrà decidere se archiviare le accuse a carico dei reclusi.
Elena Del Mastro. Laureata in
Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di
Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie
delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.
(ANSA il 26 aprile 2022) - La
Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 107 persone, in particolare
poliziotti della Penitenziaria e funzionari del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria (Dap), per le violenze avvenute nell'aprile
del 2020 nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere.
La richiesta è avvenuta nel
corso dell'udienza preliminare davanti al gup Pasquale D'Angelo; per un altro
agente coinvolto è stato richiesto poi il proscioglimento, che si aggiunge ad
altre dodici analoghe richieste avanzate dalla Procura alcuni mesi fa (in totale
erano 120 gli indagati). Due imputati hanno poi chiesto di poter accedere al
rito abbreviato.
La mattanza di Santa Maria
Capua Vetere. Carcere degli orrori, a processo 107 tra agenti penitenziari e
funzionari.
Viviana Lanza su Il Riformista il 27 Aprile 2022.
I racconti dei detenuti che
hanno avuto il coraggio di denunciare, i video ripresi dalle telecamere di
sorveglianza interne al carcere, le intercettazioni telefoniche degli agenti
finiti sotto accusa e le chat tra colleghi e funzionari. C’è tutto questo nella
storia dei pestaggi avvenuti il 6 aprile 2020 nel reparto Nilo
del carcere di Santa Maria Capua Vetere. «La pagina più brutta» come l’hanno
definita in tanti. E come ha ricordato il procuratore Alessandro
Milita pronunciando le conclusioni della Procura dinanzi al giudice dell’udienza
preliminare.
La pubblica accusa ha concluso
con una richiesta di rinvio a giudizio per 107
imputati, fra poliziotti e funzionari della penitenziaria. Ha chiesto il
processo davanti alla Corte d’assise, cioè davanti a un collegio composto da
giudici togati e cittadini della giuria popolare. La richiesta si fonda sulla
contestazione dell’aggravante secondo cui i pestaggi concorsero a determinare la
morte di uno dei detenuti picchiati, Lakimi Hamine, detenuto algerino
considerato un soggetto fragile per via di problemi di natura psichiatrica e
trovato morto in cella un mese dopo quel pomeriggio di violenze e i giorni di
isolamento. Ritenendo inoltre la connessione tra le torture e le lesioni ai
danni degli oltre cento detenuti del reparto Nilo e il caso Hamine, l’accusa ha
chiesto che il processo si celebri davanti alla Corte d’assise non solo per gli
agenti e i dirigenti direttamente chiamati a rispondere delle conseguenze che
portarono alla morte del giovane detenuto algerino ma anche di tutti gli altri
imputati, quindi degli agenti che si armarono di caschi e manganelli formando
quel corridoio umano che diede il via alle violenze, di chi li cooptò e li
coordinò, di chi seguì tutto a distanza dalle stanze più alte della gerarchia
penitenziaria.
La decisione spetterà al
giudice Pasquale D’Angelo che concluderà l’udienza preliminare al termine delle
discussioni di tutti gli avvocati di parte civile e del collegio di difesa.
Forse entro giugno, si vedrà. Centosette imputati, si diceva. Un numero che
rende unico questo processo. Per uno solo degli agenti coinvolti la Procura ha
ieri concluso con una richiesta di proscioglimento: le indagini hanno accertato
che Luigi Macari non era in servizio quel 6 aprile 2020 ed era stato quindi
erroneamente inserito nell’elenco degli agenti che parteciparono
alla “mattanza”. Altri due agenti imputati hanno invece optato per il rito
abbreviato, accettando di definire la propria posizione direttamente in sede di
udienza preliminare e sulla base degli atti raccolti dal pubblico ministero,
senza gli approfondimenti e le lungaggini del dibattimento. Tutti gli altri,
invece, seguiranno la via del rito ordinario. Molti, infatti, in questo
processo, che in dibattimento avrà una durata di anni visti i numeri e la
complessità dei fatti, si giocano anche il posto di lavoro: in caso di condanna,
rischierebbero il licenziamento. I reati contestati spaziano a vario titolo
dalla tortura alle lesioni, falso in atto pubblico, abuso di autorità.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
Macelleria sammaritana,
richiesto il giudizio per 107 imputati.
Sono agenti penitenziari e
funzionari del Dap, accusati a vario titolo di tortura, lesioni e falso per gli
episodi di violenza avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile
del 2020. Damiano Aliprandi su Il Dubbio il 27 aprile 2022.
Richiesto il rinvio a giudizio
per 107 persone per le violenze avvenute il 6 aprile del 2020 nel carcere
casertano di Santa Maria Capua Vetere, nello specifico parliamo degli agenti
della polizia penitenziaria e funzionari del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria (Dap).
La richiesta è avvenuta nel
corso dell’udienza preliminare davanti al gup Pasquale D’Angelo. Per un altro
agente coinvolto è stato richiesto poi il proscioglimento, che si aggiunge ad
altre dodici analoghe richieste avanzate dalla Procura alcuni mesi fa (in totale
erano 120 gli indagati). Ricordiamo che per 12 agenti era contestato il reato di
cooperazione in omicidio colposo relativo alla morte del detenuto algerino
Lakimi Hamine, deceduto il 4 maggio 2020 dopo essere stato tenuto per giorni in
isolamento. Proprio per quest’ultimo caso inizialmente la Procura aveva scelto
di contestare il reato di “morte come conseguenza di altro reato“, bocciato dal
Gip Sergio Enea che la classificò come suicidio. La decisione del Gip è stata
però impugnata dalla Procura che ha provveduto a integrare il quadro
accusatorio.
Sono accusati di tortura,
lesioni e falso
Per gli agenti e funzionai ai
quali la procura sammaritana ha chiesto il rinvio a giudizio, le accuse sono a
vario titolo di tortura, lesioni, reati di falso. Ricordiamo che, secondo quanto
accertato sulla base delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza
del carcere, nonché dalle chat tra gli agenti di polizia penitenziaria e dalle
dichiarazioni dei detenuti, il pomeriggio del 6 aprile 2020, tra ore 15.30 e le
19.30, all’interno del reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere,
numerosi agenti di Polizia penitenziaria – giunti anche dalle carceri di
Secondigliano e di Avellino – hanno esercitato una violenza cieca ai danni di
detenuti che, in piccoli gruppi o singolarmente, si muovevano in esecuzione
degli ordini di spostarsi, di inginocchiarsi, di mettersi con la faccia al muro.
I detenuti, costretti ad
attraversare il cosiddetto corridoio umano (la fila di agenti che impone ai
detenuti il passaggio e nel contempo li picchia), venivano colpiti violentemente
con i manganelli, o con calci, schiaffi e pugni; violenza che veniva esercitata
addirittura su uomini immobilizzati, o affetti da patologie ed aiutati negli
spostamenti da altri detenuti, e addirittura non deambulanti. Tra le immagini
più crude fecero scandalo quelle del detenuto sulla sedia a rotelle picchiato
con il manganello, e dei detenuti fatti passare in un corridoio formato da
agenti che li prendevano a manganellate, o a calci e pugni.
Nelle quattro ore di mattanza
umiliazioni degradanti
Oltre alle violenze, venivano
imposte umiliazioni degradanti – far bere l’acqua prelevata dal water, sputi,
ecc. -, che inducevano nei detenuti reazioni emotive particolarmente intense,
come il pianto, il tremore, lo svenimento, l’incontinenza urinaria. Dopo le
quattro ore di “mattanza”, le sofferenze fisiche e psicologiche venivano
perpetrate anche nei giorni immediatamente successivi, in particolare nei
confronti dei quattordici detenuti trasferiti dal reparto Nilo al reparto
Danubio – perché ritenuti ispiratori della protesta del 5 aprile -, costretti
senza cibo, e, per 5 giorni, senza biancheria da letto e da bagno, senza
ricambio di biancheria personale, senza possibilità di fare colloqui con i
familiari; tant’è che alcuni detenuti indossavano ancora la maglietta sporca di
sangue, e, per il freddo patito di notte, per la mancanza di coperte e di
indumenti, erano stati costretti a dormire abbracciati; anche ai detenuti
rimasti al reparto Nilo veniva riservato un trattamento degradante, addirittura
con l’imposizione, volutamente mortificante della capacità di
autodeterminazione, del taglio della barba, secondo quanto orgogliosamente
rivendicato in uno dei messaggi inviati sulla chat del gruppo di agenti di
Polizia penitenziaria.
Arrivarono agenti da altri
istituti che non sono stati ancora identificati
Quel giorno, ribadiamo,
arrivarono anche oltre cento agenti da altri istituti di pena come
Secondigliano, inviati dal direttore del Dap Antonio Fullone, i quali non sono
stati ancora identificati a causa dei caschi e delle mascherine che indossavano
in quella circostanza. In totale i detenuti vittime dei pestaggi sono stati 177,
tanto che la Procura, per avvisare tutte le parti offese, ha deciso di ricorrere
alla notificazione per pubblici annunci, con deposito dell’avviso di conclusione
indagini presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere e con la pubblicazione di
un estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
«È nostro dovere riflettere
sulla contingenza ma anche sulle cause profonde che hanno portato un anno fa ad
un uso così insensato e smisurato della forza nel carcere di Santa Maria Capua
Vetere. Fatti di questa portata richiedono da un lato una risposta immediata da
parte dell’autorità giudiziaria, ma ai miei occhi sono spia di qualcosa che non
va e dobbiamo indagare e intervenire con azioni ampie e di lungo periodo perché
non accada più».
A dirlo è stata la ministra
della Giustizia Marta Cartabia a luglio del 2021, nel corso dell’informativa
urgente alla Camera sui fatti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
«Fatti di quella portata reclamano un’indagine ampia perché si conosca quanto è
successo in tutti gli istituti penitenziari nell’ultimo drammatico anno, dove la
pandemia ha esasperato tutti, perché le carceri italiane già vivono in
condizioni difficili per il sovraffollamento, per la fatiscenza delle strutture,
per la carenza del personale e per tante altre ragioni – ha proseguito -. Dunque
occorre guardare in faccia i problemi cronici dei nostri istituti penitenziari
affinché non si ripetano più atti di violenza né contro i detenuti né contro gli
agenti della polizia penitenziaria e tutto il resto del personale. Il carcere è
specchio della nostra società ed è un pezzo di Repubblica che non possiamo
rimuovere dal nostro sguardo e dalle nostre coscienze», aveva affermato sempre
la guardasigilli tra gli applausi dell’aula.
È aperto un fascicolo per le
violenze nel carcere di Modena
In quell’occasione, la
ministra Cartabia ha annunciato di avere «costituito al Dap una commissione
ispettiva che visiterà tutte le carceri interessate dalle proteste». Va infatti
ribadito che non è solo il carcere di Santa Maria Capua Vetere ad essere
attenzionato. Come ha riportato Il Dubbio, ci sono altre carceri dove sarebbero
avvenuti dei pestaggi. Attualmente è aperto un fascicolo che riguarda il carcere
di Modena. Dalle testimonianze raccolte dalla procura, emerge che diversi
detenuti sarebbero stati ammassati in una stanza vengono obbligati con lo
sguardo a terra, alcuni sarebbero stati denudati con la scusa della
perquisizione, e via a una violenta scarica di manganellate e ceffoni. Emerge un
vero e proprio massacro che ha luogo in un locale situato in un casermone
attiguo al carcere di Modena, prosegue durante il viaggio notturno in pullman e
non si esaurisce quando i detenuti giungono al penitenziario di Ascoli Piceno.
Tanti di quei reclusi denudati
e picchiati nel casermone dell’istituto carcerario Sant’Anna di Modena erano già
in stato di alterazione dovuto da mega dosi di metadone assunte durante la
rivolta dell’8 marzo 2020. Sono soprattutto reclusi stranieri a essere stati
picchiati, tanti di loro – com’è detto -, in stato di incoscienza dovuto
dall’assunzione elevata dose di droga e psicofarmaci. Ma tra loro c’era anche
Salvatore Piscitelli, l’uomo che in seguito – trasferito nella notte al carcere
di Ascoli Piceno assieme agli altri – morirà dopo essere stato trasportato di
urgenza in ospedale con un oggettivo ritardo rispetto alla richiesta di aiuto da
parte dei suoi compagni di cella. Come già riportato da Il Dubbio, la procura di
Ascoli Piceno ha presentato la richiesta di archiviazione. L’associazione
Antigone, tramite l’avvocata Simona Filippi, ha avanzato opposizione.
I pestaggi in cella.
Mattanza in carcere e silenzio di Stato: “Noi derisi e umiliati per aver
denunciato, detenuti trasferiti per punizione”.
Viviana Lanza su Il Riformista
il 27 Aprile 2022.
«Dopo aver subìto critiche e
sospetti per le denunce presentate, apprendiamo ora che ci fu un uso smisurato e
insensato della forza, una violenza a freddo», afferma il garante
regionale Samuele Ciambriello, commentando la notizia della richiesta di rinvio
a giudizio avanzata dalla Procura nei confronti
di 107 fra agenti e funzionari della penitenziaria nell’udienza preliminare per
le torture e i pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
Ciambriello è parte civile insieme al garante nazionale Mauro Palma,
all’associazione Antigone, ad altre associazioni che si occupano dei diritti dei
detenuti e molti dei reclusi che subirono le violenze messe in atto dagli uomini
della penitenziaria il 6 aprile 2020.
Si era in piena pandemia e le
tensioni erano altissime ovunque. Il giorno prima un gruppo esiguo di detenuti
inscenò una breve protesta per chiedere mascherine e tamponi. La risposta della
penitenziaria il giorno seguente fu quella che gli inquirenti hanno definito
«orribile mattanza». «Ho sempre detto, sin dai primi giorni rimanendo però
inascoltato, che questa storia era una ferita gravissima della dignità delle
persone e quando arrivarono i primi avvisi di garanzia subii critiche e
umiliazioni di politici che continuavano a dire che era stata una rivolta»,
aggiunge Ciambriello ricordando il muro di diffidenza da superare. Perché quando
si parla di carcere si fa presto a definire vittime e carnefici secondo cliché
populisti.
Poi sono arrivate le denunce
messe nero su bianco, le foto e infine le riprese video che hanno documentato le
sequenze della mattanza, la dinamica e i volti di chi eseguì la spedizione
contro un centinaio di detenuti del reparto Nilo. Le indagini durarono poco più
di un anno. Nessuno aveva mai parlato di quei pestaggi se non alcuni dei diretti
interessati e i garanti. «Per tanto tempo c’è stato molto silenzio attorno a
questa vicenda – ricorda Ciambriello – . Si potrebbe parlare oltre che di
mattanza di Stato anche di silenzio di Stato». Un silenzio interrotto quando su
giornali e web cominciarono a circolare le immagini e i video dei pestaggi. A
quel punto il dubbio si dipanò. «Con piacere voglio ricordare che oltre alla
nostra costituzione di parte civile c’è anche quella del garante nazionale e del
Ministero della Giustizia», aggiunge Ciambriello sottolineando come in questa
vicenda ci sia stato anche un momento in cui al danno si unì la beffa.
Fu quando l’inchiesta della
Procura sammaritana arrivò alla svolta con le misure cautelari (poi revocate)
nei confronti di una buona parte degli oltre cento poliziotti e funzionari
indagati e contemporaneamente ci fu il trasferimento di una settantina di
detenuti fra coloro che avevano subìto i pestaggi e poi denunciato.
Ufficialmente quei trasferimenti furono decisi per tutelare i detenuti che
avevano denunciato, ma nei fatti si tradussero in una sorta di seconda punizione
per i diretti interessati perché furono portati in carceri fuori regione, alcuni
anche a distanza di centinaia di chilometri, con tutte le difficoltà di fare poi
i colloqui con i propri familiari. Una trentina di detenuti, in questo anno,
sono rientrati in istituti di pena più vicini alla Campania, altri invece hanno
deciso di mantenere la distanza fisica dal luogo di quell’inferno.
Viviana Lanza. Napoletana,
laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista
professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia.
Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano
Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il
Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).
·
Le fughe all’estero.
Le fughe all’estero di
orchi e killer. Ogni settimana un’estradizione.
Andrea Galli su Il Corriere
della Sera il 9 luglio 2022.
Una rivoluzione rispetto
all’immaginario collettivo dell’estradato quale unicamente boss della
criminalità organizzata come per esempio Rocco Morabito, il 55enne già
«avanguardia della ‘ndrangheta» per dirla con un alto ufficiale dei carabinieri
che gli diede la caccia, atterrato a bordo di un aereo Falcon dal Brasile nella
notte tra martedì e mercoledì, e adesso destinato a tre decenni di prigione, la
durata della sua latitanza in Sudamerica tra cocaina e tesori milionari,
rapporti col Potere ed evasioni farsesche. I l ha esaminato il corposo dossier
del ministero della Giustizia sulle settanta persone riportate in Italia nel
ristretto arco temporale di quindici mesi, in coincidenza
dell’insediamento della ministra Marta Cartabia. E ha scoperto una narrazione di
storie e biografie criminali, missioni diplomatiche, analisi e gestioni di casi
di geopolitica quasi o per niente mediatiche.
Gli ostacoli
L’estradizione è, di suo,
un’operazione complessa e complicata, vincolata al dialogo e alle chirurgiche
trattative con altre nazioni spesso inserite nella lista nera dei cosiddetti
«Stati-canaglia», pertanto riottose a collaborare; ed è, l’estradizione,
giuridicamente bisognosa di un gran lavorio sotterraneo e silenzioso che
banalmente può venir compromesso da un fax tardivo. Per tacere delle mosse dei
latitanti una volta catturati e in attesa di consegna: non rara l’azione di
aggredire un agente, macchiandosi così di un reato locale che può innescare
provvedimenti nello Stato chiamato alla consegna, bloccando il completamento
dell’estradizione. E anche per tacere della «disobbedienza» di elementi di
Governi esteri i quali, in conseguenza di una varietà di cause, dalla corruzione
alla paura se non alla mera azione di disturbo contro rivali politici,
favoriscono la permanenza di un delinquente invece da estradare (che può essere
un imputato, in attesa di giudizio penale, oppure un condannato da sottoporre
alle sanzioni stabilite dai Tribunali).
Il maniaco dei bambini
Qualcuno conosce il 74enne
Marcello Pigozzo ? S’era nascosto negli Stati Uniti dove credeva di divenire
fantasma lasciandosi indietro il passato di maniaco pedo-pornografico, i
computer intasati d’ogni possibile orrore con abusi contro i bambini. E il
45enne Luca Fiorentino? Scappato in Inghilterra, perseguito per violenze
sessuali su, di nuovo, minorenni. Rimpatriato Pigozzo, rimpatriato Fiorentino.
Due operazioni rese possibili da Paesi con i quali il dialogo è robusto, le
relazioni bilaterali avviate, il rischio di sorprese limitato. È con altre
nazioni che le estradizioni bisognano di un’intensa preparazione. Tradotto:
soluzioni che sarebbero scontate nel nostro alfabeto non incontrano obbligate
adesioni altrove. Come in Albania. O meglio: come un tempo in Albania.
Le rotte della coca
A lungo ha resistito una sorta
di certezza ripetuta dagli investigatori specie dell’Interpol: i criminali
albanesi le tentano tutte pur di farsi trasferire nei penitenziari di Tirana o
Valona perché poi, tanto, pagando escono quando vogliono. Il tema albanese è di
rara e intensa complessità e, forse come pochi altri, necessita di distinguo a
fronte di generalizzazioni. Ma è indubbio che l’elevata presenza, nell’elenco
del ministero della Giustizia, di albanesi dall’Italia condannati e in Italia
riportati, ci collega in forma esclusiva alle rotte del narcotraffico. Anni fa,
quei malavitosi albanesi attivi nella droga erano notori per l’ossessiva e
ottusa capacità di dilaniarsi in guerre intestine, per ambire velocemente a
ruoli egemonici stanchi com’erano di fare i galoppini delle cosche; preferivano
il guadagno subito e immediato anziché una lungimirante politica di
programmazione. Oggi no. Oggi ci sono boss albanesi che trattano alla pari con i
narcos sudamericani ragionando da sofisticati manager; boss che reclamano spazio
e potere sapendo di poterli ottenere; boss che, per un ulteriore collegamento a
Morabito, di sicuro hanno festeggiato la fine dello stesso boss, visto che dal
Brasile all’Argentina, dalla Bolivia al Cile, lungo i canali della cocaina si è
creata una voragine nella quale (provare a) inserirsi. Sicché le estradizioni di
Mateo Gjepali o Julian Mandija, di Kristo Mahmutaj o Arber Kojko, appunto tutti
albanesi e trafficanti, sono un marchio netto: segnano uno spartiacque anche per
innegabile merito del Governo albanese.
La mamma uccisa
Prevedibile obiezione: tante
grazie, Tirana ambisce all’ingresso nell’Unione europea e quindi… Però nella
vita contano i fatti, e spostando la geografia – ma il concetto non cambia –,
ecco che non era per nulla prevedibile che gli Emirati Arabi, uno dei classici
Paesi inseriti nella «black list» e meta d’una apposita missione della ministra
Cartabia, consegnassero il potente narcos Raffaele Imperiale, camorrista dotato
di ramificate reti nell’Olanda dei quintali di cocaina, e insieme aderissero a
un percorso comune con l’Italia firmando appositi e inediti accordi bilaterali.
Relazioni migliorate anche con la Tunisia dove si era rifugiato, sicuro
d’incontrare protezione assoluta al di là di eventuali sentenze dei giudici e
incarcerazioni, Mootaz Chaambi, il quale a Palazzolo, in provincia di Brescia,
aveva massacrato la moglie Daniela, mamma di due bimbi: 39 coltellate inferte
senza la minima esitazione. La riuscita dell’operazione-Chaambi era fino a poco
tempo fa insperabile. Del resto nell’analisi delle estradizioni avvenute, vanno
inserite numerose variabili relative alle differenze di leggi, popoli,
abitudini, e anche degli orgogli patriottici, della valenza che certe azioni con
lo straniero hanno in termini di propaganda e riconoscibilità degli elettori,
del circoscritto periodo nel quale avviene la trattativa bilaterale e anche con
quale partner specifico.
Falcone e Borsellino
Fin dai tempi dei brigatisti
sanguinari e codardi che laggiù scapparono vivendo di sole e d’ozio, il
Sudamerica si conferma terra ricettiva per i criminali. Anche qualora la
situazione degeneri: le debolezze strutturali delle carceri, l’estesa corruzione
e il rischio perenne di fughe di massa a causa di sollevazioni popolari e colpi
di Stato, sono le condizioni per le quali a lungo Morabito ha cercato di
rimanere in Brasile evitando di salire sul Falcon verso l’Italia, aeroporto di
Ciampino. Ma come il pregiudizio è l’errore massimo che un investigatore può
compiere, così nella diplomazia internazionale contano i momenti e i loro
interpreti, non il prima né il dopo, non le sicurezze apriori e le
sottovalutazioni. Rappresenta un innegabile elemento qualitativo, pur se dettata
dall’emergenza, la richiesta avanzata dal Paraguay di un aiuto italiano per
aggiornare la Costituzione – sì, addirittura la Costituzione – dopo l’omicidio
del pubblico ministero Marcelo Pecci, 45enne che ricorda drammaticamente, troppo
drammaticamente, i magistrati dei quali in Colombia Pablo Escobar ordinava la
morte ottenendola in poche ore. Per tacere di noi, delle nostre vittime delle
mafie. Il programma «Falcone-Borsellino» è una misura di diplomazia giuridica –
forse la definizione che inquadra anche la filosofia e l’operato del ministro
Cartabia – per aiutare nazioni sudamericane e caraibiche ad aggrapparsi alla
legge e alla tenacia degli uomini e le donne di legge. Consentendo
l’aggiornamento dell’elenco degli estradati, che di caso in caso, in settimana
in settimana, ha finora inglobato Walter Morici (dall’Ucraina, per
truffa), Graciela Cendy Rodriguez Gonzalez (Uruguay, droga), Amancio
Melgarejo (Perù, associazione a delinquere), Silvio Galizia (Capo Verde,
violenza sessuale su minore), Veaceslav Banu (Russia, estorsione)… Ogni sei
giorni, in media, un ex latitante arrestato all’estero viene riportato in
Italia. Nell’elenco, mancano gli ultimi brigatisti trincerati in Francia: alla
lunga, con questo ritmo, toccherà inesorabilmente anche a loro.
·
Il 41 bis ed il 4 bis.
L'anomala
condotta della Corte. Ergastolo ostativo tra sviste e omissioni: lo strano caso
della Corte Costituzionale.
Salvatore Curreri su
Il Riformista il 13 Novembre 2022.
Per quanto
prevedibile e prevista, l’ordinanza – anticipata con comunicato stampa – con cui
la Corte costituzionale ha deciso di non decidere sul cosiddetto ergastolo
ostativo, rinviando gli atti alla Cassazione penale che aveva sollevato la
questione d’incostituzionalità, desta talune perplessità sotto il profilo
giuridico e, soprattutto, lascia l’amaro in bocca a chi ancora riesce a scorgere
dietro l’apparente astrattezza delle questioni giuridiche la vita di persone che
oggi subiscono un trattamento penitenziario illegittimo epperò ancora una volta
prorogato.
Illegittimo perché
così la Corte costituzionale (ordinanza n. 97/2021), e ancora prima la Corte
europea dei diritti dell’uomo (13.6.2019 Viola c. Italia n. 2 confermata dalla
Grande Camera, 8.10.2019), ha giudicato il divieto assoluto per i condannati
all’ergastolo per reati di particolare allarme sociale (tra
cui mafia e terrorismo) che non hanno collaborato con la giustizia di potere
accedere dopo ventisei anni di pena alla libertà condizionale, al pari degli
altri condannati. Il “fine pena mai” per costoro costituisce, infatti, un
trattamento inumano e degradante in contrasto con la finalità rieducativa della
pena. Non perché si voglia sminuire o rendere irrilevante il significato della
collaborazione (in questo – e solo in questo – può giustificarsi il richiamo
alla memoria di Giovanni Falcone) ma perché è irragionevole ritenere questa
l’unica condizione per accedere ai benefici penitenziari, escludendo coloro che
– ripetiamo: dopo ventisei anni – hanno dato piena prova di essersi allontanati
dal sodalizio mafioso e di fattiva partecipazione al percorso rieducativo.
Se, infatti il
legislatore può legittimamente premiare chi collabora con la giustizia, di
contro non può sanzionare chi non lo fa, presumendo in modo assoluto e senza
prova contraria che la scelta di non collaborare implichi la perdurante
collaborazione con l’organizzazione criminale d’appartenenza. Come la scelta di
collaborare con la giustizia non implica di per sé “un vero pentimento” e
la “decisione di tagliare ogni legame con le associazioni per
delinquere”, potendo essere dettata da ragioni utilitaristiche di convenienza,
così la scelta di non collaborare non equivale ad una presunzione assoluta di
pericolosità sociale, per assenza di ravvedimento o persistenza di contatti con
le organizzazioni criminali, ma può essere dettata da ragioni diverse che
rendono tale rifiuto non libero (ad esempio, per l’integrale accertamento dei
fatti, la limitata partecipazione al reato o il timore di ritorsioni contro i
propri cari). Occorre dunque distinguere tra chi oggettivamente può, ma per
scelta soggettiva non vuole collaborare (Cass., I pen. 41329/2022) e chi
soggettivamente vuole ma oggettivamente suo malgrado non può collaborare (Cass.,
V pen. 36887/2020) perché come ci si può ravvedere anche senza collaborare, così
si può tacere senza per questo essere omertosi.
Sulla base di queste
premesse, la Corte costituzionale l’anno scorso ritenne in contrasto con la
finalità rieducativa della pena non l’ergastolo ostativo in sé ma l’automatica
esclusione dalla libertà condizionale degli ergastolani non collaboranti.
Trattandosi però di una condizione di estinzione della pena, e non di sua
semplice sospensione (come nel caso dell’esclusione di costoro dai permessi
premio, dichiarata incostituzionale: sentenza n. 253/2019), la Corte allora
decise – per esigenze di collaborazione istituzionale – di rimettere al
legislatore il compito di ridefinire la materia dapprima entro il 15 maggio 2022
(ordinanza n. 97 dell’11 maggio 2021) e poi entro l’8 novembre 2022 (ord.
122/2022), concedendo inusualmente un’ulteriore proroga in considerazione del
testo legislativo approvato dalla Camera lo scorso 31 marzo.
Nonostante i 18 mesi
trascorsi, le Camere, come al solito, non sono riuscite ad approvare la riforma
per cui, in vista della predetta scadenza, è dovuto intervenire il Governo con
il decreto legge n. 162/2022 approvato lo scorso 31 ottobre che riprende in
massima (ma non totale) parte il testo approvato dalla Camera il 31 maggio
2022 con il consenso di Pd, M5s, Forza Italia e Lega. In realtà il vero
obiettivo di Fratelli d’Italia è modificare l’art. 27 della Costituzione per
abrogare di fatto la finalità rieducativa della pena e vietare agli ergastolani
ogni beneficio penitenziario. Ma poiché, come candidamente ammesso dalla
presidente del Consiglio, tale obiettivo è al momento impossibile, si è
preferito riproporre il testo approvato dalla Camera. Com’è stato scritto su
queste colonne, con chiarezza d’argomenti e vis comunicativa, dal
collega Pugiotto, si tratta di un testo che solo apparentemente accoglie quel
bilanciamento auspicato dalla Corte tra i diritti dell’ergastolano e le esigenze
di contrasto del fenomeno mafioso.
In realtà, esso
introduce tutta una serie di condizioni e di limiti che rendono di fatto
impraticabile l’accesso alla libertà condizionale agli ergastolani non
collaboranti: si aumentano i reati ostativi, includendo i principali contro la
pubblica amministrazione nonché i casi di pene concorrenti inflitte per delitti
diversi se commessi per lo stesso fine (ecco il peggioramento rispetto al testo
approvato dalla Camera); si aumentano, rispetto agli ergastolani collaboranti
gli anni di carcere (da 26 a 30) da scontare prima di poter chiedere l’accesso
alla libertà condizionata, il cui periodo viene a sua volta prolungato da 5 a 10
anni; si obbliga il richiedente a provare l’assenza di collegamenti con la
criminalità organizzata non solo attuali ma futuri (una vera e propria probatio
diabolica); si abrogano i casi, oggi previsti, di collaborazione impossibile
(perché fatti e relative responsabilità erano stati integralmente accertati)
oppure inesigibile perché oggettivamente marginale e irrilevante.
Di fronte ad
un decreto legge che formalmente dà seguito alla sentenza della Corte ma ne
rinnega di fatto le indicazioni, potevano i giudici costituzionali decidere
altrimenti? Per quanto sia ormai inutile chiederselo (e non solo perché la
decisione è stata già presa…), ci sono tre elementi critici da evidenziare. In
primo luogo, sotto un profilo strettamente giuridico la Corte ha rinviato la
questione sulla base di disposizioni contenute in un decreto legge in fase di
conversione e che quindi può essere modificato o, per quanto sia politicamente
improbabile, addirittura respinto. Prudenza avrebbe voluto quindi che la Corte
avesse ulteriormente rinviato la questione di qualche settimana, così da avere
certezza dell’approvazione del provvedimento. Evidentemente, invece, la Corte
ritiene certa la conversione del decreto legge. Ma questa è una previsione
politica, che un giudice che si basa sul diritto vigente (in questo caso
provvisorio) non dovrebbe consentirsi.
In secondo luogo, la
Corte si è trovata per la prima a giudicare su un decreto legge in fase di
conversione il cui contenuto è manifestamente eterogeneo perché contiene misure
urgenti, oltreché sull’ergastolo ostativo, anche per il rinvio della riforma del
processo penale, di contrasto dei cosiddetti rave party e di riammissione di
medici e infermieri no-vax. Insomma siamo dinanzi a uno di quei decreti legge
omnibus che la Corte ha diverse volte giudicato incostituzionali a causa di
disposizioni presenti nel testo del tutto estranee o incoerenti rispetto al suo
oggetto, contenuto, finalità o ratio dominante. La Corte ha affrontato tale
profilo d’incostituzionalità o l’ha volutamente omesso ai fini del proprio
giudizio?
Infine, in terzo
luogo, la Corte dovrebbe prendere finalmente atto che, per quanto ispirate al
principio di leale collaborazione, le proprie sentenze monito e da ultimo, le
ordinanze con cui, anziché – come dovrebbe per Costituzione – dichiarare
incostituzionale una disposizione, fissa un termine entro cui il legislatore
deve rimediare, continuano a non trovare seguito. Così è stato per la pena
carceraria (ai giornalisti) in caso di diffamazione (132/2020-150/2021), per
l’aiuto al suicidio (207/2018-242/2019) ed ora per la revisione dell’ergastolo
ostativo. Evidentemente una fiducia mal riposta nelle capacità decisionali del
legislatore, il quale, ciò nonostante, gode ora di un’ulteriore apertura di
credito ai fini non tanto della approvazione della nuova normativa quanto
dell’effettivo recepimento delle indicazioni della Corte.
Si obietterà: verrà
comunque il giorno in cui la Corte avrà modo di pronunciarsi sulla nuova
normativa e, se del caso, dichiararla illegittima. A parte che ciò significa
implicitamente ammettere l’inutilità di tale rinvio, dato che sicuramente di
fronte a un peggioramento della normativa, la Cassazione non potrà che ribadire
l’eccezione d’incostituzionalità a suo tempo sollevata, peccato che in questa
vicenda il fattore tempo non è irrilevante perché, come detto all’inizio, ci
sono ergastolani, a cominciare da chi ha sollevato la questione di
costituzionalità, che stanno patendo uno stato detentivo che la stessa Corte ha
già riconosciuto illegittimo. Forse è da qui che si dovrebbe partire, dalla
storia di Domenico Papalia in carcere da 44 anni, per contrastare la narrazione
degli ergastolani che devono marcire in carcere. Perché, come scrisse Foster
Wallace, noi crediamo di sapere tutto sui diritti umani e sulla dignità umana e
quanto sia terribile privare qualcuno della propria umanità ma solo se succede a
qualcuno che conosci, allora sì che lo sai per davvero. Salvatore Curreri
Ergastolo
ostativo, la Consulta se ne lava le mani: atti in Cassazione.
La Corte
Costituzionale decide ancora di non decidere. Sarà la Cassazione a valutare il
decreto Meloni: «Le nuove disposizioni incidono direttamente sulle norme oggetto
di giudizio». Valentina Stella su Il Dubbio l’8 novembre 2022.
Chissà cosa avranno
pensato gli ergastolani ostativi quando per l’ennesima volta hanno visto
la Corte costituzionale non prendere una decisione di merito sul fine pena
mai. Forse il loro pensiero non è mai entrato in gioco in questa partita, tranne
che per il consigliere di Cassazione Giuseppe Santalucia, che sollevò ormai anni
fa il dubbio di legittimità costituzionale, dicendo che il diritto alla speranza
non andrebbe negato a nessuno. E incredibilmente ora la palla torna proprio a
lui, perché la Consulta ha deciso di restituire gli atti a Piazza Cavour.
«Dopo due rinvii
disposti per concedere al legislatore il tempo necessario al fine di intervenire
sulla materia (ordinanze n. 97 del 2021 e n. 122 del 2022), la Corte
costituzionale ha nuovamente esaminato oggi (ieri, per chi legge, ndr), in
camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla
Corte di Cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo. Oggetto
di scrutinio sono le disposizioni che non consentono al condannato all’ergastolo
per delitti di contesto mafioso, che non abbia utilmente collaborato con la
giustizia, di essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale, pur
dopo aver scontato la quota di pena prevista e pur risultando elementi
sintomatici del suo ravvedimento».
In attesa del
deposito dell’ordinanza, la Consulta ha fatto sapere di aver «deciso di
restituire gli atti al giudice a quo, a seguito dell’entrata in vigore del
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che contiene, fra l’altro, misure urgenti
nella materia in esame». Il motivo? «Le nuove disposizioni – si legge in una
nota della Corte – incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto
del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa
la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici e delle
misure alternative a favore di tutti i condannati (anche all’ergastolo) per
reati cosiddetti “ostativi”, che non hanno collaborato con la giustizia. Costoro
sono ora ammessi a chiedere i benefici, sebbene in presenza di nuove, stringenti
e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in
rilievo». Pertanto gli atti vengono «restituiti alla Cassazione, cui spetta
verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle
questioni sollevate, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non
manifesta infondatezza».
Qual è lo scenario
futuro? Tra due o tre mesi la Cassazione potrà esprimersi. In quel momento il
decreto legge sarà stato convertito dal Parlamento e quindi Santalucia potrà
esprimersi direttamente su quella legge definitiva. Lì ci sarà un bivio: per
l’ermellino la legge di conversione, pur ponendo paletti stringenti, permette in
teoria all’ergastolano ostativo non collaborante di poter richiedere l’accesso
alla liberazione condizionale. Oppure il giudice risolleva il dubbio dinanzi
alla Corte costituzionale che ne valuterà la conformità a Costituzione.
Ergastolo ostativo,
la Consulta non decide. Ecco le reazioni
L’avvocato Giovanna
Araniti, legale di Salvatore Pezzino, in carcere dal 1984 e dal cui ricorso
tutto è iniziato, così commenta: «Prendo atto della decisione della Consulta e
mi auguro che la Corte di Cassazione valuti oculatamente, come ha già fatto, la
nuova normativa e risollevi la questione dinanzi ai giudici costituzionali». Per
l’avvocato Michele Passione, assiduo frequentatore della Consulta, «in attesa di
leggere l’ordinanza, dispiace che la Corte abbia deciso di restituire gli atti
al giudice a quo e non attendere la conversione in legge del decreto del
Governo. Sarebbe stata una decisione non soddisfacente rispetto alle richieste
della parte privata ma certamente avrebbe evitato il gioco dell’oca che questa
soluzione comporta. Vedremo cosa succederà, intanto tutti gli ergastolani che
attendevano una risposta chiara ricominciano ora con una attesa infinita verso
una nuova decisione».
Dunque la Corte ha
accolto la richiesta dell’Avvocatura dello Stato rappresentata da Ettore
Figliolia: «Credo che il legislatore governativo sia stato pedissequo con quanto
richiesto dall’ordinanza della Consulta» con la sua ordinanza del 2021, aveva
detto ieri mattina. Pertanto il nuovo decreto legge, secondo il legale, è da
ritenersi «legittimo». Secondo l’Avvocatura dello Stato c’erano dunque i
presupposti per la remissione degli atti del procedimento alla Corte di
Cassazione, che aveva sollevato la questione davanti alla Consulta. Quest’ultima
ha accolto questa richiesta, senza però entrare formalmente nel merito del
decreto legge.
Si era espressa
diversamente Araniti, che aveva chiesto alla Corte di dichiarare
incostituzionale il decreto legge del Governo Meloni perché vigente. Esso
rappresenta, aveva detto, la «morte del diritto alla speranza, spero invece che
la Corte emetta una sentenza di illegittimità costituzionale che rappresenti il
germoglio di un nuovo umanesimo. Il principio della riabilitazione della pena
deve valere per tutti». Aveva proseguito: «Ci troviamo dopo 18 mesi senza una
legge approvata dal Parlamento ma con un decreto, proposto alle Camere come
antidoto». Ma quel decreto, a parere della legale, non ha «i presupposti per la
decretazione d’urgenza».
Sulla decisione
della Consulta i dirigenti di Nessuno tocchi Caino Rita Bernardini, Sergio
d’Elia ed Elisabetta Zamparutti hanno dichiarato: «Una scelta pilatesca quella
della Corte costituzionale, che aveva a suo tempo accertato la
incostituzionalità dell’articolo 4bis ma non l’ha mai dichiarata. Sicuramente la
Corte se ne è lavata le mani. Ci chiediamo dove sia finita la sua alta funzione,
che è quella di valutare le leggi. La Corte ha fatto il passacarte: prima al
Parlamento con ben due rinvii – il primo di un anno e il secondo,
particolarmente grave, di altri sei mesi – e poi alla Cassazione a cui ha, come
ha chiesto il Governo, restituito gli atti per una valutazione del decreto».
L'udienza della
Corte Costituzionale. Così la destra ha salvato l’ergastolo (e la Consulta).
Andrea Pugiotto su Il Riformista l’8 Novembre 2022
1. Il lapsus mente
raramente. La dice lunga, quindi, quel «carcere ostativo» (invece di «ergastolo
ostativo») pronunciato alla Camera dalla presidente Meloni in replica al
dibattito sulla fiducia al governo. Traducibile nell’hastag #iorestoincarcere,
svela l’intima adesione a una teologia della dannazione perenne («fine pena
mai», «deve marcire in galera», «buttare via la chiave») che è l’esatto
contrario del riscatto rieducativo iscritto in Costituzione. Non a caso, è stata
già depositata da Fratelli d’Italia la proposta di legge costituzionale per la
modifica dell’art. 27 Cost. (AC 116). Leggetela. Vi si afferma «la netta volontà
di subordinare e limitare la finalità rieducativa della pena» a favore delle
esigenze di difesa sociale, così da sdoganare «la possibilità, per il giudice,
di irrogare pene esemplari».
È in questo
orizzonte che si inserisce il decreto legge n. 162, in vigore dal 31 ottobre,
contenente «misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici
penitenziari» in assenza di condotte collaboranti. Diverso era il titolo del
testo unificato, approvato alla Camera nella scorsa legislatura e ora travasato
nel provvedimento del governo: «Disposizioni in materia di accesso ai benefici
penitenziari» per i non collaboranti (AS 2574). «Accesso», non «divieto». Torno
a dire: il lapsus mente raramente.
2. Sbobiniamo quanto
è accaduto. L’ergastolo ostativo è certamente illegittimo, laddove individua nel
collaborare con la giustizia l’unica via possibile per accedere alla liberazione
condizionale. Nell’accertarlo, la Consulta ha sollecitato il Parlamento a
ridisciplinare l’istituto in conformità alla Costituzione, concedendogli un
tempo congruo per farlo. Nella scorsa legislatura la Camera aveva approvato una
riforma, il cui iter legislativo non si è concluso in Senato «solo a causa dello
scioglimento [anticipato] delle camere». Nel frattempo incombeva la data odierna
dell’8 novembre, fissata dalla Consulta per adottare la propria decisione in
assenza di un intervento legislativo. Ecco perché solo un provvedimento del
Governo, di cui «è indubbia la ricorrenza dei presupposti di necessità e
urgenza», poteva consentire di adempiere in tempo ai moniti della Corte
costituzionale.
Questa è la
narrazione accreditata nella relazione illustrativa e nel preambolo del decreto
legge. Evidentemente persuasiva per il Quirinale, che lo ha firmato senza
rilievi di sorta, nemmeno nella forma soft dell’emanazione con dissenso (secondo
una prassi introdotta dal suo predecessore, Giorgio Napolitano). Eppure i
decreti legge si giustificano solo a fronte di «casi straordinari» (art. 77,
comma 2, Cost.), cioè imprevedibili, e tale non può certo considerarsi
un’udienza iniziata 18 mesi fa e calendarizzata da tempo. A Palazzo della
Consulta ne saranno certamente sollevati. Lo jus superveniens giustificherà la
restituzione degli atti al giudice che aveva eccepito l’incostituzionalità
dell’ergastolo ostativo (la Cassazione, sez. I penale): ad esso spetterà
verificare la rilevanza processuale della nuova disciplina e le sue eventuali
criticità costituzionali, anche alla luce delle possibili modifiche inserite in
sede di conversione. Se e quando verrà riproposta la quaestio, solo allora la
Consulta giudicherà la conformità a Costituzione delle norme effettivamente
introdotte dal legislatore. Oggi, i giudici costituzionali potranno cavarsela
con una nuova ordinanza interlocutoria, dopo le due precedenti con le quali ogni
decisione era stata rinviata allo scopo di rimettere in termini il Parlamento.
Messe in fila, esse rivelano un qualche timoroso imbarazzo nel rispondere a
un’ovvia domanda: quando dichiarerete l’incostituzionalità di un regime che pure
ritenete incostituzionale? «Non ora» (ord. n. 97/2021); «non ancora» (ord. n.
211/2022), «chissà» (ordinanza odierna).
Alle camere è certa
la conversione del decreto legge, ricalcante un testo approvato quasi
all’unanimità nella scorsa legislatura. Nessun gruppo parlamentare potrà
credibilmente sottrarsi al mantra, ripetuto come un atto di fede, secondo cui
l’ergastolo fino alla morte è uno strumento irrinunciabile nel contrasto alle
mafie: in ciò, davvero, l’unione fa la forca (e questo non è un lapsus).
Fratelli d’Italia, all’epoca contrari alla riforma perché scaturita da
«gargarismi garantistici» (così l’on. Delmastro Delle Vedove, oggi
neo-sottosegretario alla Giustizia), potranno sempre tentare di emendarla in
peius, innestando altre norme nella già sadica articolazione numerica del
nuovo art. 4-bis ord. penit., con i suoi commi 1-bis, 1-bis.1, 1-bis.2. Le norme
bis sono, da sempre, la maschera di obbrobri giuridici.
3. Dunque,
l’ergastolo ostativo è stato riformato. Eppure la premier rivendica, «fiera», di
averlo conservato. La contraddizione si scioglie nel gioco tra apparenza e
sostanza normativa.
Il decreto legge,
infatti, ammette la possibilità anche per gli ergastolani non collaboranti di
dimostrare l’assenza di legami con il crimine organizzato, ai fini
dell’ammissione alla liberazione condizionale. In tal modo, l’originario
manicheismo secondo cui «o collabori e ti mettiamo fuori, o stai dentro finché
campi» viene meno, e con esso ogni illegittimo automatismo legislativo. È stato
così rimosso il cellophane della presunzione assoluta che avvolgeva l’ergastolo
ostativo, ora imballato con una presunzione relativa, suscettibile di prova
contraria, valutata dal giudice caso per caso. Tanto basta per dire – come ha
fatto il distratto Guardasigilli – che le criticità costituzionali segnalate
dalla Consulta sono state superate. Ciò è vero, ma solo formalmente. In realtà,
il contenuto del decreto legge configura una stretta alla concessione di
qualsiasi beneficio penitenziario, tale da renderla concretamente irrealistica.
Vale specialmente per la liberazione condizionale, modificata anche nella sua
disciplina sostanziale. Così però l’ergastolo ostativo, intollerabile a parole,
risulta tollerabilissimo nella realtà. È superato de jure, ma non de facto.
4. Un primo giro di
vite è nell’incremento dei reati ostativi. L’ostica formula tecnica che apre
il decreto legge (il divieto di sciogliere il cumulo di pene concorrenti, in
caso di accertata connessione teleologica tra reati) produrrà l’effetto di
trascinare nel regime penitenziario ostativo delitti altrimenti comuni. Prosegue
così la malsana abitudine di ampliare la già lunga blacklist dell’art.
4-bis. L’effettività rinnegante della nuova normativa emerge, poi, nell’abnorme
facondia di condizioni da soddisfare per accedere a qualsiasi misura
extramuraria. Non sono sufficienti, infatti, le risultanze positive del percorso
trattamentale. Né gli ulteriori elementi che comunque il giudice dovrà
considerare: dalle circostanze personali e ambientali alle ragioni dedotte a
sostegno della mancata collaborazione, dalla revisione critica della propria
condotta criminosa alle iniziative a favore delle vittime, fino a ogni altra
informazione disponibile. Serve altro. È necessario dimostrare l’adempimento
delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna (o «l’assoluta
impossibilità» di adempiervi).
È necessario
dimostrare l’assenza di collegamenti attuali, «anche indiretti o tramite terzi»,
con la criminalità organizzata e con «il contesto» (?) nel quale il reato è
stato commesso. È necessario allegare elementi specifici che escludano il
pericolo di un futuro «ripristino» di tali collegamenti (autentica probatio
diabolica). Contestualmente, vanno disposti accertamenti patrimoniali nei
confronti del reo e del suo nucleo familiare. Siamo di fronte a un perenne “non
basta”, introdotto intenzionalmente per rendere difficili cose complicate
attraverso richieste impossibili, tanto più se rivolte a ergastolani ristretti
in carcere da decenni. Che il decreto legge sia orientato a ostacolare il loro
diritto alla speranza emerge anche dalla nuova configurazione della liberazione
condizionale. La sua concessione slitta sempre più nel futuro, con l’estensione
a 30 anni (contro i 26 attuali) del termine per accedervi e a 10 anni (contro i
5 attuali) della durata della successiva libertà vigilata. È peggio che prima
della legge Gozzini. Così, per l’ergastolano non collaborante, il tempo della
detenzione si dilata fino a togliere il respiro, obbligandolo ad un’apnea
esistenziale prossima a renderlo postumo in vita.
E ancora. Il decreto
legge abroga i casi di collaborazione impossibile o irrilevante, assorbiti nella
più generica ipotesi di «assenza di collaborazione con la giustizia» all’interno
della kafkiana procedura di accesso ai benefici penitenziari già descritta.
Viene così sbarrato il solo ponte verso misure extramurarie fino ad oggi
transitabile da tutti i condannati per reati ostativi, ergastolani compresi,
quando veniva accertata una loro inesigibile collaborazione. Scelta doppiamente
irragionevole. Perché non si può chiedere di fare ciò che è impossibile fare,
come accade se la collaborazione non è «naturalisticamente e giuridicamente»
esigibile (sent. n. 89/1989). Perché non sono assimilabili le posizioni di chi è
silente “per scelta” e di chi lo è “suo malgrado” (avendo poco o nulla da
riferire per la limitata partecipazione al reato o per l’integrale accertamento
di fatti e responsabilità o perché vittima di errore giudiziario): lo ha
ribadito la Consulta con una recente sentenza (n. 20/2022) che il provvedimento
governativo ignora o finge di ignorare. Questa, nell’essenziale, è la pista da
cui dovrebbe decollare, verso il rientro in società, l’ergastolano ostativo che
abbia dato prova di «sicuro ravvedimento» (art. 176 c.p.). Cadrà nel vuoto, come
un aeroplanino di carta.
5. Alla fine – come
denuncia, non a torto, l’UCPI – l’operazione gattopardesca messa in piedi si
rivela un «espediente solo formale» per accreditare l’attuazione dei moniti
della Consulta, in realtà aggirati con «un vero e proprio atto di ribellione»
normativa. Vedremo, oggi, se e come la Corte costituzionale troverà il modo di
replicare. Andrea Pugiotto
Anche Woodcock
stronca l’ostativo: «È una tortura. Si pretende la delazione».
Il pm napoletano
scrive a Travaglio. E punta il dito contro chi tira in ballo a sproposito
Falcone: «Culturalmente e ideologicamente lontano da alcune delle più che
rispettabili posizioni che capita di leggere sui giornali». Simona Musco Il
Dubbio il 9 novembre 2022.
Ergastolo ostativo
uguale tortura. A ribadirlo, in una lettera inviata al Fatto Quotidiano, è il
magistrato napoletano Henry John Woodcock, che smonta la bufala del “fuori tutti
i mafiosi” che ha tenuto banco nella discussione sull’articolo 4 bis dopo la
pronuncia della Corte costituzionale di oltre un anno fa. Una bufala che si basa
su alcune convinzioni: che la collaborazione con la giustizia sia l’unica prova
di una recisione dei legami con il contesto criminale d’appartenenza da parte di
detenuti che hanno passato in carcere 26 anni della loro vita (termine che sale
a 30 anni con il decreto legge licenziato dal governo Meloni) e che pensare una
disciplina diversa, rispettosa della Costituzione, equivalga a infangare la
memoria di Giovanni Falcone, tirato in ballo ogni volta che c’è da affrontare
l’argomento per far sentire dalla parte sbagliata chi solleva qualche dubbio.
Woodcock – che di
certo non può essere accusato di essere “amico dei mafiosi”, come spesso viene
tacciato chi osa criticare l’ergastolo ostativo – mette in fila gli argomenti
criticando anche la pronuncia della Consulta. Non solo per la decisione di
rinviare al legislatore la scelta su come adeguarsi alla cornice costituzionale
violata da tale norma, ma anche per il suggerimento fornito allo stesso, che, di
fatto, rende quasi impossibile poter ottenere i benefici previsti dalla legge.
Il punto di partenza è che la collaborazione con la giustizia, lungi dall’essere
un percorso di vera rivisitazione critica delle proprie scelte, finisce con il
diventare un’opzione, una scelta di comodo, insomma, per dirla con Woodcock, una
«”scelta” imposta». Una volta scardinato l’automatismo che prevedeva la
concessione di benefici solo in caso di collaborazione e ribadito «il
fondamentale principio della polifunzionalità della pena e in particolare la
funzione rieducativa della pena stessa», la Corte costituzionale ha “suggerito”
al legislatore delle opzioni, tra le quali ancorare l’autorizzazione all’accesso
ai benefici all’accertamento di «specifiche ragioni della mancata
collaborazione».
Ed è qui che il
magistrato napoletano cita Falcone, tentando di smentire chi attribuisce a lui
quell’automatismo e quella inflessibilità bocciati dalla Corte: «Invero –
afferma – ho solo avuto, per ragioni anagrafiche, la possibilità di ascoltare e
di leggere nei media alcuni interventi di Giovanni Falcone, acuto e tenace
investigatore, unico e “moderno”, e mi è parso in tutta franchezza culturalmente
e ideologicamente lontano da alcune delle più che rispettabili posizioni che
capita in questi giorni di leggere sui giornali». L’idea di fondo, stando alla
discussione interna alla politica e parte dell’opinione pubblica, è infatti che
la pronuncia della Consulta renda meno efficace il contrasto alle mafie,
tradendo, in qualche modo, l’insegnamento di chi, come il magistrato siciliano,
ha pagato con la propria vita la lotta alla criminalità organizzata.
Ma fu proprio
Falcone – come più volte ricordato da Damiano Aliprandi dalle colonne di questo
giornale – il primo ad essere consapevole che l’ergastolo senza condizionale
sarebbe stato incostituzionale: con il primo decreto legge del 13 maggio 1991,
il numero 152, Falcone, all’epoca direttore generale degli Affari penali del
ministero di Grazia e Giustizia, non aveva infatti escluso la possibilità dei
benefici in assenza di collaborazione, bensì aveva allungato i termini per
ottenerla. E fu solo dopo la sua morte, dunque, che venne introdotto
quell’automatismo oggi considerato incostituzionale dal giudice della legge. Un
discorso che Woodcock, contrariamente ad altri, sembra ricordare bene,
nonostante la “durezza” sempre dimostrata dalla toga – spesso criticata anche da
questo quotidiano – nella gestione delle sue inchieste.
Ma il pm napoletano
va oltre, parlando non di collaborazione, bensì di «delazione»: l’ergastolo
ostativo, afferma, in realtà «vuole punire chi non “si pente”» o, peggio ancora,
rappresenta «una sorta di tortura intesa a favorire la “collaborazione” e ciò
perché per “pentimento” nella nostra prassi giudiziaria non si intende affatto
quel travaglio morale che porta a una revisione critica del proprio passato, e
di conseguenza a un autentico ravvedimento con la conseguente decisione di
cambiare vita. No, significa solo confessione e, soprattutto, delazione.
Insomma, proprio la finalità della tortura». Pensare che la discussione possa
esaurirsi attorno alla conta dei mafiosi che possono uscire dal carcere è una
visione semplicistica, secondo Woodcock, in quanto la vera questione è stabilire
se la collaborazione sia l’unico modo per accedere ai benefici, in tal modo
stabilendo «una coincidenza esclusiva e una assoluta sovrapponibilità tra il
percorso “rieducativo” cui fa riferimento l’articolo 27 della Costituzione e la
delazione». Un binomio «aberrante» e in contrasto con la Carta, «che va
applicata sempre e comunque e non una volta sì e una volta no», ricorda ai
teorici della “Costituzione più bella del mondo” a giorni alterni.
Cosa valorizzare,
dunque, per superare il contrasto? La risposta del magistrato è semplice: il
tempo trascorso in espiazione della pena. «Il trascorrere del tempo modifica
qualsiasi cosa – sottolinea -; in oltre un quarto di secolo tutto cambia (o
comunque non può a priori escludersi che tutto cambi), dalla natura e dal
vissuto del condannato, fino alle dinamiche e agli equilibri criminali». Certo,
al tempo che passa occorre che si associ anche un percorso di ravvedimento e di
autentica dissociazione dal contesto criminale di origine, «ma un tale percorso
non ha nulla a che vedere con la “delazione” che spesso, si diceva, è
sintomatica di tutto, tranne che di un autentico ravvedimento». Basti pensare,
su tutti, al caso del falso pentito Vincenzo Scarantino, che ha fatto arrestare
e condannare molti innocenti, accusati di aver eseguito la strage di via
D’Amelio. Ma l’idea di Woodcock non piace a Marco Travaglio, la cui replica è
piccatissima: «Solo i criminali chiamano “delazione” il dire la verità». Sempre
che di verità si tratti.
Ergastolo
ostativo, i docenti di diritto: «Il decreto peggiora le cose».
Oggi la
pronuncia della Consulta, che potrebbe rinviare ancora la propria decisione, in
attesa della conversione in legge del provvedimento governativo. Valentina
Stella su Il Dubbio il 9 novembre 2022.
Oggi la Corte
costituzionale si riunirà nuovamente per discutere di ergastolo ostativo. Lo
farà a otto giorni dal varo di un decreto legge con cui il governo Meloni ha
affrontato pure questa materia. Da quanto appreso, l’Avvocatura dello Stato non
ha presentato memorie, ma ha allegato agli atti il testo del decreto con una
nota di Palazzo Chigi in cui si lascia intendere che il provvedimento si sarebbe
adeguato alle indicazioni della Consulta.
Secondo il
professor Marco Pelissero, presidente dell’Associazione italiana di professori
di Diritto penale, «la soluzione più lineare è quella secondo cui la Corte
domani (oggi per chi legge, ndr) rinvii per la terza volta, in attesa che il Dl
venga convertito. È vero che al momento è vigente, ma il testo potrebbe essere
emendato dal Parlamento». Quindi, in un contesto connotato da assenza di
procedura specifica, lo scenario che ipotizza l’ordinario di Diritto
penale all’Università di Torino è che «la Corte si aggiorni in modo da riunirsi
di nuovo al termine dei 60 giorni previsti per la conversione, quindi
probabilmente a inizio gennaio. A quel punto, se la riterrà contrastante con i
principi in precedenza affermati, potrebbe dichiarare incostituzionale la nuova
disciplina, sulla quale il giudizio di legittimità costituzionale si
trasferirebbe; oppure, qualora ritenesse la nuova disciplina rispettosa dei
principi a suo tempo fissati, dovrebbe rinviare gli atti al giudice rimettente,
ossia la Cassazione, affinché applichi la nuova disciplina al caso concreto».
E se il decreto-
legge non fosse convertito in legge dal Parlamento? «Ritengo questa ipotesi
molto improbabile considerata la maggioranza che sostiene questo Governo.
Comunque qualora non dovesse essere convertito, la Consulta sarebbe chiamata a
pronunciarsi sulla disciplina originaria ( ossia quella vigente prima
dell’entrata in vigore del decreto- legge) della quale aveva già evidenziato i
profili di illegittimità costituzionale, dichiarandone definitivamente
l’incostituzionalità, nei termini che la Corte indicherà».
Intanto il Consiglio
direttivo dell’Associazione presieduta da Pelissero ha pubblicato un durissimo
documento contro il decreto legge del 31 ottobre su norma anti rave, rinvio
della riforma Cartabia ed ergastolo ostativo, appunto. Su quest’ultimo punto i
giuristi ritengono che «una serie di profili critici» «inaspriscono la
disciplina dei c. d. reati ostativi in termini che vanno ben al di là delle
indicazioni che erano state date dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n.
97/ 2021».
In particolare, «da
parte dei detenuti o internati per uno dei reati ostativi, l’oggetto
dell’allegazione si traduce in una sorta di probatio diabolica, in quanto
diventa difficile, se non impossibile, addurre “elementi specifici” “che
consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è
stato commesso nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche
indiretti o tramite terzi”».
A questo si aggiunge
il fatto che «non convince il passaggio da ventisei a trent’anni di pena
scontata affinché i condannati alla pena dell’ergastolo possano accedere alla
liberazione condizionale: il legislatore fa un passo indietro» «anche rispetto
all’originaria disciplina, introdotta con l. 25 novembre 1962, n. 1634, che
aveva stabilito che l’ergastolano potesse essere ammesso alla liberazione
condizionale dopo aver scontato ventotto anni di pena». Inoltre «la nuova
disciplina accentua, in termini manifestamente irragionevoli, la disparità di
trattamento tra detenuto collaborante e non collaborante» ; «appare altresì
irragionevole l’estensione da cinque a dieci anni della durata della libertà
vigilata» ; «risulta parimenti ingiustificata l’estensione del novero dei reati
ostativi al di là dei fatti di criminalità organizzata, comune e terroristica».
Insomma una
stroncatura netta da parte degli esperti. Che non ci vanno leggeri, anzi,
neanche in merito alla norma anti- rave: per i professori di diritto penale la
nuova fattispecie di reato «appare frutto di una tecnica legislativa davvero
approssimativa e lacunosa, e si distingue per indecifrabilità del tipo criminoso
e incontrollabilità della sfera di applicazione». Infatti «rimane imprecisato
come e quando si realizzi un pericolo per l’ordine pubblico, per l’incolumità
pubblica o per la salute pubblica, referenti di valore che risultano
intrinsecamente affetti da irrimediabile vaghezza se non vengono tipizzate le
modalità di offesa».
Per i giuristi «non
si può fare, inoltre, a meno di rilevare come la previsione – quale massimo
edittale della pena – della reclusione fino a sei anni comporti il fatto che,
durante la vigenza del decreto- legge, possano prodursi effetti limitativi e
restrittivi di diritti e libertà individuali che non sono circoscritti alla sola
possibilità di effettuare intercettazioni. E la conseguenza di un evidente
difetto di proporzionalità e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio, cui
si aggiunge l’ingiustificata previsione dell’obbligatorietà della confisca delle
cose indicate nel comma 4».
Ma forse l’aspetto
più grave e non abbastanza evidenziato nel dibattito pubblico è l’ «incongruo
inserimento di questa fattispecie tra le ipotesi di pericolosità specifica di
cui al codice antimafia, legittimando in tal modo persino l’applicazione di
misure di prevenzione personali e patrimoniali. In definitiva, la fattispecie di
cui all’art. 434 bis c. p. pone seri dubbi di legittimità costituzionale e
convenzionale, sotto i diversi profili della determinatezza, della
proporzionalità rispetto al diritto di riunione, e della ragionevolezza/
proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio».
Infine, per quanto
concerne il rinvio dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, che tra
l’altro prevede la riforma di diverse disposizioni del codice di procedura
penale, l’Associazione esprime preoccupazione per il rinvio in blocco
dell’entrata in vigore del decreto legislativo 150/ 2022, in quanto sono state
coinvolte «anche le parti sulla riforma del sistema sanzionatorio penale che,
non oggetto di peculiari criticità rilevate dalla dottrina e dalla prassi,
avrebbe ben potuto entrare in vigore».
La polemica. La guerra dei
Pm contro l’abolizione dell’ergastolo ostativo.
Tiziana Maiolo su Il
Riformista il 26 Gennaio 2022.
I vertici della magistratura
italiana sono in larga parte fuori dalla Costituzione e dallo Stato di diritto,
in guerra esplicita contro l’Alta Corte e le sue sentenze. Le recenti
inaugurazioni dell’Anno giudiziario 2022 sono state veri campi di battaglia.
Alla testa dello squadrone si è messo il procuratore generale della Corte di
Cassazione, quel Giovanni Salvi ormai soprannominato “lo smemorato”, da quando
non ricorda più dove ha messo il telefonino, o anche “il pentito”, dopo che ha
capovolto la propria posizione sull’ergastolo ostativo per allinearsi a presenti
e passati procuratori “antimafia”.
Quello dell’ergastolo
ostativo, uno dei temi più ignorati dalla grande stampa, non è una faccenda
tecnico-giuridica, pane e formaggio per barbosi giuristi o perditempo
“garantisti pelosi”, come dicono i tagliagole, è semplicemente qualcosa che fa
la differenza tra la vita e la morte. Tra la civiltà giuridica dei Paesi
liberali e democratici e la barbarie degli Stati totalitari e vendicativi che
mantengono la pena capitale. In quale contesto sta l’Italia, dal momento che le
decisioni della Corte Costituzionale, oltre che quelle della Corte europea dei
diritti dell’uomo, vengono combattute proprio da chi dovrebbe applicarle? E lo
stesso Parlamento viene minacciato se non obbedirà ai diktat dei
pm “antimafia”? Se qualcuno domandasse al procuratore generale Salvi se è
favorevole alla pena di morte, stiamo certi che risponderebbe sdegnato di no,
come, crediamo, se qualcuno lo avesse accusato di essere a favore della
schiavitù o della tortura. Infatti, pochi mesi fa, in quel mese di marzo 2021 in
cui si era in attesa della decisione della Corte costituzionale sull’ergastolo
ostativo, si era un po’ sbilanciato a dirsi contrario al “fine pena mai”.
Ma era in un ambiente
rilassato, un dibattito culturale un po’ fuori contesto rispetto alla necessità
di indossare elmetto e giubbotto antiproiettile per la “lotta” alla mafia, come
se questa spettasse ai magistrati. L’inaugurazione dell’ anno giudiziario è
altra cosa, e allora si deve mandare un messaggio brutale e dire che il “fine
pena mai” e il “carcere duro” sono utili, perché servono a “impedire che i boss
comandino dal carcere”. Lo squillo di tromba partito da un vertice così
autorevole è indirizzato a due interlocutori altrettanto elevati: la
magistratura e il Parlamento. Si deve decidere chi comanda. La Corte
Costituzionale e il potere legislativo o quello illegittimo del Partito dei Pm?
Bisogna spostarsi da Roma a Palermo per trovare la carta assorbente su cui
depositare il messaggio. In terra di “trattativa” ritroviamo, tra gli orecchi
musicali più sensibili allo squillo guerriero partito dal vertice della
magistratura, un vecchio gruppo di toghe che pare uscito dalla fotografia
ingiallita della “vicenda Scarantino”. La storia di quel falso pentito coltivato
amorevolmente dagli inquirenti siciliani, dopo che era stato torturato nel
carcere speciale di Pianosa, fino a che era riuscito a mandare in galera una
quindicina di innocenti accusando falsamente anche se stesso per l’assassinio
del giudice Paolo Borsellino. Un bell’esempio di “pentito”, cui non sappiamo si
siano ispirati anche il giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario i tre ex
pm che di Scarantino si erano occupati, e che poi hanno fatto belle carriere.
Parliamo di Nino Di Matteo,
Dino Petralia e Anna Maria Palma. Il primo, oggi membro del Csm, ritiene che, se
si mette in discussione il fatto che per accedere ai benefici penitenziari si
debba per forza essere delatori, “si fa il gioco della mafia”, “si attua il
programma di Totò Riina”. Ecco sistemata l’ Alta Corte, che ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, dando al Parlamento un anno di
tempo, che scadrà il prossimo maggio, per attuare le riforme necessarie ad
adeguare le norme emergenziali varate nel 1992 agli articoli
3 e 27 della Costituzione. Di Matteo, pur facendo parte di un organismo di alta
giustizia come il Csm, si ribella ai principi cardine della Legge delle leggi
come ribaditi dall’Alta Corte. Preferisce usare il palcoscenico di Palermo per
invitare la magistratura a proseguire la ricerca “dei mandanti delle stragi del
1992”. Come se la sconfitta nel processo “trattativa” non dovesse ancora
bruciargli sulla guancia. Allineatissima la procuratrice generale facente
funzioni Anna Maria Palma, che chiede in modo esplicito “non si abolisca
l’ergastolo ostativo”. Dino Petralia ha invece dismesso l’abito del
pm “antimafia”(persona diversa dall’omonimo Carmelo, che condusse le indagini
sul falso pentito Scarantino con i colleghi Di Matteo e Palma), indossando a
tutto tondo quello di capo del Dap, cioè di amministratore delle carceri. Vedere
qualche prigione gli è servito, e forse anche la contaminazione con “Nessuno
tocchi Caino”, l’associazione di cui ha anche partecipato al congresso dello
scorso dicembre. Vogliamo trattenere come vera perla la sua seguente
affermazione: “La Costituzione parla di pena e non necessariamente di carcere”.
Lasciamola lì, senza commentarla.
Torniamo invece
all’aggressione violenta che alcuni vertici della magistratura hanno sferrato
contro la Costituzione. Ci sono quelli del passato, la cui opinione è però
sempre autorevole sui quotidiani (non solo sul Fatto), come Giancarlo
Caselli, che fu ai vertici di Magistratura democratica, ma soprattutto
procuratore capo di Palermo. Ed è questa seconda veste che gli è rimasta
appiccicata addosso anche da pensionato. Un altro è Roberto Scarpinato, che ha
lasciato la toga da poco, con una sorta di testamento il cui leitmotif risuona
delle parole di Di Matteo sull’uso dei “pentiti”, il timore che con le riforme
garantistiche e costituzionali diminuiscano i collaboratori di giustizia. Sempre
con l’ossessione dei “mandanti occulti“ delle stragi, cioè di una sorta di
trattativa continua tra la mafia e lo Stato. Neanche la sentenza della Corte
d’appello di Palermo che ha bocciato questa tesi viene rispettata. La verità è
che questo partito dei pm “antimafia” sta giocando una propria partita di potere
anche all’interno della magistratura, con la sponda di alcuni partiti in
Parlamento. Non è un caso che, non appena sentite le parole di Salvi e di Di
Matteo alle inaugurazioni dell’Anno giudiziario, gli esponenti del Movimento
cinque stelle si siano svegliati con un sussulto, proponendo che la riforma del
Parlamento disattenda subito la richiesta della Corte Costituzionale. In molti
modi.
Prima di tutto azzerando le
competenze dei giudici e tribunali di sorveglianza territoriali, gli unici che
conoscono il percorso rieducativo di ogni detenuto, per accentrare le
valutazioni a Roma. E poi scaricando sul singolo prigioniero l’onere di
dimostrare di aver rescisso ogni legame con gli ambienti criminali e affidando
al procuratore nazionale antimafia e al pm che aveva condotto le prime indagini
il compito della decisione finale. Il che significa una cosa sola: inchiodare
ogni detenuto alla fotografia di venti-trent’anni prima, al momento della
commissione del reato. Quindi negarne ogni possibilità di cambiamento (del
resto Caselli l’ha detto chiaro: dalla mafia non si esce mai!) e condannarlo a
morte. Si, morte, morte sociale, stillata goccia a goccia, ogni giorno e ogni
notte. Ma i magistrati non dovrebbero essere obbligati alla fedeltà
costituzionale? E i membri del Parlamento?
Tiziana Maiolo. Politica e
giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e
XIII legislatura.
Caro Travaglio, quella
sentenza sul 41bis andrebbe letta nelle scuole.
Dietro l’attacco di Travaglio
c’è la moltitudine dei giustizialisti che nelle chiacchiere da bar chiedono al
penalista “come fai a difendere un criminale sapendolo tale?”. O peggio, quelli
che minacciano di morte il legale dei cosiddetti “mostri”, le persone accusate
di reato odiosi come stupro e pedofilia. Ebbene, con la sentenza che vieta il
visto di censura nella corrispondenza fra chi è al “carcere duro” e il suo
legale, la Corte costituzionale intona uno straordinario inno alla funzione
suprema della professione forense. Aurora Matteucci su Il Dubbio l'1 febbraio
2022.
Nonostante l’attenzione dei
media sia stata in questi giorni assorbita dall’affaire Quirinale, ha destato
un’ inaspettata attenzione la recente sentenza della Corte costituzionale che ha
censurato l’articolo 41 bis dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui
non garantisce la segretezza delle comunicazione tra assistito e difensore
imponendo il visto di censura della corrispondenza. Inaspettata se non altro
perché i principi che la Corte afferma, ad occhi forse troppo ingenui, possono
apparire tutto sommato scontati. Eppure, mai come oggi, repetita iuvant. Ci sono
voluti diversi anni (venti, per l’esattezza) per affermare l’ovvio. E cioè
che «il visto di censura riflette una generale e insostenibile presunzione di
collusione del difensore dell’imputato, finendo così per gettare una luce di
sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la
tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di
diritto nel suo complesso».
La disciplina che introduce il
visto di censura nella corrispondenza del detenuto in regime di 41 bis è stata
introdotta nel 2002, il 23 dicembre: non proprio un regalo di Natale. Fu poi
successivamente irrigidita nel 2009. Per la verità non si menziona
esplicitamente la necessità di un visto di censura nella corrispondenza tra
difensore e assistito, vietata peraltro da altra disposizione dell’Ordinamento
penitenziario, l’art. 18 ter. Ma, trattandosi di disposizione speciale che
espressamente esclude il visto di censura solo per le comunicazioni tra detenuto
e membri del Parlamento o con autorità europee e nazionali aventi competenza in
materia di giustizia e non tra detenuto e difensore, secondo la Corte
costituzionale ben si sarebbe potuto affermare, sulla base della disposizione
censurata, che quella corrispondenza fosse oggetto del controllo e della
sorveglianza dell’autorità.
Quella che doveva essere una
norma a statuto eccezionale e temporaneo – il 41 bis- è ben presto diventata il
manifesto autocelebrativo di uno Stato dal pugno duro, incapace di affrontare i
diritti fondamentali secondo Costituzione. Conosciamo la storia del 41 bis.
Molti di noi conservano ancora l’immagine dell’autostrada A 29, in zona Capaci,
sventrata da 500 kg di tritolo, gli elicotteri intorno, le auto saltate e
divelte in una minutaglia di lamiere. L’inutile corsa in ospedale del
magistrato Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta.
Il macabro scenario di uno dei più feroci attacchi al cuore dello Stato. A
distanza di 16 giorni dall’attentato, il Governo dichiara guerra alla mafia
varando, era l’8 giugno del 1992, il decreto legge che avrebbe irrobustito, in
un giro di vite strettissima, il regime carcerario dei boss mafiosi.
Vi si introduce la cosiddetta
sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario: un 41 bis in
versione aggiornata e rinnovata. La conversione in legge non si fece attendere.
Era l’8 agosto. Venti giorni prima, il 19 luglio 1992, stessa sorte era toccata
a Paolo Borsellino. Della cronaca di quei giorni conserviamo memoria, anche se
la storia ha consegnato brandelli di verità, ipocrisie, depistaggi. Il carcere
durissimo per i mafiosi doveva risultare, però, una misura eccezionale e
temporanea. Era già chiaro allora come questa sospensione delle regole ordinarie
del trattamento penitenziario potesse entrare in rotta di collisione con la
Costituzione, in particolare con la finalità rieducativa della pena.
Come bene ha detto l’avv.
Maria Brucale, in un’intervista resa a Damiano Aliprandi su queste pagine il 22
dicembre del 2017, «l’Ordinamento penitenziario è – coerentemente con l’art. 27
della Costituzione – interamente orientato alla rieducazione del ristretto e a
un trattamento intramurario individualizzato, il più possibile rispondente alla
personalità del soggetto. Basta soffermarsi su tale aspetto per rendersi conto
della vistosa incostituzionalità di un regime che sospende per tempi indefiniti
l’accesso del ristretto alla rieducazione. Ci sono persone detenute in regime
differenziato fin dal tempo dell’entrata in vigore dell’art. 41 bis
dell’Ordinamento penitenziario; 25 anni di carcere duro che isola dagli affetti
e costringe in ambiti asfittici ogni anelito di vita emotiva e creativa. Si
tratta di carcerazioni punitive sottratte per legge alla finalità cui ogni pena
deve tendere, la restituzione dell’individuo alla società».
Ma, come spesso accade ed è
accaduto per le libertà personali e per i diritti fondamentali, nuove epifanie
emergenziali (o dichiarate tali), hanno avuto lo scopo di trasformare
l’eccezione in regola. Così, neanche a dirlo, quel 41 bis viene conservato e
rimodulato secondo esigenze sempre nuove, elevato a grimaldello sul quale si
misura l’attendibilità di una classe politica incapace ormai di relegare la
repressione a fenomeno minimo, ancillare, eventuale.
Ed arriviamo, a colpi
d’emergenza, prima al 2002 e poi al 2009, quando la disposizione viene
interpolata e ulteriormente irrigidita nei termini oggi giudicati
incostituzionali: non è un caso che l’ultimo provvedimento in senso cronologico,
quello del 2009, che ha limitato ulteriormente il diritto di difesa, recasse
l’altisonante nome di “disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Vien da
chiedersi: in che termini il diritto di difesa genera insicurezza? Quando
esattamente è accaduto che “difensore” facesse rima con “fiancheggiatore”?
Ha risposto, senza farsi
attendere, il direttore de Il Fatto quotidiano in una delle solite invettive
contro gli avvocati. Pare che non abbia gradito l’ultima sentenza della Corte
costituzionale. “Geniale” -ha scritto- “così i boss mafiosi potranno ordinare
omicidi e stragi”. Detto meglio, si serviranno dei loro difensori per consegnare
pizzini. Non stupiscono le invettive e gli strali dell’uomo – cui ha fatto eco
l’immediata reazione di Ucpi e del Cnf – ma per quanto si sia fatta l’abitudine
a questo genere di affermazioni, un pruriginoso senso di indignazione scuote le
coscienze dei pochi, ahimè, che ancora credono che il diritto di difesa sia il
sacrosanto baluardo di una società democratica, che il suo contrario appartenga
a periodi storici che vorremmo relegare in un passato remoto, superato proprio
con l’avvento, guarda caso, della Costituzione.
Eppure gli avvocati continuano
ad essere minacciati non solo in territori dominati da severe dittature o
manifeste sospensioni dei diritti umani. Ma una strisciante, indomita,
insuperata sensazione di diffidenza di manzoniana memoria (l’Azzegarbugli) fa da
eco alle parole di Travaglio anche nella democratica Italia. “Come fai a
difendere un criminale sapendolo tale?” non è solo una litania da bar, ma un
dubbio tra i più resistenti, che inanella a cascata sentimenti di sospetto e
diffidenza per una delle funzioni più strategiche per la tenuta democratica del
paese.
Forme, neppure troppo velate,
di minaccia si annidano sui social, vengono scagliate all’indirizzo di chi ha
assunto la difesa dei mostri indifendibili: il femminicida, il pedofilo, il
terrorista, il mafioso e chi più ne ha più ne metta. In questa era del
mainstream manettaro, difendere chi è già stato giudicato indifendibile da una
platea male informata di leoni da tastiera non è solo uno spreco di energia, ma
il segno tangibile che tra difensore e assistito si suggelli un sodalizio,
criminale appunto, al solo scopo di farla fare franca al secondo. È fin troppo
ovvio che in questo clima di allarmante impoverimento etico e culturale, il
segreto della conversazione tra difensore e difeso, anziché indispensabile
declinazione dell’effettività del diritto di difesa, diviene esso stesso cartina
di tornasole che tra i due “sodali” possano annidarsi complicità criminali che
sfuggono all’occhio vigile dell’autorità.
Andrebbe letta nelle scuole,
questa sentenza, pubblicata sui quotidiani mediante un’opera di alfabetizzazione
ai principi costituzionali. E ripetere, ad alta voce, come si faceva con le
poesie che ci facevano imparare a memoria, che il diritto di difesa
costituisce «principio supremo» dell’ordinamento costituzionale e comprende il
diritto, ad esso strumentale, di conferire con il difensore «allo scopo di
predisporre le difese e decidere le strategie difensive, ed ancor prima allo
scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilità offerte
dall’ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze
pregiudizievoli cui si è esposti».
D’altra parte, «se un avvocato
non potesse conferire con il suo cliente e ricevere da lui istruzioni riservate
al riparo della sorveglianza da parte dell’autorità, la sua assistenza tecnica
perderebbe gran parte della sua utilità, mentre la Convenzione mira a garantire
diritti concreti ed effettivi» (Corte europea dei diritti dell’uomo, anche nella
sentenza del 27 novembre 2007, Zagaria contro Italia).
Qualche anno fa un pubblico
ministero di Torino, Paolo Borgna, scrisse un libro -sulla falsa riga del volume
di Piero Calamandrei- che si intitola “Difesa degli avvocati scritta da un
pubblico accusatore”. Se solo il dott. Travaglio avesse la pazienza di leggere
quelle pagine, avrebbe di che imparare: «Tutti i giorni trattiamo il dolore, la
vita, gli affetti degli altri. Spesso ne determiniamo il corso. E lo facciamo
quasi senza rendercene conto. Questo è inevitabile e persino salutare: non
possiamo farci trascinare nel gorgo delle vicende umane di migliaia di vite che
il nostro lavoro ci fa incrociare. L’avvocato – con la sua “professione di
carità”, con il suo “tener compagnia a chi si trova a tu per tu con il dolore” –
è lì a ricordarci quei destini che noi tocchiamo. È lui il tramite tra le nostre
carte e la vita degli altri, è lui a portare sulle proprie spalle i grumi di
dolore dei propri assistiti, ad assumere su di sé l’urto delle passioni e delle
polemiche, a sollevarci da quel peso indicibile».
Perché l’avvocato è, sempre
per Borgna, un mediatore sociale (altro che fiancheggiatore!) che contribuisce,
al pari del magistrato, all’unitaria funzione di rendere giustizia.
Caro Travaglio, a tagliare
sempre con l’accetta si decapita pure il diritto.
A parte l’offesa rivolta agli
avvocati, l’ormai famigerato occhiello del Fatto quotidiano sulla sentenza che
favorirebbe gli ordini dei boss veicolati dai difensori è soprattutto un insulto
alla Corte e alla stessa Costituzione: negare a tutti un diritto per via
dell’azione di pochi è un modo alternativo di fare leggi ad personam. Giuseppe
Belcastro su Il Dubbio l'1 febbraio 2022.
Sul recente intervento della
Consulta, che ribadisce la riservatezza della corrispondenza tra i difensori e i
loro assistiti al 41-bis (carcere duro), si susseguono commenti e opinioni. Il
Fatto quotidiano, coerente alla sua linea editoriale, attacca frontalmente la
decisione. E in questa atmosfera, surriscaldata in vero più dai titoli che dal
contenuto dei pezzi, qualcuno della redazione alza l’ingegno e compone –
postandolo pure in rete – un occhiello su un articolo di Antonella Mascali, che
irride gli Avvocati, la Corte Costituzionale e (forse pure) la Costituzione;
così, in un colpo solo. Perché si sa, al Fatto sono ecumenici.
La frase, non c’è dubbio,
prima ancora che infelice e persino dissonante dalla misura del pezzo, è
urticante perché, mentre censura in modo spiccio la decisione della Consulta,
pretende di fondare il dileggio – come vuoi definire l’antifrasi del “Geniale”
posta in apertura? – sull’idea che se tu non leggi ciò che il detenuto scrive al
suo avvocato va a finire che il primo gli ordina omicidi per iscritto e il
secondo, ça va sans dire, trasmette gli ordini a chi di dovere. Una retorica che
conosciamo, insomma, niente di nuovo sotto il sole.
L’Unione delle Camere Penali
Italiane reagisce con immediatezza e puntualizza assai bene, chiudendo gli
spazi; a fianco partono pure altre rampogne al direttore Travaglio che non
prende le distanze dal titolista, stavolta sì, davvero geniale. Rampogne, dico
io, a maglie larghe: l’unica cosa vera è che, fra l’altro, il titolo offende la
funzione difensiva, generalizzando.
Travaglio, allora, che tra i
suoi difetti non annovera la stupidità, ghigna (sembra di vederlo) e prova a
soverchiare asciuttamente i suoi detrattori: ‘Anche tra gli avvocati ci son le
mele marce, cari signori, se ne deve tener conto’. E questo è vero, anzi banale,
quasi come dire che tra i giornalisti si annoverano pennivendoli, servi di
qualche padrone.
Il punto è però, caro
direttore, che se alcuni detenuti possono spedire ordini mafiosi ai loro
difensori, i quali talvolta – al suo buon cuore: in una sparuta minoranza di
casi – possono pure prestarsi indegnamente a trasmetterli, lei, che è appunto
direttore, dovrebbe sapere che le norme (e le sentenze della Consulta tali sono)
non disciplinano alcuni casi, ma la generalità di essi; che, cioè, sono leggi ad
personam non solo quelle che salvano pochi tra molti, ma anche quelle che
affossano i diritti di tutti (e la Costituzione) per l’azione di alcuni.
Dovrebbe prima ancora sapere,
visto che vive di questo, che gli accostamenti concettuali possono diventare
contumelie e che i cardini costituzionali non sopportano di essere forzati per
le cose minute di un avvocato di Merano o di Canicattì.
E dovrebbe soprattutto sapere
che deridere la massima autorità giurisdizionale del paese, provando a darla in
pasto a una comunità nutrita di bile per anni, è rischioso: se la prenda con gli
Avvocati (si difenderanno) ma lasci perdere la Corte e la Carta, che, vivaddio,
non le rivolgeranno la parola.
È saggezza popolare che se il
dito indica la luna occorra guardare questa; stando attenti alla prospettiva
però: sai quante dita tonde e luminose…
Poi finisce che, a seguire
queste idee balzane, oltre alle mele marcisce anche il diritto.
Marco Travaglio, la sparata
sui boss scatena gli avvocati: "Non siamo mafiosi", rivolta in tribunale.
Roberto Cota su
Libero Quotidiano il 28 gennaio 2022.
La Corte Costituzionale ha
dichiarato illegittima la norma che prevede la censura della corrispondenza tra
cliente detenuto in regime di 41 bis e avvocato. La questione di
costituzionalità, peraltro, era stata sollevata dalla Corte di Cassazione. Il
Giudice delle leggi ha osservato in sentenza come l'esercizio del diritto di
difesa comprende il diritto di comunicare in modo riservato con i propri
difensori. Tale diritto spetta a chi è recluso in carcere ed anche a chi è in
regime di 41 bis. Direi tutto normale. L'anomalia era la limitazione
precedentemente in essere, assolutamente non in linea con uno dei principi
cardine dello stato di diritto. Inoltre, la Corte Costituzionale ha sostenuto
che la tesi contraria rappresenterebbe "una generale ed insostenibile
presunzione di collusione del difensore dell'imputato". Senonché, nel successivo
dibattito è intervenuto Il Fatto Quotidiano che con un titolo ad effetto ha così
dato la notizia della decisione: "La Consulta cancella la censura della
corrispondenza tra i detenuti al 41 bis e gli avvocati. Geniale: così i boss
potranno ordinare omicidi e stragi".
Oltre a sposare la tesi
secondo la quale chi è in regime di 41 bis non deve avere neppure il diritto di
difendersi, il giornale di Travaglio, nella sostanza, qualifica tutti gli
avvocati come mafiosi. I sostenitori della campagna giustizialista e manettara
utilizzano adesso un nuovo argomento: quello di confondere l'avvocato con il
cliente. Se l'avvocato difende un mafioso è un mafioso. Lo schema
delegittimante, purtroppo, è quello tipico dei sistemi antidemocratici, dove la
figura del difensore viene relegata ad inutile e fastidioso orpello.
La Giunta delle Camere Penali
ha giustamente reagito, ma questa tendenza sta prendendo piede, non soltanto
sulle pagine de Il Fatto e non sempre può arrivare la Corte Costituzionale a
sistemare le cose. Il recente caso Pittelli è emblematico. Pittelli, avvocato ed
ex parlamentare, è in carcere perché accusato di aver concorso, nel difendere
dei clienti appartenenti alla ndrangheta, nei reati dei propri assistiti. La
materia è delicata, ma il problema del perimetro del lavoro del difensore va
affrontato e non lasciato al caso. La politica, come al solito, ha la tendenza a
non occuparsi delle questioni, soprattutto quelle spinose. Il rapporto
professionale avvocato-cliente dovrebbe essere rispettato e tutelato perché
siamo in un paese democratico dove i diritti fondamentali han no ancora un
senso. Nei mesi scorsi c'è stata una sacrosanta mobilitazione per chiedere
all'Egitto il rispetto dei diritti umani nel caso Zaki : da noi è tutto a
posto?
Gli insulti del Fatto agli
avvocati e il “sogno” della giustizia sommaria.
Sul quotidiano di Marco
Travaglio insinuano la collusione dei difensori con gli assistiti mafiosi.
L’insulto è nel titolo sulla sentenza con cui la Consulta ha bocciato le
“intrusioni” nelle lettere fra reclusi al 41 bis e avvocati. Più che reagire
all’offesa, va colto il vero segnale: l’insofferenza per lo Stato di diritto e
la segreta aspirazione a una giustizia autoritaria. Anche se sono sacrosante le
reazioni di diverse voci dell’avvocatura: dall’editore del Dubbio a Ocf, Aiga e
Anf. Errico Novi su Il Dubbio il 25 gennaio 2022.
Sì, non è la prima volta. Già
in passato altri avevano insinuato che gli avvocati dei detenuti per reati di
mafia fossero istitutivamente collusi con i loro assistiti. Ma un titolo apparso
oggi sul Fatto quotidiano (incoerente anche rispetto alla correttezza
dell’articolo) trapassa qualsiasi limite: “La Consulta cancella la censura sulla
corrispondenza fra i detenuti al 41-bis e avvocati. Geniale: così i boss
potranno ordinare omicidi e stragi”.
In pratica si attribuisce ai
difensori dei reclusi al 41 bis uno stigma di mafiosi di default: se assistete i
boss, siete pure voi certamente pronti a tutto, collusi o “colludibili”. Forse
non vale neppure la pena di soffermarsi troppo nel replicare. Non è il caso di
ricordare, a chi ha superato un esame da giornalista professionista, e conosce
dunque senz’altro le basi del diritto costituzionale, il contenuto dell’articolo
24.
È più interessante un’analisi
sociologica. A partire da un interrogativo: perché? Come si può scrivere una
cosa del genere? Non veniteci a raccontare che quello 0,001 per mille di casi in
cui si è ravvisata e provata una effettiva collusione di un avvocato con un
assistito mafioso basti a giustificare quel titolo. È evidente che non è così:
il Fatto allude implicitamente a una moltitudine di casi, quindi non ha agganci
col reale. È solo un insulto a casaccio. All’intera classe forense.
La risposta al “perché” è
altrove. E per trovarla va citato un altro titolo offensivo apparso oggi sulle
pagine palermitane di Repubblica in cui in pratica si descrive la classe forense
come un esercito che “se ne approfitta”: “Avvocati in coda: è qui la festa del
gratuito patrocinio”. Nell’articolo, anche qui corretto, si segnala che il
capoluogo siciliano è il Foro in cui si registra il maggior numero di richieste
per il beneficio (che, andrebbe ricordato, non è “gratuito” ma appunto a carico
dello Stato). Nella titolazione c’è un disprezzo un filo meno sguaiato di quanto
visto su Fatto. Ma si può scorgere lo stesso fastidio per il diritto di difesa,
il sogno di una giustizia sommaria, rapida e autoritaria in cui, come in Ritorno
al futuro, l’avvocato viene semplicemente “abolito”.
È un’insofferenza non per la
categoria degli avvocati ma per il diritto. Nel caso di Repubblica, per il
diritto dei non abbienti a essere difesi in giudizio, che per un giornale
progressista dovrebbe essere un valore. Perciò forse non c’è neppure da
offendersi. Ma da interrogarsi su quanto sia radicata nel nostro paese una
cultura autoritaria, del diritto e non solo, con cui sarà sempre difficilissimo
confrontarsi.
Le reazioni dell’avvocatura
Sono certo più che
giustificate le reazioni di diverse voci dell’avvocatura. Da segnalare
innanzitutto la replica, serafica, dell’editore del Dubbio: “L’avvocatura è
grata a Travaglio per averla promossa al rango di criminale”.
Se sono indignati, liquidatori
ma non privi di un rimando a querele per diffamazione i toni dell’Ucpi (di cui
vi diamo conto in altro servizio, nda), sconcertato ma più “piano” è il
comunicato di Ocf: quella della Consulta, osserva l’Organismo forense, è una
sentenza «ineccepibile» e perciò «stupiscono certi commenti secondo cui in
questo modo si favorirebbe la mafia e i boss al 41 bis potrebbero così più
facilmente aggirare le restrizioni continuando a gestire i clan dal carcere,
magari ordinando la commissione di reati. Non solo. Questo genere di
sottolineature», fa notare l’Ocf, «gettano il discredito su un’intera categoria,
quella forense, che per il solo fatto di assicurare il diritto
costituzionalmente garantito a un boss recluso, automaticamente si presterebbe a
veicolare gli ordini della criminalità organizzata».
L’Aiga è ancora più esplicita
nell’esprimere «il proprio fermo dissenso» per le parole del Fatto: che, secondo
il presidente dell’Associazione giovani avvocati, Francesco Paolo
Perchinunno, sono «gravissime e irricevibili». Parole che «mancano di rispetto a
tutta l’avvocatura e in particolar modo a quei colleghi, ancora vivi nella
nostra memoria come Fulvio Croce e Serafino Famà, che hanno pagato con la vita
quel dovere di indipendenza che ogni avvocato assume con il giuramento. Non si
può paragonare l’avvocato ad un favoreggiatore o complice del condannato, così
si mortifica la funzione difensiva, svolta con grande passione, competenza e
dedizione da migliaia di colleghi. Sarebbe il caso di ricordare al Fatto
quotidiano, come il diritto alla difesa sia uno dei cardini della Costituzione e
di come certi commenti non facciano nient’altro che portare l’Italia verso una
deriva giustizialista».
Su un registro non diverso da
quello molto aspro della nota Ucpi è la replica dell’Associazione nazionale
forense: «Grave, offensiva e inopportuna affermazione del Fatto Quotidiano nei
confronti dell’intera categoria degli avvocati». Il giornale, ricorda il
presidente dell’Anf Giampaolo Di Marco, «si è lanciato in un’affermazione
vergognosa e imbarazzante. Gli avvocati non sono messaggeri di criminalità o
corrieri, ma professionisti a cui le persone, anche coloro che sono stati
condannati per reati gravissimi, affidano il loro destino affinché ottengano il
trattamento più giusto ed equo previsto dall’ordinamento».
Di Marco aggiunge:
«L’inaccettabile affermazione non può essere considerata una battuta o una
semplificazione e neppure una legittima opinione, ma un attacco giustizialista
che mina le basi dello Stato di diritto e non rende un buon servizio alla
percezione del sistema Giustizia nel nostro Paese, anche perché con il suo
intento acchiappa-like dirotta l’attenzione da quanto correttamente scritto
dalla Corte, ovvero che vi sia una “generale e insostenibile presunzione di
collusione del difensore dell’imputato, finendo così per gettare una luce di
sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la
tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di
diritto nel suo complesso”».
41bis, i penalisti: “Dal
Fatto miserabili infamie contro gli avvocati”.
La replica della Giunta
dell'Unione Camere penali dopo l'attacco del giornale di Travaglio sulla
sentenza della Consulta: "Ne risponderanno, come meritano gli atti diffamatori".
Il Dubbio il 25 gennaio 2022.
«Secondo “Il Fatto
Quotidiano”, giornale da poche migliaia di copie vendute e tuttavia idolatrato
dai manettari di tutta Italia, la sentenza della Corte Costituzionale che ha
finalmente abrogato, perché incostituzionale, la censura della corrispondenza
tra detenuti al 41 bis e difensori, farebbe sì che ora “i boss potranno ordinare
omicidi e stragi per lettera”». Comincia così la dura replica della Giunta
dell’Unione Camere penali all’articolo del quotidiano di Marco Travaglio sulla
sentenza di ieri della Consulta, a cui hanno reagito con sdegno anche altre
rappresentanze forensi – l’Ocf, ma anche l’Aiga e l’Anf.
«Ci siamo interrogati –
prosegue la nota – se valesse la pena replicare ad una simile, miserabile
infamia, frutto di un analfabetismo così profondo ed irredimibile da risultare,
alla fine, disarmante. Ma pur essendo tali i tempi che viviamo, cioè tali che
possano purtroppo trovare voce e risalto pubblico idee al più degne di essere
scompostamente vergate su qualche muro un po’ appartato, non possiamo non
reagire a difesa della dignità della professione forense, e della onorabilità di
chi la esercita».
«L’idea che un detenuto, quale
sia il livello di gravità delle accuse che lo raggiungano, non possa
liberamente, cioè con intangibile segretezza, corrispondere con il proprio
difensore, rimanda alle pagine più buie della storia dell’umanità, ed ai sistemi
antidemocratici più feroci e violenti. L’idea poi che, finalmente restituita
questa primordiale e davvero incoercibile libertà, il difensore si renda perciò
stesso complice di ogni crimine che quel detenuto immagini di poter commettere
per suo tramite, è talmente insensata, talmente paranoide, talmente frutto del
più cupo analfabetismo, da meritare – insieme al nostro disprezzo – la sanzione
che merita – qui davvero, ed in manifesta flagranza- ogni atto diffamatorio. E
così sarà».
«Papà fu un avvocato e
vittima della mafia, non suo complice».
Lo sfogo di Flavia Famà,
figlia di Serafino, penalista ucciso dalla mafia nel 1995. «Le parole del Fatto
Quotidiano sugli avvocati sono indegne: sono necessarie delle scuse». Simona
Musco su Il Dubbio il 26 gennaio 2022.
«L’avvocato è giusto che in
aula porti la toga. L’avvocato è giusto che dica al pubblico ministero che deve
occupare il posto che il codice prevede non sieda accanto al giudice. L’avvocato
è giusto che nell’ambito delle sue funzioni sistematicamente stia attento a che
i suoi diritti non vengano disconosciuti. (…) Io mi sono sistematicamente
rifiutato di accettare la perquisizione a Bicocca perché la trovo indegna. Trovo
indegno il fatto che il poliziotto acquisti la mentalità e la cultura che
l’avvocato è istituzionalmente soggetto meritevole di sospetto. È questo il
fatto che mi indigna non la perdita di tempo di tre minuti». Era il 1994 quando
Serafino Famà, penalista di Catania ucciso dalla mafia il 9 novembre dell’anno
dopo con sei colpi di pistola calibro 7,65, pronunciava queste parole. Si
trovava ad un’assemblea della Camera penale, in adesione allo sciopero dei
colleghi di Napoli, dove denunciò la «sistematica arrendevolezza degli avvocati
di fronte ai loro diritti». Di fronte a chi, ad esempio, considera il diritto
alla difesa un’onta che estende i “peccati” degli assistiti ai propri difensori.
Un pregiudizio, ci racconta oggi Flavia Famà, figlia di quella vittima di mafia,
che di fronte all’ennesimo attacco lanciato dal Fatto Quotidiano contro la
professione forense ha risposto indignata, ricordando il sacrificio non solo di
suo padre, ma anche di Fulvio Croce e Giorgio Ambrosoli.
«Non ci sono vittime di mafia
di serie A e vittime di serie B», sottolinea, sorpresa di dover evidenziare
l’ovvio di fronte al sistematico attacco ai diritti. Dalla propria pagina
Facebook, Famà ha definito «indegne» le parole del quotidiano diretto da Marco
Travaglio, secondo cui la sentenza della Consulta che cancella la censura della
corrispondenza tra detenuti al 41 bis e avvocati rappresenterebbe l’opportunità,
per i boss mafiosi, di “commissionare” omicidi e stragi tramite i propri
difensori. «Mio padre si ribellava a questo genere di insinuazioni infamanti che
peraltro gettano discredito su tutta la categoria – sottolinea -. Da figlia di
un avvocato ammazzato dalla mafia proprio perché svolgeva in modo corretto la
professione di difensore mi sento offesa e amareggiata». Affermazioni sbagliate,
racconta oggi al Dubbio, al netto della libertà di pensiero e di espressione.
«Ricordiamoci che, in teoria, le conversazioni degli avvocati non possono essere
intercettate, quindi non vedo perché debbano poterlo essere quelle con un
assistito che si trova al 41 bis, solo perché si dà per scontato che sia
complice di eventuali reati», afferma. Una cosa intollerabile per chi, «come me,
ha vissuto sulla propria pelle un’esperienza del genere – racconta -. Molte
volte mi sono ritrovata a dover giustificare quello che è successo a mio padre
per il solo fatto di essere un avvocato penalista, come se solo per questo lui
fosse colpevole di qualcosa. Come se se la fosse cercata, come molte volte mi
sono sentita dire. Questo tipo di giornalismo arreca tantissimo danno,
soprattutto nella settimana dedicata agli avvocati in pericolo: sembra una presa
in giro. Però quando questi giornalisti così giustizialisti vengono querelati si
rivolgono agli avvocati e li cercano altrettanto liberi e altrettanto
integerrimi di quelli che in realtà stanno infangando».
Il problema è come sempre uno:
identificare il difensore con il proprio assistito ed estendere il reato anche a
chi è chiamato a garantire la difesa dei diritti. «Ci si dimentica che la difesa
è tecnica, è garantita dalla nostra Costituzione ed è il baluardo della
democrazia – spiega -. Senza avvocati a far valere i diritti è un attimo che si
trasformi in una dittatura». Famà, come il padre, è appassionata di diritto e si
occupa di America Latina. Ed è proprio lì che va il pensiero, cogliendo al volo
l’occasione della giornata dedicata agli avvocati in pericolo nel mondo. «In
Colombia chiunque non la pensi come il governo è considerato un terrorista e gli
avvocati che assistono le vittime di Stato sono considerati allo stesso modo –
ha evidenziato -. Ovviamente in Italia non siamo a questi livelli in termini di
ritorsioni e pericolosità, ma con una magistratura che sembra concedere un
favore quando consente all’avvocato di garantire il diritto di difesa, colleghi
arrendevoli davanti ai propri diritti, come li definiva mio padre, e un
giornalismo superficiale e meschino, il passo è breve: non ci vuole molte a
perdere quel minimo di democrazia che c’è».
Famà venne ucciso per aver
detto di no alla richiesta avanzata dal boss Di Giacomo, che pretendeva di far
testimoniare al processo una donna, sua cognata e amante, nonché moglie di un
pentito, che non ne aveva alcuna intenzione. «Quando leggo cose del genere,
scritte da chi magari si straccia le vesti il 23 maggio e il 19 luglio, penso:
mio padre non ha contato niente? Delle due l’una: non si possono distinguere le
vittime di mafia. Essere avvocato non significa automaticamente non essere
onesto. Non voglio scuse in memoria di chi è morto, ma in nome di tutti gli
avvocati onesti che sono ancora in vita». L’avvocato, spiega, è come un medico:
«Non si può scegliere se operare o meno in base al fatto che il paziente sia una
brava o una cattiva persona. L’avvocato fa il proprio mestiere con solitudine e
fatica e la consapevolezza che le proprie azioni possono avere conseguenze in
termini di libertà personale». E per spiegare chi fosse realmente suo padre
racconta un episodio: «Ci fu un processo terribile, in cui fece un’arringa
lunghissima, al termine della quale il giudice voleva ritirarsi e decidere alla
fine della giornata. Ma, codice alla mano, mio padre disse che andava fatto
subito. Il giudice fece così, perché era previsto, e condannò l’imputato –
conclude -. I colleghi di studio gli dissero: “Avvocato, ma sempre tu! Ti sei
impuntato e abbiamo perso la causa”. Ma lui rispose che aveva vinto, perché
aveva fatto rispettare le norme. Un avvocato non sente di aver vinto se il
pluriomicida è libero di commettere reati, ma se ha garantito il rispetto del
giusto processo. È questo che certi giornalisti dovrebbero ricordare».
Ergastolo ostativo, passa
la linea grillina e il decreto è peggiorativo.
Il decreto legge non solo riprende il testo già approvato, ma inserisce punti
peggiorativi tratti dalla vecchia proposta del M5S. L’allarme UCPI: “Sarà
colpito anche chi non è all’ergastolo ostativo”. Damiano Aliprandi su Il Dubbio
l'1 novembre 2022.
La prima mossa del governo
Meloni sull’ergastolo ostativo non è solo il ricalco della proposta di legge
approvata alla Camera, ma presenta punti “peggiorativi” già contenuti nel
disegno di legge grillino che fu presentato dall’ex sottosegretario alla
Giustizia Vittorio Ferraresi. Nel decreto legge varato dal Consiglio dei
ministri ha vinto la concezione illiberale del diritto penale che attraversa –
tranne alcune eccezioni come Forza Italia, Terzo polo e parte del Pd -, quasi
tutto l’arco parlamentare attuale. Di fatto, già la legge che fu approvata dalla
Camera, seppur depurandola di alcuni punti della proposta grillina, non era in
linea con le indicazioni date dalla Consulta. Aveva infatti posto ulteriori
paletti come l’eliminazione delle ipotesi di collaborazione “impossibile” e
“inesigibile”.
Il decreto va contro la
sentenza della Corte costituzionale
In sostanza, verrà meno la
possibilità per rarissimi casi di ergastolani ostativi di poter accedere ai
benefici perché, solo per fare un esempio, l’organizzazione di appartenenza non
esiste più e qualsiasi collaborazione con la giustizia non servirebbe. Oppure,
altro esempio, l’ergastolano ha avuto una posizione talmente marginale
nell’associazione mafiosa, che pur volendo collaborare non può visto la non
conoscenza completa dei fatti. Eliminando tutto questo (il decreto legge
avanzato dal governo Meloni lo riprende), si va contro le indicazioni della
sentenza costituzionale stessa che sancisce la differenza tra la mancata
collaborazione per scelta con quella per impossibilità.
Nell’ostatività finiscono
anche i reati contro la pubblica amministrazione
Il decreto legge
Meloni riprende anche l’aumento da ventisei a trenta anni di pena da scontare
prima di poter presentare l’istanza di liberazione condizionale. Così come, ed è
anche ciò che hanno sottolineato i penalisti delle Camere penali, non si dice
che nell’ostatività finiscono anche i reati contro la pubblica amministrazione,
proprio insieme ai delitti di criminalità organizzata, terrorismo, eversione
dell’ordine democratico, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile,
sequestro di persona e così via. Parliamo dell’abnormità della “spazzacorrotti”,
la riforma Bonafede.
Si rende quasi del tutto
impossibile la concessione dei benefici
Ha vinto, di fatto, la
propaganda di una parte consistente dell’informazione, soprattutto quella che è
di “opposizione”. Una opposizione che pretende, riuscendoci, leggi più vicine
allo Stato di polizia che di Diritto. Paventando il pericolo inesistente della
scarcerazione facile dei boss stragisti (una bufala smentita dai fatti, leggasi
le istanze sui permessi premio respinte ai Graviano), si aggirano le indicazioni
della Corte costituzionale, per rendere quasi del tutto impossibile la
concessione dei benefici per chi si è macchiato di reati ostativi.
Il decreto legge, com’è detto,
non ricalca esattamente la proposta di legge votata alla Camera, ma inserisce
punti ulteriormente peggiorativi già avanzati dai Cinque stelle. Ad esempio c’è
il depotenziamento interpretativo che consentiva il cosiddetto scioglimento del
cumulo il quale permetteva di ritenere cessata l’ostatività una volta scontata
la parte di pena relativa appunto ai delitti ostativi. Come sintetizza bene
Vincenzo Giglio sul blog Terzultima fermata, con il decreto legge lo
scioglimento non sarà più permesso nei casi in cui il giudice della cognizione
(o, in alternativa, il giudice dell’esecuzione o il giudice di sorveglianza)
abbiano accertato la sussistenza di una connessione qualificata tra il delitto
non ostativo e quello ostativo, connessione che ricorre in particolare quando il
delitto ostativo sia stato commesso «per eseguire od occultare uno dei reati di
cui al primo periodo, ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad
altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di detti reati».
L’allarme delle Camere penali:
si aggravano gli effetti delle ostatività relativi ad un ben più ampio catalogo
di reati
Per quanto riguarda i due
requisiti per accedere ai benefici, ovvero la mancanza di collegamenti e la
mancanza di pericolo di ripristino, il decreto legge li riprende dalla sentenza
della Consulta sul permesso premio. Ma aggiungendo, come prevedeva già il testo
approvato alla Camera, la cosiddetta “probatio diabolica” a carico del
richiedente. Dopo 30 anni di carcere, il detenuto stesso deve dimostrare il
mancato pericolo di ristabilire il collegamento con il contesto territoriale suo
e dei suoi. Cosa significa? La fine delle misure alternative, non solo per i
“sanguinari”, ma anche per tutti quelli che verranno condannati a pene anche più
contenute. In sostanza, il criterio di ammissione alle misure sarà quello
dettato per l’ergastolo ostativo.
E sul punto, come già detto,
l’Unione delle Camere penali italiane lancia l’allarme, sottolineando «la
manipolazione informativa che sta accompagnando l’adozione di questo
provvedimento, indicato come relativo al solo tema dell’ergastolo ostativo,
quando invece esso riguarda ed aggrava gli effetti delle ostatività relativi ad
un ben più ampio catalogo di reati, a cominciare da quelli contro la pubblica
amministrazione». Entro due mesi questo provvedimento dovrà diventare legge,
martedì prossimo 8 novembre dovrà pronunciarsi però la Consulta. Quest’ultima
prorogherà per la terza volta la scadenza?
Patrizia Maciocchi
per ilsole24ore.com il 2 novembre 2022.
La mancata collaborazione con
gli inquirenti impedisce di ottenere un permesso premio al boss Filippo
Graviano. Le porte della cella per il capomafia, tra i mandanti per le stragi
del ’92 e del ’93, condannato all’ergastolo anche per l’uccisione di don Pino
Puglisi, resteranno chiuse, malgrado «la regolare condotta carceraria e il
percorso scolastico». Graviano, classe ’61 è in carcere dal 1994 sottoposto al
regime “differenziato”. Sul no alla richiesta di permesso premio - pronunciato
dal Tribunale dell’Aquila e confermato dalla Cassazione (sentenza 41329) - ha
pesato la sua dissociazione, considerata solo di facciata, e l’aver mantenuto
rapporti con i familiari tra i quali ci sono «anche soggetti pure convolti in
logiche associative».
La buona condotta e la laurea
La prima sezione penale della
Suprema corte ha, infatti, considerato corretta l’ordinanza con la quale i
giudici abruzzesi, il 9 febbraio 2022, avevano respinto la domanda per accedere
al beneficio fatta da Filippo Graviano, chiarendo che «il detenuto aveva
sottoscritto una dichiarazione di dissociazione, cui non aveva fatto seguito una
collaborazione con gli inquirenti».
Oltre ai rapporti con i
familiari in coinvolti in logiche di clan. Contro la decisione, la difesa ha
fatto ricorso in Cassazione denunciando la violazione dell’articolo 30ter
dell’ordinamento penitenziario che regola la concessione dei permessi premio.
«Il detenuto - aveva sottolineato il difensore - aveva reso dichiarazione
incondizionata di dissociazione ed aveva accettato il confronto con il pentito
Spatuzza, che ne aveva riconosciuto l’estraneità a fatti di sangue; non era
stato coinvolto in una recente indagine avente ad oggetto il mandamento mafioso
di Brancaccio, già di riferimento» del Graviano.
Inoltre, «la condotta in
carcere era sempre stata regolare, tanto che era stata riconosciuta la
liberazione anticipata, e di partecipazione al trattamento, come desumibile dal
percorso scolastico giunto sino al conseguimento, con il massimo dei voti, della
laurea magistrale»: La difesa aveva anche fatto presente che «la sottoposizione
al regime differenziato non è incompatibile con l’ammissione all’esperienza
premiale».
Niente collaborazione
La Cassazione ha però chiarito
che «l’istituto dei permessi premio costituisce elemento del trattamento
penitenziario e quindi va riconosciuto previa valutazione dell’andamento
complessivo del percorso riabilitativo e, dunque, se risulta, in relazione ai
progressi compiuti e alle prospettive, idoneo a contribuire al conseguimento
dell’obiettivo rieducativo». Tuttavia, nel caso di Graviano, secondo i supremi
giudici, il Tribunale di sorveglianza «ha dato conto della valutazione negativa
compiuta, giustificandola con motivazione in questa sede non censurabile».
La considerazione dei
gravissimi reati commessi si è unita al rilievo che non ne era seguita una
effettiva presa di distanza «ed anzi - scrive la Cassazione - erano stati
mantenuti i contatti con i familiari pure già coinvolti nel medesimo contesto di
criminalità organizzata». Dati che «letti alla luce della carente rivisitazione
critica dei gravissimi reati commessi, non hanno consentito di valorizzare la
pur regolare condotta carceraria e il percorso scolastico».
Passa la linea
fasciogrillina. Sulla giustizia nasce l’alleanza tra Travaglio e Meloni: e
Nordio se la dorme…Piero
Sansonetti su Il Riformista l'1 Novembre 2022
È nato un nuovo asse politico.
Si chiama Travaglio-Meloni. Al momento si applica solo al capitolo giustizia
(sulla guerra il reciproco ribaltamento di posizioni fra Travaglio, ex
filoatlantico, e Meloni, ex antiatlantica, rende impossibile la convergenza). La
convergenza attuale consiste nella scelta del nuovo presidente del Consiglio di
aderire senza obiezioni alla linea dei 5 Stelle, sostenuta con vigoria virile da
Travaglio in questi anni, e anche – diamogliene atto – dal povero e
vilipeso Bonafede. Qual è la linea? Meno garantismo, più potere alle
supposizioni, riduzione ai minimi termini dello Stato di diritto, molte molte
punizioni e poi prigione prigione prigione, anche in spregio della Costituzione
e delle idee e suggerimenti e richieste dell’Europa.
Il primo provvedimento che il
nuovo governo ha voluto adottare non riguarda
le bollette, la crisi, l’inflazione, la caduta dell’occupazione, l’aumento
delle povertà, le difficoltà delle imprese… no: riguarda la possibilità di
bloccare la timida riforma Cartabia (considerata però eccessivamente liberal
dalla nuova destra meloniana e travaglista) e soprattutto di evitare che siano
smantellate le leggi liberticide sull’ergastolo e sulle norme ostatitve che
bloccano per anni e anni in prigione persone che invece potrebbero uscire libere
o essere dirottate verso pene alternative.
La svolta è chiarissima e
fuori discussione. È di tipo fascista (se mi permettete di usare questo termine
semplicistico e un po’ grossolano, ma assai evocativo), non nel senso delle
etichette e delle litanie imparate a memoria da un pezzo di sinistra che spesso,
su questi argomenti, è fascista come Conte, Travaglio e la Meloni messi insieme.
Dico di tipo fascista nel senso che è una svolta autoritaria e illiberale e
intollerante che ci riporta ai tempi del governo gialloverde. Voi sapete che
questo giornale ha sempre considerato il movimento Cinque Stelle un movimento
con forti richiami all’ideologia fascista, e cioè alla parte antipolitica,
autoritaria e eticista, che era fondamentale nella costruzione ideologica del
vecchio regime.
Ora si vede che su quella
linea si trova perfettamente a suo agio la destra-destra
di Salvini e Meloni. C’era stata una interruzione della corsa giustizialista
col governo Draghi, che era di ispirazione liberale, anche se molto prudente
perché comunque doveva fare i conti con una maggioranza che comprendeva anche i
ragazzi di Grillo, e quelli di Salvini e i pezzi meno garantisti del Pd (meno
garantisti è un eufemismo….). La parentesi draghiana è finita. Ora però si
pongono tre questioni. La prima riguarda il ministro, la seconda riguarda Forza
Italia, la terza riguarda il Pd. Il ministro si chiama Carlo Nordio. Ha più di
70 anni e per almeno 40 anni ha militato in quella parte piccola piccola di
cultura garantista che sopravviveva in magistratura. Questo giornale ha
sostenuto qualche mese fa la sua candidatura al Quirinale, e nei giorni scorso
ha sempre accompagnato le critiche al governo e alla Meloni con le lodi a
Nordio.
Il ministro, per la verità, ci
aveva lasciato assai perplessi quando qualche settimana fa in una bella
intervista a Libero aveva introdotto – a sorpresa – delle frasi tutt’altro che
garantiste sulla legalizzazione delle droghe leggere e
sulla depenalizzazione dei reati legati alle droghe leggere. Ci eravamo
preoccupati un po’ ma avevamo continuato a battergli le mani, perché continuava
a proclamare principi assolutamente garantisti, tipici della sua impostazione
culturale. Così come gli abbiamo battuto le mani non molto più di 24 ore fa
quando ha detto che il suo principale problema era il carcere.
Noi pensavamo che lui
intendesse dire che si sarebbe impegnato per ridimensionare la funzione del
carcere nel sistema delle pene. Invece, forse, intendeva dire tutto il
contrario: non come fare uscire un po’ di gente dalla prigione, ma di come
tenercela dentro. Il decreto sul 4 bis, oltre che sfidare la Costituzione e
la Corte Costituzionale, equivale, sul piano ideologico allo slogan dei
giustizialisti più estremi: “buttare la chiave”. Nordio si allinea a questo
slogan? È difficilissimo crederlo. Noi continuiamo a immaginare che sia un
equivoco. Non possiamo rassegnarci all’idea che il potere sia una categoria
dello spirito così malvagia che in pochi giorni ti si mangia tutto il pensiero.
Aspettiamo nelle prossime ore una dichiarazione clamorosa di Nordio, o un suo
gesto eclatante, che ci permetta di tornare a stimarlo come abbiamo sempre
fatto.
2) Ora è chiarissimo il motivo
per il quale Silvio Berlusconi voleva la Casellati e non Nordio al ministero
della Giustizia. Berlusconi non si fidava. Voleva una avvocata che conosce bene
e della cui saldezza non dubita. Conosceva anche le pulsioni travagliane (o
contiste) di Giorgia Meloni e sapeva che per dare equilibrio liberale al governo
occorreva che una persona solida e non addomesticabile sedesse a via Arenula
(Per la seconda volta negli ultimi mesi devo chiedere scusa alla senatrice
Casellati.
Stavolta perché mentre erano
in corso le trattative io ero nettamente favorevole a Nordio, e chiaramente mi
sbagliavo). Ora però si pone la questione di come si muove Forza Italia. In
Parlamento il partito di Berlusconi potrà dare il voto favorevole a questo
provvedimento ispirato al più totale bonafedismo e che inverte i passi compiuti
dalla ministra Cartabia? Sarebbe una sciagura per i liberali. Una resa. Ci
troveremmo senza più argini all’ondata reazionaria.
3) Il Pd si trova ora di
fronte a se stesso. E alle scelte di fondo che dovrà compiere durante il suo
congresso. Vorrà essere un partito giustizialista, come in buona parte è stato
finora, o comunque oscillante, o vorrà realizzare la sua vera svolta, quella
liberale e garantista che in nessun modo vuol dire svolta a destra.
Il garantismo più rigoroso e radicale non entra mai in contrasto con una
politica fortissimamente di sinistra. Io che son vecchio, ho militato
nel Pci, mi ricordo di Umberto Terracini e di Alberto Malagugini, due giuristi
comunisti in dissenso da sinistra con Berlinguer e Longo, e garantisti,
garantisti a cinquecento carati. In tutti i campi del garantismo.
Probabilmente molti degli
attuali dirigenti del Pd non conoscono questi due nomi, né quello di Sullo, che
fu pure ministro della Giustizia nel ‘46, ma la storia della sinistra italiana,
che pure è stata sfregiata dal giustizialismo, contiene in se anche molti
elementi garantisti. Il Pd deve scegliere. Vuole andare con Conte a caccia di
manette, o vuole costruire una nuova prospettiva socialista,
liberale ed egualitarista? Intanto c’è questa prima occasione. Opporsi ventre a
terra a questo decreto reazionario. Sfidando Conte e il populismo manettaro.
Saprà farlo?
P.S, Non ho scritto
dei renziani e dei calendiani perché spero che non ce ne sia bisogno. Non posso
pensare che si bonafedizzino pure loro…
Piero Sansonetti. Giornalista
professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di cui è stato
vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004 al 2009, poi
di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per poi approdare
alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre 2019.
Giustizia: l'inizio
peggiore che si potesse temere. Nordio tradisce se stesso: diceva una cosa, ora
ne fa e ne dice un’altra.
Tiziana Maiolo su Il Riformista l'1 Novembre 2022
“Questa norma sull’ergastolo
ostativo è figlia dell’insegnamento di Falcone e Borsellino. E’ stata molto
osteggiata dalla mafia, che ha inserito la richiesta di abolizione nei vari
papelli…”. Ha voluto aprire con queste parole la prima conferenza stampa del
primo consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Sulla giustizia e nel modo
peggiore delle peggiori previsioni. Anche perché, subito dopo ha aggiunto, come
era prevedibile, che il rinvio dell’entrata in vigore della riforma
Cartabia sul processo penale non è solo tecnico, ma “servirà anche a valutare”
se la normativa non vada modificata in qualche sua parte.
Dispiace dover contraddire,
così, nel suo vero primo giorno di governo, la Presidente del consiglio. Non è
questione di opinioni, ma di notizie. Né Borsellino né Falcone sono i padri di
quella pena di morte sociale che ha preso le vesti, nel 1992, dopo che loro
erano stati assassinati, dei reati “ostativi”, e in particolare
dell’ergastolo. Anzi, lo stesso Falcone aveva messo mano a un provvedimento che
diceva esattamente il contrario, lasciando al condannato sempre una vita
d’uscita che non fosse quella della collaborazione. Del resto la Presidente del
consiglio, che è entrata in politica proprio per l’emozione provata dopo
l’assassinio di Borsellino e ha ricordato i depistaggi di Stato dopo la strage
di via D’Amelio e l’uso del finto collaboratore Scarantino, avrebbe tutte le
ragioni per diffidare della genuinità di certi “pentimenti”.
E credere di più, come ha
mostrato di credere l’ex ministra Cartabia, nella forza di un percorso
individuale di cambiamento della persona e nella progressiva presa di distanza
da parte del condannato, comprovata dai soggetti che stanno vicini al detenuto
nella quotidianità come i giudici di sorveglianza, dal proprio passato di
trasgressione. Vogliamo sperare che qualche imbarazzo abbia provato nella
conferenza stampa il ministro Nordio, cui la Presidente ha detto di aver “tolto
il bavaglio”, alludendo a qualche titolo di giornale che salutava con gioia il
fatto che quel cerotto sulle labbra gli fosse stato messo. Come conciliare il
pensiero del Nordio-uno, quando definiva l’ergastolo ostativo “un’eresia
contraria alla Costituzione”, con il Nordio-due quando ritiene che il
Parlamento, con il disegno di legge approvato nei mesi scorsi, abbia accolto
alcune “criticità” indicate dalla Corte Costituzionale e la Cedu? Eh no, signor
ministro, l’Alta Corte aveva dichiarato l’incostituzionalità, proprio come lei
nella fase Nordio-uno. Cioè la norma, e anche la legge approvata dal Parlamento,
che è in alcuni punti addirittura peggiorativa rispetto alla norma del 1992, è
contro la Costituzione, altro che criticità.
La domanda ora è: l’otto
novembre, quando si riunirà per deliberare sulla materia, l’Alta Corte avrà la
forza di dire al Parlamento che anche la nuova legge, votata “quasi”
all’unanimità perché il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, si era
astenuto, è contro la Costituzione? E che l’Italia sta sprofondando
nell’illegalità e ripristinando la pena di morte? Ma un’altra domanda sorge
spontanea, dopo aver ascoltato anche le parole del ministro guardasigilli:
esisterà ancora la riforma Cartabia sul processo penale dopo il 31 dicembre? La
domanda non è inutile, dopo il rinvio deciso dal Consiglio dei ministri delle
norme, indispensabili anche per l’osservanza dell’impegno assunto sul Pnrr, che
avrebbero dovuto entrare in vigore proprio domani. Rinvio tecnico,
apparentemente, anche per dare una mano alle difficoltà espresse nei giorni
scorsi dai 26 procuratori generali, soprattutto per i provvedimenti che
intervengono sulla fase delle indagini preliminari.
Ma è ormai chiaro che non sarà
così, e che interverrà qualche “manina”, come ci avevano già informato i
saputelli del Fatto quotidiano con le loro interviste anonime (ah, la passione
di consultare i citofoni!) a dirigenti di Fratelli d’Italia ansiosi di fare a
pezzetti la riforma già ribattezzata, anche dal Giornale,
come “salvaladri” o “svuotacarceri”. Nel mirino del partito talebano,
soprattutto la norma che prevede la necessità di querela per perseguire una
serie di reati. Il che è apparentemente in linea con quel che ha sempre pensato
e anche affermato fino ai giorni scorsi il ministro Nordio. Il quale, poche ore
prima che la Presidente del Consiglio Meloni si dichiarasse contraria, aveva
lanciato come primo provvedimento del suo nuovo incarico quello
della depenalizzazione di una serie di reati. E aveva in seguito fatto proprio
l’allarme sulle carceri dopo il suicidio numero settantadue dall’inizio
dell’anno. Svuotare le carceri da persone in attesa di giudizio o condannate per
pene inferiori a quattro anni è meno ancora che depenalizzare. Perché rinviare,
quindi?
Tutta la riforma Cartabia del
resto potrebbe essere la fotocopia, o viceversa, del Nordio-pensiero, basterebbe
leggere i suoi libri. E buttare via la riforma Cartabia sarebbe veramente un
insulto alla speranza di svuotare le carceri, che “ospitano” sempre almeno 5.000
detenuti in più del minimo vitale consentito per respirare, e perché la vita,
anche da prigionieri, non sia pura sopravvivenza in attesa dell’ultimo giorno.
Ma anche per favorire quella ricucitura, attraverso una sorta di patto tra il
reo e lo Stato, spesso più utile delle grida manzoniane e del pugno di ferro nei
confronti di chi quello strappo sociale ha prodotto. Su due punti precisi è
intervenuta la riforma, il potenziamento delle pene alternative al carcere per
condanne medio-basse e l’introduzione di una disciplina che regolamenti
la giustizia riparativa. Provvedimenti che dovrebbero stare a cuore anche a
coloro che vedono la pena solo in termini securitari, perché sono
statisticamente quelli che abbattono la recidiva.
È certo invece che
l’intervento ci sarà, e bisognerà vedere se la “manina” che avrà in mano il
bisturi sarà quella del Nordio-uno o del suo successore Nordio-due. Ma ci sarà.
Del resto bastava leggere la relazione allegata al testo del decreto, nel punto
in cui diceva che lo slittamento comporterà anche la possibilità di “analisi
delle nuove disposizioni normative, agevolando l’individuazione di prassi
applicative uniformi e utili a valorizzare i molti aspetti innovativi della
riforma”. Ci si domanda però, visto che neppure la stessa magistratura lo aveva
chiesto, perché il ministro abbia sentito la necessità di un rinvio della legge
in blocco e non abbia deciso di procedere in modo selettivo. Avrebbe potuto per
esempio isolare solo la parte di più complessa applicazione, come quella sulle
indagini preliminari. Se il motivo è politico, e se davvero nel nuovo governo
c’è il problema di prendere le distanze da quella che fino a ora è stata la
miglior guardasigilli, prevediamo tempi duri per il ministro Nordio-uno e l’
esordio del Nordio-due.
Possibile che dovremo
assistere a scivolamenti come quello di confondere l’incostituzionalità con la
criticità? Tra l’altro un ex procuratore non può non sapere che il differimento
di una riforma così attesa anche dagli avvocati comporterà anche un bel po’ di
confusione nelle aule di giustizia nelle prossime settimane. E ci saranno
centinaia di richieste di rinvio a raffica nei processi, da parte dei difensori
di imputati che avevano la speranza per esempio delle misure alternative o sulla
nuova causa di non punibilità per la tenuità del fatto, su cui la riforma è
intervenuta. E sarà quindi in grado il governo di confermare gli impegni presi
in sede di Pnrr con la certezza della riduzione del 25% della durata dei
processi entro il 2026? Perché occorre un impegno preciso e che abbia la forza
di realizzare quel che è la norma nei Paesi anglosassoni, il cui processo ha
ispirato la riforma nel 1989, sulle misure alternative al carcere, per ridurre i
tempi.
Resisteranno all’intervento
del bisturi della “manina” le quattro tipologie previste dalla riforma, cioè
la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e
le pene pecuniarie? Il ministro Nordio ha ricordato il fatto che la vittima per
esempio di un furto aggravato, uno dei reati per cui si prevede il passaggio
dalla procedibilità d’ufficio a quella su querela, si limita alla denuncia, non
sapendo di doversi anche querelare, magari anche solo contro ignoti. Ma la
riforma aveva fissato un tempo congruo perché tutti fossero informati del
cambiamento. Che cosa succederà adesso? Se nelle more di questi due mesi si
ascolteranno le trombe di chi ha definito la riforma
Cartabia una “salvaladri”, avremo ancora la speranza di ritrovare
quel Nordio-uno, quello che voleva avviare una grande campagna
di depenalizzazione, quello sensibile ai suicidi in carcere, quello in cui
avevamo riposto tante speranze, o via Arenula sarà occupata dagli amici
di Travaglio?
Tiziana Maiolo. Politica e
giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e
XIII legislatura.
Colpi di picconate alla
riforma Cartabia. Ira dei penalisti sul 4bis: “Sfregio alla Corte
Costituzionale”.
Angela Stella su Il Riformista l'1 Novembre 2022
Ieri il Consiglio dei
ministri ha approvato un decreto legge contenente, tra le altre, misure urgenti
in materia di ergastolo ostativo e rinvio dell’entrata in vigore della riforma
del processo penale al 30 dicembre. Due reazioni opposte da parte di
magistratura e avvocatura. Positiva da parte dell’Associazione Nazionale
Magistrati, negativa dall’Unione delle Camere Penali Italiane.
Giuseppe Santalucia, vertice
del sindacato delle toghe, ha infatti dichiarato: «Il ministro della Giustizia e
l’intero Governo hanno fortunatamente dato ascolto alle indicazioni della
magistratura associata in ordine all’opportunità di una disciplina transitoria
per importanti settori della recente riforma del processo penale. Il rinvio
dell’entrata in vigore del decreto attuativo si pone infatti come passaggio
necessario alla definizione della disciplina transitoria e – questione di non
minore rilievo – al riassetto organizzativo degli uffici giudiziari. Nel
rispetto del complessivo impianto della riforma, che contiene innovazioni
significative specie sul versante del sistema sanzionatorio, occorrerà ora
adoperarsi affinché il suo concreto avvio non soffra rallentamenti
interpretativi e non patisca ostacoli organizzativi», ha concluso Santalucia.
Per quanto concerne il fine
pena mai, lo stesso Santalucia all’Ansa ha detto: «Una normativa ci voleva,
credo che abbiano attinto a quella approvata da un ramo del Parlamento con
qualche modifica. Capisco l’urgenza perché l’8 novembre ci sarà l’udienza della
Corte costituzionale» e dunque «non mi sento di condividere il giudizio
tranchant degli avvocati penalisti. Sul merito non mi sento di esprimermi- ha
aggiunto-. Una disciplina comunque doveva esserci, ne discuteremo, ci sono 60
giorni di tempo per la conversione e se ci sarà da intervenire lo
faremo». Critiche invece dall’Unione delle Camere Penali Italiane che hanno
redatto un duro documento: «Le addotte (seppure del tutto genericamente)
difficoltà di ordine strutturale e logistico degli uffici giudiziari certamente
non possono riguardare tutta la parte della riforma dedicata al sistema
sanzionatorio e della esecuzione penale. La pretestuosa estensione anche a
questa importante parte della riforma di esigenze di natura organizzativa, qui
del tutto irrilevanti, autorizza la convinzione che detto ingiustificato rinvio
preluda ad una riscrittura di questa parte della riforma, attesa la sua evidente
incompatibilità con la fosca narrazione identitaria del ‘buttare la chiave’ che,
all’evidenza, vuole ispirare i primi passi del nuovo governo in tema di
giustizia penale».
Sulla questione dell’ergastolo
ostativo la Giunta dell’Ucpi ha scritto: «Il Parlamento è stato inadempiente, ed
ora la mera pendenza della udienza fissata dalla Corte per il prossimo 8
novembre non può certo tramutarsi in una ragione di urgenza, trattandosi di un
esito chiaro e noto sin dalla pronuncia della ordinanza, e già prorogato una
volta. Al contrario, con il pretesto della urgenza in realtà si punta a
sterilizzare la decisione della Corte, che peraltro si troverà comunque di
fronte ad un provvedimento di natura provvisoria perché in via di conversione».
Riguardo al merito della
norma, che ricalca sostanzialmente il testo approvato dalla Camera a marzo, i
penalisti sono entrati nel merito: «il d.l. propone un inammissibile
peggioramento -rispetto a quello già oggetto della valutazione di
incostituzionalità della Corte- del quadro normativo in tema di ostatività ed
accesso alle misure alternative alla detenzione. In tal modo si pone in essere
un inedito, gravissimo conflitto tra il legislatore ed il giudice delle leggi,
un vero atto di ribellione del primo verso il secondo, in spregio degli assetti
istituzionali e costituzionali che regolano quel rapporto. Inoltre, si opera una
inammissibile manipolazione informativa verso la pubblica opinione,
rappresentando le misure adottate come riferibili in via esclusiva all’ergastolo
ostativo e ai reati di mafia. le misure peggiorative introdotte riguardano tutti
i reati ostativi, a cominciare dai reati contro la pubblica amministrazione».
Sullo stesso piano il commento
dell’associazione Antigone: «La riforma approvata è un’occasione parzialmente
persa», ha detto il presidente Patrizio Gonnella, che ha proseguito: «Il governo
è rimasto imprigionato nella paura di fare un regalo alle mafie, innovando in
modo non sufficiente la legislazione penitenziaria. È mancato un generale
ripensamento dell’attuale disciplina della concessione dei benefici ai
condannati per una serie del tutto eterogenea ed illogica di reati anche ben
distanti da qualsiasi matrice organizzata, mafiosa o terroristica. Nel decreto
c’è finanche un inutile aggravamento di tale disciplina». E ha
concluso: «Vedremo se la Corte potrà dirsi soddisfatta. Ricordiamo che sul tema
si era espressa anche la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo (Viola c.
Italia) segnalando la necessità di un ripensamento dell’ergastolo ostativo. La
sicurezza del Paese non è a rischio se i giudici di sorveglianza, nell’esercizio
discrezionale delle loro funzioni, possono in casi ritenuti meritevoli favorire
percorsi di rientro controllato nella vita libera dopo decenni di carcere. Uno
Stato forte e autorevole non teme i propri giudici né deve auspicare la morte in
prigione di nessuno». Angela Stella
Carcere ostativo, le nuove
norme e a chi vanno applicate.
Egidio Lorito su Panorama l'1 Novembre 2022.
Nel primo decreto del Governo
Meloni approvata una norma contro i permessi per chi ha commesso reati molto
gravi, soprattutto legati alla criminalità organizzata
Con la pubblicazione del
decreto legge n. 162 del 31 ottobre su “ergastolo ostativo” e riforma dell’
“ordinamento penitenziario” , rinvio della “riforma Cartabia” , disciplina dei
c.d. “rave party” e nuovo articolo 434 bis del codice penale introduttivo del
reato di “invasione dei terreni o degli edifici per raduni pericolosi per
l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica o la salute pubblica” , è ufficialmente
iniziata l’attività del Governo Meloni. Ieri, infatti, attorno alle tredici, il
primo Consiglio dei Ministri ha visto la giustizia grande protagonista della
nuova era politica targata Giorgia Meloni: e la discussione più attesa è stata,
certamente, quella legata al mantenimento del c.d. “ergastolo ostativo” , ovvero
quel particolare tipo di regime penitenziario previsto dall’art. 4 bis del
relativo Ordinamento penitenziario che esclude in radice, dall’applicabilità dei
benefici penitenziari, chi si sia reso protagonista di reati di particolare
allarme sociale, ricompresi in un elenco riportato al primo comma della stessa
disposizione: ovvero di fattispecie in cui il reo, condannato, si rifiuti di
collaborare con la giustizia o di casi in cui la collaborazione stessa si riveli
del tutto irrilevante ai fini del ristabilimento dello “status quo ante”. In
pratica la permanenza dell’ergastolo ostativo vieta che il detenuto, condannato
per particolari e gravi fattispecie di reato, possa usufruire -ad esempio- di un
permesso premio come la semilibertà, salvo che lo stesso collabori con la
giustizia. Ricordiamo che nella disciplina ordinaria l’accesso al beneficio
della semilibertà, disciplinato dall’art. 50 dell’ordinamento penitenziario,
dispone che per i condannati all’ergastolo la concessione sia subordinata
all’aver già scontato 20 anni di pena. Chi riguarda l’istituto dell’ergastolo
ostativo La figura dell’ergastolo ostativo vede come destinatari chi ha ricevuto
la pena dell’ergastolo dopo essere stato giudicato colpevole di delitti di mafia
e terrorismo, così come di eversione dell’ordine democratico; ovvero di delitti
compiuti con atti di violenza, che hanno riguardato la pedopornografia, la
prostituzione minorile, la tratta di persone, la riduzione o il mantenimento in
schiavitù, la violenza sessuale di gruppo e il sequestro di persona a scopo di
estorsione. In queste particolari ipotesi, tutte caratterizzate dal particolare
allarme sociale, la pena viene scontata interamente all’interno dell’istituto
carcerario, caratterizzandosi per la sua natura di perpetuità: l’ergastolo, cioè
si trasforma nel c.d. “fine pena mai” , senza la possibilità che possa avere
effetto l’ipotetico ravvedimento del reo. Da punto di vista prettamente
penalistico il sistema in oggetto manifesta una particolare presunzione di
legge, ovvero quella assoluta della “pericolosità sociale” del detenuto, tratta
proprio dalla particolare gravità del reato commesso per il quale è stato
condannato. Tra i reati ricompresi al primo comma dell’art. 4 bis
dell’Ordinamento penitenziario risaltano, a titolo esemplificativo, quelli
commessi con violenza per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico, quelli di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), quelli delitti
commessi col metodo mafioso o per agevolare l'attività di tali associazioni e il
c.d. voto di scambio politico-mafioso. La procedura La procedura per la
concessione dei benefici penitenziari in parola ad un condannato alla pena
dell’ergastolo è piuttosto articolata: il giudice di sorveglianza dovrà
obbligatoriamente raccogliere una serie di pareri (quelli del pubblico ministero
naturale del processo, del Procuratore nazionale antimafia, vista la materia
afferente ai reati di mafia e terrorismo, e dello stesso istituto penitenziario
dove la persona è detenuta) e procedere a controlli anche delle condizioni
economiche del condannato nonché del suo nucleo familiare e dei suoi conoscenti.
La normativa prevede che nel caso in cui tali pareri e accertamenti non
dovessero arrivare nel termine di 90 giorni dalla richiesta, il giudice sarà in
ogni caso obbligato a prendere una decisione motivata. Inoltre la stessa la
Guardia di finanza sarà incaricata della “verifica della relativa posizione
fiscale, economica e patrimoniale” per come evidenziato. Oltre ai criteri
stringenti già elencati, il decreto legge n. 162/2022 ieri licenziato prevede
anche che le persone condannate all’ergastolo non possano accedere ai benefici
penitenziari prima di aver scontato almeno 30 anni di pena in carcere. In caso
di condanne inferiori all’ergastolo, andranno scontati comunque due terzi della
pena. Inoltre è previsto per chi decide di non collaborare che l’accesso alla
libertà condizionale e altri benefici sia limitato e arrivi solo dopo molto
tempo.
L’importanza della materia per
il governo Meloni Attualmente sarebbero circa 1200 i detenuti condannati alla
pena dell’ergastolo per reati di mafia e terrorismo a trovarsi sottoposti al
regime dell’ergastolo ostativo. Il decreto legge sull’ergastolo ostativo è
considerato dal governo Meloni “uno strumento essenziale” finalizzato a
contrastare la criminalità organizzata, in particolar modo “prioritario” e
“urgente” visto che il prossimo 8 novembre è in programma l’udienza innanzi alla
Corte costituzionale finalizzata alla trattazione delle questioni di legittimità
costituzionale afferenti le norme della disciplina. Non potrà sfuggire la
circostanza che il testo approdato innanzi a questo primo Consiglio dei Ministri
sia esattamente sovrapponibile al disegno di legge n. 2574 già approvato nella
passata legislatura (la XVIII, dunque): in pratica, ora come allora si mira ad
impedire la possibilità che i mafiosi possano essere scarcerati “facilmente” ,
consentendo cioè che usufruiscano di benefici penitenziari quei condannati che
abbiano dimostrato “una condotta risarcitoria” e “la cessazione dei loro
collegamenti” con la criminalità organizzata. Chiamato a questa prima prova del
fuoco, dunque, il Governo Meloni si è trovato innanzi ad una vera e propria
corsa ad ostacoli per assicurare, nella migliore tradizione, la tranquillità
sociale, impedendo che il mafioso condannato e detenuto possa lasciare il
carcere. L’intervento della Corte Costituzionale Un anno fa, la Consulta aveva
definito l'ergastolo ostativo “incompatibile” con gli articoli 3 e 27 della
Costituzione che regolano i principi di uguaglianza e di funzione rieducativa
della pena, e con il divieto di pene degradanti per come stabilito dalla
Convenzione europea dei diritti umani: i giudici costituzionali avevano, così,
sollecitato il Parlamento a intervenire sulla materia, fissando il termine
all’otto novembre del 2022. Dichiarando l’incostituzionalità dell’ergastolo
ostativo attraverso una ordinanza -che è atto non definitivo-, la Corte aveva
previsto quindi un arco di tempo affinché il legislatore intervenisse a
riformare l’istituto secondo le indicazioni dei giudici costituzionali, in modo
da organicizzare la disciplina all’ordinamento giuridico. Ecco spiegato perché
il governo ha inteso agire, a sua volta, con un’iniziativa urgente, ovvero il
decreto legge ieri licenziato
Ergastolo ostativo, Meloni
sfida la Consulta: niente benefici a chi non collabora.
Al primo Consiglio dei
ministri dell'era Meloni si punta alla conferma dell'ergastolo ostativo e al
rinvio della riforma Cartabia. Ma per Carlo Nordio, l'articolo 4 bis è
«un'eresia». Riuscirà a convincere la presidente a non smantellare lo Stato di
diritto? Simona Musco il 29 Ottobre 2022 su Il Dubbio.
Sull’ergastolo
ostativo Giorgia Meloni sfida la Consulta, con un decreto legge che prevede zero
benefici per chi non collabora. La presidente del Consiglio mette così il turbo,
portando a Palazzo Chigi un provvedimento che anticipa la decisione della Corte
costituzionale, che l’8 novembre deciderà sulla legittimità costituzionale
dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Secondo quanto appreso
dall’Ansa, l’esecutivo starebbe lavorando infatti a un provvedimento urgente che
porterebbe a una stretta dei «benefici penitenziari» con il «divieto di
concessione» per chi non collabora con la giustizia, oltre a introdurre una
proroga (probabilmente a fine anno) dell’entrata in vigore della riforma penale
che dovrebbe scattare dal 1 novembre.
Il decreto in Consiglio già
lunedì
Il decreto, ancora in via di
limatura e che sarà al vaglio del pre-consiglio lunedì mattina, potrebbe quindi
avere l’ok già lunedì, quando il Cdm dovrebbe riunirsi per la nomina di
viceministri e sottosegretari. Una mossa, dunque, che spazzerebbe via la
pronuncia della Consulta, che ad aprile dello scorso anno ha stabilito
l’illegittimità parziale della disciplina ostativa, in contrasto con gli
articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, laddove fa della collaborazione la sola via, per il
condannato, di recuperare la libertà.
Il giudice delle leggi aveva
concesso oltre un anno di tempo al Parlamento per adeguare le norme, con
«interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla
criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole
penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione
con la giustizia in questi casi». Ma finita la legislatura, le Camere hanno
lasciato il lavoro incompiuto, senza riuscire ad approvare una nuova disciplina
e lasciando la palla di nuovo in mano alla Consulta, che nel frattempo, scaduto
l’anno concesso al legislatore, ha rinviato ulteriormente la trattazione delle
questioni di legittimità dell’articolo 4 bis al prossimo 8 novembre.
FdI vuole smantellare
l’articolo 27 della Costituzione
Il testo che lunedì verrà
sottoposto al Consiglio dei ministri ricalca il disegno di legge n. 2574 già
approvato nella passata legislatura dalla Camera dei Deputati e punta a evitare
«le scarcerazioni facili dei mafiosi»: per accedere ai benefici penitenziari
sarà necessario dimostrare una condotta risarcitoria e la cessazione dei
collegamenti con la criminalità organizzata. «Una corsa contro il tempo – è il
ragionamento del governo – per garantire sicurezza sociale e impedire che ai
detenuti mafiosi possano aprirsi le porte del carcere pur in costanza del
vincolo associativo».
Il decreto legge pensato da
Meloni farebbe così il paio con la proposta di modifica dell’articolo 27 della
Costituzione già avanzata da FdI con il deputato Edmondo Cirielli, che lo scorso
13 ottobre ha depositato alla Camera una proposta di modifica costituzionale
finalizzata a «limitare la finalità rieducativa» e «salvaguardare e garantire il
concetto di “certezza della pena”». Un tentativo, quello di Cirielli, che parte
da lontano, ovvero dal 2013, con lo scopo di smantellare uno degli articoli
della Costituzione più importanti dal punto di vista dell’impianto dello Stato
di diritto, ma mai pienamente attuato.
Sul tema dell’ergastolo
ostativo Meloni è sempre stata chiara: modificare la norma, secondo la leader di
Fratelli d’Italia, significherebbe fare un favore ai mafiosi. Da qui la strenua
difesa di uno strumento, scriveva il 25 luglio ricordando il suo impegno per
Paolo Borsellino, che, «impedendo ai condannati per mafia non collaboranti di
ottenere qualsiasi beneficio di legge e sconto di pena, permette di perseguire
due obiettivi: da una parte incentivare i mafiosi a collaborare con la
giustizia; dall’altra impedire a coloro che non recidono i legami con il mondo
mafioso di ritornare, seppur parzialmente, in società».
Fratelli d’Italia aveva già
presentato due proposte di legge nella scorsa legislatura per ribadire il suo no
ai benefici per chi non collabora e «per salvare i principi ispiratori
dell’ergastolo ostativo e per impedire che chi non ha dato prova effettiva di
aver tagliato i propri ponti con la mafia possa tornare libero. Non possiamo
darla vinta a Totò Riina, che aveva messo proprio la cancellazione di questo
istituto tra i punti del famoso “papello” di richieste allo Stato per fermare le
stragi. Fratelli d’Italia si sta battendo anche per il mantenimento del carcere
duro, il 41 bis, che negli anni sta diventando sempre più un colabrodo. La mafia
continua a spingere per rendere più morbido il trattamento penitenziario dei
detenuti».
Meloni chiede “aiuto”
all’opposizione
Nel suo discorso alla Camera,
la presidente del Consiglio ha ribadito il concetto, chiedendo “aiuto” anche
all’opposizione. «Ci vogliamo lavorare insieme? – ha chiesto Meloni – Spero che
si possa lavorare insieme nei prossimi giorni per impedire che venga meno uno
degli istituti che sono stati più efficaci contro la mafia che è il carcere
ostativo. Spero che su questo ci si voglia dare una mano perché sono d’accordo:
la questione della lotta alla mafia non è un tema di retorica, è un tema che si
affronta con provvedimenti concreti».
Ma per Nordio si tratta di
«un’eresia»
Per Meloni si tratta però di
un terreno scivoloso, anche alla luce del dichiarato garantismo del neo ministro
della Giustizia Carlo Nordio, che sul tema delle carceri sembra pensarla in
maniera nettamente diversa rispetto alla leader che lo ha voluto a via Arenula:
per l’ex procuratore aggiunto di Venezia la pena non è, infatti, soltanto
carcere.
E nell’ultimo libro del
direttore del Foglio, Claudio Cerasa, l’ex toga aveva spiegato che «l’ergastolo
ostativo, il principio cioè che al reo non venga concessa la possibilità di
alcun beneficio, sia un’eresia contraria alla Costituzione. Bisogna strutturare
la legge in modo che l’ergastolo possa rimanere come principio ma bisogna anche
ricordarsi cosa dice l’articolo 27 della Costituzione: “Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato”. Spiace per chi a destra la pensa così, ma il
punto è evidente: il fine pena mai non è compatibile, al fondo, con il nostro
Stato di diritto». Riuscirà il ministro della Giustizia a convincere la
presidente del Consiglio a non smantellarlo?
Gli altri due punti all’ordine
del giorno
Sempre sul tema della
giustizia, lunedì verrà affrontato il rinvio al 30 dicembre 2022 dell’entrata in
vigore di alcune disposizioni della “Riforma Cartabia”, raccogliendo dunque
l’appello lanciato dai procuratori generali di tutta Italia con una lettera
indirizzata al ministro Nordio. Il provvedimento intende rispettare le scadenze
del Pnrr e consentire la necessaria organizzazione degli uffici giudiziari.
Il terzo punto, infine,
l’anticipo al 1 novembre 2022 della scadenza dell’obbligo vaccinale per chi
esercita la professione sanitaria e la conseguente abrogazione delle sanzioni
per l’inosservanza dell`obbligo. «L’obiettivo – è il ragionamento – è dare
seguito all’indicazione tracciata dal presidente Meloni nelle sue dichiarazioni
programmatiche rese in Parlamento e segnare così un primo atto di discontinuità,
rispetto ai precedenti esecutivi, nella gestione della pandemia da Covid-19».
Carcere, l’appello di
Woodcock: «Non assecondiamo chi vuole buttare la chiave».
Il magistrato napoletano: «Si
recuperi il principio di residualità dell'azione penale». Simona Musco Simona
Musco il 29 Ottobre 2022 su Il Dubbio.
«Spesso per il pubblico
ministero è più facile e meno impegnativo chiedere il rinvio a giudizio
dell’indagato, piuttosto che articolare una ben argomentata richiesta di
archiviazione, e per il giudice è altrettanto meno impegnativo disporre il
rinvio a giudizio, piuttosto che redigere una sentenza di non luogo a
procedere».
Difficile immaginare che a
dire queste parole sia proprio un pubblico ministero. Specie se il magistrato in
questione è uno dei più in vista, come Henry John Woodcock, sostituto
procuratore presso la Dda di Napoli e candidato da indipendente alle ultime
elezioni del Csm.
Un’autocritica che conferma
uno dei rimproveri più volte rivolti dai “garantisti” alla magistratura, ovvero
quello di “innamorarsi” delle proprie inchieste, al punto da non poter fare un
passo indietro. E se non si tratta di amore, stando all’intervento di Woodcock
sul Corriere del Mezzogiorno, l’alternativa è che si tratti di vera e propria
pigrizia.
Per il magistrato napoletano,
i problemi del sistema non sono legati ai tempi elefantiaci della giustizia –
che pure ci sono –, quanto al numero di processi celebrati. Ce ne sono troppi,
spesso per fatti «di modestissima rilevanza penale», e sono tanti anche «quelli
che si celebrano – bisogna autocriticamente ammetterlo – anche per fatti in
ordine ai quali il pubblico ministero non avrebbe dovuto a monte promuovere
l’azione penale, o per i quali il Giudice dell’udienza preliminare, a valle, non
avrebbe dovuto disporre il rinvio a giudizio».
Sì alla depenalizzazione
Un concetto fortissimo che
rappresenta anche un’apertura nei confronti di quelle che sono le dichiarate
intenzioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ovvero una forte
depenalizzazione, nei confronti della quale ha mostrato apprezzamento anche il
presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia.
E anche secondo il magistrato
del caso Consip, «solo l’effettivo e concreto recupero del principio di
residualità della sanzione penale (attraverso una drastica depenalizzazione),
unito alla acquisizione da parte del giudice dell’udienza preliminare della
piena consapevolezza della propria funzione di “sbarramento” rispetto a processi
inutili, consentirà al nostro sistema penale di fare davvero un passo avanti».
Parole che confermano un sospetto: quello di un appiattimento del gup – e prima
di lui anche del gip – sulle ragioni dell’accusa.
«Le carceri sono disumane»
Ma nel Woodcock-pensiero
rientra anche un altro aspetto, molto caro al ministro Nordio: la situazione
delle carceri. «Parlo delle condizioni in cui si trovano attualmente i detenuti
– scrive il magistrato -, condizioni che, in molti casi, non esiterei a definire
“disumane”, o comunque assai lontane da quegli obiettivi che la stessa
Costituzione assegna alla sanzione penale».
Il problema è sì legato
all’edilizia carceraria, ma è ben più «drammatico» il dato che riguarda il
sovraffollamento, «legato ad un eccessivo tasso di carcerazione, che interessa
tradizionalmente soprattutto soggetti provenienti, tanto per usare un eufemismo,
dalle fasce sociali più sfavorite». Insomma, un uso eccessivo della custodia
cautelare che colpisce soprattutto i più deboli. Nordio, da promotore dei
referendum sulla «giustizia giusta» si è schierato in favore di una limitazione
di tale strumento. Ma sul punto la presidente del Consiglio ha già chiarito di
non essere disposta a concedere deroghe.
E mentre per il ministro il
carcere non è l’unica pena possibile, nelle fila di FdI si lavora ad
una modifica dell’articolo 27 della Costituzione, con lo scopo di «limitare la
finalità rieducativa» e «salvaguardare e garantire il concetto di “certezza
della pena”». Ora a confermare che la strada da seguire è un’altra è anche
Woodcock, con la speranza che Nordio «voglia inserire nella sua agenda il tema
delle carceri immediatamente, conferendo a tale tema assoluta priorità, cercando
a tale riguardo di resistere il più possibile alle pur prevedibili controspinte
che su tale argomento verranno da quella parte dell’elettorato di centrodestra
che ritiene che basti “buttar le chiavi” per risolvere qualunque problema».
Alfredo Cospito: un
anarchico detenuto al 41 bis come i mafiosi.
Valeria Casolaro su
L'Indipendente il 26 ottobre 2022.
Nella mattina di martedì 25
ottobre un gruppo di anarchici ha occupato la sede di Amnesty International di
Roma per mostrare solidarietà ad Alfredo Cospito, anarchico detenuto in Sardegna
in regime di 41 bis a causa delle relazioni epistolari che intratteneva con
altri anarchici e con riviste affini. Cospito si trova in carcere da dieci anni
con l’accusa di strage contro la pubblica incolumità per aver piazzato, nel
2006, due ordigni a basso potenziale presso la Scuola Allievi Carabinieri di
Fossano (Cuneo), la cui esplosione non ha causato vittime. Lo scorso luglio,
tuttavia, la Cassazione ha riformulato il capo d’imputazione a suo carico,
accusando ora l’anarchico di strage contro la sicurezza dello Stato (art. 285
del codice penale), reato che prevede l’ergastolo, anche ostativo (il cosiddetto
“fine pena mai”), pur in assenza di vittime. Per intendersi, quella della strage
contro la sicurezza dello Stato, è una aggravante che non è stata contestata
nemmeno agli autori degli attacchi che uccisero i giudici Falcone e Borsellino.
Il 20 ottobre scorso Cospito ha iniziato uno sciopero della fame in segno di
protesta conto il regime detentivo al quale è stato sottoposto e contro
l’ergastolo ostativo.
Il regime del 41bis, ovvero il
cosiddetto “carcere duro”, pensato per costituire uno strumento di contrasto
alla criminalità organizzata, è stato introdotto nel 1992 in coincidenza con il
periodo di massima diffusione delle stragi mafiose. Ai soggetti che si trovano
in tale regime detentivo vengono applicate una serie di restrizioni volte
a impedire il contatto con esponenti della criminalità organizzata all’esterno
del carcere: una delle condizioni perché venga applicato, oltre alla commissione
di uno dei delitti “di mafia”, è la comprovata presenza di “elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale,
terroristica ed eversiva”. A motivare l’applicazione di tale regime detentivo
per Cospito sono le relazioni epistolari che questi ha intrattenuto, nei dieci
anni già trascorsi in carcere, con anarchici e riviste del medesimo orientamento
politico, attività mai nascosta alle autorità carcerarie ma che gli è valsa
comunque almeno tre iniziative giudiziarie per il reato di istigazione a
delinquere. La decisione di sospendere all’improvviso le garanzie che gli erano
state concordate, dunque, appare «ingiustificata» secondo il suo avvocato,
Flavio Rossi Albertini, il quale ha sottolineato come tale deliberazione sembri
voler impedire all’anarchico di continuare a «esternare il proprio pensiero
politico». Appare deducibile, come sottolineato dallo stesso Albertini in
un’intervista, che i giudici torinesi abbiano qualificato la Fai (Federazione
anarchica informale), della quale Cospito è stato riconosciuto far parte, «come
una vera e propria organizzazione».
A queste considerazioni va
aggiunto il fatto che la fattispecie di reato recentemente contestata a Cospito
(strage contro la sicurezza dello Stato) costituisce una delle più gravi del
nostro ordinamento e, come accennato, non vi è stato fatto ricorso nemmeno nel
caso delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, nelle quali la mafia uccise prima
Giovanni Falcone e la moglie e poi Paolo Borsellino, insieme agli agenti delle
rispettive scorte.
“Alfredo si trova in carcere
ininterrottamente da dieci anni, trascorsi nelle sezioni di Alta Sicurezza fino
al trasferimento in 41 bis. Nel 2016 è stato coinvolto nell’operazione Scripta
Manent, accusato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo e di
molteplici attacchi esplosivi. A seguito della sentenza di Cassazione del luglio
di quest’anno, è stata riformulata la condanna per lo stesso Alfredo e per Anna
Beniamino in ‘strage politica’, la cui unica pena prevista è l’ergastolo. Lo
Stato italiano che ha sempre protetto gli stragisti fascisti ora vuole
condannare per strage due anarchici per un attacco che non ha provocato né
vittime né feriti” scrivono in un comunicato alcuni anarchici. “Vogliamo che si
comprenda anche all’estero che la china repressiva che sta prendendo lo
Stato italiano riguarda tutti in prima persona, dato che un precedente di queste
dimensioni nel cuore dell’Europa potrebbe essere foriero di ulteriori balzi
repressivi anche ad altre latitudini”. [di Valeria Casolaro]
Storia di Alfredo,
l’anarchico al 41-bis: un atto totalmente fuori legge.
Luigi Manconi su Il Riformista il 26 Ottobre 2022
Caro Direttore,
la letteratura sul 41-bis si
fa via via sempre più nutrita, assumendo i connotati del genere horror. Emerge
un interrogativo: esiste un limite all’esecuzione della pena e alla sua
afflittività? Viene da chiederselo ripercorrendo la vicenda di Alfredo
Cospito, che ha intrapreso lo sciopero della fame all’interno della casa
circondariale di Bancali, a Sassari, per denunciare le condizioni cui si trova
costretto dal regime di 41-bis al quale è sottoposto dall’aprile scorso, dopo
sei anni in Alta Sicurezza. Cospito è un anarchico condannato per strage perché
così prevede il dispositivo del reato, anche se l’attentato in questione non ha
provocato conseguenze letali.
Nella notte tra il 2 e il 3
giugno del 2006, alla scuola Allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo), esplodono
due pacchi bomba a basso potenziale che non determinano morti, feriti o danni
gravi. Per questo, la Corte d’Assise d’Appello ha qualificato il fatto come
strage (art. 422 del Codice penale): delitto contro la pubblica incolumità, che
prevede una pena non inferiore ai 15 anni. Successivamente, nel luglio scorso,
la Cassazione ha modificato l’imputazione nel ben più grave delitto (contro la
personalità interna dello Stato) di strage, volta ad attentare alla sicurezza
dello Stato (art. 285 del Codice penale), condannando Alfredo Cospito e Anna
Beniamino all’ergastolo.
Il verdetto è palesemente
abnorme, tanto più se si considera che non si è fatto ricorso a quella
fattispecie penale – come ricorda Damiano Aliprandi sul Dubbio – nemmeno nei
casi di attentati quale quello di Capaci, che ha provocato la morte di Giovanni
Falcone, di sua moglie e degli uomini della scorta, e quello di via D’Amelio
contro Paolo Borsellino. Tuttavia, nell’immediato, tenuto conto dell’azione non
violenta intrapresa da Cospito l’attenzione va concentrata sulle sue condizioni
di reclusione. Fino all’aprile scorso, pur sottoposto al regime di Alta
Sicurezza, il detenuto poteva comunicare con l’esterno, inviare scritti e
articoli e così partecipare al dibattito della sua area politica, contribuire
alla realizzazione di due libri, scrivere e ricevere corrispondenza. Poi tutto è
cambiato.
Da sette mesi le lettere in
entrata vengono trattenute e questo, di conseguenza, induce il detenuto a
limitare e ad autocensurare le proprie. Le ore d’aria sono ridotte a due,
interamente trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadrati;
la “socialità” è limitata a un’ora al giorno, da passare con tre detenuti. In
realtà, con uno soltanto, dal momento che un secondo si trova in isolamento
diurno e un altro ormai non esce più dalla propria cella.
La conseguenza di tutto ciò è
un sistema di vera e propria deprivazione sensoriale: il perimetro dello spazio
destinato all’ora d’aria è delimitato da muri alti che interdicono lo sguardo, e
la visione del cielo è filtrata da una rete di metallo. «La mancanza di
profondità visiva incide sulla funzionalità del senso della vista – scrivono gli
avvocati Rossi Albertini e Pintus – e la mancanza di sole limita l’assunzione
della vitamina D».
Lo stato di deprivazione
sensoriale viene in genere scarsamente considerato, eppure è una delle più
efferate conseguenze della natura nociva e patogena del carcere; oltre
alle condizioni igienico-sanitarie spesso degradanti. La limitazione dei
movimenti e gli orari imposti d’autorità, l’impossibilità di avere scambi e
rapporti liberi, la determinazione dall’esterno dei ritmi quotidiani di vita e
il controllo sugli spazi più intimi: tutto ciò produce una “postura del
carcerato” che finisce inevitabilmente con l’ottundere e deprimere la
personalità.
Si tratta, in tutta evidenza,
di una condizione totalmente illegale e di uno stravolgimento della lettera e
del senso della legge che affida al regime di 41-bis il solo ed esclusivo scopo
di impedire i legami tra il recluso e l’organizzazione criminale esterna alla
quale apparterrebbe. Tutto ciò che eccede tale finalità è fuori legge. Che cosa
ha a che vedere, infatti, con la ratio della norma il blocco della
corrispondenza o quella miserabile apparenza di ora d’aria e di “socialità”?
Luigi Manconi
Articolo 41-bis.
Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera.
L'articolo 41-bis è una
disposizione dell'ordinamento penitenziario italiano introdotta dalla legge 10
ottobre 1986, n. 663, che prevede un particolare regime carcerario.
Storia.
La disposizione venne
introdotta dalla cosiddetta legge Gozzini, che modificò la legge 26 luglio 1975,
n. 354, ed era in origine applicabile solo a casi di emergenza interne alle
carceri, secondo il testo: "In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi
situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere
nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole
di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere
motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata
strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto". In seguito nel
1992, dopo la strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone,
all'articolo si aggiunse un secondo comma disposto con il decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306 (cosiddetto Decreto antimafia Martelli-Scotti), convertito nella
legge 7 agosto 1992, n. 356. Con la nuova disposizione, in presenza di "gravi
motivi di ordine e di sicurezza pubblica", si consentiva al Ministro della
Giustizia di sospendere le garanzie e gli istituti dell'ordinamento
penitenziario, per applicare "le restrizioni necessarie" nei confronti dei
detenuti per mafia, con l'obiettivo di impedire il passaggio di ordini e
comunicazioni tra i criminali in carcere e le loro organizzazioni sul
territorio.
La misura aveva quindi
carattere temporaneo, infatti la sua efficacia era limitata a un periodo di tre
anni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Tuttavia, fu prorogata
una prima volta fino al 31 dicembre 1999, una seconda volta fino al 31 dicembre
2000 e una terza volta fino al 31 dicembre 2002. Il 24 maggio 2002 il Governo
Berlusconi II deliberò un disegno di legge di modifica degli articoli 4-bis e
41-bis dell'ordinamento penitenziario, poi approvato dal Parlamento come Legge
23 dicembre 2002, n. 279 (Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario), abrogando la
norma che sanciva il carattere temporaneo di tale disciplina e prevedendo che il
provvedimento ministeriale non potesse essere inferiore a un anno né superare i
due anni, con eventuali proroghe successive di solo un anno ciascuna. Inoltre,
il regime di carcere duro venne esteso anche ai condannati per terrorismo ed
eversione. La legge 15 luglio 2009, n. 94 ne ha cambiato di nuovo i limiti
temporali, tuttora in vigore: il provvedimento può durare quattro anni e le
proroghe due anni ciascuna. Secondo le nuove regole i detenuti possono
incontrare senza vetro divisore i parenti di primo grado inferiori a 12 anni di
età, ma resta il divieto alla detenzione di libri e giornali, tranne particolari
autorizzazioni.
Caratteristiche.
La norma prevede la
possibilità per il ministro della Giustizia di sospendere l'applicazione delle
normali regole di trattamento dei detenuti previste dalla legge in casi
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza per alcuni
detenuti (anche in attesa di giudizio) incarcerati per reati di criminalità
organizzata, terrorismo, eversione e altri tipi di reato.
Il comma 2-quater dell'art.
41- bis prevede che «i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione»
siano «ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati,
collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di
sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto…». In tal
modo è stata recepita dalla legge - e, soprattutto, resa assolutamente
inderogabile - la prassi seguita in linea di massima dall'Amministrazione
penitenziaria, sin dai primi anni novanta, di allocare in apposite e selezionate
strutture penitenziarie i detenuti in questione.
Soggetti destinatari.
Il regime si applica a singoli
detenuti ed è volto a ostacolare le comunicazioni degli stessi con
le organizzazioni criminali operanti all'esterno, i contatti tra appartenenti a
una stessa organizzazione all'interno di un carcere e i contatti tra gli
appartenenti a diverse organizzazioni criminali, così da evitare il verificarsi
di delitti e garantire la sicurezza e l'ordine pubblico anche fuori dalle
carceri.
Misure applicabili.
La legge specifica le misure
applicabili:
Isolamento nei confronti degli
altri detenuti. Il detenuto è situato in una camera di pernottamento singola e
non ha accesso a spazi comuni del carcere
L’ora d’aria è limitata
(concessa solamente per alcune tipologie di reato) - rispetto ai detenuti comuni
- a due ore al giorno e avviene anch'essa in isolamento.
Il detenuto è costantemente
sorvegliato da un reparto speciale del corpo di polizia penitenziaria il quale,
a sua volta, non entra in contatto con gli altri poliziotti penitenziari.
Limitazione dei colloqui con i
familiari (anch’essi concessi solamente per alcune tipologie di reato) per
quantità (massimo uno al mese della durata di un'ora) e per qualità (il contatto
fisico è impedito da un vetro divisorio a tutta altezza). Solo per coloro che
non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del
direttore dell'istituto, un colloquio telefonico mensile con i familiari e
conviventi della durata massima di dieci minuti.
Nel caso di colloqui con
l’avvocato difensore i colloqui non hanno limitazioni in ordine di numero e
durata.
Visto di controllo della posta
in uscita e in entrata.
Limitazione delle somme, dei
beni e degli oggetti che possono essere tenuti nelle camere di pernottamento
(penne, quaderni, bottiglie, ecc.) e anche negli oggetti che possono essere
ricevuti dall'esterno.
Esclusione dalle
rappresentanze dei detenuti e degli internati.
La Corte di cassazione, con
ripetute sentenze, ha riconosciuto la legittimità della circolare del 2011 e
della regolamentazione che essa prevede.
Delitti puniti
Il "carcere duro" è
applicabile per taluno dei delitti indicati dall'articolo 41-bis della legge
penitenziaria:
delitti commessi per finalità
di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico
mediante il compimento di atti di violenza;
delitto di associazione per
delinquere di tipo mafioso;
delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dall'associazione mafiosa ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni mafiose;
delitto di riduzione o
mantenimento in schiavitù o in servitù;
prostituzione minorile,
consistente nell'indurre alla prostituzione una persona di età inferiore agli
anni diciotto ovvero nel favorirne o sfruttarne la prostituzione;
delitto di chi, utilizzando
minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce
materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad
esibizioni pornografiche e chi fa commercio del materiale pornografico predetto;
delitto di tratta di persone;
delitto di acquisto e
alienazione di schiavi;
delitto di violenza sessuale
di gruppo;
delitto di sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione;
delitto di associazione per
delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
delitto di associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Casi di revoca del regime
Il tribunale di
sorveglianza ha revocato l'applicazione della misura nei confronti di Michele
Aiello, posto ai domiciliari in quanto sofferente di favismo, e a Antonino
Troia.[5]. In entrambi i casi la presidente dell'Associazione familiari delle
vittime della strage di via dei Georgofili Giovanna Maggiani Chelli ha
contestato la decisione.
Critiche
Le reazioni internazionali
Nel 1995 il Comitato europeo
per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti (C.P.T.) ha visitato le carceri italiane per verificare le condizioni
di detenzione dei soggetti sottoposti al regime ex art. 41-bis. Ad avviso della
delegazione, questa particolare fattispecie di regime detentivo era risultato il
più duro tra tutti quelli presi in considerazione durante la visita ispettiva.
La delegazione intravedeva nelle restrizioni gli estremi per definire i
trattamenti come inumani e degradanti. I detenuti erano privati di tutti i
programmi di attività e si trovavano, essenzialmente, tagliati fuori dal mondo
esterno. La durata prolungata delle restrizioni provocava effetti dannosi che si
traducevano in alterazioni delle facoltà sociali e mentali, spesso
irreversibili.
Negli anni 2000 Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo è stata varie volte chiamata a pronunciarsi sulla
compatibilità del 41-bis con la Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e non ha ritenuto la disciplina,
in linea di principio, in contrasto con la suddetta Convenzione, ma ne ha
censurato singoli contenuti e aspetti attuativi
Nel 2003 Amnesty
International ha sostenuto che il 41-bis equivale, in alcuni casi, a un
trattamento del prigioniero "crudele, inumano e degradante".
Nel 2007 un giudice
degli Stati Uniti ha negato l'estradizione del boss mafioso Rosario Gambino,
poiché a suo avviso il 41-bis sarebbe assimilabile alla tortura.
I rilievi di costituzionalità
Il regime di 41-bis applicato
per periodi molto lunghi, anche a persone non condannate in via definitiva, è
ritenuto da alcuni giuristi come incostituzionale, ma finora le pronunce
della Corte costituzionale ne hanno confermato, nell'insieme, la legittimità.
Nonostante ciò, nelle sentenze
del 28 luglio 1993 n. 349, del 19 luglio 1994 n. 357, del 18 ottobre 1996,
n. 351, e ancora con la sentenza n. 376 del 1997, la Corte Costituzionale si è
espressa sulla compatibilità del regime 41-bis con i principi costituzionali.
Già nella prima di queste sentenze, in riferimento alla funzione di rieducazione
della pena, sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, la Corte ha
rilevato come ai detenuti venissero riservati "trattamenti penali contrari al
senso di umanità, non ispirati a finalità rieducativa ed, in particolare, non
'individualizzati' ma rivolti indiscriminatamente nei confronti di reclusi
selezionati solo in base al titolo di reato".
Nel 2013 la Corte
costituzionale ha inoltre dichiarato illegittime le limitazioni in materia di
colloqui con l'avvocato difensore.
Le strutture in Italia
In data 5
novembre 2009 il Ministro della giustizia Angelino Alfano ha reso pubblica la
decisione del governo di riaprire le carceri di Pianosa e dell'Asinara,
penitenziari nei quali sono stati storicamente detenuti i boss mafiosi in
applicazione di tale misura.[21] Il ministro dell'ambiente Prestigiacomo ha
detto che il carcere di Pianosa non riaprirà per motivi ambientali ma si
studieranno soluzioni alternative.[22]
Tra le carceri italiane non
sono più dotate di strutture idonee il Carcere dell'Asinara di Porto
Torres (SS), il Carcere di Pianosa di Campo nell'Elba (LI) e il Carcere delle
Murate di Firenze (FI), mentre quelle presenti sono ripartite sul territorio
come segue.
Abruzzo
Casa Circondariale
dell'Aquila (AQ) (carcere più duro e con più detenuti, e l'unico dotato di
sezione femminile
Campania
Casa Circondariale
di Secondigliano di Napoli (NA)
Casa
Circondariale di Poggioreale di Napoli (NA)
Emilia-Romagna
Casa Circondariale
di Parma (PR)
Friuli-Venezia Giulia
Casa Circondariale
di Tolmezzo (UD)
Lazio
Casa
Circondariale di Rebibbia di Roma (RM)
Casa Circondariale
di Viterbo (VT)
Casa Circondariale
di Latina (LT)
Lombardia
Casa
Circondariale di Opera di Milano (MI)
Casa Circondariale
di Voghera (PV)
Marche
Casa Circondariale di Ascoli
Piceno (AP)
Piemonte
Casa Circondariale
di Cuneo (CN)
Casa Circondariale
di Novara (NO)
Sardegna
Casa Circondariale di Badu 'e
Carros di Nuoro (NU)
Casa Circondariale
di Bancali (SS)
Casa Circondariale
di Macomer (NU)
Casa Circondariale
di Massama (OR)
Casa Circondariale
di Mamone a Onanì (NU)
Casa Circondariale di Uta (CA)
Umbria
Casa Circondariale
di Spoleto (PG)
Casa Circondariale
di Terni (TR)
Veneto
Casa
Circondariale di Vicenza (VI)
Articolo 4 bis Legge
sull'ordinamento penitenziario
(L. 26 luglio 1975, n. 354) Da
Brocardi.it
Divieto di concessione dei
benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni
delitti
Dispositivo dell'art. 4 bis
Legge sull'ordinamento penitenziario
1. L'assegnazione al lavoro
all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste
dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai
detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58 ter della
presente legge o a norma dell'articolo 323 bis, secondo comma, del codice
penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza,
delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319
ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 416 bis e 416 ter del
codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo
stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in
esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600 bis, primo comma, 600 ter,
primo e secondo comma, 601, 602, 609 octies e 630 del codice penale,
all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le
disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni(1)(2).
1-bis. I benefici di cui al
comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi
previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì
nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella
sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle
responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la
collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei
confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il
risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna,
dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al
comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata,
terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 575, 600 bis, secondo e terzo comma, 600 ter, terzo comma, 600
quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e
terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del
codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609
bis, 609 quater e 609 octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3,
3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al
comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui
agli articoli 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609
bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies del codice
penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della
personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la
partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della
presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in
ordine al delitto previsto dall'articolo 609 bis del codice penale salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata(3).
1-quinquies. Salvo quanto
previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e
internati per i delitti di cui agli articoli 583 quinquies, 600 bis, 600 ter,
anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater
1, 600 quinquies, 609 quater, 609 quinquies e 609 undecies del codice penale,
nonché agli articoli 609 bis e 609 octies del medesimo codice, se commessi in
danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione
specifica di cui all'articolo 13 bis della presente legge(4).
2. Ai fini della concessione
dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in
relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato
provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto
penitenziario in cui il condannato è detenuto.
2-bis. Ai fini della
concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o
il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal
questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta
delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene
che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o
extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è
prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al
lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per
delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore
distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.
Note
(1) La Corte Costituzionale,
con sentenza 22 ottobre 2014, n. 239 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo, comma 1, "nella parte in cui non esclude
dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la
misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47
quinquies della medesima legge".
Ha inoltre dichiarato, in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale del presente articolo, comma 1, "nella parte in cui non esclude
dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la
misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 ter, comma 1, lettere
a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell'insussistenza
di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti".
(2) La Corte Costituzionale,
con sentenza 23 ottobre - 4 dicembre 2019, n. 253 (in G.U. 1ª s.s. 11/12/2019,
n. 50), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in
cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del
codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo
stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in
esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di
collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin.
penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia
l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del
ripristino di tali collegamenti".
Ha inoltre dichiarato "in via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del
1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi
contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da quelli
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere
concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a
norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati
acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino
di tali collegamenti".
(3) Tale comma è stato
modificato dall'art. 12 comma 5 lettera a) della Legge 19 luglio 2019, n. 69.
(4) Tale comma è stato
modificato dall'art. 12 comma 5 lettera b) della Legge 19 luglio 2019, n. 69.
Ecco le differenze tra 4
bis e 41 bis.
Giovanni Brusca è all’ergastolo ordinario. In questi giorni si fa
anche confusione con il 41 bis, il cosiddetto carcere duro, che prevede regole
più restrittive per la detenzione. Damiano Aliprandi su Il Dubbio l’11 ottobre
2019.
Due sono gli ergastoli, quello
“ordinario” e quello “ostativo”.
Quest’ultimo è una tipologia
di pena nata dal combinato disposto tra la norma codicistica, che contempla
l’ergastolo ordinario e la norma del 4 bis dell’ordinamento penitenziario
introdotta dal decreto emanato dopo la strage di Via Capaci. Per i delitti
“ostativi” indicati nel 4 bis, l’eventuale condanna all’ergastolo non consente,
in assenza della collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art.58- ter.,
l’accesso ai benefici penitenziari.
Ad esempio c’è Giovanni
Brusca, conosciuto per aver trucidato 200 persone e ordinato di sciogliere un
bambino nell’acido (Giuseppe Di Matteo), che – avvalendosi della collaborazione
– sta scontando un ergastolo ordinario accedendo ai benefici della pena (
permessi premio, etc) e uscirà tra un anno e mezzo.
Mentre altri detenuti
ergastolani, anche per aver ucciso una sola persona (di solito di una cosca
rivale), se non collaborano con la giustizia – nonostante abbiano intrapreso un
percorso trattamentale e critico verso il passato – sono condannati ad una pena
perpetua e senza alcuna possibilità di accedere a misure alternative.
In questi giorni si fa anche
confusione con il 41 bis, il cosiddetto carcere duro, che prevede regole più
restrittive per la detenzione onde evitare che il boss veicoli messaggi
all’organizzazione di appartenenza. Non c’entra con l’ergastolo, così come non
c’entra nulla con la sentenza Cedu e con la decisione che dovrà prendere la
Corte costituzionale il 22 ottobre.
La Corte europea ha
semplicemente sentenziato, per quanto riguarda gli ergastolani ostativi, che la
legge debba prevedere, dopo un congruo numero di anni, che il giudice possa
stabilire – anche in assenza di collaborazione – se la persona che sta eseguendo
una condanna all’ergastolo rappresenti ancora un pericolo per la società esterna
e abbia o meno ancora legami criminali.
Nessun automatismo concessivo,
quindi, ma soltanto la possibilità di valutare la persona, senza inchiodarla al
reato commesso 25 o 30 anni prima.
Roberto Cota per "Libero
Quotidiano" il 27 gennaio 2022.
La Corte Costituzionale ha
dichiarato illegittima la norma che prevede la censura della corrispondenza tra
cliente detenuto in regime di 41 bis e avvocato. La questione di
costituzionalità, peraltro, era stata sollevata dalla Corte di Cassazione.
Il Giudice delle leggi ha
osservato in sentenza come l'esercizio del diritto di difesa comprende il
diritto di comunicare in modo riservato con i propri difensori. Tale diritto
spetta a chi è recluso in carcere ed anche a chi è in regime di 41 bis. Direi
tutto normale.
L'anomalia era la limitazione
precedentemente in essere, assolutamente non in linea con uno dei principi
cardine dello stato di diritto. Inoltre, la Corte Costituzionale ha sostenuto
che la tesi contraria rappresenterebbe "una generale ed insostenibile
presunzione di collusione del difensore dell'imputato".
Senonché, nel successivo
dibattito è intervenuto Il Fatto Quotidiano che con un titolo ad effetto ha così
dato la notizia della decisione: "La Consulta cancella la censura della
corrispondenza tra i detenuti al 41 bis e gli avvocati. Geniale: così i boss
potranno ordinare omicidi e stragi".
Oltre a sposare la tesi
secondo la quale chi è in regime di 41 bis non deve avere neppure il diritto di
difendersi, il giornale di Travaglio, nella sostanza, qualifica tutti gli
avvocati come mafiosi.
I sostenitori della campagna
giustizialista e manettara utilizzano adesso un nuovo argomento: quello di
confondere l'avvocato con il cliente. Se l'avvocato difende un mafioso è un
mafioso. Lo schema delegittimante, purtroppo, è quello tipico dei sistemi
antidemocratici, dove la figura del difensore viene relegata ad inutile e
fastidioso orpello.
La Giunta delle Camere Penali
ha giustamente reagito, ma questa tendenza sta prendendo piede, non soltanto
sulle pagine de Il Fatto e non sempre può arrivare la Corte Costituzionale a
sistemare le cose.
Il recente caso Pittelli è
emblematico. Pittelli, avvocato ed ex parlamentare, è in carcere perché accusato
di aver concorso, nel difendere dei clienti appartenenti alla ndrangheta, nei
reati dei propri assistiti.
La materia è delicata, ma il
problema del perimetro del lavoro del difensore va affrontato e non lasciato al
caso. La politica, come al solito, ha la tendenza a non occuparsi delle
questioni, soprattutto quelle spinose.
Il rapporto professionale
avvocato-cliente dovrebbe essere rispettato e tutelato perché siamo in un paese
democratico dove i diritti fondamentali hanno ancora un senso. Nei mesi scorsi
c'è stata una sacrosanta mobilitazione per chiedere all'Egitto il rispetto dei
diritti umani nel caso Zaki: da noi è tutto a posto?
La testimonianza. Falcone e
Borsellino non sono i padri dell’ergastolo ostativo: in cella da 33 anni difendo
la loro memoria.
Claudio Conte su Il Riformista il 17 Giugno 2022.
Nonostante io sia in carcere
ininterrottamente da quasi 33 anni non mi addolora l’ulteriore rinvio della
Corte costituzionale che sospende fino all’8 novembre 2022 gli effetti della sua
ordinanza del 2021 sull’illegittimità dell’articolo 4-bis dell’Ordinamento
Penitenziario in relazione alla liberazione condizionale. Non che io sia
d’accordo sul dare altro tempo al legislatore per una riforma che, dopo
la sentenza Viola contro Italia della Corte di Strasburgo, attendiamo dal 2019.
O che io non condivida le rilevatissime “questioni costituzionali” che solleva
la sospensione di una decisione favorevole in materia di libertà, di cui hanno
scritto Andrea Pugiotto e Davide Galliani e alle quali aggiungerei quella sulla
compatibilità di un giudice costituzionale che decide su una legge “sostenuta”
dal Governo che ai tempi presiedeva.
Non mi addolora il rinvio per
altri due motivi. Il primo è che né la sentenza sospesa né la legge auspicata
cambieranno il destino del 71,1% dei 1.750 condannati alla pena dell’ergastolo
che papa Francesco definisce una “pena di morte nascosta”. Perché, in ventuno
anni – dal 2001 al 2022 – si contano solo 32 ergastolani usciti in
“condizionale”. Altri 111 sono usciti pure, ma “coi piedi davanti”. Il secondo
motivo è l’intempestività di una decisione che avrebbe fatto cadere nel pozzo
delle illegittimità la norma simbolo della lotta alla mafia in coincidenza con
il mese e nel trentennale della morte di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino e
degli agenti della scorta. Sarebbe stato un atto di insensibilità umana e
istituzionale. Come è pure quello di assegnare la paternità di tale norma ai due
magistrati. Non vi è traccia documentale né alcuna intervista in tal senso.
Anzi. Per la loro cultura giuridica e umana, Falcone e Borsellino mai avrebbero
partorito o consigliato una legge palesemente incostituzionale.
Ma nessuno poteva farlo poiché
la modifica del 4-bis con l’introduzione della “ostatività” è avvenuta con il
decreto-legge dell’8 giugno 1992 n. 306 e, dunque, dopo l’uccisione di Falcone.
E solo per coincidenza, nel 1991, l’alto magistrato arrivò agli Affari Penali di
Via Arenula quando l’art. 4-bis rientrava in vigore con il decreto-legge del 13
maggio 1991 n. 152 che era alla sua quarta reiterazione. Esso prevedeva un
regime più gravoso rispetto alle soglie di pena da espiare, all’assenza di
attualità di collegamenti da dimostrare e alla pericolosità sociale da valutare.
Aggravamenti che resterebbero intatti anche se il Parlamento da qui a novembre
non legiferasse e la Consulta rendesse esecutiva la sua pronuncia di
incostituzionalità del 4-bis (versione 1992) senza “diaboliche” o “magiche”
interpolazioni additive. Dunque, nessun rischio di equiparazione agli altri
detenuti, i condannati per mafia resterebbero soggetti a regime aggravato. In
sintesi, “entrerebbe in vigore” l’equilibrata proposta di legge n. 1951
presentata il 2 luglio 2019 dalla senatrice Bruno Bossio e che le Commissioni
giustizia hanno ignorato.
Coinvolgere
oggi Falcone e Borsellino fa effetto ma non aiuta né i loro familiari, né la
loro memoria, né gli italiani. Non sono loro i “padri” dell’ergastolo ostativo,
come ripete Fiammetta Borsellino e come ricordo personalmente, poiché ai tempi
ero già in carcere e ne seguivo il pensiero in TV quando erano attaccati quasi
da tutti. Ricordo la professionalità, la pacatezza e l’ironia dei due magistrati
che oggi vedo trasformati in fanatici giustizialisti quasi ignoranti dei valori
costituzionali per i quali invece sono morti. A quel tempo, avevo 19 anni di età
ed ero io che ignoravo finanche l’esistenza della Costituzione. L’ho scoperta in
carcere dove mi sono laureato in Legge e sono ora impegnato in un Dottorato di
ricerca sul nuovo paradigma della Giustizia riparativa: un modo per pensare meno
alla punizione e più alle vittime, alla “Verità e Riconciliazione”.
Quella a cui si riferisce il
presidente del Tribunale di Roma Alberto Cisterna che, dopo l’incontestabile
vittoria dello Stato sulle mafie, parla di necessaria “pacificazione”, perché –
sottolinea – non si può essere sempre in “guerra”. Ed è paradossale che, in
carcere dal 1989, condannato, salentino, lontano dalle storie siciliane, debba
essere io, quasi, a difendere la “verità” in omaggio alla memoria dei due
magistrati siciliani. O, forse, paradossale non lo è perché come le “buone idee”
restano, così, anche le “persone cattive” cambiano.
Claudio Conte. Ergastolano
detenuto a Parma, Consiglio Direttivo di Nessuno tocchi Caino



 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996

 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS: