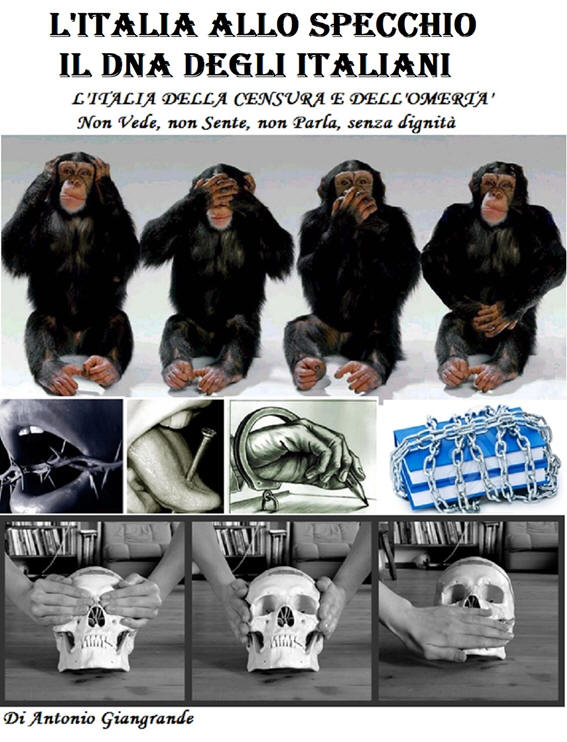Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
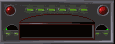
 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA -
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
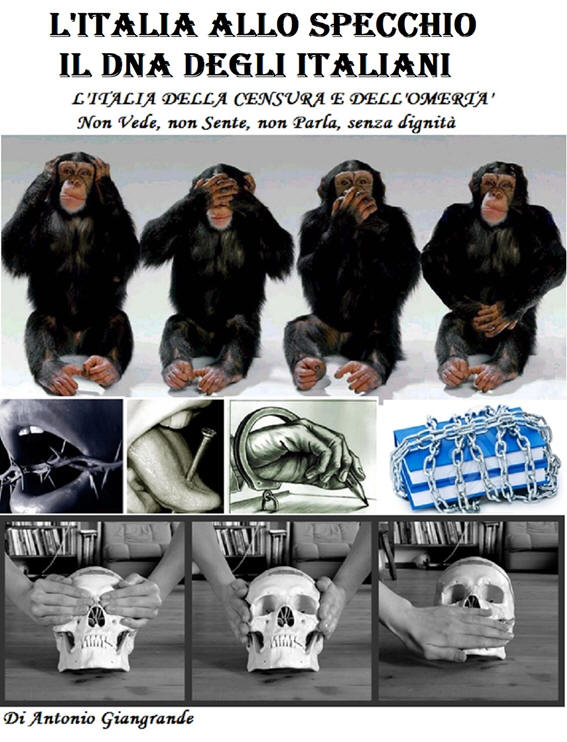
ITALIA
ALLO SPECCHIO
IL DNA
DEGLI ITALIANI
ANNO 2022
IL GOVERNO
QUARTA
PARTE
DI ANTONIO
GIANGRANDE
L’APOTEOSI
DI UN POPOLO
DIFETTATO
Questo saggio è un aggiornamento temporale,
pluritematico e pluriterritoriale, riferito al 2022, consequenziale a quello del
2021. Gli argomenti ed i territori trattati nei saggi periodici sono completati
ed approfonditi in centinaia di saggi analitici specificatamente dedicati e già
pubblicati negli stessi canali in forma Book o E-book, con raccolta di materiale
riferito al periodo antecedente. Opere oggetto di studio e fonti propedeutiche a
tesi di laurea ed inchieste giornalistiche.
Si troveranno delle recensioni deliranti e
degradanti di queste opere. Il mio intento non è soggiogare l'assenso parlando
del nulla, ma dimostrare che siamo un popolo difettato. In questo modo è ovvio
che l'offeso si ribelli con la denigrazione del palesato.
IL GOVERNO
UNA BALLATA
PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
L’ITALIA CHE SIAMO.
UNA BALLATA PER AVETRANA
(di Antonio Giangrande). L’AVETRANA CHE SIAMO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
LA SOLITA INVASIONE
BARBARICA SABAUDA.
LA SOLITA ITALIOPOLI.
SOLITA LADRONIA.
SOLITO GOVERNOPOLI.
MALGOVERNO ESEMPIO DI MORALITA’.
SOLITA APPALTOPOLI.
SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED
ESAMI DI STATO TRUCCATI.
ESAME DI AVVOCATO. LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE
TRUCCATA.
SOLITO SPRECOPOLI.
SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE
SPECULAZIONI.
L’AMMINISTRAZIONE
SOLITO DISSERVIZIOPOLI. LA DITTATURA DEI
BUROCRATI.
SOLITA UGUAGLIANZIOPOLI.
IL COGLIONAVIRUS.
SANITA’: ROBA NOSTRA.
UN’INCHIESTA DA NON FARE. I MARCUCCI.
L’ACCOGLIENZA
SOLITA ITALIA RAZZISTA.
SOLITI PROFUGHI E FOIBE.
SOLITO PROFUGOPOLI. VITTIME E CARNEFICI.
GLI STATISTI
IL SOLITO AFFAIRE ALDO
MORO.
IL SOLITO GIULIO ANDREOTTI. IL DIVO RE.
SOLITA TANGENTOPOLI. DA CRAXI A BERLUSCONI. LE
MANI SPORCHE DI MANI PULITE.
SOLITO BERLUSCONI. L'ITALIANO PER ANTONOMASIA.
IL SOLITO COMUNISTA BENITO
MUSSOLINI.
I PARTITI
SOLITI 5 STELLE… CADENTI.
SOLITA LEGOPOLI. LA LEGA DA LEGARE.
SOLITI COMUNISTI. CHI LI
CONOSCE LI EVITA.
IL SOLITO AMICO TERRORISTA.
1968 TRAGICA ILLUSIONE
IDEOLOGICA.
LA GIUSTIZIA
SOLITO STEFANO CUCCHI &
COMPANY.
LA SOLITA SARAH SCAZZI. IL DELITTO DI AVETRANA.
LA SOLITA YARA GAMBIRASIO. IL DELITTO DI
BREMBATE.
SOLITO DELITTO DI PERUGIA.
SOLITA ABUSOPOLI.
SOLITA MALAGIUSTIZIOPOLI.
SOLITA GIUSTIZIOPOLI.
SOLITA MANETTOPOLI.
SOLITA IMPUNITOPOLI.
L’ITALIA DELL’IMPUNITA’.
I SOLITI MISTERI ITALIANI.
BOLOGNA: UNA STRAGE
PARTIGIANA.
LA MAFIOSITA’
SOLITA MAFIOPOLI.
SOLITE MAFIE IN ITALIA.
SOLITA MAFIA
DELL’ANTIMAFIA.
SOLITO RIINA. LA COLPA DEI PADRI RICADE SUI
FIGLI.
SOLITO CAPORALATO. IPOCRISIA E SPECULAZIONE.
LA SOLITA USUROPOLI E
FALLIMENTOPOLI.
SOLITA CASTOPOLI.
LA SOLITA MASSONERIOPOLI.
CONTRO TUTTE LE MAFIE.
LA CULTURA ED
I MEDIA
LA SCIENZA E’ UN’OPINIONE.
SOLITO CONTROLLO E MANIPOLAZIONE MENTALE.
SOLITA SCUOLOPOLI ED IGNORANTOPOLI.
SOLITA CULTUROPOLI. DISCULTURA ED OSCURANTISMO.
SOLITO MEDIOPOLI. CENSURA, DISINFORMAZIONE,
OMERTA'.
LO SPETTACOLO E LO SPORT
SOLITO SPETTACOLOPOLI.
SOLITO SANREMO.
SOLITO SPORTOPOLI. LO SPORT COL TRUCCO.
LA SOCIETA’
GLI ANNIVERSARI DEL 2019.
I MORTI FAMOSI.
ELISABETTA E LA CORTE DEGLI SCANDALI.
MEGLIO UN GIORNO DA LEONI O CENTO DA AGNELLI?
L’AMBIENTE
LA SOLITA AGROFRODOPOLI.
SOLITO ANIMALOPOLI.
IL SOLITO TERREMOTO E…
IL SOLITO AMBIENTOPOLI.
IL TERRITORIO
SOLITO TRENTINO ALTO ADIGE.
SOLITO FRIULI VENEZIA GIULIA.
SOLITA VENEZIA ED IL VENETO.
SOLITA MILANO E LA LOMBARDIA.
SOLITO TORINO ED IL PIEMONTE E LA VAL D’AOSTA.
SOLITA GENOVA E LA LIGURIA.
SOLITA BOLOGNA, PARMA ED EMILIA ROMAGNA.
SOLITA FIRENZE E LA TOSCANA.
SOLITA SIENA.
SOLITA SARDEGNA.
SOLITE MARCHE.
SOLITA PERUGIA E L’UMBRIA.
SOLITA ROMA ED IL LAZIO.
SOLITO ABRUZZO.
SOLITO MOLISE.
SOLITA NAPOLI E LA CAMPANIA.
SOLITA BARI.
SOLITA FOGGIA.
SOLITA TARANTO.
SOLITA BRINDISI.
SOLITA LECCE.
SOLITA POTENZA E LA BASILICATA.
SOLITA REGGIO E LA CALABRIA.
SOLITA PALERMO, MESSINA E LA SICILIA.
LE RELIGIONI
SOLITO GESU’ CONTRO MAOMETTO.
FEMMINE E LGBTI
SOLITO CHI COMANDA IL MONDO: FEMMINE E LGBTI.
IL GOVERNO
INDICE PRIMA
PARTE
UNA BALLATA
PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
L’ITALIA CHE SIAMO.
UNA BALLATA PER AVETRANA
(di Antonio Giangrande). L’AVETRANA CHE SIAMO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE. (Ho scritto un
saggio dedicato)
LA SOLITA INVASIONE BARBARICA SABAUDA. (Ho
scritto un saggio dedicato)
Storia d’Italia.
LA SOLITA ITALIOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Per Nome e
Cognome.
L’Unione
Europea.
Il Piano Marshall.
Bella Ciao al 25 aprile.
Fondi
Europei: il tafazzismo italiano.
Gli
Arraffoni.
Educazione
civica e disservizi.
Quello che
siamo per gli stranieri.
SOLITA LADRONIA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Italioti
antifascisti.
Italioti
vacanzieri.
Italioti
esploratori.
Italioti
misteriosi.
Italioti Ignoranti.
Italioti
giocatori d’azzardo.
Italioti
truffatori.
Italiani
Cafoni.
Italioti
corrotti e corruttori.
Italioti
ladrosi.
INDICE
SECONDA PARTE
SOLITO GOVERNOPOLI. MALGOVERNO ESEMPIO DI
MORALITA’. (Ho scritto un saggio dedicato)
Il Potere dà alla testa.
Democrazia:
La Dittatura delle minoranze.
Un popolo
di Spie.
Nazi-fascismo e Comunismo: Economia pianificata.
Il Capitalismo.
I Liberali.
Il
Realismo.
Il
Sovranismo - Nazionalismo.
I
Conservatori. Cos’è la Destra?
Cos’è la Sinistra?
Il
Riformismo progressista.
Il
Populismo.
Il solito
assistenzialismo.
La
Globalizzazione.
L’Italia è
una Repubblica fondata sul debito pubblico.
Le
Politiche Economiche.
Il
Finanziamento ai partiti.
Ignoranti.
I
voltagabbana.
La chimera
della semplificazione nel paese statalista.
Il Voto.
Mafiosi: il
voto di scambio.
Il Voto dei Giovani.
Il Voto
Ignorante.
Il
Tecnicismo.
L’Astensionismo: e la chiamano democrazia…
La Rabbia.
I Brogli.
I
Referendum.
Il
Draghicidio.
INDICE TERZA
PARTE
SOLITO GOVERNOPOLI. MALGOVERNO ESEMPIO DI
MORALITA’. (Ho scritto un saggio dedicato)
Elezioni politiche 2022. Ennesima presa per il culo.
La Campagna
Elettorale.
INDICE TERZA
PARTE
SOLITO GOVERNOPOLI. MALGOVERNO ESEMPIO DI
MORALITA’. (Ho scritto un saggio dedicato)
Elezioni politiche 2022. Ennesima presa per il culo.
Le Votazioni
ed il Governo.
INDICE QUARTA PARTE
SOLITO GOVERNOPOLI. MALGOVERNO ESEMPIO DI
MORALITA’. (Ho scritto un saggio dedicato)
Una
Costituzione fascio-catto-comunista.
Quelli
che…La Prima Repubblica.
Le
Presidenziali.
Storia
delle presidenziali.
La Legge.
Il Potere
Assoluto della Casta dei Magistrati.
I Top Manager.
I Politologi.
INDICE QUINTA PARTE
SOLITA APPALTOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Traffico d’influenze.
La
malapianta della Spazzacorrotti.
SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED
ESAMI DI STATO TRUCCATI. (Ho scritto un saggio dedicato)
Impuniti.
Concorsopoli Vigili del Fuoco e Polizia.
Concorso
truccato nella sanità.
Concorso
scuola truccato.
Concorsi ed
esami truccati all’università.
Ignoranti e
Magistrati.
ESAME DI AVVOCATO. LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE
TRUCCATA. (Ho scritto un saggio dedicato)
Ignoranti
ed avvocati.
SOLITO SPRECOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Amministratori pubblici: Troppi sprechi e malagestio.
I
Commissari…
Il Cnel ed
Aran: Come sprecare un milione all’anno.
Spreco a 5
Stelle.
Le ali
italiane.
SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE
SPECULAZIONI.
Bancopoli.
La Nascita
dell’Euro.
Il Costo
del Denaro.
Il Debito.
Pagherò.
ConTanti
Saluti.
Il Leasing.
I Bitcoin.
I Bonus.
Evasori
fiscali!
L'Ingiunzione di Pagamento.
Bollette
luce e gas, mercato libero o tutelato.
La
Telefonia.
Le furbate
delle Assicurazioni.
I Ricconi alle
nostre spalle.
IL GOVERNO
QUARTA
PARTE
SOLITO GOVERNOPOLI. MALGOVERNO ESEMPIO DI
MORALITA’. (Ho scritto un saggio dedicato)
·
Una Costituzione fascio-catto-comunista.
Quante contraddizioni: la storia ipocrita scritta dai faziosi.
Iuri Maria Prado su Libero Quotidiano il 25 agosto 2022
È
significativo che nel Paese in cui il giuramento antifascista costituisce un
inevitabile lasciapassare di presentabilità democratica, e molto spesso per
nobili consulenze e posti assicurati alla tramoggia repubblicana, nessuno dei
dodici professori che rifiutarono il giuramento di fedeltà al regime fascista
sia considerato un padre della Patria Bella Ciao. Non uno di quelli (dodici su
oltre mille) che rifiutarono di impegnarsi in quella dichiarazione di fedeltà, e
dunque di apprestarsi a "formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria
ed al Regime Fascista", figura mai negli elenchi della retorica resistenziale
dell'Italia incorrotta che si opponeva alla dittatura: e anzi a illustrarne i
meriti e le gesta sono tanti che il giuramento invece prestarono, o altri
fervorosi del 26 Aprile già fieramente impegnati nei cimenti a difesa della
razza.
Questa
non casuale contraddizione denuncia meglio di tante altre, che pure
contrassegnano l’improbabilità di tanto antifascismo di regime, il carattere
sostanzialmente contraffattorio e ipocrita della storia scritta in piega
partigiana. E la Repubblica fondata sull’antifascismo prevede la messa in
dannazione di quei pochi, la cui sparuta testimonianza è meglio non sia
rammentata (figurarsi onorata) perché bestemmia sulla verità falsa di un regime
piovuto non si sa come né perché sulla testa di una nazione portata a
manganellate a riempire le piazze cui si annunciava l’ora delle decisioni
irrevocabili. Domandatea un candidato progressista con mostrina “antifa”, a un
libero docente dell’Italia imbarbarita e fascisticizzata per la mancata
approvazione del Ddl Zan, a un cronista democratico specializzato nel reportage
da Predappio, domandategli i nomi di quei dodici. E buon divertimento.
Niccolò
Zancan per “la Stampa” il 24 Agosto 2022
Adesso è
chiaro: non è una mostra che può lasciare indifferenti. «Mi dispiace molto per
quello che sta emergendo sull'esposizione dal titolo O Roma o morte. Un secolo
dalla marcia», dice il sindaco di Predappio Roberto Canali, eletto 3 anni fa con
una lista di centrodestra.
«Fin
dall'inizio, l'impatto della mostra non mi convinceva. Trovo molto brutto quel
manifesto e non so valutare nel merito l'allestimento. Mi dispiace per le
minacce e mi dispiace anche perché non bisogna venire a Predappio con le
intenzioni sbagliate.
Il fatto
è che non ho margini di intervento. Quello è un luogo privato, un bar
riadattato. Gli organizzatori hanno chiesto al Comune solo un cambio di
destinazione d'uso. Così la mostra è qualcosa che sfugge a qualsiasi tipo di
giurisdizione».
Forse è
per questo che attira vecchi e nuovi fascisti, e che le pagine del registro
delle presenze sono piene di parole che inneggiano al Duce. Prende le distanze
il sindaco di Predappio. Prende le distanze uno dei nomi più importanti che
stanno nel manifesto pubblicitario. «Il simbolo di San Patrignano non doveva
essere su quel cartellone, avevamo diffidato gli organizzatori dall'usarlo»
spiega Giorgia Gianni, responsabile delle relazioni esterne. Invece il nome è
rimasto. All'ingresso della mostra e su tutti i volantini. «Non lo sapevamo.
Informeremo il nostro ufficio legale».
E se gli
organizzatori della mostra sul fascismo, il professor Franco D'Emilio e
l'avvocato Francesco Minutillo, già fascista dichiarato a sua volta, sostengono
di aver ricevuto diversi inviti in giro per l'Italia, ecco una pioggia di
smentite. «L'Università la Sapienza di Roma non ha in programma di ospitare la
mostra, iniziativa di cui l'Ateneo non è a conoscenza». Così come non ne vuole
sapere lo storico direttamente chiamato in causa dagli organizzatori, il
professor Giuseppe Parlato: «Smentisco nettamente qualsiasi mio coinvolgimento».
A questo
punto resta da domandare ai due organizzatori il perché di questa
"appropriazione indebita". Risponde D'Emilio: «Mi stupisce la presa di posizione
di San Patrignano, perché ero presente durante i colloqui per il patrocinio. E
il fatto che finora non abbiamo mai adito a vie legali è significativo». Ma come
avete potuto chiamare in causa addirittura La Sapienza e un professore di
Storia? «La proposta ci è stata sottoposta da un commercialista romano di nome
Marchetti, in stretto contatto con la fondazione Ugo Spirito, il cui presidente
è». Non sarà facile portare in giro per l'Italia la mostra della vergogna.
Francesco Verderami per
il “Corriere della Sera” il 19 agosto 2022.
Con il taglio dei parlamentari
il 25 settembre cambierà la storia della politica italiana. Ma quella che
rappresenta a tutti gli effetti una svolta epocale non sarebbe che una «riforma
per caso». Almeno, stando al racconto di un autorevole ministro, presente anche
ai tempi del Conte due e testimone di un episodio che cambia radicalmente la
narrazione sull'epopea giallorossa e sul provvedimento bandiera del grillismo.
Il ministro ricorda come a
metà di ottobre del 2019, dopo che il Parlamento aveva definitivamente approvato
la riforma, al termine di una riunione di governo si fermò a parlare con
l'allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fraccaro: «Che errore
avete fatto», gli disse riferendosi alla riduzione dei parlamentari. E il
grillino rispose a bruciapelo: «Ma chi poteva immaginare che il Pd l'avrebbe
fatto passare così».
È vero, in estate il «taglio»
era stato il cuore dell'intesa tra il Movimento e i Democratici per formare un
governo e sbarrare la strada delle urne a Salvini. Ma tutto lasciava supporre
che - prima dell'ultimo passaggio della riforma in Parlamento - i dem avrebbero
chiesto il varo dei correttivi necessari a garantire la tenuta del sistema:
dalla modifica dei regolamenti per Camera e Senato fino alla legge elettorale
proporzionale.
Insomma, si sarebbe andati per
le lunghe. E se non si fosse arrivati alla fine del percorso, i dirigenti di M5S
- come riconosce oggi uno di loro - già ipotizzavano di sventolare quella
bandiera nella successiva campagna elettorale, «un po' come la sinistra aveva
fatto per vent' anni con il conflitto d'interessi contro Berlusconi».
Invece no. Il Pd, che per tre
volte aveva votato contro la riforma, alla quarta cambiò posizione. Non senza
mal di pancia interni. In pochi in Parlamento si opposero a quella «mutilazione
della Costituzione», come disse al Senato Bonino, allora anche a nome di Azione.
Sarà stato per il fatto che all'epoca Conte era considerato il «punto di
riferimento» del progressismo, ma nel Pd fu il solo Guerini - durante un
dibattito politico in una riunione di governo - ad esprimere il suo dissenso.
Certo in quella sede non si
segnalò in suo sostegno il ministro del Sud Provenzano, compagno di partito, che
l'altro giorno in un'intervista al Corriere ha di fatto sottolineato gli effetti
negativi della riforma. Il titolare della Difesa invece rese pubblica la sua
posizione nell'estate del 2020, quando si avvicinava il referendum ma dei
«correttivi costituzionali» e della proporzionale non c'era traccia: «Non c'è
una nuova legge elettorale, non c'è un nuovo sistema bicamerale. Così com' è
questa è solo una concessione alla demagogia».
Il 21 settembre però la
«demagogia» stravinse con il 70% di «sì»: all'epoca i tardivi ripensamenti di
Berlusconi e Renzi, che condannarono la «riduzione della democrazia in
Parlamento», furono sommersi dal coro (quasi) unanime a favore di una riforma
che - per dirla con Di Maio - avrebbe fatto «risparmiare soldi» e garantito
«leggi scritte meglio».
Da allora sono passati due
anni e due governi, ma le modifiche sono rimaste come le opere pubbliche:
incompiute. La riforma dei regolamenti parlamentari è stata varata solo a
Palazzo Madama, con rischi elevatissimi nella prossima legislatura per l'iter
dei provvedimenti e per la stessa vita del futuro governo.
Non è stata ridotta la quota
dei delegati regionali per l'elezione del presidente della Repubblica,
indispensabile per compensare il taglio di deputati e senatori. Non è stato
modificato il conteggio su base regionale dei voti per l'elezione alla Camera
Alta. E non è stata cambiata la legge elettorale, perché quando Letta sostituì
Zingaretti al Nazareno accettò l'invito della «orbániana» Meloni ad Atreju e lì
affossò il proporzionale per rilanciare il Mattarellum.
Così la riforma nata per
«caso» affida ora al caso la tenuta del sistema, tra il silenzio di chi avrebbe
potuto far sentire la propria voce e l'ammissione di colpa di alcuni dirigenti
democrat, consapevoli che il «taglio» era stata solo una folgorazione sulla via
di Palazzo Chigi: «Siamo un partito di atei praticanti». Ai quali verrà più
complicato intestarsi la battaglia per difendere la «Costituzione più bella del
mondo» dagli attacchi della destra. «Perché finora è stata la sinistra a
cambiare la Carta. E lo ha fatto sempre in peggio», ha detto il
costituzionalista Celotto presentando il suo romanzo Fondata sul lavoro: «Prima
modificò il Titolo V per inseguire i leghisti.
Ora lo ha fatto con il taglio
dei parlamentari per inseguire i grillini». «Lo avete fatto voi», ha detto Letta
ai compagni di partito dopo lo scontro sulle liste. Vuol dire che il segretario
del Pd è contrario alla riforma?
Com'è cambiato il
ruolo del Quirinale. Da Pertini a Mattarella, il presidenzialismo di fatto del
Quirinale.
David Romoli su Il Riformista il 16 Novembre 2022
Forse non era
possibile ricorrere a nessun altro espediente per evitare che la crisi
tra Italia e Francia si avvitasse sino a raggiungere il punto di non ritorno ma
la formula adottata dai presidenti Mattarella e Macron non è affatto
insignificante o effimera. Il capo del governo italiano è stato bypassato
dal presidente della Repubblica che ha svolto un vero e proprio ruolo di
supplenza arrogando a sé, almeno sul piano della diplomazia, prerogative proprie
del governo, del premier e del ministro degli Esteri. È un passo ulteriore su un
sentiero imboccato molti decenni fa, prima con passi piccolissimi poi sempre più
decisamente, sino a creare una sorta di presidenzialismo non dichiarato ma
effettivo.
Quando sono cambiate
le cose? Quando è iniziato a mutare strutturalmente pur se mai formalmente il
ruolo del Colle? Forse con Sandro Pertini, capo dello Stato dal luglio 1978 al
giugno 1985, il presidente socialista ed ex partigiano che non la mandava a
dire, esprimeva critiche corrosive nei confronti della politica dei governi,
come nel caso del terremoto in Irpinia del 1980. Prima di lui gli inquilini del
Quirinale non erano stati, come da leggenda, privi di ogni potere. In compenso
avevano fatto il possibile per sembrarlo, mantenendo il profilo basso,
sforzandosi di apparire anonimi. Pertini rovesciò quella logica. Fu
presenzialista e mattatore sino a incarnare agli occhi degli italiani un
“contropotere” che fustigava il malcostume del potere politico. Pertini, il
primo presidente protagonista, fu eletto pochi mesi dopo quell’uccisione
di Moro che segnò l’inizio della fine per la prima Repubblica ed è difficile
pensare che tra l’avvio del declino dei partiti e l’ascesa del Quirinale negli
equilibri istituzionali non ci sia una correlazione diretta.
Dopo
Pertini, Francesco Cossiga per cinque anni sembrò tornare all’abituale
invisibilità propria dei presidenti del passato: grigio e anonimo, quasi
burocratico. Poi qualcosa cambiò e Cossiga impugnò il piccone. Se Pertini il
socialista aveva sferzato, Cossiga il democristiano demolì e smantellò a colpi
di denunce fragorose e gesti spettacolari. Sfruttò da maestro la visibilità che
l’alto ruolo gli garantiva per delegittimare dalle fondamenta un sistema che
riteneva ormai appassito. I fatti dimostrarono che non era lontano dal
vero. Oscar Luigi Scalfaro, democristiano di prima ma non primissima fila,
arrivò fortunosamente al Colle nel maggio 1992, imposto quasi dal trauma
nazionale della strage di Capaci. Fu eletto in fretta e furia dopo un lungo
stallo anche perché la sua intera biografia sembrava garantire che avrebbe
rimesso le cose a posto, riportando alla “normalità” il ruolo del capo dello
Stato. Probabilmente era quel che davvero intendeva fare. Le circostanze e la
forza delle cose decisero diversamente. Tangentopoli, il referendum del
‘93 sulla legge elettorale che diede alla prima Repubblica l’estrema unzione,
l’improvvisa e travolgente entrata in scena di Silvio Berlusconi gli assegnarono
un protagonismo diretto del quale nessun presidente prima di lui aveva
goduto. Pertini e Cossiga avevano rivoluzionato l’immagine del primo
cittadino: Scalfaro trasformò la sostanza.
La finanziaria del
1992, forse la più importante nella storia della Repubblica, fu letteralmente
scritta da lui e dal premier Giuliano Amato senza neppure consultare gli ormai
agonizzanti partiti. La manovra che rovesciò il governo Berlusconi dopo appena 9
mesi dalla folgorante vittoria nelle elezioni del marzo 1994 non sarebbe stata
possibile senza l’attiva complicità del presidente che si impegnò con Bossi a
non sciogliere le Camere se la Lega avesse tolto la fiducia al governo, lo
incontrò, dietro sua richiesta, nelle stesse stanze del Quirinale, convinse e
quasi costrinse Berlusconi ad accettare un nuovo premier, Lamberto Dini, dopo la
caduta del suo governo in dicembre. Dopo Scalfaro il ruolo del Quirinale non
sarebbe comunque potuto tornare quello di prima, salvo che in presenza di un
sistema dei partiti forte, solido, basato sulla legittimazione reciproca dei
diversi schieramenti. La realtà era opposta e dopo la parentesi Ciampi, l’unico
presidente vecchio stile degli ultimi decenni, Giorgio Napolitano portò il
processo iniziato da Scalfaro alle estreme conseguenze. Il primo presidente ex
comunista aveva già di suo una concezione estremamente interventista del ruolo
istituzionale che iniziò a ricoprire nel maggio 2006. Il quadro nazionale e
internazionale, la delegittimazione del governo Berlusconi dopo la nuova
vittoria del 2008, la grande recessione iniziata nello stesso anno, la crisi del
debito del 2011, rafforzarono le sue tendenze. Rispetto a Scalfaro,
Napolitano poteva poi contare su un controllo di fatto assoluto sul partito da
cui proveniva, i Ds diventati nel 2008 Pd.
Napolitano è stato
un monarca costituzionale più che un presidente repubblicano. Ha imposto una
guerra, quella contro la Libia, ha cambiato un governo, quello
di Berlusconi sostituito con il tecnico Monti nel 2011, ha fatto muro contro
ogni ipotesi di scioglimento anticipato delle camere, convincendo nel
2010 Fini a posticipare di un mese il voto sulla sua mozione di sfiducia contro
Berlusconi e dando così allo stesso Cavaliere il tempo di acquisire i voti
necessari per resistere, ha condizionato a fondo le alleanze del Pd, è stato il
primo presidente rieletto nella storia italiana e in cambio della sua
disponibilità a non lasciare il Colle al termine del mandato, nel 2013, ha
imposto la nascita di un governo sostenuto sia dal Pd che da Forza Italia. Re
Giorgio.
Sergio Mattarella,
animato da un’idea da un’idea opposta del ruolo istituzionale
del Quirinale, avrebbe probabilmente voluto tornare a uno stile più sobrio,
molto meno interventista. Non c’è riuscito e non poteva riuscirsi in
una democrazia parlamentare che è ormai tale solo di nome, con un sistema dei
partiti devastato e in ginocchio, nel cuore di una conclamata crisi di
sistema. Napolitano era stato re e presidente volendolo essere, Mattarella lo è
senza volerlo ma anche senza poterlo evitare. La rielezione di Napolitano,
comunque rimasto in carica solo per due anni nel secondo mandato, poteva ancora
essere un’eccezione. Quella di Mattarella nel 2022 ha il sapore di una nuova
norma. In un quadro simile non ha molto senso chiedersi se la supplenza
esercitata da Mattarella per risolvere una crisi minacciosa con la Francia è
stata o no una forzatura. Converrebbe prendere atto di una trasformazione che si
è operata nel tempo persino contro le intenzioni di quelli che la hanno
veicolata, come nei casi di Scalfaro o dello stesso Mattarella, e decidersi a
farne un assetto istituzionale ordinato, invece di restare in quella che è oggi
una terra di nessuno. David Romoli
Il confuso
dibattito sulle riforme. Presidenzialismo, come funziona il modello francese: la
flessibilità e il governo di minoranza.
Renato Mannheimer, Pasquale
Pasquino su Il Riformista il 26 Agosto 2022
Dopo la generica proposta presente nella bozza
di programma del centro destra di “Elezione diretta del Presidente della
Repubblica”, il che implica una modifica importante della forma di governo
parlamentare in vigore in Italia dal 1948, si è aperto sui giornali un utile
dibattito a questo proposito. Con il termine presidenzialismo s’intendono in
realtà regimi politici molto diversi fra di loro. Non basta, tanto per
cominciare, l’elezione diretta del presidente della Repubblica da parte dei
cittadini per qualificare una forma di governo come presidenziale e la
confusione introdotta nel linguaggio costituzionale dal termine
semipresidenzialismo non aiuta a capire con chiarezza di cosa si sta parlando.
Uno sguardo all’esperienza francese può
aiutare probabilmente ad arricchire la discussione che si è aperta, accanto alle
utili osservazioni che sono state già presentate sul tema in generale da Gustavo
Zagrebelsky, Sabino Cassese e Luciano Violante. Le note che seguono non sono di
per sé una difesa della importazione di un modello che si è affermato in un
paese con una storia politica molto diversa dalla nostra. I trasferimenti di
istituzioni non sono facili, ma nemmeno impossibili, per essi vale la
precauzione, handle with care! Come conseguenza delle elezioni legislative dello
scorso giugno, il sistema politico-costituzionale francese si è trovato in una
situazione inabituale. Ensemble, cioè l’insieme delle forze politiche vicine
a Emmanuel Macron, rieletto per la seconda volta in aprile alla presidenza della
Repubblica, non ha ottenuto, come sperava, la maggioranza assoluta all’Assemblea
nazionale, ma solo quella relativa, una condizione che rende difficile
l’attività legislativa, in un paese che per la sua struttura per certi versi
presidenziale e per la sua legge elettorale non è abituato ai governi di
coalizione e ai compromessi fra partiti dopo le elezioni.
Si tratta di un caso con un solo precedente,
ovvero il governo del socialista Michel Rocard che nel 1988 non poté appoggiarsi
su una maggioranza assoluta, alla quale mancavano 14 voti. Spesso, però, il
presidente francese ha potuto godere di una maggioranza piena a suo favore in
seno all’Assemblée nationale, il fondamentale organo legislativo, nei confronti
del quale il Senato non può esercitare un diritto di veto. In caso di
coabitazione, che si è prodotta in tre occasioni in passato (fra il 1986 e
il 2002), quando il presidente ed il primo ministro erano espressione di opposte
maggioranze, quella dell’Assemblea era diretta dal primo ministro, il che
riconduceva fino ad un certo punto la forma di governo a quella di tipo
parlamentare. Le tre diverse versioni dell’ordinamento politico e della forma di
governo francese appena considerate si spiegano con la natura e la storia della
costituzione della 5a Repubblica.
Il testo originario del 1958– nonostante
l’ostilità di Charles De Gaulle su questo punto – presentava una struttura
parlamentare, razionalizzata rispetto al parlamentarismo debole e instabile
della 4a repubblica. Si potrebbe dire che Michel Debré diede realizzazione alle
attese dell’ordine del giorno di Perassi del 4 settembre 1946, da noi mai
soddisfatte. Struttura parlamentare, dicevamo, poiché il presidente della
costituzione francese del 1958 non era eletto dai cittadini, ma, indirettamente,
da 82000 grandi elettori (cioè i parlamentari, i consiglieri regionali e quelli
municipali: basti pensare del resto che la Francia conta su 36mila comuni). È
solo con il referendum popolare, di dubbia legalità costituzionale, voluto da De
Gaulle nel 1962 che è nata quella forma di governo nota con l’espressione
ambigua di semi-presidenzialismo.
In realtà si trattava di un ordinamento che
poteva e ha assunto in diverse occasioni per lo più due forme: quella in cui
il capo dello Stato eletto direttamente era di fatto il capo dell’esecutivo,
nonostante la presenza di un primo ministro da lui scelto e da lui sostituibile,
o, alternativamente, quella – che va, come ricordato, sotto il nome
di coabitazione – in cui il primo ministro, espressione di una maggioranza
diversa da quella che aveva eletto il presidente della Repubblica, era in realtà
il capo del governo, responsabile solo dinanzi alla sua maggioranza, mentre il
presidente – in base ad una convenzione costituzionale – aveva una specie di
quasi monopolio della politica estera. La cosiddetta coabitazione era resa
possibile dalla circostanza che mentre il mandato presidenziale era di sette
anni quello dei membri dell’Assemblea era di cinque.
Esisteva, dunque, la possibilità che la
maggioranza del corpo elettorale cambiasse opinione nel lasso di tempo che
separava le elezioni presidenziali da quelle legislative o dopo uno scioglimento
della Assemblea da parte del presidente. Fu proprio per evitare il ripetersi
di coabitazioni, che limitavano di fatto decisamente i poteri del presidente,
che Chirac promosse nel 2000 la riforma costituzionale che ha ridotto a cinque
anni il mandato presidenziale e poi, nel 2002, accorpato le elezioni
presidenziali e le legislative, che hanno ormai luogo subito dopo quelle del
presidente della Repubblica. Si poteva contare, grazie al nuovo calendario
elettorale, su un effetto di trascinamento che doveva garantire alla maggioranza
del presidente eletto il controllo dell’assemblea e la nomina di un primo
ministro politicamente vicino e in certa misura subordinato al presidente. Così
è accaduto infatti in tutte le elezioni dopo il 2002.
Fino al giugno scorso, quando i risultati
elettorali hanno prodotto una assemblea divisa per l’essenziale in tre parti: la
destra nazionalista di Marine Le Pen, che era stata sconfitta alle
presidenziali, ma il cui partito, il Rassemblement national ha conquistato ben
89 seggi, la coalizione delle sinistre radicali (Nupes) fondata da Jean-Luc
Mélenchon, 151 seggi e la coalizione macronista 250, lontana dai 289 necessari
per ottenere una maggioranza assoluta. Ma la costituzione della 5a repubblica
permette oltre alla coabitazione (il governo di una assemblea di un colore
diverso da quello del presidente), e al super-presidenzialismo (quando il
presidente controlla l’assemblea grazie alla sua maggioranza) anche una terza
versione: il governo di minoranza, nella misura in cui il primo ministro è in
grado di trovare dei compromessi con i parlamentari al di là della propria
maggioranza relativa.
Questa è la situazione in cui si trova ad
operare il primo ministro Elisabeth Borne e il suo esecutivo, mostrando per ora
una certa capacità di mediazione ed efficacia legislativa. Grazie alla presenza
nell’assemblea di 62 deputati del partito post-gollista (Les Républicains), che
a differenza delle ali estreme sembrano disposti a fare dei compromessi e
contribuire all’attività legislativa. Il ruolo della destra repubblicana è reso
più rilevante dal fatto che essa controlla tradizionalmente il Senato, che pur
non eletto direttamente dai cittadini e privo di un potere di veto assoluto, ha
una influenza nel processo legislativo, in particolare attraverso la proposta di
emendamenti. L’assenza di una maggioranza presidenziale assoluta, e dunque
un governo di minoranza con l’appoggio esterno della destra non radicale sui
singoli provvedimenti di legge, sembra permettere di evitare la paralisi
legislativa e il rischioso ricorso a nuove elezioni, che il presidente francese
ha sempre la possibilità di indire.
Nei prossimi mesi sarà possibile valutare i
progressi del governo di Elisabeth Borne che ha già ottenuto l’approvazione di
un pacchetto di misure relative all’aumento del costo della vita provocato
dall’inflazione. Questo sembra testimoniare la flessibilità della costituzione
francese, che pure era poco abituata in passato ai compromessi fra forze
politiche. Flessibilità qui nel senso di capacità di adattarsi senza rompersi a
forme diverse che assume l’ordine politico in base ai risultati delle elezioni.
In realtà riemerge la versione parlamentare della costituzione del 1958. In
conclusione, se, come qualcuno ha proposto, si vuole imitare il modello
francese, bisogna prima ben capire il prodotto di importazione.
Renato Mannheimer, Pasquale Pasquino
Elezione diretta
del premier? Un pasticcio che fa saltare la Costituzione.
"Scegli il sindaco d’Italia":
una riforma siffatta manderebbe in malora almeno tre capitoli essenziali
dell’attuale modello costituzionale. Giuliano Cazzola su Il Dubbio il 26 agosto
2022.
A me la Costituzione repubblicana va bene come
è, anzi come era prima delle modifiche che ha dovuto subire nel corso dei
decenni, dalla sciagurata riforma del Titolo V fino alla potatura delle Camere.
Sono inoltre convinto che le Carte Costituzionali vivano di vita propria – come
tutte le norme – ed evolvano insieme alla storia di un paese. A questo proposito
si potrebbero scrivere dei trattati su come le istituzioni del 1948 contenevano
in sé ampi margini di interpretazione adeguata al trascorrere dei tempi e dei
processi politici, senza per questo venir meno ai dispositivi delle norme.
Infine, trovo stupido affidare ad una complessa procedura parlamentare quella
maggiore efficienza del sistema che potrebbe essere risolto attraverso i
regolamenti delle Camere. En passant, ritengo che la parte maggiormente datata
non sia la seconda, ma la prima, in cui si avverte – specie nella Sezione dei
Rapporti economici – il peso delle ideologie dei partiti di allora, tanto che
nessuno degli attuali, riscriverebbe adesso quelle stesse norme come allora. La
questione della riforma costituzionale è entrata nel dibattito elettorale e
pertanto merita qualche commento, anche da parte di chi non la ritiene
necessaria, se non per correggere, tutt’al più, i vulnus che la Carta ha dovuto
subire.
Preliminarmente occorre mettere qualche
puntino sulle ‘’ i’’. Innanzi tutto va chiarito che il centrodestra non propone
il ‘’presidenzialismo’’, ma l’elezione diretta a suffragio universale del Capo
dello Stato. Si tratta di modelli istituzionali radicalmente diversi, almeno sul
piano teorico. In un regime presidenzialista, il presidente è eletto ed è
contemporaneamente capo dello Stato e dell’ Amministrazione, in una logica
accentuata di divisione dei poteri. Nel caso classico degli Usa, si accompagna
con il federalismo, come diretta ispirazione dei grandi costituzionalisti del
Secolo dei Lumi. Invece, l’elezione diretta del Capo dello Stato è assolutamente
compatibile nel contesto di un regime parlamentare. L’elezione popolare diretta
del Capo dello Stato è` presente nella grande maggioranza dei Paesi europei:
Austria, Irlanda, Islanda, Portogallo, Finlandia, Francia (sia pure con la
caratteristica del semi- presidenzialismo), senza contare i nuovi Stati
dell’Europa centro- orientale come Polonia, Romania, Bulgaria ed altri. Laddove
questo tipo di elezione non è contemplata di solito vige un regime monarchico.
Ma c’è di più. Se si aprissero gli armadi di tanti partiti si troverebbero gli
scheletri dell’elezione diretta del capo dello Stato, ivi rinchiusi in diverse
stagioni politiche. E’ appena il caso di ricordare che nel testo di legge
costituzionale presentato il 4 novembre 1997 dalla Commissione bicamerale
presieduta da Massimo D’Alema – il punto più alto a cui arrivò l’intesa tra i
partiti – era prevista l’elezione popolare diretta a suffragio universale –
eventualmente su due turni – del Capo dello Stato. Relatore sul punto fu Cesare
Salvi, il quale scrisse: “Si può dunque, affermare che l’elezione diretta del
Capo dello Stato è il sistema più diffuso in Europa, e che non ha dato luogo a
degenerazioni plebiscitarie o a pericoli per la tenuta democratica del sistema
istituzionale. Non si comprende dunque perché solo l’Italia, e con essa il
popolo italiano, dovrebbe fuoriuscire dal quadro europeo dominante; né credo si
possa dire che l’elettorato italiano, in cinquant’anni di elezioni politiche e
di referendum, abbia mai dato prova di comportamenti irrazionali o si sia
mostrato facile preda di suggestioni demagogiche”.
Non parliamo poi dell’altro punto che fa parte
del compromesso raggiunto all’interno della coalizione di centrodestra:
l’autonomia delle Regioni. Il dibattito sul federalismo ha attraversato intere
legislature (l’unica riforma in tal senso è attribuibile all’iniziativa
solitaria del centrosinistra) con tutti i maggiori partiti tentati da
un’operazione che intendeva spartirsi i consensi raccolti dalle Lega nel Nord
del Paese. La richiesta dell’autonomia differenziata fu sostenuta anche
dall’Emilia Romagna. Trovo invece inaccettabile – nonostante le mie simpatie per
il Terzo Polo – la proposta della elezione diretta del premier. E’ il recupero
di una vecchia idea di Mario Segni – uno dei più grandi sopravvalutati della
storia contemporanea – che si riassumeva nella seguente formula. “Scegli il
sindaco d’Italia’”. Una riforma siffatta manderebbe in malora almeno tre
capitoli essenziali dell’attuale modello costituzionale: il Parlamento, il
governo e il presidente della Repubblica. Infatti nessuno può pensare che
l’operazione potrebbe limitarsi ad eleggere un “pinco pallino” che poi deve
andare a cercarsi una maggioranza. Il modello del premierato, su cui si basa
l’elezione del sindaco e dei presidenti delle Regioni, pone in ruolo secondario
l’assemblea elettiva la cui composizione è condizionata dall’esigenza di
assicurare una maggioranza all’eletto la cui vitalità è alla mercé (nel senso
del classico simul stabunt, simul cadent’) del capo dell’esecutivo il quale
peraltro dispone a sua discrezione della nomina dei titolari delle cariche di
governo. Non esiste – che io sappia – in nessun angolo del pianeta una
Repubblica delle banane che organizzi in questo modo le sue istituzioni,
subordinando il potere legislativo al governo. Se questa fosse la soluzione,
tanto varrebbe abolire la carica del Capo dello Stato e ripristinare una
dinastia regnante.
Reazioni viscerali all'idea
del presidenzialismo. Il presidenzialismo e i prigionieri di una Costituzione
fatta con le regole del poker.
Paolo Guzzanti su Il
Riformista il 21 Agosto 2022
Perché il presidenzialismo in
Italia e soltanto in Italia provoca delle reazioni profonde e con un alito da
guerra civile? La ragione è semplice: la nostra Costituzione è stata concepita
fondamentalmente per impedire che un nuovo Mussolini, o anche semplicemente un
uomo dalla soverchiante personalità e capacità, potesse far ripetere all’Italia
qualcosa di simile a ciò che era accaduto fra il 1922, quando Mussolini
ricevette l’incarico di formare un governo di coalizione e il gennaio
del 1926 con la disfatta dei deputati e senatori che per due amni si erano
ritirati per protesta dell’Aventino.
La dittatura
fascista in Italia fu una curiosa dittatura costituzionale, dal momento che il
re come capo dello Stato fu coautore e complice di tutti gli atti del suo “capo
del governo” (questa era la dizione usata) comprese le leggi razziali del 1938 e
la partecipazione alla guerra tedesca. Anche l’epilogo della dittatura fu un
unico nella storia. Il fascismo cadde formalmente e realmente in seguito ad un
voto di sfiducia di un organismo costituzionale quale era il Gran Consiglio del
Fascismo già incorporato nello Statuto Albertino. La guerra era stra-persa
all’inizio dell’estate del 1943 e Mussolini era andato a incontrare Hitler per
dirgli che non aveva più armi né mezzi, e chiedergli pezzi della contraerea
perché era imminente il già annunciato (con la lanci di volantini) bombardamento
su Roma. Hitler rispose che non poteva certo privare il suo esercito delle armi
per difendere Roma e che se l’Italia si fosse arresa lui ne avrebbe compreso le
ragioni ma avrebbe proceduto all’occupazione.
Il bombardamento avvenne il 19
luglio con aerei corazzati come navi e ben armati, dunque senza scorta di
caccia, ed emerse la totale inabilità dell’aeronautica italiana di avvicinarsi
ai bombardieri americani. Quello fu il momento atteso da Vittorio Emanuele e dai
gerarchi dissidenti per presentare un ordine del giorno da discutere e votare
con cui si sarebbe restituito al re il comando militare delle forze armate,
esautorando Mussolini, il quale si presentò al Gran Consiglio depresso, con
l’uniforme spiegazzata, con momentanei scatti d’ira, ma rassegnato. L’ordine del
giorno passò, a tarda notte il duce tornò a Villa Torlonia rimproverato dalla
moglie Rachele che gli dette dell’imbecille per non essersi comportato come
avrebbe fatto Hitler, e al risveglio si vestì in abiti civili per andare a Villa
Savoia dal re cui intendeva spiegare che non era successo nulla di grave,
soltanto un malinteso.
Quando fu al cospetto del re e
prima che potesse dire qualsiasi cosa il sovrano gli annunciò di averlo
sostituito con il maresciallo Pietro Badoglio. Mussolini cadde di nuovo in una
profonda depressione accasciato su un divano di vimini coperto di cuscini
estivi. Chiese che ne sarà dei miei cari e il piccolo re gli disse di star
tranquille, era già stata salvaguardata l’incolumità di tutti compresa la sua,
di Mussolini, per il quale era pronta un’ambulanza piena di carabinieri per
portarlo in un luogo sicuro, tacendo sul piccolo dettaglio che Mussolini era
agli arresti. Il resto della storia non riguarda il tema del presidenzialismo ma
quello che era accaduto all’inizio, durante la fine della dittatura
costituzionale (ci fu poi il supplemento di dittatura repubblicana a Salò in
cui Mussolini fui una marionetta di Hitler nell’Italia occupata) che era stata
reale: nessun colpo di Stato all’inizio – la marcia su Roma del 1922 fu una
fragorosa manifestazione di piazza concordata con la Corona – e nessun vero
colpo di Stato alla fine – benché si trattasse evidentemente di un complotto –
perché il fascismo italiano cadde su un voto di fiducia.
Quando si scrisse la nuova
Costituzione l’Italia era sottomessa al potere politico e civile del
principe Eugenio Pacelli col nome di Pio XII e poi al potere politico di chi
aveva vinto la guerra: gli Stati Uniti rappresentati dalla Democrazia
Cristiana e l’Unione Sovietica rappresentata dal Partito Comunista e anche
dal Partito Socialista. Il risultato fu una Costituzione costruita in modo tale
da scoraggiare o impedire l’avvento di qualsiasi leader dotato di un proprio
potere personale. Si potrebbe dire che la nostra Costituzione è costruita con la
mentalità delle regole del poker. Un gioco in cui teoricamente non puoi mai
essere sicuro di avere in mano il punteggio più alto perché esiste sempre la
possibilità di un punteggio maggiore del tuo. La dizione italiana “presidente
del Consiglio dei ministri” non esiste in alcun’altra democrazia del mondo. Essa
significa che il capo del governo è una specie di presidente dell’assemblea
condominio che ha avuto l’incarico di trovare una maggioranza con cui formare un
governo.
Un “presidente del
Consiglio” (che non è un “capo del governo”, non è un “premier” o primo ministro
non ha alcun potere di nominare o revocare ministri. Può proporli: va dal capo
dello Stato e gli dice: Signor Presidente, avrei compilato, alla buona una lista
di persone che mi sembrerebbero adatte. “Vedere?”, chiede il capo dello Stato
non eletto dal popolo ma da un Parlamento che nel frattempo, è forse anche
andato a casa. Riflette e poi dice: questo va bene, anche questo ma quest’altro
non mi pare all’altezza e lo sostituirei con questo nome fidatissimo. E poi,
andando più giù…. Questo accade in modi e tonalità diversi secondo l’umore e la
personalità dei capi dello Stato. Nella preistoria della Repubblica erano tutti
democristiani, sia il capo dello stato che del governo. I democristiani avevano
bisogno di piattezza assoluta perché il loro patto interno prevedeva la
rotazione degli scialbi e degli indifferenti.
Gli italiani una mattina
accendevano la radio per il radiogiornale e apprendevano che questa mattina
l’onorevole Mariano Rumor si è recato al Quirinale per rassegnare le dimissioni
da Presidente del Consiglio dei ministri. Era tutto in famiglia. Sotto un altro.
All’estero ridevano di noi, sbagliando: era sempre lo stesso governo di un unico
organismo multicefalo in cui si praticava il rito voodoo dell’alternanza: un
giorno a te, un giorno a me. I guai cominciarono quando politici non
democristiani come Giovanni Spadolini o Bettino Craxi imposero che
la Dc cambiasse gioco e cedesse occasionalmente la poltrona di Palazzo Chigi.
Ricordiamo benissimo che cosa
accadde in Italia quando fu chiamato in servizio il generale Charles de
Gaulle che quasi da solo aveva fatto la resistenza ai tedeschi piazzandosi
a Londra dove non era simpatico a nessuno. Successe il finimondo in casa
democristiana dove capirono che un sistema del genere avrebbe fatto a pezzi il
potere della Dc. Una carovana di politici si mise in viaggio
verso Colombay-Les-Deux-Eglises per chiedere al generale se avesse potuto
scrivere una nuova Costituzione. Fu allora creata la storiella del collaboratore
di De Gaulle che disse “Bisognerebbe fucilare tutti gli imbecilli” e De
Gaulle sovrappensiero che rispose “Vasto programma”. Cominciò così la Quinta
Repubblica che funziona – rispetto alla nostra – in maniera splendida e non
troverete un solo francese, non importa quanto di destra o di sinistra, che
abbia il minimo rimpianto per la vecchia Repubblica che era più o meno come la
nostra attuale.
All’Eliseo si alternano
conservatori come Giscard e progressisti come Mitterrand e in più, oltre al
Presidente che governa, c’è anche, come ai tempi del re, un suo primo ministro
che nessuno si ricorda mai come si chiama. In Italia una tale discussione è
scoraggiata a priori. Si considera chi parla bene del presidenzialismo, di una
delle tante forme possibili, come di un poco di buono, un mascalzone con
probabili ambizioni cesaree, un nuovo duce, o Führer, o conducator,
o Volodia (Stalin) o Grande Timoniere (Mao), in ogni caso, uno che evoca la
metafora di colui che guida: nei tram tedeschi resiste la scritta “Non parlare
al Fuhrer”.
Paolo Guzzanti. Giornalista e
politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della Fondazione Italia
Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza Italia e deputato
nella XVI per Il Popolo della Libertà.
Sabino Cassese:
"Presidenzialismo? La Carta costituzionale si cambia solo con cautela".
Raffaella De Santis
su La Repubblica il 7 luglio 2022.
Siamo di fronte a un passaggio
epocale? Sabino Cassese, grande giurista, ex giudice della Corte costituzionale
e professore emerito alla Scuola Normale Superiore di Pisa, il cui nome era
stato fatto anche come possibile presidente della Repubblica, non chiude
preventivamente le porte alla possibilità di una riforma della Carta
costituzionale in senso presidenzialista, ma naturalmente ricorda ciò che fa di
una democrazia una democrazia: "Lo spirito è sempre quello ispirato da
Montesquieu nell'Esprit des Lois: poteri che bilanciano altri poteri".
I costituzionalisti sono
già divisi "Serve una norma" "No, il presidente può lasciare subito".
Le polemiche della
sinistra non aiutano il dibattito su questioni così cruciali. Il passaggio di
consegne tra sistemi potrebbe avvenire in più modi. Francesco Boezi il 13 Agosto
2022 su Il Giornale.
Il presidenzialismo, per
alcune forze politiche, resta un tabù, ma tra i giuristi italiani sembra tirare
un'altra aria. In relazione alla polemica costruita ad arte da sinistra sulle
parole che il presidente Silvio Berlusconi ha pronunciato sul futuro
istituzionale del Belpaese, Michele Ainis si è espresso così, parlandone con
l'Agi: «Nei giorni scorsi ho scritto un articolo I partiti e il presidente nel
quale credo di essere stato il primo e l'unico a fare presente ciò che, con
tutt'altro effetto politico, ha spiegato Berlusconi, ma è una ovvietà: se si
passa a un sistema presidenziale il presidente deve andare via, o perché la
legge stabilisce l'immediata decadenza, oppure - come dicevamo ed è l'ipotesi
più auspicabile - la riforma dovrebbe entrare in vigore nella prossima
legislatura, ma anche in quel caso Mattarella non so se accetterebbe di
continuare un interregno, tanto più se questo dovesse passare per un
referendum». Insomma, la bufera sollevata da sinistra ha poco senso d'esistere.
Per il professor Giovanni
Guzzetta, sentito dal Giornale, dipende tutto dal quadro normativo: «Credo che
questa campagna elettorale stia purtroppo affrontando temi delicati quali le
riforme istituzionali e costituzionali in maniera polemica. Invece bisognerebbe
porre queste questioni in modo serio - premette - . Per quanto riguarda il
presidenzialismo, il legislatore che dovesse approvare una riforma così
delicata, dovrebbe porsi il problema delle norme che accompagnerebbero la
riforma». Poi la spiegazione sull'eventuale passaggio da questo sistema a quello
presidenziale: «Tra queste, potrebbe essere prevista una disciplina transitoria.
Una riforma così può essere fatta in molti modi. Chiaro che sarà la norma a
determinare tempi e modi. Poi ovviamente, se così prevederà la legge, quando la
riforma entrasse in vigore e venisse eletto un diverso presidente, il
precedente, qualora ancora in carica, cesserebbe dal mandato». Ovvio ma a quanto
pare non per tutti. Per il professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte
Costituzionale che si è più volte soffermato sul presidenzialismo, bisognerebbe
guardare al pregresso: «Abbiamo due precedenti di modifiche costituzionali - ha
dichiarato al Giornale - che toccavano l'una la durata in carica di titolari di
funzioni pubbliche, l'altra il numero dei titolari. Mi riferisco alle leggi
costituzionali numero 2 del 1963 e numero 1 del 2020. La prima ha ridotto la
durata dei membri del Senato da 6 a 5 anni. La seconda ha ridotto il numero dei
parlamentari da 945 a 600. L'una e l'altra norma costituzionale hanno disposto
espressamente l'applicazione della modifica alla legislatura successiva». Il
giudice emerito ha proseguito: «In materia costituzionale i precedenti hanno
un'importanza fondamentale. Quindi si può concludere che una norma che modifichi
in qualche modo la disciplina della scelta o dei poteri del presidente della
Repubblica debba contenere anche una norma che pospone l'applicazione concreta
al termine del mandato del titolare in carica». Alfonso Celotto, altro
costituzionalista, ha riconosciuto la natura dicotomica del momento: «La riforma
migliorerebbe il nostro sistema - ha annotato - , consegnandoci una forma di
governo più stabile. Il punto è capire come procedere, perché il legislatore di
riforma costituzionale può operare in più modi. Facciamo il caso della riforma
del taglio dei parlamentari: abbiamo concluso la legislatura con il vecchio
assetto, pur sapendo che a breve sarebbe cambiato molto. Ripeto: dipende dal
legislatore. Ma è campagna elettorale, è normale e non vedo problemi: il
presidenzialismo è un argomento che divide». L'approvazione del presidenzialismo
modificherebbe nel profondo l'assetto istituzionale che conosciamo. La
discussione del legislatore potrebbe anche vertere su tempi e modalità, ma non
c'è dubbio sulla portata storica di una riforma che accompagna il centrodestra
sin dalla sua nascita.
Da corriere.it il 12 agosto
2022.
«Elezione diretta del
presidente della Repubblica». Recita così il primo punto del terzo capitolo di
proposte del centrodestra in vista delle Politiche del 25 settembre. I tre
leader della coalizione Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi
puntano su una riforma della Costituzione che superi la Repubblica parlamentare
— «La sovranità appartiene al popolo», recita l’articolo 1 della Carta, che
esprime la sua volontà eleggendo il Parlamento — e preveda invece una Repubblica
presidenziale. Una proposta che — complici le parole del leader di Forza Italia
(per Berlusconi «con il presidenzialismo Sergio Mattarella dovrebbe dimettersi»)
— ha già scatenato la polemica politica. Ma che cos’è nello specifico il
presidenzialismo e cosa significherebbe per l’Italia?
La forma di governo
La Repubblica presidenziale, o
il presidenzialismo, è una forma di governo in cui il potere esecutivo si
concentra nella figura del presidente che è sia il capo dello Stato sia il capo
del governo: una figura eletta direttamente dai cittadini che ha il compito di
formare il governo.
Essendo capo di Stato, il
presidente non ha bisogno di un voto di fiducia parlamentare perché, avendo già
ottenuto il voto della maggioranza dei cittadini non necessita della
legittimazione dei loro rappresentanti.
Tra i Paesi che hanno una
Repubblica presidenziale ci sono gli Stati Uniti, l’Argentina, il Cile, il
Brasile, il Messico, l’Uruguay, il Costa Rica e la Corea del Sud. La Repubblica
italiana, invece, è parlamentare (come ad esempio la Germania, la Grecia,
l’Irlanda o la Finlandia): prevede quindi la centralità delle due Camere elette
dai cittadini.
A loro volta, i deputati e i
senatori eleggono il presidente della Repubblica che poi attribuisce il compito
di formare il governo a un presidente del Consiglio incaricato. Se il premier
riesce a formare il governo, deve poi necessariamente ottenere la fiducia dei
due rami del Parlamento. Nella Repubblica parlamentare, a differenza di quella
presidenziale, il presidente della Repubblica, non eletto dal popolo, è una
figura di garanzia.
Il ruolo del presidente
Nella Repubblica presidenziale
il presidente è quindi la massima autorità, perché è contemporaneamente capo di
stato e di governo ed è anche legittimato dal voto popolare. A differenza del
parlamentarismo, nella Repubblica presidenziale il presidente ha grandi poteri e
può agire liberamente: può porre il veto alle decisioni delle Camere e svolgere
alcuni compiti legislativi, dirige la politica estera dello Stato, nomina gli
alti funzionari. La sua rimozione può essere ottenuta solo con un impeachment
attraverso il quale il presidente viene rimosso in caso di reato: alla messa in
stato d’accusa deve seguire un processo. Il Parlamento non ha la capacità di
rimuovere il presidente ma il presidente non può sciogliere il Parlamento a suo
piacimento.
L’esempio francese
Per quanto riguarda l’elezione
delle cariche, nella Repubblica presidenziale si tengono due elezioni distinte e
a suffragio universale: un voto per eleggere il presidente e un voto per
eleggere il Parlamento. Di conseguenza, possono verificarsi casi in cui la
maggioranza delle Camere non coincide con il partito del presidente, creando
così una maggiore separazione dei poteri. Il presidente sceglie liberamente i
ministri, i segretari e la denominazione che hanno i membri del suo gabinetto.
La Francia, ad esempio, è una
Repubblica semi-presidenziale: il potere esecutivo è condiviso dal presidente
della Repubblica e dal primo ministro. Il primo viene eletto a doppio turno
direttamente dal popolo e nomina il secondo sulla base del risultato delle urne.
In Francia, appunto, si tengono elezioni separate per eleggere le due cariche ed
è possibile, quindi, una coabitazione tra un presidente di un partito e una
maggioranza opposta (l’ultimo caso è avvenuto tra il presidente neogollista
Jacques Chirac e il primo ministro socialista Lionel Jospin dal 1997 al 2002).
Vantaggi e svantaggi del
sistema presidenziale
Tra i punti di forza della
Repubblica presidenziale elencati dai costituzionalisti c’è proprio la «massima
legittimità» riconosciuta al presidente grazie all’elezione popolare. Altri
vantaggi sono il rafforzamento della separazione dei poteri e l’indipendenza del
Parlamento: il presidente e le Camere sono scelti in elezioni diverse e nessuno
dei due può interferire con l’altro; il Parlamento, inoltre, non dipende dal
partito di maggioranza nella Camera legislativa.
Tra gli svantaggi elencati
spesso dai costituzionalisti, invece, al primo posto è segnalata sempre
l’instabilità politica, citando come esempio le situazioni di tensione e i colpi
di Stato che si sono verificati nei Paesi dell’America Latina. Altro svantaggio
segnalato, la mancanza di pluralismo: nelle Repubbliche presidenziali è molto
accentuata la tendenza al bipartitismo.
Da liberoquotidiano.it il 12
agosto 2022.
Le parole di Berlusconi sul
presidenzialismo e sulla possibilità che Mattarella si dimetta hanno scatenato
una polemica senza fine, soprattutto a sinistra. Adesso prende la parola il
costituzionalista Michele Ainis, che all'Agi ha detto: "L’ipotesi più
desiderabile sarebbe quella di stabilire per l’eventuale riforma costituzionale
sul presidenzialismo l’entrata in vigore nella prossima legislatura, ma non in
quella che si formerà dopo il 25 settembre. In quel caso Mattarella sarebbe a
fine mandato e quindi sarebbe il prossimo presidente della Repubblica a essere
scelto in maniera diversa".
Ainis, poi, ha spiegato di
avere detto le stesse cose di Berlusconi in un articolo di qualche giorno fa,
senza però suscitare lo stesso effetto: "Se si passa a un sistema presidenziale
il presidente deve andare via, o perché la legge stabilisce l’immediata
decadenza, oppure - come dicevamo ed è l’ipotesi più auspicabile - la riforma
dovrebbe entrare in vigore nella prossima legislatura, ma anche in quel caso
Mattarella non so se accetterebbe di continuare un interregno, tanto più se
questo dovesse passare per un referendum".
Un altro costituzionalista
intervenuto sul tema è Alfonso Celotto, che sempre all'Agi ha detto: "Mattarella
non rischia assolutamente nulla: non è referendum su Monarchia o Repubblica, ma
un procedimento complesso: serve un’articolata riforma costituzionale per
passare a un presidenzialismo all’americana o a un semipresidenzialismo alla
francese. Dunque, eventualmente, ci vorrebbe qualche anno".
Un chiarimento sulla
questione, poi, è arrivato anche da Berlusconi in persona: "Ho solo detto una
cosa ovvia e scontata, e cioè che, una volta approvata la riforma costituzionale
sul Presidenzialismo, prima di procedere all’elezione diretta del nuovo Capo
Dello Stato, sarebbero necessarie le dimissioni di Mattarella che potrebbe
peraltro essere eletto di nuovo. Tutto qui: una semplice spiegazione di come
potrebbe funzionare la riforma sul Presidenzialismo proposta nel programma del
centro-destra. Come si possa scambiare tutto questo per un attacco a Mattarella
rimane un mistero. O forse si può spiegare con la malafede di chi mi attribuisce
un’intenzione che non è mai stata la mia".
La sinistra e l’ossessione
per l’inviolabilità della nostra Costituzione.
IL COMMENTO | “La Costituzione
è tornata ad essere la più bella del mondo, quindi intoccabile, anche nel titolo
quinto”.
Francesco Damato su Il Dubbio
l'11 luglio 2022.
Anche se non lo ha detto, o
non ancora in modo esplicito, limitandosi a lamentare “la scelta riformista”
abbandonata o tradita da Enrico Letta per accordarsi anche con i rossoverdi
nella partita elettorale contro il centrodestra, deve avere contribuito alla
rottura, “strappo” e quant’altro di Carlo Calenda la blindatura
della Costituzione uscita proprio dall’intesa fra il segretario del Pd, i rossi
di Nicola Fratoianni e i verdi di Angelo Bonelli. Una Costituzione – hanno
avvertito costoro- minacciata dal progetto del presidenzialismo riproposto da
Giorgia Meloni ormai lanciata verso Palazzo Chigi. Alla quale Silvio Berlusconi,
una volta tanto deludendo forse quel Matteo Salvini cui aveva concesso troppo
secondo i “traditori” appena usciti da Forza Italia, ha riconosciuto – in una
intervista alla di avere un “coraggio” pari al suo.
Il presidenzialismo, del
resto, è sempre stato nelle corde di Berlusconi, come lo fu in quelle
dell’amico Bettino Craxi. Che si procurò per questo negli
anni Settanta su Repubblica le vignette in posa mussoliniana di un Giorgio
Forattini pur non generoso con i comunisti. Ai quali il leader socialista era
tanto indigesto da meritarsi nei menù alle feste dell’Unità l’intestazione della
trippa.
All’improvviso, con questa
storia del presidenzialismo in salsa meloniana, che un centrodestra vittorioso
nelle urne del 25 settembre potrebbe introdurre con una maggioranza tanto larga
da non correre neppure il rischio di un referendum confermativo, la Costituzione
è tornata ad essere a sinistra la più bella del mondo, come ai tempi di Pier
Luigi Bersani e della scuola del Pd affidata all’alta autorità, diciamo così,
del presidente emerito della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Che era tornato
alla politica militante, dopo i sette anni trascorsi al Quirinale, per condurre
e vincere il referendum costituzionale targato Berlusconi e Bossi.
La Costituzione, dicevo, è
tornata ad essere la più bella del mondo, quindi intoccabile, anche nel titolo
quinto – sui rapporti fra Stato e regioni modificato a stretta maggioranza in
tempi d’Ulivo per inseguire inutilmente i leghisti e alla fine riconosciuto
dalla stessa sinistra come un maledetto incidente. Al quale non fu possibile
rimediare neppure con la riforma costituzionale voluta dall’allora segretario
del Pd e insieme presidente del Consiglio Matteo Renzi nel 2016: bocciata, come
si ricorderà, a prescindere dal suo contenuto, giusto per colpire e poi
affondare la nave renziana. Dalla quale era sceso anche Silvio Berlusconi per la
corsa al Quirinale del 2015, fatta vincere a Sergio Mattarella da Renzi, sempre
nella doppia veste di capo del suo partito e del governo.
Proprio a proposito di
quell’infortunio del titolo quinto, riconosciuto ben prima che l’emergenza
pandemica ne rendesse ancora più evidenti i danni, Massimo D’Alema si distinse
nell’opposizione alla riforma costituzionale di Renzi dicendo che “in pochi
mesi” se ne sarebbe potuta approvare un’altra. Sono passati sei anni e siamo ad
un’altra campagna di intangibilità costituzionale per nuovi, sopraggiunti
pericoli di una destra ritenuta sostanzialmente eversiva. Che vorrebbe
introdurre sistemi istituzionali ai quali l’Italia non sarebbe adatta, matura e
quant’altro.
E’ appena intervenuto
l’emerito professore e presidente della Corte Costituzionale
Gustavo Zagrebelsky per spiegarci in una intervista alla Repubblica di carta
come e perché non ci meritiamo un presidente della Repubblica eletto
direttamente dagli “italiani”, peraltro indicati nella riforma Meloni come
sostantivo e non aggettivo, senza la qualifica di «cittadini, come sta scritto
nella Costituzione del 1948». «E’ una sfumatura, ma significativa», ha avvertito
il professore aggiungendo misteriosamente che «anche la scelta delle parole
restituisce una diversa idea della democrazia e dell’inclusione». Già, perché
fra gli inconvenienti dell’elezione diretta del presidente della Repubblica ci
sarebbe quello di avere ogni volta un vincitore e uno o più sconfitti, ossia
esclusi, come i «sudditi» – anziché «cittadini» negli «altri regimi».
Noi italiani, anche quelli
nati e cresciuti dopo il fascismo, abbiamo secondo Zagrebelsky una specie di
gobba, ancora più accentuata del compianto Giulio Andreotti, che non ci permette
d’indossare l’abito del presidenzialismo. Scomodando addirittura il Tacito degli
Annali Zagrebelsky ci ha accusati di “rudere in servitium”, cioè di “propensione
di accorrere al servizio” dell’imperatore di turno. «Esiste – ha insistito il
professore- una nostra attitudine a servire il potente che è ampiamente
dimostrata dal consenso plebiscitario a Mussolini sotto il fascismo. Un
affrettarsi sul carro del vincitore che può rovesciarsi anche nel suo contrario,
ossia nell’abbandonarlo precipitosamente ai primi segni di debolezza». Con
questi argomenti non politici, non filosofici ma addirittura antropologici, e un
po’ anche razzisti, diciamo la verità, dovremmo quindi difendere tutti
l’intangibilità della Costituzione, a dispetto dell’articolo 138 che ne
disciplina la “revisione”, testuale, fatta eccezione per la “forma
repubblicana», precisa l’articolo successivo.
Perché oggi si festeggia la
Giornata dell’Unità nazionale.
Chiara Barison su Il Corriere della Sera il 17 marzo 2022.
Il 17 marzo di 161 anni fa a
Torino nasceva il Regno d’Italia, mentre l’inno di Mameli è stato riconosciuto
ufficialmente solo nel 2017.
Era il 17 marzo 1861 quando a
Torino veniva proclamato il Regno d'Italia con l'incoronazione di Vittorio
Emanuele II. Oggi sono passati 161 anni e dal 2013 si festeggia la Giornata
dell'Unità nazionale, della Costituzione e della bandiera con l'obiettivo di
consolidare la consapevolezza della cittadinanza sui valori civici che fondano
la nostra Repubblica.
L’inno di Mameli
Il poeta genovese Goffredo
Mameli aveva appena vent'anni quando compose l'inno che ancora oggi tutti
intoniamo durante le occasioni ufficiali. Si narra che addirittura Giuseppe
Garibaldi ne fosse rimasto rapito, tanto da canticchiarlo durante la difesa di
Roma. Il Canto degli italiani debuttò nel lontano 1847 a Genova per opera della
Filarmonica Sestrese alla cui esibizione accorsero oltre 30.000 patrioti da
tutta la penisola. In un primo momento, l'inno era composto da cinque strofe. La
sesta venne aggiunta solo in un secondo momento per esprimere la gioia per
l'Italia finalmente unita. Anche se mise quasi tutti d'accordo sin dall'inizio,
nel corso della storia non sono mancati i detrattori. Uno su tutti fu Giuseppe
Mazzini, che riteneva il testo troppo semplice. Piacque invece al
musicista Michele Novaro: è merito suo la celebre musica legata all'inno. Dopo
essere stato censurato sia dopo l'unità - a favore della Marcia reale - e poi
durante gli anni del fascismo, nel 1946 il Consiglio dei ministri lo indicò come
inno nazionale "provvisorio". Si è dovuto attendere il 2017 affinché
fosse riconosciuto ufficialmente.
La Costituzione italiana
La Costituzione è più recente
dell'inno di Mameli. È infatti entrata in vigore nel 1948 grazie al lavoro
dell'Assemblea costituente. Al suo interno si trovano i diritti e i doveri dei
cittadini, oltre ai principi e alle libertà fondamentali. Si tratta di una
costituzione rigida, questo significa che è necessario un procedimento aggravato
per la sua modifica. A vigilare sulla conformità delle leggi rispetto a quanto
previsto dalla Costituzione è la Corte costituzionale che, nonostante fosse
prevista sin dall'inizio, vide regolato il suo funzionamento con legge solo nel
1953.
Costituzione italiana oltre
il politically correct, ecco come vorrebbero riscriverla i compagni.
Iuri Maria
Prado Libero Quotidiano il 17 marzo 2022.
La Costituzione va aggiornata,
perché il modello italiano si è sviluppato e bisogna che la Carta vi si
uniformi. È un lavoraccio, e va affrontato in diverse puntate. Bisogna
cominciare, ovviamente, dall'art. 1, che va emendato così: «L'Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro dell'italiano su sei che mantiene
tutti gli altri. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita votando a
sinistra». L'art. 6, così: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche. È fatta deroga per la minoranza di lingua italiana, troppo
divisiva».
Poi ovviamente l'art. 11, che
va riformato così: «L'Italia ripudia la guerra capitalista come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali. Salva quella del 25 aprile, ripudia inoltre ogni
forma di resistenza». La riforma dell'art. 12 sarà: «La bandiera della
Repubblica è l'arcobaleno della pace. È facoltativa, ma raccomandata,
l'apposizione della dicitura 'Hasta Siempre Ddl Zan'». L'art. 21 va emendato
come segue: «Tutti, a patto che esso sia democratico, hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione. In caso di dubbio, decide la magistratura
democratica».
Il 24 è da correggere così:
«La difesa è diritto subordinato al capriccio del magistrato, che fa ciò che gli
pare. La legge non determina i modi per la riparazione degli errori giudiziari,
perché il giudice non fa errori e se anche ne fa saranno affaracci di chi li
subisce». Idem il 25, da modificare così: «Nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, salvo che
si tratti del leader del centrodestra». Il 27 va sostituito da questo:
«L'imputato è un colpevole che tenta di farla franca, salvo il caso che sia un
magistrato». Vedremo poi le modifiche su famiglia e rapporti economici.
Cosa è stato. Calvosa
raccoglie in un romanzo gli intrighi del Novecento italiano.
Gianluca Calvosa su L'Inkiesta
il 5 Febbraio 2022.
Papi e comunisti, affari
illeciti e poco noti. “Il tesoriere” (Mondadori) racconta i passaggi più
delicati e oscuri dell’ultimo secolo e collega storie del passato al loro
riaffiorare meno visibile
L’udienza privata dal papa era
prevista per le undici e sarebbe stata l’ultima del 1972. Un’ora prima, Paolo si
fece riconoscere dalla guardia svizzera che piantonava Porta Sant’Anna e andò a
parcheggiare come da indicazioni nello spiazzo di fianco a piazza Pio XI. Andrea
e Sandra furono accompagnati all’ingresso della Sala Clementina, lo splendido
salone al secondo piano del Palazzo Apostolico accessibile unicamente in
circostanze particolari come quella. Lì furono accolti da una delle suore
deputate ad assistere il Santo Padre, che li invitò ad accomodarsi visto che ci
sarebbe stato da attendere qualche minuto.
Sandra, costretta a indossare
uno scomodo tailleur accollato acquistato per l’occasione, rimase senza fiato di
fronte alla bellezza del salone, un trionfo abbagliante di affreschi e mosaici
geometrici. Andrea, che per l’occasione aveva cercato di dare tono a uno dei due
abiti del suo risicato guardaroba arricchendolo con una cravatta troppo costosa
per i suoi standard, si era ritrovato inconsapevolmente a stringere la mano
della moglie, stupita dal suo inusuale nervosismo.
«In fondo è la prima volta che
veniamo ricevuti da un capo di Stato» si ritrovò a giustificarlo lei. Ma quello
che la colpì maggiormente fu lo scatto con cui si alzò in piedi mentre si apriva
la grande porta decorata. Sulla cui soglia apparve Ottavio, seguito da uno
stuolo di suorine dietro le quali spiccava la sagoma bianca del pontefice.
Intorno a lui tre cardinali in tunica porpora e un uomo in abiti civili con una
grande macchina fotografica a tracolla.
Andrea si ricordò in extremis
del protocollo e lasciò che fosse Sandra a salutare per prima il papa, il quale
le prese entrambe le mani nelle sue mentre lei si esibiva controvoglia in un
accenno di inchino. Il pontefice le rivolse un sorriso benevolo e le sfiorò il
viso con una carezza, poi si voltò verso il tesoriere e gli tese la mano con il
palmo rivolto verso il basso. Le spalle leggermente incurvate su cui poggiava la
mantella bianca e il viso tondo dall’espressione gioviale e dalla carnagione
rosea più accesa sulle guance componevano un ritratto perfetto di pace e
accoglienza. Andrea pensò che Dio non avrebbe potuto scegliere candidato più
giusto a interpretare il ruolo di suo rappresentante tra gli uomini.
«Andrea, abbiamo sentito belle
cose su di te».
Inaspettatamente, sentire il
papa pronunciare il suo nome gli fece un certo effetto. Il colloquio durò pochi
minuti, il tempo sufficiente a ribadire la posizione antisovietica del Vaticano.
«A cosa serve lottare per la libertà degli oppressi se il giorno dopo ci
trasformiamo in oppressori?» fu la retorica, quanto attesa, domanda del papa.
Al termine del cerimoniale che
si concluse con un paio di fotografie e una benedizione non richiesta, Ottavio e
il cardinale Bonidy proposero agli ospiti una visita ai Giardini Vaticani. Il
cardinale prese sottobraccio Andrea mentre Ottavio chiacchierava con Sandra,
accelerando il passo per lasciare suo fratello solo con il suo superiore.
L’udienza con il pontefice aveva avuto come unico scopo quello di mettere in
soggezione Andrea. Il vero colloquio si sarebbe tenuto con Bonidy.
«Siete molto diversi, lei e
suo fratello». Quelle parole suonarono strane in bocca a un cieco.
«Lui è la parte sana della
famiglia». replicò ironicamente Andrea.
«E lei quale parte è?»
«Quando deciderò di
confessarmi, glielo farò sapere». «Perché, cos’ha contro la confessione?»
«È una debolezza. Noi
comunisti non ci liberiamo mai del peso dei nostri errori confessandoci.
Preferiamo il dibattito pubblico. Per questo stampiamo tanti giornali».
«Per stampare tanti giornali
occorre un’organizzazione costosa».
«Quello è lo scopo principale
del mio incarico».
«Trovare soldi?»
«Organizzare la macchina della
propaganda».
«Quindi secondo lei è solo
questione di propaganda. Non pensa di sottovalutare la capacità di giudizio
delle persone?»
«Vostra Eminenza» il tono di
Andrea suonava come un invito alla franchezza «le persone credono a qualunque
cosa se ripetuta un numero sufficiente di volte. È per questo che vi siete
inventati la messa».
«Facciamo così, sarò io a
confessarmi con lei. L’ultima volta che ho incontrato Fragale ho usato parole di
cui mi sono pentito. In fondo era una persona perbene».
«In fondo?» Ad Andrea scappò
un sorriso. «Mi dica, cardinale, cosa possono mai avere da discutere il
presidente dello Ior e il tesoriere del Pci?»
«Di molte cose. Della
necessità di essere artefici del proprio destino, ad esempio. Di decidere,
quando le circostanze lo richiedono».
«Quelli come me e Fragale sono
al servizio di un disegno, si attengono alle regole. Le decisioni le prendono
altri».
«Al servizio di un disegno!» A
Bonidy scappò una risatina.
«Lei parla proprio come un
prete. A noi queste cose insegnano a dirle al seminario». L’alto prelato fece
una pausa e tornò serio.
«Io l’ho fatto a New York. Una
città bella ma difficile, soprattutto per un cieco, e specialmente se solo.
La capisco, sa, ho imparato
presto cosa significa non avere qualcuno con cui condividere il fardello dei
propri pensieri».
Quelle parole evocarono nella
mente di Andrea gli incubi che riguardavano suo padre. Restò in silenzio
lasciando che il cardinale continuasse il suo ragionamento mentre camminavano a
passo lento.
«Ritrovarsi soli ci obbliga a
prendere delle decisioni. Mi ricordo bene quando non trovai mia madre ad
aspettarmi come tutti i pomeriggi all’uscita dal seminario. Avevo sedici anni,
mio padre era appena passato a miglior vita e sapevo che lei da quel giorno non
sarebbe più venuta a prendermi. Avrei dovuto attraversare da solo tutta
Manhattan. Aspettai quasi dieci minuti sulla gradinata della chiesa prima di
mettermi in cammino. Poi finalmente mi decisi. Anche se conoscevo bene la strada
mi persi quasi subito e restai bloccato a un incrocio affollatissimo. Ero
confuso, spaventato dal rumore dei clacson, dalle urla dei venditori di hot dog,
dal rombo delle auto. Per la prima volta in vita mia mi sentii veramente solo.
Aspettai qualche minuto, in attesa che qualcuno mi notasse e mi aiutasse ad
attraversare. Ma niente. Fu proprio quando mi convinsi a chiedere aiuto che
sentii toccarmi il braccio con gentilezza. Il sollievo durò pochi secondi. Si
trattava di un altro cieco. Un signore anziano che tremava e stava a malapena in
piedi».
Il cardinale si fermò. Sembrò
rivivere fisicamente quel momento. «Gli dissi di tenersi a me, senza pensarci un
instante. Gli presi la mano e attraversammo insieme. Fu il momento più
emozionante della mia vita. E anche quello più rivelatore».
da “Il tesoriere”, di Gianluca
Calvosa, Mondadori, 2021, pagine 396, euro 19
La Costituzione come non
l'avete mai letta.
Michele Ainis su La Repubblica il 20 febbraio 2022.
Il presidente della Repubblica
Enrico De Nicola firma la Costituzione (1 gennaio 1948)
Due ricercatori hanno scoperto
che il testo della Carta promulgato dal presidente De Nicola non coincide in 26
articoli con quello approvato dai padri costituenti. Ma il senso è inalterato.
Sorpresa: la Costituzione che
tutti conosciamo (o almeno dovremmo), quella che si studia già sui banchi di
scuola, che campeggia sulla scrivania del presidente Mattarella e in mille
biblioteche, insomma il documento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e
promulgato da Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 - ecco, quel testo non
coincide con il testo approvato cinque giorni prima dall'Assemblea costituente.
La nostra democrazia
un lungo cammino scritto nella Costituzione.
Sergio Mattarella su Il
Corriere della Sera il 14 febbraio 2022.
Il capo dello Stato nella
prefazione al saggio di Ruffini: «Queste pagine parlano delle parole da
ricordare. Delle parole che costruiscono. Parole che uniscono»
Pubblichiamo la prefazione del
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al libro di Ernesto Maria
Ruffini «Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1848 ad
oggi»
Questo libro racconta la
nostra storia, le nostre radici e ci invita a fidarci del futuro. Leggerlo fa
riflettere sulla radice della parola «Parlamento»: il luogo dove le parole
costituiscono, fondano, la nostra identità senza congelarla in un simulacro. Fa
pensare allo spreco che spesso si fa delle parole. E al peso che le parole
hanno. Fa pensare alle parole che costruiscono e a quelle che possono
distruggere. Alle parole vuote, insignificanti, che non impegnano; e a quelle
piene, dense di significati.
Parole da ricordare o da
dimenticare. Queste pagine parlano delle parole da ricordare. Delle parole che
costruiscono. Parole che uniscono.
È il racconto di come noi
italiani siamo stati capaci di riempire di contenuto e spessore una parola
speciale, impegnativa: uguaglianza. L’uguaglianza scolpita dai Costituenti
nell’articolo 3 della Costituzione. Per quanto oggi la stagione costituente
possa sembrare lontana — tanto abituati siamo a vivere solo del presente — è
proprio in quei giorni che possiamo ritrovare le fondamenta di ciò che siamo,
del nostro essere comunità. È su quella straordinaria esperienza che abbiamo
costruito la nostra casa comune, la nostra democrazia, il nostro Paese.
Consapevoli, come disse Piero Calamandrei, che esse erano solo l’inizio, non la
fine della storia: il preludio, l’introduzione, l’annuncio di una rivoluzione,
nel senso giuridico e legalitario, ancora da compiere.
La spinta che quella stagione
seppe imprimere alla nostra storia democratica e repubblicana fu talmente forte
che ancora oggi è chiaramente visibile. I segni e i semi lasciati nella nostra
storia dai principi fondamentali della Carta costituzionale rappresentano
tuttora il nostro patrimonio più prezioso. Il saggio di Ernesto Maria Ruffini ci
accompagna con pazienza lungo il cammino percorso fino ad oggi. Passo dopo
passo, ci riporta al momento in cui l’Italia usciva dalla tragedia della
dittatura e della guerra e, nella libertà, cominciava a costruire la sua nuova
democrazia. Ritroviamo, come in un racconto suggestivo, le immagini di momenti
tra i più significativi della nostra storia repubblicana e delle conquiste che
abbiamo raggiunto nel campo dell’uguaglianza, anche grazie a dure battaglie.
Non sempre è stato un cammino
facile. Semmai, a volte, faticoso. Di certo inarrestabile, anche se per molti
aspetti ancora incompleto. Capace di porsi nuovi traguardi, da raggiungere
insieme. Questa storia, il racconto di come un’idea diventa concreta nella vita
delle persone, ci consente di apprezzare quanta strada abbiamo fatto insieme.
Abbiamo raccolto da quella straordinaria stagione un’eredità che dobbiamo a
nostra volta consegnare alle nuove generazioni. Ognuno di noi come singolo
cittadino e tutti insieme come comunità dobbiamo sentire la responsabilità di
continuare a tessere la tela dell’uguaglianza con il filo che ci è stato
consegnato dalle generazioni che ci hanno preceduto.
Nel rileggere le parole che
hanno segnato i più importanti dibattiti parlamentari, che hanno accompagnato
l’approvazione delle leggi con le quali si è cercato di dare attuazione
all’uguaglianza, ci rendiamo conto di quanti risultati siano legati all’impegno,
al coraggio, alla caparbietà, e molte volte anche al sacrificio, di donne e
uomini che hanno tracciato la strada per tutti noi. Vediamo lo straordinario
viaggio della nostra democrazia e cogliamo lo sguardo attento dei cittadini che
chiedono al Parlamento di dare vita ai principi costituzionali. Comprendiamo il
ruolo della Corte costituzionale chiamata a garantire la piena osservanza della
nostra Costituzione. E intuiamo anche come sia responsabilità di ognuno
proseguire il cammino. Perché le leggi da sole non bastano. Le parole scritte
nelle raccolte legislative rischiano di rimanere fissate solo sulla carta se non
sono anche accompagnate dalla capacità di ognuno di fare il proprio dovere, di
sentirsi parte di una comunità. È un libro che può servire soprattutto ai più
giovani perché parla alla loro speranza e, raccontando la fatica, il dolore,
l’impegno civile di tanti italiani che hanno scritto con le loro vite la storia
della Repubblica, ci dice come sia inestimabile il valore della nostra libertà.
Da Craxi a Renzi, guai a
chi prova a toccare la Costituzione più bella…
Oggi una revisione della
Costituzione imporrebbe di ridisegnare i confini delle competenze tra i poteri
dello Stato restituendo al Parlamento un ruolo che oggi sfiora l'inesistenza.
Paolo Delgado Il Dubbio il 07 febbraio 2022.
È “la Costituzione più bella
del mondo”. Ne consegue che ogni tentativo di modificarla equivale a uno
sfregio. Qualcosa si può aggiungere, qualche particolare si può ritoccare ma
mettere mano all’impianto di fondo significherebbe aggiungere i baffoni a Monna
Lisa. Non solo un errore ma una bestemmia: delitto politico sufficiente a
stroncare carriere e circondare i proponenti di un’aura losca o peggio. In parte
almeno, ma in parte rilevante, l’eterna anomalia italiana, il guado a metà del
quale la Repubblica stagna da decenni, senza annegare ma in compenso marcendo
progressivamente, è qui.
Questa sacralità era solo in
parte voluta e prevista dai famosi “padri costituenti”. Scelsero
una Costituzione rigida e difficilmente riformabile, anche perché bruciava
ancora come fiamma non del tutto spenta il ricordo del fascismo. Però indicarono
anche la strada, stretta ma tutt’altro che impraticabile, per rimettere mano a
una Carta la cui “bellezza” non andava scambiata, come è poi invece di fatto
avvenuto, per eterna perfezione.
Il primo a bestemmiare, ad
affermare cioè che la seconda parte della Costituzione, quella sul funzionamento
dello Stato, necessitava di una revisione fu Bettino Craxi, in un editoriale
uscito sul quotidiano del Psi Avanti! il 25 settembre 1979. S’intitolava “Ottava
legislatura”, denunciava il “logorio del tempo” subìto dalla Carta, proponeva
una “Grande Riforma” che avrebbe dovuto toccare “l’ambito istituzionale,
amministrativo, economico-sociale e morale” e garantire così “l’efficacia
dell’esecutivo”. Tra le battaglie ingaggiate da Bettino Craxi nel decennio del
suo fulgore fu una delle più perdenti. Si risolse in un inutile “abbaiare alla
luna”, come sentenziò alla fine lo stesso Craxi. La commissione bicamerale per
la riforma fu effettivamente istituita nel 1983, guidata dal liberale Bozzi, ma
non concluse niente. Craxi, nel frattempo, era diventato agli occhi di una parte
vasta della pubblica opinione, in particolare a sinistra, una specie di
aspirante dittatore, figura pericolosa, sospetta, in odor di stretta
autoritaria.
All’inizio del decennio
successivo della necessità di svecchiare il capolavoro del dopoguerra parlò però
il guardiano della Costituzione in persona, l’allora presidente della
Repubblica Francesco Cossiga, in un lungo e dettagliato messaggio alle Camere
del 1991. Era una bomba a potenziale esplosivo talmente alto che il
premier Andreotti rifiutò di controfirmarlo e passò la palla avvelenata al
Guardasigilli Martelli. Il capo dello Stato aveva in mente una legge elettorale
maggioritaria, il potenziamento dell’esecutivo, la fine del bicameralismo
perfetto, un intervento drastico sulla magistratura. Nessuno accusò Cossiga di
tentazioni golpiste. In compenso lo fecero passare per matto.
Nel 1992, in piena tempesta
tangentopoli, il Parlamento ci riprovò, con una commissione bicamerale
presieduta prima da De Mita e poi, dopo le sue dimissioni, da Nilde
Iotti. Stavolta una proposta arrivò, modellata di fatto sul sistema tedesco. Ma
quando fu presentata, l’11 gennaio 1994, il referendum del 1993 aveva già
abbattuto la legge elettorale proporzionalista che aveva sino a quel momento
retto la Repubblica e tangentopoli aveva falcidiato un’intera classe politica
seppellendo la prima Repubblica. La proposta rimase lettera morta.
Il tentativo più serio di
riformare la Costituzione è stata la bicamerale presieduta da Massimo
D’Alema, allora segretario del Pds, istituita nel gennaio 1997 pochi mesi dopo
la vittoria elettorale dell’Ulivo di Romano Prodi: la grande occasione perduta
dalla politica italiana è stata quella. Nella situazione di terremoto permanente
di quella fase una riforma profonda della Carta sarebbe stata accettabile, anche
se su D’Alema si abbatterono gli strali delle tante vestali dell’intoccabilità
della Carta. Non furono quelle proteste però ad affossare la riforma ma la
richiesta di Berlusconi di modificare anche i capitoli sulla magistratura.
Richiesta non solo lecita ma doverosa: il PdS però non se la sentì.
Si potevano mettere le mani
nella forma di governo, nella struttura del Parlamento ma non toccare le toghe.
Il peso di quel fallimento ha pesato su tutta la politica italiana
determinando quella condizione di stagnazione in mezzo al guado dalla quale la
politica e le istituzioni non sono più riuscite a trarsi fuori. La maledizione
non risparmiò D’Alema: diventò seduta stante l’emblema della “intelligenza col
nemico”, delle trame segrete, dei “patti della crostata” stretti in segreto a
casa Letta. I panni di ‘uomo dell’inciucio’ non è più riuscito davvero a
strapparseli di dosso.
Una riforma costituzionale
però fu varata davvero nel corso di quella legislatura: l’ultimo giorno prima
dello scioglimento con una strettissima maggioranza. Era la riforma
“federalista” decisa dal centrosinistra per rispondere alla spinta federalista
della Lega e da allora ha fatto solo danni, al punto che a tutt’oggi non si
trova un leader disposto ad assumersi la responsabilità della sua approvazione.
Berlusconi ci provò di nuovo
con una revisione totale della seconda parte della Costituzione, stilata da tre
“saggi” riuniti in conclave a Lorenzago. Approvata a maggioranza dagli elettori
e poi bocciata dagli elettori nel referendum confermativo del 2006. E’
significativo che, all’opposto di 10 anni, del testo e del suo merito quasi non
si discusse affatto. Il Paese era ormai diviso in berlusconiani e
antiberlusconiani, e il voto si orientò solo su quella scelta.
La riforma di Matteo
Renzi, approvata nell’aprile 2016 e poi bocciata nel dicembre dello stesso anno
dal referendum popolare, aveva obiettivi meno ambiziosi della bicamerale di
vent’anni prima o della riforma di Lorenzago del decennio precedente. Mirava
soprattutto a eliminare il bicameralismo perfetto, trasformando la camera alta
in Senato delle Regioni e degli enti locali. Non andava dunque in direzione
diversa da quella indicata nel 1994 dalla commissione De Mita-Iotti. Tuttavia
anche in quel caso Renzi finì nel mirino perché accusato di tentazioni
autoritarie e sostanzialmente antidemocratiche.
L’aspetto per molti versi più
inquietante di questa visione, per cui solo un rispetto integrale e spesso
integralista della seconda parte della Carta è garanzia di rispetto della
democrazia, e del conseguente tiro al bersaglio che falcidia chiunque osi
proporne una revisione, è il puntuale conseguimento di risultati opposti a
quelli sbandierati. Il rifiuto di affrontare, normandolo, il problema di un
esecutivo troppo debole ha portato a una brutale “riforma di fatto” che ha
finito per consegnare all’esecutivo quasi tutte le prerogative che i costituenti
avevano affidato al Parlamento. Al punto che oggi il problema delle istituzioni
si presenta rovesciato rispetto a quando Craxi lanciò la sua ipotesi di “Grande
Riforma”. E’ infatti il potere legislativo quello che è stato via via svuotato
di significato, in un processo coronato dalla demagogica riforma costituzionale
voluta dal M5S e approvata in via definitiva dal referendum popolare del 2020.
Oggi una revisione
della Costituzione imporrebbe di ridisegnare i confini delle competenze tra i
poteri dello Stato restituendo al Parlamento un ruolo che oggi sfiora
l’inesistenza, come si verificherebbe persino con una oculata riforma in senso
presidenzialista. Certo, per farlo bisognerebbe smettere di considerare una
bestemmia qualsiasi ipotesi di profonda riforma costituzionale per lasciare
invece campo libero alle torsioni istituzionali realizzate praticando
l’obiettivo, senza norma né regola né soprattutto razionalità.
Le radici nascoste della
Costituzione.
Luigi Iannone il 22 dicembre 2021 su Il Giornale. Da qualche
giorno è in libreria il volume di Francesco Carlesi e Gianluca Passera, Le
radici nascoste della Costituzione. La terza via, il corporativismo e la carta
del 1948 (Eclettica edizioni, p.237, euro 16) con prefazione di Daniele
Trabucco, introduzione di Gherardo Marenghi e mia postfazione. Riporto,
di seguito, un brano tratto dal primo capitolo.
La Costituzione italiana è
stata spesso al centro di aspri dibattiti, ancor più oggi nell’epoca
dell’emergenza pandemica. Molti l’hanno costantemente dipinta come la «più bella
del mondo», per l’ampio spazio dato ai diritti politici e civili, altri l’hanno
messa sul banco degli imputati considerandola obsoleta e incapace di garantire
continuità politica e poteri adeguati ai governi. Eppure la parte più
significativa risiede negli articoli che trattano di materie economiche:
programmazione, ruolo economico dello Stato, riconoscimento giuridico dei
sindacati, collaborazione dei lavoratori alle imprese, disciplina pubblica del
credito, il Cnel sono tutti elementi ricchi di spunti chi volesse superare i
dogmi del neoliberismo e dell’individualismo. Il libro «Le Radici Nascoste della
Costituzione», sesta opera promossa dall’Istituto «Stato e Partecipazione»,
vuole andare alle radici di quelle impostazioni, che si collegano direttamente
alle idee di «terza via» e socializzazione espresse dal fascismo, ripercorrendo
minuziosamente tutto il dibattito costituente, la storia e il bagaglio culturale
di tanti protagonisti dell’epoca.
Gianluca Passera ha effettuato
una lunga e profonda ricerca su tutte le posizioni dei democristiani, dei
socialisti, dei comunisti e di tutti gli altri politici, professori e
intellettuali che animarono il primissimo dopoguerra, quando cominciava a
prendere forma la democrazia italiana dopo il crollo del fascismo. Un viaggio
affascinante che apre mille spunti di discussione a proposito della storia
italiana, allontanando qualsiasi semplificazione su quella complessa stagione.
Tra spaccature evidenti e punti di contatto, proprio nella parte economica del
testo costituzionale (artt. 35-47) riaffiorarono tanti spunti sociali emersi nel
dibattito economico tra le due guerre. Uomini come Fanfani, Moro, Pergolesi e
Mortati, d’altronde, dovevano gran parte della loro formazione al
corporativismo, teoria che tra le due guerre ambì a superare il liberismo,
recitando un ruolo importante nella discussione globale seguente alla crisi del
’29 e divenendo un modello internazionale per molti paesi.
Proprio queste considerazioni
portarono Gaetano Rasi a scrivere: «Non ha alcun fondamento la tesi che
all’egemonia della sinistra nella sfera pubblica abbiano contribuito i contenuti
della Carta costituzionale entrata in vigore nel 1948 in quanto i suoi principi
solidaristici e di tutela collettiva, soprattutto dei più deboli, rientrerebbero
nella tradizione marxisteggiante e del cattolicesimo democratico. La realtà
evolutiva è storicamente diversa. Quei principi erano già ben presenti prima del
periodo di elaborazione dell’attuale Costituzione e riguardavano una maturazione
dottrinale e politica risalente ai primi del Novecento e definiti
istituzionalmente negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso. La continuità, a
prescindere dalle fratture storiche, del pensiero politico che contribuì alla
messa a punto della Costituzione, è ampiamente rintracciabile nella produzione
scientifica precedente. Già nel 1940 Costantino Mortati aveva avanzato idee
rivolte ad una nuova Costituzione che sostituisse lo Statuto Albertino e
trasformasse in precettiva e formale la Costituzione materiale che si era andata
formando in Italia. Il prof. Mortati fu poi uno dei più attivi costituenti nel
corso del 1947.
Ed anche altri costituenti di
parte cattolica, come Amintore Fanfani, Aldo Moro, Paolo Emilio Taviani – tutti
usciti dai Littoriali della cultura (il primo come giudice, gli altri due come
concorrenti) – portarono nel dibattito costituente una sensibilità ancora
permeata dalla concezione corporativa. Tale pure un esponente della Dc, come il
prof. Alberto Canaletti–Gaudenti (che fu segretario della Dc romana), scriveva
allora un libro di prospettive dal titolo “Verso un corporativismo democratico”.
Nello stesso periodo anche da sinistra il giovane costituzionalista prof. Vezio
Crisafulli – passato ai comunisti dopo essere stato redattore capo della rivista
“Lo Stato” di Carlo Costamagna – esercitava la sua influenza nelle elaborazioni
impregnate di concetti partecipazionisti (tanto che poi egli rifluì, in un
percorso per certi versi simile a quello di Ugo Spirito, su posizioni vicine a
quelle missine). E pure non possono essere trascurati i giuristi allievi di
Gaspare Ambrosini (che fu poi Presidente della Corte Costituzionale e che era
fratello di quel Vittorio Ambrosini famoso per essere stato, prima, capo degli
Arditi del Popolo e poi tra i sostenitori del corporativismo); del prof. di
Diritto Civile Emilio Betti; del romanista Piero De Francisci; del prof. di
Diritto Amministrativo Menotti De Francesco (che fu rettore dell’Università di
Milano), del maggiore costituzionalista del secolo, il prof. Santi Romano, che
formò intere generazioni sulla base della sua teoria delle istituzioni. E ancora
non è possibile trascurare la partecipazione degli economisti alla Costituente.
A questo proposito, lo storico dell’economia Piero Barucci ha osservato che: “è
chiaro che le nuove generazioni, quelle che si erano formate nella palestra del
dibattito del corporativismo, non fecero un grande sforzo ad adattarsi a quel
tipo di discussione che si andava formando”. Ed è qui che fu evidente il ruolo
di produzione giuridico costituzionale degli economisti i quali, come Amintore
Fanfani e subito dopo Francesco Vito e la scuola dell’Università Cattolica con
Padre Agostino Gemelli, avevano espresso chiaramente la sua adesione ad una
corrente di pensiero politico che aveva superato le grette concezioni di destra
e sinistra».
In più, anche istituti come
l’Iri e le strutture dello Stato sociale furono usati proficuamente nel
dopoguerra dopo il ritorno del pluralismo partitico e sindacale in Italia.
Infine, ampi settori dell’Msi e della Cisnal cercarono di elaborare riforme
radicali della Costituzione, ma di fronte alla parte economica si affermò l’idea
di promuoverne l’attuazione concreta, sulle linee di partecipazione e centralità
del «lavoro» che già erano stati i capisaldi delle frange rivoluzionarie e
sociali del regime. Su questo si concentra in particolare Francesco Carlesi,
che, dopo un inquadramento storiografico del periodo ’45-’48, analizza tanto le
posizioni della “destra sociale” quanto di uomini come Mattei (che raccolse e
potenziò la struttura dell’Agip nata nel 1926) i quali portarono avanti progetti
alternativi di affermazione italiana sulla scena globale. Il tentativo fu quello
di andare “oltre” i due blocchi, nel disperato sforzo volto a dare all’Italia un
ruolo internazionale e una dignità, ad oggi sempre più lontana.
·
Quelli che…La Prima Repubblica.
Prima Repubblica,
atto finale. L’esperienza del governo Amato e il tentativo di far invertire la
rotta al Paese nel 1992.
Giuliano Cazzola su
L’Inkiesta il 22 Novembre 2022.
Dopo i drammatici
mesi di inizio anni Novanta l’esecutivo sperava di avviare una stagione conti
pubblici in ordine, privatizzazioni e altre riforme. Lo ha raccontato Giuliano
Cazzola nel suo ultimo libro “L’altro 1992. Quando l’Italia scoprì le riforme”,
di cui pubblichiamo un estratto
IBL Libri, la casa
editrice dell’Istituto Bruno Leoni, ha di recente pubblicato il nuovo libro di
Giuliano Cazzola, “L’altro 1992. Quando l’Italia scoprì le riforme”. Il libro
racconta l’esperienza del primo Governo Amato, che nei drammatici mesi che
videro gli attentati a Falcone e Borsellino e l’avvio di “Mani Pulite”, avviava
un percorso di riforme destinato ad aprire una nuova fase nella storia politica
dell’Italia.
Pubblichiamo di
seguito un brano tratto dall’introduzione del libro, che verrà presentato
giovedì 24 novembre a Milano presso la sede dell’Istituto Bruno Leoni. Insieme
all’autore interverranno Franco Debenedetti, Alessandra Del Boca e Mario
Monti. A Roma, invece, il libro verrà presentato il prossimo 12 dicembre. Con
l’autore, parteciperanno Giuliano Amato e Tiziano Treu.
La slavina ebbe
inizio il 17 febbraio del 1992 con l’arresto del socialista Mario Chiesa,
presidente del Pio Albergo Trivulzio, mentre intascava una “mazzetta”. La più
recente saggistica è tornata agli avvenimenti di quel periodo riconoscendo i
limiti e gli arbitri dei metodi di “fare giustizia” da parte delle procure a
cominciare da quella di Milano, che divenne la procura “più uguale” delle altre,
ammettendo – da parte degli stessi protagonisti – la costituzione di un circolo
mediatico-giudiziario che concertava le linea di condotta; in questo modo sono
emerse le contraddizioni di indagini che si concentrarono con particolare
accanimento su alcuni partiti e i loro leader, magari trascurando o
sottovalutando altre piste. Si è trattato di un lavoro di ricerca tardivo, ma di
revisione importante, non solo perché condotto con maggiore obbiettività e con
un minimo di pietas che allora fu negato a quanti furono coinvolti in
quell’operazione, ma anche perché in quei mesi la stessa classe politica che
veniva messa alla gogna iniziava un percorso di riforme che apriva una nuova
fase nella storia politica del Paese.
Protagonisti di tale
svolta furono il governo presieduto da Giuliano Amato e il parlamento degli
“inquisiti”, che non si sottrassero dall’assumersi pesanti responsabilità
nell’interesse del Paese in un momento di gravissima crisi, benché, ogni giorno,
calasse su alcuni di loro la scure dell’avviso di garanzia sempre “strillato”
sulle prime pagine dei quotidiani e in apertura dei Tg, mentre erano soliti
stazionare davanti al Palazzo di Giustizia milanese dei veri e propri presidi
permanenti. Da allora iniziò la trasformazione di un atto di garanzia per
l’indagato in una condanna già definitiva. Tangentopoli offuscò il lato virtuoso
di quegli anni difficili, che fu espunto dalle cronache perché niente doveva
essere salvato di una classe politica destinata all’infamia, in quanto corrotta,
privilegiata e intrallazzona. Non si poteva riconoscere a essa l’aver fatto
anche “cose buone”, tanto più che l’opinione pubblica non era pronta a misure
rigorose come quelle che furono adottate in quei mesi.
Per anni, l’Amato
del 1992 non ha potuto prender posto nella galleria degli statisti gloriosi.
Sulla sua compagine pesavano la condanna che il nuovo regime aveva decretato per
il vecchio, la maledizione di Mani pulite, la colpa di un risanamento
finanziario condotto con l’accetta e senza guardare in faccia a nessuno. Così si
era arrivati a falsificare non solo le pagine, ma persino la cronologia della
storia patria. La nuova era (quella del latte e del miele, delle virtù
repubblicane, dell’intelligenza applicata alle riforme) prendeva l’avvio, nelle
cronache ufficiali, col governo Ciampi, la personalità che era succeduta al
Dottor Sottile a Palazzo Chigi e che, per la prima volta, avrebbe avuto fior di
ministri ex comunisti se non fosse capitato quel maledetto 29 aprile 1993, un
incidente di percorso imprevisto, ovvero il voto della Camera che aveva respinto
l’autorizzazione a procedere contro Bettino Craxi e che aveva indotto Achille
Occhetto a chiedere le dimissioni di Vincenzo Visco e Augusto Barbera. Ma questa
è tutta un’altra storia. Forse di un’occasione sprecata.
La rimozione del
ruolo svolto dal governo Amato è arrivata ai nostri giorni. A gennaio di
quest’anno, quando si parlava dei possibili candidati al Quirinale, tra i quali
anche il Dottor Sottile, dell’azione dell’esecutivo da lui presieduto si
ricordava solo la sorpresa del taglio del “6 per mille” sui conti correnti, come
se si trattasse di un impeachment preventivo e permanente. Ma segnali di oblio,
molto più raffinati e profondi, si sono riscontrati in un’altra circostanza. Chi
scrive lo ha notato in una occasione particolare: la formazione della
maggioranza di unità nazionale e del recente governo presieduto da Mario Draghi.
In quei giorni di giustificata euforia (poi rientrata nel giro di alcuni mesi),
le cronache si accanirono nella ricostruzione di una sorta di albero genealogico
dei casi di buongoverno. La ricerca non poteva che partire da Palazzo Koch
(l’edificio con le palme di via Nazionale) sede della Banca d’Italia. Si sarebbe
potuto risalire a Luigi Einaudi, uno dei “padri” della ricostruzione e del boom
economico, che divenne il primo presidente della Repubblica, inaugurando un
cursus honorum che sembra essere lo sbocco naturale degli ex governatori,
chiamati, nelle ore più buie, a salvare il Paese.
Nel passare in
rassegna i governi di alto profilo del recente passato, i commentatori hanno
avuto una grave e ingiusta dimenticanza. Nessuno ha ricordato l’azione del primo
governo di Giuliano Amato. Fu l’ultimo rantolo della Prima Repubblica (ora
oggetto di una rivalutazione postuma persino eccessiva) ormai sottoposta allo
smantellamento per via giudiziaria. Eppure, quell’esecutivo, operò con coraggio
per consegnare ai posteri un’Italia meno sofferente di quella che gli era stata
affidata. Chi scrive è convinto che il coraggio prima o poi paghi sempre. E che
all’uomo di Stato sia chiesto di avere una visione di prospettiva, di saper
guardare più lontano degli altri. Anche per conto di chi insiste a non
allontanare gli occhi dalla punta dei piedi. Certo, a volte diventa
un’imperdonabile colpa aver compreso prima degli altri la via da seguire.
Purtroppo – come Eschilo fa dire al suo Prometeo incatenato – parlare è dolore.
Ma anche tacere è dolore.
Le elezioni del 1948, le
prime e le più importanti: la campagna infuocata e la sorpresa dei risultati.
Storia delle elezioni in
Italia - Il voto del 1948. Paolo Mieli su Il Corriere della Sera- CorriereTv il
19 Settembre 2022.
Le elezioni del 1948, le prime
e le più importanti: gli aiuti degli Usa e della Chiesa alla DC, gli aiuti della
Russia al PCI. La campagna elettorale infuocata negli animi, i risultati
sorprendenti, il 20% di scarto. Ecco cosa successe. L’analisi di Paolo Mieli.
Storia delle Elezioni
italiane: il voto del 1953. La grande tensione DC/PCI.
Paolo Mieli / CorriereTv su Il
Corriere della Sera il 20 Settembre 2022.
Il voto del 1953 fu in qualche
modo la rivincita del voto del 1948. La legge ad hoc, detta «legge truffa» dai
comunisti, e la frenata inaspettata della Democrazia Cristiana che segnò
il declino del suo capo Alcide De Gasperi. La seconda puntata della storia delle
elezioni italiane in 100 secondi.
Il voto del 1968 e il
centrosinistra che non si riprese mai più
Storia delle Elezioni
italiane: il voto del 1968 e le ripercussioni sui governi del centrosinistra.
CorriereTv
su Il Corriere della Sera il 21 Settembre 2022.
Le elezioni del maggio 1968 si
svolsero in un clima di sommovimento politico giovanile che aveva sconvolto
tutto il mondo. Per l’Italia ebbero un carattere particolare: eravamo nel pieno
dell’alleanza tra DC e i partiti di sinistra, escluso il Partito Comunista. I
socialisti e i socialdemocratici che si erano scissi nel ‘47, andarono a queste
elezioni unificati: ma insieme raccolsero meno voti di quanto non avrebbero
fatto da separati. Un fatto che ebbe ripercussione sui governi del
centrosinistra che da allora non si riebbero mai più.
Storia delle Elezioni
italiane: il voto del 1976 e il sorpasso a sorpresa della Dc sul Pc.
Paolo Mieli
CorriereTv su Il Corriere della Sera il 22 Settembre 2022.
Nelle elezioni del 1976
il Partito Comunista si giocò la carta del sorpasso forte del successo mel 1974
del referendum sul divorzio e dei risultati alle elezioni amministrative del
1975. Ma la Democrazia Cristiana era forte di appoggi esterni, tra tutti quello
di Indro Montanelli che in un celebre articolo scrisse: «Turiamoci il naso ma
votiamo Dc». E la Democrazia Cristiana, un po’ a sorpresa, prevalse di 4, 5
punti sul PCI senza la maggioranza assoluta: nacque così un governo di unità
nazionale per la prima volta dove i comunisti si astenevano. Il governo era
presieduto da Giulio Andreotti.
Storia delle elezioni
italiane: Il Pci sorpassa la Dc e diventa il primo partito in Italia.
di Paolo Mieli /
CorriereTv su Il Corriere della Sera il 23 settembre 2022.
Le elezioni europee del
1984 furono particolarmente importanti per l’Italia perché il Partito Comunista
riuscì, per la prima e unica volta, a scavalcare la Democrazia Cristiana. Un
evento che venne ricordato non soltanto per la vittoria del Pci, ma anche per la
scomparsa prematura del segretario del partito, Enrico Berlinguer. Colpito da un
ictus durante un comizio elettorale a pochi giorni dal voto, Berlinguer morì
«sul campo di battaglia» e commosse tutti gli italiani, anche chi non avrebbe
mai votato per il Pci.
La quinta puntata della storia
delle elezioni italiane in 100 secondi. La rubrica di Paolo Mieli in vista
delle elezioni politiche del 25 settembre.
La storia delle Elezioni in
Italia: il voto del 1994.
Paolo Mieli / CorriereTv su Il Corriere della Sera il 24
settembre 2022.
Il voto del 1994:
arriva Silvio Berlusconi con un’alleanza stravagante con la Lega al Nord
e Alleanza Nazionale al Sud e il tentativo contro le sinistre con poche
speranze. Il confronto televisivo da Enrico Mentana con Achille Occhetto e la
vittoria incredibile. L’anno benedetto di Silvio Berlusconi.
La storia delle Elezioni in
Italia: il voto del 1996.
di Paolo Mieli / CorriereTv su Il Corriere della Sera il 25
settembre 2022.
Il voto del 1996: dopo solo
due anni il governo formato da Silvio Berlusconi cade. La sinistra si
riorganizza e sotto la guida di Romano Prodi l’Ulivo vince nettamente. Per
l’unica volta nella storia della Seconda Repubblica la Lega si presenta divisa
dal centrodestra, dopo un litigio tra Umberto Bossi e Berlusconi tra la fine del
1994 e l’inizio del 1995.
"Una vita al vertice delle istituzioni”. La carriera di Andrea Manzella.
Da Aldo Moro a
Ciriaco De Mita, Spadolini e Ciampi, quella di Manzella è una vita vissuta al
vertice delle istituzioni italiane. Federico Bini il 21 Settembre 2022 su Il
Giornale.
Andrea Manzella, all’età di
quasi 90 anni, splendidamente portati, ricorda con straordinaria lucidità e
simpatia gli anni di una carriera che lo ha visto protagonista nel ruolo di
“grand commis” di Stato. Dagli esordi come consigliere di prefettura a Benevento
a consigliere parlamentare della Camera dei deputati dal 1961 al 1980. Poi
consigliere di Stato, segretario della presidenza del Consiglio con Spadolini,
De Mita e Ciampi. Dall’83 all’87 è stato consigliere giuridico del ministro del
ministro della Difesa, ancora con Spadolini. È stato anche parlamentare
dell’Ulivo a Bruxelles e al Senato. Nel suo studio di professore nel centro di
Roma, immersi tra libri, giornali e documenti, si possono notare le foto di
Spadolini, Cossiga, Napolitano, Ciampi, Pertini e Mattarella con personali
dediche. Attualmente è presidente del Centro di studi sul Parlamento della
Luiss.
Professor Manzella, la sua
vita è stata profondamente legata alle istituzioni di questo paese, di cui è
stato costante servitore.
“Sì, ho vissuto le istituzioni
in molte articolazioni. Sono stato prima consigliere di prefettura a Benevento
(ricordo ancora i bravi sindaci della Val Fortore). Poi superai il concorso in
magistratura e sono stato pretore a Pordenone: un’esperienza che mi fece capire
l’Italia del miracolo economico. Pordenone era allora una capitale del successo
italiano: giorno per giorno nascevano e crescevano imprese. E poi c’era
l’ammirevole genio produttivo e creativo dei friulani. Dovevo però trasferirmi a
Roma, per ragioni mie, e vinsi un concorso come consigliere alla Camera dei
deputati. La lasciai, dopo quasi vent’anni, come direttore del servizio studi.
Nominato consigliere di Stato, su proposta di Nino Andreatta, cominciò la mia
esperienza a diretto contatto con la politica di vertice”.
Nel suo percorso di studio ha
avuto la possibilità di incontrare Aldo Moro.
“Ho fatto il primo anno di
università a Bari, dove Moro insegnava Filosofia del diritto, per poi completare
il percorso di studi a Napoli. Moro nelle sue lezioni in classe aveva
l’abitudine di fare una specie di appello mnemonico, quasi a stabilire un
contatto fisico con gli alunni. Poi quando stavo per andarmene da Bari a Napoli,
ci incontrammo casualmente e lui mi disse: 'Ho saputo che lei si trasferisce,
faccia attenzione a non perdersi in quella bolgia di Napoli'. Aveva ragione:
ebbi un periodo di molte difficoltà…”.
Moro diceva sull’Italia: “È un
paese dalla passionalità intensa ma dalle strutture fragili”. Condivide questa
frase?
“Assolutamente. Lui aveva
l’idea precisa di una Italia repubblicana in cui la passionalità politica si è
potuta incanalare per molto tempo nella struttura forte delle ideologie
politiche: popolar-cattolica, comunista. Queste si traducevano in
partiti-apparato con sezioni diffuse in tutto il territorio: erano il sostegno
“materiale” della nostra democrazia. Ma ci fu sempre la criticità di una fragile
struttura istituzionale, una dannosa eredità che ci portiamo dietro
storicamente: forse anche per il modo straordinario con cui si era arrivati allo
Stato unitario. Per molto tempo si governò con il meccanismo dei prefetti, senza
che si realizzasse l’idea di una dorsale statale solida, comune, condivisa.
L’avventura della grande guerra fu determinata anche da questo. Il tentativo di
cementare quelle strutture precarie con l’iniezione di una unificante idea
nazionale di integrazione territoriale (Trento e Trieste) che accomunava milioni
di italiani-soldati, dal sud al nord del paese. Senonché proprio dai reparti di
“arditi” che non vedevano realizzata in quel dopoguerra italiano la forte idea
di Nazione per cui avevano combattuto, vennero i primi germi della lunga vicenda
fascista”.
Dal centro-sinistra al
compromesso storico. Aldo Moro è la figura centrale di queste due grandi svolte
politiche italiane. Come furono vissute all’interno del palazzo?
“Il compromesso storico fu un
nuovo tentativo di realizzare quell’unità nazionale: ed ebbe un luogo
privilegiato nelle aule parlamentari. Ma non nell’aula dell’assemblea, bensì in
quelle delle commissioni dove si intrecciavano e compensavano le proposte
legislative dei grandi partiti. Un momento centrale di questa fase fu nel varo
di nuovi regolamenti parlamentari, nel 1971. Ne fu protagonista Sandro Pertini
alla Camera (seguì una rincorsa di Amintore Fanfani al Senato). L’indice più
chiaro fu l’introduzione del criterio della programmazione parlamentare che
poteva attuarsi solo nella necessaria intesa fra i gruppi maggiori. Prima del
1971 ogni sera si decideva l’ordine del giorno della seduta successiva… Lo
capirono subito i “gruppuscoli”: prima la frazione del Manifesto che denunciò
l’accordo “gruppocratico a scapito della vera opposizione”, poi i radicali di
Pannella. Ecco: al centro del compromesso storico non ci furono accordi tra i
partiti, ma accordi parlamentari sulla sostanza delle cose”.
Ugo La Malfa, a cui Lei è
stato vicino, negli anni ‘70 mancò l’elezione a presidente della Repubblica e a
presidente del Consiglio. Nel primo caso venne eletto Pertini e nel secondo
Andreotti. Cosa successe?
“L’elezione del presidente
della Repubblica italiana è stata sempre 'un mistero avvolto in un enigma'
avrebbe detto Churchill. In quella delicatissima vicenda c’è sempre qualcosa che
sfugge. Qualcosa che è sempre diverso da elezione ad elezione. Più chiara fu
invece la vicenda che vide La Malfa protagonista del famoso “tentativo” di
formare un governo. Determinante in quell’insuccesso una certa mancanza di
visione dei comunisti. La Malfa aveva proposto un direttorio dei segretari di
partito, in cui ci sarebbe stato anche Berlinguer, da affiancare al governo: che
però non avrebbe avuto ministri comunisti. In fondo, sarebbe stata
l’istituzionalizzazione - però con una estensione, davvero storica, al Pci -
della corrente prassi dei “vertici” dei segretari dei partiti della coalizione
di governo. Enrico Berlinguer non accettò questa soluzione, fermo sulla
pregiudiziale di una effettiva presenza comunista nel governo. La Malfa era già
consapevole che i democristiani non l’avrebbero mai accettato, in quel momento.
Rinunciò, perciò, per questi veti incrociati. Nacque così il governo Andreotti”.
Roberto Gervaso diceva su Ugo
La Malfa: “È perentorio, dogmatico, esclusivo. Le ragioni dell’avversario non
sono mai buone… Questa Italia non gli piace e si vede”.
“Sì, lui era molto critico
dell’Italia ma anche severo con se stesso. Però era pure quello che aveva il
miglior “telefono abilitato”. Poteva parlare, autorevolmente, con tutti: dal
prefetto di Forlì, al governatore della Banca d’Italia, ai segretari di tutti i
partiti. Alzava il telefono e parlava con l’Italia. Da questo punto di vista,
sarà stato critico, però era anche attentissimo ad avere un circuito relazionale
completo con tutti, senza nessuna esclusione, per capire le ragioni di tutti.
Era insomma un “antiitaliano” inclusivo, cioè sapeva cos’era l’Italia, le
profonde connessioni reali e aveva grande capacità nel giudicare l’autenticità
del valore degli uomini”.
Spadolini invece com’era?
“Spadolini era molto
“spadoliniano”: nel senso che era davvero come la vulgata giornalistica lo
raccontava (primo fra tutti il suo grande amico Montanelli). Dal punto di vista
umano, accanto alla famosa – e giustificata - consapevolezza di se stesso -
aveva il culto delle grandi, perduranti amicizie e una acutissima capacità di
introspezione delle persone. Severissimo nella ricerca della perfezione, era
spesso irascibile con gli intimi, con scatti di cui si pentiva rapidamente: in
contrasto con la sua aria bonaria, da saggio tranquillo… Da grande storico, era
straordinario nell’arte di arrivare subito al vero fondo delle cose e di rendere
le cose complesse in maniera semplice”.
In che modo la nomina di
Spadolini a presidente del Consiglio cambiò la politica dei primi anni ’80?
“Si verificheranno tre fatti
di rilievo costituzionale. In primo luogo, con la nomina di un leader di estrema
minoranza, venne capovolta la gerarchia dei partiti, fino allora intoccabile. Ci
fu, poi, l’istituzionalizzazione, per allora solo in via amministrativa,
dell’apparato della presidenza del Consiglio, come primo strumento operativo del
premier. E infine cominciò una comunicazione politica diretta fra il “presidente
del governo” e i cittadini. Lui fu il primo dei grandi comunicatori da Palazzo
Chigi (e ricordo ancora le accuse di “cancellierato”…). Non gli fu dato però il
tempo di affrontare radicalmente l’eterna “questione istituzionale”: di cui
aveva però individuato alcuni più urgenti elementi in un Decalogo alla base del
suo secondo, breve governo”.
I rapporti tra Spadolini e La
Malfa?
“Molto buoni nel reciproco
riserbo, come li ricordo. Era stato Ugo La Malfa, del resto, che aveva avuto la
geniale intuizione di fare entrare Spadolini nella grande politica: offrendogli
la candidatura nel prestigioso collegio senatoriale di Milano dopo la brusca
estromissione dalla direzione del Corriere della Sera”.
Con l’ascesa di Craxi a
Palazzo Chigi, Spadolini venne nominato ministro della Difesa. Tra le varie
vicende ci fu il caso di Sigonella. Lei a quel tempo era consigliere giuridico
del ministro repubblicano.
“La crisi di Sigonella si
articola in due fasi. La prima fu la decisa affermazione della sovranità
nazionale - con i carabinieri in armi che circondano nella base i militari
americani - nella competenza a processare i terroristi (per crimini compiuti su
una nave italiana) richiusi nell’aereo egiziano dirottato dai caccia USA. In
questa fase, Spadolini è assolutamente concorde con Craxi. La seconda fase vide
invece il ministro repubblicano schierarsi contro il presidente del Consiglio
quando venne a conoscenza che si era di fatto permessa, sia pure in confuse e
affannose circostanze, la fuga del terrorista Abu Abbas dal territorio e quindi
dalla giurisdizione nazionale”.
Dall’88 all’89 Lei affiancò
invece un altro presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita.
“A De Mita vanno riconosciuti
almeno tre meriti di grande importanza. In politica interna, ponendo una specie
di “questione di fiducia implicita” - minacciando dunque una crisi di governo di
esiti dirompenti, in perfetta sintonia con il segretario socialista - riuscì a
ottenere che le due Camere (a scrutinio segreto!) abolissero il voto segreto
(salvo i casi personali). La vergogna dei “franchi tiratori” che rendevano
ancora più fragile la endemica precarietà dei nostri governi fu per gran parte
eliminata. Con la legge n. 400 del 1988, riuscì (dopo 40 anni) ad attuare
l’art.95 della Costituzione che prevedeva una organizzazione specifica della
presidenza del Consiglio, completando così il percorso amministrativo
spadoliniano. In politica estera dette grande fiducia a Gorbaciov con la famosa
riunione di ministri a Mosca: comprendendo così che era quello un momento
irripetibile per una vocazione europea della Russia. Ma credo che ci sia un dato
interessante su De Mita, poco o mai sottolineato. Lui capì che c’era un’Italia
che doveva essere assemblata in maniera diversa: andando oltre la Dc, in un
partito liberal-democratico di massa. Una intuizione che anni dopo doveva essere
corroborata dai grandi successi elettorali realizzati, in modi certo assai
diversi, da Silvio Berlusconi”.
Però De Mita non vi riuscì…
“No, in quanto gli vennero
“tagliate le gambe”. Anche se lui fece l’errore, forse inevitabile a quel fine,
di tenere insieme la segreteria del partito e la presidenza del Consiglio”.
Era un politico cinico come lo
descrivono?
“Quando ricordo la sua
commozione alla notizia dell’assassinio di Roberto Ruffilli, il “suo” uomo delle
istituzioni, i suoi gesti di affettuosa familiarietà con gente “comune” e anche
la sua ansia di “vedere” ogni cosa dal lato umano, “esperienziale” - come diceva
- non ritrovo alcun segno di cinismo. Il suo servizio come sindaco di Nusco,
sino alla fine, spiega anche il risvolto “buono” di certi tratti duri di una
certa tradizione di gestione del potere locale”.
Con quali altri presidenti del
Consiglio ha avuto modo di collaborare?
“Carlo Azeglio Ciampi fu
l’ultimo: e il suo destino finale come Capo dello Stato era in un certo senso
chiaro. Mi colpirono molto, quando lo vidi da vicino al lavoro, la sua grinta
decisionista e la sua risolutezza nel richiamo costante ad una sua bussola di
patriottismo “euro-nazionale”. Nel lavoro aveva l’abitudine di non finire la
giornata se non quando la sua scrivania fosse sgombra da ogni dossier. Quando,
poi, anni dopo, si ebbe di nuovo bisogno di lui come ministro per il nostro
difficile ingresso nell’euro, Ciampi giocò senza remore il suo prestigio e la
sua serietà internazionali. Raccontava che capì che si apriva qualche
possibilità nel muro dei “no” all’Italia quando, in un suo colloquio
confidenziale con il governatore della Bundesbank Tietmeyer, questi, pur
escludendo ogni apertura, gli chiese a bruciapelo: 'Ma nel caso che noi
decidessimo di accettare l’Italia nell’euro, tu nel direttorio della Banca
centrale europea chi manderesti?'. Ciampi rispose pronto: “Tommaso Padoa
Schioppa”, un nome che nessuno in Europa poteva rifiutare…”
Nel corso della sua lunga
carriera istituzionale con quali politici ha avuto un rapporto particolarmente
stretto?
“Nino Andreatta, Spadolini, De
Mita, Ciampi e con il grande intellettuale comunista Alfredo Reichlin”.
Giulio Andreotti?
“Assai meno. Quando lo conobbi
da vicino, Andreotti mi apparve come lo si è sempre raffigurato: molto “romano”
nella sua abitudine a minimizzare, a sdrammatizzare tutto. Una volta gli chiesi
come aveva vissuto i giorni fondativi della comunità europea. Rispose: 'Vedevo
De Gasperi, Adenauer e Schuman che si mettevano in un angolo e cominciavano a
parlare in tedesco. Sai, io non conosco il tedesco, però capivo tutto'. Un’altra
volta raccontò di aver riconosciuto il grande filosofo cattolico francese
Jacques Maritain in un passeggero vociante con i camerieri nel vagone-ristorante
del treno Genova-Roma per una banale questione di priorità nel servizio… Ecco in
questa “maniera” c’era tutto il popolarismo di Andreotti che ho conosciuto. Poi,
per altri lati, il personaggio è, come si dice, affidato al giudizio storico”.
A Roma si dice che Lei e
Gianni Letta siate uomini “influenti”.
“Io davvero non lo sono mai
stato. Gianni Letta è un vecchio e caro amico: mi rivolgerei a lui, nel caso…
Nelle mie esperienze istituzionali ho sempre e solo cercato di migliorare, per
quel che potevo, il meccanismo che mi era affidato, di guardare un po’ più in là
della semplice ripetizione burocratica dei “precedenti”, di rimediare, nel mio
assai modesto margine d’azione, a qualcuna di quelle istituzionali “fragilità”
di cui, una volta per sempre, aveva parlato Moro”.
Pavia, morto a 98 anni ex
ministro Virginio Rognoni. Esponente della Dc è stato vicepresidente del
Consiglio Superiore della Magistratura dal 2002 al 2006. Redazione online su La
Gazzetta del Mezzogiorno il 20 Settembre 2022
È morto questa notte, nella
sua casa di Pavia, Virginio Rognoni, uno dei politici italiani più conosciuti
della seconda metà del Novecento. Rognoni, che aveva compiuto 98 anni lo scorso
5 agosto, si è spento nel sonno. Docente alla facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Pavia, è stato un personaggio di primo piano della Dc. Fu
ministro dell’Interno negli anni di piombo (dal 1978 al 1983) e,
successivamente, di ministro della Giustizia e della Difesa. Dopo la fine
dell’esperienza della DC, aveva aderito prima al Partito Popolare e poi al
Pd. E’ stato vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 2002
al 2006.
BIOGRAFIA DI VIRGINIO
ROGNONI. Da cinquantamila.it la storia raccontata da Giorgio Dell'Arti
• Corsico (Milano) 5 agosto
1924. Politico. Deputato dal 1968 al 1994 (Dc), fu ministro dell’Interno
nell’Andreotti IV e V, Cossiga I e II, Forlani, Spadolini, Fanfani V
(1978-1983), ministro di Grazia e giustizia nel Craxi II e Fanfani VI
(1986-1987), della Difesa nell’Andreotti VI e VII (1991-1992). Dal luglio 2002
al luglio 2006 fu vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura.
• «Ex allievo del collegio
Ghislieri di Pavia, Gingio per gli amici, è un esemplare pregiato di quella
scuderia del Biancofiore che vinceva tutto nelle corse elettorali e nei Grand
Prix elettrizzanti per Palazzo Chigi. Il 26 aprile 1945, a ventuno anni, teneva
a Pavia il suo primo comizio ai giovani cattolici della Fuci. Le sue fortune
ministeriali sono dipese in buona parte dalla grande forza contrattuale della
sinistra di Base (prima “Cronache sociali” di Dossetti poi Marcora, De Mita,
Misasi, Andreatta). Per tanti anni è stata questa la sua corrente di
riferimento. Cioè fino all’estate del 1990. Quando Gingio, entrato un po’ nel
cono d’ombra della sinistra dc, subentra alla Difesa a Mino Martinazzoli nel
sesto governo Andreotti. Il Guardasigilli si dimette insieme ad altri tre
ministri dc per protesta contro la legge Mammì sull’emittenza televisiva. Una
rottura dolorosa.
“Mi sono iscritto alla Dc non
ad una componente”, dichiarò piccato il ribelle nella quiete del suo buon ritiro
di Punta Ala. Fece grande rumore una sua battuta maligna (“Bettino è già
cotto!”) sul Craxi presidente del Consiglio, strappatagli “a tradimento” nel
Transatlantico dal cronista politico dell’Espresso, il bravo Guido Quaranta.
Insomma, per dirla con le parole di sua moglie Giancarla Landriscia, donna che
affascinava per intelligenza, delicata bellezza e simpatia Sandro Pertini e gli
inquilini dei Palazzi romani, la famiglia Rognoni “ha sempre mantenuto il senso
delle proporzioni”.
Con il marito politico e
ministro, Lady Giancarla ha diviso la responsabilità di una famiglia numerosa
(quattro figli) e gli studi di Giurisprudenza. Lei a Pavia dedita all’istituto
di Medicina legale a studiare i diritti alla salute; lui, professore di
Istituzioni di diritto processuale, impegnato a Roma a guidare prima il
dicastero dell’Interno negli anni di piombo (affronta e risolve il caso del
rapimento del gen. Dozier) poi quello della Giustizia» (Fernando Proietti).
• Uno dei dodici saggi
dell’Ulivo chiamati a scrivere il manifesto del Partito democratico, ultimato
nel febbraio 2007. Presidente del Collegio dei garanti del Pd «La storia dei
cattolici democratici è legata, con i suoi valori, alla comprensione della
laicità della politica, al gioco della libertà e al dovere della giustizia.
Questa coscienza i cattolici l’hanno trovata nel Pd» [Cds 7/11/2009].
• Visto anche a teatro, a
Milano, in uno spettacolo dedicato a Danilo Dolci: il regista Renato Sarti,
riproponendo il processo all’intellettuale, gli fece pronunciare l’arringa di
Piero Calamandrei sui principi della Costituzione (affidata in altre serate ad
altri non-attori).
• Nell’autunno 2007 suscitò
polemiche l’assegnazione, senza concorso, di un incarico di professore associato
(Storia della lingua neogreca) alla figlia Cristina da parte dell’Università di
Palermo. Disse di essere «indignato»: «Si sa bene che ci sono nicchie di
privilegi nelle università, ma lei è sempre stata di una moralità radicale».
L'ultimo 'incarico' da
vicepresidente del Csm. È morto Virginio Rognoni, storico esponente della DC: fu
ministro degli Interni negli anni di piombo.
Redazione su Il Riformista il 20 Settembre 2022
Si è spento nel sonno all’età
di 98 anni Virginio Rognoni. Esponenti di primo piano della Democrazia
Cristiana, fu uno dei protagonisti della ‘Prima Repubblica’: aveva compiuto 98
anni lo scorso 5 agosto ed è morto questa notte nella sua casa di Pavia.
Docente alla facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Pavia, è stato un personaggio di primo piano
della Dc. Fu ministro dell’Interno negli anni di piombo, entrando al Viminale
dopo le dimissioni di Francesco Cossiga a seguito dell’assassinio di Aldo Moro,
fu nominato al suo posto e restando in carica dal 1978 al 1983. Successivamente
fu ministro della Giustizia nel secondo governo Craxi e nel sesto
governo Fanfani (dal 17 aprile 1987 al 29 luglio 1987) e ministro della
Difesa nel sesto e settimo governo Andreotti (dal 26 luglio 1990 al 28 giugno
1992).
Da ministro dell’Interno è
ricordato per aver affidato il coordinamento della lotta al terrorismo al
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e per esser stato promotore assieme al
deputato del Pci Pio La Torre della prima legge desinata a colpire i beni
gestiti dalla mafia, la legge Rognoni-La Torre.
Dopo la fine dell’esperienza
della Democrazia Cristiana, spazzata via da Tangentopoli, ha aderito al Partito
Popolare guidato da Mino Martinazzoli.
È stato vicepresidente del
Consiglio Superiore della Magistratura dal 2002 al 2006, ultima esperienza
istituzionale. Dopo l’incarico a Palazzo dei Marescialli, Rognoni aderirà
al Partito Democratico.
“Un grande amico e un punto di
riferimento”, lo definisce Enrico Letta, che ha commentato su Twitter la
scomparsa dell’ex ministro. Rognoni è stato “protagonista sempre in positivo di
tante stagioni importanti della vita istituzionale del nostro Paese”, lo ricorda
il segretario del Partito Democratico. Nel 2007 Rognoni è stato scelto come uno
dei dodici saggi dell’Ulivo chiamati a scrivere il manifesto del Partito
democratico.
M. Antonietta Calabrò
per justout.it il 21 settembre 2022.
L’ intramontabile “Gingio”,
grande vecchio della politica italiana. Non volle rispondere alla Commissione
Moro II, dopo la desecretazione degli archivi. Di lui si può ben dire che è
stato grande vecchio della politica italiana. Un potere solido, non ostentato,
durevole, attraverso decenni e decenni della storia italiana e dei suoi momenti
più drammatici. Morto il 20 settembre 2022 quasi centenario, essendo nato nel
1924. Un gran lombardo. Ancora in forma e attivo, sino alla fine. L’ultima
apparizione pubblica, nella primavera del 2021 per la celebrazione dei 660 anni
della fondazione della “sua” università, quella di Pavia, dove è stato
professore.
Virginio Rognoni era ministro
dell’Interno, quando il 9 ottobre 1982 un commando palestinese riferibile ad uno
dei terroristi più temibili, fondatore del Consiglio rivoluzionario di al Fatah,
Abu Nidal, mette a segno un attentato proprio nel centro di Roma. Davanti alla
Sinagoga, a pochi passi dal Tevere. Nell’agguato muore un bambino di due anni,
Stefano Gaj Talché, cittadino italiano di religione ebraica e altre 37 persone
rimangono gravemente ferite.
Il fatto nuovo (riportato per
primo da "Il Riformista” un anno fa) è che in base ai documenti ufficiali del
Sisde (il servizio segreto per la sicurezza interna, ora AISI) desecretati in
questi ultimi anni, un attentato era stato “segnalato” come altamente probabile
in ben sedici “alert”, nei quali se ne riteneva possibile l'esecuzione in
occasioni delle feste ebraiche. E il 9 ottobre ricorreva appunto "la festa dei
bambini”.
Nonostante questo e nonostante
le molte richieste della comunità ebraica di incrementare le misure di
sicurezza, proprio quel giorno persino la singola camionetta che usualmente
stazionava davanti al Tempio maggiore, quella mattina venne rimossa. Perché?
Come mai il Viminale non dette seguito alle informative del Sisde? Cosa avrebbe
potuto ancora dire Virginio Rognoni al riguardo? Quarant’anni fa ci furono forti
polemiche per quella che apparì subito come una grave inefficienza del Ministero
dell’Interno.
Ma i nuovi documenti e molti
altri che sono ormai consultabili in base alla legge “Renzi” del 2014, hanno
fatto sorgere nell’ultimo anno nuovi e pesanti interrogativi. Quelli che il
fratello sopravvissuto della piccola vittima della Sinagoga ha raccolto in un
libro che viene pubblicato a quarant'anni da quell'agguato. (Gadiel Taj Tache'
"Il Silenzio che urla", settembre 2022)
Noi oggi, infatti, sappiamo
con certezza che, a partire dal 1973, venne sottoscritto un patto tra i nostri
servizi segreti e le fazioni terroristiche palestinesi in modo che l’Italia
diventasse per esse un terreno di passaggio per il traffico d’armi. Con una
sostanziale "non interferenza" italiana, se gli obbiettivi dei palestinesi in
Italia fossero stati israeliani, ebrei o americani.
Come spiegò nel 2008 in una
intervista Francesco Cossiga al quotidiano israeliano Yediot Aharonot: “Poiché
gli arabi erano in grado di disturbare l’Italia più degli americani, l’Italia si
arrese ai primi”. E lo stesso capo dell’OLP Yasser Arafat nei suoi Diari (di cui
il settimanale L’Espresso ha fatto un’anticipazione nel 2018), ha annotato,
perentorio, in relazione a quegli anni: “L’Italia è una sponda palestinese nel
Mediterraneo”.
Il mondo allora era diviso in
due e Roma assomigliava a Berlino, a metà tra Est ed Ovest. La prova del patto
con i palestinesi è in un telex del febbraio 1978, a noi noto solo dal 2015,
quando esso è confluito negli atti a disposizione della Commissione Moro 2,
presieduta da Giuseppe Fioroni. In quel cablogramma da Beirut il colonnello
Giovannone (preannunciando il rischio di una grossa azione terroristica in
Europa) confermava la volontà del Fronte popolare per la liberazione della
Palestina (Fplp) di tenere indenne l’Italia.
In realtà le cose andarono
molto diversamente. Perché neppure un mese dopo Aldo Moro venne rapito ad opera
delle Brigate Rosse, ma operarono sul campo terroristi tedeschi della Rote Armee
Fraktion, gestiti dal servizio segreto della Germania orientale (Stasi), in
stretto contatto con i gruppi terroristici palestinesi. E a Berlino Est aveva
trovato rifugio sicuro lo stesso George Habbash, leader del Fronte per la
liberazione della Palestina, proprio il “firmatario” palestinese del “patto” con
l’Italia e il terrorista Wadi Haddad, coinvolto dal colonnello Giovannone nelle
trattative per liberare Moro durante i 55 giorni.
Un “patto” la cui esistenza è
stata confermata personalmente anche da un protagonista dell’epoca ancora in
vita, Abu Sharif, soprannominato da Time magazine “il volto del terrore”,
braccio destro di Arafat , nella sua audizione a Palazzo San Macuto del giugno
2017. La documentazione completa relativa a quell’accordo impropriamente
denominato "Lodo Moro" (visto che in realtà fu voluto dall’allora presidente del
Consiglio Andreotti anche se Andreotti ne ha sempre negato pubblicamente
l’esistenza) è ancora tutelato dal segreto di Stato, rinnovato nell’estate del
2020 dal Governo Conte II.
Eppure, già quello che oggi
sappiamo in base a decine di migliaia di atti desecretati e consegnati alla
Commissione Moro che ha chiuso i suoi lavori nel 2018, e all’Archivio di Stato,
è sufficiente per “ristrutturare" il campo della conoscenza della storia degli
anni di piombo nel nostro Paese . E degli attentati organizzati in Italia dai
palestinesi (compreso quello di Fiumicino del 1985 con 13 morti e 76 feriti).
Del resto, l’Italia era diventata dall’inizio degli anni Settanta e fino al
1989, uno dei terreni principali su cui venne messa in atto la Guerra Fredda. E
i terroristi palestinesi vi giocarono un forte ruolo.
Rognoni, esponente di lungo
corso della sinistra Dc, eletto deputato a partire dal 1968 per sette
legislature, nel 1976 divenne vicepresidente della Camera, fino a quando il
presidente del Consiglio Giulio Andreotti, nel 1978, lo chiamò a sostituire come
ministro dell’Interno, Francesco Cossiga che si era dimesso subito dopo
l’assassinio di Moro. “Gingio", per gli amici, rimase al Viminale per 5 anni,
fino all’83, mentre si sono succeduti ben cinque governi (Andreotti, Cossiga,
Forlani, Spadolini I e II, Fanfani).
Nell’82 ai tempi
dell’attentato alla Sinagoga era presidente del Consiglio, Giovanni Spadolini,
il primo premier filoatlantico e filoisraeliano, salito a Palazzo Chigi dopo
l’esplosione dello scandalo P2. Spadolini fu anche l’unico politico presente ai
funerali del bambino. I cinque anni di Rognoni al Viminale risultarono cruciali.
Rognoni era al Viminale il 1
ottobre del 1978 quando fu scoperto dagli uomini del generale Dalla Chiesa il
covo brigatista di via Montenevoso, dove (sappiamo oggi) venne ritrovata la
copia di documento delicatissimo relativo all’organizzazione della NATO,
circostanza di cui Dalla Chiesa informò il Ministero dell’Interno, all’inizio
del 1979. Rognoni era al Viminale quando, nella primavera del 1979, si
concretizzò una veloce e concordata “consegna” alla polizia dei due br
“dissociati” Valerio Morucci e Adriana Faranda che erano riparati in casa di
Giuliana Conforto (figlia di Giorgio, “Dario", il più importante agente Kgb in
Italia nel Dopoguerra, secondo il "dossier Mitrokhin") , appartamento in cui fu
sequestrata una delle due armi che uccisero Moro, la mitraglietta Skorpion.
Rognoni era al Viminale quando
Dalla Chiesa, capo dell’antiterrorismo, per oltre un anno si era messo alla
ricerca dei documenti originali sull’organizzazione Gladio, scomparsi dalla
cassaforte del Ministro della Difesa Ruffini, cui alludevano le copie ritrovate
a via Montenevoso. Era al Viminale quando il generale, nel marzo 1980, eseguì il
blitz di via Fracchia a Genova, dove venne ucciso Riccardo Dura, capo della
colonna genovese e soprattutto, sappiamo oggi, venne recuperata una quantità
imponente di documentazione. E tra essa quegli “originali”, che così riuscirono
tornare al loro posto a palazzo Baracchini, qualche mese più tardi.
Rognoni era al Viminale quando
il 4 maggio del 1982 venne stilato un cartellino segnaletico di Alessio
Casimirri (l’unico br presente in via Fani e condannato a sei ergastoli, ma che
a tutt’oggi non ha fatto un giorno di carcere, ancor oggi riparato nel Nicaragua
governato dai sandinisti) dopo un "probabile" arresto di cui si è avuta traccia
solo nel 2015. Rognoni era al Viminale, quando succedette a Rinaldo Ossola, nel
1982, come presidente dell’Associazione di amicizia italo- araba (carica che ha
mantenuto per oltre un decennio). Incarico che non deve stupire visto che già
dagli Anni Settanta, tra tutti gli esponenti della sinistra dc, “Gingio” era
considerato il più filoarabo, sulla scia del suo mentore e maestro Luigi
Granelli (che lui accompagnò in delegazione ad una Conferenza al Cairo di cui si
ricordano interventi di fuoco di Granelli contro Israele).
Per tutti questi motivi, pochi
anni fa i commissari della Commissione Moro II avrebbero voluto ascoltare l’ex
responsabile del Viminale. Per sentire da lui cosa potesse rendere noto sulle
novità emerse dagli archivi. Si sarebbero recati loro a Milano, in modo da
evitare all’anziano politico una faticosa trasferta a Roma. Sono state scambiate
mail su mail, ma alla fine Rognoni ha fatto in modo di far cadere la cosa.
Nel 2018, tuttavia, Rognoni ha
trovato tempo e voglia per presentare un libro sui lavori della Commissione,
scritta da Wladimiro Satta insieme all’unico parlamentare, Fabio Lavagno, che ha
votato contro la Relazione finale dell’organismo parlamentare (approvato
all’unanimità anche dall’Aula di Camera e Senato).
Evidentemente non si è trovato
d’accordo con la ricostruzione del terrorismo italiano ed internazionale fatta
dalla Commissione Moro II e con la sua principale conclusione. E cioè che la
ricostruzione “ufficiale” della storia degli anni di piombo (quella nota fino
alla recente apertura degli archivi) è stata il frutto di un negoziato tra
istituzioni e le Br, per “confezionare” - grazie al cosiddetto Memoriale Morucci
- “una verità di compromesso” che non alterasse equilibri internazionali troppo
delicati, a cominciare da quelli con l’Est europeo e i palestinesi.
Tra l’estate del 1986 e quella
successiva, 1987, un anno fondamentale - questo oggi lo sappiamo con certezza -
per la stesura del Memoriale che viene attribuito a Valerio Morucci, Rognoni era
Guardasigilli, cioè titolare del Ministero della Giustizia, che ha anche il
controllo delle carceri.
“Gingio", sarà nuovamente
ministro, nel luglio 1990, l’anno dopo della Caduta del Muro di Belino, con
Andreotti presidente del Consiglio (per rimanervi fino al 28 giugno 1992). Nuovo
ruolo, questa volta: ministro della Difesa.
Per andare al governo, ruppe
con tutta la sinistra dc (i cui esponenti, compreso Sergio Mattarella, non erano
d'accordo nell’impegnarsi nella formazione del nuovo esecutivo) e ruppe in modo
clamoroso con Granelli che lo accusò pubblicamente di “essere un traditore”.
Come responsabile della Difesa gestì (a partire da agosto) insieme al presidente
Andreotti, il “disvelamento” della struttura della NATO che era stata creata
alla fine della Seconda Guerra Mondiale per rendere operativa la resistenza nel
caso di una eventuale invasione sovietica, la struttura Gladio-Stay Behind.
All’inizio di ottobre (1990),
una nuova irruzione nel covo br di Via Montenevoso portò alla luce la parte
“mancante" del Memoriale di Moro riguardante la Gladio. Ma secondo l’analisi
filologica compiuta sulle varie versioni del Memoriale di Moro (se ne contano
almeno quattro) e ai loro rimandi interni, da Francesco Maria Biscione
(consulente della Commissione stragi e collaboratore dell’Istituto
dell’Enciclopedia italiana) mancherebbero però ancora all’appello il riferimento
ai rapporti tra Andreotti e i servizi segreti e alle operazioni dei nostri
servizi segreti in Libia.
Quello di ministro della
Difesa è stato l’ultimo incarico governativo di Virginio Rognoni (anche se venne
eletto dal 2002 al 2006, vicepresidente del Csm). Dopo che tanto tempo è passato
dagli attentati e dalle stragi, oltre al Pnrr e alle riforme, il Paese ha
bisogno di verità sulla sua Storia: dall’attentato alla Sinagoga al caso Moro.
Perché un filo rosso li unisce: un filo rosso che emerge dai documenti
ufficiali, non dalle dietrologie. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ne
è consapevole e il 2 agosto 2021 (anniversario della strage alla stazione di
Bologna del 1980) ha firmato una direttiva per un’ulteriore desecretazione di
documenti.
Un uomo con un così lungo e
prestigioso standing istituzionale, come Virginio Rognoni, non ha però sentito
il bisogno di aggiungere nulla a quanto ha aveva detto in passato. Adesso porta
vis con se' alcuni segreti della storia italiana.
La strage di via Fracchia e
le torture: tante ombre sull’ex dc.
Chi era Virginio Rognoni, a 98
anni se ne va il successore (più cattivo) di Cossiga. David Romoli su Il
Riformista il 21 Settembre 2022
L’incontro con Virginio
Rognoni, allora ministro degli Interni, scomparso ieri a 98 anni, lo racconterà
anni dopo Marco Pannella. Erano entrambi a Montecitorio, di fronte al tabaccaio,
e il leader radicale avvertì il ministro democristiano che la sera stessa, nel
corso di una Tribuna autogestita con Emma Bonino, i radicali avrebbero mostrato
in gigantografia le foto delle torture alle quali era stato sottoposto il
brigatista rosso Cesare Di Lenardo. Pannella chiese anche all’importante
esponente democristiano compianto oggi coralmente se fosse al corrente delle
torture. Era il 1982. Lo Stato aveva già vinto la sua battaglia contro il
terrorismo ma ancora non lo sapeva o non ne era sicuro. La risposta di Rognoni
fu dunque gelida: «Questa è una guerra e il nostro dovere per difendere la legge
e lo Stato, è coprire i nostri uomini».
La Tribuna andò regolarmente
in onda. Tutti fecero finta di niente: erano moltissimi i bravi democratici che
la pensavano come Virginio Rognoni, esponente di spicco della sinistra Dc molto
vicino all’ex segretario Benigno Zaccagnini, dunque a Moro. Del resto quel
“coprire” era probabilmente un eufemismo. Dopo il rapimento del generale Dozier,
il 17 dicembre 1981, le pressioni di Washington sul ministero erano diventate
martellanti. Uno dei principali dirigenti di polizia che lavoravano a tempo
pieno sul sequestro racconterà trent’anni dopo, nel 2012, che il prefetto capo
dell’intelligence del Viminale, prefetto De Francisci, convocò tutti e fu molto
chiaro senza bisogno di fare nomi: «Ci dice che l’indagine è delicata,
importante. Dobbiamo fare bella figura. Ci dà il via libera a usare le maniere
forti. Indica verso l’alto, quindi non preoccupatevi, se restate con la camicia
impigliata da qualche parte sarete coperti, faremo quadrato». Le torture non
avevano aspettato l’ostaggio americano. La squadretta di torturatori detta
“Quelli dell’Ave Maria” e guidata dal professor De Tormentis era attiva già dal
1978. Il sinistro, al funzionario Nicola Ciocia lo aveva dato direttamente il
dirigente dell’Ucigos Improta, con in mente la Colonna infame di Manzoni. Che il
ministro non fosse al corrente della pratica lo si dovrebbe escludere.
Forse il termine “coprire” è
più adatto al comportamento del ministro dopo la strage di via Fracchia, il 28
marzo 1980. Quella notte i carabinieri del generale Dalla Chiesa irruppero
nell’appartamento nel quale dormivano 4 brigatisti e li uccisero. Per rispondere
al loro fuoco, dissero, ma ai giornalisti che per primi entrarono
nell’appartamento fu invece chiaro, come affermerà molti decenni dopo Giorgio
Bocca, che erano stati fucilati. I cronisti scelsero di coprire la mattanza e in
tutta evidenza lo stesso fece il ministro. Nella leggenda popolare il ministro
degli Interni a capo della guerra contro il terrorismo è stato Francesco
Cossiga. Non è così. Quando Cossiga si dimise, dopo l’uccisione di Moro il 9
maggio 1978, il terrorismo era all’offensiva, lo Stato aveva subìto la sua più
cocente sconfitta. Il compito di risollevare le sorti della battaglia adoperando
il pugno di ferro se lo assunse Rognoni, un uomo discreto, gentile,
universalmente lodato per la sua signorilità. Un democristiano diverso dalle
star dell’epoca, che non mancavano di istrionismo, erano personaggi celebri,
vistosi, conosciuti da tutti.
Rognoni no. Non si metteva in
mostra. Era riservato, geloso della vita privata: un matrimonio durato 57 anni,
fino alla morte della moglie Giancarla Landriscina conosciuta all’università,
quattro figli, sei nipoti. A spingerlo ad accettare un incarico considerato
allora ad alto rischio, succedendo a Cossiga, era stata proprio lei: «Hai scelto
di fare politica: quel che segue lo devi accettare». Tuttavia fu proprio questo
compassato signore a dare il via libera alle torture e a una guerra combattuta
senza esclusione di colpi e senza pastoie legali. Nei guai il ministro ci finì
una volta sola, nel 1980. Il primo grande pentito delle Br, Patrizio Peci, aveva
parlato di un leader di Prima linea figlio di un ministro, Carlo
Donat-Cattin. Cossiga, allora primo ministro, avvertì il padre, ne venne fuori
uno scandalo coi fiocchi, Rognoni finì nel tritacarne ma ne uscì indenne. Lo
Stato scelse di coprire, in questo caso non per meriti di guerra. La verità,
tanto per cambiare, la raccontò Cossiga molti anni dopo. Disse che il primo
reato lo aveva commesso il ministro, mettendo a parte dell’increscioso caso il
segretario della Dc Piccoli. Decisero di informare insieme Cossiga. Fu proprio
Rognoni, “gigante di coraggio”, a chiedere a Cossiga di informare lui
Donat-Cattin, con il quale il titolare del Viminale “non andava d’accordo”.
Rognoni vinse la guerra con il
terrorismo e perse quella con Cosa nostra. O forse non la combattè oppure non
potè combatterla. Gli allarmi di Piersanti Mattarella e del generale Dalla
Chiesa, l’isolamento denunciato da quest’ultimo spedito a Palermo senza alcuna
copertura da parte dello Stato rimasero lettera morta. Lo zu Totò chiuse la
partita a colpi di kalashnikov. Nell’82 fu però lui a sostenere, firmare e far
approvare la legge La Torre, nel frattempo assassinato, contro Cosa nostra. Dopo
gli Interni Rognoni passò alla Giustizia, quindi alla Difesa. La tempesta dei
primi anni 90, con la fine della Dc sembrava averlo spedito in pensione per
sempre nel 1994, dopo 28 anni passati in Parlamento. Invece nel 2002 fu chiamato
alla vicepresidenza del Csm, da dove fece muro contro ogni critica rivolta alla
magistratura in perfetta consonanza con quella che era la linea del suo
partito, La Margherita, e del partito di cui nel 2007 contribuì, con altri 11
saggi, a scrivere il “manifesto”: il Pd. Antifascista negli anni giovanili a
Pavia anche se mai partigiano, giurista raffinato e colto, avvocato e
docente, Virginio Rognoni è stato senza dubbio un democratico convinto e vicino
all’anima più aperta e di sinistra dello scudocrociato. Ma è stato anche
l’ultimo nella tradizione democristiana dei ministri degli Interni col pugno
durissimo. David Romoli
Massimiliano Panarari
per “Specchio – La Stampa” il 16 agosto 2022.
Cosa resterà degli anni
Ottanta? Così cantava Raf al Festival di Sanremo nel 1989. Tanto, decisamente.
L'inizio di questo periodo ha conosciuto la tragedia - non solo in Italia, ma
specialmente nel nostro Paese - degli anni di piombo, prosecuzione della coda
velenosa dei Settanta, una cappa cupa e sanguinosa che ha oscurato le strade e
le speranze dei nostri connazionali con gli attentati e gli omicidi del
terrorismo nero e del brigatismo rosso.
Gli Eighties furono così, per
molti versi, anche una reazione a quanto avvenuto negli anni Settanta sotto il
profilo politico-ideologico, nel quadro dell'ascesa del neoliberismo. Ovvero, il
paradigma socioeconomico della rivoluzione neocon portata al potere dal
thatcherismo e dal reaganismo, che trovò degli autentici manifesti
cinematografici nelle saghe di Rambo (dal 1982) e Top Gun (dall'86).
Gli anni Ottanta - quelli che
non sono mai finiti, a giudizio di alcuni osservatori - hanno rappresentato il
trionfo del ritorno al privato e del «riflusso» di generazioni desiderose di
lasciarsi alle spalle l'impegno collettivo (e certi suoi estremismi) per
concentrarsi su di sé.
La nuova era
dell'individualismo spinto e dell'edonismo reaganiano (per dirla col tormentone
inventato da Roberto D'Agostino a Quelli della notte, poi divenuto una categoria
tout court del dibattito culturale). Dal «tutto è politica» si è passati, per
tanti versi, al «tutto è comunicazione», grazie al potenziamento anche
tecnologico dei media, alla loro moltiplicazione, e ai mutamenti radicali della
cultura e dello spirito dei tempi.
È il decennio che ha
consacrato la «cultura del narcicismo» (come la denominò Christopher Lasch), in
cui il culto del corpo - dal surf al body-building e al fenomeno sociale
dell'andare in palestra - è letteralmente esploso, provenendo in primis (al pari
di parecchie altre novità) dalla California, frontiera dell'Estremo Occidente.
Autorappresentazione di sé e
autoperformatività che affondavano i loro albori simbolici in una celebre
pellicola di John Badham di fine anni Settanta, La febbre del sabato sera con
John Travolta. E che avrebbero gettato le basi per la ricerca sempre più
frenetica di strumenti e opportunità per comunicare, una dimensione che rimanda
anch' essa, in maniera eminente, all'espressione della soggettività (premessa
per il successivo dilagare di quell'«autocomunicazione di massa» di cui ha
scritto magistralmente Manuel Castells).
Il decennio dell'ascesa, nella
triangolazione Parigi-West Coast-New York, della cultura postmoderna. Quella
che, in un battibaleno, diventa di massa e pop(olare) con il successo planetario
del romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco, pubblicato da Bompiani nel 1980.
E che incontra una macchina
comunicativa e scenografica poderosa nelle varie edizioni dell'Estate romana,
nata nel 1977 (anno seminale che chiude, di fatto, i «brevi Settanta» e inaugura
i «lunghi Ottanta») su iniziativa di Renato Nicolini proprio per rianimare le
piazze della capitale atterrita dalla violenza politica (e per animare le
periferie), mescolando cultura alta e bassa, giustappunto secondo la visione di
fondo del postmodernismo.
La colonna sonora del decennio
- ricchissima - in Italia propone alcune hit storiche di ricerca del
divertimento e di fuga dai "cattivi pensieri" e dalle preoccupazioni, come
quelle dell'album Alè-oò di Claudio Baglioni ('82), Gioca jouer di Claudio
Cecchetto ('81), Vacanze romane dei Matia Bazar ('83), Bello e impossibile di
Gianna Nannini ('86), Gimme Five di Jovanotti ('88).
L'età aurea delle discoteche e
del clubbing, anche nella versione di quella creatività individuale del look
degli avventori che raggiungerà l'apice in locali quali il Tenax di Firenze,
tempio della new wave. Soprattutto, gli anni Ottanta furono quelli del «diluvio
commerciale» delle televisioni e radio private (come lo definì il sociologo dei
media Jay Blumler) e della pubblicità, in grado di stabilire un'inedita egemonia
sottoculturale, che in Italia venne sparsa a piene mani dal berlusconismo
catodico.
Con le sue punte di diamante
in trasmissioni tv come Drive In, un complesso «apparato finzionale», ispirato
da alcune intuizioni del situazionismo rovesciate politicamente di segno che,
dietro l'atmosfera ridanciana e disimpegnata, veicolava la nuova religione
dell'iperconsumo (compreso quello sessuale, svestendo un gruppo di ragazze per
la prima volta in prima serata) e un'ideologia de facto di taglio
neoconservatrice.
E proprio allora ebbe inizio
anche la marcia trionfale della rivoluzione informatica: Apple metteva sul
mercato il suo pc Macintosh, accompagnandolo con lo spot 1984 diretto da Ridley
Scott (reduce dal capolavoro Blade Runner); e il 20 novembre dell'85 Microsoft
lanciava la versione originaria del sistema operativo Windows.
Dagospia il 16 agosto 2022.
PRECISAZIONE CON RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
In Riferimento all’articolo
Caro Dago,
la risposta in questione è una
garbata precisazione dell’ufficio stampa.
Fosse stato per me, mi sarei
limitato a osservare, guardando la foto di Panarari, che purtroppo in alcuni
casi Lombroso ha ragione. Antonio Ricci
Gentilissimo Massimiliano
Panarari,
Con la pervicacia di un
Goebbels de’ noantri, torna a ripetere falsità su Drive in. Così tocca pure a
noi ripeterci e ri-ricordarle che il varietà di Antonio Ricci fu una
trasmissione libera e libertaria, un programma comico e satirico che ha irriso e
messo alla berlina protagonisti, mode e personaggi degli anni ‘80.
Una parodia dell’Italia di
quegli anni esagerati, della Milano da bere, del riflusso, e di quell’edonismo
reaganiano anche da lei nominato. Oreste Del Buono, Angelo Guglielmi, Federico
Fellini, Umberto Eco e tanti altri intellettuali dell’epoca la definirono “la
trasmissione di satira più libera che si sia vista e sentita per ora in tv” o
“l’unico programma per cui vale la pena di avere la tv”.
Ancora le facciamo notare che
- come lei le definisce - “le ragazze svestite” erano altrove. Oltre che al
cinema e sulle copertine dei settimanali di opinione, erano sui canali Rai. Rosa
Fumetto ne Il Cappello sulle 23, Ilona Staller in C’era due volte, Barbara
d’Urso in Stryx e quelle che facevano da tormentone in Due di tutto, per fare
qualche esempio.
A Drive In, per la primissima
volta in un varietà, le ballerine di fila (più vestite delle “donnine di
Macario” e delle acrobate di qualsiasi circo) prendevano la parola e facevano
battute, tra l’altro interpretando testi scritti da una donna, Ellekappa.
All’epoca non si erano mai viste in tv tante comiche donne: da Margherita Fumero
a Syusy Blady, da Olga Durano a Johara, da Caterina Sylos Labini a Luciana
Turina e Antonia Dell’Atte. Una piccola grande rivoluzione che suscitò
l’attenzione anche di Maria Novella Oppo che ne scrisse sull’Unità.
Vorremmo evitare anche di
inviarle nuovamente il documentario di Luca Martera “Drive In: l’origine del
male”. Potrebbe farsi un’idea più completa degli anni ‘80 e rivedere certe sue
assurde certezze, ma non ci pare abbia troppa voglia di studiare. Visto, però,
che l’anno prossimo Drive In compie 40 anni, ci riproviamo ed esprimiamo il
desidero soffiando sulle candeline. Con l’augurio che lei non prenda più
cantonate come accadde tempo fa con il deepfake di Matteo Renzi, ricorda?
Aveva sostenuto che Striscia
la notizia aveva solo in seconda battuta rivelato che il famoso video era un
falso. Mentre era stato lo stesso Ricci a darne notizia pochi giorni prima della
messa in onda davanti a decine di giornalisti in una affollata conferenza
stampa. Il fatto era stato riportato anche da La Stampa, quotidiano sul quale
scrive, ma che evidentemente non legge. Per cortesia nella sua risposta non la
butti, come sempre, in caciara. Fatti, non mal di pancia.
Cordiali saluti, L’Ufficio
stampa di Striscia la notizia (e di quel che resta del Drive In)
DAGONEWS il 16 agosto 2022.
È un tormentone della rete. Un
collage di memorabilia politico, datato trentacinque anni fa (sette anni prima
della discesa in campo dal Cavaliere) con una catena di spot di famiglie felici
che intonano: Forza Italia! E non per la nazionale, ma per la Democrazia
Cristiana. Uno spot diventato iconico, creato dalla stessa agenzia che produsse
quello de “Il Mulino Bianco” per la Barilla e della “Milano da bere” per l’Amaro
Ramazzotti: “Per un sorriso, per la libertà, per un grande sogno, l’amore per
l’avvenire, per una vita e la serenità, la tua casa e il lavoro del futuro dei
tuoi sogni, forza Italia, forza Italia, Forza Italia. Fai vincere le cose che
contano: vota Democrazia Cristiana”.
Un mondo semplice: con i
comunisti, i socialisti e i socialdemocratici, i repubblicani, i liberali e i
radicali e il Movimento Sociale Italiano (Destra Nazionale).
Si parte coi trenini di
Spadolini. Un plastico che riduce in versione Rivarossi (o Lima) uno scenario
da Cassandra Crossing dove sui treni c’è il destino del Paese (alla guida dei
locomotori dei due convogli pronti a scontrarsi non si capisce se ci siano De
Mita e Craxi. Fischio urlante e: “Diritti per la propria strada, decisi,
irriducibili, così alcuni partiti, pretendono di uscire dalla crisi, ma quando
nessuno da strada a nessuno, quando tutti vogliono tutto, la corsa al potere
diventa la corsa verso il disastro.
Oggi c’è una via di uscita la
via della chiarezza e della ragione. Imbocchiamola insieme” e un bel fermo
immagine di Giovanni Spadolini - in modalità airbag - con invito a votare per
lui (unico che si fa citare: “Vanità della vanità, tutto è vanità” Ecclesiaste).
Poi c’è la Destra Nazionale, che gioca con la Nazionale, in azzurro. Siamo al
rigore finale (in un montaggio tenerissimo; si passa da un’inquadratura di uno
stadio stracolmo a un dettaglio di un calciatore che poggia il pallone sul
dischetto in uno stadio vuoto e con anello per l’atletica – assente
nell’immagine precedente: “Il momento è arrivato, puoi farcela. Basta un gesto
per cambiare il tuo futuro e quello della tua nazione. È il tuo futuro in gioco,
non sbagliare! Vota Movimento Sociale Italiano”. Il calciatore tira e fa goal.
Dove tira? Al centro! Appunto. A corredo c’è la solita bella fiamma, tricolore,
che arde ancora inconsapevole delle future polemiche ideologiche e, presto,
energetiche.
Quindi scena bucolica, poi del
lavoro, poi ragazzina che guarda in camera e tiene un’inquadratura stretta di
10” che nemmeno Liz Taylor al massimo splendore: “C’è un’altra possibilità
eliminare l’inquinamento non l’ambiente. C’è un’altra possibilità far crescere
il lavoro non solo i profitti. C’è un’altra possibilità una politica lontana
dagli intrighi vicina ai cittadini. Vota Partito Comunista Italiano”. C’erano
ancora i comunisti.
Elettore in cabina: “E questi
si fanno un governo e non se lo votano (si riferisce al monocolore democristiano
per cui ricevette l’incarico Amintore Fanfani con l’obiettivo di portare il
Paese alle elezioni).
Questi sono contro quelli e
poi ci vanno insieme. Questi fanno la terza posizione… E questi stanno alla
finestra. Oooo gli unici con un po’ di buon senso mi sembrano i
socialdemocratici. Da un anno a questa parte sono cambiati hanno coraggio di
scegliere e parlano a viso aperto. Vota social democratico. Vota l’alternativa
riformista! Oh – ritorna in camera il protagonista - diffidate delle
imitazioni!”. A interpretare il cittadino, socialdemocratico, Gigi Reder, Luigi
Schroeder, l’immortale Ragionier Filini. Paolo Villaggio, risponderà, nelle
stesse elezioni, con un appello al voto per Democrazia Proletaria.
“Le regole del gioco: barare o
cambiare? Hai un voto per dirlo: Partito Liberale Italiano. L’Italia è cambiata!
Cambia con noi”. Spot grafico, dove i colori del tricolore si alternano e
scambiano come carte da gioco. Segretario Renato Altissimo.
Quindi tocca alla DC seguita
dallo spot dei radicali che intonano “Nel blu dipinto di blu” del loro Domenico
Modugno - ne fu parlamentare e presidente - su immagini di Marco Pannella: “Se
solo c’è in gioco il più piccolo dei tuoi diritti noi radicali siamo capaci di
fare di tutto proprio di tutto. Capite perché si può decidere di votare
radicale?” con un giovanissimo Giovanni Negri, che guarda in camera. Magrissimo.
Si chiude coi socialisti:
“Costruiamo nuovi anni di progresso, di modernità, di eguaglianza. In questi
anni l’Italia è cresciuta. Può continuare a farlo”. Si esce dalla lettura dello
speaker: “Possibilmente con un fiore” è Bettino Craxi che guarda in camera con
in mano un garofano. I socialisti rispondono al Filini socialdemocratico con un
Minoli turbo socialista (in versione intervistatore ossessivo che insegue il
leader socialista tra università, parchi, fabbriche e supermercati – qui sta
alla cassa - per porgli irrimandabili domande).
Se ne viene dai due governi
socialisti, in un’Italia che ha visto l’inflazione passare dal 16 al 4% e da una
staffetta tradita del PSI con la Democrazia Cristiana.
Siamo in un mondo agli
sgoccioli della “Guerra fredda”; in America vanno in onda la prima puntata di
Beautiful e dei Simpson; Gary Hart, candidato democratico alla Presidenza,
capitola su Donna Rice; l’Italia, a Sanremo, canta con Morandi, Ruggeri e Tozzi:
“Si può dare di più”.
Sarebbe arrivato molto di
meno.
Da repubblica.it il 16 agosto
2022.
Era il 1996. In Italia, due
alleanze concorrevano alle elezioni del 21 aprile. La destra con il partito di
Silvio Berlusconi, Forza Italia, Alleanza Nazionale e il CDD. La sinistra con il
partito di Romano Prodi, il PDS, il PPI e le varie sinistre (coalizione
dell'Ulivo). In un servizio del telegiornale francese Soir 3 Giorgia Meloni,
all'epoca 19enne, viene descritta come una militante molto attiva di Alleanza
Nazionale che riprende idee neofasciste.
Nell'intervista in francese,
la Meloni spiega che Mussolini è stato un buon politico per l'Italia, un'idea
(secondo la tv francese) condivisa dal 61% dei militanti di Alleanza Nazionale e
da quella di sua madre, Anna Paratore, ex militante del partito fascista MSI e
poi di Alleanza Nazionale.
Massimo Caprara amarcord.
C’era una volta la passione.
WALTER VELTRONI su Il Corriere della Sera il 20 Giugno 2022.
Un testo edito dalla Camera
dei Deputati ripropone i discorsi dell’esponente comunista. Il volume sarà
presentato giovedì 23 giugno a Roma nell’Aula dei Gruppi parlamentari
Il nome di Giovanni Battista
Giuffrè dice qualcosa? Probabilmente no, son passati tanti anni. Eppure alla
fine degli anni Cinquanta era sulla bocca di tutti. Per lui fu inventato il
soprannome di «banchiere di Dio» (che tornerà poi appiccicato a spalle ben più
importanti, come quelle del cardinale Paul Marcinkus), lui fu il protagonista di
uno scandalo che coinvolse i pubblici poteri e quelli ecclesiastici che fece
intravvedere il rischio di una finanza sregolata che raccoglieva fondi per
«costruire nuove chiese» e che finì per rovinare risparmiatori ingenui
(arricchendone pochi ma molto meno ingenui). Sono passati più di sessant’anni
eppure nelle pagine di un volume edito dalla Camera dei Deputati emerge una
descrizione vivida e acuta. Non è un’inchiesta giornalistica, ma l’intervento di
un parlamentare, un parlamentare un po’ speciale che risponde al nome di Massimo
Caprara.
Questi scritti — pensati per
esser letti in un’aula severa, senza dirette televisive — hanno una nitidezza e
una profondità che ancora suscitano ammirazione. Polemiche politiche durissime
ma non urlate o condite di insulti ma ricche di dettagli, di studio, in cui i
fatti si allineano e le domande incalzano. Che si parli dello scandalo dei
«banchieri anonimi» (questo il nome scelto per la commissione parlamentare
d’inchiesta non su Giuffrè ma sui mancati controlli che avevano reso possibile
quello scandalo), o della speculazione edilizia a Roma, e — con una passione
personale ancora maggiore — della drammatica situazione di Napoli nel lungo
dopoguerra, Massimo Caprara è sempre lì: documentato, pungente, affronta di
petto i problemi, polemizza direttamente con i membri del governo.
Caprara è stato, dal 1953,
deputato per quattro legislature, era il secondo eletto della circoscrizione di
Napoli (il primo era regolarmente Giorgio Amendola, capolista) era famoso per la
sua cultura, per i suoi modi, per il rapporto di confidenza con Palmiro
Togliatti di cui per anni era stato segretario. E già qui vediamo come nell’idea
di un Pci tutto di ferro c’è qualche cosa che non va. Immaginate un leader
politico che arriva in Italia nel 1944, in piena guerra, dopo un lungo esilio,
che era stato tra i capi dell’Internazionale comunista, che a Mosca aveva
vissuto gli anni di ferro e di fuoco. Ebbene, la prima cosa che fa — appena
lanciata la svolta di Salerno — è quella di andare in cerca di giovani di
talento: incontra Massimo Caprara, parla con lui di letteratura francese, di
poeti ermetici e lo sceglie come redattore di «La Rinascita» e poi come suo
segretario personale. Ci voleva del coraggio per scommettere su un giovane,
appassionato borghese nato a Portici e approdato al comunismo negli ambienti
culturali della Milano dove aveva studiato da liceale e nella Napoli dove aveva
animato un circolo di giovani intellettuali raccolti attorno a «Latitudine».
Aveva coraggio Togliatti, ma anche occhio, perché Caprara e quel gruppetto di
amici «diventarono» il regista Franco Rosi, il romanziere Raffaele La Capria, lo
scrittore Luigi Compagnone, il promettente dirigente politico (anche se allora
si occupava soprattutto di teatro) Giorgio Napolitano.
Ecco, questi discorsi
parlamentari ci raccontano una generazione e una Italia che può apparirci
lontana ma nella quale stanno le nostre radici. La passione per il Mezzogiorno
(quello orgoglioso, non quello «con la mano tesa del mendicante», come ebbe a
dire lui stesso) lo portò a essere sindaco di Portici, a battersi contro Achille
Lauro, il sindaco monarchico e il padre di una specie di populismo straccione,
persino a fare un cameo nel film di Rosi Le mani sulla città insieme a quel
gruppetto di amici che si chiamavano Carlo Fermariello, Andrea Geremicca,
Maurizio Valenzi... Ma la biografia di Caprara non si ferma certo qui, perché la
sua è la «storia di un italiano che ha attraversato il XX secolo», come si
intitola la bella e complessa prefazione firmata da un altro Caprara, Maurizio,
che i lettori di questo giornale conoscono bene. E la sua è stata anche una
storia di dissensi, di uscite, di ripensamenti, di una ricerca spinta da domande
e urgenze. Massimo Caprara fu tra quanti vennero radiati dal Pci per la nascita
del «Manifesto». Attraversò l’esperienza di quel giornale (più che del partito
che ne era stato il frutto) tenendo insieme il rispetto per il Parlamento e le
istituzioni e la passione per i Consigli di fabbrica e le nuove forme di
democrazia. Soprattutto scrivendo, con la sua lingua allenata ai poeti
simbolisti francesi e alle battaglie politiche.
Rileggere oggi queste carte ci
dice molto di noi, della nostra storia, di una generazione di italiani che si
era scrollata di dosso quel fascismo nel quale erano nati. Che ha vissuto
intrisa di politica e, man mano, scoprendo, anche nel proprio campo ideologico,
la bellezza del dubbio, sinonimo di libertà.
Giovedì 23 alle 18 - La
presentazione a Roma nell’Aula dei Gruppi
Il volume che raccoglie
i Discorsi politici e parlamentari di Massimo Caprara sarà presentato giovedì 23
giugno alle 18 a Roma (Aula dei Gruppi parlamentari, via di Campo Marzio 78,
06.67609307, cerimoniale.adesioni@camera.it). Dopo l’intervento introduttivo di
Ettore Rosato, vicepresidente della Camera, sono in programma interventi di
Rocco Buttiglione, già vicepresidente della Camera, di Anna Finocchiaro,
presidente dell’associazione «Italiadecide», di Filippo Ceccarelli, giornalista.
Partecipa Maurizio Caprara, modera la giornalista Giovanna Pancheri. Durante
l’incontro l’attore Ignazio Oliva leggerà alcuni brani dal volume. Il libro di
Massimo Caprara è reperibile nella libreria online della Camera dei Deputati a
link: camera.it/leg18/1163.
Il volume e la vita
Discorsi politici e
parlamentari di Massimo Caprara, a cura della Biblioteca della Camera dei
deputati, con una introduzione di Maurizio Caprara, sono editi dalla Camera dei
Deputati (pp. 244, euro 10). Politico e giornalista, Massimo Caprara (Portici,
Napoli, 7 aprile 1922) fu, tra l’altro, segretario particolare di Palmiro
Togliatti, sindaco di Portici dal 1952 al 1954, deputato eletto nelle liste del
Pci per quattro legislature, membro del comitato centrale del partito e
segretario regionale del Pci in Campania. Tra i fondatori del gruppo del
«Manifesto», nel 1969 venne radiato dal Pci. È morto a Milano il 16 giugno 2009
Prima repubblica e crisi
della politica. La morte della democrazia non fu colpa solo di De Mita.
Enzo Carra su Il Riformista il 5 Giugno 2022.
Caro direttore, nel
tuo epicedio per Ciriaco De Mita, così diverso dagli altri da sembrare stonato,
ma la politica non obbedisce a un canone melodico, tu concludi, perdona la
citazione demitiana, con un ragionamento. Dici che da “quando non c’è stata più
la grande politica è rimasto solo il demitismo e a quel punto è stato spazzato
via tutto e quindi è stata spazzata via la Prima Repubblica.”
Così, tu attribuisci a De Mita
un ruolo imponente nell’ultima fase di quella che con leggerezza chiamiamo Prima
Repubblica (è forse stata cambiata la Costituzione?). Certo, dal caso Moro in
poi quella parte della nostra storia ha proseguito il suo corso come sospesa,
malamente, senza idee e senza progetti. La cosiddetta lotta politica s’era
trasformata dalla fine degli Anni settanta in uno scontro tra i detentori del
potere e quelli che volevano impossessarsene. Per dire: Andreotti spogliato del
governo dopo il caso Moro punta sull’elezione di De Mita alla segreteria
della Democrazia Cristiana per poi mollarlo appena ottenuto il ministero degli
esteri da Bettino Craxi. Per dire.
Negli Anni ottanta la “grande
politica” è assente. Molta tattica, un governo a guida socialista appoggiato da
una parte della Democrazia Cristiana e il partito di Scalfari-Repubblica che
appoggia De Mita: c’è questo e poco altro in quel fine secolo ed è complicato
limitare a uno solo dei protagonisti dell’epoca la responsabilità del crollo. È
sicuro invece che questo crollo, tu lo definisci icasticamente la “morte della
democrazia”, avviene nel maggio del 1982 quando si vota per il presidente della
repubblica. Sarà il successore di Francesco Cossiga, il “picconatore” tanto per
restare in tema di crolli. In quei giorni si consuma l’ultimo atto della
repubblica dei partiti. Si inizia con un saggio di filodrammatici, li chiamano
franchi tiratori, che seminano trappole e si finisce avvolti dalle fiamme in una
tragedia che brucia uomini e istituzioni.
Cominciamo dalla fine, una
fine vera. Lunedì 25 maggio a metà giornata i grandi elettori applaudono Oscar
Luigi Scalfaro nuovo capo dello stato: hanno votato a stragrande maggioranza una
persona che prima di quell’infernale week end avevano escluso dalla lista degli
eleggibili. Sono le fiamme e la tragedia di Capaci a obbligare quell’esercito
allo sbando a votare per Scalfaro, il candidato al di sopra di ogni sospetto. E
alla domanda perché Riina e gli altri assassini abbiano scelto quel giorno per
la strage la risposta è: Andreotti. Dopo Salvo Lima, Cosa Nostra completa la sua
vendetta contro chi l’ha scaricata con quell’orrore inimmaginabile che impedirà
a Andreotti di chiudere al Quirinale la sua carriera politica.
Per ottenere questo risultato
però non c’era bisogno di quintali di tritolo perché già dall’estate del 1990,
al rientro a Roma della commissione parlamentare antimafia presieduta da Gerardo
Chiaromonte da una importante e rivelatrice missione a Palermo, i comunisti
fanno sapere ad alcuni dirigenti democristiani che il partito non sosterrà
più Andreotti. La Democrazia Cristiana tiene conto di questa decisione del
partito con il quale ha sempre condiviso la scelta al Colle più alto. Una prassi
che ha tollerato un’unica eccezione, il voto per Giovanni Leone che mandò il
giurista al Quirinale e su tutte le furie il partito comunista, neutralizzato in
quell’occasione, che poi seppe come dilaniare il presidente che non doveva
ringraziarlo. Il 1992 è un anno speciale. Mani Pulite è partita da poco ma
promette grandi cose e i partiti, tutti i partiti comunisti compresi, non hanno
lo smalto di una volta, anzi boccheggiano.
Un’ultima volata, un disperato
sforzo di restare in piedi per non mandare all’aria il sistema -la Prima
Repubblica– che non ha alternative se non quella dell’avventura come sistema, è
questo il tentativo del quadripartito (democristiani, socialisti,
socialdemocratici e liberali). Un’operazione che nello scrutinio decisivo potrà
raccogliere i cosiddetti voti in libertà da sinistra e forse anche da destra.
Una scelta conservativa, sì ma per evitare il peggio. È vero, all’occorrenza ci
sarebbe anche Oscar Luigi Scalfaro, il “candidato di Marco Pannella” come
scrivono i giornali. Non è per questo che sul quel nome ci sia il “no” della
Democrazia Cristiana. Ciriaco De Mita, presidente del partito
con Forlani segretario, non dimentica la severità curiale, l’enfasi
moraleggiante, la demagogia con cui Scalfaro ha condotto, da presidente della
commissione parlamentare d’inchiesta, i fatti della ricostruzione in Irpinia.
Prima Montanelli sul Giornale, con una grande inchiesta giornalistica di Paolo
Liguori, ha sommerso di accuse il “clan degli avellinesi”, poi la commissione
parlamentare ha messo in bella copia e dettagliato quelle denunce. Raro esempio
di un’azione giudiziaria ispirata e sorretta da un’inchiesta giornalistica, da
allora in poi infatti avverrà il contrario e i giornali aspetteranno il via,
soprattutto le carte dalle procure. De Mita controlla un buon quaranta per cento
dei grandi elettori della Democrazia Cristiana e i suoi orientamenti influenzano
l’intero arco costituzionale che del resto è una sua invenzione. Arnaldo
Forlani è capo della parte moderata che adesso si chiama Azione popolare e
comprende la vecchia cara corrente del Golfo che fa capo a Antonio Gava.
Insomma, il
candidato Forlani parte bene anche se Mario Segni, ex capo dei
superanticomunisti democristiani, i “101” di Massimo De Carolis e Luigi Rossi di
Montelera, sta molto simpatico al capo dei democratici di sinistra Achille
Occhetto. Segni chiede un completo rinnovamento del suo partito, a cominciare
dal candidato alla presidenza, ma i suoi amici di partito non raccolgono
l’appello. Non tanto per il rinnovamento in sé quanto per gli uomini che lo
reclamano. Superato questo problema resta solo la prova dell’aula. De
Mita e Forlani sentono odore di bruciato, è soprattutto De Mita a intuire che
qualcuno sta armando una piccola ma efficace forza speciale di franchi tiratori.
All’operazione lavora probabilmente Cirino Pomicino e quei pochi che credono nel
rientro di Andreotti.
Tra i congiurati non
figura Vittorio Sbardella, lo Squalo, come è sobriamente definito il capo
andreottiano di Roma e dintorni, odia talmente Pomicino da fare qualunque cosa
pur di far fallire i piani del rivale. Il cui piano è però talmente striminzito
da sfuggire ai controlli. “Mi dissero che si trattava di bloccare Forlani perché
poi sarebbe entrato Andreotti e con lui noi parlavamo meglio” mi racconta anni
dopo un ex sottosegretario socialista di Ariano Irpino che un tempo si chiamava
Ariano di Puglia ed è distante da Nusco. I franchi tiratori che sfuggono a De
Mita e atterrano Forlani sono 39 al quinto scrutinio e 29 al sesto. Voti di
andreottiani che sperano, socialisti che odiano Bettino Craxi, qualche
socialdemocratico e un paio di liberali del genere hai visto mai.
Ecco fatto, Forlani getta la
spugna, sconfitto dai franchi tiratori, dopo aver respinto con sdegno una
possibile trattativa con Bossi proposta da Pierferdinando Casini. Chi si sente
sconfitto più di lui è De Mita che vede con chiarezza pararsi davanti la fine
della democrazia nel senso della Prima Repubblica, come la definisci tu, caro
direttore. Stavolta, davvero, non è colpa sua ma dei sogni irrealizzabili di
certi avventurieri. Enzo Carra
Arnaldo Forlani e
la lezione del Padreterno democristiano.
Redazione L'Identità
il 9 Dicembre 2022
Arnaldo Forlani
compie novantasette anni, e io sono contento due volte: per lui, e per noi. Per
lui, si capisce: ha avuto il dono di una lunghissima vita, la prima parte della
quale occupata da straordinari onori pubblici, l’ultima segnata dall’umiliazione
dell’oblio, ingiusto ma da lui accettato col buon senso marchigiano che mette la
bilancia in pari tra glorie e dolori. Sono contento anche per noi, che siamo gli
ultimi ragazzi democristiani, ormai sessantenni, giovani solo quando ci troviamo
tra di noi, o quando – in giorni come questo – ci rapportiamo ai grandi maestri
della nostra giovinezza. E’ un anno triste, perché si è portato via Ciriaco De
Mita e Gerardo Bianco. Bianco fu il più grande sostenitore di Forlani, con cui
condivideva le idee, la moderazione e soprattutto la straordinaria signorilità.
De Mita invece fu gemellato ad Arnaldo nel patto di san Ginesio, dal nome del
paesino marchigiano dove i due si allearono conquistando e dividendosi la
segreteria della Dc. Pensavano di aver fatto fuori la vecchia guardia del
partito, che invece fece fuori loro, alla prima fermata utile, come si usava
nella Dc. Altri tempi. Ma ogni anno è bello fare gli auguri ad Arnaldo, ed
assaggiare con lui quella quota di eternità democristiana che il Padreterno gli
ha permesso di godere già su questa terra. Certo, l’ultimo segretario dc vivente
non fa più interviste, non esce, mi dicono che non segue neppure più i
telegiornali, ad essi preferendo le partite di calcio, dopo la politica la sua
seconda passione (forse quella che gli ha recato meno dolori). Ma Arnaldo c’è
ancora, e siamo felici di fargli gli auguri. Forlani non ha più parteggiato per
nessuno , dopo la fine della Dc. Penso che abbia preferito il centrodestra al
centrosinistra, ma come elettore, senza particolare coinvolgimento. Ha seguito
con distacco le vicende della politica, persino quando hanno coinvolto suo
figlio, valoroso parlamentare del CCD. Eppure Forlani è stato il solo
democristiano consapevole di quanto stava accadendo al partito. Sfogliamo
l’album dei ricordi, recuperando alcuni suoi pensieri che scandivano l’inizio
della lunghissima e non ancora conclusa transizione postdemocristiana: ‘ se vi
riunirete per provare a rifondare la Dc, scoprirete solo il motivo per cui ci
siamo divisi’. E ancora: ‘in politica, come nel teatro, a un certo punto
cambiano gli scenari, e la cosa più penosa è quando gli attori recitano la parte
che sanno a memoria, senza accorgersi che alle loro spalle è stata montata la
scena successiva’. E sulla fine dell’unità dei cattolici: ‘ se ci divideremo,
nasceranno due partiti che faranno a gara a quale dei due sarà più cattolico, e
continueranno a dividersi senza più limite’. Oggi siamo arrivati a contare
settantacinque sigle centriste e democristiane. Auguri Arnaldo, lunga e vita e
complimenti soprattutto per esserti tenuto a distanza dai paciughi con cui ci
siamo baloccati noialtri ragazzi democristiani privi della tua guida sorniona e
discreta.
Festa della Repubblica, chi
era la ragazza della foto simbolo del Referendum? Un mistero risolto lungo 70
anni.
Alessandro Vinci su Il Corriere della Sera il 2 Giugno 2022.
Federico Patellani, il
reporter che realizzò lo scatto, non lo volle mai rivelare. La svolta nel 2016
grazie a una segnalazione anonima.
È il volto simbolo della
Repubblica italiana, ma la sua identità è rimasta ignota per 70 anni. Quindici
giugno 1946: sulla copertina del settimanale Tempo campeggia una fotografia che
sarebbe entrata nell’immaginario collettivo. Una ragazza, la cui testa
attraversa la prima pagina del Corriere della Sera del 6 giugno 1946, guarda
sognante verso il cielo. «È nata la Repubblica italiana» il titolo a piena
larghezza, riferito all’esito dello storico referendum istituzionale di quattro
giorni prima. A realizzare lo scatto la Leica di Federico Patellani, caposcuola
del fotogiornalismo nel nostro Paese nato a Monza nel 1911. Già documentarista
militare durante la campagna di Russia, tra il 1943 e il 1945 aveva trascorso
due anni e mezzo di internamento in Svizzera. Poi, una volta tornato in Italia,
aveva ripreso a collaborare con la rivista milanese.
Emblema di speranza e fiducia
nel futuro, l’immagine venne intitolata «Rinasce l’Italia» e, grazie alla sua
potenza espressiva, non faticò a tramutarsi in un manifesto universale per
le celebrazioni del 2 giugno. Parallelamente crebbe la curiosità di saperne di
più. Non suscitò particolare sorpresa scoprire che non si trattava di una foto
«spontanea», scattata cioè immortalando un genuino momento di gioia della
protagonista. L’istantanea è infatti frutto di ben 41 provini a contatto oggi
conservati presso il Museo della Fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo
(Milano). In alcuni la giovane è ritratta davanti a una serie di manifesti, in
altri legge il giornale, in altri ancora esulta con il pugno alzato.
Infine l’idea vincente: quella dello «sfondamento» della prima pagina (in un
primo momento anche con la mano sinistra, come dimostra il buco rimasto sotto il
sommario).
Ma chi era quella ragazza?
Malgrado le ripetute insistenze dei curiosi, Patellani, scomparso nel
1977, tenne sempre la bocca cucita. Molti pensarono potesse essere identificata
con una sua familiare, ipotesi però smentita dal figlio Aldo. Secondo un’altra
versione, invece, sarebbe stata un’ex partigiana. Ebbene, dopo decenni
all’insegna del mistero, a fare luce sul caso è stata nel 2016
un’inchiesta pubblicata su Medium da Giorgio Lonardi e Mario Tedeschini Lalli. I
quali, dopo aver invitato chiunque avesse informazioni utili a farsi avanti,
hanno ricevuto una segnalazione anonima: «Finalmente trovo il tempo affinché sia
dato giusto onore alla figura sorridente che con il suo volto giovane sbuca
dalla pagina del Corriere della Sera dal lontano 1946». Ed ecco poi l’agognato
nome, scritto nero su bianco: Anna . Anna Iberti. All’epoca 24enne e futura
moglie di Franco Nasi, tra i primi giornalisti del Giorno. Come poi emerso, in
quel giugno 1946 lavorava come impiegata nell’amministrazione dell’Avanti! ,
quotidiano del Partito Socialista per il quale in quei mesi scriveva anche lo
stesso Nasi. In precedenza, concluse le scuole magistrali, aveva invece avuto
una breve esperienza come insegnante, mentre dopo il matrimonio preferì lasciare
il lavoro per dedicarsi interamente alla famiglia.
Non restava a quel punto che
mettersi sulle sue tracce. Lonardi e Todeschini Lalli hanno però scoperto che la
donna è scomparsa nel 1997. In compenso hanno raggiunto a Milano le
figlie Gabriella e Manuela, che ancora conservano alcune stampe del servizio
fotografico. «Quasi quasi mi spiace che diventi pubblica questa cosa che per
tanti anni è rimasta in famiglia», ha detto la prima. «La mamma era un tipo
molto riservato, parlava poco di questa cosa», le ha fatto eco la seconda. Sono
state tuttavia proprio loro a rivelare, sulla base degli scarni racconti della
madre, che lo scatto venne realizzato sulla terrazza del palazzo di via Senato
38 che ospitava la redazione milanese dell’Avanti!. Resta però un ultimo punto
da chiarire: in che modo Patellani conobbe Anna, arrivando poi a chiederle di
posare per lui. Di certo i due avevano diverse amicizie in comune nel mondo del
giornalismo ma, considerato che il figlio Aldo «non ricorda alcuna particolare
frequentazione tra le due famiglie», a ben vedere è proprio questa la vera
domanda destinata a restare senza risposta.
I cavalieri
del grande centro tra pacifismi e nemici.
Paolo Mieli
su Il Corriere della Sera il
22 Maggio 2022.
Vi fanno parte
Lega, Forza Italia e Movimento Cinque Stelle. Li accomuna l’esibita devozione
(intermittente nel caso di Salvini) nei confronti di Papa Francesco. Oltre a
un’autentica passione per lo scostamento di bilancio, al non essere ossessionati
dal rispetto delle regole europee (compresi gli impegni assunti con il Pnrr)
Le parole
pronunciate da Silvio Berlusconi, tre giorni fa, all’uscita dal ristorante
«Cicciotto a Marechiaro» davano un’innegabile sensazione di schiettezza.
Maggiore, l’autenticità, di quella rintracciabile nelle declamazioni dello
stesso Berlusconi il giorno successivo alla Mostra d’Oltremare. Fuori dal locale
napoletano, l’ex presidente del Consiglio aveva detto in modo nitido che — fosse
per lui — si dovrebbe smettere di dare armi all’Ucraina; che, qualora si
decidesse di continuare a fornire armamenti alla resistenza antirussa,
bisognerebbe farlo di nascosto; e che l’Europa dovrebbe impegnarsi a costringere
Zelensky a prestare ascolto alle indicazioni che gli vengono da Putin. Una cosa,
quest’ultima, che fin qui non aveva proposto neanche Vito Rosario Petrocelli.
L’indomani, alla
convention di Forza Italia, Berlusconi è stato meno sorprendente limitandosi a
rievocare la propria militanza atlantica risalente al 1948 (stavolta omettendo
però ogni menzione di Putin). E a richiamare il rischio che l’Africa venga
lasciata in mano ai cinesi. Senza tralasciare l’appello per un coordinamento
militare comune della Ue. Evocazione, quella dell’«esercito europeo», alquanto
diffusa nel discorso pubblico italiano, ad uso di chi intenda manifestare una
qualche presa di distanze dagli Stati Uniti.
Berlusconi
ovviamente non si è poi sentito in obbligo di rettificare quel che aveva detto
all’uscita dalla trattoria. Parole venute dal cuore, pronunciate nella
consapevolezza che avrebbero avuto la dirompenza di un missile piovuto dalla
Russia sulla politica italiana. Con conseguenze fin d’ora ben individuabili.
L’allocuzione da
«Cicciotto a Marechiaro» ha aperto la via per la nascita — all’insegna del no
alle armi all’Ucraina — di un nuovo Grande Centro del quale faranno parte Lega,
Forza Italia e Movimento Cinque Stelle. Schieramento al quale Berlusconi porterà
in dote l’ancoraggio al Partito popolare europeo. E che costituirà una sorta di
approdo naturale per tre partiti anomali che hanno fatto la storia di questi
trent’anni (Berlusconi più degli altri, quasi venti). M5S, Lega e Fi hanno
all’attivo d’aver ottenuto, in fasi diverse del trentennio, alcuni ragguardevoli
record di voti. Favorite (talvolta danneggiate) dalla presenza di leader
impegnativi.
Tre formazioni
che non hanno un’autentica parentela con la storia della Prima Repubblica. Né —
eccezion fatta (forse) per Forza Italia — con i filoni tradizionali della
politica europea. Tre partiti che nel corso della loro vita hanno dato prova di
non essere refrattari ai cambiamenti di orizzonte, di strategia e di alleanze.
Anche repentini. E che, per il motivo di cui si è appena detto, hanno come
tallone d’Achille il non potersi fidare l’uno dell’altro. Li accomuna, però,
l’esibita devozione (intermittente nel caso di Salvini) nei confronti di Papa
Francesco. Oltre a un’autentica passione per lo scostamento di bilancio, al non
essere ossessionati dal rispetto delle regole europee (compresi gli impegni
assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza). In politica estera,
sono uniti da un’ostinata ricerca di orizzonti sempre nuovi. Ad est, s’intende.
Questo Grande
Centro è già oggi largamente maggioritario in Parlamento. E, se rimarrà intatta
la legge elettorale, al momento della composizione delle liste sarà determinante
per entrambi gli schieramenti, centrodestra e centrosinistra. Ma, anche se si
adottasse un sistema proporzionale, questo insieme di partiti, nelle nuove
Camere, avrà quasi certamente i numeri per condizionare ogni possibile
maggioranza. A meno che, nel Parlamento rinnovato, non si costituisca un asse
tra Fratelli d’Italia, il partito di Enrico Letta e quelli di Centro. Un asse —
però — assai improbabile.
Quanto a chi fa
affidamento sulle potenziali secessioni dei Di Maio, Gelmini o Fedriga, va
osservato che nelle retrovie della sinistra e dello stesso Pd si annidano truppe
di dubbiosi pronte a rimpiazzare gli eventuali secessionisti ricongiungendosi al
M5S nel nome dell’ostilità agli Stati Uniti e alla Nato. Truppe peraltro già ben
visibili.
In attesa delle
elezioni del 2023, si può notare che il minimo comun denominatore di questo
Grande Centro, oltre alla quasi esibita antipatia per la causa di Kiev, è una
ben individuabile avversione nei confronti di Mario Draghi nonché dell’attuale
governo. Si intravedono dunque per l’esecutivo draghiano settimane, mesi di
inferno: il percorso di qui alla fine della legislatura sarà disseminato di
trappole e mine.
Unico particolare
trascurato dai nuovi «partigiani della pace» è l’impegno atlantista di cui,
negli ultimi tre mesi, ha dato prova il Capo dello Stato. Un impegno manifestato
senza dubbi, incertezze, esitazioni. E che, proprio per questo, potrebbe
riservare qualche sorpresa.
Cossiga, Craxi e Andreotti:
quando l'Italia atlantista si faceva rispettare.
Luigi Bisignani su Il Tempo il
22 maggio 2022.
Caro direttore, grande
fermento in Paradiso: “Bettinoooo, Giulioooo, nemesi! Nemesi storica!”, va
urlando Francesco Cossiga, collegato via satellite con i lavori del Senato, dove
Stefania Craxi è stata appena eletta Presidente della Commissione Esteri
determinando l’ennesima débâcle M5Stelle.
“Giuseppi è finito in
pellicceria in meno di niente”, commenta Craxi, armeggiando con le sue scarpe di
tela, tagliate in punta, per lasciare ai suoi alluci quella libertà smarrita da
vivo.
Andreotti, alle ultime battute
del suo nuovo libro “I Santi visti da vicino”, ridacchia ironico: “Fare
simultaneamente il compare dei cinesi e degli americani è complicato per tutti,
figuriamoci per uno che viene da Volturara Appula.”
Cossiga: “Eppure ha avuto un
grande maestro, il professor Guido Alpa che avrei voluto alla Consulta. Ma era
troppo giovane…”.
Andreotti: “Alpa non ha colpe.
Del resto anche Gesù tra gli apostoli aveva Giuda”.
Craxi: “Su Conte se ne sta
accorgendo pure Grillo, al quale ho perdonato, ma non dimenticato, quella
battuta infame su di me”.
Cossiga: “Lascia stare, su
quella stagione di manettari tu e Giulio non avevate capito nulla”.
Andreotti: “Riflettendoci,
tutto iniziò con l’accordo sulla moneta unica europea. Me lo fece notare Guido
Carli tornando in aereo”.
Carli : “La tua memoria è
infallibile. Dissi che avevamo creato un vincolo europeo più forte di quello
Atlantico e che a Roma non avevano capito nulla”.
Cossiga: “In compenso lo
capirono molto bene a Washington scatenando, poco dopo, Mani Pulite per
“sfarinarci”, come direbbe Rino Formica. E non solo a Washington, anche a
Londra”.
Andreotti: “Addirittura la
regina?”.
Cossiga: “Non la regina. Il
Britannia, lo yacht reale che approdò a Civitavecchia per dar via alle
privatizzazioni”.
Craxi: “In Russia le
privatizzazioni le hanno fatte gli oligarchi. Da noi, invece, la finanza anglo
giudaico massonica”.
Andreotti: “Sul Britannia
Ciampi spedì a fare il discorso inaugurale il mio bravo Mario Draghi. Ed era in
buona compagnia, da Barclays a Goldman Sachs. Ma anche Bazoli e Andreatta”.
Cossiga: “Draghi ringraziò
“gli invisibili britannici” e se la svignò. Forse si era già pentito”.
Craxi: “Da allora hanno
svenduto l’Italia! Mancava solo Alessandra Ricci alla Sace, imposta dal solito
duo Giavazzi-Funiciello, in passato nemica numero uno delle aziende pubbliche
italiane, da Fincantieri a Finmeccanica.
Andreotti: “Si ha la
sensazione di assistere ad una cessione di sovranità. Speriamo che Mattarella li
mandi tutti a casa”.
Serafica, come sempre,
sopraggiunge Santa Madre Teresa di Calcutta che, zittendoli, mette tutti in
preghiera: “Dovreste essere felici. La Fondazione Craxi è riuscita a organizzare
un Convegno sulla vostra meritoria azione in terra, coinvolgendo eminenti
storici come Giovanni Orsina, Antonio Varsori, Lucia Coppolaro e Andrea Spiri”.
Andreotti: “Almeno per una
giornata non sono Belzebù e il presidente Craxi non è il cinghialone”.
Cossiga: “Brava Stefania per
il Convegno e bravo tuo figlio Stefano, insieme al mio amico Sessa,
l’ambasciatore, hanno saputo come rendervi omaggio con lavoro di verità e
ricordi. Invece i miei figli…di me, laggiù, non parla più nessuno”.
Andreotti: “La mia
presentazione come un papalino romano mi è piaciuta”.
Craxi: “Io come garibaldino
lombardo un po’ calvinista mi ci vedo proprio”.
Andreotti: “Nonostante ciò
molti sono i punti in comune tra noi”.
Madre Teresa: “Penso
all’ingiusto calvario che avete subito: un cattolico che crede nella Provvidenza
e nel Disegno Divino e un garibaldino con le sue sofferenze, appunto, che si
ribella e contrattacca innanzi alle ingiustizie”.
Cossiga: “Pragmatici direi.
L’ambito internazionale rappresenta il vostro lascito più significativo.
Entrambi atlantisti; di un atlantismo della ragione che rendeva l’Italia un
interlocutore credibile”. E malinconicamente aggiunge: “Non come questi pupazzi
di oggi”.
Madre Teresa: “C’erano anche
punti di dissenso”.
Andreotti: “Certo! Ma eravamo
avversari, non nemici. Rammento ancora poco prima del mio sesto governo, nel
1989, che parlammo a quattrocchi in un salottino di Villa Madama dove mi diede
il viatico del PSI”.
Craxi ridendo: “Lo ricordo
bene. A volte mandavi Peppino Ciarrapico, che ci metteva del suo”.
Andreotti: “In pochi mi
mettevano di buonumore come il Ciarra, gli perdonavo tutto”.
Cossiga: “Anche l’assegno a
vuoto a Gorbaciov per il Premio Fiuggi?”.
Andreotti: “ Mai avremmo
pensato che lo incassasse subito. A coprirlo provvide il caro Geronzi”.
Madre Teresa: “Sempre questi
gossip, serietà! Quindi? I punti salienti di maggior dissenso?”.
Cossiga: “Il Primo? Una
lettura completamente diversa del compromesso storico. Andreotti veniva ancora
percepito come l’uomo del dialogo con i comunisti. Una percezione che gli è
costata addirittura la diffidenza iniziale di San Karol Wojtyla. E poi la
vicenda Moro”.
Andreotti: “Hai sentito
Bettino che hanno fatto un’altra fiction su Aldo Moro? Una serie, come dicono
ora! Una nuova mascalzonata dopo quella de ‘Il Divo’ ”.
Craxi: “Sono sempre loro.
Stavano coi russi e spiegavano come difendere la democrazia a noi democratici.
Mi viene da sorridere a pensare alla fermezza che si evocava per Moro contro la
trattativa socialista quando poi si è trattato, giustamente, grazie all’AISE,
per ogni nostro singolo ostaggio. E adesso la sinistra illuminata riscopre la
trattativa anche per l’Ucraina”.
Cossiga: “A me han dato pure
del bipolare e hanno mandato uno psichiatra al Quirinale perché dicesse che ero
pazzo”.
Craxi: “Rinnegati! Hanno perso
ovunque: nella politica, nell’economia, nella storia, nella società e continuano
a raccontare al mondo l’Italia enfatizzando il peggio. E dove non lo trovano lo
inventano”.
Andreotti: “Arriverà anche per
loro l’onda che li travolgerà. E sarà quella dell’incompetenza, dalla quale è
impossibile difendersi”.
Cossiga: “E pensare che un po’
di questo casino l’ha messo su la famiglia del mio caro amico Mieli. Paolo, con
la pubblicazione dell’avviso di garanzia a Berlusconi del 1994 - in pieno
simposio internazionale sulla criminalità organizzata-, e il figlio producendo
le serie su tangentopoli per SKY. E ora, questo indegno “Esterno notte” di
Bellocchio.
Craxi, tornando sui suoi
passi: “Ricordate la vicenda Sigonella, quando gli americani cercarono di
riprendersi l’assassino di Klinghoffer?”
Andreotti: “ E ricordo anche
che con gli alleati non si sta mai sugli attenti”.
Craxi: “Altro che alleati. Ce
l’hanno fatta pagare cara: a te con accuse infamanti quanto ridicole e a me
costringendomi all’esilio”.
Nel frattempo, Cossiga,
vestito da Appuntato d’onore dei Carabinieri dice loro: “Il 12 giugno prossimo
si votano i referendum sulla giustizia. Marcello Sorgi bene ha fatto a ricordare
che ad un mafioso, condannato all’ergastolo, è stato concesso di lasciare il
carcere per motivi di salute mentre un Presidente del Consiglio, gravemente
malato, l’hanno lasciato morire esule in terra tunisina”.
Andreotti: “Provai perfino ad
intercedere presso la Procura di Milano, attraverso la Santa Sede, dopo che mi
venne a trovare Stefania, pochi mesi prima del tuo lungo viaggio fino a qui. Ma
Il procuratore Borrelli non ne volle sapere”.
Irrompe San Pietro: “Il Signor
Borrelli non è ancora arrivato quassù. Se e quando arriverà gli farete le vostre
rimostranze. Ora basta! Torniamo a pregare, anche per lui. Credo ne abbia
bisogno.”
Dopo trent’anni stiamo
ancora pagando l’illusione di una democrazia senza partiti.
MARCO ALMAGISTI E PAOLO
GRAZIANO su Il Domani il 19 febbraio 2022
Tangentopoli fu la miccia che
innescò l’implosione di un sistema politico già in difficoltà da un paio di
decenni, costretto ad adattarsi ad un mondo reso differente dalla caduta del
Muro di Berlino e dai processi di europeizzazione.
Si pensò di risolvere la crisi
passando a un modello di democrazia “maggioritaria”. In realtà, è molto
difficile che una democrazia cambi “tipo” in modo radicale. L’unico precedente
storico di significativo era la Francia di De Gaulle e il passaggio al
semipresidenzialismo. La nostra transizione si è bloccata presto.
Nel biennio 1992-1994 cambiò
la legge elettorale, ma soprattutto cambiò in modo drastico il sistema
partitico: nessuna delle famiglie politiche fondatrici della Repubblica rimase
in campo con i suoi simboli, il suo nome e la sua classe dirigente. MARCO
ALMAGISTI E PAOLO GRAZIANO
Paolo Cirino Pomicino scrive a
Dagospia il 7 aprile 2022:
Si scopron le tombe si levano
i morti! L’inno di Garibaldi sembra sia aleggiato nell’ultima riunione alla
fondazione de Gasperi dove si sono riuniti per commemorare qualcosa di antico
Alfano, Casini e Cesa, i veri responsabili dell’ecclissi totale del popolarismo
italiano e della gloriosa storia della democrazia cristiana.
Da 38 anni in parlamento il
mio amico Pier ferdinando Casini ha bruciato ogni tentativo di rilanciare una
cultura ed una politica che affondassero le radici nella storia centenaria del
partito popolare bruciandola, alla fine, nel camino di Mario Monti che con
quella cultura non aveva nulla da spartire, mentre il povero Alfano ubbidiente a
Berlusconi per oltre 15 anni si mise in proprio e sotto il suo naso da ministro
dell’interno i Kazaki rapirono Alma Shalabayeva, moglie del dissidente Kazako
Mukhtar Ablyazov.
Scelba e Restivo siciliani
come Angelino, si stanno ancora girando nella tomba. Quelli che avrebbero dovuto
essere gli eredi di Moro, FORLANI, de Mita Andreotti, Donat-Cattin ma anche dei
Bodrato dei Mannino e di tanti altri dirigenti DC dopo aver accumulato macerie
politiche per qualche oncia di potere si sono ridotti, come hanno dichiarato
alla fondazione de Gasperi, a spiegare ai giovani la storia della DC (già
ricordata autorevolmente da Antonio Polito sul Corriere della sera) in una
stagione nella quale bisognerebbe riaccendere il fuoco delle idee e delle
identità a difesa delle conquiste democratiche messe oggi in discussione
nell’indifferenza di tanti e nella profonda crisi del nostro parlamento.
I nostri defunti ci sono cari
ma lasciamo che politicamente i morti seppelliscano i loro morti (Matteo 8,
18-22).
(ITALPRESS il 7 aprile 2022)
– Nel 1942 fu fondata la Democrazia Cristiana, quarant’anni fa nasceva la
Fondazione De Gasperi. In occasione di queste due ricorrenze si è aperto un
percorso per rappresentare e ricordare l’esperienza della DC a 80 anni dalla sua
nascita.
“Il nostro impegno è lavorare
per custodire la memoria e mantenere vivo un ideale, ma senza la nostalgia del
passato perché ogni tempo ha la sua storia”, ha detto Angelino Alfano,
Presidente Fondazione De Gasperi, nel corso dell’iniziativa organizzata dalla
Fondazione: “1992-2022: 30 anni dall’ultima volta della DC”, che ha aperto
l’incontro ricordando Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista venuta a
mancare lo scorso 30 marzo: “Era una donna straordinaria. Si parla giustamente
di padri della patria ma quando si ricorda la sua figura si ricorda anche una
figlia della Repubblica, la signora Maria Romana ha incarnato la figlia di
Alcide e la figlia del Presidente De Gasperi, e credo che solo il rapporto
psicologico tra padre e figlia possa spiegare tutto l’impegno di un’intera vita
per divulgare la missione di suo padre”, ha sottolineato Alfano.
“Dal 1942 al 1992, ultimo anno
in cui si è candidata, la DC ha fatto la storia d’Italia, l’indirizzo storico
della Repubblica è segnato dalle scelte fondamentali della Dc. C’è il suo DNA
nella scelta Atlantica, nella scelta europeista, nell’idea di una società che
dovesse reggersi su una economia sociale di mercato, nei diritti universali come
istruzione e sanità, in scelte di campo permanenti come quella della NATO e in
alcuni indirizzi sul Mediterraneo.
Oggi, a 30 anni dall’ultima
volta della Prima Repubblica – ha concluso il presidente Alfano – credo sia
arrivato il momento per una valutazione e credo si possa fare una analisi che
mantenga vivo un ideale”.
Nel corso dell’iniziativa,
dove è stato presentato lo studio condotto da IPSOS su chi votano oggi gli
ultimi elettori della Democrazia Cristiana, è intervenuto, tra gli altri, anche
Pier Ferdinando Casini, senatore e Presidente del Gruppo Italiano dell’Unione
Interparlamentare, che ha evidenziato la necessità di “coltivare assolutamente
la memoria, un Paese che disperde la memoria di personalità fondamentali per la
sua storia, è un Paese che ha radici poco salde.
Bisogna capire e trasmettere
alle giovani generazioni quelli che è stata la grande ricostruzione del Paese e
il protagonista è stato senza dubbio la Democrazia Cristiana. Coltivare la
memoria di queste personalità – ha spiegato – non significa essere intrisi di
nostalgia, ma avere ben chiaro cosa è stato fatto per posizionare l’Italia dove
è: la scelta Atlantica, la scelta della NATO, la politica mediterranea,
l’Europa”.
Entrando nella più stretta
attualità Casini ha ricordato come nel 1954 “De Gasperi prima di morire nelle
sue lettere scrisse la sua grande delusione: non ci sarebbe stata una politica
comune di difesa bocciata dalla Francia. Lui diceva che non poteva resistere la
costruzione europea basata solo sul polmone economico e monetario, ma che doveva
esserci l’anima politica. Da quell’epoca sono passati 70 anni e siamo a questo,
la vicenda Ucraina ci dimostra in modo inequivocabile che c’è bisogno di De
Gasperi.
C’è bisogno di tornare a
queste grandi personalità che avevano visto tutto 70 anni fa, e i politici
grandi, gli statisti, sono quelli che capiscono prima. È importante che si
coltivi la memoria ed è importante che sia anche da insegnamento per non
ripetere gli errori.
L’occidente ha preso un
abbaglio collettivo su Putin, oggi questi errori ci costano molto. Ci siamo
andati a mettere in una situazione sotto il profilo energetico drammatica, non
abbiamo una autonomia e dipendiamo da Putin.
Se vogliamo vedere la storia
con un qualche fatalismo - ha concluso Casini - diciamo che questa vicenda
drammatica ci sta insegnando a tornare ai grandi principi di De Gasperi, alla
politica di difesa e ad aprire gli occhi. L’Occidente aveva chiuso gli occhi e
girato la testa dall’altra parte, oggi siamo tutti costretti a guardare la
realtà per quella che è”.
La distanza dal mondo
politico post 1994. Viva la Prima Repubblica.
Redazione su Il Riformista il
14 Febbraio 2022.
Con la rielezione
del Presidente della Repubblica molte cose sono avvenute in questi giorni nel
panorama politico e sociale del nostro Paese. La società civile ha preso atto
della crisi profonda nella capacità dei gruppi dirigenti dei partiti (nessuno
escluso) di colmare – in via definitiva – la distanza tra la più che contestata
e criticata 1° Repubblica e l’intero mondo politico nato dopo il 1994. La
rappresentazione plastica del “pellegrinaggio” di tutti i “cosiddetti” grandi
elettori verso il Palazzo del Quirinale a chiedere –con costrizione ed umiltà –
di ritornare indietro sulle sue affermazioni e di accettare il reincarico, non
lascia alcun dubbio.
I “nuovi” politici per
continuare a esercitare il mandato parlamentare loro delegato dai cittadini
devono rivolgersi a personalità della Prima Repubblica, quali il
Presidente Mattarella. E così per Giuliano Amato e così anche per l’attuale
Presidente del Consiglio che può esser annoverato sicuramente tra le risorse
dello Stato proveniente dal quel periodo. Ciò è quello che emerge dai commenti
che ogni cittadino ha pubblicato sui social informatici (tenuto conto che gli
organi di stampa sono tabù al di là di alcune brevi lettere che vengono
pubblicate) e, da questi commenti, emerge anche il rammarico e la dolorosa
certezza di aver perduto oltre 30 anni di democrazia dando fiducia ai politici
ed ai partiti del dopo 1994! Si parla di crisi dei partiti, si solleva il fatto
che “i peones” del parlamento hanno impedito ai loro leader di individuare un
nuovo PdR non all’altezza, ma volutamente si dimentica che i “peones” sono
“nominati” e rispondono a coloro che li hanno scelti! Ogni sussulto di dignità e
di presa di distanza dagli “input” dei segretari dei partiti è stata motivata, a
nostro giudizio, da giochi di “potere” all’interno degli stessi partiti.
Così per il 5Stelle
(gruppo “dimaiano” contro gruppo “contiano”), così per
la Lega (gruppo “salviniano” contro gruppo “giorgettiano”) e così per il PD
tra “lettiani” ed “ex renziani, ex DC, etc.”. Le ultime vicende hanno fatto
emergere, a nostro avviso, non solo l’incapacità politico/culturale della nostra
classe dirigente, ma la loro continua conflittualità a livello personale; il
distacco verso le esigenze reali dei cittadini e l’assenza di visioni di un
progetto politico importante! A riprova di ciò vale ricordare l’intervista ed i
commenti del segretario del PD rilasciati nell’intervista della Annunziata di
domenica scorsa, subito dopo il risultato della elezione del PdR. Ha parlato
della situazione di crisi politica da superare con una nuova legge elettorale
(maggioritaria sostanzialmente e senza preferenze) e per la crisi sociale ha
fatto riferimento al mondo del lavoro citando cifre e percentuali negative sul
piano dell’occupazione.
Ma ha dimenticato – e non è la
prima volta nella sua carriere politica – il fatto che la disoccupazione e
soprattutto la precarietà in Italia è dovuta all’assenza di una politica
meridionalista. Politica meridionalista scomparsa dopo Giacomo Mancini anche
dalla azione politica socialista! Sino a ieri i giovani meridionali – la più
triste gioventù italiana – è riuscita a sopravvivere sostenuta dalle loro
famiglie che hanno rappresentato, nei fatti, la “cassa integrazione” della
gioventù meridionale la quale già da alcuni decenni ha iniziato ad emigrare
verso il Nord e verso l’estero. In un partito come il PD che si dichiara di
sinistra “non una parola” e non una iniziativa “sostenibile” verso questo dramma
dell’Italia (solo l’ex ministro Provenzano ha assunto una posizione” ma il PD
non ha mai mostrato di crederci con convinzione). A fronte di ciò noi crediamo
che i socialisti ed il Psi non debbono e non possono restare silenti.
Abbiamo il dovere, come
partito storico della sinistra, di continuare e rafforzare le lotte in favore
dell’emancipazione sociale, del diritto al lavoro e della sicurezza sul lavoro,
al diritto allo studio ed alla salute pubblica e così per la ricerca ed al
diritto di pari dignità di genere e di difesa delle professionalità e del merito
e, quindi, delle pari condizioni di lavoro e di giudizio in tutti i settori
produttivi. La nostra riflessione di fronte a questa “Waterloo” della politica,
di questi politici e di questi partiti è quella che “non dobbiamo sentirci
vittime” del quadro politico post macerie e considerato che a brevissimo
inizierà l’anno della “campagna elettorale”, sin da subito e senza ulteriore
ritardo, noi socialisti abbiamo il dovere di proporre ai cittadini linee di
profondo cambiamento. Si tratta di fare proposte e di indicare quale strada da
seguire e quali iniziative da assumere sia all’interno dell’area socialista che
verso quello che rimane del quadro politico e, non meno importante, verso la
cosiddetta società civile.
Riteniamo, in primis, che sia
giunto il momento di inviare un forte invito ed un altrettanto fortissimo
appello rivolto ai nostri dirigenti di ogni ordine e grado, ma soprattutto a
tutti gli iscritti al PSI, convinti che mai come adesso abbiamo il dovere di
aprire un dibattito aperto e non strumentale con tutto il mondo dei socialisti
senza tessera sia come singoli cittadini che alle loro realtà organizzate
(associazioni, circoli, movimenti e quant’altro). Non possiamo vivere la nostra
azione politica quotidiana nel chiuso del nostro partito, dove la partecipazione
dei compagni alle scelte politiche fondamentali spesso non è stimolato come
dovrebbe. Nel Paese emerge una richiesta di “socialismo” che va a contrastare
l’inefficienza pubblica quale naturale conseguenza della venuta meno dei valori
portanti socialisti e della stagnazione degli ideali e assenza di alternativa.
In questi anni (e ci riferiamo
non solo agli ultimi anni possiamo andare al 1994) è indubbio che non c’è stata
alcuna alternativa in quanto la sinistra – pur dichiarandosi tale – non è stata
protagonista di un ricambio credibile nell’esercizio della sua azione politica
quotidiano ed a lungo termine. Abbiamo necessità, come socialisti e come Psi, di
ricomporre la diaspora nel nostro stesso mondo, nella nostra stessa area
culturale. Ciò dovrebbe diventare un traguardo da raggiungere a breve termine
quale risultato di un progetto politico che intende misurarsi con tutti i
problemi che la gestione di questi partiti hanno lasciato aperti e che
continuano a lasciarli aperti.
E’ una scelta di fondo e
l’invito ai socialisti senza tessera è quello di “iscriversi” al PSI in quanto
non si possono fare battaglie isolate sui temi economici, sociali e sui diritti
civili se non siamo uniti. Dobbiamo e possiamo dare forza ai lavoratori per
rinnovare anche il movimento sindacale ed a tutto il mondo civile che si ispira
e si identifica con i valori della sinistra. In ultimo solo se uniti e più forti
potremo essere incisivi per quanto riguarda le iniziative che si intendono
assumere a livello parlamentare sul piano della “nuova legge elettorale”. Se
quanto avvenuto fa emergere una considerazione diversa sui politici e sulla
Politica della Prima Repubblica non possiamo che chiedere che sia approvata una
legge elettorale proporzionale pura, con i voti di preferenze e non più nominati
e che sia inserita la “sfiducia costruttiva” e la piena applicazione dell’art.
49 della Costituzione con il riconoscimento dei diritti delle minoranze onde
evitare il fenomeno dei cambi di casacca durante le legislature. E’ auspicabile
che i nostri dirigenti riflettano su queste nostre considerazioni ed assumano le
iniziative? Si è auspicabile e nel nostro piccolo inizieremo a farlo!
F.to – Domenico Carrino, Paolo
Di Pace, Paolo Gonzales, Sandro Petrilli; Gianfranco Salvucci e Christian
Vannozzi del Direttivo della Federazione Socialista di Roma Capitale
Cosa è restato. La lunga
eredità degli anni ’80 che influenza la politica di oggi.
Simona Colarizi su L'Inkiesta
il 26 Gennaio 2022.
Tutte le condizioni che hanno
segnato il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica sono ancora presenti e
definiscono il raggio d’azione degli attuali partiti. Il libro di Simona
Colarizi analizza gli effetti di questa continuità.
Nelle tre ripartizioni del
tempo elaborate da Sant’Agostino – presente del passato, presente del presente,
presente del futuro – «il presente del passato è la storia» attraverso la quale
si ricostruisce proprio quella serie di eventi sui quali è stato edificato «il
presente del presente».
Questa citazione accompagna
costantemente gli storici nel loro lavoro di analisi attraverso il quale fissare
le partizioni temporali, determinanti per valutare quanto profonde siano le
cesure che sanciscono la fine di un’epoca e l’inizio di un’altra, ma anche
quanto a lungo restano operanti gli elementi di continuità tra un prima e un
dopo.
Malgrado la ricca
pubblicistica sulla fine dei partiti che avevano fondato la Repubblica
democratica antifascista nel 1945, sono ancora numerosi gli aspetti di questa
vicenda storica da approfondire; in particolare quei tanti lasciti del vecchio
sistema politico che dopo più di trent’anni, invece di svanire, si sono
moltiplicati fino a diventare caratteri dominanti della seconda Repubblica.
Non stupisce dunque la
persistenza nel tempo delle polemiche appassionate su questa fase rimasta così
viva nella memoria non solo dei protagonisti, ma dei tanti cittadini che nel
giro di due soli anni – primavera ’92-primavera ’94 – hanno assistito alla
scomparsa di tutte le forze politiche della prima Repubblica.
Per individuare quale sia
stata la loro eredità, è necessario risalire alle cause che hanno portato alla
caduta del vecchio sistema politico, ma ancora oggi condizionanti l’esistenza
tormentata della seconda Repubblica quale si è andata definendo dopo il 1994.
Un’esistenza così tormentata da rischiare di travolgere ancora una volta tutti i
partiti del nuovo sistema.
Lo hanno dimostrato le crisi
politiche nel 2011 e nel 2021, quando il ricorso a governi “tecnici” ha
riportato alla memoria l’esecutivo di transizione guidato da Ciampi nel ’93-’94.
In massima sintesi si possono individuare tre elementi di crisi che sono stati
determinanti allora e che continuano a prolungare uno stato di instabilità
politica paralizzante: l’Europa, scelta tormentata alla scadenza di Maastricht
nel ’92 e diventata scelta profondamente divisiva con la nascita dei sovranismi;
il problema del gigantesco debito pubblico che affligge l’Italia negli anni
Duemila come negli Ottanta e nei Novanta; la sfiducia nella rappresentanza
politica all’origine dei movimenti populisti e antipolitici, destinati a
irrobustirsi col passare degli anni fino ad arrivare al governo nel 2018.
Nella ricerca del
passatopresente sono emersi prepotentemente però anche i tanti legami col
passatoremoto, una chiave indispensabile per leggere le tre crisi che sul finire
degli Ottanta portano alla caduta finale. In questa luce il decennio degli
Ottanta, prolungato fino al ’92, può essere interpretato come una lunga fase di
passaggio da un’epoca all’altra, coincidente con l’intero scenario mondiale che
fa da cornice alla vicenda italiana. A partire dagli anni Settanta, con la fine
dell’era industriale e l’avvento di una nuova epoca postmoderna, tutti i paesi
dell’Occidente europeo vivono una lunga fase di trasformazioni profonde da ogni
punto di vista, dai rapporti internazionali alla globalizzazione delle economie
e delle finanze, alle straordinarie acquisizioni scientifiche e tecnologiche; un
insieme di fattori che sconvolgono valori, istituzioni, sistemi di relazioni e
di organizzazione, certezze culturali e materiali, insomma la vita di ogni
individuo e di intere società.
Una rivoluzione di queste
dimensioni mette ovunque a dura prova i governi, tanto più quando nel 1989 con
la caduta del muro di Berlino e poi la dissoluzione dell’impero comunista si
conclude la guerra fredda che ha condizionato l’intero continente diviso per
quarant’anni in due sfere, l’una sotto l’influenza degli Stati Uniti l’altra
dell’Unione Sovietica. In questa cornice l’Italia, come gli altri paesi europei
in balia di una progressiva instabilità sistemica, rappresenta però un caso
unico rispetto ai suoi partner della Cee, in nessuno dei quali la crisi si
manifesta con tale violenza distruttiva da arrivare alla totale distruzione del
sistema dei partiti.
Un’eccezione vistosa da
analizzare alla luce di quei problemi tra loro intrecciati cui si è fatto cenno,
anche se a innescare l’implosione finale sono soprattutto gli eventi dell’89 che
nel caso italiano hanno un effetto devastante, da collegare naturalmente al
maggior peso del vincolo esterno negli equilibri politici italiani rispetto agli
altri paesi dell’Occidente.
Le ragioni sono note,
riassumibili da un lato nella posizione geopolitica del nostro paese, alleato
della Nato e proiettato nel Mediterraneo, un territorio cruciale nel confronto
tra le due superpotenze in guerra; dall’altro lato, nella presenza in Italia del
più forte partito comunista di tutto l’Occidente. Questi due opposti
condizionamenti internazionali per mezzo secolo avevano garantito alla Dc,
alleata degli Usa, una posizione di maggioranza nel paese e nei governi col
risultato, però, di bloccare di fatto ogni ricambio con le forze di opposizione
egemonizzate dal Pci, il cui legame organico con l’Urss era di ostacolo alla sua
legittimazione a governare. Con la fine della guerra fredda il sistema politico
italiano perdeva dunque la sua rigidità, entrando in quella fase di
fibrillazione che si sarebbe conclusa nel 1994 con la scomparsa di tutti i
partiti della prima Repubblica.
Il primo a dissolversi era
stato il Pci che, dopo la caduta del muro, iniziava la lenta mutazione in
Partito democratico della sinistra; ma nessun vantaggio ne aveva ricavato la Dc
che anzi si indeboliva con la scomparsa del “nemico”, da sempre un fattore
fondamentale nella raccolta dei consensi. Insomma, senza più il sostegno dei
vecchi vincoli internazionali, i cattolici come i loro storici avversari si
erano trovati a fare i conti con se stessi e con il compito ineludibile di
consolidare il legame storico con l’Europa, rimasta ormai l’unica sponda
esterna.
Per tutti gli anni Novanta e
anche oltre, con l’eccezione dei saggi specifici sulle relazioni internazionali
e sull’economia mondiale, gli storici politici, a mio giudizio, non hanno
indagato a sufficienza sulle ricadute che il nuovo complesso scenario dei
rapporti tra le potenze avrebbe avuto anche sul sistema economico e finanziario
italiano – e naturalmente su quello europeo. Eppure, si tratta di un campo di
ricerca necessario, se si considera quanto abbia pesato nella caduta del sistema
politico il Trattato di Maastricht che aveva fissato i paletti del percorso
verso l’Unione Europea. Già nella seconda metà degli Ottanta in tutti i paesi
della Cee si era consolidata la consapevolezza di quanto fosse urgente
rafforzare le strutture unitarie per rispondere alla sfida delle trasformazioni
in atto nell’economia mondiale.
Dopo l’89 poi, di fronte al
nuovo mondo policentrico, ci si affrettava a fissare quella serie di regole
sempre più stringenti, confluite poi nell’accordo da firmare alla riunione di
Maastricht, fissata per la fine del ’92. Una firma non scontata da parte di
tutti gli Stati membri, restii ad accettare gli impegni onerosi richiesti da
Bruxelles non solo nel campo dell’economia, ma anche della politica e delle
istituzioni, come avrebbero dimostrato le resistenze registrate prima e dopo il
varo del Trattato. Particolarmente difficile appariva poi l’adesione
dell’Italia, arrivata a questa scadenza con un debito pubblico incontrollabile
che escludeva di fatto il rispetto dei parametri fissati per entrare nel
percorso verso la moneta unica.
Si tratta di un passaggio nel
quale restano ancora senza risposte persuasive molti interrogativi sulla
decisione finale che si assumeva il governo Andreotti; una decisione largamente
condivisa dai politici della destra e della sinistra, lucidamente consapevoli o
ancora parzialmente inconsapevoli che il nuovo vincolo europeo avrebbe fatto
emergere tutte le debolezze di un’economia, di una finanza e di un’industria
ferme ancora alla visione keynesiana nel pieno della rivoluzione liberista
da “Passatopresente. Alle
origini dell’oggi 1989-1994”, di Simona Colarizi, Laterza 2022, pagine 224, euro
20
Muore De Gasperi, il Paese è
sconvolto. La prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno del 20 agosto 1954. De
Secly: è stato l’uomo di tutti gli italiani. Il racconto sulla «Gazzetta» di 68
anni fa. Annabella De Robertis su la Gazzetta del Mezzogiorno il 20 Agosto
2022.
È il 19 agosto 1954: la
notizia della morte di Alcide De Gasperi a Borgo Valsugana sconvolge un Paese
intero. «La Gazzetta del Mezzogiorno» pubblica in prima pagina la foto della
salma dello statista.Uno degli uomini pubblici più in vista d’Italia, è morto
circondato solo dall’affetto della sua famiglia. Nato a Pieve Tesino, in
provincia di Trento, nel 1881, De Gasperi studiò lettere a Vienna. Si batté
fortemente per difendere l’identità culturale italiana della sua regione e fu
propugnatore della completa autonomia trentina dall’Austria. Dopo l’annessione
all’Italia, nel 1921 entrò in Parlamento: tre anni dopo sostituì Sturzo,
costretto all’esilio da Mussolini, alla guida del Partito Popolare.
Antifascista, nel 1927 fu arrestato e condannato a 4 anni: dopo aver scontato un
anno di detenzione, si rifugiò in Vaticano, dove fu assunto come bibliotecario.
Caduto il fascismo, fu tra i fondatori della Democrazia Cristiana. Da allora in
poi è stato protagonista assoluto dell’Italia della Ricostruzione: ultimo
presidente del Consiglio dei Ministri del Regno e primo della Repubblica,
mantenne l’incarico per sette mandati consecutivi, fino all’agosto 1953.
Ebbe l’ingrato compito di
rappresentare un Paese marchiato dal fascismo e dilaniato dalla guerra di
Liberazione alla Conferenza di Pace di Parigi, all’indomani della Seconda Guerra
Mondiale: con un eccezionale discorso al Palais du Luxembourg contribuì a
ristabilire la credibilità politica internazionale dell’Italia. «L’improvvisa e
inattesa morte di Alcide De Gasperi ci ha colpiti profondamente come uno dei più
cari lutti familiari», scrive Luigi De Secly in prima pagina. «Gli ultimi dieci
anni di questa travagliata e perigliosa esistenza l’avevamo vissuti accanto a
lui, anche se fisicamente lontano da lui. Prima ancora di essere uomo di parte,
capo ammirato e amato della Democrazia Cristiana, De Gasperi è stato l’uomo di
tutti, colui che per il suo Paese aveva speso e andava spendendo le energie
migliori della sua natura pacata ed esuberante al tempo stesso, della sua fede
che non conosceva infingimenti e che aveva sfidato mille prove sempre più gravi,
dall’esilio al carcere, dalla clausura alla ribalta più spietata, alle
responsabilità politiche e storiche probabilmente le più gravi che abbia dovuto
affrontare umana creatura.
Fiero oppositore del regime
fascista, artefice della rinascita dell’Italia pur tra incertezze e discordie ma
sempre fermissimo nel volere e nel perseguire il benessere generale,
specialmente delle classi diseredate alla cui esistenza aveva giorno per giorno
partecipato e per le quali aveva formulato nuove leggi che oggi pongono l’Italia
alla testa dei Paesi riformatori dell’Europa».
Alcide De Gasperi: Il più
grande statista del ‘900 italiano.
Alcide Amedeo Francesco De Gasperi (3 aprile 1881- 19 agosto 1954) è considerato
dalla storiografia moderna come uno dei più grandi statisti italiani. Tanto che
lui amava ripetere: "Il politico guarda alle prossime elezioni, lo statista alla
prossima generazione". Federico Bini il 21 Ottobre 2022 su Il Giornale.
Enzo Biagi, riguardo a uno dei
più illustri padri della Democrazia Cristiana, scriveva: “De Gasperi è scomodo
per i potenti d’oggi. De Gasperi è una figura di statista che ti spinge a fare
confronti tra i suoi comportamenti, i suoi riserbi, la sua sobrietà, la sua
solitudine e lo stile di vita di coloro che vogliono accreditarsi come i suoi
eredi. Lui rispondeva solo alle sue idee e alla sua coscienza. Lo celebrano, lo
ascoltano, lo esaltano, ma non fu amato e non fu capito. Nemmeno dai suoi. Per
tutti gli anni in cui lavorò nella Biblioteca Vaticana, non ebbe mai una visita
da un prelato, anche se poi aggiungeva: “Ho un debito di gratitudine poiché con
le 700 lire che guadagnavo ogni mese ho mantenuto la famiglia”.
Dalla penombra e dalle ceneri
della guerra perduta, l’Italia vide emergere un personaggio inconsueto, rigoroso
e austero, lontano dalla retorica e dalla narrativa teatrale della politica a
cui gli italiani erano stati abituati durante il fascismo ma anche prima,
nell’Italia liberale.
Nato in un piccolo borgo di
montagna, Pieve Tesino (vicino Trento), circondato da castagneti, abeti, pini e
dal suono dolce e rilassante dei pascoli. Poi ci sono i campanili e le chiese
che con loro suono segnano le ore nel vuoto delle valli. Gente semplice gli
abitanti, contadini e massaie che lottano nella loro quotidianità contro le
fatiche e i dolori di una vita dura ma ricompensata dall’amore per i loro monti,
per la loro terra, per i loro bestiami.
A Borgo Valsugana, De Gasperi
abitava nella prima grande casa, a sinistra venendo dalla stazione. “La casa,
bassa, un po’ tozza, in pietra e dagli alti soffitti - ricorda la figlia Maria
Romana – ha i tappeti e i mobili scuri che sembravano a proprio agio, certi di
vivere a lungo”.
In questo umile mondo
contadino, molto ‘verghiano’, in cui si cercava attraverso i veri valori della
vita di proteggersi dalla “fiumana del progresso”, nacque Alcide De Gasperi. Il
più grande statista del ‘900 italiano e, assieme a Cavour ed Einaudi, uno dei
padri della patria. De Gasperi era un uomo dall’aspetto apparentemente severo e
asciutto nell’eloquio. Occhi grigi e volto di pietra, con evidenti e scavati
segni di anni di lotta e sofferenze, mantenne sempre un carattere calmo,
paziente, quasi “liturgico”.
Era un uomo di grandi ideali,
di specchiata onestà, un servo devoto di Cristo e cercò sempre nel corso della
sua vita di non perdere mai la speranza ed il senso della fede, la sua vera
àncora di salvezza insieme all’amore per la famiglia nei tanti momenti bui in
cui tutto sembrava perduto.
Egli seppe conciliare la fede
con l’amore per la patria. Pur mantenendo distinte le due sfere d’influenza.
Politico accorto e realista, di rara modestia, consigliava ai giovani di non
lasciarsi andare alla “mitologia politica” e proprio ad un Congresso della
gioventù democristiana disse: “Non ci sono uomini straordinari. Non ci sono
uomini entro il Partito e fuori, pari alla grandezza dei problemi che ci stanno
di fronte [...] Per risolvere i problemi, vi sono vari metodi: quello della
forza, quello dell’intrigo, quello dell'onestà, quello della fermezza in una
fede sicura. Se io sono qualche cosa, in questa categoria, mi reputo di
appartenere alla terza. Sono l’uomo che ha l'ambizione di essere onesto. Quel
poco di intelligenza che ho la metto al servizio della verità] Non voglio essere
altro. Quindi il grido di “Viva De Gasperi”, lo traduco “Viva l’uomo di buona
volontà che cerca la verità”.
La nomina a presidente del
Consiglio
Nel difficilissimo momento del
dopoguerra, in cui la fame, la miseria, i contrasti politici e sociali tra forze
democratiche, comuniste e monarchiche infiammavano la vita politica del paese,
ecco che Alcide De Gasperi seppe guidare il popolo italiano, con fermezza,
intelligenza e lucidità, cercando di unirlo e di rinfrancarlo. Molti lo
criticarono, soprattutto i comunisti di Togliatti, pensando che volesse
distrarre l’opinione pubblica, che era al servizio del Vaticano e degli Stati
Uniti, ma niente fermò la sua ascesa, data dal suo prestigio personale e
culturale.
Nel 1945 fu nominato
presidente del Consiglio dei ministri, l’ultimo del Regno d’Italia; carica
delicatissima in un momento drammatico: l’unità nazionale – faticosamente
raggiunta – era messa in pericolo e tra il governo e la casa reale gli scontri
di palazzo furono durissimi.
Alle 22:10 dell’11 giugno
1946, De Gasperi, a colloquio con il Re, tra galanteria politica e diplomazia,
ormai in rotta con il marchese Luciferino che accusava (nuovamente) il governo
di fare pressione sulla Cassazione per accelerare i lavori, De Gasperi, si
rivolse al marchese dicendo: “Io ho finito il mio latino, si vuole ricorre alla
forza? Va bene, vorrà dire che io verrò a trovarla a Regina Coeli o Lei verrà a
trovare me”. Fu uno scontro che fece tremare il già fragile Statuto albertino.
Durante tale governo fu
proclamata la Repubblica e perciò De Gasperi fu anche il primo presidente del
Consiglio dell’Italia repubblicana.
Il 9 dicembre del 1946 fu
invitato dall’amministrazione americana, e nel suo viaggio negli Stati Uniti
(4-17 gennaio 1947) mise fine all’isolamento internazionale dell’Italia. Il
presidente Truman rimase colpito da quest’uomo, che rappresentando un paese
sconfitto, demoralizzato, alla fame e con poche prospettive per il futuro, seppe
dare prova della sua grande dignità, ma anche della sua tenacia e soprattutto
del suo essere italiano nonostante Mussolini con disprezzo lo chiamasse
“l’austriacante”.
Parlò a nome del popolo
italiano, mantenendo la schiena dritta e non venendo meno ai suoi principi
cristiani e liberali. L’Italia era sì un paese sconfitto, ma De Gasperi – con la
sua squadra di governo aiutata anche dal ruolo fondamentale degli ambasciatori a
Parigi, Londra, Washington come ad esempio Tarchiani – riuscì a far passare un
messaggio di svolta, autorevolezza e sincera amicizia tra due nazioni che
avevano a cuore i destini, la stabilità e la pace del mondo occidentale.
L’amministrazione Truman non esitò a concedere prestiti e aiuti alimentari.
L’Italia della ricostruzione
di De Gasperi prese avvio dopo questo fondamentale viaggio, che lui fece
accompagnato dall’amata figlia e segretaria particolare, Maria Romana.
Il 10 agosto 1946 si era
invece recato invece a Parigi, con il ministro degli Esteri Carlo Sforza, per
partecipare alla Conferenza che doveva stabilire le clausole del Trattato di
pace. I diplomatici lì convenuti presentarono il conto da pagare ai paesi
sconfitti. Il presidente del Consiglio italiano prese la parola per pronunciare
uno dei suoi interventi più memorabili, esordendo così: “Prendendo la parola in
questo consesso mondiale sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è
contro di me”. Nessuno applaudì, solo il Segretario di Stato americano James
Byrnes si alzò per andargli a stringere la mano e fu l’unico gesto di umanità.
La rottura con il Pci
Tra crisi di governo, attacchi
da parte di molti Paesi che ci vedevano come sconfitti in ogni campo, l’avvio
difficile del Piano Marshall, l’Italia che andò a votare nel 1948 (ben il 92%
degli aventi diritto), ebbe fiducia in De Gasperi e per la Democrazia Cristiana
fu un trionfo: maggioranza relativa dei voti (48,5% alla Camera dei Deputati,
48,14% al Senato) e la maggioranza assoluta dei seggi.
Personalmente il presidente
democristiano ottenne un plebiscito di preferenze, battendo enormemente gli
altri leader. Dopo queste elezioni iniziò la vera e propria fase del ‘centrismo’
con De Gasperi che volle però allargare l’esecutivo.
La Democrazia Cristiana di De
Gasperi si mostrava come un partito fortemente interclassista, capace di
catturare il consenso nei diversi e divergenti strati sociali del paese: dal
piccolo mondo rurale del mezzogiorno alle grandi proprietà fondiarie e
imprenditoriali del nord. Se poi ci soffermiamo allo straordinario risultato
raggiunto alle elezioni del 18 aprile del 1948, quella che De Gasperi definì
“una battaglia di civiltà”, osserviamo che il partito raggiunse la maggioranza
assoluta alla Camera e una maggioranza risicata al Senato. Questo risultato,
contrariamente alle spinte che venivano dalla Chiesa e da settori interni alla
dc, non impedì al presidente del Consiglio di formare un nuovo governo
comprendendo i “partiti laici”.
Il raggiungimento di un
risultato così unico fu dato dal fatto che ampie parti del paese, dalla grande
industria ai forti interessi economici locali, nonostante fossero pervase da un
trasversale anticlericalismo votarono la dc in chiave anticomunista. Uno dei più
attivi oppositori a De Gasperi, in una dc che ancora non era divisa in numerose
correnti che si andranno formando dopo la morte dello statista trentino, fu
Giuseppe Dossetti. Qui è utile distinguere tra la dc di De Gasperi e Dossetti,
come fa il Prof. Bedeschi nel suo libro La Prima Repubblica. Storia di una
democrazia difficile.
Mentre De Gasperi si era
formato sotto l’influenza della Rerum Novarum di Leone XIII, si ispirava ai
principi del cattolicesimo liberale e rappresentava la classe dirigente del
defunto Partito Popolare, Dossetti, anche per età anagrafica, era cresciuto nel
fascismo e in particolare negli anni della crisi del ’29 scoppiata in America e
da cui aveva maturato una forte critica al sistema capitalistico. Da qui le
letture di Jacques Maritain, l’ammirazione per la Costituzione sovietica del
1936 e la collaborazione con i comunisti. Non a caso, quando De Gasperi ruppe
con il fronte socialcomunista la “grande collaborazione tra forze popolari”, per
citare Togliatti, fra i suoi più accesi oppositori vi fu Dossetti, che intorno a
sé aveva radunato un gruppo di giovani, da La Pira a Fanfani che saranno i
futuri rappresentati della sinistra democristiana.
Le elezioni del 1948 videro
scontri politici molto duri tra i vari candidati, in particolare tra Togliatti e
De Gasperi. Quest’ultimo percorse l’Italia in aereo, in treno, in macchina, da
nord a sud, per andare a diffondere in ogni angolo del paese la sua politica, le
sue idee e la sua fede.
I tanti governi di De Gasperi
L’attività politica dei
governi De Gasperi si sviluppò su tre fronti, che rispecchiavano, la concezione
politica degasperiana espressa nel suo manifesto dal titolo Le idee
ricostruttive della Democrazia Cristiana: l’Italia entrò nel Patto Atlantico il
5 maggio 1949, nacque il Consiglio d'Europa e il ministro Carlo Sforza disse “è
il frutto di un compromesso fra le più avanzate aspirazioni franco-italiane e
quelle assai più caute, invece, del governo britannico”. Furono realizzati
accordi economici europei, quali ad esempio la CECA , la politica di
ricostruzione fu caratterizzata dalla riforma agraria, predisposta dal ministro
dell'Agricoltura Antonio Segni e inizialmente denominata ‘legge Sila’, poiché
riguardava solo la Calabria, poi estesa - con l’approvazione della “legge
stralcio” - ad altri territori italiani. Venne poi varato il piano INA-Casa,
nacquero la Cassa per il Mezzogiorno e l’Eni, fu compiuta la riforma tributaria
e la Lira si stabilizzò sotto la guida di Einaudi. Infine furono modificate la
legge elettorale amministrativa e poi quella politica. Era l’estate del 1950
quando furono varate queste riforme: successivamente il 1950 passerà alla storia
come “l’anno delle riforme”.
De Gasperi, dopo tutti questi
mesi di grande fatica e laboriosità, era felice dell’andamento del suo governo,
pur mantenendo sempre un certo realismo sulle importanti riforme appena varate
scrisse: “Con la riforma agraria, vedete, noi facciamo un atto di giustizia
distributiva immediata, umanamente e cristianamente necessaria, forse
politicamente utile, benché in politica non bisogna sopravvalutare la
riconoscenza degli uomini. Tutto questo, ricordatevi, non risolverà il problema
economico del Mezzogiorno. Esso va completato in un quadro di economia più vasta
guardando al domani. Oggi non possiamo adottare una forma migliore, ma noi
uomini politici dovremmo stare attenti a non scivolare dall’economia alla
demagogia. C’è tanto da fare e in così poco tempo!”.
I governi repubblicani, che De
Gasperi guidò dal 1948 al 1953, pur tra mille difficoltà politiche, sociali ed
economiche, furono di grande spessore e soprattutto governi ‘europei’, con un
presidente del Consiglio europeista.
De Gasperi sognava un’Europa
unita, tanto che diceva “la nostra patria Europa” e dopo che nel luglio del 1953
decise di dedicarsi solo alla vita di partito, ecco che ci fu il coronamento di
una grande carriera, ma soprattutto un riconoscimento personale alla sua
attività politica e diplomatica: Alcide De Gasperi divenne presidente
dell’Assemblea Comune della CECA.
Il ‘figlio delle Dolomiti’,
delle sue amate montagne che tanto la avevano formato e rafforzato, diventò il
simbolo della futura Europa unita. Alcide De Gasperi, quel ragazzo che diceva
senza vergogna “Io vengo da un ceppo di contadini e mio nonno lavorava quella
magra terra, che è più roccia che terra”, arrivò al vertice della politica
europea, che per lui non consisteva nel trarne vantaggi personali o partitici,
la vita gli aveva tolto ma anche dato tanto, bensì lavorare nell’esclusivo
interesse dei cittadini.
La scomparsa
Ma De Gasperi aveva già dato
tanto, anzi troppo al nostro paese che forse mai lo capì veramente. Il suo corpo
lo aveva sostenuto anche laddove nessuno se lo sarebbe mai immaginato, come
quando, ormai malato, il medico gli sconsigliò di andare a Parigi, egli andò
ugualmente e poi riuscì a partecipare al suo ultimo Congresso politico, a Napoli
nel 1954, dove parlò e si sentì male, tanto che dovettero interrompere i lavori.
Tuttavia dopo venti minuti riprese la parola e finì il discorso. Fu proprio quel
discorso, forse perché sapeva che sarebbe stato l’ultimo, ad essere considerato
come il suo testamento politico.
È il 19 agosto 1954 la data
che segnerà la morte del più grande statista e uomo politico italiano del ‘900.
Le sue spoglie riposarono su
un letto coperto di ciclamini e fiori di montagna. Fino all’ultimo desiderò che
il suo letto fosse spostato verso la finestra per poter vedere meglio le sue
montagne, che tanto lo avevano formato e che mai dimenticò.
La salma fu trasportata in
treno da Trento a Roma, e ovunque la folla giunse per rendere omaggio. A Roma fu
sepolto nel porticato della Basilica di San Lorenzo. Qualcuno tra la folla, in
una delle stazioni in cui il treno si fermava, mentre si avvicinavano i
potentati della Dc urlò: “De Gasperi è nostro, non vostro!”.
La Democrazia Cristiana, il
partito da lui creato, governerà per ben cinquant’anni, ma i suoi allievi forse
un po’ troppo ambiziosi di potere e meno degli interessi delle classi sociali
verso cui De Gasperi chiese massima attenzione prima di morire, portarono la Dc
al suo inesorabile tracollo politico e morale.
Con la scomparsa del politico
trentino, scrisse Indro Montanelli che “entrò in scena una classe politica che
nulla sapeva di Stato e tutto di una cosa sola: il potere che mai smise di
contendersi [...] Con De Gasperi finisce un’epoca e ne comincia un’altra
certamente non migliore”.
Vita e opere
di uno dei padri della Repubblica. La storia di Alcide De Gasperi, il suddito
austriaco che ci portò nel mondo libero.
Paolo Guzzanti su
Il Riformista l'1
Aprile 2022.
L’Alcide. Alcide
e Palmiro. E Pietro Nenni. Come ritirar fuori dalla naftalina della memoria un
uomo come Alcide De Gasperi, di cui si ricorda a malapena che fu lui con la
sua Democrazia Cristiana e gli alleati, a vincere le minacciosissime elezioni
del 1948? Fu allora, il 18 aprile di quell’anno, che il “Fronte Popolare” delle
sinistre perse quello che si rivelò un referendum per la scelta di campo nella
guerra delle civiltà che a quei tempi era brutale: Russia o America, I
socialisti avevano appena perso il gruppo filoamericano di Giuseppe Saragat, con
cui si schierò anche la rivoluzionaria russa Anna Kuliscioff.
Fra le due guerre
mondiali Anna era stata una dirigente del partito comunista nell’Unione
Sovietica di Lenin e Stalin e poi era tornata in Italia sconvolta e felice di
parteggiare per i filoamericani. Alcide invece era imperiale. Era nato cittadino
dell’Impero Austro-Ungarico, era stato deputato per l’etnia italiana al
Parlamento di Vienna, era impazzito di dolore quando il Regno
d’Italia nel 1915 decise di scendere in guerra con l’Intesa contro la Triplice
alleanza. Alcide era costernato e di notte a Trento litigava con Cesare
Battisti, che poi scappò in Italia, si arruolò, fu preso prigioniero dagli
austriaci e giustiziato da un boia con la bombetta che gli stringeva a mano il
cappio. L’altro del terzetto a Trento che faceva notti insonni con la barba
lunga e il revolver sempre sul tavolo, era Benito Mussolini, con gli occhi
strabuzzati per la fame, la barba incolta e senza fissa dimora, tessendo
complotti. Poi, la polizia imperiale gli notificò un ordine di espulsione che lo
portò a Ginevra nello stesso albergo di Lenin, il quale in seguito dirà di non
averlo mai visto mentre Mussolini non faceva che raccontare storie su
quell’amicizia.
Alcide De
Gasperi era uomo d’ordine e quando l’Italia dichiarò guerra all’Austria, andò a
trovare i funzionari viennesi che conosceva per dire quanto era disperato per la
scelta di Roma e che certamente a un eventuale referendum il novanta per cento
dei trentini italianofobi sarebbe stato per l’Impero. Poi ci fu la guerra, venne
in Italia e seguitò a costruire il Partito Popolare, ovvero il partito dei
cattolici, ovvero la futura Democrazia Cristiana. Quell’allucinato capopolo
baffuto con cui litigava di notte a Trento, era diventato capo del governo
fascista a Roma, e si era tagliato i baffi. Ma si era messo in testa il cilindro
e portava le ghette. Il resto è storia nota: esilio, sparizione, rapporti
clandestini con i cattolici diventati antifascisti dopo essere stati
fascistissimi e poi lo spirito della Resistenza. E poi scoppiò la Guerra
fredda. Erano le avvisaglie, già marcate. Stati Uniti e Regno Unito stavano
rompendo con Stalin dopo Yalta. Churchill aveva pronunciato il discorso
di Fulton, in America, in cui aveva inventato l’espressione “Cortina di
ferro” – The Iron courtain – da cui i derivati oggi incomprensibili
come “oltrecortina” e insomma bisognava decidersi e schierarsi da una parte o
dall’altra.
Per la verità
c’era poco da decidere perché i quattro grandi avevano già deciso tutto
a Yalta dove i dettagli erano stati decisi solo da Churchill e Stalin che
trattavano durante la conferenza passandosi dei disegnini fatti su una scatola
di fiammiferi da cui sarebbe emersa l’Europa: Stalin voleva i “buffer
states” esattamente come oggi Putin: una cintura di stati vassalli, occupati. E
l’Italia non era fra quelli: appartenevamo al mondo libero dei Paesi liberi
sotto controllo americano ma ancora a quei tempi britannico. De Gasperi odiava
i Savoia che invece i conservatori inglesi avrebbero voluto salvare per maggior
stabilità conservatrice e De Gasperi amò gli americani. Così, di botto. C’è da
dire che nel frattempo l’Alcide era diventato capo del governo ed era un governo
con dentro comunisti e socialisti (Pietro Nenni agli Esteri, Togliatti alla
Giustizia) e lo sarebbe stato per circa cinque anni, per essere poi fatto fuori
dalle leve fameliche della Dc. Basta dire che De Gasperi si era preso come
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio il più giovane, il più votato da
monache e preti, deputato italiano, un ragazzino di nome Giulio Andreotti.
L’Italia che fu
governata da De Gasperi all’inizio era l’Italia del Cln e dell’antifascismo, ma
dopo il viaggio in America sarebbe diventata l’Italia della Guerra Fredda e
dell’anticomunismo. I comunisti sapevano perfettamente che sarebbe finita così
perché era scritto non sull’acqua ma sulle carte ma reagirono molto male.
Durante il suo
primo viaggio, De Gasperi restò sbalordito dall’America, dagli americani, dal
loro modo di festeggiarti. Gli Usa avevano i duri al comando: i fratelli Dulles
– Foster al dipartimento di Stato e Allen capo della Cia – il
presidente Truman succeduto a Roosevelt come suo vice, ma con un animo da
repubblicano pronto alla rissa. Fra cerimonie e fuochi, parate e fanfare, gli
americani dissero ad Alcide che l’Italia si sarebbe trovata benissimo nello
schieramento delle democrazie del mondo libero. E poi, ecco qua i primi
cinquecento milioni di dollari in aiuti, molti di più ne verranno, pensa di
poter dire che Italy is with us? De Gasperi non aveva bisogno di essere forzato:
aveva dichiarato molte volte il suo timore, poi il suo disgusto per il mondo
dell’Est. Una volta rientrato De Gasperi, si sparse subito la voce: abbiamo un
contratto con l’America. Dobbiamo sbattere fuori comunisti e socialisti dalla
coalizione di governo.
De Gasperi lo
fece e l’Italia andò allo scontro: da una parte la Democrazia cristiana alleata
dell’America e dall’altra comunisti e socialisti alleati dell’Urss. A quel tempo
le posizioni di Pietro Nenni erano ancora fortemente filosovietiche anche se poi
avverrà lo sganciamento con la riconsegna del “Premio Stalin” che il leader
socialista aveva incautamente accettato. Gli americani avevano promesso a De
Gasperi di darsi da fare per restituire Trieste all’Italia. Trieste era in un
regime di occupazione alleato ma di fatto sotto il dominio jugoslavo del
Maresciallo Josip Broz, detto Tito, un eroe partigiano legatissimo, tuttavia,
agli inglesi e in particolare a Winston Churchill, considerato il delfino
di Stalin, ma che proprio nel 1948 ruppe con Stalin provocando un terremoto
nell’area balcanica. Nel 1948 si sarebbe consumato un colpo di Stato comunista a
Praga. Le elezioni del ‘48 furono elezioni come non se ne erano mai viste in
Europa: combattute con comizi volanti, manifesti, gli “agit-prop” comunisti
capaci di tener testa a chiunque, sicché la sensazione era che il Fronte
vincesse.
Ricordo benissimo
gli uomini in bicicletta – le città erano solo piste ciclabili con poche
macchine, che si fermavano un attimo come le formiche per dirsi: “il Fronte
vince”. Il Fronte si presentava con il volto di Garibaldi, la coalizione
democristiana aveva per simbolo lo scudo crociato che è pur sempre un’arma
difensiva. La coalizione guidata dalla Dc prese il 48 per cento e le sinistre
erano crollate anche sotto il martello dei parroci chiamati a ricordare dal
pulpito delle chiese che i comunisti erano scomunicati e nemici della chiesa di
Dio. De Gasperi personalmente aveva vinto e si preoccupò di dar vita a un
governo di coalizione con repubblicani e socialdemocratici di cui non aveva
realmente bisogno. Ma sapeva che le elezioni non sarebbero più state vissute
come uno scontro di civiltà e che l’idea di dare al Paese uscito da una guerra
voluta da un uomo solo al comando, era sbagliata.
D’altra parte, lo
aspettava una prova tremenda: far accettare agli italiani e ai partiti,
l’adesione al Patto Atlantico, quello che oggi chiamiamo
semplicemente Nato. L’Italia, fascisti a parte, non si sentiva per niente
affascinata dalla prospettiva dell’adesione a una alleanza militare che
rappresentava una parte del mondo armata contro l’altra. Il capo del movimento
cattolico contrario a quell’adesione fu l’intellettuale, non ancora
prete, Giuseppe Dossetti, che fece appello alla coscienza dei cattolici affinché
non accettassero un voto parlamentare di ratifica del trattato. La risposta di
De Gasperi fu da giocatore di scacchi: mandò a Castel Gandolfo (residenza estiva
del papa) il conte Sforza, che era stato il suo candidato presidente. Sforza
spiegò al principe romano Eugenio Pacelli, ora Papa Pio XII, la necessità di
richiamare all’ordine la sinistra cattolica e Pacelli – che era stato per anni
il miglior diplomatico della Santa Sede – acconsentì. Fece un’omelia in cui si
spiegava perché ogni buon cristiano avrebbe dovuto essere a favore
dalla Nato e Dossetti in Parlamento fu costretto a votare a favore.
Ma col Vaticano
le cose non andarono sempre lisce: «Chi poteva immaginare che proprio a me,
povero cattolico della Valsugana, dovesse capitare di dire di no al papa»,
scrisse De Gasperi nelle sue memorie. Era accaduto quando il papa aveva deciso
di far candidare a Roma come sindaco Don Sturzo, figura storica del partito
popolare di cui era stato fondatore, con i voti di monarchici e fascisti per
contrastare i comunisti. De Gasperi disse di no, non avrebbe mai chiesto al suo
partito di coalizzarsi con fascisti e monarchici. L’ultima sua battaglia fu una
battaglia persa. Quella della cosiddetta “legge truffa”. Si trattava di una
legge elettorale maggioritaria arrivata al voto in Parlamento che avrebbe
assegnato un premio al partito di maggioranza relativa,
Il Pci e
il Psi scatenarono una formidabile campagna mediatica fatta da giornali, radio e
comizio per strada e alla fine la legge non passò per pochi voti e la sinistra
unita ebbe la sua rivincita. E De Gasperi vide anche che nel partito la sua
leadership era finita. Era stato battuto. E con uno stile impeccabile si dimise
e lì terminò la sua carriera storica cominciata come suddito entusiasta
dell’imperatore Francesco Giuseppe.
Paolo Guzzanti.
Giornalista e politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della
Fondazione Italia Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza
Italia e deputato nella XVI per Il Popolo della Libertà.
L’Ucraina e la scelta
occidentale: il timone della vecchia Dc (che manca all’Italia).
Antonio Polito su Il
Corriere della Sera il 3 aprile 2022.
Il ruolo che fu di De Gasperi
e degli altri democristiani. Ora intorno a Pd e FdI potrebbero saldarsi due poli
per garantire, nell’alternanza, la collocazione del Paese.
Ci vorrebbe un’altra Dc.
Nell’assistere alla confusione ideale e talvolta anche morale, alle furbizie e
ipocrisie del dibattito politico italiano intorno alla guerra all’Ucraina, viene
da rivolgersi al passato. Perché la Democrazia Cristiana, che trent’anni fa,
proprio in questi giorni, partecipava con il suo simbolo per l’ultima volta alle
elezioni, ha commesso molti errori, e anche qualche reato, ma su un punto non ha
mai sbagliato: è stata per quarant’anni la garante della collocazione
dell’Italia in Occidente, dalla parte giusta della storia.
L’adesione alla Nato
Ripercorrendo le vicende
dell’adesione alla Nato nell’aprile del 1949 sembra di rileggere le vicende
dell’oggi. Allora eravamo noi, piccola nazione sconfitta e distrutta dalla
guerra, a chiedere di entrare nella nuova Alleanza, e negli Stati Uniti molti
non si fidavano, tanto che la decisione finale fu rimessa al presidente Truman
in persona. Ma anche allora il pericolo per l’Europa era l’espansionismo russo,
a quel tempo rivestito peraltro della formidabile forza ideologica del
comunismo. Non fu facile, nemmeno per la Dc. Esisteva in quel partito una
componente di «terzaforzismo religioso», ben rappresentata dal gesuita
padre Riccardo Lombardi. C’era il gruppo di Giovanni Gronchi, un cattolico così
poco atlantista che quando fu eletto presidente nel 1955 l’ambasciatrice
americana Clare Boothe Luce rifiutò di partecipare al ricevimento inaugurale,
lamentando un malanno che fu subito ribattezzato «gronchite». E poi c’era la
resistenza dei dossettiani. Perfino nella diplomazia vaticana si auspicava una
collocazione più defilata dell’Italia, ospite della Santa Sede. Fu Pio XII a
rompere gli indugi: il cristiano doveva rifiutare il motto «si vis pacem para
bellum», ma anche l’espressione «pace a tutti i costi»; perché l’opzione
pacifista doveva essere «pratica e realistica», non frutto di «debolezza o
stanca rassegnazione».
Il trionfo di De Gasperi
Così vinse De Gasperi. E
l’Italia non ebbe a pentirsene. Né in termini economici né in quanto a libertà.
Certamente non nel 1956, quando l’Armata Rossa invase l’Ungheria per stroncare
un tentativo di riformismo, o nel 1968 quando i tank del Patto di Varsavia
stroncarono nel sangue la primavera di Dubcek a Praga. Al punto che Enrico
Berlinguer, il capo di quel partito comunista italiano che negli anni ’50 si era
battuto in nome del pacifismo contro la scelta atlantica, nel 1976 riconobbe a
Giampaolo Pansa, sul Corriere, che sotto l’ombrello Nato si sentiva più sicuro
per la democrazia italiana. Da un certo punto di vista la scelta della Dc di
allora fu persino più facile, perché più obbligata, di quella di fronte alla
quale si trova l’Italia di oggi: il mondo diviso in blocchi, il fattore K, il
pericolo comunista, non lasciavano molti margini di scelta. Ma, d’altra parte,
allora ci si trovava di fronte a una minaccia grave ma pur sempre rimasta sempre
e solo virtuale: una Guerra Fredda fondata sulla deterrenza che per fortuna non
diventò mai calda. Mentre oggi la guerra è calda del sangue di migliaia di morti
civili in Ucraina, e il pericolo è ben più reale e immediato, e l’espansionismo
russo è anche più cinico, animato com’è da un nazionalismo neanche più portatore
di una missione universale, come era ai tempi del comunismo. Qualcosa di questa
radice occidentalista (che del resto non impedì alla Dc di essere anche
europeista con De Gasperi, neo-atlantista e mediterranea con Fanfani,
filo-palestinese con Andreotti) è per fortuna rimasta nell’elettorato italiano,
almeno in quello più anziano. In una ricerca di Ipsos realizzata per la
Fondazione De Gasperi, la scelta di entrare nella Nato è ancora considerata da
un terzo degli italiani nati prima del 1974 come la più importante fatta dalla
Dc (contro un quarto dei «millennial», nati dopo il 1980). E, curiosamente, gli
ex elettori scudocrociati — ne sono rimasti 5.628.000 che votarono Dc nel 1992 —
riversano oggi i loro voti principalmente al Pd (13,8%) e a Fratelli d’Italia
(13,4%); cioè ai due partiti più coerentemente schierati dalla parte dell’Europa
e dell’Occidente nella crisi ucraina e più attenti alla dimensione
internazionale della politica.
Il buco nero al centro
C’è da chiedersi se questo
seme potrà germogliare in un sistema politico italiano che ha oggi al suo
centro un grande buco nero, un partito di maggioranza relativa che non lo è più,
che non ha una sua idea della politica estera, e soprattutto tende a
subordinarla agli interessi contingenti della politica interna. Naturalmente non
nascerà una nuova Dc. Ma nei due schieramenti potrebbero saldarsi intorno al Pd
e a FdI poli che garantiscano, anche nell’alternanza delle maggioranze, la
collocazione del Paese. Oppure potrebbe un giorno nascere al centro una
maggioranza ridefinita da questa guerra, unita dalla politica estera e di
difesa, garante dell’europeismo e del rapporto transatlantico, corazzata contro
gli avventurismi filo-russi o filo-cinesi. Ma, per nascere, avrebbe bisogno di
una legge elettorale proporzionale. Proprio ciò che i due maggiori eredi del
voto democristiano, Pd e FdI, per ora rifiutano.
Maria Romana De Gasperi:
«Io e mio padre Alcide». Il podcast «Le figlie della Repubblica».
Tommaso Pellizzari su Il
Corriere della Sera il 17 Gennaio 2022.
Il primo episodio della serie
della Fondazione De Gasperi realizzata col «Corriere della Sera» che compone un
ritratto fra pubblico e privato di cinque uomini che in modi diversi hanno fatto
la storia d'Italia
C’è Maria Romana De Gasperi ,
figlia di Alcide, che si faceva raccontare dai suoi genitori quello che avevano
immaginato di comprare nelle loro passeggiate domenicali in una Roma che stava
rinascendo dal dopoguerra. Non si potevano permettere nulla, ma era bello
sognare tutti insieme.
C’è Serena Andreotti, figlia
di Giulio, che vide piangere suo padre il giorno dell’uccisione di Aldo Moro.
Una cosa del genere era successa solo una volta, tanti anni prima, quando era
morta la madre del sette volte presidente del Consiglio.
C’è Flavia Piccoli, figlia di
Flaminio, che a 10 anni accompagnava (mano nella mano) il padre vittima di un
pesantissimo esaurimento nervoso, quando dopo cena il politico democristiano
andava a camminare per le vie di una Trento deserta e freddissima.
C’è Chiara Ingrao, figlia di
Pietro, che negli ultimi anni di vita del primo presidente comunista della
Camera andava a casa sua a leggergli ad alta voce le poesie del suo amato
Giacomo Leopardi, perché lui non ci vedeva abbastanza per continuare a farlo da
solo.
C’è Stefania Craxi, che pur di
stare col padre Bettino, lo seguiva negli appuntamenti delle campagne elettorali
del Partito socialista di cui era segretario, affidando così alla politica il
compito di farle vivere le esperienze di vita che le ragazze della sua età
sperimentavano in modi più classici.
E c’è un podcast, diviso in 5
puntate di circa mezz’ora ciascuna, che racconta tutto questo: si chiama «Le
figlie della Repubblica» e il primo episodio (con Maria Romana De Gasperi) è
ascoltabile da oggi sul sito del Corriere della Sera e su tutte le principali
piattaforme (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Spreaker eccetera).
«Le figlie della Repubblica» è
un podcast della Fondazione De Gasperi, l’istituto che custodisce e promuove gli
insegnamenti ideali, morali e politici di Alcide De Gasperi, realizzato
nell’ambito del programma di eventi con cui nel 2022 celebrerà i 40 anni dalla
sua nascita. La serie, prodotta in collaborazione con il Corriere e con il
sostegno della Fondazione Cariplo, nasce da un’idea di Martina Bacigalupi ed è
stato scritto e diretto da Emmanuel Exitu con la supervisione dello
storico Antonio Bonatesta e realizzato da Ways - The storytelling agency, con la
voce narrante di Alessandro Banfi.
Le puntate usciranno con
cadenza settimanale. Questo il calendario:
18 gennaio: Maria Romana De
Gasperi (ascoltala qui)
25 gennaio: Serena Andreotti
2 febbraio: Flavia Piccoli
9 febbraio: Chiara Ingrao
16 febbraio: Stefania Craxi
Alla serie «Le figlie della
Repubblica» che compone un ritratto fra pubblico e privato di cinque uomini che
in modi diversi hanno fatto la storia della Prima Repubblica hanno collaborato
alcuni Amici Giovani della Fondazione De Gasperi tra cui Corrado Cassiani,
Martina Cirelli, Elisabetta Fiaschi, Federico Mossuto, Ludovica Pietrantonio e
Michela Zarbaglia.
Riposa in pace.
Massimo Gramellini
su Il Corriere della Sera il 31 Marzo 2022.
Uno degli ultimi ricordi che
ho di mio padre — ripeteva spesso la signora Maria Romana De Gasperi, scomparsa
ieri a 99 anni — è lui stanco e malato, la schiena affondata nella poltrona del
salotto e i piedi appoggiati su una cassetta della frutta, mentre aspetta la
telefonata che gli dirà se il parlamento francese ha approvato la formazione
dell’esercito comune europeo.
Era stata una scelta sofferta,
la sua, per certi versi ancora più difficile dell’adesione alla Nato. «A chi
risponderà, questo esercito?», domandava agli interlocutori, che lasciavano la
risposta volutamente in sospeso, perché l’unica possibile era anche la più
difficile: a un governo europeo.
Ma con la capacità di visione
degli statisti, Alcide De Gasperi intuiva che solo una difesa comune avrebbe
creato i presupposti per completare l’unione politica. Perciò si era deciso a
correre quell’azzardo. E anche per un’altra ragione, che in questi giorni suona
quanto mai attuale.
Un esercito europeo avrebbe
progressivamente affrancato il Vecchio Continente dalla protezione americana.
Gli sembrava incoerente che proprio chi lo accusava di avere sottomesso l’Italia
agli Stati Uniti fosse poi in prima fila nell’opporsi all’esercito europeo, in
nome di un pacifismo ingenuo o peloso. Il telefono di casa De Gasperi non
squillava e così fu lui — raccontava la figlia — a comporre un numero
all’apparecchio. Appena seppe che la Francia aveva detto di no, si lasciò andare
sulla poltrona e chiuse gli occhi. Chissà quando apriremo i nostri.
Il podcast con le parole di
Maria Romana De Gasperi
È morta Maria Romana De
Gasperi: «Quella volta che capii chi era mio papà».
Aldo Cazzullo su Il Corriere
della Sera il 30 Marzo 2022.
La figura di Alcide De Gasperi
nelle parole della figlia Maria Romana morta questa notte a 99 anni. La guerra,
la politica, la famiglia.
Maria Romana De Gasperi
Il padre la teneva d’occhio
dal ritratto sulla parete dello studio — «mi piace perché restituisce bene i
suoi occhi azzurri» — e dalla foto sul tavolino. In un’altra foto Alcide De
Gasperi teneva in braccio la sua bambina, la sua primogenita Maria Romana, morta
oggi a quasi cent’anni. Adorava il padre, ma non ne parlava come di un santo. Ti
restituiva l’idea di un uomo vivo e pieno di passioni. Il suo primo ricordo di
lui fu quando uscì dalle carceri fasciste. De Gasperi fu preso dalla polizia sul
treno che da Roma lo portava a Firenze. «Lo portarono a Palazzo di Giustizia in
catene, con altri detenuti. Si sentiva sicuro che l’avrebbero mandato libero: in
fondo era un deputato che criticava il governo. Lo condannarono a quattro anni
di carcere. A mia madre raccontò che non era riuscito neppure a piangere;
mormorò solo il nome di Dio. Lo riportarono incatenato a Regina Coeli. Da lì mi
scrisse: “Mia cara pupi, sii brava e prega tanto la Madonna per il tuo povero
papà”».
Un giorno la guardia lo scoprì
dallo spioncino mentre scriveva sulla parete della cella con uno spillo,
sfuggito alle persecuzioni corporali. Era una frase del Vangelo: “Beati qui
lugent quoniam ipsi consolabuntur”». Beati coloro che piangono, perché saranno
consolati. «La guardia chiamò il suo capo, che costrinse mio padre a cancellare
la frase con il manico del cucchiaio di legno. Papà commentò che era stato
gentile, perché non l’aveva punito. Dalla finestrella intravedeva l’orto
botanico. Mi scrisse: “C’è dentro un usignolo e la sera quando canta penso a te;
e la notte quando, bassa all’orizzonte, vedo una stella penso a te e a Lucia”,
la mia sorellina, che era nata da poco».
Poi arrivò il Natale del 1927.
«E papà decise di farmi un regalo. Non aveva soldi e in ogni caso non avrebbe
potuto comprarmi nulla. Così ritagliò le fotografie di una rivista che gli
avevano mandato in carcere, il National Geographic Magazine. Erano immagini
della Palestina. Pastori con le pecore. I prati fioriti della Galilea, con il
mare di Tiberiade sullo sfondo. Siccome le didascalie erano in inglese, lui le
traduceva. E aggiungeva qualche riga per raccontarmi la storia di Gesù. E mamma
mi leggeva la storia ad alta voce».
Quel carcerato divenne
presidente del Consiglio, per otto anni consecutivi, come non è più accaduto a
nessuno. «L’importante è non perdere mai la speranza, neanche nell’ora più buia.
Papà dal carcere ci scriveva: “Miei cari, dormite in pace; io sono presente”. In
cella si ammalò. Lo portarono in ospedale, ma sempre con la porta aperta, e la
guardia di fuori. Fu liberato dopo 14 mesi. Il primo vero ricordo che ho di lui
è quando tornò a casa. Non sapevo che fosse stato in prigione, mi avevano detto
che era in una città lontana, per lavoro. Lucia rifiutò di abbracciarlo: “Tu non
sei il mio papà, il mio papà è quello lì” diceva indicando la sua fotografia».
Con le figlie era dolcissimo. «Se combinavamo qualcosa, mamma ci avvisava: “Lo
dico a papà!”. Ma noi eravamo tranquille perché sapevamo che papà non ci avrebbe
fatto niente. Io ero innamoratissima di lui. A tavola mia madre sedeva alla sua
destra, io alla sua sinistra. Appena lui diceva qualcosa, io aggiungevo: “Ha
ragione papà!”».
La sorella di Maria Romana,
Lucia, si fece suora. “Poi nacque Cecilia. Papà voleva un maschio per chiamarlo
Paolo: era molto devoto a san Paolo. Ma arrivò un’altra bambina; e fu chiamata
Paola». Nei giorni di festa comprava sette paste, una per ogni familiare, perché
in casa abitava sua sorella, zia Marcella. A Natale però oltre al presepe
facevano l’albero: un retaggio austroungarico. «Papà trovò un posto nella
biblioteca del Vaticano. All’inizio fu dura, molti lo guardavano con sospetto.
Lavorava il mattino, lo ricordo all’una attraversare una piazza San Pietro
enorme e vuota, senza sedie, senza transenne… Il pomeriggio per arrotondare
faceva traduzioni dal tedesco, che parlava come l’italiano: lui dettava ad alta
voce, mamma batteva a macchina. Ogni tanto mi assegnava una piccola missione.
Nei giorni delle manifestazioni del regime, si temevano arresti e perquisizioni.
Allora papà mi affidava un pacco con il suo diario e le sue carte, da portare
alla vicina del piano di sotto, che era una brava persona. Un giorno spuntò un
ritaglio con il suo nome. Solo allora capii chi era. E lui mi raccontò la sua
vita politica. Ero ancora bambina, ma stavo già dalla sua parte».
Quando entrarono i tedeschi a
Roma si dovette nascondere. «Era chiuso in Laterano, con lui c’era Pietro Nenni.
Arrivarono i nazisti, i preti li fecero scendere nei sotterranei. Nenni disse a
papà: “Tu la chiami Provvidenza, io lo chiamo Fato; ma mi sa che stavolta è
finita”. Invece si salvarono, però dovettero cambiare nascondiglio. Papà si
rifugiò nel palazzo di Propaganda Fide, in una stanzina sul tetto. Io andavo a
trovarlo in bicicletta, mi vestivo tutta colorata per sembrare una ragazza in
gita. Nel cestino, sotto la verdura, nascondevo i suoi articoli per i giornali
clandestini e i messaggi per i resistenti. Una volta ero in tram quando il pacco
si lacerò, un passeggero mi disse: “Forse è meglio se scende”. Dopo la guerra
volevano darmi una medaglia. Papà disse che non era il caso». E del Duce cosa
diceva? «Non ne parlava mai. Solo una volta in Liguria, davanti a un assalto di
sostenitori che picchiavano le mani sul vetro per invitarlo a fermarsi, mi
disse: “Ora comprendo Mussolini. È difficile capire se fanno così perché hai
combinato qualcosa di buono, o perché sei il capo”».
Serena Andreotti: «Io e mio
padre Giulio».
Il podcast «Le figlie della Repubblica» di Tommaso Pellizzari su Il Corriere
della Sera il 24 gennaio 2022.
Il secondo episodio della
serie della Fondazione De Gasperi realizzata col «Corriere della Sera» che
compone un ritratto fra pubblico e privato di cinque uomini che in modi diversi
hanno fatto la storia d'Italia.
È Serena Andreotti, quarta
figlia di Giulio, la protagonista della seconda puntata del podcast «Le figlie
della Repubblica». La più piccola dei figli nati dal matrimonio del 7 volte
presidente del Consiglio con Livia Danese, racconta il lato privato di uno degli
uomini politici più discussi del dopoguerra, scomparso il 6 maggio 2013 a 94
anni: dall’affetto per la madre rimasta vedova giovanissima alla rigorosa
educazione cattolica, dal legame con Alcide De Gasperi ai tormentati anni del
sequestro e dell’uccisione di Aldo Moro, dai processi di mafia alle battute
taglienti.
«Le figlie della Repubblica» è
un podcast della Fondazione De Gasperi, l’istituto che custodisce e promuove gli
insegnamenti ideali, morali e politici di Alcide De Gasperi, realizzato
nell’ambito del programma di eventi con cui nel 2022 celebrerà i 40 anni dalla
sua nascita. La serie, prodotta in collaborazione con il Corriere e con il
sostegno della Fondazione Cariplo, nasce da un’idea di Martina Bacigalupi ed è
stato scritto e diretto da Emmanuel Exitu con la supervisione dello
storico Antonio Bonatesta e realizzato da Ways - The storytelling agency, con la
voce narrante di Alessandro Banfi.
Flavia Piccoli: «Io e mio
padre Flaminio».
Il podcast «Le figlie della Repubblica» di Tommaso Pellizzari su Il Corriere
della Sera il 31 gennaio 2022.
Il terzo episodio della serie
della Fondazione De Gasperi realizzata col «Corriere della Sera» che compone un
ritratto fra pubblico e privato di cinque uomini che in modi diversi hanno fatto
la storia d'Italia.
È Flavia Piccoli, figlia di
Flaminio che fu due volte segretario della Democrazia cristiana, la protagonista
della seconda puntata del podcast «Le figlie della Repubblica». Deputata del
Partito democratico, Flavia Piccoli racconta il lato privato di un uomo politico
con una biografia molto particolare: a partire dal nome, impostogli dal padre
Bennone per continuare la tradizione di famiglia che rendesse impossibile la
traduzione in tedesco. Piccoli era infatti nato a Kirchbichl, in Austria, nel
1915, dove la sua famiglia originaria di Borgo Valsugana era stata evacuata dopo
la dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria-Ungheria. Nella Seconda
guerra mondiale, invece, Piccoli fu arruolato come alpino e riuscì all’ultimo a
salvarsi dall’internamento in un campo di concentramento. Nel dopoguerra inizia
la sua carriera politica, che parte dall’Azione cattolica trentina per poi
passare alla Dc, non senza qualche contrasto col Vaticano. Dello scudo crociato
fu segretario nel 1969 e poi tra il 1980 e l’82, mentre tra il 1970 e il 1972
ricoprì l’incarico di ministro delle Partecipazioni statali. Deputato dal 1958
al 1992 e senatore nei due anni successivi, Piccoli è morto l’11 aprile del 2000
a Roma.
Stefania Craxi: «Io e mio padre Bettino».
Tommaso Pellizzari su Il
Corriere della Sera il 14 febbraio 2022.
È Stefania Craxi, figlia di
Bettino, la protagonista della quinta e ultima puntata del podcast «Le figlie
della Repubblica». Nei giorni in cui ricorre il trentennale di Tangentopoli, che
segnò l'inizio della fine dell’allora segretario del Partito socialista ed ex
presidente del Consiglio, la sua primogenita difende la figura del padre, morto
nel gennaio del 2000 in Tunisia, nella casa di Hammamet. È lì che Craxi era
fuggito (la figlia da allora parla e parlava di «esilio») nel 1994 dopo le
condanne per corruzione nel processo Eni-Sai e per finanziamento illecito per le
tangenti della Metropolitana milanese. Ma il racconto di Stefania Craxi va molto
oltre, ricordando il suo rapporto simbiotico con tutto ciò che era politica e
che inevitabilmente finì per sottrarre suo padre alla famiglia. Cosa che spinse
la giovane Stefania a vivere una gioventù molto diversa da quella dei suoi
coetanei e coetanee: una gioventù fatta di politica pur di passare qualche ora
in più col padre.
«Le figlie della Repubblica» è
un podcast della Fondazione De Gasperi, l’istituto che custodisce e promuove gli
insegnamenti ideali, morali e politici di Alcide De Gasperi, realizzato
nell’ambito del programma di eventi con cui nel 2022 celebrerà i 40 anni dalla
sua nascita. La serie, prodotta in collaborazione con il Corriere e con il
sostegno della Fondazione Cariplo, nasce da un’idea di Martina Bacigalupi ed è
stato scritta e diretta da Emmanuel Exitu con la supervisione dello
storico Antonio Bonatesta e realizzata da Ways - The storytelling agency, con la
voce narrante di Alessandro Banfi.
Clemente Mastella.
Giuliano Foschini per “la Repubblica” il 13 Aprile 2022.
Tra le doti di Clemente
Mastella, sindaco di Benevento, ex ministro della Giustizia, bandiera della
prima Repubblica, ce n'è una, taumaturgica, fin qui rimasta nascosta: la
cancellazione delle multe.
Eppure Mastella pare esserne
grande esperto se è vero - come racconteranno stasera "Le Iene", su Italia 1, in
un'inchiesta firmata da Marco Occhipinti e Filippo Roma- che è riuscito a farsi
annullare quasi tutte le 150 che ha preso in meno di cinque anni. Tutte
contestate all'auto di rappresentanza del Comune di Benevento che lo porta in
giro ogni giorno. Per impegni istituzionali ma anche nei continui su e giù con
Roma, frequentissimi per esempio durante le elezioni per il presidente della
Repubblica quando Mastella era una presenza fissa nei talk show televisivi.
A raccontare la storia alle
Iene, carte alla mano, è un ex dipendente comunale, Gabriele Corona, esponente
di Altra Benevento, associazione beneventana mai tenera con l'amministrazione
Mastella. «In questi anni - spiega Corona, indicando una pila di documenti - la
macchina del sindaco ha preso multe per eccesso di velocità, circolazione in
zona Ztl, corsie preferenziali per gli autobus ».
Ma Mastella, che è un
fuoriclasse, è riuscito a impugnarle e vincere i ricorsi. Come? A ogni
contravvenzione ricevuta Mastella spiegava che si «recava per motivi
istituzionali» in un tal luogo e che l'autista che lo accompagnava, «su
indicazione dell'operatore di Polizia a bordo, ha doverosamente superato il
limite di velocità imposto a salvaguardia della sicurezza personale del
sottoscritto: difatti il notevole rallentamento imposto nella circostanza dal
traffico sarebbe stato fonte di potenziale esposizione a pericolo».
Mastella non è sotto scorta.
Ma sottoposto a regime di sorveglianza: un poliziotto lo accompagna in tutti gli
spostamenti. L'ex ministro sostiene che sia stato proprio l'agente, nei 150
casi, a spingere l'autista (visto che Mastella non guida) alle infrazioni per
«motivi di sicurezza». Il punto è che alcune multe sono davvero strane. Sulla
Napoli-Roma, dove c'è un limite di 130 chilometri, Mastella sfrecciava a 171,
alle 13. Perché? Che pericolo c'era? E ancora: chi attentava alla sicurezza di
Mastella alle 3:44 di notte sulla Benevento-Caianello quando, tra l'altro su una
strada pericolosissima, superava il limite di velocità? (a proposito: il
Mastella sindaco ha criticato duramente i colleghi che mettevano autovelox su
quel tratto).
C'è poi il caso Roma: nel 2017
all'auto dell'ex ministro sono state notificate 12 multe per ingressi non
autorizzati nella Ztl: conto, 2988 euro. Anche in questo caso, ricorso. Però
respinto. Ma Mastella comunque non paga. Ripresenta il ricorso, «e - racconta
sempre Corona carte alla mano - questa volta la Prefettura non lo valuta. Passa
il tempo e decorrono i termini». Risultato: Mastella non paga e il comune di
Roma gli deve 950 euro di spese legali.
«State sprecando tempo» dice
però Mastella a Repubblica . «Io non ho la patente. Non guido. Che c'entro? ».
Le multe sono alla sua macchina di servizio. È lei che firma i ricorsi,
sostenendo che il codice della strada è stato violato per ragioni di sicurezza.
«C'è un poliziotto che è sempre con me. Mica posso dire bugie! ». Ma la notte,
chi la mette in pericolo sulla Benevento-Caianello? E perché tutti quegli
ingressi nella Ztl a Roma? «E che ne so? Io dormo in macchina, parlo al
telefono, mica sto attento a quello che succede. E poi: ho fatto ricorso. Ho
vinto. Che volete ancora?».
Le Iene, Clemente Mastella?
150 multe annullate in 5 anni, come ci è riuscito: uno "strano caso" a
Benevento.
Libero Quotidiano il 13 aprile 2022.
Clemente Mastella al centro di
un'inchiesta de Le Iene su Italia 1. Nell'inchiesta, che andrà in onda questa
sera e di cui Repubblica ha già dato qualche anticipazione, si rivela che l'ex
ministro della Giustizia e oggi sindaco di Benevento sarebbe riuscito a
farsi annullare quasi tutte le 150 multe prese negli ultimi cinque anni. Tutte
contestate all'auto di rappresentanza del comune di Benevento, con cui di solito
va in giro sia per impegni istituzionali sia per gli spostamenti da e per Roma,
una città molto frequentata per esempio durante le elezioni per il Quirinale.
A sollevare il caso è stato
l'ex dipendente comunale Gabriele Corona, esponente dell'associazione "Altra
Benevento": "In questi anni la macchina del sindaco ha preso multe per eccesso
di velocità, circolazione in zona Ztl, corsie preferenziali per gli autobus", ha
spiegato a Le Iene. Sottolineando, poi, come il primo cittadino sia riuscito a
impugnare tutto e a vincere i ricorsi. Alle contravvenzioni Mastella avrebbe
risposto spiegando che si "recava per motivi istituzionali" in un tal luogo e
che l'autista che lo accompagnava, "su indicazione dell'operatore di Polizia a
bordo, ha doverosamente superato il limite di velocità imposto a salvaguardia
della sicurezza personale del sottoscritto".
L'auto, insomma, avrebbe
spesso superato i limiti di velocità perché "il notevole rallentamento imposto
nella circostanza dal traffico sarebbe stato fonte di potenziale esposizione a
pericolo". In effetti Mastella è sottoposto a regime di sorveglianza, il che
significa che un poliziotto lo accompagna sempre negli spostamenti. Alcune
multe, comunque, destano qualche sospetto: sulla Napoli-Roma, dove c'è un limite
di 130 chilometri, per esempio, Mastella sarebbe andato a 171, alle 13. Caso
simile alle 3:44 di notte sulla Benevento-Caianello. Qual era la situazione di
pericolo in quei casi? Sentito da Repubblica, Mastella ha replicato: "Io dormo
in macchina, parlo al telefono, mica sto attento a quello che succede. E poi: ho
fatto ricorso. Ho vinto. Che volete ancora?".
Da Un Giorno da Pecora il 14
febbraio 2022.
Clemente Mastella e sua moglie
Sandra Lonardo, sposati da quasi 50 anni, oggi hanno 'festeggiato' il San
Valentino intervenendo al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, dove
hanno raccontato molti aspetti della loro lunga e felice relazione. “Siamo
sposati dal 1975 e prima siamo stati fidanzati per 6 anni”, hanno esordito i
due. Qual è il segreto per mantenere un rapporto così lungo? “Ci vuole molto
affetto, molta stima e comprensione”.
Cosa ha regalato Clemente a
sua moglie per questo S.Valentino? “Un grande mazzo di rose rosse, e stasera
faremo una cena da soli”. Con un bigliettino? “Quest'anno niente bigliettino –
ha detto la senatrice Lonardo a Un Giorno da Pecora Radio1 - ma gli altri anni
mi ha scritto cose bellissime, come 'ti risposerei' o 'starei ancora 100 anni
con te'. Più passano gli anni e più è bello stare insieme alla nostra età”.
Avete dei nomignoli affettuosi? “Mai avuti, ci chiamiamo da sempre per nome”.
Qual è il difetto peggiore
dell'altro? “Sandra magari su una cosa che dico mi risponde 'no vabbé...' ed io
mi arrabbio”. E per lei? “Clemente è molto distratto, non si interessa per nulla
delle cose della casa, demanda tutto a me”. Si può dire che siete un po' i
'Ferragnez' della politica? “Siamo un po' come i Maneskin e i Cugini di
Campagna: ecco, noi siamo i Cugini di Campagna...” Potreste essere i
'Mastellaz'? “E perché no...”
Chi dei due è più geloso? “Lo
siamo stati entrambi, quando Clemente faceva il deputato a Roma, e non c'era
ancora il cellulare, Clemente mi chiamava 25 volte al giorno...” Dite la verità:
in passato c'è stato qualche tradimento? “Non mi sono mai soffermata, qualche
volta ci sono andato vicino, ho preferito non sapere, è preferibile non sapere”,
ha detto a Un Giorno da Pecora la senatrice.
Iva Zanicchi qualche giorno fa
ha detto che far l'amore fa bene anche superati gli 80 anni. Siete d'accordo?
“L'amore fa bene sempre, a qualsiasi età. Cambiano i tempi ma è sempre bello”.
Infine, prima del termine della lunga intervista, a Rai Radio1 i 'Mastellaz'
hanno cantato il brano della loro vita insieme, la celebre 'il Cielo in una
Stanza' di Gino Paoli.
Paolo Cirino Pomicino.
Illusioni perdute. L’abbandono della politica è il grande inganno che ha
rovinato l’Italia, scrive Cirino Pomicino. Beppe Facchetti su L'Inkiesta il
12 Maggio 2022.
Nel suo ultimo fumantino libro
pubblicato da Lindau, l’antico democristiano passa in rassegna i mali del Paese,
attribuisce colpe eccessive alla finanza, rivaluta Andreotti e trova nel mito
del maggioritario uno dei problemi più grandi dell’instabilità di oggi.
Stimolante come i precedenti,
l’ultimo libro di Paolo Cirino Pomicino (“Il grande inganno”, edizione Lindau) è
però questa volta meno provocatorio, più serioso, in qualche passaggio
addirittura un po’ troppo in stile testamento morale. Ma forse è solo una
impressione, perché nella sua nuova vita di scrittore e polemista, ci aveva
abituato ai fuochi di artificio, ai ritratti fulminanti, alle ricostruzioni
ardite ma suggestive, e forse ci aspettavamo, colpa nostra, più divertimento
intellettuale, come in certi suoi articoli, fin da quelli firmati Geronimo sui
giornali di Vittorio Feltri.
Certo, seduto davanti alla
tastiera, Pomicino ha rivelato una forte attitudine alla scrittura, pari alla
sua indomabile voglia di esserci, di combattere, di dire la sua, in questa
seconda o terza Repubblica che non gli appartiene, che ha spazzato via quasi
tutti i protagonisti della sua epoca. Lui no, anzi ha risalito la china di
un’ostilità, talora un pregiudizio, che un tempo era forte, sia sui media che
nell’opinione pubblica (ma non tra gli elettori campani, che lo voterebbero in
massa ancora adesso se ci fossero le preferenze), ed è invece sempre più solida
la reputazione riconquistata da osservatore capace di opinioni non banali o
strampalate come quelle prevalenti nei salotti televisivi.
In questo nuovo libro, su
molte cose si può non essere d’accordo, e il bello è che persino il prefatore,
Ferruccio De Bortoli, non risparmia critiche e prese di distanza, quasi fosse un
recensore e non una firma associata a quella dell’autore.
Siamo d’accordo con De Bortoli
soprattutto sull’eccesso di amplificazione dell’importanza di ciò che ha a che
fare con la finanza.
In Pomicino è quasi
un’ossessione, ma è davvero un eccesso, che si scontra con la realtà. Certo che
la finanza ha un ruolo ben poco al servizio all’industria e allo sviluppo, come
dovrebbe essere. È un male non solo italiano innegabile, ma che la finanza sia
una piovra che tutto controlla – politica e giornali – è una forzatura. Non
vogliamo essere ingenui e vediamo naturalmente tanti difetti nella
finanziarizzazione dell’economia, ma di quale finanza parliamo?
Ai tempi di Pomicino la piovra
poteva essere la Mediobanca di Enrico Cuccia, che aveva un’importanza superiore
alla sua forza reale, entrando nel vivo delle realtà industriali e
condizionandole con quote di minoranza e molta suasion, magari poco moral. Ma
oggi chi rappresenta la finanza onnivora? Se ci fosse stata finanza forte in
Italia avremmo avuto buone privatizzazioni, non una farsa furbetta come quella
della prima Telecom e molte delle successive!
La recente vicenda Generali ha
messo in evidenza un conflitto interno, peraltro risolto alla fine con una
logica di mercato, perché ha prevalso la convenienza. Carlo De Benedetti fa in
tarda età il pacifista che critica la Nato e i poteri forti mondiali. Le banche
sono molto strettamente condizionate da Francoforte e vengono da una stagione
che è stata un bagno di sangue. E i protagonisti delle stragi venete e toscane
non erano dei finanzieri, ma imprenditori dell’azzardo e della vanità. Le
anomalie del potere bancario sono state semmai facilitate da leggi della Prima
Repubblica, che trasferirono il controllo a Fondazioni autoreferenziali.
Quanto al rapporto con i
giornali, si sopravvaluta il ruolo di quel che rimane dell’editoria e del
giornalismo. Il sorprendente blocco unitario tra Stampa e Repubblica non ha
risposto a logiche di sopraffazione finanziaria e oggi, semmai, c’è
un’omologazione cui fanno da contrappeso solo le direzioni di Giannini e ancor
più di Molinari. Lontani i tempi in cui Scalfari dava la linea a tutti (il
narcisismo di Scalfari, non la finanza). Questi cambiamenti davvero notevoli
sembrano più ripiegamenti difensivi, istinto di sopravvivenza delle redazioni,
alle prese con l’inarrestabile calo delle vendite in edicola, anche quando
questo ha ispirato campagne un po’ disperate che hanno spianato la strada alla
miseranda ascesa dei 5 Stelle, comunque non a Soros. In fondo, l’unico
imprenditore che se la cava, Urbano Cairo, è una figura del tutto nuova nel
panorama editoriale, il primo tentativo di editore puro tanto auspicato per la
complessiva libertà di stampa. Le bizzarrie de la7 e spesso anche del Corriere
non sembrano i tentacoli di una finanza proterva.
La finanza cattiva è dunque la
protagonista in filigrana del libro, ma è anche il legittimo pensiero personale
dell’autore, la cui mano si vede in tante pagine in cui ha voglia e forza di
lasciare le impronte digitali del suo essere controcorrente, e già questo
potrebbe bastare per meritare la lettura.
C’è naturalmente la difesa di
Giulio Andreotti, e non poteva non esserci. D’altra parte, se uno che è stato
professionalmente sconfitto nelle “sue” aule giudiziarie come Gian Carlo Caselli
viene periodicamente ospitato dal Corriere della Sera per raccontare una
controverità sempre moralistica che, nonostante le sentenze, sancisce ex
cathedra la colpevolezza dell’odiato Giulio, avrà pur diritto un amico di sempre
a far valere la forza dei fatti e affermare che la mafia si è vendicata del
legislatore che più l’ha colpita.
Meno scontati altri giudizi.
Vanno letti con attenzione i numerosi riferimenti a Mario Draghi. Da un lato,
Pomicino è un po’ il Pippo Baudo che rivendica “l’ho scoperto io”, dall’altro è
sottile e capzioso nel commentare alcune pagine non allineabili con il coro
laudativo attuale, ma l’autore sta sempre molto ben attento: butta lì qualche
riflessione che sembra critica e conclude sempre con un elogio.
Più gustose – tra ironia e
finta di non capire – le citazioni di Gianni De Gennaro, l’uomo di tutti i ruoli
delicati dell’intelligence e dell’ordine pubblico. È uno slalom strepitoso tra
dubbi e fatti accaduti, mai concluso con una censura, che viene se mai lasciata
al lettore. Chiave di tutto una frase che attribuisce a Giuliano Amato, ministro
dell’Interno di Prodi, impossibilitato a rispondere su quanti siano stati i
mafiosi scarcerati per programmi di protezione tra il 1993 il 2005. «Caro Paolo,
sulle tue domande la mia amministrazione è reticente», rispose l’ineffabile, e
il reticente era appunto De Gennaro.
Come dice lo stesso titolo del
libro, l’opera di Pomicino è fondamentalmente un ammonimento a non credere al
mainstream, oggi in verità sempre meno vincente, sui meriti e le glorie solo
immaginarie della Seconda repubblica.
Il grande inganno allora
riguarda un po’ tutto: dal disastro della politica estera, allo sfottò per le
porte lasciate aperte ai francesi predatori, alle doppie verità a 5 Stelle della
vicenda Benetton Atlantia. E soprattutto – qui siamo totalmente d’accordo –
sull’inganno della soluzione dei problemi tramite legge elettorale. Il grande
inganno del maggioritario che doveva ridurre il numero dei partiti e lo ha
moltiplicato, incentivando il “tarlo democratico” del trasformismo. Fino al
paradosso che col proporzionale precedente c’era comunque una corrispondenza tra
Paese reale e Parlamento, mentre il salvifico maggioritario ha prodotto governi
sostanzialmente di minoranza, non a caso ripetutamente affidati o non politici.
Tutte ricadute di un
fallimento generale della classe politica, ben lontani dalle favolose promesse
di una seconda Repubblica redentrice, nutrita di personalismi già di per sé
discutibili, ma inaccettabili quando a interpretarli sono apparsi sulla scena
leader dell’invettiva da talk show o – quando andava bene – “bravi ragazzi di
paese” come Spadafora e Di Maio.
Ventisette anni di illusioni e
promesse sbagliate, culminate con il successo pentastellato, una “lilliput
grillina, autoritaria e farsesca”.
E una grande colpa: non aver
approfittato – ora che sta svanendo – della grande occasione dei tassi
favorevoli, dell’inflazione inesistente, delle materie prime abbordabili.
Quanto appunto al terreno
economico, Pomicino – medico mancato, anche se suo malgrado gran frequentatore
di camere operatorie (auguri sempre!) – dimostra la lucidità dei vecchi tempi.
Rivendica – contro la tendenza
acritica dei commentatori degli anni ’80 come anni del debito – che «nel
1992-1993 consegnammo alla seconda Repubblica un paese ricco e benestante, privo
di tensioni sociali, disinflazionato e con una disoccupazione intorno al 5%».
Sono dati di fatto, così come lo sono quelli che hanno successivamente portato
il debito sopra il 150% attuale.
Debito che Pomicino considera
sempre il grande problema (oggi un po’ accantonato dalla distinzione tra buono e
cattivo, ma la guerra lo sta trasformando tutto in cattivo) e ripropone una sua
ricetta che presuppone un “accordo” tra Stato e ricchezza nazionale che
metterebbe a disposizione 120 miliardi di euro non a fronte di un condono ma di
un nuovo accordo conveniente per il contribuente.
Insomma, ripetiamo: un libro
da leggere, pieno di suggestioni, con qualche scivolata (l’eccessivo e un po’
troppo scolastico omaggio all’ambientalismo stride un po’ con il personaggio),
ma con un grande denominatore comune: la passione per la politica.
Su questo, Pomicino non
transige, e ha profondamente ragione, perché molti dei guai italiani
contemporanei nascono dall’aver schiacciato la politica in una dimensione
caricaturale, mentre è la più seria delle pratiche intellettuali. Come tale,
richiede personale adeguato ed è un’anomalia ricorrere costantemente a non
politici per poter meglio combattere gli antipolitici, che hanno procurato tanti
guai. Solo l’emergenza di grandi temi epocali – la pandemia, l’aggressione russa
in Ukraina – hanno forse rimesso ordine alla gerarchia delle cose davvero
importanti, purché non sia già troppo tardi.
Che poi Pomicino faccia
coincidere la sua nostalgia di politica con l’amore quasi esclusivo, monogamico,
con la Democrazia Cristiana, possiamo rilevarlo ma perdonarglielo. Anche la Dc,
in fondo, sta attraversando una stagione postuma di rivalutazione.
Pietro De Sarlo
per basilicata24.it il 9 maggio 2022.
Fresco di stampa il libro di
Cirino Pomicino “Il grande inganno”. Per chi non ricordasse il suo contributo
alla Prima Repubblica, basta sapere che fu ministro con De Mita e Andreotti sia
alla funzione pubblica sia al bilancio e programmazione economica. Come dice lui
stesso fu l’ultimo politico a essere ministro dell’economia.
Non ha mai goduto di buona
stampa. La sua parlata stimola il vezzo, venato di razzismo anti meridionale,
che si sostanzia in sottolineature denigratorie come “avvocato di Volturara
Appula”, riferito a Giuseppe Conte, oppure “commercialista di Bari”, per Rino
Formica, o il più garbato ‘intellettuale della Magna Grecia’ con cui Gianni
Agnelli chiamò Ciriaco De Mita.
Persino Ferruccio De Bortoli,
autore della prefazione, con riflesso pavloviano mette in guardia dalla “arguzia
tutta partenopea” dell’autore. Già, a Milano e dintorni l’arguzia pare sia
finita e da tempo.
Se però siete
intellettualmente liberi e scevri da pregiudizi la lettura è interessante. La
tesi del libro è che la Seconda Repubblica è stata un disastro e molto peggio
della Prima che vide l’autore tra i protagonisti.
Molto “cicero pro domo sua”,
certo, ma Pomicino le cose le sa. Qualcuna la dice, qualcun’altra gli scappa. Si
tratta, pur nel morbido tono democristiano, di un pesante attacco al PD e al
sistema della finanza e della informazione che protegge e di cui è strumento.
Ecco il libro in pillole.
L’informazione in Italia
Molto spazio dedica al tema
della informazione, tema all’attualità visto che è appena uscita l’ultima
classifica mondiale sulla libertà di informazione di Reporters sans Frontiere.
L’Italia è precipitata in un solo anno dal 41 esimo al 58 esimo posto, tra la
Macedonia del Nord e il Niger.
La genesi di questa
situazione, con accuse pesanti, l’autore la fa risalire agli inizi degli anni
novanta, quando il ‘salotto buono’ del capitalismo italiano, scelse di costruire
la Seconda Repubblica dando credibilità e sostegno, con i propri media, a quelli
che Cirino chiama i ‘vinti della storia’, ossia a quelli del vecchio PC, ora PD,
sconfitti ideologicamente dalla perestroika e dalla caduta del muro di Berlino.
Il salotto buono era
costituito da Carlo De Benedetti, Gianni Agnelli, Marco Tronchetti Provera,
Carlo Pesenti, Enrico Cuccia, Cesare Romiti, Eugenio Scalfari. Gente che deve
molto al pubblico potere e in specie al PD “che si trasformò nel braccio
operativo della destra neoliberista europea”.
Ma attenzione, l’intreccio tra
capitale, finanza e informazione genera: “Un’arma letale per le democrazie
liberali… Una potenza di fuoco difficilmente sostenibile dalle istituzioni
democratiche.” Anche perché operano: “utilizzando nel contempo le insinuazioni
personali e la gogna contro gli avversari, manipolando pesantemente la verità”.
In effetti il metodo si
ripropone tutti i giorni su Repubblica e dintorni, e solo una narrazione
farlocca può far ritenere che il PD sia stato, e sia, un partito di sinistra. A
furia di ‘spiegoni’ e ‘zorate’ qualcuno ancora ci casca.
I giudizi su Ciampi, Draghi,
Letta, Prodi …
C’è altro però nel libro. A
partire da Carlo Azeglio Ciampi che fece “la peggiore legge finanziaria” e “a
elezioni già avvenute e a capo di un governo dimissionario da due mesi” assegnò
“all’amico Carlo De Benedetti” la gara per il secondo gestore di telefonia per
700 miliardi delle vecchie lire e a rate.
Affare girato a Mannesmann per
14.000 miliardi di lire dopo poco tempo. Poi Romano Prodi e Arturo Parisi,
“dovrebbero spiegare dopo trenta anni” perché “impoverirono un grande Paese come
l’Italia” certamente “a loro insaputa”.
Su Letta c’è poco, giusto per
chiedere, visti passati incarichi tra cui quello di autorevole membro della
Trilateral Commission, fondata da Rockefeller nel 1973, se sia “completamente
libero”. Identica domanda c’è su Mario Draghi, con lodi di circostanza, insieme
ad alcune vicende imbarazzanti come il giretto a Goldman Sachs, l’autorizzazione
dell’acquisto di Antonveneta e le norme europee sul sistema bancario.
Lo stato della democrazia
Da buon DC fa quindi un
invito, che pare ipocritamente strumentale, a Draghi a “trasformarsi da
rappresentante delle élite finanziarie internazionali a rappresentante delle
élite politiche”, come? Banalmente “candidandosi”. Perché? ” Il battesimo
elettorali è essenziale per la legittimità politica in un paese democratico”. E
come dargli torto.
Intanto ci ricorda che il
parlamento è svuotato da ogni funzione tanto che l’ultima finanziaria di Draghi
è stata approvata senza il parere della apposita commissione e senza che il
Parlamento abbia avuto il tempo di leggerla. E Mattarella? Nella circostanza non
pervenuto.
Insomma, la democrazia è a
rischio e occorre recuperare la centralità della politica e del parlamento a
partire proprio da quella media e piccola borghesia che è stata massacrata nella
Seconda Repubblica.
L’Italia e la Francia
Deprimente la narrazione di
come l’Italia non abbia da Sigonella, ossia da Andreotti e Craxi in poi, una
politica estera, e gli effetti si vedono. Sigonella non ci è mai stato perdonato
dagli USA. In ogni caso la ininfluenza del Paese è certificata dalla completa
assenza di una posizione autonoma dell’Italia, appiattita sugli USA più che
sull’Europa, nel conflitto attuale tra NATO e Russia sul campo Ucraino. Tanto
che Mario Draghi non fu neanche invitato alla riunione tra Biden, Macron e
Sholzt.
In compendo sulla Seconda
Repubblica sono piovute ‘Legion d’Onore’ a tanti politici italiani, specialmente
del PD. Fatto è che l’elenco delle aziende cedute ai francesi nella Seconda
Repubblica è lungo e di peso: BNL, poi Pioneer e CariParma, senza dimenticare
Edison, Telecom, l’agroalimentare, la grande distribuzione e il settore della
moda. Quando Fincantieri cercò di fare shopping oltralpe venne però
immediatamente fermata e Draghi non ha rinnovato il mandato al protagonista di
quella tentata acquisizione Giuseppe Bona.
Nell’accordo di Aquisgrana del
2019 tra Francia e Germania, a detta dell’autore, tra le cose non scritte pare
ci sia la divisione dell’Europa in due aree di influenza: la Grecia e l’Est alla
Germania, l’Italia alla Francia. “Il trattato del Quirinale” approvato sotto gli
occhi di un “compiaciuto Mattarella” pur essendo paritetico nella forma rischia
di trasformarci quindi in un protettorato francese.
L’economia, Conte e il M5S
Bocciata la Seconda Repubblica
anche in economia con tanto di numeri e percentuali. In compenso vede Conte e il
M5S come fumo negli occhi, invece di apprezzare il tentativo di porre fine alla
Seconda Repubblica, che lui stesso giudica fallimentare. Qui è la pancia che
prevale, non solo nell’autore, non riconoscendo al tentativo del M5S
quell’embrione di rivolta piccolo borghese e popolare che poteva dare una
spallata al sistema. La spalla se la sono invece lussata.
Conclusione
Peccato gli sia rimasta la
cerchiobottista sindrome DC, per cui Cirino Pomicino non arriva mai a trarre le
necessarie conseguenze dai fatti. Mattarella: fortuna che c’è. Draghi: idem.
Tutti amici.
I contenuti del libro non
costituiscono un vero e proprio scoop, più che altro si tratta di un esercizio
di memoria. Utile specialmente a chi per fatti anagrafici non ha dimestichezza
con la storia recente del Paese.
Eppure la lettura si rivela
preziosa per comprendere alcune dinamiche di oggi, come la santificazione di
Draghi e la sua nomina a primo ministro. Da non far cadere la denuncia degli
interessi in gioco della élite economica e finanziaria, più francofila che
europeista, difesi dal PD e da una stampa sempre più asservita.
Se dovessimo essere pignoli
manca ancora molta ‘materia oscura’ per apprezzare fino in fondo il degrado
della nostra democrazia descritto nel libro. Ci sarebbe molta materia di
‘scandalo politico’, ma temo che siamo talmente scorati e demoralizzati che
tutto ci scivolerà addosso come nulla.
Fabrizio Roncone per “Sette -
Corriere della Sera” il 14 febbraio 2022.
Talvolta ruvido,
permalosissimo, ancora appassionato, con una competenza strepitosa, cinico e
severo ai limiti della ferocia e pero anche lucido e – piaccia o no – credibile:
Paolo Cirino Pomicino di anni 82, un passato politico travolgente nella Prima
Repubblica si aggira sulle macerie di questa, cosi piena di modesti e modestia,
di improvvisati e impostori, tutta una classe di capi e capetti con molti
autentici scappati di casa che poi quando parla lui, cioè Cirino Pomicino, hai
la sensazione non sia nemmeno più un ex potente e discusso notabile
democristiano, ma un incrocio tra Churchill e De Gaulle.
’O ministro, com’era chiamato
a Napoli negli anni Ottanta, in un miscuglio di rispetto e tremendo timore,
durante la drammatica setti- mana che ha poi riportato Sergio Mattarella al
Quirinale, e tornato ad essere molto cercato, intervistato, spesso ospite dei
più importanti talk televisivi.
Anche Rino Formica e Clemente
Mastella sono stati parecchio ascoltati: rispetto a loro, pero, Cirino Pomicino
ci mette sempre un tasso di perfidia in più. Un giorno s’è chiesto: «Non capisco
perchè ci si accanisca così tanto nel volere diventare presidente della
Repubblica: lo sanno anche i bambini che il potere vero ce l’ha chi sta a
Palazzo Chigi».
La grammatica del potere. La
logica del potere. Spiegata a chi oggi lo insegue ovunque e senza uno straccio
di progetto. Pomicino osserva basito le mosse di chi guida certi partiti in
questa tragica stagione. Giuseppe Conte dovrebbe farsi dare ripetizioni private.
Matteo Salvini potrebbe provare: ma e possibile che Cirino Pomicino si rifiuti
di dargliene.
L’abisso di vaghezza, il buio
dell’improvvisazione, tutto agli occhi di uno come lui può apparire definitivo
e, forse, inaccettabile. Del resto: la sua stella brillo con Giulio Andreotti e,
poi, con il Cavaliere. Ha visto da vicino tutto. Compresa Tangentopoli. «E
l’aldilà: 4 bypass a Houston, 2 a Londa, trapianto cardiaco a Pavia nel 2007».
Da Di Pietro, che lo indago per la vicenda Enimont, si fece promettere: «Quando
succederà, devi scrivermi l’orazione funebre». Poi non e successo.
E cosi adesso cambi canale e
lo senti spiegare un po’ di sintassi politica a questi ragazzi che pensano di
farla mettendosi una pochette nel taschino o mangiando pane e Nutella.
Donat-Cattin, un riformista
al governo. Lunedì 11 aprile la presentazione.
Il Domani il 09 aprile 2022.
Il libro di Marcello Reggiani
sul politico e ministro democristiano verrà presentato da Elsa Fornero e Carlo
De Benedetti lunedì 11 aprile al Polo del 900 di Torino.
La presentazione del libro “Un
riformista al governo. Carlo Donat-Cattin ministro del centro-sinistra
(1963-1978)” di Marcello Reggiani sarà lunedì 11 aprile al Polo del 900 di
Torino alle ore 17.30.
A intervenire saranno Carlo De
Benedetti, l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, Gianfranco Zabaldano,
presidente della Fondazione Vera Nocentini e Giovanni Zanetti, professore
emerito, già ordinario di Economia politica all’Università di Torino. A
coordinare il dibattito sarà Mariapia Donat-Cattin del comitato scientifico
della Fondazione che prende il nome dal politico democristiano.
Il libro è una ricostruzione
delle riforme fatte e di quelle incompiute a cavallo degli anni sessanta e
settanta: dalle leggi quadro per l’industria allo Statuto dei lavoratori, dalla
riforma presidenziale a quella sanitaria.
Carlo Donat-Cattin è stato un
sindacalista, giornalista e politico italiano. Fu deputato della Repubblica dal
1958 al 1979 e senatore dal ‘79 fino 1991, sempre con la Democrazia Cristiana.
Ministro del lavoro dal ‘69 al ‘72 e dall’89 al ‘91, ministro dell’Industria dal
‘74 al ‘78 e della Sanità dall’86 all’89.
Carlo Donat-Cattin.
LA VIOLENZA IN CASA. Il caso Donat-Cattin. Padri contro figli negli anni del
terrorismo. MONICA GALFRÉ su Il Domani il 29 marzo 2022
Il caso Donat-Cattin-Cossiga
innesca sentimenti contraddittori. Da una parte, alimenta il clima di sospetto e
mina ulteriormente la credibilità delle istituzioni.
Dall’altra, svela quanto sia
diffuso il contagio eversivo. In più il nemico sembra acquisire un volto, che è
quello di un ragazzo come tanti, familiare nonostante il nome famoso.
Perché prima di tutto Carlo e
Marco Donat-Cattin sono un padre e un figlio. Divisi dalla storia, che in quegli
anni ha corso più veloce del solito, non si sono mai capiti, come migliaia di
padri e figli di quell’età. MONICA GALFRÉ
Marco Revelli per “la Stampa”
il 22 marzo 2022.
Mercoledì 7 maggio 1980 il
quotidiano Paese sera esce col titolo in prima pagina: «Il figlio di
Donat-Cattin fa parte di Prima linea». E' l'inizio di uno scandalo di dimensioni
potenzialmente devastanti, esploso nel cuore della Prima Repubblica. Carlo
Donat-Cattin è il potentissimo vice-segretario della Democrazia Cristiana. Ha
appena scritto il Preambolo alle tesi congressuali del partito, con cui è stata
decretata la fine del «compromesso storico», in un Paese ancora stretto nella
morsa del terrorismo. Che il figlio Marco sia un militante di una delle più note
formazioni della lotta armata è di per sé sconvolgente. Ma non finisce lì.
Pochi giorni più tardi, il 16
maggio, la Procura di Torino trasmette alla Presidenza della Camera i verbali
d'interrogatorio di Roberto Sandalo, un altro membro di Prima linea, amico del
cuore di Marco, arrestato il 29 aprile, da cui risulta che Carlo Donat-Cattin
avrebbe saputo della situazione giudiziaria del figlio direttamente dall'allora
presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, in un incontro riservato. Che la
seconda carica dello Stato risulti imputabile di favoreggiamento nei confronti
del figlio di un altissimo dirigente del suo partito configura le condizioni per
cui quel vulnus giunga a colpire lo stesso «cuore dello Stato» con effetti
persino più distruttivi del fuoco delle Brigate Rosse.
Tanto più che nel frattempo
Marco Donat-Cattin è raggiunto da un mandato di cattura per l'assassinio del
giudice milanese Emilio Alessandrini. Le sedute della Commissione parlamentare
per i procedimenti d'accusa (il cosiddetto «tribunale dei ministri»), di fronte
alla quale il capo del governo è chiamato a rispondere come imputato, tra la
fine di maggio e la fine di luglio, metteranno in scena tutti gli aspetti di
quello che Eugenio Scalfari definì come «uno scandalo senza precedenti».
Il quale tuttavia non ebbe
tutta la assorbente visibilità che la cosa in sé avrebbe meritato solo perché
inserito in una serie terribile di eventi che finirono per relativizzarne
l'impatto: è del 28 maggio l'omicidio a Milano del giornalista Walter Tobagi, il
23 giugno a Napoli è assassinato dai neofascisti dei Nar il giudice Mario Amato,
la strage di Ustica, con i suoi 81 morti, è del 27 giugno, mentre quella alla
stazione di Bologna (85 morti, 200 feriti) segna l'inizio di agosto Così, quando
il 31 maggio, la Commissione a maggioranza risicata (11 contro 9) e poi il 27
luglio l'Aula (507 contro 416) scagionano il capo del governo dall'accusa di
favoreggiamento, il rumore mediatico è relativamente contenuto. Cossiga farà
ancora in tempo a diventare presidente del Senato e poi il presidente della
Repubblica «picconatore» che tutti ricordano.
Per Carlo Donat-Cattin,
invece, di fatto la carriera politica finirà lì, inchiodato alla sorte di quel
figlio con cui non era mai andato d'accordo. Sotto il profilo strettamente
politico la riflessione potrebbe chiudersi così. Uno dei tanti esempi di
malapolitica da «Prima Repubblica».
Ma in realtà il «caso dei
Donat-Cattin» (padre e figlio) è un viluppo di problemi più profondi, di
questioni più «ultime», attinenti ai temi della vita, della morte, del dolore,
del senso e del non-senso, del rapporto tra le generazioni naturalmente, come
suggerisce il titolo del libro di per sé evocativo di tragedia: Il figlio
terrorista. «Nodi» che l'autrice Monica Galfré rivisita con competenza e
sensibilità, affidandosi alle fonti con acribia da archivista ma anche
all'intuito e alla capacità di compassione indispensabili quando si costeggiano
abissi di questa profondità. In primo piano il livello più «visibile» della
vicenda, quello processuale, con un focus importante sul passaggio parlamentare
(«La repubblica sotto processo» è il titolo del capitolo), da cui emergono, con
drammatica evidenza, le due «culture politiche» a confronto: da una parte quella
democristiana, segnata dall'attenzione alla dimensione umana del dramma del
proprio vice-segretario, in forza dei rapporti di amicizia ma anche della
centralità che la «famiglia» - con i suoi affetti e i suoi difetti - ha
nell'universo valoriale identificante; dall'altra quella comunista, del Pci
berlingueriano, che utilizzò il caso per un attacco frontale, catafratta
nell'affermazione intransigente del rilievo pubblico (già sperimentata nel corso
del rapimento di Aldo Moro) e del primato dello Stato come istituzione «fredda».
Ma poi, come secondo cerchio,
il livello più intimo del rapporto «padre/figlio»: di quel padre così assente,
tutto assorbito dalla vita politica romana, e così inarrivabile nella sua
statura di leader nazionale; di quel figlio così bello, e ribelle, intreccio di
vitalismo e di incostanza. E, attraverso quella coppia, la questione più
generale del rapporto tra le generazioni in un'epoca di sconvolgimento delle
relazioni fondamentali, in cui la modernizzazione tardiva del Paese, brutale e
rapida («il crollo finale della società patriarcale»), ha lacerato consolidati
legami, strutture elementari come la famiglia, mondi affettivi consolidati e
violati da una tempesta di cui il Sessantotto fu la cornice.
E in cui un Edipo scatenato
fece, per una feroce parentesi, terra bruciata di un intero repertorio di
regole, sentimenti, umanità accumulati nel ciclo lungo della civilizzazione.
Infine c'è la galassia ampia, incandescente e avvelenata, del movimento diffuso
della lotta armata, col suo reclutamento di massa, i suoi giochi di morte, i
meccanismi dell'emulazione e dell'iniziazione, i corpi di un nemico neppure
conosciuto usati come «tragici trofei» per segnare il territorio, misurare
rapporti di forza tra micro-sette, dimostrare a se stessi di esistere perché
capaci di uccidere. E la domanda sul come, e il perché tanta parte di quella
gioventù sospesa tra due tempi in rapido distanziamento vi si sia arruolata, da
un certo punto in poi prigioniera di un presente in cui contava solo l'atto,
l'azione sempre più violenta, fino all'omicidio, bruciando in pochi anni tutte
le tappe di un «carnivoro cupio dissolvi».
L'autrice cita, più volte, il
motto di La Rochefocauld ripreso da Elias Canetti: «Due cose non si possono
guardare in faccia: il sole e la morte». Marco Donat-Cattin (e alcuni come lui)
la morte, la morte degli altri da loro provocata, riuscirono a guardarla solo
«dopo», dalle sbarre di una cella. La sua dissociazione fu autentica, così
giudicò il tribunale. E «dignitosa», aggiunge l'autrice. Nonostante la lunga
serie di reati, anche gravissimi, la sentenza sarà mite. La vigilia di Natale
del 1987 uscì in libertà provvisoria. Ma ne godrà per poco. Meno di sei mesi
dopo, il 19 giugno del 1988, morirà, sull'autostrada Serenissima, mentre tentava
di aiutare una donna vittima di un tamponamento. «La morte ha riportato Marco a
casa», commenterà qualcuno al funerale. E forse è una verità più profonda di
quanto sembri.
Lettera di Antonello Piroso a
Dagospia il 22 marzo 2022.
Caro Roberto, nell'articolo di
Marco Revelli per La Stampa da voi ripreso -a parte l'inesattezza di collocare
l'assassinio del giudice Mario Amato a Napoli (no: fu ucciso alla fermata
dell'autobus vicino casa, a Roma)- c'è una ricostruzione sulla vicenda
Cossiga-Donat Cattin che non tiene conto di quanto raccontato dallo stesso
Cossiga nel suo libro "Italiani sono sempre gli altri".
Riassumo per punti:
1) Roberto Sandalo, "pentito"
di Prima Linea, raccontò di aver incontrato Carlo Donat-Cattin, padre del
terrorista Marco, per informarlo del destino del figlio (espatriato in Francia
dopo diversi attentati, tra cui quello che era costato la vita al giudice Emilio
Alessandrini);
2) il Pci di Enrico Berlinguer
dedusse -è sempre Cossiga che parla- che se il figlio era scappato, era perchè
era stato avvisato dal padre, a sua volta informato dal presidente del
Consiglio, cioè dallo stesso Cossiga, in nome della colleganza democristiana
(Donat-Cattin era all'epoca vicesegretario del partito e ministro del lavoro);
3) fu promossa una raccolta di
firme per la messa in stato d'accusa di Cossiga, ma il Parlamento rigettò la
richiesta del Pci;
4) ma chi aveva davvero messo
in circolo la notizia? Cossiga da chi avrebbe saputo che Donat-Cattin junior era
uno dei capi di Prima Linea? Dal ministro dell'interno Virginio Rognoni, altro
Dc, che lo era andato a trovare con il segretario del partito, Flaminio
Piccoli;
5) Rognoni invita Cossiga a
dirglielo lui, a Donat-Cattin, della situazione del figlio, perchè "noi non
andiamo d'accordo". Ma, aggiunge Cossiga, a me parve una scusa per non trovarsi
coinvolto nella rivelazione di segreti di Stato;
6) Cossiga avverte Rognoni:
guarda che sei già in fallo, e pure grave, perchè un conto è se tu, ministro,
avvisavi solo me, presidente del consiglio; ma per il fatto di averne parlato
anche con Piccoli, che è comunque un privato cittadino, hai già commesso un
reato;
7) incontrando Cossiga a un
successivo vertice per le nomine agli enti previdenziali, sarà Donat-Cattin a
chiedere a Cossiga cosa sappia del figlio, e Cossiga gli dice cosa ha appreso
delle rivelazioni di Sandalo e di quelle convergenti di Patrizio Peci, catturato
dal generale Dalla Chiesa;
8) quando sta per salire in
aereo per andare ai funerali del Maresciallo Tito con il cugino Berlinguer,
Cossiga viene avvisato dal capo della polizia Coronas che nei confronti di
Donat-Cattin jr, fino a quel momento ancora solo "sospettato", erano stati
spiccati mandati di cattura;
9) e qui, commenta Cossiga,
"commetto l'ingenuità più grande: metto al corrente Enrico della tragedia in
corso, sottovalutando che è pur sempre segretario del Pci", che fa reagire il
partito come detto;
10) il bello è che Tonino
Tatò, portavoce di Berlinguer, aveva informato Luigi Zanda (sì, proprio lui, ai
tempi portavoce di Cossiga) che secondo la segreteria del partito si trattava di
una manovra di bassa lega politica. In effetti, il ministro dell'interno-ombra
del Pci, Ugo Pecchioli, aveva difeso Cossiga, anche perchè aleggiava il sospetto
che Sandalo fosse stato arrestato -non dai carabinieri di Dalla Chiesa- e
rimesso in libertà come "agente provocatore", e Giancarlo Pajetta si era
distinto con una riflessione che, conclude Cossiga, non ho mai dimenticato: "Io
non so cosa Cossiga abbia veramente detto a Donat-Cattin, ma so che ha detto nè
più nè meno di quanto avrebbe detto a ciascuno di noi qui dentro se avessimo un
figlio nelle stesse condizioni".
Di tutto questo Cossiga, che
intrattenne con me un cordialissimo rapporto, mi parlò in occasione della sua
collaborazione televisiva con La7, quando -secondo una vulgata interessata- io
sarei stato su una sua personale blacklist per aver individuato una sua
fantomatica amante quando lavoravo a Panorama (circostanze entrambe false, ma
questa è un'altra storia).
Il lavoro di Monica Galfrè.
Il figlio terrorista, la storia di Marco Donat-Cattin che scosse la Repubblica.
David
Romoli su Il Riformista il 5 Maggio 2022.
Nella notte del 20 giugno
1988 un giovane uomo di 35 anni viene coinvolto di striscio in un tamponamento a
catena sull’autostrada Milano-Venezia, all’altezza del casello Verona Sud. C’è
un ferito, sua moglie sta provando a fermare le macchine in arrivo. L’uomo la
affianca, segnala con lei l’incidente anche se il buio e la velocità delle auto
rendono l’impresa rischiosa. Una Thema arriva sparata, li prende in pieno,
uccide entrambi sul colpo. La vittima ha un nome noto: è Marco Donat-Cattin, ex
militante di Prima linea, ex detenuto politico, considerato un pentito anche se
è vero solo a metà. Il padre, Carlo Donat-Cattin, è uno dei principali leader
della Dc, più volte ministro, in quel momento vicesegretario del partito.
Intorno a quella parentela e
al sospetto che il potente padre, allertato addirittura dal presidente del
consiglio Cossiga, avesse brigato per mettere in salvo il figlio era scoppiato
nel 1980 uno dei più clamorosi scandali nella storia della Repubblica.
Ricostruisce quella tempesta politica, e soprattutto la parabola tragica di
Marco, il libro della storica Monica Galfré, edito da Einaudi, Il figlio
terrorista. Il caso Donat-Cattin e la tragedia di una generazione: uno dei
migliori nella foltissima bibliografia su quell’epoca storica, forse il migliore
in assoluto. Per quanto attiene allo scandalo, ricostruito nella prima parte del
libro, la vicenda ancora oggi non è accertata nei dettagli. All’origine c’è il
brigatista Patrizio Peci, primo tra i grandi pentiti della lotta armata in
Italia. Nella sua fluviale deposizione aveva detto di aver saputo da un
dirigente di Prima linea, il principale gruppo armato dopo le Br, che tra i
dirigenti di quell’organizzazione c’era il figlio di Donat-Cattin. Era il 2
aprile 1980: pochissimi giorni dopo la deposizione di Peci arrivò nelle mani di
Cossiga che – secondo la testimonianza del pentito di Pl Roberto Sandalo – si
premurò di avvertire l’amico Carlo perché facesse espatriare il figlio
terrorista quanto prima.
I verbali degli interrogatori
di Peci, depurati però della pagina in cui veniva citato Donat-Cattin, finirono
nelle mani del giornalista del Messaggero Fabio Isman, consegnatigli da numero 2
del Sisde Silvano Russomanno: finirono entrambi in galera per violazione del
segreto d’ufficio. Ci rimasero per mesi, poi il giornalista fu prosciolto,
l’uomo dei servizi condannato. Sandalo, il militante di Pl che aveva parlato a
Peci di Marco Donat-Cattin, fu arrestato il 29 aprile. Tra la deposizione di
Peci e quell’arresto, Cossiga aveva certamente incontrato il vicesegretario
della Dc nel suo studio privato e il potente Carlo aveva immediatamente
contattato proprio Sandalo, che sapeva essere amico e compagno di suo figlio,
secondo quest’ultimo per rintracciare e avvertire il figlio. “Roby il pazzo”,
come lo chiamavano, si pentì subito. Il 3 maggio fece il nome di Marco
Donat-Cattin, contro cui quattro giorni dopo fu spiccato un mandato di cattura
ma il “comandante Alberto”, come da nome di battaglia, era già oltre confine. Fu
arrestato a Parigi mesi dopo, il 20 dicembre. Che fosse stato messo in guardia
dal padre o meno, la decisione di espatriare la aveva già presa. Non dipese
dall’indiscrezione del presidente del consiglio.
Le deposizioni del pentito di
Prima linea non si fermarono lì. Coinvolsero Cossiga, scatenando un uragano
politico. Appena due anni prima, con lo stesso Cossiga inflessibile ministro
degli Interni, la Dc aveva sacrificato il suo esponente più prestigioso, Aldo
Moro, per non trattare con i terroristi. La fermezza era una professione di
fede, un dogma, un obbligo morale prima che politico: trasgredire in nome della
famiglia o dell’amicizia, degli affetti, sembrava letteralmente inconcepibile.
Sia Donat-Cattin che Cossiga
smentirono. Solo 27 anni più tardi il Picconatore avrebbe ammesso e indicato la
catena lungo la quale aveva viaggiato l’informazione: dal ministro degli Interni
Rognoni al segretario della Dc Piccoli, i quali avevano poi messo al corrente
Cossiga, affidando a lui lo sgraditissimo compito di mettere al corrente il più
diretto interessato, Donat-Cattin padre.
La faccenda finì di fronte
alla Commissione parlamentare per i procedimenti d’accusa, il “Tribunale dei
ministri”. Seduta fiume: tesa, molto drammatica e tuttavia dall’esito
predeterminato. La Commissione avrebbe dovuto decidere non sull’eventuale
colpevolezza del premier ma solo sulla necessità o meno di procedere con
ulteriori accertamenti. Discusse invece come se dovesse emettere un verdetto e
assolse a furor di maggioranza. Il Pci raccolse le firme necessarie per ripetere
il “processo” in luglio, di fronte alle Camere in seduta congiunta. Fu un
momento tanto solenne quanto disertato: dopo cinque giorni di dibattito ad aula
semivuota Cossiga ne uscì incolume. Donat-Cattin invece rassegnò le dimissioni e
uscì di scena ma solo per qualche anno: nell’86 era di nuovo ministro.
Monica Galfrè ricostruisce non
solo i passaggi di quella crisi ma soprattutto la temperie che rifletteva e
veicolava: il dibattito sui media, gli intrecci tra calcolo politico, propaganda
e avvio, per la prima volta, di una riflessione della società italiana su se
stessa e sulla bufera che stava attraversando ormai da oltre 10 anni. Quella che
emerge è la verità di un Paese che perla prima volta faceva i conti con il
terrorismo, cioè con l’emergenza che lo ossessionava più di ogni altra,
riconoscendone la natura “interna”, inscritta nella propria storia. Sino a quel
momento i terroristi erano stati visti come alieni: gelidi, efficienti, feroci,
nemici mortali, sempre e comunque “altro da sé”. Complice l’intreccio familiare
reso fragoroso dalla notorietà e dal ruolo dei protagonisti, i terroristi, e con
loro un’intera travagliata generazione, cominciavano a essere visti per quello
che erano: non solo parte del Paese ma parte delle famiglie. In senso proprio
qualche volta, ma in senso più lato sempre.
Anche da questo punto di vista
il 1980 è un anno di svolta: il percorso successivo non sarebbe stato lineare,
la “soluzione politica” invocata dai terroristi sconfitti sarebbe sempre rimasta
una chimera. Però, senza dubbio, una volta sconfitto il terrorismo, l’Italia
della prima Repubblica dimostrò una disponibilità alla clemenza e una volontà di
superare l’emergenza marcata dalla consapevolezza di avere a che fare con i
propri figli. Quei “figli”, Marco Donat-Cattin in qualche modo li rappresenta
tutti. Ragazzo ribelle, padre a 17 anni, militante di Lotta continua, poi
di Senza tregua e di lì in Prima linea, quando viene denunciato il “comandante
Alberto” era già uscito da Pl, deluso da una deriva militarista che stava
rendendo quell’organizzazione sempre più simile alle Brigate rosse e dunque
sempre più lontana dalla “struttura armata di movimento” delle origini, di
ispirazione opposta a quella brigatista. Se la “ritirata strategica”
in Francia lo avrebbe condotto ad abbandonare la militanza armata o a puntare su
un nuovo gruppo terrorista, come sembrava comunque intenzionato a fare, non è
dato sapere. Di certo nel suo percorso individuale si rifletteva una crisi che
non era interna solo alle organizzazioni armate. In quel 1980, che col senno di
poi sappiamo aver segnato il tramonto del terrorismo e che si sarebbe concluso
alla Fiat con la sconfitta di una ribellione operaia durata oltre 10 anni, si
consumò anche la fine di una sorta di incanto collettivo, generazionale,
degenerato in tragedia.
L’obiettivo di rendere la
parabola di Marco Donat-Cattin esemplare è esplicitato da Monica Galfré sin dal
sottotitolo del libro. Per farlo, l’autrice procede in senso inverso rispetto a
quello usuale: spoglia Marco Donat-Cattin di ogni componente stereotipa,
dal “terrorista” al “militante rivoluzionario”, cercando invece di rintracciarne
l’individualità: una verità personale condivisa, pur se declinata da ciascuno a
modo proprio, da molti altri giovani del suo tempo e del suo Paese. Da storica,
l’autrice ha scelto di affidarsi essenzialmente alle deposizioni di Marco,
considerandole comunque meno falsate, in virtù dell’immediatezza, dei ricordi e
delle ricostruzioni a distanza di decenni.
Sono gli aspetti sempre
dimenticati e messi da parte quelli che vengono qui indagati e scandagliati: il
rapporto con la morte data e rischiata, molto più complesso di quanto le
ricostruzioni storiche non siano in qui riuscite a restituire, centralissimo
nella parabola di Marco Donat-Cattin, che uccise personalmente il giudice Emilio
Alessandrini e dall’incubo di quella morte data con le proprie mani non si
liberò mai; le relazioni sentimentali, che c’erano ed erano essenziali anche per
i militanti della lotta armata; soprattutto il rapporto tra comunità e
individui, quello più articolato, per molti e contrapposti versi essenziale
nello spiegare sia la precipitazione negli inferi di una lotta armata vissuta
spesso con disagio e lacerazioni interiori, sia la rottura che portò molti alla
dissociazione, al pentimento o alla resa. Donat-Cattin appare come un “pentito a
metà”, quasi un dissociato ante litteram: quando iniziò a collaborare, non
facendo nomi ma ricostruendo l’intera genesi di Prima linea, la sua
articolazione e i delitti compiuti, la dissociazione ancora non esisteva. Quando
morì sull’autostrada, era uscito di galera da sei mesi, lavorava nel sociale per
il recupero dei tossicodipendenti. La sua tragedia personale è una chiave per
capire la storia d’Italia in un momento cruciale come non è ancora stato fatto.
David Romoli
Storia di Carlo Donat
Cattin, il sindacalista che portò i diritti in fabbrica.
Paolo Guzzanti su Il
Riformista il 15 Maggio 2020
La storia di Carlo Donat
Cattin, uno dei più importanti leader sindacalisti e capo di una delle fazioni
più forti della Democrazia cristiana, è una delle più drammatiche e rapidamente
dimenticate della Prima Repubblica. Eppure fu lui a portare a compimento nel
1970 insieme al giuslavorista socialista Gino Giugni (che sarà per questo
“gambizzato” dai terroristi nel 1983) quello Statuto dei lavoratori che aveva
varato il socialista Giacomo Brodolini nel 1969 poco prima di morire. Donat
Cattin era uno dei pochi maschi alfa della Dc, uno di quel sangue ligure
piemontese fatto di durezza, silenzio e intransigenza di una stirpe montanara e
di scoglio forte e taciturna, con idee duramente trattabili, ma inflessibili.
Era uno che non andava giù alla destra Dc e alla destra politica in genere (che
oggi, sia detto per inciso non esiste più sul panorama politico, occupato da
altre destre) perché il suo sindacato – da lui creato con una scissione dalla
originaria Cgil – era spesso più intransigente del sindacato guidato dai
comunisti.
La destra conservatrice di
allora, un genere di destra di cui oggi non c’è più traccia, lo definiva «un
comunista da sagrestia», sbagliando totalmente perché Donat Cattin, come
Brodolini, apparteneva a quella sinistra spesso più a sinistra delle Botteghe
Oscure, ma che nel frattempo governava, e aveva accesso a quella che il vecchio
leader socialista Pietro Nenni aveva chiamato «la stanza dei bottoni». Carlo
Donat Cattin oltre che farsi un suo sindacato, si era di fatto anche una sua
personale Democrazia cristiana all’interno del grande corpaccione elettorale
cattolico con la corrente “Forze Nuove” che nei momenti di maggior splendore
raggiungeva il venti per cento. Donat Cattin era dunque un politico politicante,
in questo più affine al socialista Pietro Nenni – il quale dall’esilio francese
aveva portato lo slogan la politique d’abord, la politica prima di tutto – che
non ai comunisti infinitamente più togliattiani, ovvero sottili e duttili ma
anche gelosi del loro primato nella classe operaia e del sindacato malvolentieri
condiviso con i socialisti al governo insieme ai democristiani.
Erano state tutte queste
contraddizioni logiche e politiche a mettere sotto stress una politica che si
era arenata con l’uccisione di Aldo Moro sulla soglia del compromesso storico e
che era fortemente animata dalle frange estremiste che praticavano la politica
delle armi piuttosto che le armi della politica, ad imitazione di quanto
avveniva nella Repubblica federale tedesca con la Rote Armee Fraktion. Fu
quindi un fatto imprevisto, ma al tempo stesso di piena coerenza storica,
l’emersione del ruolo di un figlio di Carlo Donat Cattin, Marco, come
terrorista, anzi un leader del terrorismo rosso, uno dei più sanguinari
“comandanti” di Prima Linea, una organizzazione combattente comunista affine e
concorrente delle Brigate Rosse. Per il padre non fu soltanto uno shock, ma la
fine della sua carriera politica, almeno come dirigente.
L’emersione del nome del
figlio – che poi si pentì e morì tragicamente in un terribile incidente stradale
mentre tentava di salvare alcuni automobilisti dallo stesso incidente in cui era
coinvolto – prese subito la forma di uno scandalo che coinvolse Francesco
Cossiga nella sua qualità di ministro degli Interni (ma che in quel momento era
capo del governo) e Donat Cattin, ministro dell’industria in un governo
Andreotti, che dovette dimettersi, sostituito il 25 novembre 1978, da una new
entry: Romano Prodi. Non si è mai capito da quanto tempo e a chi esattamente
fosse noto il fatto che Marco Donat Cattin fosse un terrorista. La sua
identificazione avvenne per opera di uno dei tanti pentiti allora gestiti dai
corpi speciali e quando la storia venne allo scoperto, lo scalpore raddoppiò
quando emersero imbarazzanti dettagli sul retroscena della vicenda che
diventarono terreno di uno scontro violentissimo perché Cossiga era ora
presidente del Consiglio e messo formalmente in stato d’accusa.
Alla fine di un dibattito
accesissimo, fu assolto con 597 no contro 416 sì dal sospetto di aver avvertito
Donat Cattin padre della situazione di suo figlio, suggerendogli di farlo
sparire alla svelta. Fu una faccenda brutta e penosa perché Donat Cattin, quasi
spezzato nella sua struttura di vecchia quercia dovette ammettere di avere
chiesto a Cossiga se avesse notizie di suo figlio Marco. E Cossiga ammise di
aver risposto di non avere alcuna notizia del latitante. Carlo Donat Cattin
restò fuori dalla politica finché fu recuperato da Bettino Craxi che lo volle
ministro della Sanità in piena crisi per il diffondersi dell’Aids. Era un ruolo
per lui secondario, ma non c’era ormai altro. Anche per il presidente del
Consiglio Cossiga, benché salvato dal voto, fu l’inizio di un profondo
turbamento umano perché – mi raccontò più volte – mai si sarebbe atteso un
personale e rovente accanimento in Parlamento da parte di Enrico Berlinguer che
era, tecnicamente, suo cugino. Il commento gelido di Berlinguer a questa
manifestazione di sorpresa, fu: «Con i cugini si mangia soltanto l’agnello a
Pasqua».
Cossiga sparì dalla politica e
fu recuperato da Ciriaco De Mita, su consiglio di Eugenio Scalfari che a quei
tempi riceveva a pranzo Cossiga una volta a settimana, quando Amintore Fanfani
si giocò lo scranno di presidente del Senato per guidare un governicchio
balneare che, alla fine, mise fuori anche lui. Allora Cossiga fu riammesso nel
circolo del grande perdono cattolico comunista ed eletto presidente del Senato e
di lì, quasi con un plebiscito, spedito al Quirinale perché considerato un uomo
ormai privo di qualsiasi tossina pericolosa. Errore drammatico perché, come
sappiamo, dopo i primi quattro anni di settennato, l’ex presidente del Consiglio
umiliato alla Camera per il caso Donat Cattin cominciò a togliersi i sassolini
dalle scarpe.
A Donat Cattin, che era stato
un fautore dell’incontro storico con i comunisti, era del tutto passata la
voglia di quella stagione. Anche lui, in maniera analoga a quel che fece
Cossiga, invertì la rotta facendosi portatore del cosiddetto «preambolo» che
consisteva nello smontaggio di quanto ancora rimaneva della collaborazione fra
Dc e Pci: la nuova linea era quella di sbattere fuori i comunisti da ogni
maggioranza, anche se Giulio Andreotti fece tutto il possibile e anche
l’impossibile per riagganciare il Pci grazie al quale sperava un giorno di
arrivare al Quirinale.
Nel 1986 come ministro della
Sanità di Craxi (che lo apprezzava proprio per la sua incompatibilità con i
comunisti e la disponibilità con i socialisti) si trovò il Pci di traverso ogni
volta che se ne presentava l’occasione. Così fu attaccato violentemente sulla
questione – oggi dimenticata– dell’atrazina: un diserbante inquinante, che
superava la quantità massima concessa dall’Europa di 0,1 microgrammi per litro.
I sindacati aderenti alla Cgil dichiararono guerra insieme ai verdi di Marco
Boato finché il Pci non propose una mozione di sfiducia personale insieme
alla Sinistra indipendente e Verdi, che non passò ma che contribuì ad azzopparlo
ulteriormente, mentre la stella del suo protettore Craxi perdeva di forza.
Sull’Aids, Donat Cattin fece
una gaffe che gli valse molte palate di fango, non del tutto immeritate. Disse
infatti che «l’Aids ce l’ha chi se lo va a cercare», alludendo pesantemente alla
forte incidenza di omosessuali maschi fra gli infettati dal virus Hiv E in
questa battutaccia c’era un po’ di tutto: una vena di cattolicesimo
conservatore, una rusticana ostilità per le élite intellettuali e omosessuali
molto diffusa nel Piemonte e nella Liguria operaie e che costituivano
paradossalmente lo stesso bacino sardo-ligure-piemontese di cui era nutrito il
Pci di Gramsci, Togliatti, Longo, Berlinguer e fino a Natta.
Nulla di più che una
significativa coincidenza geografica con l’antico Regno di Sardegna, che però
nella vecchia e buona Repubblica che chiamiamo “prima” come se ce ne fossero
state altre, aveva un certo valore codificato dall’asprezza di i duelli mortali,
combattuti senza mettere di mezzo amici o parenti, perché con quelli, al
massimo, ci si mangia l’agnello a Pasqua. Donat Cattin fu il secondo padre
dello Statuto dei lavoratori, dopo Giacomo Brodolini, ma probabilmente pochi lo
ricordano per questo e dunque lo facciamo noi nel tentativo di rimettere insieme
alcuni pezzi e capire come andarono le cose.
Paolo Guzzanti. Giornalista e
politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della Fondazione Italia
Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza Italia e deputato
nella XVI per Il Popolo della Libertà.
Gerardo Bianco. "Moro,
Fanfani, Mattarella. La mia lunga vita nella Dc".
Federico Bini il 7 Febbraio
2022 su Il Giornale.
A 91 anni quasi compiuti,
Gerardo Bianco, uno degli ultimi storici esponenti di spicco della Democrazia
cristiana e del popolarismo italiano racconta la sua straordinaria vita.
L'ascesa politica con Sullo e
De Mita, la passione per il parlamento, gli incarichi di capogruppo, ministro e
segretario del Ppi dopo la fine dell'amata Dc. Il tentativo di includere il Psi
nell'area di governo, le nottate in parlamento, l'elezione mancata di Forlani al
Quirinale, il ricordo di Moro, Fanfani, Cossiga e Andreotti e l'elelogio del
presidente della Repubblica Mattatella.
Presidente Bianco è vero che
Lei è un intellettuale prestato alla politica?
"Io metto in dubbio che sia un
intellettuale. Intellettuale per me è un discorso molto profondo. Bisogna
veramente essere persone di grande cultura. Ho coltivato gli studi, sono uno che
ha moderatamente letto parecchi libri anche quelli del mondo latino ma non mi
ritengo un grande intellettuale. Ho fatto politica, questo sì, per tutta la
vita, con grande passione, soprattutto la vita parlamentare. Per me il
parlamento era il cuore della politica italiana e lì ho vissuto le mie ore
migliori e le giornate più avvincenti".
Lei una volta ha detto: “Il
parlamento è la mia passione”.
“Esatto. Io mi sono sentito
sempre un rappresentante parlamentare anche se ho avuto ruoli più di carattere
partitico o di governo, io mi sono sempre sentito un rappresentante della
nazione”.
Lei entra in parlamento nel
1968 e vi rimane per oltre quarant’anni. Guardando retrospettivamente come sono
cambiate da dentro le istituzioni italiane. Pensiamo ad esempio al ruolo della
presidenza della Repubblica.
“La situazione nel corso degli
anni si è parecchio modificata. In sostanza quello che ha inciso moltissimo
nella evoluzione delle nostre istituzioni a mio avviso è stata una data, una
data infausta, che avrebbe stabilizzato il sistema politico italiano, ed è il
1953. Quando la legge cosiddetta 'truffa' non viene praticamente approvata e
cominciano le instabilità dei governi. In questo contesto il ruolo del
presidente della Repubblica vedrà crescere i suoi poteri, continuando a svolgere
il ruolo che comunque la Costituzione gli conferisce di bilanciamento dei
poteri, di stabilizzazione che è stato esercitato in maniera sempre più
incisiva”.
Prima di entrare in parlamento
da ragazzo avellinese era dato vicino come anche De Mita al ministro Fiorentino
Sullo.
“Sullo aveva un carattere
difficile, complicato e molte volte mutevole. A Sullo dobbiamo riconoscere di
aver fatto crescere una classe dirigente. Sullo è stato un grande politico,
aveva una visione straordinaria nella concezione dello sviluppo del paese.
Rimane celebre la sua proposta di legge urbanistica, bocciata clamorosamente
dalla stampa che era ostile e in qualche maniera anche dall’interno del partito
democristiano perché chi governava il partito, all’epoca Aldo Moro, si era reso
conto che avremmo perduto centinaia di migliaia di voti”.
Su De Mita invece una volta
disse: “De Mita voleva la mia pelle e io mi sono rotto le palle”.
“Sono situazioni che fanno
parte della dialettica politica. C’è stata prima una grande intesa, un grande
incontro. De Mita era mio compagno di studi alla Cattolica a Milano, aveva già
una posizione chiaramente di leadership anche dal punto di vista politico. Il
suo carattere e il suo interesse erano maggiormente orientati verso la politica
rispetto a me e ad altri colleghi. Abbiamo lavorato poi insieme con Sullo nella
creazione della corrente di Base che era aperta all’inclusione nel sistema
democratico del Partito socialista”.
Quanto ha pesato sulla Dc la
morte di Aldo Moro?
“È fuori discussione che Moro
fosse una figura centrale nella conduzione strategica delle alleanze politiche e
quindi dell’assestamento del sistema politico-istituzionale italiano. Io però
non accetto la teoria secondo cui con la morte di Moro ci fu la rottura del
dialogo con il Partito comunista. Io penso che la responsabilità sia da
addossare al Partito comunista e alla leadership del momento su questioni di
carattere internazionali. La rottura avvenne nel 1978, quasi subito dopo il voto
a favore del governo Andreotti, sul problema del serpente monetario europeo.
Praticamente il Partito comunista si opponeva affinché l’Italia sottoscrivesse
l’accordo. E poi l’altro fatto successivo fu il problema degli euromissili”.
Con Craxi che si smarcò
nettamente dai comunisti.
“Qui ci fu il grande
cambiamento della politica italiana. Craxi ricordo che non voleva che si
mettesse la fiducia e disse a me che ero capogruppo della Dc che se si poneva la
fiducia lui non poteva votarla. Se invece la fiducia non si metteva lui avrebbe
approvato la missione che poneva il dispiegamento degli euromissili per
controbilanciare quelli installati dall’Unione Sovietica”.
Lei è stato capogruppo Dc alla
Camera dei Deputati dal 1979 al 1983.
“È stata una bellissima
esperienza caratterizzata da una intensa attività parlamentare con il Partito
radicale che ci costringeva a fare le notti. E qui c’era da trascorrere delle
vere e proprie nottate per far approvare i vari provvedimenti. La sera tardi ci
ritrovavamo nella ‘residenza’, una stanza del segretario generale della Camera.
Un grande segretario, Vincenzo Longi il quale cercò sempre di mantenere
l’assoluta terzietà della Camera”.
A quale politico è stato più
vicino nella sua lunga carriera?
“Un rapporto importante l’ho
avuto con De Mita, con Sullo e poi negli ultimi tempi un rapporto molto inteso e
di grande stima l’ho avuto con Donat-Cattin”.
Come erano i grandi leader Dc
visti da vicino?
“Moro l’ho conosciuto
benissimo, Fanfani che appariva così antipatico era di una simpatia assoluta.
Poi aveva la mania di cucinare. Quando era presidente del Senato e ci invitava
varie volte con mia moglie, stava dietro a fare il risotto. La Pira era insieme
vicino e distante. Andreotti invece era cinico nella gestione politica. Forlani
un grande gentiluomo, uno degli uomini migliori della Dc. Ricordo quando
rinunciò alla candidatura al Quirinale. Io insistevo perché rimanesse perché
secondo me c’era la possibilità di recuperare i voti dei repubblicani e in più
avremmo recuperato molti dei democristiani andreottiani convinti che Andreotti
non ce la faceva ma Forlani disse seccamente di “no”. Cossiga, persona
coltissima, preparatissima e un grande amore per la classicità, fu sempre molto
apprezzato”.
Qual è stato il momento più
gratificante della sua lunga storia politica?
“L'elezione di presidente del
gruppo sia nel ’78 ma poi soprattutto nel ’92. Il biennio ’92/’94 viene
ricordato solo per Mani pulite, invece fu un periodo di grande importanza perché
preparò l’Italia a entrare nella moneta unica europea”.
Ma come avveniva allora la
scelta dei candidati alla presidenza?
“Le elezioni del presidente
della Repubblica passavano per il voto interno dei gruppi parlamentari
democristiani. Io ero stato eletto da poco, e in genere chi era stato eletto in
prima battuta non prendeva posizione, io invece parlai in aula e parlai a favore
di Moro. Il voto dei gruppi parlamentari veniva fatto nell’aula del nostro
gruppo, e alla fine c’era il controllo fatto dai presidenti dei gruppi, più dai
rappresentanti delle correnti interne e alla fine le schede venivano bruciate”.
A quante elezioni di
presidenti della Repubblica ha assistito?
“Se non ricordo male cinque,
da Leone fino al Napolitano I. Ho fatto parte come presidente del gruppo
dell’elezione di Scalfaro e Ciampi. Durante l’elezione di Scalfaro (’92) la Dc
contava ancora 906 parlamentari, e poi ero presidente del partito (Popolare)
durante la scelta di Ciampi. Qui c’è una cosa che a mio avviso va precisata.
Oggi tutti dicono che la scelta di Scalfaro ci fu a seguito dell’eccidio di
Capaci. Per quello che io ricordo, ci fu certamente una accelerazione, ma la
scelta di Scalfaro era già avvenuta. Era stata fissata la data per la votazione
dopo il ritiro di Forlani”.
E la candidatura di Andreotti?
“Non è mai esistita dal punto
di vista reale. Il voto interno era stato tutto a favore di Forlani. Era stata
ventilata la possibilità di una sua candidatura ma non avvenne niente di
concreto. Anche perché c’era la contrarietà del Partito socialista”.
Craxi lavorava al suo schema…
“Sì. Il presidente della
Repubblica alla Democrazia cristiana, il governo al Partito socialista e la
presidenza della Camera a Napolitano. E ritornando a Scalfaro, lui era anche ben
accetto da parte di Craxi perché ne era stato ministro dell’Interno e molto
vicino a Forlani tanto che quest’ultimo lo sostenne apertamente”.
Nel ‘90/’91 è stato ministro
della Pubblica Istruzione con Andreotti.
“Contro la mia volontà. Io non
volevo andare a giurare, ma mia moglie fu pregata da Forlani”.
Suo predecessore
(democristiano) al ministro della Pubblica Istruzione dall’89 al ’90 fu Sergio
Mattarella oggi presidente della Repubblica.
“Con Mattarella ho avuto
rapporti eccellenti da tutti i punti di vista. Il rapporto è stato poi
eccellente perché io ero presidente del gruppo e lui relatore della legge che
porta il suo nome, il Mattarellum. Nel ’94 io sono diventato segretario del
Partito popolare e lui nel ’96 è eletto capogruppo dei popolari alla Camera. Il
presidente Mattarella lo ricordo come austero, severo, cordiale e amico”.
Quale giudizio conferisce alla
presidenza Mattarella?
“Eccellente. È uno dei più
grandi presidenti della storia repubblicana. Io scherzando ho detto che con
Mattarella si è dissipata la maledizione dei papi sui presidenti democristiani
al Quirinale. Mattarella con la rielezione ha disperso questa cosa. Oggi
possiamo affermare senza ombra di dubbio che Mattarella è entrato tra i grandi
padri della storia e della Dc”.
Tra i grandi padri della Dc,
chi sono stati i migliori politici?
“Svettano De Gasperi e Moro.
Però io vorrei fare una precisazione, la storia della democrazia cristiana non
si scrive sulla storia dei grandi leader, ma la si scrive sulla storia dei
cosiddetti uomini della seconda o terza linea che erano leader locali che
avevano anche una dimensione nazionale. Sono uomini come Fiorentino Sullo,
Giacomo Sedati… nomi che hanno rappresentato la vera classe dirigente
democristiana".
Lei crede nella ricostruzione
di una grande area di centro?
“Vedo un’aggregazione di cose
diverse. Se poi c’è del buon condimento nel dare sapore al minestrone va bene.
Ma insomma, per ora non è quella la strada che può essere seguita”.
Moriremo tutti democristiani?
“Sarebbe bello. Il problema
però è che questa è una cosa passata. Credo però che finiremo per usare il
termine democristiano come discredito, ma la maggior parte dei giornalisti e
scrittori non sa cosa veramente è stata la democrazia cristiana. E mi permetto
di dire che nel discorso del presidente Mattarella, quando lui usa il termine
‘dignità’, ripetendolo una decina di volte, là dentro c’è tutta la cultura del
personalismo cristiano, c’è dentro Maritain, e quella è una grande eredità,
l’importante non è morire democristiani ma preservare la cultura dei cattolici
democratici”.
Federico Bini. (Bagni di Lucca
1992) maturità classica e laurea in legge. Lavoro nell’azienda di famiglia, Bini
srl materie prime dal 1960, come membro del commerciale e delle pubbliche
relazioni. Liberale e un po’ conservatore. Lettera 22 sulla scrivania,
Straborghese, cultore dell’Italia di provincia. Svolgo da quando avevo quindici
anni un’intesa attività pubblicistica e di studio in ambito
politico, giornalistico e storico. Collaboro con diverse riviste d’informazione
e approfondimento culturale. Tra le mie pubblicazioni si ricorda: Montanelli e
il suo Giornale (Albatros editore), Roberto Gervaso. L’ultimo dandy
(L’Universale) assieme a Giancarlo Mazzuca, Un passo dietro Craxi (Edizioni We)
e Una democrazia difficile. Partiti, leader e governi dell’Italia repubblicana
(Albatros editore). Sono stato condirettore del settimanale Il Caffè.
I candidati al Quirinale.
Ritratto di Pier Ferdinando Casini, il bello che a pranzo mangia una mela verde.
Paolo
Guzzanti su Il Riformista il 30 Dicembre 2021. Conobbi Pier Ferdinando
Casini nel ‘99 quando diventai vicedirettore del “Giornale”: mi chiamò per
conoscermi e per pranzare in un ristorante del Centro. Non ricordo che cosa
mangiai io, ma non dimenticherò mai il pasto di Casini: una sola e unica mela
verde, che pelò, tagliuzzò, contemplò, assaggiò a minuscole dosi e che poi si
decise a mangiare come antipasto, primo, secondo, dessert, caffè e ammazzacaffè.
Nient’altro.
Dieta, fisico asciuttissimo,
conversazione esplorativa e riconoscimento reciproco che col passare del tempo
diventò anche una buona amicizia, specialmente quando ci trovammo arrampicati
sulle curve del Gruppo Misto alla Camera. Infatti, erano passati gli anni, io
ero entrato in Senato dove presiedetti la “famigerata commissione Mitrokhin” che
scoprì un po’ più di quello che c’era da scoprire e che fu per questo coperta da
una massa di letame mediatico accuratamente preparato secondo gli usi e costumi
della casa Italia. E non soltanto Italia. Casini a quell’epoca era uno dei tre
alleati del primo governo Berlusconi: con Gianfranco Fini e Umberto
Bossi permetteva al governo di reggere. Le cronache riferivano costantemente di
cene tempestose e rappacificazioni mai definitive perché tutti i contraenti
facevano politica e dunque avevano bisogno come dell’ossigeno di poter emergere
e differenziarsi da Berlusconi senza metterlo in crisi.
Casini fu presidente della
Camera e questa carica e funzione lo abilitano, secondo le regole tradizionali
del Cursus Honorum, ad essere un papabile Presidente della Repubblica. Di fatto
lo azzopparono. Ci fu una volta in cui Berlusconi fu persino costretto ad andare
a presentare le dimissioni dal Capo dello Stato per vedersele respingere e farsi
reincaricare cinque minuti dopo. Erano tutti riti tribali della nuova formula
bipolare in cui la parte che vince governa ma al suo interno si spappola e
l’inventore della formula nonché direttore dell’orchestra si trova continuamente
legato e impacciato. D’altra parte Berlusconi aveva compiuto quel gioco di
prestigio, quel miracolo storicamente irripetibile di vincere le prime elezioni
a cui partecipava, mettendo insieme pezzi che non combaciavano tra di loro:
La Lega Nord antifascista di Bossi al Nord, alleanza nazionale fascista al Sud
con Gianfranco Fini. E poi Pierfi. Lo chiamavano così e io trovavo detestabile
questo nomignolo né credo piacesse a lui ma non c’era niente da fare: Pierfi di
qua, Pierfì di là e Pierfì svolgeva un ruolo importante nell’area democristiana
dove allora si contendevano la leadership il professor Rocco Buttiglione, un
amico papista wojtyliano ma anche amante della logica formale, Cesa e altri
minori.
La Democrazia
Cristiana l’avevo vista rinascere flebilmente per subito rimorire ed ero stato
testimone degli ultimissimi atti quando con Mino Martinazzoli facemmo dei
convegni in qualche vecchio cinema di Roma mentre andava forte il Patto Segni,
con Mario Segni che però non ebbe mai da Martinazzoli la luce verde per fare ciò
che tutti gli italiani si aspettavano facesse: dare la svolta, fare una piccola
rivoluzione che fosse almeno un rimodernamento e aprisse a una destra liberale
sulla quale già aveva messo il cappello Berlusconi perché vedeva che la
situazione della Repubblica era in crisi e che i partiti della prima Repubblica
avrebbero fatto una brutta fine. L’autore della profezia come è noto era stato
il presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che usava riversarmi
confidenze di cui la più solida fu la previsione di quello che sarebbe successo
al nostro paese con la fine della guerra fredda: l’Italia non avrebbe contato
più un accidente, non sarebbe più stata la cerniera tra est e ovest, tutte le
piccole grandi porcherie fatte da democristiani repubblicani socialisti
socialdemocratici, ma anche comunisti missini e radicali e chi più ne ha più ne
metta, sarebbero passate al pettine del supervincitore americano il quale
avrebbe alzato le sue forche e messo sul rogo le sue streghe pur senza farlo
vedere.
Poi cominciarono a cadere le
teste di mani pulite, la celebre operazione americana “Clean Hands” e poi la
gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, il colpo di reni berlusconiano,
la vittoria, il governo, l’avviso di garanzia recapitato dal Corriere della
Sera a Berlusconi al suo primo meeting mondiale, con crollo dell’embrione della
seconda Repubblica, passaggio di campo di Lamberto Dini per un governo tecnico,
palla al centro, elezioni, governo Prodi, poi D’Alema in cabina di bombardiere
sulla Serbia, poi finalmente Berlusconi rivince e dice adesso si gioca tutta
un’altra partita, qui comando io o perlomeno vorrei che voi seguiste le mie
linee. Non ci fu verso, e quello fu il fallimento politico del berlusconismo
nato da una grande idea visionaria, il paese che amo, il rilancio di tutto il
mondo liberale, l’emigrazione dei cervelli comunisti verso Forza Italia guardata
anche da intellettuali schizzinosi come un porto d’approdo e poi un grande
rilancio festoso al quale partecipò anche lui: Pier Ferdinando Casini, che a
casa mia, mia moglie, da quando aveva saputo la storia della mela al ristorante,
chiamava semplicemente il bello. Hai visto il bello, che cosa fa oggi il bello,
stasera in televisione il bello non c’era, e così via.
Poi capitò che ci rivedessimo
tutti a New York al Four Seasons per un saluto frettoloso e la comune vita
parlamentare ci avvicinò man mano. Conobbi così un uomo molto esperto, un non
divo ma non un uomo di abbuffate, al contrario un uomo di diete e di centimetri
molto misurato ma anche capace di invettive. Ricordo il giorno in cui io mi
precipitai dall’America e tutti i senatori e i deputati tornarono dalle loro
vacanze per la improvvisa riunione delle commissioni esteri e difesa nella
grande sala del mappamondo quando la Russia invase la Georgia. Era la prima
volta dalla fine della Seconda guerra mondiale che un paese europeo entrava col
proprio esercito oltre i confini di un altro paese europeo per sottometterlo.
Ricordo Casini pronunciare un discorso di rara energia e rettitudine morale,
senza enfasi chiassosa ma con le idee chiare nella distinzione tra il bene e il
male, il lecito e l’illecito. In quell’occasione anch’io fui molto turbato da
questo evento dal momento che venivo dal tremendo impegno per la commissione
sulle penetrazioni sovietiche in Italia e avevo avuto almeno quattro dei miei
informatori uccisi tra cui il povero Alexander Sasha Litvinenko, ucciso col
polonio radioattivo e che diventò per poche ore la tragica star di tutte le news
del mondo.
Casini è un uomo delle
istituzioni, vicino quanto basta alla chiesa ma non ho mai saputo esattamente
quanto e a chi, è un uomo che sa giocare a scacchi nella vita, conosce le
aperture e le chiusure di tutte le partite senza per questo avere del pelo sullo
stomaco ma una buona punta di cinismo si, la sua cordialità è contagiante e
contagiosa e ogni suo gesto è complessivamente elegante mai fuori misura, mai
volgare anche se Pierfi è certamente un uomo di mondo e anzi di buon mondo.
Tralascio qui volutamente tutti i pettegolezzi, le storie che riguardano la sua
vita personale che all’epoca impegnarono molto giornaletti e giornaloni come
sempre accade, ma devo dire che il vecchio Pierfi mi è sempre apparso come un
uomo non esente da innocenza, ma non per questo un’ipocrita. Per tutta la mia
esperienza l’ho visto stare ragionevolmente dalla parte di ciò che è ragionevole
anche quando ciò che è ragionevole non è per forza il giusto. Come il celebre
personaggio di Totò (“E poi dice che uno si butta a sinistra”), venne il momento
in cui “si buttò a sinistra” e fu quando nel 2016 l’Unione per il Centro di cui
faceva parte, mollò Renzi che “si buttava troppo a sinistra”. Oggi Bossi dice a
mezza voce che secondo lui per questo Casini è papabile e anzi manda un
messaggio a Draghi di cui non si è capito bene il senso.
Nella cabina delle grandi
manovre e sala scommesse, girano vari organigrammi, fra cui quello secondo
cui Draghi deve restare dov’è e Amato deve traslocare in collina, oppure in
collina si trasferisce Pier Ferdinando e allora Draghi dovrebbe stare a Chigi,
altrimenti i tedeschi fanno volare lo spread e ricomincia la caccia grossa sulla
politica italiana. Vai a sapere quanto c’è di vero, però intanto lo spread è
salito. Lui, Pierfi, è sempre aderente alla persona e al personaggio: fu
recuperato per un pelo all’elezione alla camera dove stava per non farcela due
legislature fa, ma poi ce l’ha fatta e ha trovato il suo ecosistema, lo ha
trasformato in giardinetto, ha aperto del report lasciando transitare aria e
persone che la respirano rendendosi disponibile appunto “en reserve”, come le
bottiglie di pregio che una volta o l’altra saranno l’occasione per celebrare
una grande occasione. Sono tempi in cui tutto può essere.
Paolo Guzzanti. Giornalista e
politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della Fondazione Italia
Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza Italia e deputato
nella XVI per Il Popolo della Libertà.
Tommaso Labate per
il “Corriere della Sera” il 6 febbraio 2022.
«Il fronte
politico-istituzionale è un conto, quello strettamente partitico un altro. Io
sono stato impegnato in politica per talmente tanti anni che una cosa l'ho
capita bene. Non ha senso rifare le cose che si sono fatte in passato. Il
centrodestra ha i suoi protagonisti, l'area centrale anche. Se mi mettessi a
rifare le cose che ho fatto per trent' anni, sarei un protagonista consunto...».
Al dodicesimo chilometro della
sua corsa a Villa Borghese, Pier Ferdinando Casini si ferma a prendere fiato. La
settimana di elezioni del Quirinale l'ha consolidato nel rango di «eterno
ragazzo» della politica, un po' come il Festival di Sanremo sta facendo per il
suo concittadino Gianni Morandi. La gente lo ferma per strada, i suoi social
network sono pieni di messaggi di incitamento, la giacchetta è idealmente
sbrindellata da chi la tira da una parte e dell'altra, Silvio Berlusconi lo
incontra, i centristi lo invocano, il centrosinistra lo cerca, si spendono sulla
sua figura un ventaglio di adesivi, «padre nobile», «leader», qualcuno
addirittura «leader spirituale», «figura di collegamento».
È lei il grande suggeritore
del Centro?
«Vede, ho imparato a mie spese
che quello del suggeritore è un destino gramo. Se suggerisci quello che una
persona si aspetta di sentirsi dire, il consiglio viene seguito. Altrimenti no.
Lo sa come ho fatto le volte che una mia figlia mi ha portato un ragazzo a
casa?».
Come?
«Vedevo questi ragazzi due o
tre volte e continuavo a tacere, zitto. E allora lei a chiedermi: "Papà, vuoi
dirmi che ne pensi?". E io niente. Anzi, dicevo: "Se vuoi sapere il mio parere,
me lo devi chiedere cinque volte". Ma sono ed ero consapevole che il modo
migliore per suggerire a una figlia di non frequentare un ragazzo che
eventualmente non ti piace è di non farglielo sapere».
Spostando la lezione sul piano
del centro, se Renzi
«Altolà. Ma lei ha presente
Renzi? È un leader a cui voglio bene, con qualità politiche indiscutibili, che
tra l'altro ha confermato in questa storia del Quirinale. Ma lei ce lo vede
qualcuno nei panni del suggeritore di Renzi? È ovvio che poi fa quello che gli
pare. E lo capisco anche: anch' io, quando ero leader dell'Udc, ascoltavo tutti
ma poi facevo di testa mia».
Si sente «padre nobile» del
Parlamento?
«Se le dicessi di sì, sarei
altezzoso; se le rispondessi di no, mi prenderebbero per ipocrita. Nel corso di
una lunga carriera, in cui ho fatto cose positive e anche errori, ho capito che
alla fine quello che ti resta è la reputazione. Anzi, che la reputazione viene
prima degli incarichi. Mi ha scritto mio figlio in un messaggio che conservo:
"Papà, ci hai insegnato a rispettare sempre tutti, anche i più umili. Oggi hai
vinto senza vincere"».
Anche Berlusconi l'ha
chiamata. Com' è stato ritrovarsi dopo tanto tempo?
«Con Berlusconi ho fatto un
bel pezzo di strada e ho anche litigato. Ma il nostro rapporto umano non si è
mai interrotto. Abbiamo fatto una lunga passeggiata, mi ha detto "sei ancora
giovanissimo", anche se ovviamente non è vero. Vede, per Berlusconi una volta
contava vincere e farlo a ogni costo. Adesso, col passare del tempo, ha capito
che il suo compito storico è quello di unire, di ridurre le divisioni. Il ritiro
della sua candidatura per il Colle credo sia derivato soprattutto da questa
consapevolezza».
Berlusconi era pronto a
sostenerla per il Quirinale, Salvini e Meloni no.
«Meloni l'ha detto con
chiarezza e da subito. Salvini non da subito ma poi è arrivato alla stessa
conclusione: ha preferito Mattarella, a dimostrazione che nella vita non tutti i
guai vengono per nuocere».
Lei ha attraversato tre
repubbliche.
«Per me la repubblica è una
sola. E comunque almeno un altro lo ha fatto senz' altro meglio di me, molto
meglio. Si chiama Sergio Mattarella ed entrò con me in Parlamento nel 1983. La
sua rielezione è una benedizione per il Paese. La democrazia è malata quando la
politica pensa che i tecnici siano inutili ma anche quando i tecnici scalzano
completamente i politici. Facendo un parallelo con l'emergenza della pandemia:
Mattarella è a capo dell'ospedale e Draghi è il primario. Ma nel mezzo di una
piena pandemia non mandi il primario a fare il presidente dell'ospedale. Non
funziona».
Ha anche la stima dei Cinque
Stelle, adesso?
«I Cinque Stelle sono
maturati. Entrando nelle istituzioni, hanno capito che non erano come loro
immaginavano che fossero. Una delle loro figure più importanti, di cui non
faccio il nome, mi ha scritto in una lettera: "Sei la prova della distanza tra
quello che pensavamo della politica e quello che la politica è davvero"».
Il Pd è il partito che l'ha
riportata in Parlamento.
«Alcuni mi hanno sostenuto con
grande calore, altri meno. Sento che qualcuno rimprovera a Franceschini di
avermi sostenuto per il Quirinale con troppo affetto. Vede, da ragazzi io e
Franceschini ci incontravamo nella nebbia del casello autostradale di Ferrara.
Dario mi sosteneva nonostante il ras locale della Dc, Nino Cristofori, fosse
contrario. Questo vale a riprova di quello che le ho detto finora. La politica è
importante. Ma prima della politica, viene sempre la vita».
·
Le Presidenziali.
Il Quirinale e la politica
estera. Terrorismo, deforestazione, epidemie: un solo luogo, molte sfide.
Andrea
Muratore, Federico Giuliani, Mauro Indelicato su inside Over il 24 gennaio 2022.
Quando si parla della politica
estera italiana, vengono in primo luogo in mente due palazzi romani nevralgici
in tal senso: Palazzo Chigi e la Farnesina. Nel primo ha sede la presidenza del
consiglio, nel secondo invece il ministero degli Esteri. É lungo questo asse che
si prendono le scelte più importanti. Del resto la costituzione assegna
unicamente in capo al governo le competenze sulle linee politiche da
intraprendere. La presidenza del consiglio, secondo l’articolo 95 del testo
costituzionale, mantiene “l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l’attività dei ministri”. Il ministro degli Esteri è
poi titolare di tutte le attività concernenti i rapporti internazionali e la
cooperazione. In tutto questo, il Quirinale che ruolo ha? Il Colle ha solo in
apparenza una funzione di mera “rappresentanza”, come indicato dall’articolo 87.
Anzi, proprio la sua funzione rappresentativa spesso ha reso l’istituto della
presidenza della Repubblica attivo nella fase decisionale. In politica estera
non sono mancati nella storia recente presidenti “interventisti”.
Il caso della partecipazione
dell’Italia ai raid in Libia
Quando si parla
di interventismo del Quirinale, il primo pensiero spesso va a quanto accaduto la
sera del 17 marzo 2011. Quel giorno l’Italia festeggiava i 150 anni di unità
nazionale e al teatro dell’Opera di Roma andava in scena il Nabucco diretto da
Riccardo Muti. Erano quindi presenti tutte le più alte cariche dello Stato, a
partire ovviamente dal presidente che in quel momento era Giorgio Napolitano.
Anche su quel clima di festa però incombeva la drammaticità degli eventi in
corso in Libia. Qui da circa un mese erano nate manifestazioni contro il
rais Muammar Gheddafi e Francia e Gran Bretagna premevano per l’intervento.
Anche se non si trattava di un’operazione a guida Usa, da Washington il
presidente Obama aveva già dato il benestare per le azioni militari.
L’Italia con la Libia era legata da un trattato di amicizia stipulato appena due
anni prima. Tra il presidente del consiglio in carica, Silvio Berlusconi, e
Muammar Gheddafi c’era anche un buon rapporto personale. Dalla presidenza del
consiglio arrivava quindi un input per un non intervento. In quella sera del 17
marzo in una sala del teatro dell’Opera Napolitano si è riunito con
Berlusconi, Ignazio La Russa, allora ministro della Difesa, e Bruno Archi,
consigliere diplomatico di Palazzo Chigi. A premere per far partecipare l’Italia
agli imminenti raid in Libia è stato proprio Napolitano. E alla fine la linea
passata è stata quella del Quirinale.
A ricostruire gli eventi di
quella serata è stato nel maggio 2011 il settimanale Panorama. Giorgio
Napolitano ha dato quel preciso input in qualità di comandante in capo delle
Forze Armate e presidente del supremo consiglio della Difesa. Funzioni
attribuite dalla costituzione al presidente della Repubblica, senza però dare a
quest’ultimo ruoli esecutivi. Questi spettano sempre alla presidenza del
consiglio. In un’intervista rilasciata dallo stesso Napolitano a Repubblica l’ex
presidente ha ricordato proprio questo aspetto, dichiarando come la decisione
finale di bombardare Tripoli è stata presa unicamente da Berlusconi. Sotto il
profilo politico però, la linea avanzata dal Colle si è rivelata decisiva. Tanto
che, come ricostruito sempre da Panorama, Barack Obama nel chiedere una
partecipazione italiana ai raid ha chiamato il Quirinale e non Palazzo Chigi.
Soltanto dopo quando dalla Casa Bianca si è alzata la cornetta in direzione
della sede della presidenza del consiglio, allora dall’esecutivo è arrivato il
definitivo via libera. Ad oggi è forse questo l’esempio più calzante su come il
Quirinale può incidere sulla linea estera dell’Italia.
Le linee di indirizzo di
Mattarella al momento della nascita del Conte I
In anni ancora più recenti, un
altro intervento di chiaro indirizzo politico in politica estera è arrivato
anche da Sergio Mattarella. Nel 2018, a seguito di un risultato elettorale da
cui non è uscita una chiara maggioranza, M5S e Lega hanno avviato le trattative
per formare un esecutivo. A fine maggio i giochi sembravano fatti. In
particolare, l’inedita coalizione ha indicato Giuseppe Conte quale nuovo
presidente del consiglio e quest’ultimo ha ricevuto da Mattarella l’incarico. La
nuova maggioranza all’estero ha suscitato sia clamore che perplessità. In Europa
soprattutto i timori erano indirizzati sulle linee antieuropeiste professate in
precedenza dai due partiti. Come stabilito dall’articolo 92, i ministri, su
proposta del presidente del consiglio, sono nominati dal Presidente della
Repubblica. Mattarella non ha accettato la nomina come ministro dell’economia
di Paolo Savona, professore che negli anni precedenti si era mostrato scettico
sull’esperienza dell’Euro. La scelta di Mattarella, che ha provocato la fine del
primo tentativo di Conte di formare un governo (mentre andrà a buon fine, pochi
giorni dopo, il secondo tentativo sempre con Lega e M5S), ha dato un chiaro
orientamento sulla linea dell’Italia in politica estera. E, in particolare,
sulla necessità di rimanere nell’orbita europea senza manifestare scetticismi in
tal senso: “L’incertezza sulla nostra posizione nell’Euro – ha spiegato
Mattarella alle telecamere motivando la sua scelta – ha posto in allarme gli
investitori e i risparmiatori, italiani e stranieri, che hanno investito nei
nostri titoli di Stato e nelle nostre aziende. L’impennata dello spread, giorno
dopo giorno, aumenta il nostro debito pubblico e riduce le possibilità di spesa
dello Stato per nuovi interventi sociali”. L’europeismo di Mattarella non ha
però frenato il Quirinale dal tuonare contro Christine Lagarde e la Bce quando,
nei primi tempi dell’emergenza Covid, l’Eurotower rischiava di consegnare il
debito italiano agli assalti speculativi.
Un altro punto della politica
estera di Mattarella ha poi riguardato l’atlantismo. Il capo dello Stato uscente
ha dimostrato, dapprima velatamente (ad esempio muovendosi per spingere il Conte
I a riconoscere Juan Guaidò come legittimo presidente del Venezuela) e poi con
scelte organiche (dallo scrutinio dei ministri nei governi successivi al
Conte-bis alla chiamata di Mario Draghi) di considerare l’atlantismo altrettanto
importante dell’europeismo come cardine irrinunciabile dello schieramento del
Paese nel mondo. La linea euroatlantica è stata custodita con forza dal
Quirinale e ha avuto in Mattarella un continuatore di Giorgio Napolitano e Carlo
Azeglio Ciampi.
Perché all’estero guardano al
Quirinale
La funzione rappresentativa
dunque non ha mai coinciso con una “ingessatura” del presidente della Repubblica
in semplici ruoli istituzionali. In politica estera il Colle ha più volte detto
la sua, incidendo e non poco sulle decisioni di Palazzo Chigi e Farnesina. Ecco
perché anche all’estero si sta guardando con attenzione in queste ore alle
vicende relative all’elezione del nuovo capo di Stato. Sapere chi andrà al
Quirinale è più che mai importante per le cancellerie internazionali. Anche
perché l’istituto della presidenza della Repubblica ha un vantaggio rispetto al
governo: è di gran lunga l’istituzione più stabile. Mentre nelle sedi della
presidenza del consiglio o del ministero degli Esteri i titolari cambiano nel
giro di pochi anni a causa di una durata media dei governi italiani molto bassa,
al Colle ci si resta comunque vada almeno sette anni. Agganciare il Quirinale
vuol dire poter pianificare rapporti nel medio e lungo termine con Roma.
Il caso dei rapporti con la
Cina
Ne sanno qualcosa a Pechino. I
rapporti italo-cinesi hanno avuto il Quirinale come prima sponda. Agli sgoccioli
dell’esperienza maoista, e pochi anni prima delle riforme di Deng Xiaoping, il 6
novembre 1970 hanno formalmente inizio le relazioni bilaterali tra l’Italia e la
Repubblica Popolare Cinese. Per capire come è sbocciato il seme diplomatico
sino-italiano bisogna tuttavia fare qualche passo indietro.
Ottobre 1955: Pietro Nenni,
all’epoca Segretario Generale del Partito Socialista italiano, è stato ricevuto
da Mao Zedong nella capitale cinese. Nenni ha così posizionato la prima pietra
visibile di un rapporto presto destinato a decollare. Anche perché, nel 1971, il
due volte ministro italiano degli Affari Esteri ha visitato la Cina per la
seconda volta, ricevendo dall’allora primo ministro Zhou Enlai niente meno che
“l’eterna gratitudine del popolo cinese” per l’impegno messo in campo ai fini
del riconoscimento italiano della Repubblica Popolare.
Che cosa era accaduto in mezzo
ai due viaggi? La Cina non faceva parte dell’Onu complice l’opposizione degli
Stati Uniti; l’Italia riconosceva, di fatto, soltanto la Repubblica di Cina,
ovvero Taiwan. Già allora, tuttavia, Pechino considerava quell’isola,
autoproclamatasi indipendente, una provincia ribelle sotto la propria bandiera.
Allo stesso tempo, Taiwan rivendicava la propria sovranità sul territorio della
Repubblica Popolare, spingendo quest’ultima a considerarlo Paese ostile. In uno
scenario del genere era impossibile avere, allo stesso tempo, relazioni formali
con la Cina e con Taiwan. Nel 1969, una volta diventato ministro del governo
Rumor, Nenni ha presentato la proposta per riconoscere la Repubblica Popolare
Cinese. Per l’Italia, era arrivato il momento di aprire definitivamente le porte
al gigante asiatico. Fu così che i due Paesi nominarono i rispettivi
ambasciatori e che Taiwan cessò i rapporti bilaterali con l’Italia. Il 25
ottobre 1971, con Giuseppe Saragat presidente della Repubblica Italiana,
l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto i rappresentanti della
Cina come “l’unico rappresentante legittimo della Cina alle Nazioni Unite”.
Nenni è stato il principale
demiurgo delle relazioni italo-cinesi e ha trovato in Saragat un fautore
della distensione. Le memorie dell’epoca ricordano che la Repubblica Popolare ha
inviato a Roma tale Xu Ming, funzionario del ministero degli Esteri già
vicedirettore del reparto Europa orientale; anche la Farnesina sperava di
spedire oltre la Muraglia un profilo diplomatico, ma ciò non accadde per
scongiurare una possibile reazione avversa di Washington, gli americani,
infatti, avrebbero potuto pensare che l’ufficio commerciale italiano fosse una
sorta di ambasciata. Il terreno era tuttavia preparato. Di lì a poco, Italia e
Cina sarebbero diventate ancora più vicine, fino ad arrivare al marzo 2019, con
la firma tra i due Paesi del MoU (Memorandum of Understanding) sulla Nuova Via
della Seta e l’incontro tra il presidente italiano Sergio Mattarella e quello
cinese Xi Jinping.
Il Quirinale essenziale per la
politica estera
In politica estera il
Quirinale, dunque, prevale sulle altre strutture dello Stato perché, nel mandato
settennale, custodisce la lunga durata in un paese dove la politica resta
fragile nella capacità di domare il tempo. E in quest’ottica si rivela garante
dell’unità nazionale anche nel senso delle questioni geopolitiche e strategiche:
il Presidente della Repubblica ha il potere non codificato di definire la
cornice, il terreno di gioco entro cui lo Stato può muoversi e la diplomazia
agire. La sua moral suasion vale anche all’estero, come moltiplicatore di
potenza per il sistema-Paese nell’ottica di quelle relazioni internazionali che
non vanno confuse con la semplice politica estera ma rappresentano la capacità
di incidere di una figura o personalità in virtù dello standing individuale o
dell’istituzione ricoperta. Logico dunque pensare che un Quirinale sempre più
“geopolitico” troverà il suo inquilino ideale, negli anni a venire, in figure
dal pedigree ben strutturato nel campo delle relazioni in questione.
Qual è il crocevia del mondo
di domani?
Quanto guadagna il
presidente della Repubblica: stipendi e costi del Quirinale.
Redazione su Il Riformista il
24 Gennaio 2022.
In questi giorni verrà eletto
il 13esimo presidente della Repubblica italiana. Il mandato del Capo dello Stato
uscente, Sergio Mattarella, scade il prossimo 3 febbraio ed entro quella data i
Grandi Elettori (1009), riuniti in questi giorni a Montecitorio, dovranno
eleggere il nuovo presidente. Fino alla terza votazione necessaria la
maggioranza dei due terzi dell’assemblea, 673 voti, dalla quarta in poi basterà
la maggioranza assoluta, 505.
Ma qual è lo stipendio
previsto per il Capo dello Stato e quali sono i costi di gestione del Quirinale?
Il Presidente della Repubblica italiana guadagna 239mila euro lordi l’anno. Uno
stipendio da circa 18.300 euro (sempre lordi) al mese, calcolato su tredici
mensilità. Dopo l’elezione avvenuta al quarto scrutinio il 31 gennaio 2015,
Sergio Mattarella ha disposto per se stesso e per tutte le persone che svolgono
funzioni all’interno della presidenza “l’introduzione del divieto di cumulo
delle retribuzioni con trattamenti pensionistici erogati da pubbliche
amministrazioni”.
Per le spese di gestione del
Quirinale ogni anno vengono spesi complessivamente 224 milioni di euro, circa
613,698 euro al giorno, così come emerge dal Bilancio di Previsione 2020
consultabile sul sito Quirinale.it. Oltre la metà della cifra stanziata ogni
anno è destinata al pagamento degli stipendi e delle pensioni del personale che
lavora o ha lavorato al Colle.
Poi c’è ci sono circa 570mila
euro stanziati per il parco auto e altri 200mila per il carburante, oltre alle
spese di luce, acqua, gas e bollette telefoniche. Per la cancelleria ogni anno
vengono spesi 215mila euro mentre altri 170mila per la posta. Altra voce di
spesa sono i costi per intrattenere e accogliere gli altri Capi dello Stato e
questo costa 400mila euro di pranzi e banchetti e 145mila per i regali.
Garage Quirinale, tutte le
auto del Presidente.
Marco Tullio Giordana su La Repubblica il 29 Gennaio 2022.
La Lancia Flaminia 335
cosiddetta “Presidenziale” costruita in 4 esemplari fra il 1960 e il 1961 è la
più bella e ricca di fascino. Ecco storia e aneddoti. La tormentata elezione del
Presidente della Repubblica, dopo che gli spericolati dilettanti allo sbaraglio
avevano rischiosamente tentato di sabotarla, ha strappato Sergio Mattarella
(adorato dal popolo italiano, meno dalla nomenklatura) alla vita privata cui
anelava richiamandolo in servizio. L’increscioso spettacolo offerto da quasi
tutti i leader (con lodevoli eccezioni) deve aver convinto il Presidente al bis,
sperando tutti noi comuni mortali che non sia concesso malvolentieri come può
succedere a grandi attori o musicisti esausti. Il Presidente Mattarella si
rivelerà invece inesausto e buon per noi che torni al Quirinale la sua saggezza
e ferma moderazione.
Fra le tante cose, il
Presidente dovrà scegliere l’auto con cui sfilare fra cittadini cittadini
festanti e politicanti delusi, e per sua e nostra fortuna il garage del
Quirinale offre una fra le più magnificenti delle auto di rappresentanza mai
costruite, ancora in perfetta forma malgrado i sessant’anni e più sul groppone:
la Lancia Flaminia 335 cosiddetta “Presidenziale” costruita in 4 esemplari fra
il 1960 e il 1961. Si tratta di modelli con piccole differenze tra loro,
derivati dalla Flaminia di serie prodotta dalla Lancia fra il 1956 e il 1970,
modello già di per sé opulento e “istituzionale” ma che nel caso della 335 fu
ulteriormente ingigantito e munito di dotazioni uniche da Giovanni Battista
“Pinin Farina, che proprio in quegli anni incorpora per decreto presidenziale il
soprannome infantile diventando Pininfarina tutto attaccata. D’altronde fu
proprio il Presidente Gronchi a commissionare le 4 gemelle pensando alle
imponenti Lincoln americane, alle Rolls-Royce britanniche, alle Mercedes-Benz
tedesche, alle Citroën francesi, e bisogna dire che la nostra Flaminia 335 non
sfigura affatto accanto alle rivali, rappresentando anzi l’epitome della
smagliante salute industriale dell’Italia del boom. La prima a esservi
trasportata nel 1961 è Elisabetta II d’Inghilterra e la sovrana mostra di
apprezzarla al punto da far nascere la leggenda di una quinta Flaminia regalata
alla Corona. Le Flaminia non sono che quattro e tutte ancora in efficienza.
Portano nomi di purosangue, come usava in casa Savoia: due sono in forza al
Quirinale, la Belvedere (targa Roma 454307) e la Belfiore (Roma 454308). La
Belsito (Roma 474229) è in esposizione al Museo dell’Automobile di Torino e la
Belmonte (Roma 454306) al Museo della Motorizzazione militare della Cecchignola
in Roma.
Dopo Giovanni Gronchi
(1955-1962) la Flaminia venne regolarmente usata da Antonio Segni (1962-1964),
Giuseppe Saragat (1964-1971) e Giovanni Leone (1971-1978), rimanendo invece
spenta nel settennato di Sandro Pertini (1978-1985) e Francesco Cossiga
(1985-1992) a favore delle meno esposte (e invece molto blindate) Alfetta,
Lancia Thema, Fiat Croma e soprattutto Maserati Quattroporte. Due esemplari
della terza serie furono donati a Pertini - che l’adorava! -da Alejandro De
Tomaso, allora alla testa del gruppo che deteneva la marca modenese. Nel 2004 la
Maserati, stavolta capitanata da Luca di Montezemolo presidente del Gruppo Fiat,
fece invece dono di una smagliante quinta serie al Presidente Ciampi.
Ridimensionato l’incubo del
terrorismo e di possibili attentati, la Flaminia tornò in auge per merito di
Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999) e da quel momento in poi anche i successivi
presidenti - Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006), Giorgio Napolitano (2006-2015) e
Sergio Mattarella (2015-2022) - hanno sempre voluto utilizzarla sia per la
cerimonia d’insediamento che per la parata del 2 giugno.
Piccolo ricordo personale.
Nell’estate del 2011 stavo girando sulla piazza del Quirinale una breve sequenza
del film Romanzo di una strage. Il Ministro degli Esteri Aldo Moro si recava in
forma privata al Quirinale a bordo della sua Flavia berlina per gli auguri
natalizi al Presidente Saragat. L’azione si svolge nel dicembre del 1969. Moro
era interpretato da Fabrizio Gifuni e la somiglianza, dopo ore di trucco, era
davvero impressionante. L’azione si svolgeva all’esterno ma Fabrizio fu
riconosciuto dal personale del Quirinale, dove suo padre, Gaetano Gifuni, era
stato Segretario Generale sia con Scalfaro che con Ciampi. Ci dissero che il
Presidente era in sede e che ci avrebbe ricevuto. Non perdemmo l’occasione e ci
recammo a salutare il Presidente che, alla vista di Gifuni nei panni di Moro,
rimase piuttosto impressionato.
C’era in quei giorni la crisi
del governo Berlusconi e il Presidente si trovava nel pieno delle consultazioni.
Con sfacciataggine di cui fui il primo a sorprendermi, indicai Gifuni e proposi
di affidare l’incarico a… Moro. Per un istante ebbi la sensazione che il
Presidente, prima di sorridere, si lasciasse sopraffare dalla nostalgia.
Il Quirinale cessò nel 1970 di
essere residenza del Papa per entrare invece nella piena disponibilità di Casa
Savoia. Le sue scuderie trasformate in moderni garage non poterono ospitare le
fastose Mercedes Nurburg 460 che fu l’auto di Pio XI insieme alla Citroën
Lictoria Six e alla Graham Page utilizzata anche da Pio XI. I Savoia li
riempirono invece con le FIAT 2800 e le Lancia Astura che rappresentavano allora
il non plus ultra della produzione italiana, visibili in tanti cinegiornali LUCE
circondate da folle in visibilio per le apparizioni del Duce e di Sua Maestà il
Re e Imperatore. Queste possenti limousine, insieme ad auto meno imponenti, come
le Lancia Aurelia, le Fiat 1400 e 1900, le Alfa Romeo 1900, accompagnarono i
primi nostri primi Presidenti Enrico De Nicola (1947-1948) e Luigi Einaudi
(1948-1955) fino ad arrivare a Gronchi e alla Flaminia 335 che ancora oggi
svolge senza acciacchi il suo prestigioso servizio.
Quirinale, il mondo
bestiale del nostro Parlamento: grillini struzzi, pitonesse e asini. Vi
raccontiamo la giungla.
Melania Rizzoli su Libero Quotidiano il 25 gennaio 2022.
"L'uomo è un animale
politico" scriveva Aristotele in tempi lontani e non sospetti, ma nella storia
contemporanea l'interazione simbolica o metaforica tra mondo animale e mondo
politico non ha mai raggiunto livelli così esagerati come negli ultimi anni, in
cui il Parlamento italiano viene evocato sempre più spesso perla presenza in
Aula di un contesto faunistico da far invidia al più variegato patrimonio
bestiale di un qualunque parco zoologico al mondo.
LA LISTA È LUNGA - L'ultimo
animaletto ad essere avvistato alla Camera dei Deputati è stato lo scoiattolo,
il simpatico roditore che da solo, saltellando di scranno in scranno, è stato in
grado di creare forti tensioni all'interno dei partiti, ignaro però che stormi
di uccelli già da giorni volteggiavano su di lui per cercare di portare cattiva
sorte alla sua segreta operazione, come i gufi, i falchi e i piccioni che gli
hanno tramato contro, senza dimenticare le colombe che insidiavano con finto
candore il premier in carica, oltre a gazze ladre, oche o minacciosi avvoltoi
pronti a scacciare corvi, tacchini sui tetti, anatre azzoppate, struzzi che
nascondevano la testa sottoterra, in un vorticoso, sinistro e surreale sbattere
di ali, minaccioso come nel peggiore incubo di Hitchcock. Questo affollamento
bestiale si rianima e rumoreggia ogni qual volta lo scontro politico diventa più
acceso, in particolare con l'avvicinarsi delle scadenze elettorali, come quella
iniziata ieri del Presidente della Repubblica, la più importante e solenne della
legislatura, ma l'elenco degli animali che hanno trovato dimora nei palazzi
romani della politica è infinito, dal mercato delle vacche al posto d'onore
riservato ai suini, come il famoso Porcellum usato per definire appunto le
presunte 'porcate' votate e legittimate, anche se, quando lo scontro politico
diventa più acceso, oltre ai maiali vengono fatte entrare nell'emiciclo le belve
feroci da non sottovalutare affatto, perché incutono timore e vengono liberate
per sbarrare la strada al cammino delle riforme, come i giaguari da smacchiare,
i caimani da distruggere, i camaleonti da rendere trasparenti, gli sciacalli
affamati e gli oranghi infuriati che distruggono tutto il raccolto appena
seminato. In genere in tali contesti degni di una giungla inesplorata
intervengono i capi dell'esecutivo che, pur sprovvisti di bacchetta magica,
cominciano ad estrarre dal cilindro bianchi conigli o ad introdurre canguri
salta emendamenti, dando la caccia a volpi da spedire in pellicceria, con
l'aiuto di grilli parlanti di collodiana memoria, oltre che di vecchie lumache
lente e sbavanti che tracciano il solco di una legge sulla loro scia
appiccicosa, brillante e spesso salutare. In controtendenza con la loro fama,
tutti questi protagonisti del regno animale terrestre si sono ritrovati a lungo
sulle prime pagine dei quotidiani italiani senza nemmeno saper leggere, buttati
a casaccio, nel marasma politico che emerge nei momenti di crisi, da
parlamentari paragonati a cavalli di razza, a pitonesse, ad aquile strabiche o
leoni da tastiera, al punto che per non vedersi affibbiate sempre le solite
sembianze animalesche, da qualche tempo si è andato a pescare finanche nel
profondo degli oceani, rievocandola gloriosa stagione ittica dei tempi passati,
quando fu eliminata la balena bianca dalle acque del parlamento, l’esemplare più
longevo ed ingombrante, arpionata dai tanti piccoli capitani Achab, gli
stessi che in seguito hanno istituzionalizzato una pesca a rete più popolare ed
economica, meno faticosa e alla portata di tutti, issando a bordo del
transatlantico una fauna ittica meno nobile di Moby Dick, come le trote, le
spigole, le triglie, i tonni, i piranha e da ultimo le famose e numerosissime
sardine, il cui branco di piccoli esemplari ha regalato in realtà poche
soddisfazioni, ovvero poca polpa e tante spine.
FANTASIA ITALIANA - Gli
italiani saranno anche un popolo di inventori, di sognatori e di navigatori, ma
non mancano certo di fantasia, al confronto per esempio degli Stati Uniti il cui
paragone bestiale è limitato all’asino democratico e all’elefante repubblicano,
ma in realtà quando mancano gli strumenti espressivi per dichiarare i propri
dubbi e la cultura per imporre le proprie convinzioni politiche, il ricorrere al
paragone bestiale come fosse una caricatura degli uomini, o una metafora che
tenta di piegare la storia ai propri scopi bestiali, è in realtà una
contraddizione in termini che paragona il mondo animale a quello umano, per
intelligenza e furbizia, come fosse la stessa cosa, dimenticando chela storia,
anche se ha qualcosa che sfugge alla comprensione umana, con il passare del
tempo ribadisce che a forza di essere falsata per motivi ideologici o a vedersi
giustificata al pari degli istinti animali, ridotti a grottesca caricatura degli
umani, perde ogni consistenza ed ogni rilevanza, e per un periodo cessa di
esistere. Salvo poi ribellarsi alla forza della propaganda faunistica, alla
falsa etica e alla labilità della memoria, riuscendo comunque alla fine a
costruire ed imporre un’autentica e duratura democrazia, quella che resterà
negli annali senza ruggire, barrire, ragliare o squittire, e quella che tutti ci
auguriamo in queste settimane, come se lo augurano anche tutti gli amici
bestiali tirati inconsapevolmente dentro il ballo sgraziato della politica
italiana.
Il circolino degli ex
presidenti.
Claudio Brachino il 27 Gennaio 2022 su Il Giornale.
A un passo dal Colle, ma
spesso immolati per il Colle, vicini all'Olimpo laico ma forse troppo vicini e
dunque in un attimo sospinti verso il basso, nel precipizio dei franchi tiratori
e delle mille fluide trattative.
A un passo dal Colle, ma
spesso immolati per il Colle, vicini all'Olimpo laico ma forse troppo vicini e
dunque in un attimo sospinti verso il basso, nel precipizio dei franchi tiratori
e delle mille fluide trattative. Stiamo parlando della seconda e terza carica
dello Stato, i presidenti del Senato e della Camera. Per la statistica sono
stati premiati di più nel Quirinal game quelli della Camera. Dal 1948 ad oggi
cinque di loro sono diventati presidenti, Gronchi, Leone, Pertini, Scalfaro e
Napolitano. Per quanto riguarda il Senato solo due, De Nicola e Cossiga. Però i
loro nomi entrano sempre nella battaglia più complessa e più ambita della nostra
democrazia. Per ragioni istituzionali e per ragioni politiche. Nel primo caso è
una questione di pura forma, di anello nella struttura della Repubblica. Il 3
febbraio, quando scade il mandato di Mattarella, ad esempio, se non sarà stato
trovato un successore, potrebbe diventare capo dello Stato temporaneamente
Elisabetta Casellati, attuale presidente del Senato, voluta nel 2018 da Forza
Italia ed eletta anche dai grillini. Poi ci sono i motivi politici, figure
proposte dalle parti ma spesso votate trasversalmente, per accordi, per balance
maggioranza-opposizione, per questioni di potere all'interno dei partiti e delle
coalizioni. La Casellati, tolto l'aspetto tecnico, proposta di fatto dal
centrodestra al di là dei tre petali di rosa subito sfioriti (c'era anche l'ex
presidente del Senato Pera), è già stata impallinata dal centrosinistra perché
troppo di parte. Almeno finora, nella fluidità delle ore. Nel caso di Casini,
ancora in corsa, fa più notizia l'aver calato la gioventù democristiana nella
piattaforma della contemporaneità, Instagram, ma l'essere stato presidente della
Camera è ancora un punto a favore. La bocciatura più dolorosa fu quella di
Marini, presidente del Senato dal 2006 al 2008 e proposto nel 2013 da Bersani,
Berlusconi d'accordo. Al primo scrutinio l'ex sindacalista venne affossato dai
franchi tiratori, bipartisan. Nella percezione pubblica i nostri eroi sono un
po' come capiclasse di aule spesso indisciplinate, garanti dell'equilibrio
apparente ma capaci sottobanco di fare politica, di muovere la barra del potere
su agende, procedure, regole del gioco. Qualche volta vogliono far dimenticare
le proprie origini e seguono linee ideologiche personal. Riserve della
Repubblica, certo, in senso nobile, ma qualche volta riserve nel senso
calcistico, quando la politica difetta di idee e di campioni. Oppure li ha e non
li usa. Claudio Brachino
Ingresso nell'emiciclo solo con tampone
antigenico negativo di terza generazione. Come si
elegge il presidente della Repubblica: massimo 200 ‘grandi elettori’ per lo
spoglio e ‘catafalchi 2.0’. Riccardo Annibali su Il Riformista il 13 Gennaio
2022.
Per la votazione del presidente della Repubblica
nell’aula di Montecitorio saranno allestiti quattro catafalchi, gli stessi
utilizzati solitamente per le votazioni segrete per schede, ma dotati di
accorgimenti particolari anti Covid tra cui una luce ultravioletta. È stato
deciso, a quanto apprende l’Ansa, nella conferenza dei capigruppo di
Montecitorio i cui lavori sono in corso.
I ‘Catafalchi 2.0‘, attrezzati per l’emergenza
Covid, potrebbero assomigliare di più a cabine che assicureranno la sicurezza
sanitaria, a cominciare dalla ventilazione, e la segretezza. Non è chiaro ancora
se ci saranno dispositivi speciali di disinfezione all’interno. In ogni caso,
sarà necessario disinfettarsi le mani prima e dopo il voto. Per votare i
deputati entreranno cinquanta per gruppo da uno dei due ingressi all’Emiciclo,
usando l’altro per uscirne.
“Far votare i grandi elettori positivi per non
inficiare o indebolire l’elezione del presidente della Repubblica”. È quanto
ha chiesto Fratelli d’Italia, secondo quanto apprende LaPresse, nel corso della
riunione della conferenza dei capigruppo dove si sono discusse le regole
delle votazioni che partiranno il 24 gennaio alle 15. Contrari i capigruppo di
centrosinistra, filtra dalla riunione, che hanno fatto muro. Secondo le stesse
fonti il rischio è che, secondo l’aumento dei contagi da Covid, si arrivi a
oltre 100 assenti per quarantena.
Per lo spoglio la capienza massima è di 200
persone da aggiungere le circa 100 postazioni nelle tribune. È questo
l’orientamento del collegio dei questori di Camera e Senato che si sono riuniti
in vista delle elezioni del Quirinale. L’accesso all’aula di Montecitorio
avverrà dal lato sinistro e per fasce orarie per un massimo di cinquanta grandi
elettori alla volta che dovrebbero avere complessivamente 11 minuti per
esprimersi, poi usciranno ed entreranno gli altri cinquanta.
Complessivamente, tra le fasi di voto e spoglio sono state previste 4 ore e
mezza.
Per quanto concerne il giuramento del prossimo
presidente della Repubblica ci sarà la possibilità per tutti i parlamentari di
stare dentro all’Aula della Camera, mentre i delegati regionali troveranno
spazio in tribuna. Questo perché – viene spiegato – è prevista una durata
ridotta della cerimonia di giuramento, tra i quaranta ed i cinquanta minuti, e
non sono in programma altri interventi se non quello del capo dello Stato. Si
potrà entrare nell’emiciclo solo con un tampone antigenico negativo di terza
generazione, fatto la mattina stessa del giuramento, a Montecitorio o a palazzo
Madama. Riccardo Annibali
Niccolò Carratelli per "la
Stampa" il 25 gennaio 2022.
Alle 15 in punto un'ambulanza
imbocca via della Missione, sotto Montecitorio. Nessuno si è sentito male,
proprio all'inizio delle votazioni per eleggere il presidente della Repubblica.
Dentro l'ambulanza c'è l'ex presidente della Sardegna, ora deputato di Forza
Italia, Ugo Cappellacci.
Da sabato sera positivo al
Covid, ma asintomatico, solo un po' di raffreddore. È pronto a inaugurare il
seggio anti Covid allestito nel parcheggio di solito riservato ai deputati. Non
appena all'interno il presidente delle Camera, Roberto Fico, apre ufficialmente
la seduta, Cappellacci scende dal mezzo sanitario (noleggiato per l'occasione)
ed entra a piedi nel parcheggio. Con lo smartphone gira un video, per
documentare una scena inimmaginabile fino a due anni fa. È lui il primo grande
elettore della storia repubblicana a esprimere la propria preferenza per il capo
dello Stato fuori dalle aule parlamentari.
Ad accoglierlo c'è un
funzionario della Camera vestito come un infermiere di un reparto Covid di un
qualsiasi ospedale italiano: tuta di contenimento, guanti, occhiali, coperto
dalla testa ai piedi.
Primo gazebo, identificazione,
sanificazione delle mani e consegna di guanti protettivi, insieme a una matita e
alla scheda da compilare.
Secondo gazebo, due cabine a
disposizione, dove votare in segretezza.
Terzo gazebo, urna sigillata
dove inserire la scheda.
Dopo circa cinque minuti
Cappellacci esce e risale sulla "sua" ambulanza, proprio mentre un mini suv
grigio arriva alla sbarra di via della Missione. Il parlamentare alla guida
svolta a destra ed entra direttamente nel parcheggio: non scende, abbassa solo
il finestrino, mostra il documento di riconoscimento e ritira la scheda.
Poi prosegue fino a un'area di
sosta, l'abitacolo è il suo "catafalco" personale. Riparte verso l'uscita e si
ferma a metà, per inserire la scheda nell'urna. Il seggio drive-in è realtà.
Nelle successive due ore, almeno altre otto macchine compiono lo stesso giro,
simile a quello che milioni di italiani hanno fatto, negli ultimi due anni, per
sottoporsi a un tampone. Ma non tutti i 17 grandi elettori (positivi o in
quarantena) che si sono prenotati, partecipano alla prima votazione. Alla fine
in 6 non si presentano.
È il caso della deputata del
Misto, ex 5 stelle, Doriana Sarli, che spiega con un post su Facebook di non
essere «nelle condizioni di uscire ed esprimere la mia preferenza». Mentre
un'altra ex del Movimento, la senatrice Bianca Laura Granato, racconta di non
essere «riuscita a raggiungere il seggio per motivi logistici: doversi spostare
con l'auto in zone a traffico limitato è un problema», forse non sapendo che
basta comunicare alla Camera la targa della propria macchina per ottenere il
permesso. Prova a "imbucarsi", invece, la deputata Sara Cunial, nota per le sue
posizioni No Vax e No Pass, bloccata dalla polizia all'inizio di via della
Missione.
Vuole votare nel seggio per i
positivi al Covid, senza un certificato medico che giustifichi la sua richiesta.
D'altra parte, da non vaccinata, le sarebbe bastato un tampone negativo nelle 48
precedenti per entrare e votare in aula. «Il Green Pass, che è un documento
amministrativo, non può subordinare il diritto al voto - ha attaccato - Siamo
pronti a querelare quelli che ci hanno bloccato l'accesso, a cominciare da Fico,
e a invalidare tutta l'elezione del presidente della Repubblica» .
Ecco chi sono i 58
delegati-grandi elettori delle Regioni.
Il Corriere del Giorno il 24
Gennaio 2022.
Tutti i
rappresentanti-delegati delle Regioni presenti a Roma per eleggere il prossimo
presidente della Repubblica. Tra i rappresentanti scelti, la maggioranza è del
centrodestra, poche le donne: solo sei.
I 58 delegati regionali che da
oggi lunedì 24 gennaio hanno indossato l’abito “buono” per vestire i panni dei
Grandi elettori, per eleggere il prossimo presidente della Repubblica, votato
dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione appunto dei delegati
eletti dai Consigli regionali. In totale, i Grandi elettori sono 1.009: 321
senatori, 630 deputati (tra questi c’è anche la new entry Cecilia D’Elia del
Pd scelta alle suppletive di Roma centro che ha preso il seggio della Camera
lasciato libero dal sindaco Roberto Gualtieri) e 58 delegati regionali (tre per
ogni Regione, generalmente due di maggioranza e uno di opposizione, a eccezione
della Valle d’Aosta che ne avrà uno, garantendo anche la rappresentanza delle
minoranze).
Tattiche, sgambetti negli
stessi schieramenti soprattutto nel centrodestra alleanze in bilico. In
Lombardia la Lega ha nominato due delegati mentre il Pd è stato estromesso a
favore del M5S. Cosa che invece non è successa nel Lazio: qui il Pd ha retto
nonostante le insistenze dei grillini che volevano uno dei loro al posto del
secondo dem scelto (oltre a Zingaretti).
Questa la mappa completa dei
58 Grandi elettori designati dalle Regioni. Il centrosinistra arriva a 25
delegati rispetti ai 33 del centrosinistra. Quasi irrilevante la presenza
femminile: solo su 58.
Valle d’Aosta
La Valle d’Aosta, cui secondo
l’articolo 83 della Costituzione spetta un solo delegato, sarà rappresentata dal
presidente della Giunta Erik Lavevaz (Union Valdotaine).
Trentino Alto Adige
Maurizio Fugatti (Lega), Josef
Noggler (Svp) e Sara Ferrari (Pd) sono i tre delegati della Regione Trentino
Alto Adige che partecipano all’elezione del presidente della Repubblica. Li ha
eletti il consiglio regionale lunedì 17 gennaio. Fugatti, presidente della
Provincia di Trento e della giunta regionale, ha ottenuto 33 voti su 61
espressi. Noggler, presidente del consiglio regionale del Trentino Alto Adige e
vicepresidente del consiglio provinciale di Bolzano, ha ottenuto 29 preferenze.
Mentre la dem Sara Ferrari, consigliera provinciale di Trento e consigliera
regionale, ne ha prese 22.
Liguria
La squadra ligure dei Grandi
elettori è composta dal governatore Giovanni Toti, centrista, il presidente del
consiglio, il leghista Gianmarco Medusei, e il consigliere del Pd Sergio
Rossetti.
Piemonte
Il Piemonte ha scelto i suoi
delegati: tutti uomini e due del centrodestra. Si tratta del governatore Alberto
Cirio di Forza Italia, del presidente leghista del Consiglio regionale Stefano
Allasia e dell’ex capogruppo Pd nella passata legislatura Domenico Ravetti. I
tre sono stati votati martedì scorso a scrutinio segreto dal Consiglio
regionale, riunito da remoto, dopo l’annullamento della prima votazione nella
quale era stata registrata una discrasia fra il numero dei votanti e il numero
di voti pervenuti dalle Pec dei consiglieri per lo scrutinio. Cirio ha ottenuto
30 voti, Allasia 28 e Ravetti 16.
Lombardia
La scelta dei delegati
lombardi non è stata così semplice. Il Pd è stato fatto fuori e scelto un
esponente del M5S, una mossa che testimonia quanto l’alleanza tra Pd e 5S sia
sempre in bilico. In quota opposizione, infatti, è stato scelto il
grillino Dario Violi votato soprattutto dal centrodestra. Sconfitto il dem Fabio
Pizzul. Il Partito democratico lombardo con una nota ha parlato di “accordo
sottobanco” per aggiungere quel voto ai sostenitori di Silvio Berlusconi. Ma il
diretto interessato, Violi, ha negato. Alla fine, per Roma partono il
governatore leghista, Attilio Fontana, il presidente del consiglio
regionale Alessandro Fermi (con un passato in Forza Italia e poi passato con
Salvini) e il grillino Dario Violi.
Veneto
Due leghisti e un dem. In
Veneto la scelta dei delegati-Grandi elettori è stata senza sorprese. A votare
il successore di Mattarella, sono il governatore leghista Luca Zaia, il
presidente del consiglio, altro leghista Roberto Giambetti e il capogruppo del
Pd, Giacomo Possamai.
Friuli Venezia Giulia
Il presidente del consiglio
regionale Piero Mauro Zanin di Forza Italia, il presidente leghista della
Regione Massimiliano Fedriga e il dem Sergio Bolzonello dell’opposizione. Sono i
tre grandi elettori del Friuli Venezia Giulia che a Roma, dal 24 gennaio,
parteciperanno alle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica. Tutti i
49 consiglieri eletti (29 di maggioranza, se comprendiamo due dei tre esponenti
del Gruppo Misto, e 20 di opposizione) hanno partecipato giovedì scorso al voto
a scrutinio segreto, che consentiva di esprimere un massimo di due preferenze. È
stato il presidente Zanin a ottenere il maggior numero di consensi (31, più del
totale dei voti della maggioranza), seguito dal governatore Fedriga (27) e
da Bolzonello (16).
Emilia Romagna
Anche la Regione
Emilia-Romagna ha eletto i tre delegati regionali che partecipano a Roma alle
votazioni per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica. La
maggioranza ha premiato le due massime cariche, il presidente della
Regione Stefano Bonaccini del Pd e la presidente dell’Assemblea Emma
Petitti (anche lei del Pd). Il centrodestra ha puntato invece sul capogruppo
della Lega Matteo Rancan. Critiche di Fratelli d’Italia sul voto telematico
avvenuto tramite app (metodo utilizzato per ridurre i rischi di contagio in
aula).
Toscana
Alla fine sono stati scelti il
governatore pd Eugenio Giani (che ha ottenuto 25 voti), il presidente dem del
consiglio regionale Antonio Mazzeo (per lui 27 preferenze) e il consigliere
della Lega Marco Landi (13 voti). Non è stata eletta, ma ho ottenuto due
preferenze la 5 Stelle Irene Galletti.
Umbria
Dall’Umbria sono partiti per
Roma la governatrice leghista Donatella Tesei, il presidente del consiglio
regionale Marco Squarta di Fratelli d’Italia e Fabio Paparelli del Pd.
Marche
A rappresentare le Marche sono
il governatore di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli, il presidente del
Consiglio regionale Dino Latini (Udc) e Maurizio Mangialardi (Pd). Su 29 votanti
il presidente della Regione ha ottenuto 12 preferenze, il presidente del
consiglio regionale 9 ed il capogruppo del Pd 8.
Abruzzo
Tra le pochissime donne scelte
come delegato regionale c’è la grillina abruzzese Sara Marcozzi. Insieme a lei
parteciperanno alle votazioni anche il governatore di Fdi, Marco Marsilio e il
presidente del consiglio regionali, il forzista Lorenzo Sospiri. L’Abruzzo è
stata la prima regione a scegliere i propri rappresentanti già dallo scorso 27
dicembre.
Molise
Il Consiglio regionale del
Molise ha eletto il governatore Donato Toma di Forza Italia, il presidente
dell’Assemblea Salvatore Micone (Udc) e il consigliere Andrea Greco (M5S).
Lazio
A differenza della Lombardia,
nel Lazio tra Pd e M5S alla fine ha vinto il primo. Oltre al governatore
dem Nicola Zingaretti, il futuro presidente della Repubblica sarà votato
da Marco Vincenzi anche lui del Pd. Per il centrodestra all’opposizione è stato
scelto Fabrizio Ghera di Fratelli d’Italia. Il Pd ha retto, nonostante le
insistenze dei grillini che volevano uno dei loro al posto di Vincenzi.
Campania
Sgambetti tra forzisti in
Campania. Sicuro in quota opposizione era stato dato l’azzurro Stefano Caldoro –
sfidante di Vincenzo De Luca alle regionali – ma a sorpresa tra i Grandi
elettori è stata eletta Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in
consiglio regionale che ha fatto sapere che il suo voto andrà al leader del suo
partito, Silvio Berlusconi. Gli altri due Grandi elettori campani sono il
governatore Vincenzo De Luca e il presidente del consiglio Gennaro Oliviero,
entrambi del Pd.
Puglia
I tre grandi elettori pugliesi
sono il governatore del Pd Michele Emiliano che ha ricevuto 31 voti, la
presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone (sempre Pd) che ne ha
ricevuti 30, e il vicepresidente del Consiglio regionale Giannicola De
Leonardis (Fdi) che ha ottenuto 15 voti. Non ci sono state sorprese nel
centrosinistra rispetto alle indicazioni iniziali, mentre nel centrodestra alla
fine ha prevalso la linea di Fratelli d’Italia, primo partito di opposizione
mentre Paolo Pagliaro eletto nella lista civica “La Puglia domani”, ma di fatto
dalla Lega, ha dovuto fare un passo indietro.
Basilicata
Per la Basilicata a
partecipare all’elezione del successore di Mattarella saranno tre uomini, due
del centrodestra e un democratico. Ossia: il governatore forzista Vito Bardi, il
presidente del Consiglio regionale il leghista Carmine Cicala e Roberto
Cifarelli, quest’ultimo consigliere regionale in quota Pd.
Calabria
Dalla Calabria la schiera che
voterà il nuovo capo dello Stato è tutta maschile. I tre delegati indicati dal
Consiglio regionale per partecipare all’elezione del presidente della Repubblica
sono il presidente della giunta Roberto Occhiuto di Forza Italia, il presidente
del Consiglio Filippo Mancuso (Lega) e il consigliere dell’opposizione e
capogruppo del Pd Nicola Irto. Un riconoscimento del partito a Irto, che fu
fatto fuori nella corsa a governatore.
Sardegna
Per la Sardegna ci sono i
presidenti di Giunta e Consiglio regionale, Christian Solinas (Psd’Az) e Michele
Pais (Lega), e il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau.
Sicilia
L’Assemblea regionale
siciliana ha eletto il presidente Nello Musumeci (Diventerà Bellissima), il
presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè di Forza Italia e Nunzio Di Paola (M5S).
Quei leoni del Nord
consumati dalla politica.
Gabriele Barberis il 26 Gennaio 2022 su Il Giornale.
C' è una nota di dolcezza
struggente nella sguardo di Umberto Bossi, il vecchio Leone del Nord che si è
rivisto alla Camera per le elezioni del presidente della Repubblica. Vale un
romanzo la toccante immagine in bianco e nero che ha postato sui social il
giornalista Massimo Maugeri: il Senatùr sulla sedia a rotelle salutato con
affetto da Pierluigi Bersani nel cortile di Montecitorio.
Bossi in privato poteva
stupire per bonarietà e timidezza, ma in realtà era il Barbaro spaventoso che si
era mangiato la Prima Repubblica con picconate che avevano sbriciolato Dc e Psi.
Nella foto con Bersani fuma seraficamente il sigaro, con la rassegnazione
dell'anziano fuoriclasse escluso dai giochi che è già passato alla storia e non
ha bisogno di affermarsi per il presente. Il fondatore della Lega ha 80 anni,
mentre l'ex segretario Pd Bersani ne ha dieci di meno. Eppure anche lui si è
ritagliato il ruolo della vecchia gloria, sopravvissuto ai veleni dei
democratici e all'emorragia cerebrale che lo colse nel 2014. Prima di infilarsi
in una deriva anti berlusconiana e di veterocomunismo di ritorno, il deputato di
Leu aveva incarnato il moderno ministro riformista, in sintonia con il Nord,
produttivo che sfornava privatizzazioni e liberalizzazioni. Ormai recita il
ruolo del saggio rispettato a destra e mal tollerato tra i dem, e ha già
annunciato che non si ricandiderà a fine legislatura. Entrambi, Umberto e Pier
Luigi, hanno indossato le maschere popolari della Seconda Repubblica tra battute
feroci e un gramelot linguistico intriso di sfumature padane.
A sinistra Bersani è passato
inosservato, sopportato come un soprammobile ereditato da faide interne che
hanno visto in pochi anni la fuoriuscita dal Pd di tre segretari (D'Alema e
Renzi i compagni di disavventure). Un brontolone fuori dal dibattito che al
massimo può regalare un titolo brillante agli intervistatori. Invece nel mondo
leghista il rientro di Bossi è stato vissuto con emozione, una macchina del
tempo che ha riportato tutti a vent'anni fa, quando Salvini era un giovane
consigliere comunale senza felpa e senza barba. Ieri mattina il Senatùr ha
coronato il suo dissestato percorso interno alla Lega negli ultimi anni con una
standing ovation che l'ha commosso. E per induzione i delegati leghisti sono
esplosi in un applauso fragoroso per Silvio Berlusconi, la tessera numero uno
esterna della Lega, l'alleato di ferro che faceva ingelosire Fini per il suo
rapporto strettissimo con Bossi, Calderoli e Maroni. Tanto che all'epoca si
diceva malignamente che la sede del governo non era Palazzo Chigi bensì Arcore,
con le cene del lunedì sera. Anche il Cavaliere è fuori dalla partita del
Quirinale, ma il Carroccio 4.0 di Salvini l'ha inserito di diritto nel Pantheon
verde. Bisogna sempre guardare in avanti, ma alla fine non è così triste
soffermarsi su un'istantanea in bianco e nero. La sottile differenza tra il
ricordo e il reducismo.
Gabriele Barberis.
Caporedattore Politica, Il Giornale
(ANSA il 26 gennaio 2022) - In
un Transatlantico anche oggi affollato e con i finestroni spalancati per far
circolare l'aria, ci sono ripetuti siparietti tra grandi elettori che si
salutano e si fanno dei selfie insieme. Pierferdinando Casini, indicato tra i
possibili papabili per il Quirinale, è andato a salutare il fondatore della Lega
Umberto Bossi, in sedia a rotelle ma finora sempre presente ai tre scrutini;
immancabile la foto della stretta di mano. Anche l'ex premier Mario Monti ha
salutato Bossi, così come diversi delegati regionali.
LA PAZIENZA DI UMBERTO
BOSSI.
Maurizio Crippa per “il Foglio” il 26 gennaio 2022.
Se i cronachisti umorali della
Repubblica, quelli che compilano schede biografiche come fossero sentenze,
avessero avuto (avessero sempre, come norma assoluta) un po’ di pazienza, cioè
intelligenza, non avrebbero dovuto ieri ricredersi, o fare finta di niente.
Ieri, quando il vecchio
Senatùr Umberto Bossi, malandato ma col sigaro tra i denti, che da quasi tre
anni non si muoveva da Gemonio, s’è fatto spingere in carrozzina fino a
Montecitorio, la cravatta verde, la pochette verde. Per votare il presidente
della Repubblica.
Lui che dalla Repubblica
voleva secedere, lui che aveva 300 mila insorti su nelle valli contro Roma
ladrona. Invece ieri Bossi era lì, facendo uno sforzo sanitario senz’altro più
ingente di quello non fatto dalla no vax come si chiama, e uno sforzo politico
maggiore di tante burbette alla prima chiama, per quella Repubblica contro cui
ha sempre alzato il vocione.
A chi gli chiedeva pronostico,
ha detto furbo che “Draghi è un nome che può uscire alla fine”. E a chi gli
chiedeva del suo amico-nemico-amico, ha disegnato col sigaro un lampo
d’intelligenza: “Berlusconi ha una grande dote, è un uomo coraggioso, ma la dote
che gli manca è la pazienza”. Politico di razza.
7 anni di Mattarella sui
social: poco successo, ma tanto rispetto.
Piero de Cindio su Il
Riformista il 26 Gennaio 2022.
E’ finito ufficialmente il
percorso di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. L’ultimo
inquilino del Quirinale ha iniziato il suo mandato nel 2015 e, secondo
un’analisi del data journalist Livio Varriale, le parole Quirinale e Mattarella
hanno generato solo su Twitter 1.941.995 tweets, 14.517.195 mi piace, 4.395.844
condivisioni, 377.696 citazioni e 1.674.199 commenti.
All’interno di questo schema,
la parola Mattarella è comparsa in 1.412.660 tweets mentre Quirinale 654.203.
Il trend del presidente della
repubblica negli anni ha raggiunto il maggior coinvolgimento nel 2018 come da
grafico ed è singolare come questo anno sia stato migliore degli anni della
pandemia.
2018 è stato l’anno di
Mattarella
Nel 2018, gli argomenti che
hanno fornito maggiore visbilità al Presidente della Repubblica sono stati: le
Consultazioni che hanno portato al primo Conte con Salvini al Governo e la
polemica con Luigi Di Maio per l’affaire Savona, non gradito all’Europa, su cui
si scatenò la furia incrociata sui social dove si invocava il processo al
Presidente per attentato alla Costituzione. In questo stesso anno, iniziano a
scoppiare le prime le prime polemiche sugli immigrati che hanno portato alla
caduta di Salvini nell’anno successivo.
Nel 2019 e nel 2020 è emerso
un lato di Mattarella dissacrante sia in forma diretta che indiretta. Nell’anno
pre Pandemia, il tweet con più condivisioni e preferenze è stato di un utente
francese che ha raccontato come “Trump lo abbia chiamato Mozzarella e non
Mattarella”
Nel 2020 invece ha fatto
sorridere la gaffe della diffusione di un video istituzionale ai media dove il
Presidente della Repubblica lamentava la scompostezza dei suoi capelli nel
messaggio alla nazione durante il lockdown. Un evento questo, il cui dubbio
sulla sua genuinità resta ancora in piedi, che ha aumentato la popolarità del
presidentissimo, a seguito di un messaggio di scuse del profilo Twitter
ufficiale del Quirinale ed è il post social più gradito di tutto il settennato.
Sono del 2020 gli altri due
post che hanno dato lustro a Mattarella nel mondo virtuale: quello di Ivana
Trump che si congratulava con la moglie del Presidente per l’accoglienza
ricevuta in occasione del g8, più la nota del Quirinale in piena pandemia. Nel
2021, invece, la convocazione di Draghi al Quirinale ha scaldato il popolo della
rete.
Chi sono i politici più citati
insieme al Presidente?
N° Tweets
Mattarella – Salvini
106233
Mattarella – Conte
96053
Marratella – Renzi
74401
Mattarella – Draghi
43361
Mattarella – Meloni
23843
Marratella – Berlusconi
19933
Mattarella – Speranza
9050
Mattarella – Calenda
4389
Mattarella – Letta
3623
Matteo Salvini e Giuseppe
Conte sono i leader di partito più presenti nei tweets dove è stato citato in
questi sette anni il presidente Mattarella. Il peggiore di tutti è Enrico Letta,
superato persino da Calenda, mentre Draghi in un solo anno è già nel mezzo della
classifica.
Secondo Google Trends,
l’interesse del pubblico per il Presidente è stato nella fase iniziale del suo
mandato e nel 2018 come già ampiamente riportato. Sicuramente è stato maggiore
rispetto al Quirinale ed è curioso notare come l’Abruzzo sia la regione che ha
cercato di più su Internet Mattarella, mentre la ricerca più frequente è stata
“discorso di Mattarella”, riferito al messaggio di fine anno.
Secondo l’autore della
ricerca, Livio Varriale, “l’analisi ha evinto che Mattarella non è stato un
presidente social, nonostante la pandemia gli abbia generato intorno maggiore
consenso senza convertirlo in successo “di immagine”. Negli anni trascorsi con
lui alla guida, c’è da evidenziare che il Presidente della Repubblica seppur non
sia di alto interesse, resta una figura rispettata dalla popolazione e la
solidarietà espressa nel 2018 ne è stata la prova”.
Piero de Cindio. Esperto di
social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format
Fabrizio Roncone per
il Corriere della Sera il 26 gennaio 2022.
L'incarico: trovare un peone
qualsiasi, farsi raccontare come lo trattano, lo schifo di giornate che sta
vivendo qui a Montecitorio, tenuto all'oscuro, grande elettore per modo di dire,
per lui solo comandi bruschi, costretto a votare come gli ordinano i capi via
WhatsApp (finora: sempre scheda bianca; infatti poi alcuni s' infilano nelle
cabine e, per sfregio, scrivono Claudio Baglioni o Nino Frassica).
Lo sguardo scivola sul
Transatlantico e giù nel cortiletto: bolgia anche in questo secondo giorno, si
fuma ovunque, mascherine abbassate, chiacchiere, la candidatura di Mario Draghi
al Quirinale perde quota, Renato Brunetta l'unico che lo difende platealmente.
Sì, ma i peones? Eccone un gruppetto.
Questo con le mani in tasca è
Mario Acunzo da Battipaglia. Ex 5 Stelle: cacciato perché non versava i soldi al
Movimento. Arrotonda facendo l'attore nella fiction di Rai 1 «Il commissario
Ricciardi». Ma Acunzo non parla (è disperato: fece l'errore di dire che avrebbe
voluto Berlusconi al Quirinale).
Questa invece è Carmela «Ella»
Bucalo da Barcellona Pozzo di Gotto, di anni 58, Fratelli d'Italia: ieri si
scattava selfie di ricordo. «Decide tutto Giorgia, certo: ci mancherebbe». Un
giovane cronista ha già battuto il terreno: «Con la Granato, perdi tempo. Puoi
provare con Ciampolillo, ma lo sai anche tu che è un po' banale. Le grilline
sono diventate furbe, annusano il pericolo, sono reticenti».
Poi passa Sergio Battelli.
«Come mi ha chiamato?». Peone. «Guardi che io mica mi offendo». Ma infatti io
non intendevo offenderla. «Peone ero quando entrai nel 2013, peone mi sento».
Sì, ecco: Sergio Battelli di anni 39, grillino genovese, può funzionare. È amico
di Luigi Di Maio, però questo non sposta di un centimetro la sua condizione di
bracciante della politica. Battelli, tra qualche tempo, sarà materia di studio:
licenza media, un decennio trascorso a lavorare come commesso dentro un negozio
di animali. Cucce, croccantini, guinzagli.
Poi l'apparizione di Beppe
Grillo sulla porta d'ingresso. Due clic, parlamentarie e, nel 2013, si ritrova
qui: deputato. Circa 14 mila euro accreditati sul conto corrente. Ogni mese. Per
la tragica regola imposta da Gianroberto Casaleggio dell'«uno vale uno», nel
2018 lo nominano pure presidente della commissione Affari europei. «Se devo
essere trattato male...».
Guardi, è cronaca. «Okay: cosa
vuol sapere?». La sua giornata. «Mi sveglio, faccio colazione, mi vesto...»
(tipo simpatico, veloce, ha imparato le regole del gioco: ma sul vestire non ci
siamo. Indossa un abito di lana a quadratini e un maglione nero a collo alto).
State eleggendo il nostro
nuovo presidente della Repubblica: non pensa di essersi presentato vestito come
per un brunch al lago? «Lei pensa?». Penso che tra il suo maglione e la
grisaglia di Aldo Moro possa esserci una decorosa via di mezzo. Parliamo di
queste votazioni. «Vengo qui in anticipo. Parcheggio il monopattino ed entro.
Oggi ho mangiato un panino al volo alla buvette. Poi aspetto che arrivi il mio
turno di voto parlando con i miei colleghi, immaginando soluzioni, scenari».
Siete preoccupati? «Senta: se
a Palazzo Chigi venisse giù tutto, o perché Draghi sale al Colle, o perché al
Colle magari ci va un altro e Draghi si stranisce e molla, il rischio di andare
a votare è chiaro che esiste. E io, che come Di Maio sono al secondo mandato,
per le attuali regole del Movimento dovrei tornarmene a casa. Ma le assicuro che
non mi ammazzerei di certo se dovessi lasciare questo luogo, la politica. E
poi...».
Poi? «Mi sono sempre saputo
reinventare. Anche stavolta troverei qualcosa per campare». Tipo? «Mi piace la
musica. Suonavo, so incidere, potrei buttarmi nella produzione discografica».
Squilla il cellulare: sul display comincia a lampeggiare la scritta «Luigi Di
Maio». Allora Battelli mette su uno sguardo che tiene insieme imbarazzo e fretta
(è noto che Di Maio s' infuria se non gli rispondono entro il secondo squillo;
il suo ragionamento dev' essere, più o meno, questo: ma come, io sto qui a
faticare per voi, a combattere con Letta zio e Letta nipote, a parlare con
Salvini e ad ascoltare persino Conte, e voi fate salotto?). Così Battelli s'
allontana. Ma, tenendolo d'occhio, eccolo poi che passetto passetto torna subito
ai divanetti, dove lo aspettano. «Allora, Giggino che dice: butta male?».
Peones.
Fabrizio Roncone per
il “Corriere della Sera” il 30 gennaio 2022.
È il rosario che aspettavano.
« Mattarella... Mattarella... Mattarella... ». Cortiletto di Montecitorio, lo
spoglio in diretta sui maxischermo. Nel riverbero giallastro dei lampioni, loro.
I vincitori. Sta finendo come volevano. Fanteria parlamentare all'ultimo
bivacco.
Occhiate di purissima allegria
sotto le mascherine, febbrile eccitazione: «Siamo già a 348 voti! Eh eh...».
Seduti in circolo, pregustano
la certezza di poter trascorrere un altro anno abbondante dentro questo potere e
questo lusso, certi qui e gli altri a Palazzo Madama, ma tanto un Transatlantico
vale l'altro: l'importante, per la maggior parte di loro, è continuare a
camminare nei corridoi con il velluto rosso alle pareti, i marmi che
risplendono, i lampadari sempre accesi come nemmeno a Versailles e un
bell'accredito sicuro sul conto corrente. « Mattarella... Mattarella...
Mattarella... ».
Ha ripreso colorito Mario
Acunzo da Battipaglia, ex 5 Stelle, quello che per arrotondare recita nella
fiction di Rai 1 «Il commissario Ricciardi» e che pensava di aver fatto un
casino ammettendo di volere Berlusconi al Quirinale.
Ecco pure Alviso Maniero, un
altro gigante del gruppo Misto che, quando lasciò il Movimento, paragonò Davide
Casaleggio a Kim Jong-un. Ma lo spettacolo più tragico è stato assicurato, ogni
giorno, da molti di quelli che sono rimasti grillini. Paura battente. Animi
sanguinanti.
Eccoli qui, i conti
cimiteriali ancora in tasca: con un voto elettorale anticipato, un po' per il
calo dei consensi, un po' per la contrazione dei seggi prevista dalla nuova
legge, due terzi di loro non sarebbero stati rieletti.
Così l'arrivo di Luigi Di Maio
è stato sempre accolto con inchini e sospiri. Lui incedeva offrendo il suo corpo
rassicurante, distribuiva carezze, blandiva, state tranquilli, non può
succedervi nulla. Tiziana Ciprini e Luca Frusone, Paolo Parentela e Marta
Grande. «Giggino, siamo nelle tue mani».
«Giggino, che Dio ti
benedica». Una fatica bestiale. Adesso giacciono stremati sulle panchine. Passa
Daniela Santanché avvolta in un giaccone maculato (che potrebbe essere di
leopardo finto ma anche vero, cacciato appositamente per lei). Li osserva
schifata: «Hanno pensato solo a cadrega e portafoglio».
Occhiate feroci per lei e per
quelle altre che la poltrona comunque non l'avrebbero rischiata: la Ravetto, con
le sue borse firmate che costano come l'annualità di un metalmeccanico; oppure
la Boschi, ormai definitivamente altera e lassù, distante, tra una copertina di
Chi e la promessa di tornare, prima o poi, a fare il ministro. «Mattarella...
Mattarella... Mattarella...» .
Sbuffano in un miscuglio di
stanchezza e soddisfazione pure certi leghisti. Perché anche da quelle parti:
calcoli malevoli. Con gli attuali sondaggi, un voto anticipato avrebbe prodotto
almeno 70 seggi in meno, tra Camera e Senato. E però vedevano il capo piombare
di corsa, stravolto. Salvini entrava, votava, spariva. Due ore dopo annunciava
cinquine, terne. Pera, Moratti, Nordio. Un pomeriggio è andato a casa di Sabino
Cassese.
Nel frullatore ha messo
Giampiero Massolo e Franco Frattini. Poi ha mandato a sbattere la seconda carica
dello Stato, Maria Elisabetta Casellati. Infine, la tombola: candidando
Elisabetta Belloni, il capo dei servizi segreti. Così i leghisti - preoccupati -
erano spesso accucciati accanto all'Umbertone Bossi: seduto sulla sedia a
rotelle, il sigaro acceso, faceva segno di no, non andrà come «pensa quello lì,
state calmi». I governatori Fedriga e Zaia, muti, sgomenti, di cera.
«Mattarella... Mattarella... Mattarella...». Sul tabellone luminoso siamo a 487
voti.
C'è ancora il tempo di
ricordare la visita pastorale di Giuseppe Conte, che Rocco Casalino, l'altro
giorno, ha deciso di trascinare qui. «Devi venire perché sei tu, fino a prova
contraria, il capo del Movimento... Non possiamo lasciare i gruppi nella braccia
di Di Maio». Solo che Conte lisciava, non riconoscendole, le sue pecorelle
grilline: e così il panico diventava totale.
«Questo non sa nemmeno chi
siamo, porcaccia miseria!». Ma Conte aveva altro, in testa. Per dimostrare
d'essere il miglior alleato riformista possibile del Pd, si stava accodando a
Salvini, che voleva dare all'Italia una guida tipo quella di Abdel Fattah
al-Sisi in Egitto. Giornate penose per tutti. Potete recuperare sui social le
immagini di euforica liberazione con cui il pattuglione del Pd, nella sala del
Mappamondo, ha accolto la notizia che al Quirinale sarebbe rimasto il vecchio
Presidente.
Anche tra i dem serpeggiava il
dubbio: lo sapete, sì, che se Enrico dovesse rifare le liste elettorali, almeno
la metà di noi tornerebbe a casa? Poco fa, Matteo Renzi se ne è andato seguito
dalla sua guardia d'onore (per qualche ora, al mattino, ha provato a piazzare
Casini: che, annusato il colpaccio, da meraviglioso democristiano soffiava ai
peones: «Fratelli, non smarrite la strada, che siamo vicini...». E quelli: «Ha
svalvolato?». « Mattarella... Mattarella... Mattarella... ». Ci siamo: 503, 504,
505. Quorum. Abbiamo il Presidente. Applauso lungo e forte (ma è rivolto a lui,
o a loro stessi?)
Fabio Martini per “La Stampa”
il 30 gennaio 2022.
Oramai le riflessioni di Rino
Formica somigliano ad aforismi politici: «A noi ci hanno "salvato" i peones!».
Sarebbe a dire?
«Sarebbe a dire che in
Parlamento c'è stata una disperata rivolta degli autoconvocati: la loro
sopravvivenza di parlamentari ha coinciso con la sopravvivenza del potere
democratico e del Parlamento! Molti di loro forse neanche lo sanno che hanno
battagliato per la democrazia. Per la prima volta abbiamo assistito ad un
attacco del potere esecutivo al potere di garanzia, rappresentato dalla
Presidenza della Repubblica e al potere legislativo».
Classe 1927, già ministro
socialista, Rino Formica ha iniziato a far politica nel 1944 in casa Laterza a
Bari, un giorno che da lì passò Benedetto Croce e da allora non ha più dimesso
la passione per la cosa pubblica.
Ventinove gennaio 2022: al
netto della retorica che oramai accompagna ogni evento, che giorno è stato?
«E' tornato al vertice della
Repubblica un presidente forte di suo come Mattarella e alla presidenza della
Corte Costituzionale abbiamo un democratico come Giuliano Amato. Due personalità
che rappresentano una garanzia per le istituzioni. Nessuno dei due ha però una
forza reale come quelle che si muovono fuori dal Parlamento».
Perché tanto allarme
democratico?
«In queste settimane si è
consumato uno scontro tra chi voleva mantenere l'equilibrio dei poteri previsto
dalla Costituzione e chi voleva cambiarlo a Costituzione invariata».
Draghi?
«Il sistema dell'informazione
quasi non se ne è accorto: ma quando mai palazzo Chigi e il suo leader sono
stati il centro dell'organizzazione politica? Mai l'istituzione si era fatta
partito. Neppure quando la Dc aveva il 40 per cento».
Ma si è trattato di
un'ambizione personale
«Appunto l'ambizione di un
"partito personale"».
Draghi non ha mai mostrato di
avere ambizioni partitiche o politiche in senso stretto, non le pare?
«Peggio. Ambizioni di potere.
Ancora più pericolose. Se avesse fondato un partito, benissimo. Monti non era
pericoloso: ci ha provato e non è andata bene. Ogni tanto si alza in Senato e fa
il cigno: io ne sapevo più di voi».
Per qualche mese il governo
sarà più forte?
«Nei prossimi mesi vengono al
pettine nodi politico-sociali inediti. Si svolgerà il referendum sulla
giustizia: nella campagna elettorale saranno coinvolte milioni di persone,
toccate direttamente da problemi di giustizia civile, penale, tributaria».
Il governo resisterà un anno?
«Un anno di governo reale non
c'è. Fra sei mesi siamo in campagna elettorale, comunque. Ecco perché mi fa
ridere il "patto di legislatura"».
L'ammaccato Salvini di queste
ore non aspetta altro che tornare libero a scorrazzare?
«Per forza. Con una aggiunta
che le anticipo».
Sarebbe a dire?
«Che quasi nessuno dei
ministri draghiani sarà candidato nel proprio partito. Non Brunetta e neppure le
donne di Forza Italia. Ma anche quelli del Pd rischiano tranne Orlando che ha
una sua componente. Non parliamo poi di quelli della Lega»
Forza Italia si renderà
disponibile per un'alleanza di centro-sinistra?
«Forza Italia non può che
avere una posizione liberale. Per necessità. Mediaset produce informazione, non
scarpe. E quando si arriva al dunque, gli interessi da tutelare non sono
industriali, perché Berlusconi ha bisogno del pluralismo delle idee come
imprenditore. Sulla candidatura Belloni una posizione liberale è venuta proprio
da Forza Italia».
Sul tema si è esposto Renzi,
da lei mai risparmiato
«E invece dico: viva Renzi! Ha
detto l'abc. Dopo 75 anni di vita democratica, ma come caspita si fa a pensare
che si passa dalla guida dei Servizi alla guida dello Stato senza un "lavaggio
elettorale?»
L’impossibile segreto. Le
regole per eleggere il Capo dello Stato e il culto idolatrico della trasparenza.
Carmelo Palma su L'Inkiesta il 28 Gennaio 2022.
I padri costituenti non
potevano immaginare che i mass media avrebbero racconto in tempo reale la scelta
del presidente della Repubblica. Chi corre per il Quirinale dovrebbe candidarsi
o essere candidato in modo ufficiale, spiegando in Parlamento le ragioni della
scelta.
Non so come andrà a finire tra
qualche ora o tra qualche giorno l’elezione del Capo dello Stato e su chi finirà
per ricadere la scelta dello Spirito Santo che, per previsione costituzionale,
soffia sul collegio quirinalizio.
Rimane comunque l’impressione
che neppure se uniformate a quelle del conclave dei cardinali per l’elezione
papale – tutti chiusi dentro e nessuno parla con l’esterno – le regole
dell’elezione presidenziale potranno mai più resistere al pervertimento del
mondo in tempo reale e dell’interconnessione globale, delle dirette permanenti e
del pedinamento dei grandi elettori, delle indiscrezioni e dei depistaggi.
D’altra parte, se le notizie
ormai trapelano più o meno in diretta pure dalla Cappella Sistina quando c’è da
scegliere un nuovo Papa, non c’è da illudersi che il segreto, che la Carta
vorrebbe precedesse la fumata bianca sul nuovo Capo dello Stato, sia custodito
da mille grandi elettori o da dieci capi partito, abituati a vivere in diretta
Facebook e la cui esistenza e potenza politica è certificata in primo luogo
dalla ubiquità mediatica.
Se le regole istituzionali per
funzionare devono comunque adattarsi al modo con cui la realtà retroagisce su di
esse, deformandole o conformandole ai propri paradigmi, i meccanismi di
un’elezione tanto importante dovrebbero tenere conto della potenza e della
pervasività di un apparato mediatico, che i costituenti non potevano neppure
immaginare. Un’elezione segreta non è più compatibile né con la tecnologia, né
con la cultura del sistema e della società dell’informazione.
La segretezza delle trattative
per la scelta di un Capo di Stato confligge in primo luogo con il culto
idolatrico della trasparenza, la cui diffusione dimostra di per sé
l’irreversibile confusione concettuale e pratica tra le categorie del politico e
quelle del mediatico e suscita l’illusione che la controllabilità del potere e
dei potenti sia legata alla loro perpetua esposizione pubblica, come se questa
non fosse già un prodotto, un mezzo di persuasione, prima che un oggetto di
conoscenza, un far vedere, prima che un vedere.
In ogni caso, se pure si
volesse eroicamente resistere all’idea che la difesa della democrazia passi da
uno streaming ininterrotto di chiacchiere e distintivi, rimane il fatto che per
sua stessa natura la politica non ha più un dentro che non sia anche un fuori,
cioè non ha più materialmente la possibilità di custodire alcunché in un
segreto, che per esistere, per rilevare, per fare consenso, per stabilire chi ha
vinto e chi ha perso, deve essere raccontato.
Di fronte a tutto, perché
l’inconciliabilità dell’elezione presidenziale non rimanga una causa di
ulteriore opacità e sospetto sui movimenti e sulle intenzioni dei politici (per
definizione sordide, come vuole la vulgata) sarebbe di gran lunga preferibile
che quella per il Quirinale venisse trasformata in una vera elezione, in cui ci
si candida o, se si viene candidati, si accetta o non accetta la candidatura e
in cui si spiegano istituzionalmente – in Parlamento, non uscendo dalle pizzerie
o dalle case private – le ragioni dei sì e dei no.
Viene comunque quasi da
sorridere a immaginare questa come una riforma possibile, in un sistema
istituzionale condannato da decenni alla paralisi dalla ferrea alleanza tra
quelli che vogliono sfasciare tutto e quelli che non vogliono cambiare niente.
Quirinale, bordata di
Dagospia a votazioni aperte: "Tutto questo caos? Quando Mattarella e il suo
uomo..."
Libero Quotidiano il 28 gennaio 2022.
Prima di giocarsi la carta
Draghi per Palazzo Chigi, Sergio Mattarella avrebbe voluto l'ex banchiere come
suo successore al Quirinale. Lo rivela Dagospia in una nota: "Una scelta
sofferta. L’arrivo a Palazzo Chigi di Draghi bruciava quella che era la prima
opzione alla sua successione. L’asso nella manica che aveva tenuto al riparo dai
partiti per spianargli la strada verso il Colle”. Pare, inoltre, che per evitare
di giocarsi il suo nome durante la crisi di governo di un anno fa, l’uomo ombra
del presidente, Ugo Zampetti, si fosse speso per dare vita al Conte ter. Opzione
poi fallita.
Alla fine infatti, come
sappiamo, il nome dell'ex banchiere si è reso necessario vista la crisi profonda
che si stava attraversando. Anche perché Mattarella, come da lui spiegato un
anno fa, voleva scongiurare il voto anticipato sia perché si era in piena
pandemia sia perché mancava una nuova legge volta a ridisegnare i collegi
elettorali dopo la riduzione del numero dei parlamentari.
In ogni caso pare,
spiega Dagospia, che i nomi “super partes” dei possibili candidati al Colle,
evocati in questi giorni, siano gli stessi che aveva in mente il Capo dello
Stato uscente da oltre un anno per garantire stabilità al Paese: Mario Draghi,
Giuliano Amato, Marta Cartabia e Sabino Cassese.
IL GIORNO DELLE VOTAZIONI
Elezione Presidente della
Repubblica, la diretta del voto per il Quirinale della prima giornata: incontro
Salvini-Letta “apre il dialogo”.
Antonio Lamorte su Il Riformista il 24 Gennaio 2022.
Al via oggi le elezioni
del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Camera Roberto Fico ha
convocato l’assemblea che eleggerà il prossimo Capo dello Stato oggi, lunedì 24
gennaio 2022, alle 15:00 per la prima seduta. Il successore di Sergio
Mattarella (che ha in diverse occasioni ribadito che non è in corsa per un
secondo mandato) sarà il 13esimo Presidente della Repubblica Italiana. Fino alla
terza votazione necessaria la maggioranza dei due terzi
dell’assemblea, 673 voti, dalla quarta in poi basterà la maggioranza
assoluta, 505.
Causa covid-19 si terrà una
sola votazione al giorno. Al massimo 50 elettori alla volta in aula per votare.
I Grandi Elettori positivi potranno votare nel parcheggio della Camera con un
seggio drive-in appositamente allestito nel parcheggio della Camera. A votare
i 1009 cosiddetti Grandi Elettori: 630 deputati, 321 senatori (di cui 6 a vita,
5 di nomina presidenziale e un ex presidente della Repubblica) e 58 delegati
regionali, tre per ogni Regione, uno solo per la Valle d’Aosta. Votano prima i
senatori, poi i deputati e infine i delegati regionali. Il voto è anonimo:
perciò le elezioni del Capo dello Stato sono il regno dei franchi tiratori. Solo
in due occasioni, nel 1985 con Francesco Cossiga e nel 1999 con Carlo Azeglio
Ciampi, il Presidente venne eletto alla prima seduta.
Caos e ore di trattative
febbrili tra i partiti. Il leader e fondatore di Forza Italia
Silvio Berlusconi ha sciolto la riserva: fallita l’operazione scoiattolo, ha
rinunciato alla corsa al Quirinale. Scricchiola la candidatura del Presidente
del Consiglio in carica, dato da mesi per favorito, Mario Draghi. Ancora preso
in considerazione per alcuni il secondo mandato di Sergio Mattarella. Le ipotesi
Pierferdinando Casini e Giuliano Amato ancora in corsa, come quelle di
Marta Cartabia ed Maria Elisabetta Alberti Casellati. New entry della giornata
di ieri: il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi e la
direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
Elisabetta Belloni.
Il live minuto per minuto
8:00 – Si va verso un primo
scrutinio senza intese tra i partiti. L’unica certezza, salvo sorprese, è che
nell’urna finiranno molte schede bianche. Continuano le trattative febbrili.
Oggi incontro Letta-Salvini. Il segretario del Pd ha chiesto una presa di
posizione chiara su Mario Draghi: “Ha rappresentato per l’Italia una
straordinaria risorsa e il compito di tutti noi è di preservarlo”. Opzione
Mattarella ancora in campo per il leader dem: “Darebbe il massimo, la soluzione
ideale e perfetta”. Letta pronostica tra martedì e mercoledì una candidatura
condivisa. Per Salvini invece “togliere Draghi da Palazzo Chigi è pericoloso”.
Per il segretario del Carroccio “Casini non è un candidato del centrodestra”.
8:50 – Con la morte del
deputato di Forza Italia Enzo Fasano, scomparso ieri sera a 70 anni, i Grandi
Elettori scendono a 1008. Scende così anche a 672 il quorum dei due terzi
chiesto nelle prime tre votazioni per l’elezione. Per tornare al 1009 andrà
proclamato il primo dei non eletti, che parteciperà subito al voto.
9:00 – Secondo La
Repubblica la trattiva che potrebbe sbloccare tutto è quella di Elisabetta
Belloni, prima donna a capo dell’intelligence, Presidente del Consiglio e Draghi
al Quirinale. Si tratterebbe della prima donna a Palazzo Chigi e del primo capo
dell’intelligence a guidare un governo. L’attuale direttrice generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza è stata segretario generale
della Farnesina e alla direzione dell’unità di crisi del ministero. Sarebbe
considerata una personalità trasversale.
10:48 – Il vicepresidente e
coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani ha dichiarato, in linea con
Berlusconi e Salvini, ai giornalisti arrivando a Montecitorio in mattinata che
“oggi serve unità nazionale e Mario Draghi è il miglior garante dell’unità
nazionale. Non è una questione personale ma dell’interesse del Paese. Serve
unità di governo e che questo esecutivo arrivi a fine legislatura”. No a veti da
parte di Tajani: “Ho parlato con Salvini, Meloni e gli altri leader, nella
giornata di ieri, e ritengo che il centrodestra farà delle sue proposte e poi
valuteremo, ci confronteremo. Ciò che non possiamo accettare è che si sostenga
il principio per cui chi è espressione del centrodestra non possa avere
incarichi pubblici, perché questo è illiberale ed antidemocratico”.
11:00 – Il successore di
Enzo Fasano, il deputato di Forza Italia morto ieri sera, sarà scelto tramite
una procedura rapidissima che dovrebbe riportare il numero dei Grandi Elettori a
1009 entro mercoledì. La Giunta per le elezioni di Montecitorio e l’aula della
Camera in una seduta ad hoc saranno convocate in queste 72 ore per individuare
il primo dei non eletti di Forza Italia nella Circoscrizione Campania 2 e
verificarne i titoli. È la prima volta nella storia che la Camera sarà convocata
durante le elezioni del Capo dello Stato per la proclamazione di un deputato
subentrante.
11:15 – Nessun veto da parte
del Movimento 5 Stelle. “Abbiamo alzato l’asticella, vogliamo una personalità di
alto profilo, compatibile coi valori del Movimento”, ha detto il leader
Giuseppe Conte arrivando a Montecitorio. “L’assemblea M5s, che è il numero più
consistente, ha convenuto diffusamente che l’obiettivo è preservare la
continuità dell’azione di governo perché non possiamo trascurare che ci sono
famiglie, imprese cittadini che ci guardano e non possono pensare che prima ci
fermiamo per il Quirinale e poi per un nuovo governo”.
12:00 – Il Presidente della
Camera Roberto Fico pubblica sul suo profilo Facebook le foto delle
cosiddette “insalatiere”, le urne dove consegnare il proprio voto: “Alle 15 il
Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente della
Repubblica. Stamattina in programma le due riunioni congiunte di Camera e Senato
– prima quella dell’Ufficio di Presidenza e poi la Conferenza dei capigruppo –
per ultimare l’organizzazione dei lavori”.
12:30 – Spunta un nome nuovo
per il Colle. A farlo è Giorgia Meloni, con Fratelli d’Italia che lancia per il
Quirinale l’ex procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio. “Molte personalità,
che provengono dall’area del centrodestra, avrebbero il curriculum e lo standing
per ricoprire il ruolo di presidente. Nomi come quello di Marcello Pera, Letizia
Moratti, Elisabetta Alberti Casellati, Giulio Tremonti, Franco Frattini sono
tutti autorevoli. Io ho chiesto di allargare la rosa anche alle personalità che
non hanno un trascorso politico e per questo abbiamo aggiunto il nome di Carlo
Nordio, su cui ci pare difficile che si possano muovere obiezioni”, ha detto ai
suoi grandi elettori riuniti in assemblea.
13:00 – Decisa la ‘timeline’
del voto. Il calendario prevede infatti la convocazione per domani alle 15,
confermando dunque l’orario odierno per consentire la partecipazione ai funerali
del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano, scomparso domenica sera.
Il terzo scrutinio, previsto
mercoledì, inizierà alle 11 del mattino, come stabilito dalla conferenza dei
capigruppo di Camera e Senato.
13:30 – Maria Rosa Sessa,
detta Rossella, sarà il grande elettore numero 1009. La deputata prenderà
infatti il posto di Enzo Fasano, il deputato di Forza Italia morto domenica
sera. L’annuncio è stato dato in commissione Affari Costituzionali da Stefano
Ceccanti, deputato e capogruppo del Partito Democratico.
Una decisione lampo con la
verifica dei ‘titoli’ della Sessa da parte della Giunta per le elezioni della
Camera, con l’elezione che verrà proclamata in apertura di seduta oggi
ripristinando così il quorum.
13.50 – Niente schede segnate.
Il presidente della Camera Roberto Fico leggerà solo il cognome del votato ove
la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando, pur riportando altre
notazioni, sia comunque univocamente individuabile il soggetto cui è attribuito
il voto. Si tratta di una informazione importante: la lettura del solo cognome e
non la lettura “tale e quale” del voto evita il controllo da parte dei gruppi
politici che in queste ore sono a lavoro per individuare il prossimo presidente
della Repubblica. Un escamotage utilizzato più volte in passato per contarsi e
capire effettivamente quanti voti si avevano a disposizione. Storico – come
riporta l’Ansa – il caso della votazione in cui Franco Marini era candidato del
centrosinistra e non venne eletto. Le variabili furono tante, da “Marini Franco”
a “Franco Marini” a “Marini dottor Franco” o “Franco dottor Marini”.
14:30 – Stamattina il vertice
tra il segretario del Pd Enrico Letta, il leader del Movimento 5 Stelle
Giuseppe Conte e il segretario di Articolo Uno Roberto Speranza. Scheda bianca
al primo scrutinio, preservare il nome di Andrea Riccardi e aprire un confronto
“vero” con il centrodestra le indicazioni dal summit. Conte, a differenza di
Letta, ha detto che non avrebbe “remore a considerare una candidatura che venga
dal centrodestra”. L’ex premier avrebbe preferito tra l’altro tenere coperto il
più possibile il nome di Andrea Riccardi fino al momento giusto. Per Letta è “il
candidato ideale”. Previsto oggi pomeriggio l’incontro tra il segretario dem e
quello della Lega Salvini.
14:35 – Il Presidente del
Consiglio Mario Draghi e il segretario della Lega Matteo Salvini si sono
incontrati stamattina a Palazzo Chigi. “No comment” sul faccia a faccia.
14:46 – “La Lega voterà scheda
bianca”, l’indicazione emersa durante la riunione con il segretario Matteo
Salvini alla Camera. “Confermeremo di essere seri e responsabili”.
15:06 – In programma oggi
pomeriggio il segretario della Lega Matteo Salvini e il leader del M5s
Giuseppe Conte. L’ex premier pentastellato avrebbe sentito ieri diversi leader
il presidente di Fdi Giorgia Meloni e oggi il coordinatore di Forza Italia
Antonio Tajani.
16:00 – Giornata di incontri
per una giornata interlocutoria che dovrà mettere le basi per un possibile
accordo. Per questo Matteo Salvini, come confermano fonti della Lega, incontrerà
sia Enrico Letta che Giuseppe Conte, i due leader di Partito Democratico e
Movimento 5 Stelle.
Prima di vedere però gli
“alleati” di governo, Salvini si confronterà con Giorgia Meloni. Fratelli
d’Italia ha candidato, almeno per le prime votazioni, l’ex magistrato Carlo
Nordio.
16:15 – SkyTg24 apprende da
fonti parlamentari che nell’agenda agenda Draghi sono previsti incontri con
tutti i leader di partito.
16:20 – Fine della votazione
dei Senatori. Dopo 10 minuti di pausa, con sanificazione degli ambienti, si
riprenderà con i deputati.
16:25 – Renzi ai cronisti
davanti a Montecitorio: “Come vedo bis di Mattarella? Non lo vedo”. E “al
momento non vedo grandi soluzioni all’orizzonte. Il parlamento 2013 ha fallito,
il parlamento del 2015 era lo stesso, ma ha eletto Mattarella. La differenza la
fa la politica”. L’ex premier ha aggiunto: “Penso e spero che nelle prossime 48
ore, siano decisive per passare dal Wrestling alla politica. E sono sinceramente
ottimista perché hanno tutti interesse a farlo. Basta schermaglie, ora si fa sul
serio”. L’ipotesi Draghi “sta in piedi solo in un quadro di accordo politico”.
16:53 –
Incontro Salvini-Letta: “Si è aperto dialogo”. Riferiscono fonti della Lega e
del Partito Democratico: “Lungo e cordiale incontro tra Matteo Salvini ed Enrico
Letta negli uffici della Lega alla Camera. Con il faccia a faccia si è’ aperto
un dialogo: i due leader stanno lavorando su delle ipotesi e si rivedranno
domani”.
17:50 – Quello con il
segretario della Lega Matteo Salvini è stato “un incontro molto positivo”
secondo il segretario del Pd Enrico Letta. Domani un altro faccia a faccia.
“Abbiamo aperto il dialogo, è positivo, ci rivediamo domani”.
18:15 – Un messaggio
importante su una possibile convergenza sul nome di Pier Ferdinando
Casini arriva dal senatore del Partito Democratico Dario Stefano, presidente
della Commissione politiche Ue. Da Stefano infatti è arrivato uno stop alle
ambizioni di Draghi al Quirinale: “diffusa che Draghi debba proseguire il lavoro
al governo per portarci fuori dalla crisi pandemica, dalla emergenza dei costi
energia e materie prime e per conseguire la piena attuazione del Pnrr. Il Paese
non puo’ permettersi una crisi al buio”. Per il colle quindi “serve un nome che
unisce, che non sia bandiera di nessuno, che aiuti le convergenze e che conosca
bene il parlamento e le sue regole di funzionamento. Casini è certamente uno dei
candidati che risponde perfettamente a questo profilo”.
Tesi ribadita anche dal
ministro delle Politiche agricole e capodelegazione del Movimento 5 Stelle al
Governo, Stefano Patuanelli: “Mario Draghi deve restare a palazzo Chigi? “I
cittadini hanno bisogno di certezze”.
19:50 – “Sto lavorando perché
nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di
qualità, donne e uomini di alto profilo istituzionale e culturale, su cui
contiamo ci sia una discussione priva di veti e pregiudizi, che gli italiani non
meritano in un momento così delicato dal punto di vista economico e sociale”. E’
quanto dichiara il leader della Lega Matteo Salvini.
20:09 – Inizia lo spoglio da
parte del presidente della Camera Roberto Fico. Moltissime schede bianche, voti
poi per Alberto Angela, Paolo Maddalena, Elisabetta Belloni, Ettore Rosato,
Amadeus, Sergio Mattarella, Umberto Bossi, Franco Rutelli, Bruno Vespa, Marco
Cappato, Marta Cartabia, Craxi, Silvio Berlusconi, Walter Veltroni, Claudio
Lotito, Alfonso Signorini, Giuseppe Cruciani, Mauro Corona e Claudio Sabelli
Fioretti.
20:21 – “C’è un clima positivo
di confronto” ha dichiarato Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle,
all’uscita da Montecitorio.
21:38 – Dopo circa un’ora è
finito lo spoglio delle schede dopo la prima votazione per l’elezione del
presidente della Repubblica. I votanti sono stati 976. Come previsto, la
stragrande maggioranza sono schede bianche (672), 49 quelle nulle. Preferenze
poi per il presidente uscente Sergio Mattarella (16), i magistrati Paolo
Maddalena (32), Carlo Nordio (pochissime per il candidato avanzato da Fratelli
d’Italia) e Nicola Gratteri, le donne Elisabetta Belloni e Marta Cartabia (9),
poi i politici Silvio Berlusconi, Ettore Rosato, Umberto Bossi, Pierluigi
Bersani, Francesco Rutelli, Walter Veltroni, Marco Cappato e spunta anche Craxi.
Nuova votazione domani, martedì 25 gennaio, alle 15.
22:30 – Elezioni presidente
Repubblica, tutte le preferenze dopo primo scrutinio: da Amadeus a Lotito a
Signorini
23.56 – Draghi presidente
della Repubblica e Di Maio premier: i nomi e le ipotesi dopo la prima
giornata. Le strategie in Transatlantico: asse tra il ministro degli Esteri e
Giorgetti.
Antonio Lamorte. Giornalista
professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha
frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha
collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura,
spettacoli.
672 le schede bianche. Elezioni
presidente Repubblica, tutte le preferenze dopo primo scrutinio: da Amadeus a
Lotito a Signorini. Redazione su Il Riformista il 24
Gennaio 2022.
Fumata nera, come era ampiamente prevedibile, dopo
il primo voto dei Grandi Elettori per scegliere il
13esimo presidente della Repubblica (il mandato di Mattarella scade a inizio
febbraio). Domani, martedì 25 gennaio, alle ore 15 è in programma la seconda
votazione.
In questa prima giornata sono stati
complessivamente 976 i votanti e dallo spoglio, diretto dal presidente della
Camera Roberto Fico, sono ben 672 le schede bianche. Quelle nulle sono invece
49. Chi ha ottenuto più preferenze è il magistrato Paolo Maddalena, candidato
avanzato dalla componente “Alternativa c’è”, ovvero gli ex Movimento 5 Stelle
confluiti nel gruppo Misto.
Maddalena ha racimolato 36 preferenze. Al secondo
posto si piazza il presidente uscente Sergio Mattarella con 16, segue la
ministra della Giustizia Marta Cartabia con 9. Poi Silvio Berlusconi, il
deputato di Forza Italia Roberto Cassinelli, Guido De Martino, figlio di
Francesco, e il deputato ex M5S Antonio Tasso, con 7; Umberto Bossi e il
presidente di Italia viva, Ettore Rosato, con 6.
Marco Cappato prende 5 voti; il senatore della
Lega Cesare Pianasso e il giornalista Bruno Vespa con 4 voti; il conduttore di
un ‘Giorno da pecora’ Giorgio Lauro, Enzo Palaia, il direttore del Dis
Elisabetta Belloni, la deputata di Italia viva Maria Teresa Baldini, il
presidente della Lazio Claudio Lotito, Pierluigi Bersani, il giornalista Claudio
Sabelli Fioretti, Francesco Rutelli, il presentatore Amadeus e Craxi 3 voti.
Due voti per Giuliano Amato, il presidente del
Senato Elisabetta Casellati, il divulgatore scientifico Alberto Angela, Pier
Ferdinando Casini, l’ex premier Giuseppe Conte, Gianluca De Fazio, il ministro
dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il chirurgo Ermanno Leo, Antonio
Martino, il giurista Ugo Mattei, il sottosegretario all’Editoria, Giuseppe
Moles, il deputato del Pd Paolo Siani.
Un voto a Sabino Cassese, Carlo Nordio (candidato
proposto da Fratelli d’Italia), Mario Draghi, Walter Veltroni, Anna Finocchiaro,
Rosy Bindi, Antonio Tajani. Hanno ricevuto un voto anche, tra gli altri, Donina
Cesare, Ugo Mattei, Andrea Pertici, Ermanno Leo, Pastorino, Fulvio Abbate,
Alessandro Barbero, Alfonso Signorini, Giuseppe Cruciani, Vincenzo De Luca,
Mauro Corona, Mario Segni, Giorgio Presu, Aldo Morrone, Antonio Razzi,
Prosperetti, Giuseppe Cossiga, Gioacchino Gabbuti, Salvatore Borsellino, Dino
Zoff e il magistrato Nicola Gratteri.
Il nome scelto dal Gruppo Misto. Chi è
Paolo Maddalena, il magistrato candidato al Quirinale dagli ex grillini.
Redazione su Il Riformista il 24 Gennaio 2022-
Nato a Napoli 85 anni fa, Paolo Maddalena è un
ex magistrato e vice presidente emerito della Corte Costituzionale. Nei giorni
scorsi il suo profilo è stato scelto dai parlamentari ex Movimento 5
Stelle confluiti ora nel Gruppo Misto e nella componente “Alternativa c’è”, di
cui fanno parte poco più di 40 tra deputati e sanatori. “Per individuare una
figura di alto profilo morale e tecnico da proporre per l’ormai prossima
elezione del presidente della Repubblica, si è aperto un confronto tra
parlamentari del Gruppo Misto di Camera e Senato all’opposizione, che ha portato
all’indicazione del professor Paolo Maddalena”, si legge nella nota diffusa.
Maddalena è una “figura super partes, lontana da
appartenenze politiche: ha messo al centro della sua opera di magistrato,
docente universitario e giudice costituzionale (vice presidente della Consulta)
la tutela dei beni pubblici demaniali, della legalità, della sovranità popolare
e della nostra Costituzione. Per queste ragioni riteniamo possa essere una
figura tra le più importanti sulla quale tutte le forze politiche potrebbero
convergere. Le invitiamo ad esprimere il proprio voto per una personalità in
grado di incarnare pienamente le caratteristiche di garante della Costituzione e
dei diritti del popolo italiano”.
Chi è Paolo Maddalena?
Subito dopo la laurea (conseguita presso
l’Università di Napoli nel 1958), Maddalena iniziò l’attività didattica e di
ricerca nell’ambito del diritto romano, come assistente di Antonio Guarino.
Libero docente di Istituzioni di diritto romano dal 1971, successivamente al suo
ingresso in magistratura spostò i suoi interessi verso il diritto amministrativo
e costituzionale. I principali risultati in questo settore hanno riguardato una
nuova configurazione della responsabilità amministrativa e la tesi della
risarcibilità del danno pubblico ambientale. Dopo avere insegnato per alcuni
anni nell’Università degli Studi di Pavia, parallelamente al suo impegno come
magistrato, dal 1991 al 1998 è stato titolare della cattedra Jean Monnet Diritto
della Comunità Europea per il patrimonio culturale ed ambientale presso
l’Università degli Studi della Tuscia a Viterbo. In questo periodo si è
occupato, in numerosi scritti, anche dei profili istituzionali ed ordinamentali
dell’Unione europea. Presidente dell’associazione di promozione sociale Attuare
la Costituzione dal 2017. Dal 5 settembre 2019 è a capo della Consulta sul
Debito del Comune di Napoli (Audit).
Maddalena è entrato nella Magistratura della Corte
dei Conti nel 1971. Dopo un lungo periodo trascorso presso la Procura Generale,
nell’ultimo periodo, dal 1995, è stato Procuratore regionale del Lazio della
magistratura contabile. Ha avuto modo di applicare le tesi da lui prospettate in
sede scientifica sia collaborando allo svolgimento di numerose istruttorie, in
particolare su temi ambientali, sia svolgendo incarichi di diversa natura. Tra
l’altro ha fatto parte del gruppo Ecologia e Territorio istituito presso la
Corte suprema di cassazione, ed è stato Capo di gabinetto del ministro della
Pubblica istruzione Gerardo Bianco (1989-1991) e Capo ufficio legislativo presso
il Ministero dell’ambiente.
Dopo una lunga carriera nella quale ha coniugato
l’attività di studio e ricerca nei settori del diritto romano, diritto
amministrativo e costituzionale e diritto ambientale con le funzioni di
magistrato, culminate con la nomina alle funzioni di presidente di sezione della
Corte dei conti, il 17 luglio 2002 è stato eletto alla Corte costituzionale
nella quota riservata alla magistratura contabile. Ha assunto le sue funzioni
dopo aver giurato il 30 luglio dello stesso anno.
Il 10 dicembre 2010 è stato
nominato vicepresidente della Corte dal neoeletto presidente Ugo De Siervo,
carica nella quale è stato riconfermato il 6 giugno 2011 dal neoeletto
presidente Alfonso Quaranta. Tra il 30 aprile 2011 e il 6 giugno dello stesso
anno ha svolto le funzioni di presidente della Corte. Il suo mandato alla
Consulta è giunto a termine il 30 luglio 2011.
Il 1 aprile 2014 è stato nominato esperto a titolo
gratuito dal Sindaco di Messina Renato Accorinti, per le politiche di
giurisdizione costituzionale per i beni comuni.[1] Nel 2016 ha espresso
posizioni vicine al movimento No Cav schierandosi a favore della tutela delle
Alpi Apuane. Il 16 gennaio 2022 viene indicato da 40 parlamentari, per la
maggior parte fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle come candidato per l’elezione
del Presidente della Repubblica Italiana del 2022.
Moneta parallela all’euro
In passato Maddalena propose una moneta parallela
all’euro: “L’antico pensiero economico e produttivo di stampo keynesiano –
scriveva il giurista – prevedeva una distribuzione della ricchezza anche alla
base della piramide sociale. E il maestro di Mario Draghi, Federico Caffè, si
ispirava agli insegnamenti di Keynes. Purtroppo il sistema di stampo keynesiano
è stato trasformato in un sistema economico patologico e predatorio di stampo
neoliberista. E il sistema neoliberista vuole tutta la ricchezza concentrata
nelle mani di pochi: autostrade, frequenze televisive, acqua, rotte aeree. Il
primo vero problema da affrontare, per uscire dalle crisi ambientale, sanitaria
e economica nelle quali siamo caduti, è quello che riguarda il tema
importantissimo, ma stranamente trascurato, della “creazione del danaro dal
nulla”. La moneta non nasce in natura, ma è creata dalla mano dell’uomo, e, in
pratica, o dallo Stato, o dalle banche, che al momento sono tutte private. E
privata è anche la Bce che è oggetto di proprietà delle banche centrali private
dei singoli Stati europei. Insomma utilizziamo una moneta a debito anziché una
moneta a credito, emessa direttamente dallo Stato che, per giunta, ha anche la
capacità, come suol dirsi, di “monetizzare il debito”, cioè di pagare i debiti
con l’emissione di nuova moneta e non con la creazione periodica di nuovi
debiti, come oggi avviene”.
Paolo Maddalena
per ilfattoquotidiano.it il 22 febbraio 2022.
Il governo Draghi, dopo aver
disposto la vendita agli stranieri di tutti i servizi pubblici essenziali (Ddl
Concorrenza Art. 6) e, in particolare, della distribuzione dell’acqua
(emendamento 22.6 al Dl Recovery), con decreto ministeriale del 19 febbraio
2022, ha disposto la messa a gara della compagnia di bandiera Ita Airways.
Con tali atti Draghi dimostra
di diventare in pratica l’esecutore delle multinazionali e della finanza
internazionale per la liquidazione dell’intero patrimonio pubblico del Popolo
italiano.
Egli agisce in palese
contrasto con la Costituzione, la quale considera i servizi pubblici essenziali,
le fonti di energia, le situazioni di monopolio e le industrie strategiche (art.
43 Cost.) in proprietà pubblica demaniale del Popolo, ai sensi del comma uno,
primo alinea, dell’articolo 42, il quale sancisce che la proprietà è pubblica e
privata.
È chiaro che svendendo
l’intero demanio pubblico lo Stato italiano resta nella impossibilità di
garantire a tutti i servizi pubblici indispensabili per la vita di tutti i
cittadini.
Infatti alle entrate del
bilancio statale vengono sottratti i molto lauti guadagni che provengono dalla
gestione dei servizi pubblici essenziali, e alla pubblica amministrazione non
resta altro, per soddisfare i bisogni della popolazione, se non la possibilità
dell’aumento delle imposte, le quali riducono la domanda e impediscono lo
sviluppo economico, distruggendo posti di lavoro, portando tutti a una
ineliminabile miseria.
In sostanza il governo Draghi
non si accorge che, con queste operazioni, sta distruggendo il nostro
Stato-Comunità, rendendolo schiavo degli Stati economicamente più forti a
cominciare da Germania e Francia. E tutto questo mentre i media di tutto
parlano, tranne che della rovina economica nella quale siamo indirizzati.
È indispensabile che gli
uomini di buona volontà, pure esistenti nel Paese, svolgano una incisiva azione
di divulgazione di questo stato di cose, e che il maggior numero possibile di
cittadini adiscano la via giudiziaria con il fine di portare davanti alla Corte
costituzionale queste disposizioni legislative tanto dannose per gli interessi
generali.
E a tal proposito si ricorda
che i cittadini singoli o associati sono legittimati ad agire in giudizio: in
quanto parte della collettività (art. 2 Cost.), in quanto titolari del diritto
di partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese
(art. 3, comma 2, Cost.) e in quanto autorizzati a svolgere attività di
carattere generale secondo il principio di sussidiarietà (art. 118, comma 4,
Cost.).
Siamo davvero ad una svolta
decisiva e, se non facciamo attuare nel settore economico la nostra
Costituzione, ci aspetta soltanto un futuro di schiavitù sotto lo schiacciante
potere economico delle multinazionali e della finanza internazionale.
Si tratta di adempiere al
dovere sacro del cittadino di difendere la Patria, secondo quanto sancisce il
primo comma, primo alinea, dell’articolo 52 Cost. Come al solito, e con maggiore
apprensione, invito tutti ad attuare gli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 11, 41, 42, 43
e 118 della nostra Costituzione repubblicana e democratica.
Chi è Elisabetta Belloni,
tra i candidati a presidente della Repubblica.
Corriere della Sera il 27
Gennaio 2022.
Elisabetta Belloni,
ambasciatrice, è la prima donna a raggiungere il vertice dei servizi segreti: il
suo è tra i nomi di cui si parla per il Quirinale, in queste ore.
Il nome di Elisabetta
Belloni — la diplomatica ora alla guida del Dipartimento delle informazioni per
la sicurezza — è tra quelli per la scelta del prossimo presidente della
Repubblica. Belloni, 63 anni, romana, è stata nominata lo scorso anno da Mario
Draghi Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
In precedenza aveva ricuperto il ruolo di segretario generale del ministero
degli Esteri, dove è stata sostituita dall’ambasciatore Ettore Sequi. Belloni è
la prima donna ad arrivare ai vertici dell’intelligence (dopo essere stata la
prima donna a guidare l’Unità di crisi, la prima donna a dirigere la
Cooperazione allo Sviluppo, la prima donna capo di Gabinetto di un ministro
degli Esteri, la prima donna a dirigere tutta la macchina della Farnesina). A
pesare, come scritto qui da Fiorenza Sarzanini, è stata la sua grande
esperienza: per anni capo dell’unità di crisi della Farnesina, Belloni ha
gestito i sequestri degli italiani in Iraq lavorando fianco a fianco con gli 007
e diventando punto di raccordo per l’azione del governo per la liberazione degli
ostaggi, ma anche punto di riferimento per le famiglie. Da segretario del
ministero degli Esteri si è occupata dell’organizzazione della Farnesina. Come
raccontato in questo ritratto di Marco Galluzzo, Belloni adora camminare: «esce
di casa alle prime luci dell’alba, tuta e scarpe da ginnastica, impiega un’ora
per arrivare alla Farnesina. Ogni giorno, che sia sole o pioggia cambia poco.
Alle sette e mezza si è già fatta una doccia ed è alla sua scrivania. Autorevole
ma non autoritaria, una capacità eccezionale di relazioni esterne, intese come
tali ma anche umane, nel mondo diplomatico, economico, istituzionale, compreso
quello dei Servizi, con cui ha lavorato fianco a fianco quando dirigeva l’Unità
di crisi. Non si stacca mai dal suo cellulare, ma stacca veramente quando nel
weekend si gode la sua casa nella campagna aretina, insieme ai suoi adorati tre
pastori alsaziani e alle gioie di un orto che ama curare con le sue mani». Nel
corso della carriera, è stata candidata diverse volte, con un profilo tecnico,
anche per cariche politiche: da ministra degli Esteri a presidente del
Consiglio. Come in queste ore.
Quirinale, chi è Elisabetta
Belloni, la riserva della repubblica ideale.
LISA DI GIUSEPPE su Il Domani
il 24 Gennaio 2022. Uno dei nomi più evocati nelle ultime ore sia per palazzo
Chigi che per il Quirinale è quello di Elisabetta Belloni, capo dei servizi
segreti.
Il curriculum dell’ex
segretario generale vicinissima a Di Maio è prova sufficiente della sua
competenza sopra la media, ma Belloni è stata brava a coltivare i propri
rapporti con tutto l’establishment italiano.
Il fatto di non essere legata
a nessun partito potrebbe rappresentare un limite per la sua elezione: tutto
l’arco parlamentare la stima, ma si discute dell’opportunità di mandarla a
palazzo Chigi e di come possa accoglierla il paese da presidente della
Repubblica.
LISA DI GIUSEPPE. Scrivo di
politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters,
La7, Corriere della Sera e Public Policy.
Quirinale, Elisabetta
Belloni presidente dalla Repubblica? "Quella ha in mano i dossier", chi piomba
nel panico in Parlamento.
Libero Quotidiano il 27 gennaio 2022.
Salgono le quotazioni
di Elisabetta Belloni al Quirinale e i parlamentari, rivela Aldo Cazzullo nella
sua diretta sul sito del Corriere, sono già nel panico. "Quella ha i dossier di
tutti… Io non ho niente da nascondere, per carità…però, insomma…". La Belloni
infatti, è il capo dei Servizi segreti, e ora potrebbe diventare presidente
della Repubblica, visto che il suo nome convince tutti, da Fratelli d'Italia
di Giorgia Meloni a Enrico Letta.
Ma appunto si solleva una
questione di opportunità. Il problema, infatti, è che Elisabetta Belloni
passerebbe dal ruolo di capo dei Servizi segreti a ricoprire la prima carica
dello Stato. "Non viviamo in una democrazia dimezzata o in uno stato
autoritario. Il capo dei servizi segreti, chiunque sia, non può assurgere a
ruoli istituzionali per inadeguatezza della funzione e potenziale potere
di condizionamento, tantomeno può concorrere ai vertici dello Stato", ha
attaccato il senatore del Psi Riccardo Nencini in una nota. "Un'Italia che
percorresse strade sudamericane o emulasse la Russia di Putin tradirebbe la sua
storia repubblicana è lo spirito della costituzione".
Evidentemente non è l'unico a
pensarla così. E al di là delle questioni puramente istituzionali, la sua figura
inquieta più di qualche deputato e di qualche senatore.
Luca Pellegrini
per repubblica.it il 27 gennaio 2022.
Quirinale, Mastella: "Belloni
al Colle? È come se un portiere volesse fare il centravanti". "Ufficialmente
sono perché il capo dei servizi segreti italiani diventi il capo del mondo. A
dire il vero, avrei preferito che arrivasse qua con la veste di segretario della
Farnesina, non come capo dei servizi segreti": così Clemente Mastella, lasciando
Montecitorio, commenta la possibilità di eleggere al Quirinale Elisabetta
Belloni. "Sarebbe giusto che continuasse a ricoprire il ruolo suo - continua
l'ex Guardasigilli e attuale sindaco di Benevento - ma qui nessuno lo vuole
giocare, come se il portiere volesse diventare centravanti. E vale anche per
Draghi, essere a Palazzo Chigi è un incarico prestigioso".
Le manovre della Farnesina.
Il mistero Belloni e il caso Kostin, l’ombra della Farnesina.
Aldo Torchiaro su Il
Riformista il 26 Gennaio 2022.
Tre governi europei ieri hanno
riunito il gabinetto di guerra. Le manovre militari russe, che oggi impegneranno
quasi diecimila militari sul campo, premono sui confini ucraini. La telefonata
di Biden a Draghi non ha sortito gli effetti sperati: complice l’appuntamento
istituzionale più importante, l’Italia sembra distratta. E anche intorno
al Colle si nota qualche strana manovra, qualche manina che proviene dalle barbe
finte. Quel mondo si interroga da giorni sulla misteriosa vicenda della
candidatura anomala del capo del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza,
l’apprezzatissima Elisabetta Belloni.
Per la prima volta nella
storia repubblicana il direttore dei servizi segreti ha fatto capolino quale
possibile Capo dello Stato. Naturale che si sia accesa subito la caccia grossa
sui nomi dei suoi propugnatori. Belloni dell’iniziativa non era informata e –
per chi ne conosce lo stile – si può immaginare con quale fastidio l’abbia
accolta. Ma neanche si può immaginare che chi governa l’intelligence ne sia
potuta rimanere al buio fino all’ultimo. Ci dice il direttore di una prestigiosa
fondazione geopolitica: “Non può che essere stato un ballon d’essai
della Farnesina, ovviamente in chiave anti-Draghi”. Si scherza col fuoco.
E sul dialogo e sugli eccessi
di diplomazia con Mosca c’è chi punta il dito verso il Ministero degli esteri
per un caso serio: con Decreto del Presidente della Repubblica formalizzato
sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio scorso, su proposta del Ministro degli
Esteri Luigi Di Maio, è stata conferita l’onorificenza di Commendatore
dell’Ordine della «Stella d’Italia» a due cittadini russi Andrey
Kostin (banchiere) e Viktor Evtukhov (sottosegretario di Stato al Ministero
dell’Industria e Commercio Estero). Entrambi oggetto di pubbliche denunce per
utilizzo scorretto di denaro pubblico da parte del dissidente russo Alexei
Navalny. Andrey Kostin è sottoposto a sanzioni da parte dei governi
di USA e Canada, dove non può mettere piede per “il suo ruolo chiave nel portare
avanti politiche nocive di Putin”.
Altroché medaglie,
sottolineano i Radicali Italiani che per primi hanno rilevato l’affaire:
“Constatiamo che il Movimento 5 Stelle ha svoltato di 180 gradi su quasi tutte
le posizioni politiche assunte in passato, tranne che per i suoi ammiccamenti
con il regime di Mosca. Tale ambiguità, da parte non di un esponente di partito
ma di un ministro degli Esteri di un Paese membro della Nato, nel giorno in cui
gli Stati Uniti hanno iniziato ad evacuare la loro ambasciata a Kiev, è
francamente vergognosa ed inaccettabile”, dicono in coro i dirigenti di Radicali
Italiani Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini, Igor Boni.
Aldo Torchiaro. Romano e
romanista, sociolinguista, ricercatore, è giornalista dal 2005 e collabora con
il Riformista per la politica, la giustizia, le interviste e le inchieste.
Dalla Farnesina agli incarichi con i
governi Berlusconi, Renzi, Conte e Draghi. Chi è Elisabetta Belloni, la
diplomatica che potrebbe essere la prima donna Presidente della Repubblica.
Elena Del Mastro su Il Riformista il 23 Gennaio 2022.
È la prima donna a capo degli 007 italiani e
potrebbe essere anche la prima Presidente della Repubblica italiana
donna. Elisabetta Belloni, 63 anni, potrebbe essere il nome che mette insieme
tutti anche perché dal suo curriculum sembrerebbe piacere a tutti i colori
politici.
Belloni è una stimata diplomatica, ha collaborato
con ministri politici di tutti gli schieramenti, riuscendo però a non schierarsi
mai. Tanto che non è chiaro per chi voti. A maggio 2021, è stata nominata dal
premier Mario Draghi direttore generale del dipartimento delle Informazioni per
la sicurezza, un ruolo delicatissimo che è coperto da una donna per la prima
volta nella storia italiana.
Belloni si è laureata in Scienze politiche nel
1982 alla Luiss di Roma cominciando presto – a soli 27 anni – la sua carriera
diplomatica alla Farnesina, presso la Direzione generale degli Affari
politici (era il 1985). Un anno dopo Belloni si trasferisce prima a Vienna, poi
a Bratislava dove rimane fino al 1999, quando rientra in Italia, al ministero
degli Esteri. Lì ricopre il ruolo di capo della segretaria della Direzione per i
Paesi dell’Europa, capo dell’Ufficio per i Paesi dell’Europa centro-orientale e
capo della segretaria del Sottosegretario di Stato agli Esteri.
Nel 2004 l’allora ministro degli Esteri Franco
Frattini (Forza Italia, governo Berlusconi) la nomina capo dell’unità di crisi
della Farnesina. Ruolo in cui la confermerà subito dopo Gianfranco Fini,
subentrato al ministero. Belloni gestisce, in quel caso, dossier delicatissimi
come il rapimento di cittadini italiani in Iraq e Afghanistan e si occupa anche
del coordinamento delle ricerche a seguito dello tsunami in Thailandia. Nel
2008, invece, ancora Frattini la nomina direttore generale per la Cooperazione
allo sviluppo. Nel 2013, sotto il governo tecnico guidato da Mario Monti (oggi
senatore a vita, dunque “grande elettore”), Belloni diventa direttore generale
per le Risorse e l’Innovazione, su richiesta del ministro degli Esteri Giulio
Terzi di Sant’Agata.
Nel 2015 il ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni (governo Renzi) la chiama come capo di gabinetto per poi nominarla
segretaria generale del ministero degli Esteri, prima donna a ricoprire questo
incarico. Ruolo che continuerà ad avere anche con i successivi governi
presieduti da Giuseppe Conte, diventando un punto di riferimento prezioso anche
per Luigi Di Maio, ministro degli Esteri. Belloni resta segretaria generale fino
alla nomina di Draghi alla guida dei servizi segreti.
Elena Del Mastro. Laureata in Filosofia, classe
1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui
cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone,
cercando di rimanere distante dagli stereotipi.
Da corriere.it il 24 gennaio
2022.
Il caso Sara Cunial continua a
tenere banco. La deputata ex M5S, dichiaratamente no vax e no green pass (il
certificato verde è necessario per entrare a Montecitorio), chiede di poter
votare nella postazione esterna riservata ai grandi elettori positivi o in
quarantena. La parlamentare non ha intenzione di spostarsi.
«Sono sana e chiedo di poter
votare il Presidente come è mio diritto costituzionale fare, non vedo perché non
possa votare come i malati di Covid sia vaccinati che non». E ancora: «Non far
votare un cittadino prima ed un parlamentare poi perché sano è un affronto alla
democrazia, alla legge e alle istituzioni».
L'aria che tira, Gasparri
travolge Molinari: "Morta una persona, un po' di rispetto". Quel titolo
agghiacciante su Repubblica.
Libero Quotidiano il 24
gennaio 2022.
"Sono molto triste per la
morte di questo nostro parlamentare, Enzo Fasano, una persona seria e
perbene": Maurizio Gasparri, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7,
ha iniziato così il suo intervento, ricordando il deputato scomparso ieri.
Approfittando della presenza del direttore di Repubblica, poi, il senatore di
Forza Italia ha detto: "Voglio dire una cosa a Maurizio
Molinari. Ieri Repubblica titolava: 'I grandi elettori scendono a 1.008'. Un po'
più di calore e rispetto quando muore una persona, non è solo un numero".
Gasparri, poi, ha lanciato una
proposta: "Se Repubblica facesse qualcosa di più caloroso per riparare a questo
modo statistico di dare la notizia sarebbe apprezzato". Poi, cambiando
argomento, il senatore azzurro ha dichiarato: "Berlusconi non ha voluto dare
luogo a spaccature e divisioni. Adesso però il veto su Berlusconi sembra, nelle
parole di Enrico Letta, essere stato trasferito su chiunque non sia della
sinistra".
Quirinale, sfregio di
Roberto Fico al deputato di Forza Italia morto: "Niente minuto di silenzio",
sconcerto in Parlamento.
Libero Quotidiano il 24 gennaio 2022.
Roberto Fico ha declinato la
proposta di osservare un minuto di silenzio per ricordare Enzo Fasano. È
accaduto durante il primo giorno di votazione per il prossimo capo dello Stato.
Qui il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha chiesto al collega
della Camera dei deputati di richiamare alla memoria il deputato di Forza
Italia, scomparso alla vigilia del voto per il Quirinale.
A ricostruire l'accaduto è
stata l'Adnkronos. Fico, racconta l'agenzia, avrebbe consultato il segretario
generale della Camera Fabrizio Castaldi, salvo poi soprassedere. Le motivazioni
non sono ufficiali, ma stando ad alcune ipotesi dietro la decisione
dell'esponente del Movimento 5 Stelle ci sarebbe il protocollo. Quest'ultimo non
prevederebbe la richiesta della Casellati. A maggior ragione perché questo caso
l'Assemblea è seggio elettorale.
Ma quanto accaduto nella
giornata del 24 gennaio non sarebbe il solo episodio. È tornato infatti
d'attualità un precedente risalente al 24 giugno 1985. In quell'occasione la
presidente Nilde Iotti, nella seduta comune del Parlamento, espresse il
cordoglio per la scomparsa il giorno prima del senatore della Dc Angelo
Tomelleri, senza che venisse osservato il minuto di silenzio. Accadde lo stesso
anche il 24 maggio del 1992, dopo la commemorazione di Giovanni Falcone,
di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta uccisi nella strage di Capaci.
In quel caso il presidente Oscar Luigi Scalfaro non invitò l'Aula a osservare un
minuto di silenzio. "Richiamiamo la nostra volontà a responsabilità più alte;
diamo al popolo italiano la percezione di un mondo politico responsabile che
sente l'urgenza di una unità di intenti e di una volontà viva e vera per
servire, non per dominare. Colleghi, il silenzio sia la sottolineatura di questo
impegno; le vittime del dovere e le vittime civili siano richiamo", furono le
sue parole.
II GIORNO DI VOTAZIONI
Il live minuto per minuto
della seconda giornata. Elezione Presidente della Repubblica, la diretta del
voto: Letta boccia la rosa del centrodestra e chiede un conclave, rabbia Lega
contro veti.
Redazione su Il Riformista il 25 Gennaio 2022.
In attesa dei candidati veri,
la prima giornata dedicata all’elezione del 13esimo presidente della
Repubblica si è conclusa con una valanga (672) di schede bianche su un totale di
976 votanti. Oggi, martedì 25 gennaio, si torna a Montecitorio per la seconda
votazione in programma a partire dalle 15.
Il successore di Sergio
Mattarella (che ha in diverse occasioni ribadito che non è in corsa per un
secondo mandato) sarà il 13esimo Presidente della Repubblica Italiana. Fino alla
terza votazione necessaria la maggioranza dei due terzi
dell’assemblea, 673 voti, dalla quarta in poi basterà la maggioranza
assoluta, 505.
Causa covid-19 si terrà una
sola votazione al giorno. Al massimo 50 elettori alla volta in aula per votare.
I Grandi Elettori positivi potranno votare nel parcheggio della Camera con un
seggio drive-in appositamente allestito nel parcheggio della Camera. A votare
i 1009 cosiddetti Grandi Elettori: 630 deputati, 321 senatori (di cui 6 a vita,
5 di nomina presidenziale e un ex presidente della Repubblica) e 58 delegati
regionali, tre per ogni Regione, uno solo per la Valle d’Aosta. Votano prima i
senatori, poi i deputati e infine i delegati regionali. Il voto è anonimo:
perciò le elezioni del Capo dello Stato sono il regno dei franchi tiratori. Solo
in due occasioni, nel 1985 con Francesco Cossiga e nel 1999 con Carlo Azeglio
Ciampi, il Presidente venne eletto alla prima seduta.
Caos e ore di trattative
febbrili tra i partiti. Il leader e fondatore di Forza Italia
Silvio Berlusconi ha sciolto la riserva: fallita l’operazione scoiattolo, ha
rinunciato alla corsa al Quirinale. Scricchiola la candidatura del Presidente
del Consiglio in carica, dato da mesi per favorito, Mario Draghi. Ancora preso
in considerazione per alcuni il secondo mandato di Sergio Mattarella. Le ipotesi
Pierferdinando Casini e Giuliano Amato ancora in corsa, come quelle di
Marta Cartabia ed Maria Elisabetta Alberti Casellati. New entry della giornata
di ieri: il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi e la
direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
Elisabetta Belloni.
00:30 – Elezioni presidente
Repubblica, tutte le preferenze dopo primo scrutinio: da Amadeus a Lotito a
Signorini
02:30 – La strategia di Draghi
dopo i colloqui con Salvini, Letta e Conte. E spunta l’ipotesi Di Maio premier.
03:30 – Attesa per le proposte
del centrodestra promesse da due giorni a questa parte dal leader della Lega
Matteo Salvini. L’ex numero uno del Viminale ha ribadito: “Sto lavorando perché
nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di
qualità, donne e uomini di alto profilo istituzionale e culturale, su cui
contiamo ci sia una discussione priva di veti e pregiudizi, che gli italiani non
meritano in un momento così delicato dal punto di vista economico e sociale”.
Ore 8:35 – Secondo Matteo
Renzi l’Italia “avrà un nuovo presidente della Repubblica “non oltre giovedì o
venerdì”. In una intervista a Il Messaggero, il leader di Italia viva ritiene
che il Presidente sia “l’arbitro imparziale della politica interna per sette
anni ma anche un presidente credibile in politica estera: le tensioni tra Russia
e Ucraina, le sfide globali tra Stati Uniti e Cina, la crisi della Nato
richiedono che il nuovo inquilino del Quirinale sia un leader forte, garante del
patto atlantico e dal marcato profilo europeista. Si tratta di raccogliere anche
su questo l’eredità di tre grandi presidenti quali Ciampi, Napolitano e
Mattarella”. Renzi lancia “un appello alla serietà: non perdiamo altro tempo. La
crisi geopolitica, la pandemia, l’inflazione, il costo delle bollette e delle
materie prime chiedono alla politica di non buttare altro tempo”. Per Renzi c’è
“sola una ipotesi in campo: Draghi al Quirinale con un grande accordo politico.
L’altra no. L’idea di perdere Draghi anche come premier infatti non sta in
piedi: può lasciare Chigi solo per un trasloco istituzionale. Altrimenti si
scelga un uomo o una donna di equilibrio per la funzione di Capo dello Stato
lasciando a Draghi la responsabilità di governo per l’anno e mezzo che ancora ci
manca”. “Di tutte le possibilità – conclude – l’unica che non esiste è che
Draghi se ne vada da tutto“.
Ore 09:45 – Pier Ferdinando
Casini, tra i candidati alla presidenza della Repubblica, si riscopre
improvvisamente social. Su Instagram ha pubblicato una foto da giovanissimo
(quando guidava i giovani Democratici Cristiani) con la didascalia: “La passione
politica è la mia vita!!”.
Ore 10:30 – In mattinata la
Lega prova a smorzare gli animi e i retroscena sulle trattative tra Matteo
Salvini e Mario Draghi su “un presunto rimpasto”, ovvero sulla trattativa in
contemporanea su Palazzo Chigi e Quirinale.
“Non è in corso alcuna
trattativa tra il senatore Matteo Salvini e il presidente del Consiglio Mario
Draghi a proposito di un presunto rimpasto”, spiega infatti in una nota la Lega.
“È infondato e irrispettoso per il senatore Salvini e per il presidente Draghi
immaginare che in questa fase, anziché discutere di temi reali, siano impegnati
a parlare di equilibri di governo”.
Ore 11:40 – L’accordo tra i
partiti su un nome condiviso per il Colle appare lontano. Il centrodestra si
riunirà alle 15 per un vertice in cui verranno fuori i candidati da proporre
alle altre forze in Parlamento: secondo l’Agi ci saranno Letizia Moratti,
Marcello Pera, Maria Elisabetta Casellati e Carlo Nordio (fuori dunque Frattini
e Casini). I nomi verranno poi ufficializzati in una conferenza stampa convocata
alle 16:30 alla Camera.
Dal Nazareno però fonti Pd
rilanciano e annunciano un ‘no’ certo a figure come lo stesso Pera, Casellati o
simili.
Ore 12:30 – Appare ormai fuori
dai giochi la candidatura al Colle di Franco Frattini. Le quotazioni dell’ex
ministro degli Esteri di Berlusconi, attuale presidente del Consiglio di Stato,
erano date in forte rialzo anche per una probabile convergenza sul suo nome di
Salvini e Conte.
Una proposta su cui però hanno
fatto muro Italia Viva e Partito Democratico. Colpa delle posizioni filorusse di
Frattini mentre in Ucraina si sta infiammando lo scontro tra Mosca e i Paesi
della Nato. Opinione condivisa di Enrico Letta e Matteo Renzi è che in una fase
delicata per la crisi Ucraina serva un profilo di presidente della Repubblica
“europeista e atlantista”.
Ore 12:50 – Il vertice del
centrodestra è stato anticipato di mezz’ora: si terrà infatti alle 14:30, con la
conferenza stampa che verrà svolta alla Camera alle 16.
Ore 13:20 – Anche i leader del
centrosinistra ‘allargato’, ovvero Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto
Speranza, si incontreranno nel pomeriggio per fare il punto della situazione. Un
vertice fissato alle 15, quando inizierà anche la seconda giornata di voto
nell’Aula della Camera.
Da 5 Stelle, Partito
Democratico e Leu l’indicazione è ancora quella di confermare la scheda bianca.
Ore 14:30 – Matteo Salvini
ribadisce il no al trasloco di Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. Il leader
della Lega nei minuti che hanno preceduto l’avvio del vertice di coalizione ha
riferito ai cronisti fuori Montecitorio che il premier “già lavora bene a
Palazzo Chigi”, smarcandosi ancora una volta da tale ipotesi.
Salvini ha quindi confermato
l’esclusione dalla ‘rosa’ dei candidati di Pier Ferdinando Casini e di Franco
Frattini, attuale presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro degli Esteri
dei governi Berlusconi: “Nessuno lo ha ancora fatto eppure è stato già
bocciato”. Quindi una sottolineatura ambigua: “I nomi che proporremo non hanno
neanche una tessera di partito”, ha spiegato Salvini.
Ore 15:15 – Arriverà dopo le
17 la risposta del centrosinistra sui ‘Quirinabili’. Pd, 5 Stelle e
Leu attenderanno infatti la conferenza stampa di Salvini e soci in cui verrà
avanzata la lista dei candidati per fare una controproposta.
Ore 16:20 – L’ex
premier Matteo Renzi chiede di iniziare a tirare fuori i candidati: “Chi ha un
candidato lo tiri fuori. Il centrodestra ha diritto di avanzare la candidatura.
Ma questo non è uno show”. Poi suggerisce: “Spero che la presidenza inizi a far
votare due volte al giorno perché c’è una crisi pesantissima in Ucraina, la
crisi economica su energia e gas, regole assurde a scuola per la dad, almeno il
Parlamento abbia la consapevolezza di quello che si sta giocando. Il mio è un
appello a fare presto”.
Ore 16:33 – Tre nomi per la
corsa al Quirinale. Sono quelli lanciati dal centrodestra nella conferenza
stampa tenuta a Montecitorio. Matteo Salvini ha annunciato per la corsa al
Quirinale l’ex presidente del Senato Marcello Pera, l’ex magistrato Carlo
Nordio e l’attuale assessore regionale lombardo (ex sindaco di Milano ed ex
ministro) Letizia Moratti.
Ore 16:45 – Nel corso della
conferenza stampa, Giorgia Meloni ha ricordato che “gli ultimi 4 presidenti
della Repubblica sono stati proposti dal centrosinistra, in un paese in cui si
dice che la maggioranza sia di centrodestra. Rivendico rispetto da chi dice che
qualsiasi proposta del centrodestra sarà respinta”. Poi aggiunge: “Sono molto
soddisfatta della compattezza con cui il centrodestra sta affrontando questa
prova. Crediamo sia nostra responsabilità cercare di fare un passo avanti con
proposte concrete. Il centrodestra non ha i numeri per eleggere da solo il
presidente, ma ha i numeri maggiori e ha il diritto di fare delle proposte e
chiedere agli altri di esprimersi”.
Ore 16:55 – Sempre nel corso
della conferenza, Salvini ha voluto anche rimarcare come nei tre nomi
proposti non ci sono “dirigenti di partito anche se ovviamente, e lo dico io,
c’è qualcuno a questo tavolo che non avrebbe un titolo ma tantissimi per ambire
a questa carica, a proposito di europeismo, atlantismo, dimestichezza con le
diplomazie”.
Ore 17:20 – Anche Giuseppe
Conte, leader del Movimento 5 Stelle, chiude all’ipotesi Draghi al
Quirinale: “Se abbiamo affidato a un timoniere questa nave in difficoltà, non ci
sono le condizioni per fermare i motori e cambiare l’equipaggio. La nostra nave
è ancora in difficoltà”. Sui tre nomi avanzati dal centrodestra commenta:
“Rispettiamo proposte ma ci riserviamo di fare valutazioni”.
Ore 18:20 – Il patto tra Conte
e Salvini: “Draghi resti premier”, Letta e il Pd furiosi
Ore 18:40 – Iniziato lo
spoglio alla Camera dopo la seconda votazione. Molte le schede bianche
annunciate dal presidente Roberto Fico. Il quorum richiesto è dei due terzi,
pari a 673 voti. Anche nella seconda giornata di votazioni compaiono voti per
Sergio Mattarella, Pierluigi Bersani, Silvio Berlusconi, Giancarlo Giorgetti e
Francesco Rutelli. Ma ci sono preferenze anche per il ‘senatùr’ Umberto Bossi,
il premier Mario Draghi, Marco Cappato, Massimo D’Alema, Nicola Gratteri, Fulvio
Abbate, Roberto Cassinelli, Claudio Lotito.
Ore 19:20 – Mentre prosegue lo
spoglio con la maggiorana delle schede bianche, Giuseppe Conte, Enrico Letta e
Roberto Speranza bocciano i tre nomi avanzati dal centrodestra. “Prendiamo atto
della terna formulata dal cdx che appare un passo in avanti, utile al dialogo.
Pur rispettando le legittime scelte del centrodestra, non riteniamo che su quei
nomi possa svilupparsi quella larga condivisione in questo momento necessario”
fanno sapere al termine del vertice di centrosinistra. “Riconfermiamo la nostra
volontà di giungere ad una soluzione condivisa su un nome super partes e per
questo non contrapponiamo una nostra rosa di nomi”.
Ore 19:22 – Il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio lascia Montecitorio e ai giornalisti si limita a dire un
“sono ottimista“. Non è chiaro in merito a cosa.
Ore 19:25 – “Nella giornata di
domani proponiamo un incontro tra due delegazioni ristrette in cui porteremo le
nostre proposte“. Lo afferma una nota congiunta di Giuseppe Conte, Enrico Letta
e Roberto Speranza, al termine del vertice congiunto.
Ore 19:41 – Tanti i voti-burla
della seconda giornata. Tra le preferenze per il Presidente della Repubblica
compaiono Claudio Baglioni, Al Bano e Enrico Ruggieri. Un voto anche per Dino
Zoff come ieri. E poi il conduttore Alberto Angela, Giorgio Agamben (il
filosofo), e i conduttori Massimo Giletti e Cladio Sabelli Fioretti. Un voto
anche per il comico Nino Frassica.
Ore 19:44 – “La proposta che
facciamo è quella di chiuderci dentro una stanza e buttiamo via le chiavi: pane
e acqua, fino a quando arriviamo a una soluzione, domani è il giorno chiave” ha
dichiarato Enrico Letta, segretario del Pd, all’uscita da Montecitorio.
Ore 20:05 – I voti più strani
a Presidente della Repubblica: “Ma chi sono?”
Ore 20:10 – Sulla stessa linea
di Letta, ovviamente, anche le dichiarazioni di Giuseppe Conte. “Oggi abbiamo
deciso di non presentare una rosa di nomi. In questo modo acceleriamo il dialogo
con il centrodestra con l’impegno di trovare nelle prossime ore una soluzione
condivisa” ha spiegato l’ex presidente del Consiglio e leader dei 5 Stelle.
“L’Italia non ha tempo da perdere. Non è il momento del muro contro muro“, ha
aggiunto Conte.
Ore 20:20 – Ufficiale la
seconda ‘fumata nera‘ di queste elezioni per il presidente della Repubblica.
Come previsto infatti a stravincere sono state le schede bianche, 527, con 976
votanti su 1009 grandi elettori.
I più votati sono stati
l’attuale capo dello Stato Sergio Mattarella e Paolo Maddalena (39), seguiti
da Renzo Tondo (18) Roberto Cassinelli (17), Ettore Rosato (14), Umberto
Bossi (12) Giancarlo Giorgetti, Luigi Manconi e Marta Cartabia (8), Silvio
Berlusconi e Giuseppe Moles (7) e Nicola Gratteri (6).
Ore 21:50 – Il ‘no’ di Letta,
Conte e Speranza alla terna dei nomi proposta dal centrodestra per il Quirinale
agita la Lega. Il Carroccio infatti tramite fonti ha fatto filtrare
l’irritazione per la bocciatura della ‘rosa’ composta da Letizia Moratti, Carlo
Nordio e Marcello Pera.
“A differenza di chi cambia
idea dopo poche ore, la Lega continua a lavorare con contatti a tutto campo.
Restiamo convinti dell’assoluto spessore delle candidature presentate oggi per
il Quirinale, ed è evidente la differenza tra noi e chi dice no a ripetizione e
mette veti”, spiegano fonti del partito di Salvini.
Ore 22:20 – L’irritazione di
Salvini avrà in realtà anche un altro bersaglio, perché anche Matteo Renzi
boccia i tre nomi proposti dal centrodestra per la presidenza della Repubblica.
Il leader di Italia Viva, ospite di Cartabianca su Rai 3, esprime infatti un
giudizio netto: “Sono tre nomi di livello ma credo che domani non voteremo i
candidati di centrodestra: il presidente della Repubblica non è un giudizio
sulla persona, ma è la scelta del candidato più adatto a fare il presidente
della Repubblica”.
La tradizione allo spoglio.
I voti più strani a Presidente della Repubblica: “Ma chi sono?”
Antonio Lamorte su Il Riformista il 25 Gennaio 2022.
“Ma chi sono?”, ha scandito
perfino Enrico Mentana a un certo punto della sua diretta su La7, mentre il
Presidente della Camera Roberto Fico leggeva e passava i fogli con le preferenze
alla Presidente del Santo Maria Elisabetta Alberti Casellati. E chi sono allora?
Alcuni sconosciuti, altri che impegnano le redazioni a scovare profili e
biografie, molti vip come sempre. E a Montecitorio, nel secondo giorno
di votazioni per il prossimo Capo dello Stato, è andato in scena il consueto
teatrino delle preferenze creative e buffe.
Il portiere della Nazionale
Campione del Mondo nel 1982 Dino Zoff, il cantautore Claudio Baglioni, il
divulgatore scientifico Alberto Angela, i cantanti Albano ed Enrico Ruggeri, il
presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus che già era
stato tirato in ballo ieri, lo storico Alessandro Barbero. Un voto persino per
Aldo Moro. Un altro per il sociologo Domenico De Masi. Varia umanità, molto
spettacolo, sport: c’è chi si diverte insomma in queste ore di stallo
a Montecitorio.
Dino Zoff
Claudio Baglioni
Enrico Ruggeri
Alberto Angela
Roberto Mancini
Claudio Lotito
Giorgio Agamben
Massimo Giletti
Claudio Sabelli Fioretti
Alfonso Signorini
Mauro Corona
Giuseppe Cruciani
Antonio Razzi
Christian De Sica
Giorgio Lauro
Claudio Sabelli Fioretti
Fulvio Abbate
Francesco Verderami
Giovanni Rana
Enrico Chiapponi
Antonio Lamorte. Giornalista
professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha
frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha
collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura,
spettacoli.
I voti-burla e il tempo dei
pagliacci.
Francesco Maria Del Vigo il 26 Gennaio 2022 su Il Giornale.
Giovanni Rana, Enrico
Ruggeri, Nino Frassica, De Sica, Alberto Angela, Amadeus, Al Bano, Antonio
Razzi, Mauro Corona. E sono solo alcuni dei tanti.
Giovanni Rana, Enrico Ruggeri,
Nino Frassica, De Sica (non si sa quale, ed essendo una stirpe è difficile
capirlo), Alberto Angela (in questo caso siamo sicuri, ma onore anche al padre,
ingiustamente trascurato), Amadeus (temiamo non si tratti di Mozart), Al Bano,
Antonio Razzi, Mauro Corona. E sono solo alcuni dei tanti. Cos'hanno in comune
tutti questi personaggi? La risposta normale sarebbe questa: sono, a vario
titolo, dei vip; nomi di spicco dell'imprenditoria, della musica, del cinema,
della cultura o della televisione. Risposta normale in un Paese normale. Dunque
risposta errata. Sono alcuni - solo alcuni perché la lista completa è
decisamente più lunga - dei nomi che i nostri parlamentari, ieri, hanno votato
come Presidente della Repubblica. Tutti personaggi rispettabilissimi, alcuni
persino più credibili e rappresentativi dei vari «signor nessuno» che hanno
fatto capolino nei vari retroscena giornalistici. Ma non confondiamo il veglione
di Capodanno e il trenino in diretta tv con il discorso del Presidente a reti
unificate: nonostante tutti i vani tentativi della politica di
autodelegittimazione, l'elezione del capo dello Stato rimane una cosa seria. La
scheda con la quale i «grandi» elettori votano non è un meme come quelli che i
«piccoli» cittadini usano per candidare Rocco Siffredi o Topolino al Quirinale
nei loro post su Facebook.
Beh, è sempre successo -
obietterà qualcuno - in ogni elezione presidenziale qualche burlone si è
divertito a scarabocchiare un nome impossibile. Vero, ma ogni cosa ha il suo
tempo e questo non è esattamente quello dei pagliacci. O, per lo meno, non
dovrebbe esserlo. E non c'è nulla di peggio di un comico che non riesce più a
fare ridere, di una battuta che viene accolta dal silenzio imbarazzato della
sala. Questo ora è l'effetto dei voti beffa. Non è una questione di moralismo,
che da queste parti non ha mai albergato, ma piuttosto di pragmatismo.
Le ferite del nostro Paese non
si sono ancora cicatrizzate, la pandemia rallenta ma continua a fare paura,
l'economia è claudicante e dall'est soffiano venti di guerra che preoccupano
tutta l'Unione Europea. Ma i nostri parlamentari hanno, evidentemente, del gran
tempo da perdere. Loro sì, l'Italia no. E mai come in questo caso si tratteggia
chiaramente la distinzione tra Paese reale e Paese virtuale. Tra chi lavora e
chi si balocca. Ci sono decine di milioni di cittadini incollati a televisori e
pc nel tentativo di seguire un'elezione tanto importante quanto complessa,
sempre più simile a un rebus del quale si è persa la soluzione. Cittadini che
non meritano lo spettacolo dei politici che si spernacchiano da soli.
Francesco Maria Del Vigo è
nato a La Spezia nel 1981, ha studiato a Parma e dal 2006 abita a Milano. E'
vicedirettore del Giornale. In passato è stato responsabile del Giornale.it. Un
libro su Grillo e uno sulla Lega di Matteo Salvini. Cura il blog Pensieri
Spettinati.
Fondatore dell'Intergruppo
Parlamentare 2.0 per l'innovazione. Chi è Roberto Cassinelli, avvocato e
deputato di Forza Italia votato per diventare presidente della Repubblica.
Redazione su
Il Riformista il 25 Gennaio 2022.
Genovese, avvocato, liberale,
interista, deputato al Parlamento. Già senatore della Repubblica. Fuori dai
radar fino al momento in cui il presidente della Camera Fico ha iniziato lo
spoglio. È nato a Genova il 10 Dicembre 1956. Ha conseguito la maturità classica
presso il Liceo “Vittorino da Feltre” di Genova, si è laureato in giurisprudenza
presso l’Università statale di Milano.
È avvocato, patrocinante
presso la suprema Corte di Cassazione ed è stato per due mandati consigliere
dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Genova. Opera prevalentemente nel settore
civile ed amministrativo, con particolare riferimento al diritto societario,
bancario, finanziario, fallimentare ed alla contrattualistica. Svolge attività
di consulenza ed assistenza legale per istituti bancari e di credito di
rilevanza nazionale ed europea, per gruppi industriali e commerciali, per
società di servizi ed enti pubblici. È stato, consigliere di amministrazione,
sindaco, commissario giudiziale e commissario straordinario in numerose società.
Inoltre è membro del Consiglio dell’Associazione Proprietà Edilizia della
Provincia di Genova.
Ha aderito sin da giovanissimo
al Partito Liberale Italiano, di cui il padre Giorgio è stato Vicepresidente
Nazionale. Con il P.L.I. è stato eletto tre volte al Consiglio Comunale di
Genova, nel 1981, nel 1985 e nel 1990. Ha inoltre ricoperto numerosi incarichi
pubblici nell’ambito della Fiera internazionale di Genova, delle Unità Sanitarie
Locali VIII e XIII, dell’Azienda per l’igiene urbana di Genova, dell’Ente per il
diritto allo studio universitario della Liguria e dell’Autorità per i servizi
pubblici del Comune di Genova.
Tra i fondatori di Forza
Italia in Liguria, ne è stato Vice Coordinatore Regionale dal 1994 al 2006,
Commissario Cittadino per la città di Genova dal 2005 al 2007 e Coordinatore
Cittadino per la città di Genova, eletto dal Congresso, dal 2007 al 2009. Dal
2005 fino allo scioglimento del Partito ne è stato membro del Consiglio
Nazionale. Dalla nascita del Popolo della Libertà ha assunto l’incarico di
Coordinatore Vicario per la città di Genova ed è di diritto membro
dell’Assemblea dei Parlamentari. Dal giugno 2009 è membro della Consulta
nazionale del Pdl sul tema della Giustizia e responsabile nazionale del
Dipartimento sul diritto societario e fallimentare del Popolo della Libertà.
Alle elezioni politiche del
13-14 Aprile 2008 è stato eletto alla Camera dei Deputati per il Popolo della
Libertà, nella Circoscrizione Liguria. Nella XVI Legislatura è membro della
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Nell’ambito della propria
attività di deputato, si occupa prevalentemente di Giustizia, Libere
Professioni, Legge & Internet. È fondatore dell’Intergruppo Parlamentare 2.0, un
gruppo di deputati e senatori di ogni schieramento che ha l’obiettivo
di promuovere le politiche dell’innovazione presso il Parlamento italiano.
Dai canali Rai a lui
interamente dedicati a come realizzare il paradiso in Terra. Chi è Mauro
Scardovelli, il candidato Presidente della Repubblica che ha raccolto oltre
20mila firme online.
Gianni Emili su Il Riformista il 25 Gennaio 2022.
Mauro Scardovelli è giurista,
psicoterapeuta e musicoterapeuta. È stato professore di diritto pubblico presso
l’Università degli Studi di Genova e docente di musicoterapia al Cep di Assisi.
Nel 1998 fonda l’associazione Aleph Umanistica, scuola di crescita personale che
coniuga la formazione psicologico-relazionale, interiore e spirituale, con
quella costituzionale, relativa al mondo esterno.
Vive e lavora a Camogli,
insieme a un gruppo di ‘monaci-ricercatori’ che hanno deciso di dedicare la loro
vita all’applicazione più integralista non di testi sacri, bensì della
Costituzione italiana. Per la sua autoproposta al Colle sono state raccolte
oltre 20mila firme online con l’iniziativa ‘Vogliamo Mauro Scardovelli come
Presidente della Repubblica’. Nel testo dal titolo ‘Il Nuovo Rinascimento‘ con
il quale Scardovelli suggella la sua candidatura in modo entusiastico precisa
che “non era la prima volta che ricevevo messaggi in tale direzione”, e si
riserva come primo nome di candidare “Paolo Maddalena, che considero il mio
Maestro”.
Nel testo che snocciola il
programma per un “presidente scelto dal basso, dal Popolo, per ripristinare la
legalità Costituzionale, violata da tutte le altre Istituzioni, che hanno
tradito la Costituzione, aderendo al modello ad essa antitetico:
il Neoliberismo” vengono citati molti “pensatori più illuminati e coraggiosi del
nostro tempo”, da Diego Fusaro a Ermanno Bencivenga passando per Fulvio
Grimaldi. Rifacendosi alle “dirette come quella di Robert Kennedy a Milano, o
del processo di Assange a Londra, o della settimana intera a Trieste a seguire i
portuali, o di Firenze dove nessuna televisione voleva andare, a seguire
la vicequestore Schilirò, i convegni come l’International Covid Summit,
Sapiens³”.
Non manca ovviamente la totale
sfiducia nei media: “Tutto questo ha prodotto la Tv dei Cittadini in soli tre
mesi guadagnandosi la fiducia di milioni di italiani mentre le redazioni dei TG
tradizionali chiudevano per mancanza di ascolti. Siamo arrivati fino a qui solo
ed esclusivamente grazie a voi. L’Italia è quel Paese dove i cittadini si pagano
una televisione di tasca loro perché quelle grandi li hanno stufati“.
Il primo punto cita
testualmente: “Come Presidente della Repubblica scelgo due canali Rai, Rai
televisione 1 e Rai radio 1 che siano a me interamente dedicati” poi come
esimersi dal “discorso del Presidente di fine anno, trasmesso a reti unificate”.
Il programma prosegue poi allontanandosi dall’esaltazione della persona per
“valorizzare la nostra piccola impresa, i nostri medici italiani, i nostri
fisici italiani” per poi incontrarsi nel punto di convergenza con altri partiti
che dall’Europa vogliono uscire. Necessario è il “recupero della sovranità
monetaria“.
Le richieste si fanno più
nebulose con “l’incompatibilità della democrazia Costituzionale con una
popolazione che è fatta, quasi esclusivamente, di narcisisti” di cui non se ne
capisce benissimo il fine, e neppure il significato pratico. Seguita da una
paventata ‘soluzione’ al problema del “narcisismo dilagante” per poi virare su
una fantomatica educazione pedagogica “ai nuovi valori Costituzionali,
Spirituali, Cristici”. Non manca l’energia pulita “inesauribile”, l’aspirazione
robespierriana di “mettere al servizio dei Popoli, anziché delle élite, le nuove
straordinarie tecnologie mediche di ultima generazione, oggi disponibili” da
cui, non è chiaro, se sia più importante aiutare i poveri o privare i ricchi.
Sulla salute torna con quello
che forse è il punto più oscuro “promuovere la vera medicina: quella preventiva”
e poi sulla pandemia: “Covid e vaccini, la mia esperienza personale e l’azione
giudiziaria“. Imperdibile infine il punto “Come realizzare il paradiso in
Terra“. Una rivoluzione costituzionale dell’Italia che secondo Scardovelli parte
“dalla pratica della preghiera come premessa” e che si svolgerà “all’interno di
un contesto dove l’humor, il gioco e l’Eros sono sempre presenti e la violenza
assente”.
Non c’è bisogno di aggiungere
altro. “Quello che facciamo parla da solo”, se no fa niente, dice Scardovelli:
“Siam pronti alla morte“.
Vittima due volte di errori
giudiziari. Serafino Generoso, chi è l’ex assessore regionale vittima di
malagiustizia votato per il Quirinale.
Carmine Di Niro su Il
Riformista il 25 Gennaio 2022.
Per due volte arrestato e
incarcerato, per due volte assolto con la formula del “fatto non sussiste”. È la
storia di malagiustizia che ha visto protagonista Serafino Generoso, fino al
1992 potente assessore ai Lavori Pubblici democristiano della Regione Lombardia,
che oggi nel secondo giorno di votazioni per l’elezione del presidente della
Repubblica ha incassato cinque voti.
Avvocato 73enne di Pozzo
d’Adda, nell’hinterland milanese, si vide arrestare per la prima volta nel 1992,
il 25 novembre, mentre in Regione la sua Dc aveva chiuso l’accordo per la giunta
col Psi guidata da Fiorella Ghilardotti.
“Dieci giorni di custodia
cautelare per una storia di mazzette negli appalti post alluvione in
Valtellina”, raccontò in una intervista al Giornale Generoso, che poche ore dopo
quell’intesa “ero a San Vittore”. Una prima vicenda giudiziaria da cui
l’assessore democristiano esce assolto e risarcito con 50 milioni di lire.
I magistrati però non si
fermano: l’anno successivo il secondo arresto con 21 giorni trascorsi in
carcere. Questa volte l’accusa è di tentata concussione in relazione a presunte
tangenti per la realizzazione della centrale Enel di Turbigo, in provincia di
Milano.
Risultato? Assolto dalla
seconda sezione penale del tribunale di Milano, mentre la pm Margherita Taddei
aveva chiesto per lui una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione.
“Sono stato arrestato due
volte ed in entrambi i casi assolto perché il fatto non sussiste. Sono contento
ma certo c’è tanta amarezza per quello che ho subito. In questi anni ho ripetuto
sempre che non c’entravo nulla ma è stato veramente difficile farsi ascoltare”,
dichiarava dopo la seconda assoluzione l’ex assessore.
Su quelle vicende, sul suo
essere vittima di malagiustizia, Generoso tornerà a parlare in una intervista
a Il Giornale del 2011. I problemi, manco a dirlo, erano gli stessi di quelli
odierni: “La custodia cautelare resta un problema grave. Andrebbe limitata ai
fatti di sangue, e per quelli amministrativi usata solo in casi estremi”,
denunciava 11 anni fa Generoso. Non solo, parole nette anche sull’obbligatorietà
dell’azione penale, che “si traduce con potere discrezionale. Va abolita, ma è
l’intero sistema che va riformato, dai tempi dell’indagine alla responsabilità
civile dei magistrati”.
Oggi un ‘riconoscimento’ nei
suoi confronti da parte di cinque grandi elettori, che nel segreto dell’urna
hanno deciso di ricordare così una delle tante vittima di malagiustizia del
nostro Paese.
Carmine Di Niro. Romano di
nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di
politica, sport e tecnologia
Pera, Moratti e Nordio:
ecco la rosa del centrodestra.
I leader della coalizione
presentano tre nomi per il Quirinale. Il segretario leghista: "Spero che non ci
saranno veti a priori". Il Dubbio il 25 gennaio 2022.
La rosa di tre nomi del
centrodestra comprende «Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio» e nessuno
dei tre «ha la tessera di un partito in tasca». Ad annunciarlo nella seconda
giornata di voto per il prossimo presidente della Repubblica è il leader della
Lega, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa del centrodestra di
oggi.
«Speriamo che gli altri
abbiano la voglia di confrontarsi nel merito sui nostri nomi» dice il leader
della Lega. «Non si tratta di candidati di bandiera perché noi non abbiamo
bisogno di fare giochetti – avverte – sono personalità di alto profilo che
pensiamo possano rappresentare la comunità italiana al meglio». «Io – dice – non
sono qui a imporre niente a nessuno». «Non presentiamo dirigenti di partito
anche se c’è qualcuno seduto a questo tavolo avrebbe tutti i titoli per ambire a
questa carica», sottolinea poi il leader della Lega riferendosi ad Antonio
Tajani, presente in conferenza stampa e citato per l’alto profilo
internazionale. «Non c’è invece il nome di Elisabetta Alberti Casellati perché
riteniamo le cariche istituzionali debbano essere tenute fuori», aggiunge il
leader leghista dopo aver escluso il nome di Draghi. «Abbiamo fatto una lunga e
proficua riunione. Il centrodestra è compatto, ci muoviamo all’unisono
dall’inizio alla fine di questo percorso. C’è e ci sarà accordo, sono
soddisfatto del clima». Poco dopo è arrivato il commento di Enrico Letta, il
quale fa sapere che «sono nomi sicuramente di qualità, li valuteremo senza
spirito pregiudiziale».
«Frattini pare non vada bene a
prescindere, io non lo conosco, Casini poi in una rosa di centrodestra non c’è.
E Draghi sta a Chigi e lavora bene a Chigi», aveva commentato Salvini dopo
il veto dem sul nome di Frattini. «Sto lavorando per arrivare a un sì, non dico
no preventivi, mi auguro che nessuno dica che la cultura liberale e moderata non
possa fare proposte», aveva annunciato Salvini. «Noi non andiamo a proporre il
Prodi di turno, vorremmo quindi quantomeno discuterne», aveva sottolineato dopo
l’assemblea con i grandi elettori, sul tema della rosa che verrà proposta dal
centrodestra.
I tre nomi presentati dal
centrodestra «non sono candidati di bandiera, né di tattica, ma personalità di
altissimo profilo», ribadisce Giorgia Meloni parlando alla conferenza stampa dei
leader. «Non sono proposte buttate li», assicura la leader di Fdi. «Esprimo la
soddisfazione di Fdi per la compattezza e l’unità con cui la coalizione di
centrodestra sta affrontando questo passaggio politico così importante –
sottolinea -. Chi spera in una nostra disarticolazione sta rimanendo
spiazzato…».
Chi sono i candidati del
centrodestra al Quirinale: Moratti, Pera e Nordio per la corsa al Colle.
Carmine Di Niro su
Il Riformista il 25 Gennaio 2022.
Tre nomi per la corsa al
Quirinale. Sono quelli lanciati dal centrodestra nel pomeriggio, in una
conferenza stampa tenuta a Montecitorio, nella stessa sala dove Matteo Renzi
ritirò le ministre Bellanova e Bonetti facendo di fatto cadere il secondo
governo Conte.
Matteo Salvini ha annunciato
infatti per la corsa al Quirinale l’ex presidente del Senato Marcello Pera, l’ex
magistrato Carlo Nordio e l’attuale assessore regionale lombardo (ex sindaco di
Milano ed ex ministro dell’Istruzione) Letizia Moratti.
Fuori dunque dalla ‘rosa dei
nomi’ l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti, il coordinatore di Forza
Italia Antonio Tajani e la presidente del Senato Elisabetta Casellati. “È una
terna che offriamo alla discussione — ha detto Matteo Salvini illustrando la
proposta — sperando che non ci siano veti”. Obiettivo, ha ricordato ancora
Salvini, “è l’apertura al dialogo e fare in fretta. Non diciamo no
pregiudizialmente a nessuno e speriamo che anche gli altri si confrontino nel
merito”.
Salvini ha voluto anche
rimarcare come nei tre nomi proposti non ci sono “dirigenti di partito anche se
ovviamente, e lo dico io, c’è qualcuno a questo tavolo che non avrebbe un titolo
ma tantissimi per ambire a questa carica, a proposito di europeismo, atlantismo,
dimestichezza con le diplomazie”.
Il riferimento è ad Antonio
Tajani, il coordinatore di Forza Italia presente accanto a Salvini nella sala
conferenze della Camera: “Uno come lui ha i titoli per ambire alla carica anche
se è un capo di partito”, ha infatti sottolineato il leader del Carroccio.
In merito alla mancata
candidatura della Casellati, Salvini ha spiegato che la sua assenza nella ‘rosa
dei nomi’ è perché il centrodestra “vuole che le cariche istituzionali siano
tenute fuori e abbiano in sé la dignità di essere una possibile scelta“. In
realtà proprio la mancata candidatura ufficiale nella ‘rosa’ appare come il
segnale di voler ‘coprire’ il nome della seconda carica dello Stato, vera carta
del centrodestra per il Quirinale.
Giorgia Meloni, intervenendo
nella conferenza, ha invece rimarcato che gli ultimi quattro presidenti della
Repubblica sono espressione del centrosinistra e che nel rispetto del principio
di alternanza il nuovo capo dello Stato può avere una appartenenza culturale
diversa, anche alla luce della maggioranza relativa in Parlamento di Fratelli
d’Italia e gli altri partiti della coalizione.
Nomi che hanno visto una prima
parziale apertura da parte di Enrico Letta, il segretario del Partito
Democratico che sempre nel pomeriggio farà assieme a Movimento 5 Stelle e Leu
una ‘controproposta’ sui candidati per il Colle. Secondo Letta dal centrodestra
sono arrivati “nomi di qualità” che saranno valutati “senza pregiudizi“, ha
spiegato il segretario Dem parlando con i giornalisti in Transatlantico.
Marcello Pera
Già presidente del Senato dal
2001 e dal 2006 col centrodestra a trazione berlusconiana, ha un passato da
accademico come professore di Filosofia della scienza all’università di Pisa.
Prima vicino al Psi, Pera passa in Forza Italia nel 1994 e viene subito eletto
senatore, carica che ricopre fino al 2013.
Una vita politica ambivalente:
durante la stagione di Mani Pulite Pera cavalca gli istinti più giustizialisti,
quindi il cambio radicale e l’approccio garantista con Forza Italia. Stessa cosa
anche nell’ambito religioso: definitosi in passato “non credente”, Pera si
avvicinerà al pensiero cristiano arrivando addirittura a firmare un libro sulle
radici cristiane dell’Europa assieme all’allora cardinale Joseph Ratzinger.
Carlo Nordio
Ex magistrato 74enne, ora in
pensione, si è occupato nella lunga carriera trascorsa a Venezia delle inchieste
sul Mose, sulla Tangentopoli delle cooperative rosse e del terrorismo, in
particolare delle Brigate Rosse.
Il nome di Nordio è stato
espresso come candidato nella ‘rosa’ del centrodestra da Fratelli d’Italia di
Giorgia Meloni.
Letizia Moratti
Assessore al Welfare della
Regione Lombardia, chiamata a sostituire Giulio Gallera nel pieno dell’emergenza
Covid dal presidente Attilio Fontana, è anche vicepresidente della Giunta. In
passato è stata sindaca di Milano dal 2006 al 2011 e in precedenza ministro
dell’istruzione nel governo Berlusconi (tra il 2001 e il 2006) e presidente
della Rai tra il 1994 e il 1996.
Formalmente Letizia Moratti
non è iscritta ad alcun partito del centrodestra, ma è da sempre considerata
vicina al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.
Carmine Di Niro. Romano di
nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di
politica, sport e tecnologia
Il nome 'Quirinabile' per Fratelli
d'Italia. Chi è Carlo Nordio, l’ex magistrato proposto da Meloni come presidente
della Repubblica. Fabio Calcagni su Il Riformista il
24 Gennaio 2022.
C’è un nome nuovo tra i ‘Quirinabili’, i nomi che
da giorni ormai circolano nelle stanze dei partiti in subbuglio per trovare il
profilo adatto per la presidenza della Repubblica. A farlo è
stata Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia che ha proposto per il
Colle l’ex magistrato Carlo Nordio.
“Molte personalità, che provengono dall’area del
centrodestra, avrebbero il curriculum e lo standing per ricoprire il ruolo di
presidente. Nomi come quello di Marcello Pera, Letizia Moratti, Elisabetta
Alberti Casellati, Giulio Tremonti, Franco Frattini sono tutti autorevoli. Io ho
chiesto di allargare la rosa anche alle personalità che non hanno un trascorso
politico e per questo abbiamo aggiunto il nome di Carlo Nordio, su cui ci pare
difficile che si possano muovere obiezioni”, ha detto la Meloni ai suoi grandi
elettori riuniti in assemblea.
Le chance di elezione sembrano però
particolarmente limitate. Era stato lo stesso Nordio la scorsa settimana a
stroncare una ipotesi di questo tipo, dopo che il suo nome era iniziato a
rimbalzare nel centrodestra. “Credo che la carica di capo dello Stato debba
esser affidata a un politico, e la mia cultura politica è esclusivamente
teorica, non ho mai fatto parte neanche di un Consiglio comunale. Comunque, se
cercassero tra i giuristi, ce ne sono molti assai più preparati e autorevoli di
me”, aveva spiegato l’ex procuratore di Venezia.
Ex magistrato, nato a Treviso nel febbraio del
1947, Nordio è stato procuratore aggiunto di Venezia e titolare dell’inchiesta
sul Mose di Venezia, oltre a essere protagonista della ‘stagione’ di Mani
pulite con le inchieste sulle cooperative rosse.
Non solo: Nordio nella sua lunga attività in
magistratura indagò anche sul terrorismo rosso, quello delle Brigate rosse. Ma
il suo focus sono sempre stati i reati economici e di corruzione: fino al 2017,
anno del suo pensionamento, si è occupato di questi ‘settori’ come procuratore
aggiunto della Procura di Venezia.
Nordio è stato particolarmente attivo anche sul
fronte delle pubblicazioni. Ha collaborato a lungo con giornali e riviste
giuridiche, tra cui i quotidiani Il Messaggero, Il Gazzettino e il Tempo. Con
l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia è stato co-autore del libro “In attesa
di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili”, pubblicato nel 2010.
Dopo la pensione per limiti di età nel febbraio
2017, avendo compiuto 70 anni, Nordio è diventato collaboratore del quotidiano
romano Il Messaggero e dal 2018 componente del CdA della Fondazione Luigi
Einaudi Onlus.
Nel 2000 fu anche al centro di una campagna di
stampa e di polemiche politiche per una vicenda di cronaca che aveva seguito
come magistrato. Nordio infatti convalidò il sequestro della macchina e la
denuncia per favoreggiamento della prostituzione di un geometra incensurato di
25 anni, che stava accompagnando una prostituta moldava. Imputato che si suicidò
per la vergogna, con Nordio che venne di fatto ‘accusato’ di aver provocato il
gesto estremo del 25enne.
L’ex magistrato, passando alla vita
privata, celebrò il matrimonio di Adriano Panatta, unico tennista italiano
capace di vincere una prova dello Slam, il Roland Garros. Nordio sposò con rito
civile Panatta con Anna Bonamigo nell’ottobre del 2020.
Fabio Calcagni. Napoletano, classe 1987, laureato
in Lettere: vive di politica e basket.
Carlo Nordio, l'ex toga che
indagò sulle tangenti del Pci e critica i magistrati.
Paolo Bracalini il 26 Gennaio
2022 su Il Giornale.
Magistrato in pensione dal
2017, si è occupato di Br, sequestri di persona, tangenti, Mose. Ma Carlo
Nordio, trevigiano, 73 anni, non ha mai fatto difesa corporativa della sua
categoria, anzi sulla magistratura italiana ha espresso profonde critiche
arrivando a dire che la politica la «fa da padrona» sia nell'Anm che nel Csm.
Giudice istruttore a Venezia, poi pubblico ministero, all'inizio degli anni
Ottanta ha portato avanti l'inchiesta sulle colonne venete delle Br e poi su
alcuni rapimenti. Durante Mani Pulite indagò sui finanziamenti al Pci-Pds dalle
coop rosse, filone che gli costò dei problemi. «Nel '97, la giunta
dell'Associazione nazionale magistrati mi convocò a Roma per un'audizione
davanti ai probiviri... Mi chiamarono a causa delle interviste in cui avevo
detto che la politica non era poi così corrotta come sembrava perché in Italia
solo in un determinato periodo tutti i partiti, e sottolineo tutti, venivano
finanziati in modo illegale e clandestino... Il Pci non aveva nessuna
legittimazione a dare lezioni di moralità tenuto conto che il Pci veniva
finanziato dall'Urss, ovvero da un Paese nemico. Ricordo l'onorevole Pietro
Folena che, al limite dell'oltraggio, ci dipinse come una "procura fascista"» ha
raccontato Nordio.
Consulente della Commissione
parlamentare per il terrorismo e le stragi (1997-2001), presidente della
Commissione per la riforma del codice penale (2002-2006), ha scritto libri molti
critici sulla gestione della giustizia. Sul caso Palamara dice :«Adesso tutti si
scandalizzano per le riunioni carbonare fra i consiglieri e i politici, ma da
sempre la politica la fa da padrona a Palazzo dei Marescialli e
nell'Associazione nazionale magistrati. Basta riflettere sulle correnti che sono
costruite a imitazione dei partiti, con una destra, un centro e una sinistra. Le
nomine sono pilotate, se non hai la sponsorizzazione di questa o quella corrente
non puoi aspirare a uffici importanti».
Ama l'equitazione e i libri
antichi, di cui è un appassionato collezionista e raffinato lettore. In passato
lo si è anche intravisto a Parigi, sui Lungosenna, dove andava ad acquistarli.
L'idea di essere candidato al Quirinale, confessa, gli fa «tremare i polsi».
Paolo Bracalini
L'ascesa del forzista. Chi
è Marcello Pera, il candidato del centrodestra al Quirinale che negli anni ha
criticato Lega e Berlusconi.
Redazione su Il Riformista il
25 Gennaio 2022.
Le mosse di Matteo Salvini
agitano il centrodestra. Il leader del Carroccio che si sfrega le mani per un
possibile ritorno alle urne, gioca la carta di altri nomi per la corsa al
Quirinale. In una conferenza stampa tenuta a Montecitorio, il leghista ha messo
sul piatto anche il nome di Marcello Pera che, insieme agli altri due (l’ex
magistrato Carlo Nordio e l’attuale assessore regionale lombardo Letizia
Moratti), non “ha una tessera di partito ma ha ricoperto ruoli importanti”, ha
detto Salvini.
Toscano, classe 1943, vanta
un’esperienza istituzionale. Sempre appoggiato dall’area del centrodestra, Pera,
è stato presidente del Senato dal 2001 al 2006, dopo un passato da accademico
come professore di Filosofia della scienza all’università di Pisa. Pera,
infatti, è anche filosofo, accademico, scrittore. Si è laureato in filosofia
all’Università di Pisa nel 1972, con 110. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia
Meloni lo ha presentato come il candidato che “ha il curriculum”.
Il suo percorso politico è
stato però accidentato. Prima è entrato nel Psi e poi, nel 1994, è passato a
Forza Italia, di cui diventa coordinatore nazionale della Convenzione per la
riforma liberale. È stato eletto senatore, carica che ha ricoperto fino al 2013.
Nel 1998 è diventato vicepresidente del Gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama.
Nel 2001 è stato eletto al primo scrutinio Presidente del Senato della
Repubblica, seconda carica dello Stato, che manterrà fino al 2006.
Pera non ha mai avuto una
buona idea dei leader di partiti che ora lo stanno promuovendo per salire al
Quirinale. Prima del 1994, e quindi prima del suo ingresso in Fi, Pera definiva
il Cavaliere “un cabarettista azzimato” e persino “un venditore televisivo di
stoviglie”. Inoltre, non ha sempre appoggiato le posizioni della Lega:
all’inizio descriveva il Carroccio come un movimento che “rischia di essere
eversivo, portando alla divisione del Paese”. Lo scorso anno, poi, la virata
salviniana. “Salvini? Mi sembra un leader su cui si può scommettere per
costruire una nuova cultura di governo”. Parole subito condivise sui social dal
leader della Lega.
Durante la stagione di Mani
Pulite, Pera ha abbracciato la morale giustizialista, criticando apertamente la
corruzione della politica. Posizione che lo ha portato a schierarsi senza
riserve dalla parte dei magistrati di Milano. Poi il cambio radicale: abbandona
le posizioni giustizialiste temperandole in senso garantista.
Anche il suo iter religioso ha
conosciuto una svolta. Definitosi in passato “non credente”, si è poi avvicinato
al pensiero cristiano arrivando a scrivere diversi libri e saggi.
Nel 2004, ha firmato con il
cardinale Joseph Ratzinger, che poi diventerà papa Benedetto XVI, il libro
“Senza radici”. Nel 2008 ha scritto il saggio “Perché dobbiamo dirci cristiani.
Il liberalismo, l’Europa, l’etica”. Il forzista non appoggia le posizioni sui
migranti di Papa Francesco, che, per lui, sconfinano nel “fare politica”. Dopo
aver attaccato Bergoglio per aver reso la Chiesa una sorta di Ong, non ha
mancato di criticare il Papa nemmeno per la sua visione green: “Ha trasformato
Greta (Thunberg) in un idolo”, ha detto.
I QUIRINABILI.
Quirinale: ecco chi è Marcello Pera, nella rosa di candidati di centrodestra.
VANESSA
RICCIARDI su Il Domani il 25 gennaio 2022.
L’ex presidente del Senato che
fa parte della “rosa” del centrodestra nel 1993 descriveva la Lega come una
forza eversiva, oggi vede in Salvini un nuovo leader. Papa Francesco sui
migranti per lui «ha trasformato la chiesa in una specie di Ong». D’accordo su
Renzi con il referendum del 2016, ha criticato spesso Berlusconi
Il centrodestra ha nella sua
“rosa” di candidati Marcello Pera, l’ex presidente del Senato di Forza
Italia. Il suo nome non dispiace nemmeno a Matteo Renzi, il leader di Italia
viva con cui in passato ha condiviso la battaglia per il sì al referendum
costituzionale del 2016. Critico con papa Francesco, Pera vede nell’immigrazione
un rischio.
L’elezione arriverebbe in
prossimità del suo compleanno: il forzista (che oggi non ha più la tessera) è
nato a Lucca il 28 gennaio 1943. Professore ordinario di Filosofia della Scienza
all’università di Pisa, ha condiviso la sua carriera politica con Silvio
Berlusconi, anche se è celebre la sua frase del 1994: «Berlusconi è a metà
strada tra un cabarettista azzimato e un venditore televisivo di stoviglie, una
roba che avrebbe ispirato e angosciato il povero Fellini».
Il primo ingresso in
parlamento è del 1996. Si candida e perde nell'uninominale a Lucca, ma grazie al
recupero del proporzionale in Toscana entra per la prima volta in Senato e
ci resterà fino al 2013. Dal 2001 al 2006 ha ricoperto la carica di presidente
del Senato in quota Pdl, la seconda carica dello stato.
LA CHIESA E I MIGRANTI
«Quale prezzo il cristianesimo
paga alla dottrina dei diritti umani? Può pagarlo? E se lo paga, aggiorna o
trasforma il messaggio cristiano?» gli interrogativi che Pera, uscito dal
parlamento, si poneva nel saggio del 2015 Diritti umani e cristianesimo. «Penso
che, accettando i diritti umani, in particolare i diritti sociali - rifletteva
Pera - la Chiesa abbia riveduto il suo tradizionale insegnamento che mette al
centro del comportamento cristiano i doveri dell'uomo verso Dio».
Nel 2004, è autore con il
cardinale Joseph Ratzinger, che poi diventerà papa Benedetto XVI, del
libro Senza radici. Nel 2008 scrive il saggio Perché dobbiamo dirci cristiani.
Il liberalismo, l'Europa, l'etica.
Pera, contro «l’ideologia dei
diritti», non apprezza papa Francesco. La posizione di accoglienza ai
migranti per lui sconfina nel «fare politica»: «Francamente questo Papa non lo
capisco, quanto dice è al di fuori di ogni comprensione razionale. evidente a
tutti che un’accoglienza indiscriminata non è possibile», diceva nel 2017.
E chiedeva: «Perché manca di un minimo di realismo, di quel poco che è richiesto
a chiunque?». E accusava Bergoglio di usare il Vangelo per fini politici. Nel
2019 ha detto che papa Francesco «ha ridotto o la chiesa a una specie Ong».
Non solo, anche
l’ambientalismo di Francesco non gli piace: «Ha trasformato Greta (Thunberg,
l’attivista svedese) in un idolo, corre dietro a visioni solidaristiche,
politiche e sociali, al buonismo».
CONSERVATORE LIBERALE
Sul piano politico e
culturale, il politico si definisce un "conservatore liberale". Il caso vuole
che nel 1995 abbia firmato con Luigi Manconi, oggi il candidato ufficiale alla
presidenza della Repubblica di Sinistra italiana e dei Verdi, un appello per
l'uso delle droghe leggere.
In più occasioni si è detto a
favore delle unioni gay, criticando invece la chiesa: «La chiesa italiana ha
subìto il divorzio, l’aborto. Si rassegnerà anche alle unioni civili» aveva
affermato in occasione dell’approvazione della legge Cirinnà.
IL RAPPORTO CON LA LEGA
Mentre adesso sembra pronto a
diventare il nome che unisce il centrodestra, nel 1993 i rapporti con la Lega
non erano buoni: «La Lega Nord è un movimento che, anche non è
programmaticamente eversivo, rischia di esserlo, e può effettivamente portare
alla divisione del Paese. Non c’è una risposta democratica alla Lega sul terreno
della Lega». Sette anni dopo, Salvini diventa l’uomo su cui costruire una nuova
cultura di governo.
RENZI E REFERENDUM
Non è strano che il nome sia
gradito al leader di Italia viva, Matteo Renzi. Nel 2016 Pera si è
schierato dalla parte di Renzi contro Berlusconi sul referendum costituzionale,
al punto da portare avanti l’appello “Liberi Sì'” firmato da trentacinque ex
parlamentari di Forza Italia: «Sono uomini e donne che hanno fatto la storia di
Forza Italia. Tra loro c'è chi ha ricoperto il ruolo di ministro, di
sottosegretario, di presidente di Regione». Lui per primo a spendersi per
mantenere Renzi al governo.
L’ex premier non ha escluso
l’appoggio della sua compagine qualora fosse una reale possibilità per il Colle:
«Quasi tutti gli ex presidenti di assemblea sono da sempre quirinabili, specie
se hanno svolto il compito con rigore istituzionale e con apprezzamento
complessivo».
L’ipotesi di una convergenza
tra Salvini e Renzi circola da ottobre, anche se Pera è rimasto sempre vago: «Se
smentisco confermo» ha detto a fine dicembre a Libero.
LE PRESSIONI PER ENEL
Nel suo curriculum ci sono
anche rapporti poco chiari con il tessuto economico. Marco Travaglio e Peter
Gomez, nel loro saggio Se li conosci li eviti, una sorta di antologia delle
biografie dei candidati in vista delle elezioni politiche del 2008, ricordano le
sue vicende giudiziarie. Pera, scrivono, compare in un’indagine archiviata dalla
procura di Lucca nel 2007 per presunte pressioni sul sindaco di Lucca, Pietro
Fazzi, e sui vertici della Lucca Holding Spa e della Gesan Gas Spa per portare a
termine un affare con Enel.
L’«indebita» ingerenza
rilevata dai giudici dell’allora presidente del Senato risultava riscontrata,
tuttavia il reato di concussione era indimostrabile, in quanto quelle pressioni
erano state fatte per «non pregiudicare i rapporti tra Enel e presidente del
Senato», dunque senza che ci fosse alcuno scambio di denaro.
VANESSA RICCIARDI. Giornalista
di Domani. Nasce a Patti in provincia di Messina nel 1988. Dopo la formazione
umanistica tra Pisa e Roma e la gavetta giornalistica nella capitale, si
specializza in politica, energia e ambiente lavorando per Staffetta Quotidiana,
la più antica testata di settore.
Marcello Pera, l'amico
laico di Ratzinger che guidò il Senato. Può avere i voti di Renzi.
Paolo Bracalini il
26 Gennaio 2022 su Il Giornale.
Berlusconiano della prima ora
(il 1994), l'apice politico di Marcello Pera è la presidenza del Senato
raggiunta nel 2001, alla sua seconda legislatura da senatore con Forza Italia.
Filosofo, accademico di area liberale, Pera nasce come un laico ma negli ultimi
anni si avvicina al cattolicesimo grazie al magistero di Joseph Ratzinger, con
cui ha un legame di amicizia e sintonia di pensiero (hanno scritto insieme un
libro, Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, islam), mentre è molto
critico sul pontificato di Bergoglio. Dopo il 2013, quando finisce la sua
carriera parlamentare, Pera torna ai suoi amati studi, ma sempre con la politica
sullo sfondo. Nel 2016, insieme ad altri padri nobili di Fi come Giuliano Urbani
si schiera per il Sì al referendum costituzionale lanciato da Renzi. Presiede il
comitato «Liberi Sì» per radunare «tutti quei liberali, democratici, popolari,
che ritengono che il referendum sia l'occasione preziosa e irripetibile per
rendere le nostre istituzioni più efficienti, più snelle, più trasparenti». Il
referendum finisce male, come noto, ma quella posizione di Pera potrebbe ora
servire per raccogliere i voti di Italia viva. Nel 2018 è stato nominato
dall'allora premier Giuseppe Conte presidente del «Comitato storico-scientifico
per gli anniversari di interesse nazionale».
La genesi politica di Pera in
realtà è negli anni '80 con il Psi. Nel 2004 andrà ad Hammamet in visita alla
tomba di Bettino Craxi, da lui definito un «patrimonio della Repubblica», che
appartiene alla «storia della sinistra italiana». Poi agli inizi degli anni '90
si schiera con i magistrati nella lotta alla corruzione politica, mentre negli
anni successivi prende le distanze da quello che definisce il «giustizialismo
dei giudici». Nel 2001, prima di essere nominato presidente del Senato, si fa il
suo nome per il ministero della Giustizia. Per il quale ha un programma
immediato: far fuori la scrivania che fu nel 1946 del Guardasigilli comunista
Palmiro Togliatti (l'anticomunismo è un altro pilastro del suo pensiero).
Filosofo e pensatore, ma anche abile tessitore di rapporti. Dietro la sua
candidatura c'è una rete che va da Denis Verdini, a Salvini (anche per il
tramite della leghista toscana Susanna Ceccardi), a Franceschini e Luca Lotti
nel Pd, a Di Maio e Conte con cui si è sentito. Paolo Bracalini
Letizia Moratti, la lady di
ferro al timone di ministeri, Rai e Milano. Sarebbe la prima donna.
Paolo Bracalini il
26 Gennaio 2022 su Il Giornale.
La carica pubblica per cui è
più nota è quella di sindaco di Milano, nel 2006, dopo Albertini e prima di
Pisapia. È con lei che nasce la candidatura di Milano all'Expo 2015 che sarà poi
un successo (per Sala). Ma di cariche e poltrone prestigiose è piena la vita di
Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, vedova Moratti (il petroliere Gian Marco
Moratti, presidente della Saras, morto qualche anno fa). Nel secondo governo
Berlusconi era già stata ministro dell'Istruzione dando prova di un carattere da
lady di ferro (Montanelli diceva di lei «soave pugno di ferro»), celebri le sue
liti con Tremonti per i fondi alla scuola. Da ministro scese in piazza a Milano
per celebrare il 25 aprile. Sfidando i fischi e le contestazioni degli autonomi,
festeggiò la Liberazione insieme al papà, il «partigiano bianco» insignito di
due medaglie al valor militare, incassando la solidarietà del centrosinistra, da
Prodi alla Cgil. Ha guidato la Rai per un biennio, provando a privatizzarne un
canale in seguito al referendum sulla tv pubblica del '95, missione impossibile
anche per lei.
Milanese classe '49, a 25 anni
manager in campo assicurativo e poi presidente di News Corp Europe del gruppo
Murdoch, poi appunto la carriera politica, gli incarichi in società e banche,
dal gruppo Carlyle alla Bracco a Ubi Banca, di cui è stata presidente fino al
2020, quando è tornata in prima linea come vicepresidente e assessore al Welfare
(con delega sul servizio sanitario regionale) chiamata da Berlusconi e Salvini
per raddrizzare la campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia. L'altro campo a
cui si dedica da una vita è il sociale, con l'impegno decennale nella Comunità
di San Patrignano, che la convinse a lasciare il consiglio comunale di Milano. E
poi la cooperazione internazionale, nel 2015 ha fondato la E4Impact Foundation,
di cui è presidente (Obiettivo: «Formare una nuova generazione di imprenditori a
forte impatto sociale in Africa»). Nel 2018 firma insieme agli altri ex sindaci
di Milano una lettera a sostegno del presidente della Repubblica Sergio
Mattarella sotto attacco del M5s (che minacciò persino l'impeachment). Prima,
nel 2016, il suo sì al referendum costituzionale del governo Renzi. È stata la
prima donna sindaco di Milano, la prima donna a guidare la Rai. Potrà esserlo
anche per il Colle? Paolo Bracalini
Chi è Franco Frattini, il
candidato al Quirinale che piace perfino a Conte.
Giampiero Casoni il 25/01/2022
su Notizie.it.
L'uomo che potrebbe essere il
grimaldello per i grandi elettori del M5S: chi è Franco Frattini, il candidato
al Quirinale che piace perfino a Conte
Franco Frattini, il candidato
al Quirinale che piace perfino a Giuseppe Conte, potrebbe essere l’uomo giusto.
Per cosa e per chi mentre decade il Mattarella bis? Il due volte ministro degli
Esteri e fautore della legge sul conflitto di interessi, oggi presidente
del Consiglio di Stato, potrebbe diventare l’uomo da indicare per il Colle se
sul perennemente intraversato Mario Draghi non si trovasse la quadra.
Frattini potrebbe entrare in
lizza del centrodestra alla quarta chiama con il quorum un po’ sgonfiato.
Franco Frattini, il candidato
“ideale” per sopravvivere alla quarta chiama e per andare al Quirinale
Quale rosa? Open la
riassume: Elisabetta Casellati Carlo Nordio, Marcello Pera, Gianni Letta,Letizia
Moratti ed Antonio Tajani. Questi in superficie e col 90% di loro destinato a
fare “ammuina”, poi con Frattini palombaro che potrebbe sbancare. Perché? Perché
Franco Frattini piace anche fuori dal recinto del centrodestra, piace
ai Cinquestelle per una serie di “piacionerie” vissute a suo tempo con Giuseppe
Conte.
Chi ha fatto il nome di Franco
Frattini come candidato al Quirinale non solo del centrodestra
E non è un caso che l’ex
premier abbia fatto il nome di Frattini con il playmaker del centrodestra Matteo
Salvini. Franco Frattini è nato nel 1957 a Roma. È laureato in giurisprudenza,
ha fatto l’avvocato di Stato nel 1984 ed è passato al Tar Piemonte. Frattini è
stato due volte alla guida della Farnesina nei governi Berlusconi. Nel governo
Dini ebbe invece la Funzione Pubblica.
Dopo il 2012 lasciò Forza
Italia per passare con Scelta Civica di Monti. Consigliere giuridico di Claudio
Martelli e già segretario generale della presidenza del Consiglio nel 1994, ha
presieduto il Comitato di Controllo dei servizi segreti. Dalla Farnesina
caldeggiò l’appoggio logistico all’invasione dell’Iraq da parte degli Usa ed è
l’autore della legge sul conflitto d’interessi del 2004. Frattini è buciabile
come gli altri ma qualche skill aggiuntiva ce l’ha. Glie la potrebbe dare
proprio Salvini, che sta cercando di portare a casa non solo un presidente, ma
anche un esecutivo gradito.
La regia di Salvini e
l’opzione di Franco Frattini candidato al Quirinale, con “l’aiuto della Russia”
Se Draghi va al Colle Salvini
vuole uno scranno da ministro, se Draghi resta vuole accreditarsi come
regista di un’operazione che metta sotto i corazzieri un uomo su cui ha lavorato
lui, magari con l’inavvicinabile (si far per dire) Conte. Ma quali furono le
“piacionerie” che Frattini e Conte si fecero e che potrebbero fare breccia nella
hit del presidente M5S? C’entra la Russia: Frattini fu con Conte nel chiedere
lo stop delle sanzioni europee a Mosca e nel 2018 lo accreditò con Sergey
Lavrov, il potentissimo capo dei diplomatici di Putin.
Grazie dei fior, però… Così
i giallo-rossi rifiutano i nomi del centrodestra.
Pd, M5S e Leu rispediscono al
mittente la terna Moratti-Pera-Nordio, senza lanciare una rosa alternativa al
centrodestra. Letta propone un conclave a tutti i partiti. Rocco Vazzana su Il
Dubbio il 25 gennaio 2022.
Grazie dei fior, ma non
possiamo accettare. Risponde più o meno così, in serata, il trio
Letta-Conte-Speranza alla rosa dei nomi per il Quirinale presentata dal
centrodestra. Nessun appunto sui profili scelti, definiti inizialmente «di
qualità», ma i giallo-rossi preferirebbero figure maggiormente condivise. Senza
però mettere sul piatto controproposte utili.
Il vertice del centrosinistra,
infatti, si conclude con la scelta di non fornire rose alternative, un po’ per
evitare un clima da contrapposizione e un po’ per nascondere le profondissime
divisioni interne. «Prendiamo atto della terna formulata dal centrodestra che
appare un passo in avanti, utile al dialogo», fanno sapere i tre leader
giallo-rossi, convinti però che «che su quei nomi» non «possa svilupparsi la
larga condivisione in questo momento necessaria». Porta educatamente chiusa in
faccia, dunque a Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera, i tre candidati,
«senza tessere di partito in tasca» proposti da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e
Antonio Tajani.
Lo schema digiallo-rosso
pretende un profilo «super partes». Che per Letta significa Mario Draghi e per
Conte chiunque tranne l’attuale premier. Per venirne a capo, il segretario del
Pd propone il metodo “conclave” ad alleati di coalizione e di governo:
«Chiudersi dentro una stanza, buttare via la chiave e stare a pane e acqua fino
ad arrivare a una soluzione finale», dice Letta, uscendo dal vertice. Da giovedì
si potrà eleggere il capo dello Stato a maggioranza semplice, è dunque arrivato
il momento di «smetterla con il tatticismo. Dobbiamo chiuderci in una stanza e
arrivare a una soluzione con un nome condiviso, super partes e senza forzature»,
aggiunge il leader dem. Il centrosinistra chiede dunque un incontro per oggi con
tutte le delegazioni. E solo allora i giallo-rossi, fanno capire, scopriranno le
carte con i loro “jolly”.
L’obiettivo di Letta è
duplice: scongiurare che qualcuno metta il cappello sull’elezione del nuovo
presidente e troncare il dialogo troppo fitto tra Salvini e Conte, decisi a
fermare il cammino del presidente del Consiglio.La soluzione individuata, in
realtà, serve solo a coprire lo stallo delle trattative sul Quirinale e prendere
ancora tempo. Un atteggiamento insensato, secondo Matteo Renzi, abituato a
giocare da protagonista le partite del Palazzo e momentaneamente escluso da
entrambi i tavoli: «Si fanno le rose senza il coraggio di votare i nomi», scrive
sulla sua E-news. «Alla terza votazione per il Presidente della Repubblica non
si fanno le rose, si votano i nomi: facciamo politica, non sondaggi d’opinione.
Si perde tempo con una votazione al giorno (torniamo almeno a fare due votazioni
al giorno). E manca la regia politica», aggiunge il leader di Italia viva.
Ma dentro le coalizioni e
soprattutto all’interno dei singoli partiti le lacerazioni sono troppo profonde
per immaginare che qualche leader sia in grado di intestarsi la regia politica
del film quirinalizio. Salvini deve districarsi tra l’unità della maggioranza e
quella dell’alleanza da lui guidata, consapevole che basta spostare un
mattoncino per far venir giù almeno una delle due case. Letta, già alle prese
col governo complicato del suo partito, dichiara di avere un ruolo («proteggere
Draghi») profondamente diverso da quello di Conte («difendere l’interesse
nazionale»). Sullo sfondo: il rischio elezioni anticipate che terrorizza più
della metà dei protagonisti. E in questo clima di incertezza e diffidenza – in
cui nessuno schieramento ha i numeri per far da sé – il guizzo del regista tarda
ad arrivare.
Non resta che prender tempo e
tenere fuori dalle rose ufficiali qualche nome da tirar fuori all’occorrenza,
come quelli di Maria Elisabetta Casellati e Pirferdinando Casini, i candidati
ufficiosi di cui tutti chiacchierano nei corridoi di Montecitorio, senza che
nessuno li schieri a viso aperto. E in attesa di una mossa del cavallo, oggi il
centrodestra, al terzo scrutinio, l’ultimo a maggioranza qualificata, potrebbe
scegliere di votare uno dei tre candidati messi in lista, giusto per testare la
tenuta della coalizione.Tanto la partita vera inizierà solo giovedì. E senza una
soluzione realmente condivisa, in tanti sperano ancora in “San Mattarella”, come
recita il meme che in serata spopola sulle chat grilline.
Quel tabù della sinistra
che esclude la destra dal Colle.
Le reazioni isteriche alla
stravagante e improbabile candidatura di Silvio Berlusconi sono soltanto
l’aspetto più fastidioso di un pregiudizio profondo, che ha le sue radici nel
secondo dopoguerra. Daniele Zaccaria su Il Dubbio il 25 gennaio 2022.
È un patto gentilizio,
un’alleanza di ottimati, un’intesa tra maggiorenti e virtuosi. Ma soprattutto è
il tabù più resistente della seconda repubblica: stiamo parlando
dell’esclusione, quasi de jure, del centrodestra dalla corsa al Quirinale.
Le reazioni isteriche alla
stravagante e improbabile candidatura di Silvio Berlusconi sono soltanto
l’aspetto più fastidioso di un pregiudizio profondo, che ha le sue radici nel
secondo dopoguerra, ossia nel bipolarismo catto-comunista che disegnava il
cosiddetto arco costituzionale. L’idea è semplice: la Costituzione antifascista
può essere custodita solo dagli eredi di quelle due famiglie politiche che,
guarda caso, da tre decenni costituiscono l’ossatura del centrosinistra. Nel
corso degli ultimi 30 anni abbiamo avuto due presidenti ex
democristiani (Scalfaro e Mattarella, un ex Pci (Napolitano) e un laico
progressista (Ciampi). In nessuna di queste tornate un candidato proveniente dal
blocco Forza Italia-An-Lega ha mai avuto la possibilità concreta di aspirare
alla prima carica dello Stato.
Si è negoziato senza problemi
per le presidenze di Camera e Senato ma mai per il Colle. Ciò non vuol dire,
come pretendono puerilmente in molti nel centrodestra, che a questo giro “tocchi
a loro”. L’elezione di un presidente della Repubblica non segue logiche
riparatorie o una turnazione meccanica. Ma neanche che vengano esclusi dalla
corsa per partito preso, come a dover scontare il peccato originale di essere
stati berlusconiani o comunque sodali del Cavaliere e del suo fantomatico
progetto “eversivo”. La destra non è la landa dei barbari e al suo interno ci
sono diverse personalità moderate, capaci di mediare tra i veti e i capricci dei
partiti e di assumere un ruolo super partes. Continuare a considerarli degli
appestati illegittimi è soltanto un vecchio imbroglio politico.
Dubbi, confusioni e
incertezze sul ruolo del Capo dello Stato. Presidente della Repubblica, quanto
ne sanno gli italiani: tra gaffe e amnesie il test sul Quirinale.
Redazione su Il Riformista
il 25 Gennaio 2022.
Mancano poche ore alla fine
del secondo giorno di chiama per eleggere il Presidente della Repubblica e gli
italiani osservano con incertezza i movimenti dei partiti politici. Le elezioni
hanno acceso gli animi di politici e cittadini. Mentre circolano i nomi del
successore di Sergio Mattarella, tra giochi politici e vecchie alleanze, fuori
dalla Camera aleggia confusione sul ruolo e i compiti del Capo dello Stato.
Mentre c’è chi balbetta
sorridente per non sapere che una persona, per essere eletto Presidente, deve
avere almeno 50 anni di età, c’è chi ostenta preparazione e consapevolezza. I
cittadini romani, tra shopping e una passeggiata nella fredda via del Corso,
hanno saputo rispondere senza esitazione su chi ha impacchettato le ultime cose
prima di lasciare il Quirinale. A tentennare sono soprattutto i giovani che sono
un po’ imbarazzati per non riuscire a rispondere a qualche domanda. La
separazione tra nuove e vecchie generazioni si è andata via via allargando se si
guardano i numeri dei sondaggi che vedono i ‘giovani’ e ‘coloro che si informano
prevalentemente sui social’ come le categorie meno interessate a questa
elezione.
“Mi trovi impreparato”, ha
detto un giovane che ha balbettato qualche risposta. Mentre un ragazzo ha
azzardato persino come i cittadini siano attualmente impegnati in una lunga
tornata elettorale per scegliere il Presidente della Repubblica che deve avere
almeno 18 anni, “anzi no, deve essere più anziano”, si è poi corretto. Qualcun
altro, invece, ha tentennato su quanti Capi dello Stato sono stati i garanti
della Costituzione. “Ce ne sono stati 16, o forse 17”, ha detto un ragazzo,
mentre una giovane donna ha persino affermato che al Quirinale, in 76 anni di
storia della Repubblica italiana, ci fossero stati quattro Capi di Stato. Per
un’altra, invece, il primo Capo dello Stato è stato Carlo Azeglio Ciampi,
dimenticando, però, che quest’ultimo è stato il decimo Presidente della
Repubblica.
L’incertezza, poi, ha prevalso
sui compiti del Capo dello Stato: molti sono caduti in confusione alla domanda
sul potere del Presidente della Repubblica di dichiarare lo stato di guerra.
“Non c’è mai stata l’occasione, fortunatamente”, ha detto un’anziana signora.
“Non farmi parlare di chi comanda in questo Paese”, ha detto invece in romanesco
un’altra signora rifiutando di rispondere alle domande.
Prima che senatori e deputati,
insieme ai ‘grandi elettori’, eleggano il nuovo Presidente della Repubblica, è
meglio che gli italiani aprano i libri per ripassare chi è e cosa fa il Capo
dello Stato.
Michele Ainis per "la
Repubblica" il 25 gennaio 2022.
Girano regole bizzarre attorno
all'elezione del prossimo capo dello Stato. Anzi: doppiamente bizzarre, giacché
nel Paese delle cinquantamila leggi le regole in questione sono figlie d'una
lacuna normativa, derivano insomma da un vuoto di diritto. Eppure il paradosso
si profila già al momento della scelta, durante l'espressione del voto. In
questo caso mancano, difatti, candidature avanzate ufficialmente dai partiti. La
Costituzione non le vieterebbe, ma una prassi battezzata nel maggio 1948 (quando
fu eletto Einaudi) qualifica il Parlamento in seduta comune come collegio
imperfetto, dove si vota ma non si può discutere sull'oggetto del voto.
Di conseguenza il primo
accorgimento del candidato perfetto è negare l'esistenza stessa della sua
candidatura, per evitare di bruciarla. Da qui un festival dell'ipocrisia, ma da
qui inoltre un velo d'opacità sull'elezione, che si consuma in conciliaboli
nelle segrete stanze dei partiti, mentre ai cittadini non resta che sbirciare
dal buco della serratura. Infine viene fuori un nome. Quale? Poniamo Mario
Draghi.
Ma poniamo altresì che si
chiami Draghi Mario anche un postino di Siena, e che il giorno dopo quest'
ultimo si presenti ai corazzieri per cominciare il suo mandato. Dopotutto, ne
avrebbe buon diritto. Mancando candidature formali, mancando una lista
elettorale affissa nei seggi come avviene alle politiche, per quale ragione non
potrebbe essere proprio lui l'eletto? Risposta: perché evidentemente si presume
che il nuovo presidente sia persona già nota agli italiani, e non è il caso del
postino.
Però si tratta di un'altra
regola non scritta, di un'altra toppa sopra il buco delle regole. E Mattarella?
Scade il 3 febbraio, ma con l'aria che tira non è detto che quel giorno il
Parlamento abbia già trovato il successore. Che ne sarà, quindi, di lui? La
Costituzione non lo dice. L'articolo 85, difatti, menziona un'ipotesi diversa:
se le Camere sono sciolte, o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione,
l'elezione slitta, mentre il presidente viene prorogato. Sicché delle due l'una:
o s' estende per analogia la prorogatio anche a questo caso, oppure il 3
febbraio subentrerà il supplente, cioè la presidente del Senato.
Più giusta la prima soluzione,
tuttavia, giacché la supplenza muove da un "impedimento" del capo dello Stato,
mentre qui l'impedito è il Parlamento. Che perciò potrebbe giocare uno
scherzetto al vecchio presidente: per rieleggerlo basta non eleggerlo, basta
mandare a vuoto ogni successiva votazione, tanto lui verrebbe prorogato. Chi
invece non può subire proroghe è il presidente del Consiglio, ove venga eletto
al Quirinale. Dovrà dimettersi con effetto immediato, dato che la Costituzione
vieta il doppio mestiere.
E il governo, chi lo guida?
Silenzio: nessuna norma disciplina l'ipotesi in questione, né la morte (facciamo
gli scongiuri) del premier in carica. L'unica regola si legge nell'articolo 8
della legge n. 400 del 1988: nel caso d'impedimento temporaneo, il timone passa
al vicepresidente del Consiglio, ovvero - "in assenza di diversa disposizione da
parte del presidente del Consiglio" - al ministro più anziano. Basta perciò
applicare (un'altra analogia) la norma che disciplina questa situazione
all'impedimento permanente, e il rebus si risolve. Sicuro?
Un conto è un automatismo, per
cui se manca il generale il comando passa al colonnello. Un altro conto è
conferire al generale il potere di nominare il caporale. Tanto più che il
premier, nel nostro ordinamento, non ha la facoltà di revocare i suoi ministri,
mentre avrebbe viceversa l'autorità di nominare il successore, come gli
imperatori dell'antica Roma. E siccome la regola varrebbe anche se il presidente
del Consiglio muore (doppi scongiuri), dovremmo immaginare che quest' ultimo si
rechi dal notaio per fare testamento: lascio la casa al figlio, l'automobile al
nipote, Palazzo Chigi al ministro dello Sport. Ma è il bello delle regole che ci
cadono addosso come tegole: se qualcuno ci rimette, qualcun altro giocoforza ci
guadagna.
III GIORNO DI VOTAZIONI.
Il live minuto per minuto
della terza giornata: ancora fumata nera.
Elezione Presidente della
Repubblica, la diretta del voto. Salvini smentisce incontro con Cassese e
attacca: “Da Pd e M5S mai proposte”. Redazione su Il Riformista il 26 Gennaio
2022.
Fumata nera per la terza
giornata dedicata all’elezione del 13esimo presidente della Repubblica, l’ultima
con il quorum di 2/3. Sono diminuite le schede bianche, scendendo dalle 527 di
ieri a 412. Durante lo spoglio si sono imposti i nomi di Sergio Mattarella e
Guido Crosetto, lanciato a sorpresa da FdI. Per l’attuale Capo dello Stato sono
spiccati i 125 voti, mentre quelli incassati dal cofondatore di Fratelli
d’Italia sono 114, quasi il doppio dei 63 grandi elettori del partito di Giorgia
Meloni. Al terzo posto si piazza il giurista Maddalena con 61 voti di
Alternativa c’è e di molti ex M5s, seguito da Casini che raggiunge quota 52.
Il successore di Sergio
Mattarella (che ha in diverse occasioni ribadito che non è in corsa per un
secondo mandato) sarà il 13esimo Presidente della Repubblica Italiana. Fino alla
terza votazione necessaria la maggioranza dei due terzi dell’assemblea, 673
voti, dalla quarta in poi basterà la maggioranza assoluta, 505.
Causa covid-19 si terrà una
sola votazione al giorno. Al massimo 50 elettori alla volta in aula per votare.
I Grandi Elettori positivi potranno votare nel parcheggio della Camera con un
seggio drive-in appositamente allestito nel parcheggio della Camera. A votare i
1009 cosiddetti Grandi Elettori: 630 deputati, 321 senatori (di cui 6 a vita, 5
di nomina presidenziale e un ex presidente della Repubblica) e 58 delegati
regionali, tre per ogni Regione, uno solo per la Valle d’Aosta. Votano prima i
senatori, poi i deputati e infine i delegati regionali. Il voto è anonimo:
perciò le elezioni del Capo dello Stato sono il regno dei franchi tiratori. Solo
in due occasioni, nel 1985 con Francesco Cossiga e nel 1999 con Carlo Azeglio
Ciampi, il Presidente venne eletto alla prima seduta.
Caos e ore di trattative
febbrili tra i partiti. Il leader e fondatore di Forza Italia Silvio
Berlusconi ha sciolto la riserva: fallita l’operazione scoiattolo, ha rinunciato
alla corsa al Quirinale. Scricchiola la candidatura del Presidente del Consiglio
in carica, dato da mesi per favorito, Mario Draghi. Ancora preso in
considerazione per alcuni il secondo mandato di Sergio Mattarella. Le
ipotesi Pierferdinando Casini e Giuliano Amato ancora in corsa, come quelle
di Marta Cartabia ed Maria Elisabetta Alberti Casellati. New entry della prima
giornata: il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi e la
direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza Elisabetta Belloni.
Nel secondo giorno il fronte
progressista ha respinto la terna di nomi proposta dal centrodestra
(Pera-Moratti-Nordio), i più votati risultano l’attuale inquilino del Colle
Sergio Mattarella e l’ex magistrato Paolo Maddalena, candidato promosso dal
gruppo di Alternativa. Entrambi raccolgono 39 preferenze, ma a salire rispetto a
ieri è soprattutto il capo dello Stato uscente, che raccoglie 23 voti in più.
Invariato il numero di grandi elettori presenti e votanti (976), si abbassa il
numero delle schede bianche (527 rispetto alle 672 del primo scrutinio), quello
delle nulle (38 rispetto a 49), mentre salgono i voti dispersi che toccano quota
125 (ieri 88).
Alle 11 si riunisce il
Parlamento in seduta comune per la terza votazione, l’ultima con il quorum di
2/3, ma c’è chi chiede di velocizzare da giovedì le operazioni per cercare di
chiudere la partita in settimana. “Spero che la presidenza autorizzi le
votazioni due volte al giorno – dichiara il leader di Italia Viva, Matteo Renzi,
intercettato in Transatlantico durante le votazioni -. C’è una crisi in Ucraina
pesantissima, la crisi su energia e gas, regole assurde per la scuola: il
Parlamento abbia la consapevolezza di quello che si sta giocando”. Richiesta poi
formalizzata da una lettera inviata dalla capogruppo di Italia viva a
Montecitorio, Maria Elena Boschi, al presidente della Camera, Roberto Fico: “Le
misure per garantire sicurezza sanitaria e limitare la possibilità di contagi
durante le operazioni di voto possono essere messe in pratica anche nel caso di
una seconda votazione nel corso della stessa giornata”.
“No a una guerra delle due
rose, non serve”. Pd, M5S e Leu non rispondono con altri nomi d’area alle
candidature di Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio avanzate dal
centrodestra. Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, a sera, dopo un
faccia a faccia che va avanti per quasi due ore, definiscono “un passo in
avanti, utile al dialogo” la mossa fatta dai leader del campo ‘avversario’. Sono
“nomi di qualità e li valuteremo senza spirito pregiudiziale”, si spinge a dire
il segretario dem e anche Stefano Patuanelli, capodelegazione pentastellato al
Governo, li definisce ipotesi “di peso”.
La strada, però, resta
sbarrata. “Non riteniamo che su quei nomi possa svilupparsi quella larga
condivisione in questo momento necessaria”, mettono nero su bianco i
rappresentanti della coalizione progressista. Nessuna contrapposizione di
‘area’, quindi, ma la “volontà di giungere ad una soluzione condivisa su un nome
super partes”. Per questo, la proposta è riunire domani le due delegazioni.
“Chiudiamoci dentro una stanza, buttiamo via la chiave e stiamo a pane e acqua
fino ad arrivare a una soluzione finale”, dice chiaro Letta. “Acceleriamo il
dialogo con il centrodestra con l’impegno di trovare nelle prossime ore una
soluzione condivisa.
LA DIRETTA
Ore 08.30 – “Casellati? È la
seconda carica dello Stato, non ha bisogno di essere candidata…. Pera, Moratti e
Nordio sono nomi all’altezza. Spero che Conte e Letta non si fermino ai no”. Lo
dice Matteo Salvini prima di andare nei suoi uffici a Montecitorio. “Il mio
tentativo è quello di dialogare” conclude il leader della Lega. “Il nuovo
premier non lo troviamo a Campo de Fiori…Stiamo lavorando già a un Presidente
della Repubblica e io ho un’idea. Qualora Draghi lasciasse il governo avremmo
settimane di confusione, sarebbe un problema per l’Italia, con la crisi
economica, sanitaria…”. “A parte che se perdo tre chili male non mi fa, ma il
mio tentativo e’ dialogare, ma per farlo bisogna essere in due. Se mi siedo a un
tavolo e mi dicono, ‘sono pronto a dialogare ma qualunque nome tu mi faccia è
no’, allora si capisce che è un dialogo un po’ particolare. Noi dei nomi li
abbiamo fatti. E ne potremmo farne altri dieci all’altezza, speriamo che ce ne
sia uno di questi nomi che vada bene, dopo 30 anni uno non di sinistra”.
Ore 09.05 – “Con i tre nomi
del centrodestra si è fatto un passo in avanti, stiamo parlando finalmente di
iniziare a discutere, a votare nomi. Basta con questa manfrina delle schede
bianche che mal si lega alla situazione che stiamo vivendo. Bisogna fare
presto”. Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi a Cartabianca, su
Rai3 “Sono nomi di livello, – aggiunge – ma noi domani non li voteremo”. Ipotesi
Casellati? “Che il centrodestra presenti tre candidati per tirare il terzo mi
sembra mancanza di rispetto ai tre candidati, come dire che sono finiti”.
“Se penso che Draghi possa
andare al Quirinale ?Assolutamente sì. E sono contento che questo paese si sia
innamorato di Draghi, perchè un anno fa quando dicevo che bisognava mandare a
casa Conte mi dicevano che ero pazzo”. Lo ha detto il leader di Italia viva
Matteo Renzi a Cartabianca, su Rai3 affermando: “Sono stato più draghiano di
Draghi”. “Non vedo l’idea che comunque vada Draghi rischi di lasciare il
governo. – aggiunge – Io però non sono convinto che la partita non sia chiusa,
nè alla quarta, nè alla quinta, nè alla sesta votazione secondo me Draghi è
ancora in pista per fare il presidente della Repubblica”.
Ore 10:30 – Come nelle prime
due giornate di voto, e nell’attesa di trovare un accordo su un nome condiviso,
i partiti confermeranno l’indicazione della scheda bianca. È questa infatti la
scelta di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Leu da una parte e della
coalizione di centrodestra dall’altra.
Ore 11:00 – Via al terzo
giorno di votazioni a Montecitorio per eleggere il Presidente della Repubblica.
Ore 11.45 – Fratelli d’Italia
si smarca dal centrodestra e, per ora, non sta rispondendo alla prima chiama
della terza votazione per il capo dello Stato. Il partito di Giorgia Meloni,
raccontano, infatti, ancora non ha deciso se votare scheda bianca come il resto
della coalizione. L’ufficialità in una nota: il partito di Giorgia Meloni
indicherà il nome di Guido Crosetto.
Ore 11.55 – “Anche oggi,
facendo seguito al nostro patto di consultazione, come Europa Verde e Sinistra
Italiana voteremo convintamente Luigi Manconi alla Presidenza della Repubblica”
affermano i co-portavoce nazionali di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi
e ii segretario nazionale di sinistra italiana Nicola Fratoianni. “Una figura
che può creare quella convergenza fondamentale che può far superare le barriere
degli schieramenti.”
Ore 12.20 – Matteo Renzi a
La7: “Io ho detto a Letta e Salvini che se avessero deciso di fare il conclave
saremo andati per discutere, ma per far che? È uno show che non sta in piedi”.
Poi aggiunge, sulla poltrona del Senato che in caso di elezione di Casellati lo
vedrebbero in pole position per sostituirla: “Io penso di essere l’uomo politico
più antipatico d’Italia ma non faccio mai una battaglia per un posto per me. Mai
uno scambio che mi vede al Senato“. Inoltre da uno guardo alle prossime
votazioni: “Voi state facendo uno schema che alla quarta Salvini e Meloni
portano la Casellati. Questo disegno punta a ricostituire la maggioranza
gialloverde, e se andasse avanti il centrosinistra tenterebbe il controblitz“.
“La destra – aggiunge il senatore – ha due obiettivi: mettere in campo tre
candidature di livello e ottenere il presidenzialismo. Se lo fa porta a casa il
risultato, ma se perde ottiene il capolavoro di un altro presidente di
sinistra“. Renzi sottolinea l’urgenza di arrivare a un nome: “Un presidente
della Repubblica non si fa facendo a gomitate. Il gioco a contendersi i resti
dei 5s non ha senso, mettiamoci insieme e individuiamo un nome (Draghi va
bene, Casini va bene).
Ore 12.58 – Il capogruppo di
Fratelli d’Italia al Senato Luca Ciriani: “FdI non partecipa a nessun conclave“.
Ore 13:00 – Le possibilità di
una ‘ascesa’ al Quirinale della Casellati si riducono. A chiarire infatti la
posizione del Movimento 5 Stelle è Stefano Buffagni, ricordando i ‘precedenti’
del presidente del Senato sul caso Ruby-Mubarak. “Sono sicuro che il
centrodestra alla fine non tirerà fuori dal cilindro il nome di Elisabetta
Casellati. Non potrei mai votare come presidente della Repubblica, e come me
tutto il m5s, chi ha avuto il coraggio di avallare la tesi di Ruby nipote di
Mubarak e che ha utilizzato voli di Stato durante il lockdown per recarsi in
vacanza in Sardegna”, scrive su Facebook Buffagni.
Ore 13:15 – Mentre l’ipotesi
di ‘conclave’ si allontana, sono in corso contatti tra i vertici del Partito
Democratico e il leader della Lega Matteo Salvini. Fonti dem spiegano il
tentativo del partito è di convincere Salvini a non procedere domani, nella
quarta votazione, in autonomia su un nome di centrodestra come quello
della Casellati perché in questo modo salterebbe la maggioranza che regge il
governo Draghi.
Ore 13:45 – Sara Cunial,
deputata eletta tra le fila del Movimento 5 Stelle e oggi passata nel gruppo
Misto, tramite l’avvocato Edoardo Polacco ha presentato querela nei confronti
del presidente della Camera Roberto Fico e contro ignoti, poiché era stata
respinta al seggio drive-in, dove ha tentato di votare per l’elezione del
presidente della Repubblica, nonostante fosse sprovvista di green pass. “Ciò che
sta avvenendo è gravissimo. In questi giorni, si sta impedendo a un parlamentare
democraticamente eletto dal popolo italiano, di esprimere legittimamente il
proprio mandato e di adempiere al proprio incarico, anzi al suo più alto
incarico in relazione all’elezione del Presidente della Repubblica”, ha
affermato Cunial, che ha definito il provvedimento “un atto illegittimo, lesivo
non solo dei miei diritti ma della nostra stessa Carta Costituzionale e della
normativa nazionale e internazionale di riferimento”.
Ore 14:13 – Terminata
nell’aula di Montecitorio la terza votazione, è iniziato lo spoglio che viene
effettuato personalmente dal presidente della Camera Roberto Fico.
Ore 14:45 – Lungo incontro
tra Enrico Letta e Matteo Renzi alla Camera, negli uffici del gruppo di Italia
viva. Il colloquio, spiegano fonti del Nazareno, è servito “per concordare i
prossimi passi”.
Ore 14:59 – A spoglio in corso
sono quasi cento i voti per Sergio Mattarella (ieri le preferenze sono arrivate
a 39). Segue Guido Crosetto, votato oggi dai grandi elettori di Fratelli
d’Italia. Segue il candidato di Alternativa C’è, Paolo Maddalena. Cresce anche
Pier Ferdinando Casini. Preferenze anche per Giancarlo Giorgetti, Umberto Bossi,
l’ex generale Antonio Pappalardo. Voti poi a Marta Cartabia e Pierluigi Bersani.
Ore 15.38 – 125 voti per
Sergio Mattarella, Guido Crosetto proposto da Fratelli d’Italia, ha raccolto 114
voti, Paolo Maddalena 61, Pierferdinando Casini 52. I votanti al terzo
scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica sono 978. Voti dispersi
84, schede nulle 22. Domani quarto scrutinio alle ore 11 con quorum a 505.
“Sono onorato. Non ho seguito
alcuno spoglio ma sono commosso. C’è la capacità del centrodestra di essere
attrattivo anche fuori dal centrodestra”, ha commentato così Guido Crosetto, a
Montecitorio, il risultato della terza votazione. L’ex deputato ha superato i
cento voti, poco meno di quelli ricevuti dall’attuale Presidente della
Repubblica in carica ancora fino a giovedì 3 febbraio.
Ore 15:50 – Da Enrico
Letta arriva un messaggio chiarissimo sulla possibile candidatura di Maria
Elisabetta Casellati da parte del centrodestra, che pensa ad una prova di forza
nella quarta di votazione di giovedì con quorum abbassato a 505. Per il
segretario Dem “proporre la candidatura della seconda carica dello Stato,
insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe
un’operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile.
Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto”.
Ore 16:30 – Il bello della
diretta, o per meglio dire della “Maratona Mentana”. Il direttore del tg di La7
ha infatti ricevuto una telefonata in diretta di Beppe Grillo, il garante e
cofondatore del Movimento 5 Stelle, che ha smentito la ricostruzione di questa
mattina secondo cui avrebbe telefonato a Giuseppe Conte per convincere il
leader pentastellato a votare Draghi al Quirinale.
Ore 16:45 – La guerra per il
Quirinale tra Lega e M5S: Di Maio e Giorgetti contro Conte e Salvini
Ore 16:50 – “Lavoro con
fiducia, serietà e ottimismo. La soluzione può essere vicina“, dice il leader
della Lega Matteo Salvini, che ha convocato una riunione con i governatori del
Carroccio alle 17,30 e con i vertici del partito alle 18. Successivamente il
segretario della Lega vedrà i gruppi parlamentari e potrebbe anche fare un nome
nuovo per il Colle superando la candidatura della Casellati.
Sullo sfondo resta la
possibilità di un incontro Letta-Salvini in serata, che potrebbe portare ad una
soluzione che sblocchi l’impasse.
Ore 17.35 – “Se domani si va
al muro contro muro tra centrodestra e centrosinistra, si rischia di
spaccare seriamente la maggioranza. Cerchiamo un nome condiviso tra centrodestra
e centrosinistra”, dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, interpellato
sugli scenari in vista della quarta votazione per l’elezione del presidente
della Repubblica.
Ore 18:05 – Fratelli
d’Italia si mette di traverso su una possibile trattativa sul nome condiviso per
il Quirinale. Il partito di Giorgia Meloni infatti in una nota sottolinea di
ritenere “imprescindibile una votazione compatta del centrodestra su un
candidato della coalizione, come concordemente valutato nell’ultimo vertice”,
ovvero uno tra Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. FdI quindi affida
a Matteo Salvini “il mandato individuare, attraverso le sue molteplici
interlocuzioni, il candidato più attrattivo tra quelli presentati ieri”.
Ore 18:33 – Gianni Letta
presidente della Repubblica, il jolly di Berlusconi e Salvini per convincere il
nipote Enrico
Ore 19:00 – Il segretario
della Lega Matteo Salvini avrebbe incontrato il giudice emerito della Corte
Costituzionale ed ex ministro Sabino Cassese nella sua casa ai Parioli. La
notizia è stata smentita dalla Lega
Ore 19:30 – Il leader del
Carroccio smentisce qualsiasi incontro con il costituzionalista Sabino Cassese.
“Non so dove abita“, assicura il leader della Lega. “Abita ai Parioli? Non ci
sono stato oggi dalle parti dei Parioli…”. Poi avvisa i giornalisti: “Tenete i
telefonini accesi perché sarà una lunga notte di lavoro“. Salvini non ha voluto
anticipare cosa voterà domani il centrodestra nella quarta votazione: “Avendo
riunito i miei 200 elettori mi sembra più rispettoso parlarne prima con loro che
con la libera stampa”. Quando gli viene chiesto dell’esclusione di Draghi e
Casini, regala una chicca: “Non mi piace escludere, non sono nato per escludere
ma per includere (e i migranti?, ndr), per proporre. Continuo a ritenere, come
penso la stragrande maggioranza degli italiani, imprenditori, artigiani, che
Draghi sia prezioso nel suo ruolo di regista, coordinatore, collante di una
coalizione di governo che ovviamente è amplissima – ha aggiunto arrivando alla
riunione con i parlamentari della Lega -. Senza Draghi penso che avrebbe qualche
difficoltà di linea di direzione”. Infine bacchetta Pd e M5S: “Stiamo lavorando,
continuiamo a lavorare per offrire nomi di alto profilo ma non possiamo
permettere che il Paese rimanga ostaggio di no e veti della sinistra. Abbiamo
fatto nomi di altissimo profilo, altri ne faremo. Da Pd e M5s invece sono
mancate le proposte”.
Ore 20:10 – “Stiamo cercando
di convincere le forze di centrodestra a evitare esibizioni muscolari che
significherebbero contrapposizione, lo spirito opposto a quel clima che stiamo
costruendo”. Sono le parole del leader del M5S Giuseppe Conte all’uscita da
Montecitorio. “Se domani dovesse venire una proposta di parte, una prova di
forza si ritarda ancora la soluzione – ha sottolineato Conte – la Presidente
Casellati è la seconda carica dello Stato, come può essere strumentalizzata per
una prova di forza? Non avrebbe proprio senso, sarebbe un cortocircuito”.
“Cassese? Non so nulla” ha aggiunto. Poi ribadisce: “Non è questione di
conclave, l’importante è coltivare lo spirito di questo confronto e trovare una
soluzione… Le forze di centrosinistra avrebbero tanti candidati degnissimi da
proporre. Il centrodestra altrettanto. Lo schema che da subito ho proposto,
complice il fatto che il M5S è una forza innovatrice, è puntiamo subito a
un candidato super partes, autorevole, ampiamente condiviso”.
Ore 20:40 – Si profila una
notte di incontri per sciogliere il nodo sul nome da portare domani in aula per
la quarta votazione sul presidente della Repubblica. Il vertice del centrodestra
dovrebbe riunirsi dopo le ore 22. L’incontro dovrebbe avvenire in parte in
presenza e in parte in streaming, dal momento che Antonio Tajani e Licia
Ronzulli si trovano a Milano. In base a quanto viene riferito, fra i nomi sul
tavolo ci sarà quello di Pier Ferdinando Casini. L’ex presidente della Camera
oggi ha ricevuto 52 voti e la sua candidatura è spinta dai centristi. “Se fosse
il centrodestra a proporlo, il centrosinistra non potrebbe non votarlo”, è il
ragionamento che viene fatto. Nulla, però, viene spiegato, è ancora chiuso. Ma
il M5S alza le barricate. Se Pd, Iv e centrodestra vogliono votare
Pierferdinando Casini lo facciano pure ma si preparino a sostenere da solo il
governo, M5s va all’opposizione. E’ questa la voce che circola tra i
pentastellati.
Ore 21:10 – L’area del
centrodestra frena su Casini. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari
la Lega non punterebbe su Casini e neanche Fratelli d’Italia sarebbe propensa ad
aprire. Anzi. Per il Pd, in realtà, l’ex presidente della Camera sarebbe un
‘piano B’, ma i centristi insistono che se non c’è Draghi allora c’è Casini.
Potrebbe aprire, invece, secondo quanto si apprende Forza Italia ma solo una
parte del Movimento 5 stelle. Il Pd punta ad una soluzione istituzionale, ad
un’intesa che non crei scossoni sia per quanto riguarda la partita di palazzo
Chigi che su quella sul Colle. Il vertice del centrodestra è convocato alle
22.30, posticipato di mezz’ora rispetto a quanto inizialmente candidato.
Ore 21: 15 – Malumori spuntano
tra Fdi e Lega. Fonti del partito guidato da Giorgia Meloni sostengono che la
decisione di votare Guido Crosetto da parte di Fratelli d’Italia “era concordata
con Matteo Salvini”, che non “avrebbe mosso obiezioni”.
Ore 21.25 – Posticipato il
vertice dei leader del centrodestra: si terrà domani mattina alle 8,30 negli
uffici del gruppo Lega alla Camera, prima della quarta chiama.
Ore 21:30 – Iniziata nell’Aula
dei gruppi parlamentari la riunione fra il segretario Enrico Letta e i grandi
elettori del Pd. “Ora viene il passaggio più complesso, in cui ognuno di noi ha
una idea e dobbiamo trovare una sintesi. Una complessità mai così forte”, ha
detto Letta. E poi ha aggiunto “Nel Parlamento più frammentato di sempre c’è una
sovrapposizione di due perimetri diversi: quello della maggioranza e quello del
centrosinistra”. Domani sarà quindi una giornata di dibattiti, mentre stasera si
riflette sullo stato dell’arte del Parlamento.
Ore 21:40 – Secondo quanto
twittato dall’onorevole Ceccanti, capogruppo Pd commissione Affari
costituzionali, il segretario dem Letta ha detto che “L’accordo deve tenere
insieme tutta la maggioranza”. Ma soprattutto il leader del Pd ha affermato che
“se non ci saranno novità entro domattina confermerò la scheda bianca”,
presentando l’ipotesi di votare un presidente non di parte, e quindi non di
destra, nella giornata di venerdì.
Ore 22:00 – Fibrillazioni
anche durante il vertice del M5S. Giuseppe Conte, parlando ai grandi elettori
del Movimento, ha affermato che il Movimento “non è una forza politica che fa
inciuci o caminetti, nessuno scambi la necessità di riservatezza col fatto che
seguiamo percorsi poco trasparenti”. “A noi – ha aggiunto – interessano i
risultati. Non abbiamo detto no a nessuno, abbiamo detto sì, lavoriamo per il
Paese, siamo disponibili a rilanciare l’esecutivo con un patto di cittadini e
non di legislatura”. Il Movimento sta dialogando per una soluzione condivisa,
fanno sapere fonti pentastellate.
Ore 22: 10 – Il segretario Dem
Enrico Letta scarica le colpe sul centrodestra. La trattativa per il Quirinale è
“difficile” perché il centrodestra ha detto no a tutte le ipotesi di
“personalità terze”, ha detto il segretario dem Enrico Letta ai grandi elettori
del Pd. “È una trattativa difficile perché dal centrodestra sono arrivati tutti
no. Ma lo schema di lavoro è stato diverso: i nostri no erano pubblici, i loro
una lunga sfilza di no privati. Spero che almeno uno dei loro no si trasformi in
sì”. “Per ora il centrodestra nella sua interezza ha detto di no a tutte le
nostre ipotesi di personalità terze: Mattarella, Draghi, Amato, Casini,
Cartabia, Riccardi”.
Ore 22: 15 – Durante
l’assemblea dei grandi elettori del M5S, Conte lancia un messaggio al
centrodestra: “Quando si è diffusa l’ipotesi di candidatura di Casellati da
parte del centrodestra si erano create le premesse di un cortocircuito con noi e
di uno sgarbo verso di lei: una carica istituzionale non può essere trasformata
in candidatura di bandiera. Creerebbe imbarazzo istituzionale senza logica. Ci
auguriamo questa ipotesi venga accantonata dal centrodestra”.
Ore 22:30 – Concluso il
vertice dei grandi elettori del M5S. Conte ha concluso il suo intervento
sottolineando che si cercherà di arrivare alla “soluzione più alta e autorevole
possibile”. ”Io – ha aggiunto – non so dove atterreremo ma vi posso dare la mia
parola d onore che mi batterò per atterrare alla soluzione più alta e autorevole
possibile”.
Aumentano i voti per
l'attuale Capo dello Stato Mattarella.
Quirinale, i nomi e le ipotesi
dopo la terza giornata: Casini e Cassese corteggiati dal centrodestra.
Redazione su Il Riformista il 26 Gennaio 2022.
Ancora fumata nera nel terzo
giorno dell’elezione del presidente della Repubblica. Le urne si sono aperte
questa mattina alla Camera alle ore 11 e lo spoglio è terminato dopo le 14.
Diminuiscono le schede bianche al terzo scrutinio per l’elezione del presidente
della Repubblica, scendendo dalle 527 di ieri a 412, e i partiti, anche al loro
interno, iniziano a contarsi.
Durante lo spoglio si
impongono i nomi di Sergio Mattarella e Guido Crosetto, lanciato a sorpresa da
FdI. Per l’attuale Capo dello Stato spiccano 125 voti, mentre quelli incassati
dal cofondatore di Fratelli d’Italia sono 114, quasi il doppio dei 63 grandi
elettori del partito di Giorgia Meloni. Al terzo posto c’è il giurista Maddalena
con 61 voti di ‘Alternativa c’è’ e di molti ex M5s, seguito da Casini che
raggiunge quota 52.
Lega e Forza Italia hanno
votato scheda bianca anche alla terza votazione. E la stessa indicazione è
arrivata dal centrosinistra: Pd, M5S e Leu. Probabilmente, sono i pentastellati
che hanno alzato la posta su Mattarella, nonostante il presidente della
Repubblica uscente abbia più volte espresso l’intenzione di lasciare il
Quirinale.
La situazione è ancora in
stallo. Dopo l’onda cavalcata con il nome della seconda carica dello
Stato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, poi respinto dal segretario del Pd
Enrico Letta perché “farebbe saltare tutte le trattative”.
Alla viglia della quarta
votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica che vedrà il quorum
scendere a quota 505, tra i partiti regna il caos ed un nome su cui convergere
ancora non c’è.
L’incertezza aumenta e
certifica un Parlamento in stallo, dove permangono antipatie e litigi nati in
passato. Fdi polemizza per la scelta dei due partiti di centrodestra di votare
scheda bianca, nonostante l’accordo tra Meloni e Salvini di votare Guido
Crosetto, proposto dal partito guidato da Meloni.
La soluzione di Matteo Salvini
per la corsa al Quirinale potrebbe essere Sabino Cassese. La notizia è stata
data dal quotidiano Il Foglio. Il segretario della Lega questo pomeriggio si
sarebbe recato nella casa romana del professore Cassese ai Parioli. Candidatura
né smentita né confermata dal diretto interessato.
Le Lega, nel giro di pochi
minuti dalla pubblicazione della notizia, ha smentito l’incontro. “Non so dove
abita”, assicura il leader della Lega. “Abita ai Parioli? Non ci sono stato oggi
dalle parti dei Parioli…”. Poi avvisa i giornalisti: “Tenete i telefonini accesi
perché sarà una lunga notte di lavoro”. Peccato però, che dopo vari rinvii, sia
arrivata la conferma di un vertice dei leader di centrodestra che si terrà
domani mattina, prima della quarta chiama.
Ma Salvini non ha voluto
anticipare cosa voterà domani il centrodestra nella quarta votazione.
Oltre al nome di Cassese, in
giornata è circolato quello di Pierferdinando Casini. L’ex presidente della
Camera è stato sedotto e abbandonato dal centrodestra ma anche dal
centrosinistra. Inizialmente la carta Casini, che oggi ha ricevuto 52 voti, è
stata presentata dai centristi. “Se fosse il centrodestra a proporlo, il
centrosinistra non potrebbe non votarlo”, è il ragionamento che viene fatto. Ma
il M5S ha alzato le barricate e ha minacciato di passare all’opposizione. Così
il centrodestra ha frenato sul nome dell’ex presidente della Camera.
Al di là dei quanto filtri
dalle riunioni, rimane avvolta nel buio l’ipotesi di convergere sul
premier Mario Draghi. Il segretario leghista torna ribadire la necessità di
lasciare SuperMario a palazzo Chigi: “Senza il premier penso che avrebbe qualche
difficoltà di linea di direzione”. Un fronte, quello che non vuole che il
premier traslochi al Colle, che comprende anche Beppe Grillo. Il fondatore M5s
nel corso di una telefonata con Giuseppe Conte avrebbe concordato sul fatto che
il presidente del Consiglio resti a Chigi.
A meno di sorprese dunque i
nomi su cui si continua a lavorare sono gli stessi, mentre gli italiani
attendono di conoscere chi sarà il primo cittadino dello Stato.
IL NOME DI BANDIERA. Chi è
Guido Crosetto, votato al Quirinale da Fratelli d’Italia.
DAVIDE MARIA DE LUCA su Il
Domani il 26 gennaio 2022.
Fondatore del partito insieme
a Giorgia Meloni oggi è il capo della lobby dell’industria degli armamenti:
Fratelli d’Italia ha deciso di votarlo nella terza giornata dell’elezione del
presidente della Repubblica per “contarsi”
Nel corso della terza giornata
di votazioni per il presidente della Repubblica, Fratelli d’Italia ha deciso di
fare il nome di Guido Crosetto, ex parlamentare, fondatore del partito e
consigliere di Giorgia Meloni. Crosetto non ha possibilità di essere eletto, ma
è stato votato per “contarsi”, cioè verificare di quanti dispone Meloni. Sulla
carta, Fratelli d'Italia dispone di 63 grandi elettori e quindi ci si aspettano
almeno altrettanti voti per lui.
Segui tutti gli aggiornamenti
sulla terza giornata di votazioni per il presidente della Repubblica
LA CARRIERA
Guido Crosetto ha 58 anni ed
è nato a Cuneo, in Piemonte. Nel 2012 insieme a Giorgia Meloni e ad altri
dirigenti politici provenienti dalla galassia della destra radicale ha fondato
Fratelli d’Italia, di cui è stato anche coordinatore nazionale. Da qualche anno
si è ritirato dalla vita politica, anche se è spesso ospite di trasmissioni tv
come opinionista. Dal 2014 è presidente dell’Aiad, l’associazione di categoria
delle imprese del comparto difesa.
La sua carriera politica è
iniziata negli anni Ottanta, quando frequentava l’università ed era iscritto
alla Democrazia Cristiana. Nel 2001 viene eletto per la prima volta deputato con
Forza Italia. Nel quarto governo Berlusconi, tra 2008 e 2011, ricopre l’incarico
di sottosegretario al ministero della Difesa.
È in questo periodo in cui
Crosetto si avvicina a Meloni. Anche se provengono da percorsi diversi, Meloni
viene da Alleanza nazionale e dalla destra radicale, Crosetto dalla Dc e
dall’ambiente liberale e conservatore, entrambi militano nel Popolo della
libertà. Quando il partito entra in crisi dopo la caduta del governo Berlusconi,
Meloni e Crosetto decidono di fondare Fratelli d’Italia.
Il partito inizialmente si
presenta come una formazione liberale, anche se di ispirazione conservatrice.
Crosetto, ad esempio, dice che il candidato ideale del partito è il giornalista
Oscar Giannino. Con il passare dei mesi, però, l’identità del partito torna a
spostarsi verso destra. Nel 2014, Crosetto annuncia l’abbandono dell’impegno
politico e diventa presidente dell'Aiad.
Ma continua a mantenere buoni
rapporti con Meloni e con il partito. Tanto che nel 2017 partecipa al congresso
di Fratelli d’Italia e l'anno dopo viene eletto deputato nelle sue liste. Non
durerà molto, però. A maggio, pochi mesi dopo le elezioni, annuncia le sue
dimissioni da deputato e torna a esercitare a tempo pieno il suo lavoro di
presidente delle industrie del comparto difesa.
IL QUIRINALE
Il voto per Crosetto di oggi è
soprattutto un espediente tattico di Fratelli d’Italia. Crosetto non ha vere
possibilità di essere eletto e questo Meloni lo sa bene. Votando per lui, però,
Fratelli d’Italia comunica la sua distanza dal resto del centrodestra, che
invece ha votato scheda bianca, e ha l’occasione di “contarsi", cioè di mostrare
agli altri partiti quanto vale e ottenere quindi maggior peso nelle trattative
dei prossimi giorni.
DAVIDE MARIA DE LUCA.
Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai
e con il sito di factchecking Pagella Politica.
Il nome del partito di
Giorgia Meloni. Chi è Guido Crosetto, il candidato di Fratelli d’Italia a
Presidente della Repubblica alla terza votazione.
Vito Califano su Il Riformista
il 26 Gennaio 2022.
Il gruppo di Grandi Elettori
di Fratelli d’Italia ha oggi, al terzo giorno di votazioni per il Presidente
della Repubblica, voterà Guido Crosetto. I votanti di Fdi hanno risposto alla
seconda chiama. Ignazio La Russa ha comunque spiegato che la decisione non
rappresenta una divisione nel centrodestra. “Vogliamo dare un segnale che questa
storia della scheda bianca cui ci sta costringendo la sinistra deve finire. E
dimostreremo anche che siamo un partito compatto, i nostri 63 voti li prenderemo
tutti”, ha assicurato citato dall’Aska. Fdi esprime 21 i senatori, 37 deputati e
5 delegati regionali per un totale di 63 delegati.
“Non facciamoci illusioni,
potrebbe ancora essere Draghi, e si vota tra un anno”, uno degli ultimi commenti
di Crosetto, tra i fondatori del partito guidato da Giorgia Meloni, in queste
ore di trattative convulse e caos sulla corsa al Quirinale. Classe 1963, nato
a Cuneo, imprenditore che fin da giovanissimo ha preso la guida dell’azienda di
famiglia che produce macchine per l’agricoltura. L’attività si era poi allargata
al comparto immobiliare e turistico. Ha studiato Economia all’Università degli
studi di Torino. Da giovane era iscritto alla sezione giovanile della Democrazia
Cristiana.
Divenne segretario regionale
del movimento giovanile e responsabile nazionale della formazione. È
stato consigliere economico del Presidente del Consiglio Giovanni Goria, sindaco
di Marene in provincia di Cuneo dal 1990 al 2004, candidato di Forza Italia alla
Presidenza della Provincia di Cuneo nel 1999, consigliere provinciale fino al
2009 con l’incarico di capogruppo di Forza Italia. È stato eletto alla Camera
dei deputati nelle elezioni nel 2001, nel 2006 e nel 2008 prima nelle fila di
Forza Italia e quindi con il Popolo delle Libertà.
Crosetto è stato
sottosegretario alla Difesa nel IV governo Berlusconi e tra i fondatori di
Fratelli d’Italia di cui è stato coordinatore nazionale. È stato nominato nel
2014 presidente dell’Aiad, la Federazione delle Aziende Italiane per
Aerospazio. Ha fondato Fdi con Meloni e La Russa nel dicembre 2012. Si è
candidato a Presidente della Regione Piemonte piazzandosi quarto con il 5,73%.
Dopo aver lasciato la politica nel 2014, è tornato in campo nel 2017
candidandosi alle elezioni del 2018 come capolista alla Camera, dove è stato
eletto. Si è dimesso da Montecitori nel marzo 2019 per tornare a svolgere a
tempo pieno il ruolo dell’AIAD e quindi da coordinatore del partito. È stato
presidente di Orizzonte Sistemi Navali, impresa creata come joint venture tra
Fincantieri e Leonardo specializzata in sistemi ad alta tecnologia per le navi
militari e di gestione integrata dei sistemi d’arma.
Vito Califano. Giornalista. Ha
studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive
principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di
televisione e teatro.
Quirinale, Crosetto: «Che
onore quei 114 voti. Ma in tempi così difficili va scelto un padre nobile».
Giuseppe
Alberto Falci su Il Corriere della Sera il 26 gennaio 2022.
L’ex deputato di FdI al terzo
scrutinio per la scelta del presidente della Repubblica ha ottenuto 51 voti in
più dei grandi elettori del partito: «È un piacere vedere che ho seminato a
livello umano. Ci punto? Ho senso della misura».
Nella tarda mattinata Guido
Crosetto, imprenditore, ex parlamentare, fondatore di Fratelli d’Italia, riceve
una chiamata da Giorgia Meloni. «Ero al lavoro, a fare il privato cittadino, si
illumina il cellulare ed è Giorgia: “Scusami, non ti creo problemi se propongo
il tuo nome come candidato alla presidente della Repubblica?”».
E lei, Crosetto, cosa
risponde?
«Intanto la ringrazio, le dico
che sono lusingato e che può procedere, che so benissimo che è una candidatura
di bandiera ma che è sempre un onore. Per di più è stata annunciata nel pieno
della prima chiama della terza votazione».
Se l’aspettava?
«No. Anche perché pensavo che
il centrodestra potesse votare uno dei candidati proposti nella rosa».
Il Corriere ha una newsletter
dedicata alla corsa al Quirinale: si intitola «Diario Politico», è gratuita, e
per iscriversi basta cliccare qui
La sua candidatura dimostra
che il centrodestra non è compatto.
«A me pare che sia compatto.
Quando nessuno ha la maggioranza, l’elezione del presidente della Repubblica è
una partita a scacchi. Fai diverse mosse ma te ne accorgi solo a fine partita».
Lei ha insomma scalzato la
concorrenza di Carlo Nordio, Marcello Pera, Letizia Moratti. A suo avviso su chi
dei tre avrebbe dovuto convergere il centrodestra?
«Non sono un grande elettore.
E sono tre amici...».
Cosa succede un minuto dopo
esser stato candidato al Quirinale?
«Ricevo centinaia di chiamate
e di messaggi da amici, ex colleghi parlamentari, conoscenti. Ma mi affretto
subito a spiegare: “Guarda che la mia è una candidatura di bandiera”. Dovrei
prendere i 63 voti di Fratelli d’Italia. Risentiamoci dopo il voto».
Quando si conclude lo spoglio
della terza votazione Crosetto ottiene 114 voti, una cinquantina in più dei
grandi elettori di Fratelli d’Italia. Lo ricontattiamo.
Si è commosso?
«Mi sono sentito onorato
dall’amicizia di tanti ex colleghi. È un piacere vedere che si è anche seminato
umanamente. Poi però sì che il risultato è il frutto di un impegno personale di
Giorgia e dei due capigruppo che hanno cercato di non farmi fare brutta figura».
A questo punto ci crede?
«Ma no, per chi mi prende? Ho
rispetto delle istituzioni e senso della misura. Voglio credere nella capacità
del Parlamento di individuare una persona autorevole nella quale riconoscerci
tutti. Tempi difficili richiedono padri nobili».
Che significato dà il suo
risultato?
«Il mio risultato dà ragione a
Giorgia Meloni quando dice che il centrodestra può avere una capacità attrattiva
in questo Parlamento e che deve misurarsi compattamente su una proposta
condivisa. Perdere un’occasione per timore è forse peggio di perdere la
partita».
E adesso come si comporterà
FdI?
«Sosterrà una candidatura
unitaria».
L’operazione Crosetto va a
segno: «Sono onorato e commosso». L'ex
parlamentare di Fratelli d’Italia capitalizza quasi il doppio delle preferenze
rispetto a quelle avute sulla carta: i grandi elettori del partito di Giorgia
Meloni, infatti, sono 63. Il Dubbio il 26 gennaio 2022.
«Mi chiami pure presidente,
tanto a Roma sono tutti dottori e presidenti…». Raggiunto al telefono
dall’Adnkronos Guido Crosetto sta al gioco e sorride quando gli viene chiesto
come ci si sente, per un giorno, nei panni di candidato alla presidenza della
Repubblica.
Per denunciare e stoppare il
«balletto surreale delle bianche», Fdi aveva lanciato l’operazione “Guido for
president”, chiedendo ai suoi grandi elettori di indicare nella scheda, alla
terza votazione per il Colle, il nome dell’ex sottosegretario dei governi
Berlusconi e poi fondatore del partito di Giorgia Meloni. Così alla
fine Crosetto ha ottenuto 114 voti nel corso della terza votazione per eleggere
il presidente della Repubblica, capitalizzando quasi il doppio delle preferenze
rispetto a quelle avute sulla carta: i grandi elettori del partito di Giorgia
Meloni, infatti, sono 63. «Sono onorato, commosso, grazie», commenta dopo lo
spoglio. «Secondo me è la capacità, se volesse il centrodestra, di poter
prendere voti anche al di fuori del centrodestra. Ci sono, ed escludo me
ovviamente dal giudizio, persone nel centrodestra che hanno questa capacità»,
aggiunge l’ex parlamentare.
«I miei 114 voti dimostrano
che Giorgia Meloni aveva ragione e ha lavorato bene: i grandi elettori del
centrodestra volevano esprimersi e vogliono un presidente della loro area…»,
dice ancora Crosetto. Che poi scherza: «Io al Quirinale? Sì, il 2 giugno per la
festa della Repubblica, se mi invitano». Crosetto parla poi azzarda qualche
pronostico: «Penso che entro venerdì avremo il Presidente della Repubblica.
Auspico che si arrivi a una personalità il più condivisa possibile. I gruppi
parlamentari hanno voglia di votare dei nomi dopo tante schede bianche ma se è
difficile trovare accordi nelle riunioni di condominio, figuriamoci
nell’elezione del presidente della Repubblica».
"Da repubblica delle
banane", perché a Omnibus stroncano Elisabetta Belloni presidente.
Federica Pascale su
Il Tempo il 27 gennaio 2022.
Durante la puntata di Omnibus
di giovedì 27 gennaio, si commentano in studio le parole del segretario del PD
Enrico Letta, che rimane dell’idea che sia necessario trovare un candidato super
partes per il Quirinale e che, pare, abbia convinto anche il centrodestra a
proporre nomi “meno divisivi”.
Ospite in collegamento la
giornalista del Corriere della sera Maria Teresa Meli, che evidenzia: “È l’unica
vittoria che si possa dire del centrosinistra, che è spaccatissimo. Salvini non
è andato avanti con la prova di forza della Casellati”. Ma è una vittoria
facile, “perché mi pare che in questo momento Salvini sia davvero in
difficoltà”.
Logica avrebbe voluto che il
segretario della Lega si intestasse la candidatura di Mario Draghi per il
Quirinale, e tutti avrebbero dovuto supportarla. “Perfino Conte avrebbe dovuto
accettare, e fare buon viso a cattivo gioco”. D’altra parte, un centrosinistra
frastagliato: “Il PD è spaccato tra Draghi e Casini. I cinque stelle non si
capisce cosa vogliono”.
L’unico nome sul quale pare si
possa convergere è quello di Elisabetta Belloni, l’unico al quale Conte ha detto
sì. La donna a capo del Dis, ossia gli 007 italiani, "è una persone encomiabile
e straordinaria, ma l’idea che il capo dei servizi segreti possa andare al
Quirinale... neanche nella Repubblica delle banane”. La Meli rimane dell’idea
che le uniche due opzioni realistiche siano il senatore di lungo corso Pier
Ferdinando Casini e l’attuale presidente del consiglio Draghi. “Un Parlamento
che dice che Draghi è un tecnico e non può andare, ma mette la persona che guida
i servizi segreti al Quirinale, forse è un Parlamento con problemi gravi”.
Quirinale, sul tavolo
restano le carte Casini e Draghi. Gli sms di Casellati ai leader del
centrodestra: «Votatemi».
Francesco Verderami su Il Corriere della Sera il 28 Gennaio 2022.
La quinta votazione per il
capo dello Stato avrà un valore politico: è la prova chiesta da Meloni per dare
un segnale di solidità.
Il vertice di centrodestra
terminato a notte fonda anticipa un’altra fumata nera oggi. Ma il passaggio
della quinta votazione avrà un valore politico, sarà la prova chiesta dalla
Meloni per tenere salda l’alleanza prima di arrivare a quella che si prospetta
come la chiama decisiva: quella di domani. La leader di Fdi ha chiesto di
contarsi in modo da verificare i numeri della coalizione, e il capo della Lega
ha accettato la richiesta. Sarà l’ultimo giro di giostra, l’ennesima contorsione
di una corsa al Colle che finora è parsa una sciarada.
Ieri Salvini aveva passato la
giornata nel disperato tentativo di sfuggire alla forza di gravità, facendo suo
lo slogan di Conte, secondo il quale bisognava «trovare rapidamente un nome per
evitare il nome di Draghi». Così nel pomeriggio — dopo una performance da
dimenticare per il centrodestra alla quarta votazione — il segretario del
Carroccio aveva rilanciato su Frattini, figura condivisa giorni fa con il leader
del Movimento. Già allora era stato sommerso da una valanga di no. Compreso
quello dell’Ambasciata americana, che era sobbalzata al nome dell’ex ministro
degli Esteri considerato un «filo russo». Al secondo tentativo, si è beccato
anche il veto della sua coalizione e sottovoce persino quello dei suoi compagni
di partito.
Qui trovate il «calcola
maggioranze». Qui invece il link per iscriversi alla newsletter «Diario
Politico» (è quotidiana, e gratuita)
Era stata l’ennesima mossa per
resistere alla forza di gravità e all’insistenza della Meloni, perché
l’operazione per Salvini resta rischiosa. Più che per i rapporti con il
centrosinistra, per lo stato di disgregazione che emerge nel centrodestra, dove
i franchi tiratori sono pronti a colpirlo insieme al candidato. Se così stanno
le cose, non si capisce come mai per tutto il giorno la Casellati abbia inondato
i cellulari di (quasi) tutti i maggiorenti della coalizione con lo stesso,
stringato messaggio: «Mi dovete votare». E la sua richiesta è stata esaudita.
In effetti è complicato
guidare una trattativa, se oltre alle difficoltà di trattare con gli avversari
bisogna gestire le ambizioni degli alleati. Ma un kingmaker non può limitarsi a
sostituire una terna di nomi con un’altra nel giro di pochi giorni, senza fare i
conti con il principio di realtà. E Salvini ieri ha dovuto constatare la
debolezza della linea Maginot costruita assieme a Conte per evitare l’ascesa di
Draghi al Colle. È a questo che Di Maio si è riferito quando ha contesta il modo
in cui si è giocato con «figure di spessore» come la responsabile del Dis
Belloni, finita nel tritacarne dei candidati anche con la complicità di una
parte dei democratici. Perché pure nel Pd fino a ieri mattina si era smarrito il
senso delle istituzioni, inserendo nella lista dei quirinabili il capo dei
Servizi segreti.
Il ministro degli Esteri,
oltre a contestare il fatto che «stiamo bruciando alti profili verso i quali
serve rispetto», ha avvertito del rischio di un passo falso che farebbe «saltare
il governo e ci porterebbe al voto». Così si è rivolto a Salvini e Conte
(arroccato vanamente su Mattarella), usando le parole di Draghi. Perché è su
Draghi che si ragiona, ora che i leader si trovano a corto di candidati e
munizioni. «C’è Draghi in campo», dice Renzi, nonostante il premier — a suo
giudizio — abbia «commesso vari errori anche per responsabilità dei suoi
collaboratori». «C’è Draghi», ripete Letta per una volta in sintonia con
l’acerrimo rivale. «C’è Draghi», sussurrano persino i leghisti più vicini al
Capitano. Figurarsi Giorgetti e i governatori, che danno appuntamento alla sesta
chiama.
Si vedrà se Berlusconi farà il
passo, dopo il colloquio con l’ex presidente della Bce. Se la posizione di Forza
Italia, formalmente «non mutata», sia stato solo un gesto rispettoso verso
Salvini. Il capo della Lega è chiamato alla decisione: sul tavolo sono rimasti i
nomi di Draghi e di Casini. E Salvini al termine di una giornata trascorsa a
fare casting, è parso orientato nella scelta: «Il mio obiettivo è tenere unito
il centrodestra e la maggioranza di governo». Non è che ci sia molto spazio per
la fantasia.
Elisabetta Casellati, chi è
la candidata al Quirinale a cui Salvini disse: "Ti farò Presidente".
Filippo Ceccarelli
su La Repubblica il 28 Gennaio 2022.
Dalla sua scorta che sperona
quella di Mattarella ai premi accumulati ai voli di Stato: ascesa e incidenti di
percorso della seconda carica dello Stato.
Fuori da ogni retorica e
ipocrisia, il bello della corsa per il Quirinale è che riattiva la memoria di
eventi così belli, simbolici e a questo punto densi di presagi da sembrare
finti, mentre al contrario sono avvenuti sul serio.
Era il 17 settembre del 2020
quando, lungo la strada che portava a Vò Euganeo, nel tentativo di superare di
gran carriera il mega corteo istituzionale, una delle auto della scorta
della presidente
Quirinale, ecco cosa diceva
Elisabetta Casellati nel 2011 su Berlusconi e il caso Ruby.
su L'Espresso il 26 Gennaio
2022.
Il nome di Elisabetta
Casellati - presidente del Senato - è tra quelli spesi in queste ore per la
successione a Sergio Mattarella al Quirinale. Per questo motivo è tornata virale
sui social un'intervista concessa l'11 aprile 2011 da Casellati a Otto e Mezzo a
difesa di Silvio Berlusconi, all'epoca al centro dello scandalo Ruby. "Quando
Berlusconi ha incontrato Mubarak prima di questo episodio pare che sia venuto
fuori da alcune testimonianze che proprio nell’incontro Mubarak aveva parlato di
questa sua nipote, ed era un incontro ufficiale", afferma la presidente del
Senato commentando la famosa telefonata alla questura di Milano per chiedere il
rilascio di Ruby. "Il centrodestra la vorrebbe al Quirinale", commentano sui
social
Maria Elisabetta Alberti
Casellati, la zia di Mubarak.
Susanna Turco su L'Espresso il
26 Gennaio 2022.
Avanza la candidatura della
Presidente del Senato e subito torna sui social la sua performance ai tempi di
Ruby.
Il centrodestra converge su
Casellati e Mubarak torna in tendenza su twitter. È il primo effetto del nome
del possibile candidato del centrodestra alla quinta votazione per la svolta sul
Quirinale.
Nemmeno il tempo di domandarsi
cosa c’entri la seconda carica dello Stato con Hosni Mubarak, colui che fu
presidente dell’Egitto per quasi trent’anni, fino al febbraio 2011, ed ecco che
la rete soccorre, con un imperdibile frammento di Otto e mezzo, datato 11 aprile
2011 nel quale la futura presidente, all’epoca sottosegretaria alla Giustizia,
intervistata da Lilli Gruber, con soave andamento argomentativo alla Niccolò
Ghedini – del resto l’avvocato è suo amico di famiglia e grande elettore -
spiegò che sì, Berlusconi aveva telefonato alla questura di Milano ritenendo
Ruby la «nipote di...
Così lo Stato ha finanziato
le iniziative musicali di Alvise Casellati, figlio della presidente del Senato.
Per un
filmato visto da poche decine di persone, una sorta di prove generali di un
concerto, l’Istituto italiano di cultura di New York ha speso 30.000 dollari per
pagare i cantanti del maestro. Il direttore Finotti: “Omaggio a Caruso in
collegamento col ministero e il Comitato del centenario”, ma entrambi
smentiscono. Il ruolo del direttore d’orchestra nei contratti dei suoi soprani e
del suo tenore. Carlo Tecce su L'Espresso il 27 Gennaio 2022.
Finalmente lo Stato è riuscito
a sovvenzionare le attività di un artista musicale di rapida e fulgida carriera
che in un decennio si è formato e si è consacrato nei più prestigiosi teatri
d’opera d’Italia: Alvise Casellati, il direttore d’orchestra, il figlio di Maria
Elisabetta Alberti Casellati, la presidente del Senato. Con un investimento di
oltre 30.000 dollari, attraverso l’Istituto italiano di cultura di New York, lo
Stato si è conquistato il merito e l’onore di finanziare non un concerto, quello
è ancora un’aspirazione, ma le prove generali di un concerto del maestro
Casellati e dei suoi cantanti. Il filmato è ancora disponibile sulla pagina
dell’Istituto su Youtube e ha già deliziato qualche decina di appassionati.
Ogni anno da quattro anni, ben
sostenuto da diverse multinazionali italiane, il maestro Casellati si esibisce a
New York oppure a Miami, davanti a un pubblico non pagante, con un classico
repertorio italiano, brani di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gaetano
Donizetti, Gioachino Rossini. La manifestazione, organizzata da «Central Park
Summer Concerts» di cui Alvise è presidente, si intitola «Opera italiana is in
the air».
Quest’anno il maestro
Casellati ha omaggiato la rinascita dopo la pandemia e il tenore Enrico
Caruso nel centenario della scomparsa. Così l’Istituto italiano di cultura di
New York, che dipende dal ministero degli Esteri, si è fiondato sull’evento.
Il direttore Fabio Finotti, alla vigilia del concerto che si è tenuto il 28
giugno a Central Park, ha ospitato nella sede dell’Istituto un’ora e mezza di
lezione a imprecisati allievi del maestro Casellati con i soprani Gabriella
Reyes e Jennifer Rowley e il tenore Stephen Costello. Il gruppo ha intonato un
paio di arie e il maestro Casellati ha insistito parecchio con la giovane Reyes
sull’esigenza di non far vibrare troppo la voce su «Oh mio babbino caro» come ha
insegnato Maria Callas. Poi unanime commozione per «Core ‘ngrato».
Quando L’Espresso ha
contattato l’Istituto italiano di cultura di New York, il direttore Finotti ha
rivendicato la sua impresa, cioè di aver ottenuto «senza il versamento di alcuna
somma» che il concerto venisse dedicato a Caruso, «il tutto in collegamento con
il ministero della Cultura e col comitato Caruso ivi insediato per celebrare il
centenario della morte del tenore che - come lei sa - è un'icona dell'italianità
negli Stati Uniti». Chi non sapeva, però, erano proprio il ministero della
Cultura e il comitato Caruso ivi insediato. E non li si può biasimare. Poiché il
programma ufficiale per le celebrazioni di Caruso è stato presentato al teatro
San Carlo di Napoli il 6 luglio con il ministro Dario Franceschini e Franco
Iacono, presidente del comitato. «Noi non c’entriamo nulla con New York. Ci
hanno soltanto chiesto l’utilizzo del nostro logo e non me ne sono neanche
occupato io», racconta Iacono, già deputato socialista e assessore regionale.
Finotti ha sempre quasi
confermato e quasi negato una partecipazione economica. Ha quasi risposto.
Finché L’Espresso ha chiesto se l’Istituto avesse utilizzato del denaro pubblico
per registrare quella lezione – viene chiamata «Masterclass» – in cui il
direttore Finotti siede accanto al concittadino maestro Casellati (entrambi sono
di Padova) e Reyes e colleghi scaldano le corde vocali prima del concerto di
Central Park. A quel punto Finotti ci ha comunicato, in terza persona, di essere
in congedo e di rivolgerci alla segreteria dopo il 22 agosto.
Per fare chiarezza, prima che
il video raggiungesse le cento visualizzazioni in trenta giorni, L’Espresso ha
ricavato le informazioni in altro modo. E dunque l’Istituto italiano di cultura
di New York, a parte i costi fissi per le riprese di Awen Films, ha speso 30.000
dollari per ingaggiare Reyes, Rowley e Costello. Una cifra considerevole per la
prestazione artistica dei cantanti e per le risorse di solito utilizzate. In
passato per un concerto dal vivo, durante il mandato di Giorgio Van Straten,
l’Istituto ha impiegato non più di 1.500 dollari.
Rowley e Costello hanno fama
internazionale e perciò si sono divisi gran parte dei compensi, mentre Reyes si
è accontentata di 5.000 dollari per un intenso ripasso di «Oh mio babbino
caro». Alessandro Ariosi di Ariosi Management è l’agente del soprano Rowley e
anche del maestro Casellati (non retribuito per la lezione). Stavolta Ariosi,
come i rappresentanti di Costello, non ha dovuto gestire complesse trattative o
pratiche burocratiche. Perché l’Istituto italiano di cultura di New York si è
riferito a Casellati per i contratti dei suoi cantanti. Basta poco, un sorriso.
Viva Caruso: «Era lu tiempo antico/pe mme lu paraviso/ca sempre benedico/pecchè
cu nu surriso/li bbraccia m’arapive».
ESCLUSIVO: L’ITER PARTITO
QUANDO SALVINI ERA MINISTRO DELL’INTERNO. Superbonus Casellati, dal Viminale
270mila euro per i lavori nella sua villa.
EMILIANO FITTIPALDI E GIOVANNI
TIZIAN su Il Domani il 27 gennaio 2022.
Il ministero dell'Interno ha
investito una somma monstre per la sicurezza della casa di Padova della
presidente del Senato e di suo marito
I lavori di ristrutturazione
sono già costati 175 mila euro: cambiati tutti gli infissi e le finestre. Altri
95 mila euro sono già stati preventivati per il muro del giardino
"Motivi di sicurezza" dice la
prefettura. Domani ha sentito Mattarella, Fico e gli ex presidenti Boldrini e
Grasso: tutti hanno negato investimenti pubblici nelle loro abitazioni.
Emiliano Fittipaldi e Giovanni
Tizian per editorialedomani.it il 28 gennaio 2022.
A Padova, nella centralissima
via Euganea, c’è una villa che in città conoscono tutti. Un palazzetto del
Settecento extra lusso di tre piani e 546 metri quadri più giardino annesso e
scale d’epoca. Un immobile di proprietà di Giambattista Casellati, avvocato e
presidente dell’ente Veneranda Arca di San Antonio, e della di lui moglie Maria
Elisabetta Alberti Casellati, ex avvocato di Silvio Berlusconi e attuale
presidente del Senato.
Una dimora che negli ultimi
tempi, in gran segreto, è stata sottoposta a qualche importante lavoro di
ristrutturazione. Pagato con i fondi del ministero dell’Interno e della
prefettura padovana.
Anche se Casellati vive a Roma
a palazzo Giustiniani e torna a casa di tanto in tanto nei weekend, Domani ha
scoperto che l'organo periferico del Viminale (il ministero al tempo delle prime
richieste autorizzative era guidato da Matteo Salvini) ha già speso la bellezza
di 175mila euro. A cui vanno aggiunti 94mila euro di lavori già preventivati ma
non ancora realizzati.
In pratica, lo stato ha già
investito o sta per investire 271mila euro nella casa dell’avvocata per la
sostituzione degli infissi, la sopraelevazione e ristrutturazione del muro del
giardino che circonda la casa, più altri interventi ufficialmente destinati
«alla messa in sicurezza, a tutela, dell'abitazione del presidente», spiega il
prefetto Raffaele Grassi, che ha ereditato la pratica da pochi mesi: l’ex
direttore dello Sco della polizia e questore di Reggio Calabria è arrivato in
città solo a maggio scorso.
La cifra è consistente, e così
Domani ha cercato di capire se c’erano precedenti di spesa confrontabili con
quelli fatti per Casellati. La presidente non ha risposto alle domande che le
abbiamo fatto attraverso il suo ufficio stampa.
Abbiamo però contattato le
prefetture competenti, lo staff di Sergio Mattarella, il presidente della Camera
Roberto Fico, gli ex numeri uno di Montecitorio e palazzo Madama, cioè Laura
Boldrini e Pietro Grasso: non risultano lavori con costi lontanamente
comparabili per la messa in sicurezza delle loro abitazioni.
Casellati è tra i candidati
papabili alla presidenza della Repubblica. Salvini è il suo principale sponsor,
ma anche Giuseppe Conte e un pezzo dei Cinque stelle sono tentati di votarla in
chiave anti Draghi.
Nonostante dall’inizio del suo
incarico sia stata spesso criticata per l’uso di risorse pubbliche, in primis
per i costi dei suoi viaggi. Il quotidiano Repubblica ha raccontato qualche mese
fa «di 124 voli di stato in un anno» («falso, sono di meno, e non ho violato
alcuna legge», replicò lei), mentre altri giornali spiegarono come la presidente
si facesse accompagnare dalla sua scorta anche all’interno del bar di palazzo
Madama.
La casa di via Euganea era già
diventata protagonista delle cronache della stampa locale e del Corriere della
Sera nel 2018, a causa delle proteste del vicinato, innervosito dalla decisione
delle forze dell’ordine di vietare la sosta delle auto ai residenti sulla via,
scelta fatta per «proteggere la sicurezza» dell’avvocata specializzata nelle
cause di nullità davanti alla Sacra Rota.
«È un privilegio», disse
qualcuno a sinistra, forse in antipatia a una politica di fama, vicinissima allo
storico legale di Berlusconi, Nicolò Ghedini, e celebre per il carattere
assertivo e non facile, che secondo i maligni l’ha costretta durante i primi
quattro anni del suo mandato a cambiare sette portavoce.
Ora, la messa in sicurezza
delle abitazioni dei vertici istituzionali e di soggetti a rischio è
disciplinata da norme che prevedono tutele e investimenti pubblici decisi dal
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dai vari
prefetti. Ma com'è possibile che si sia arrivati, per Casellati, a quasi
trecentomila euro, cifra con cui è possibile comprare a Padova un appartamento
nuovo di 100 metri quadri?
E come mai a Domani risulta
che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sua storica casa a
Palermo, molto esposta essendo un attico in via Libertà, ha goduto solo di
sistema d'allarme elettronico con un investimento pubblico minimo, mentre il
presidente Roberto Fico non ha avuto nelle sue abitazioni private a Napoli alcun
lavoro strutturale né blindatura di sicurezza?
Infine, come è stata scelta la
ditta, il Gruppo Garbo, che ha fatto (e dovrà ancora fare, fossero approvate le
ultime autorizzazioni) i lavori di villa Casellati?
Dal momento che la casa della
presidente è vincolata, chi scrive ha chiesto innanzitutto informazioni alla
soprintendenza archeologica delle Belle arti di Venezia e Padova. L’accesso agli
atti richiesto nei mesi scorsi ci è stato però negato dagli uffici dell’ente.
Più disponibile è stato il
sovrintendente Fabrizio Magani, intervistato nella splendida biblioteca nei suoi
uffici patavini. «I lavori a casa della presidente sono partiti da anni, ben
prima che io arrivassi qui. Sono stati autorizzati dalla prefettura. Sono loro
la stazione appaltante, non noi» spiega.
«La soprintendenza ha dato il
via libera a tre autorizzazioni, solo per quel che ci competeva: la prima risale
al 19 marzo 2019, c’era ancora il mio predecessore Andrea Alberti, e riguarda la
fornitura e l’installazione di serramenti vari e vetri antisfondamento.
La seconda riguarda
l’ancoraggio di una porta finestra. La terza, del settembre 2020, la
sopraelevazione del muro di cinta. Qui forse bisogna fare una variante perché la
parete va prima consolidata. Lavori degli spazi interni? Non mi risultano».
Almeno una volta, ad aprile
2021, la presidente ha verificato di persona l'andamento della pratica della
ristrutturazione della sua villa, andando a supervisionare i progetti insieme
agli uomini della prefettura e a quelli della soprintendenza.
«Sì, ci sono andato anche io
due volte a casa Casellati – dice Magnani – Dovevo verificare come i lavori
erano stati eseguiti. Il vecchio muro del giardino per esempio non era del tutto
allineato, ed era intenzione di portarlo allo stesso livello». La «friabilità»
del muro avrebbe inciso sul prezzo dell’opera, che ha un costo preventivato di
94mila euro, pagata sempre con denaro pubblico.
L’azienda incaricata è
un’impresa di Padova: si tratta della impresa individuale Edili Garbo, dodici
dipendenti (non ci sono bilanci depositati alla Camera di commercio),
specializzata in edifici residenziali. L’elenco dei lavori per mettere in
sicurezza la dimora privata della presidente prevede il montaggio di finestre
blindate, l’innalzamento del muro esterno, forse l’impianto di
videosorveglianza, che dovrebbe essere realizzato da un’altra ditta
specializzata del settore.
Non sappiamo se con i soldi
della prima tranche già spesi sia stato fatto altro. Il prefetto di Padova, «in
qualità di committente unico dei lavori», indica a Domani solo l’importo
notevole già finanziato: «La loro esecuzione ammonta a 175.916 euro. La
sopraelevazione del muro di cinta perimetrale dell'abitazione padovana della
presidente del Senato allo stato non è ancora stata realizzata», ci dice con
trasparenza il prefetto Grassi.
La necessità di realizzarlo
«per esigenze di sicurezza» è stata però già «attestata», e «la somma
preventivata per tali lavori ammonta a 94.588 euro. Non ci sono state pressioni
da parte della presidente per questi lavori e queste spese. La ditta? Non c’era
bisogno di fare la gara, abbiamo fatto affidamento diretto»
Per avere altri dettagli sui
lavori della presidente del Senato abbiamo dunque contattato la Edili Garbo. La
procuratrice speciale Giorgina Garbo ha negato un loro coinvolgimento: «Non mi
risulta affatto, non so di cosa sta parlando. Comunque non sono io che mi occupo
di cantieristica, arrivederci». Anche Giampietro Garbo, l’ingegnere titolare
dell’impresa, non ha voluto dare alcuna precisazione sui lavori: «Si tratta solo
di preventivi, nessuno ha incassato niente, non abbiamo ancora iniziato alcun
lavoro da nessuna parte».
Non sappiamo quali sono i
criteri con cui la prefettura abbia scelto la Garbo. «Una ditta seria e
affidabile», dicono a Padova. Consultando documenti degli uffici antiriciclaggio
della Banca d'Italia risulta che Giampietro nel 2009 abbia usufruito dello scudo
fiscale varato dall’allora governo Berlusconi. In quegli anni Garbo ha riportato
in Italia quasi 5 milioni di euro complessivi, sia dalla Svizzera sia da San
Marino.
Per la cronaca, all’epoca la
loro concittadina Casellati (che ha come migliore amica e stilista del cuore
Rosy Garbo, che ha disegnato anche i vestiti che sta indossando durante le
votazioni di questi giorni: su fonti aperte non risultano parentele) era
sottosegretario alla Giustizia del governo Berlusconi che promulgò il mega
condono per chi aveva tesori all’estero.
Casellati all’epoca era pure
impegnata nella strenua difesa del premier dagli “attacchi” dei pm di Milano e
della stampa avversa al premier. Tanto che l’allora deputata disse in tv che il
nome di Karima El Mahroug, alias Ruby Rubacuori (spacciata dal Pdl per la nipote
dell’ex presidente egiziano) «pare sia venuto fuori in un incontro ufficiale»
tra Berlusconi «e Mubarak, che aveva parlato di questa sua nipote».
Se non ci sono illeciti, e se
non conosciamo i dettagli dei lavori fatti con i soldi del Viminale per la villa
di via Euganea, è possibile però fare dei raffronti, e verificare se medesime
cifre siano state investite anche per la sicurezza delle altre alte cariche
istituzionali, sia del presente sia del passato.
Mentre a Roma Mattarella vive
nel palazzo del Colle, fonti qualificate del Quirinale spiegano che a Palermo
non sono mai stati fatti dalla prefettura competente investimenti per la
sicurezza della casa del presidente uscente. «Mattarella vive all’ultimo piano,
e qualcuno di noi pensò che fosse doveroso cambiare gli infissi, perché gli
affacci sono molto esposti. Ma alla fine non si è fatto nulla: la sicurezza
viene garantita da una volante e da un sistema elettronico che costa poche
migliaia di euro».
Roberto Fico, tra i leader di
un movimento che ha fatto della lotta agli sprechi veri e presunti della casta
politica mantra elettorale, durante il mandato da presidente della Camera dice
di non aver avuto mai lavori in casa pagati dalla la prefettura di Napoli o dal
ministero dell’Interno. «Nei primi anni il presidente ha vissuto in una casa in
affitto, poi si è trasferito in un residence. Ma in nessun caso ci è stata
proposta una “blindatura” dell’abitazione, né lui l’avrebbe mai chiesta»,
assicura il suo portavoce.
Domani ha sentito anche Laura
Boldrini, che è stata alla guida di Montecitorio dal 2013 al 2018. Minacciata
per un lustro da fanatici e gruppi fascisti sul web, ha ricevuto buste con
proiettili. Nel 2017 i giornali di destra la criticarono a tutta pagina
inventando la bufala di un «trasloco (e sarebbero comunque stati pochi migliaia
di euro, ndr) pagato dagli italiani», ma l’ex presidente chiarisce che,
nonostante non abbia mai vissuto a Montecitorio, la sua abitazione a Trastevere
a Roma non ha mai subìto lavori di ristrutturazione pagati dallo stato per
aumentarne la sicurezza.
«C’era solo un sistema
d’allarme elettronico vecchio che hanno migliorato perché vivevo al piano terra
a via delle Mantellate, davanti al carcere di Regina Coeli. Lo hanno solo
collegato all’ispettorato della Camera. Il costo? Credo sia stato irrilevante»
dice. «Nessuna finestra, nessuna telecamera e nessun muro nuovo, nessun
intervento per migliorare la casa. Ho sempre avuto una porta sgangherata che si
poteva aprire con una spallata e che non è mai stata cambiata. Ma va bene, non
c’era bisogno di blindarla, anche perché avevo i miei agenti di scorta come
tutte le alte cariche dello stato».
A Domani risulta però che il
ministero dell’Interno abbia speso alcune migliaia di euro per la protezione di
una casa di campagna nelle Marche, buen retiro di Boldrini e di proprietà
(anche) dei suoi fratelli. «Quanto è costato? Ma credo pochissimo: si tratta di
una rete, di quelle verdi con l’anima di ferro, che hanno voluto mettere perché
non c’era alcun tipo di recinzione tra il mio giardino e la strada» dice
Boldrini. «Una volta mi sono trovata nella mia proprietà mentre ero in pigiama
delle persone che volevano farsi un selfie, mentre un’altra volta alcuni
ragazzini entrarono – a causa di un incidente – con la loro macchinetta dentro
il mio terreno. Ma la rete sarà costata poco e nulla, ora ci ho fatto crescere
delle siepi davanti perché è davvero orrenda».
Insomma, i 270mila euro spesi
per Casellati sembrano un unicum. Abbiamo però contattato anche il portavoce di
Pietro Grasso, predecessore di Casellati alla presidente del Senato ed ex
procuratore Antimafia.
Alcune fonti avevano infatti
raccontato a Domani che anche l’ex presidente Grasso aveva avuto finestre nuove
pagate dallo stato. «È falso» dice il portavoce Alessio Pasquini: «Quando fu
eletto lui viveva in zona Laurentina, in periferia di Roma, perché aveva
rinunciato a vivere a palazzo Giustiniani, come voleva lo spirito anti casta del
tempo. L’allora prefetto gli mandò però una lettera, con allegati un preventivo
molto alto per la messa in sicurezza della sua abitazione.
Lui rispose che non voleva
pesare per centinaia di migliaia di euro sui contribuenti, e così si convinse a
spostarsi con tutta la famiglia a palazzo Giustiniani». Grasso però ha pure
un’abitazione a Palermo. Abbiamo chiesto se sono stati fatti lavori almeno lì:
«C’è solo una garitta costruita anni fa, null’altro», conclude Pasquini. «Tra
l’altro gli sembrò opinabile che da procuratore nazionale antimafia minacciato
dai clan avesse bisogno di minori protezioni rispetto a quando è diventato capo
del Senato»
A sentire le fonti dirette,
solo Elisabetta Casellati avrebbe dunque goduto di un superbonus immobiliare
così oneroso destinato alla sua villa. E quanto ci è dato sapere la presidente
non è mai stata obiettivo dei clan come Grasso.
Le uniche minacce conosciute
verso Casellati sono quelle ricevute un anno fa via social da due uomini: un
62enne di Teramo e un 42enne della provincia di Verona, “leoni da tastiera”
disoccupati, con piccoli precedenti alle spalle e non appartenenti a frange
estremiste. Fortunatamente sono stati individuati dai carabinieri. Ma
difficilmente la coppia sarebbe riuscita a entrare nella villa-bunker che il
Viminale ha voluto per la presidente.
I PROBLEMI DELLA
PRESIDENTE. Quirinale, Elisabetta Casellati e i passi falsi della donna che
aspira alla presidenza.
VANESSA RICCIARDI su Il Domani il 26 gennaio 2022.
La presidente nel suo
curriculum ha molte situazioni poco chiare: la difesa di Berlusconi su Ruby
«nipote di Mubarak», voli di stato mai giustificati, poco opportuni fondi
pubblici ai concertisti del figlio Alvise a New York e lo stop alle
interrogazioni del Metropol
Mentre la presidente del
Senato Elisabetta Casellati prende quota tra i nomi coperti della “rosa” di
centrodestra per il Quirinale, ha iniziato a circolare in rete il video di
quando a La7 ha difeso strenuamente la versione di Silvio Berlusconi su Ruby
“Rubacuori”, il caso da cui sono partite le inchieste per le «cene eleganti» e
la presunta prostituzione minorile: per Casellati era credibile che B. la
ritenesse la “nipotina” del presidente egiziano Hosni Mubarak e per questo si
sarebbe mosso in suo favore.
La presidente, che adesso
aspira al Colle, non ha avuto nel suo passato solo quella gaffe, tra voli di
stato per tornare a casa mai giustificati, poco opportuni fondi pubblici ai
concertisti del figlio Alvise a New York, sono molti i dubbi che accompagnano la
sua candidatura.
Anche la sua presunta
posizione “super partes” suscita qualche perplessità, visto che nel 2019 ha
deciso di non ammettere nessuna delle interrogazioni dei dem che riguardavano
l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini per la trattativa del Metropol di
Mosca. Il caso che lei aveva definito un «pettegolezzo giornalistico» ha visto
indagato l'ex portavoce di Salvini per corruzione internazionale.
I VOLI DI STATO
La tratta Roma-Venezia è stato
il tragitto che la presidente del Senato avrebbe percorso più spesso nei 124
voli di Stato effettuati da maggio del 2020 fino al 21 aprile 2021. Un numero
elevato di spostamenti sul Falcon 900 dell'Aeronautica che ha scatenato le
richieste di chiarimento da parte del Movimento 5 Stelle. Non solo. Il Codacons
ha presentato un esposto alla Corte dei Conti con l'obiettivo di «accertare il
possibile danno sul fronte erariale».
Il quotidiano La Repubblica ha
dettagliato: 97 volte sulla rotta Roma-Venezia (il tragitto casa - lavoro) e 6
volte tra la Capitale e la Sardegna. L’ex pentastellato Alessandro Di Battista
ha fatto i calcoli: «C’è chi sostiene che un'ora di Falcon costi tra i 5000 ed
i 7000 euro. Se fosse così i voli blu della Casellati ci sarebbero costati circa
750.000 euro nell'ultimo anno».
La presidente non ha mai
voluto rispondere ufficialmente, solo a margine di un evento pubblico ha detto
al sindaco di Milano, Beppe Sala, con cui stava camminando: «Tutto per arrivare
a lavorare. Non c’erano voli, non c’erano treni, questo nessuno lo dice». Nessun
commento su quelli per andare in vacanza in Sardegna.
I SOLDI AI CANTANTI
DEL FIGLIO
Il 27 luglio
2021 L’Espresso ha rivelato che l’Istituto italiano di cultura di New York, che
dipende dal ministero degli Esteri, ha finanziato con 30mila dollari
un’iniziativa legata al figlio, il maestro Alvise Casellati e dei suoi cantanti,
pagando agli artisti una masterclass in cui i protagonisti del concerto “In
onore di Enrico Caruso” si sono esibiti davanti alle telecamere.
L’evento si sarebbe tenuto il
28 giugno a Central Park e la registrazione è del giorno prima. «Le prove
generali», obietta il settimanale. L’Istituto italiano di cultura di New York
dipende dal ministero degli Esteri e ha ribadito che Caruso è «un’icona di
italianità». Casellati non ha mai ritenuto di dover spiegare.
IL METROPOL
Sul caso del Metropol di Mosca
che ha messo in difficoltà il leader della Lega Matteo Salvini, Casellati ha
invece utilizzato con tutta evidenza il suo peso istituzionale.
L’Espresso nel 2019 ha portato
alla luce la trattativa a cui ha partecipato l’ex portavoce di Salvini, Gianluca
Savoini, nello storico hotel russo per finanziare la Lega tramite una fornitura
di gasolio all'Eni. Oltre all’inchiesta, con foto degli incontri in quei giorni
di Savoini, è stato pubblicato anche un audio da BuzzFeed.
Per Casellati però si trattava
solo di chiacchiericcio, e ha bloccato le interrogazioni del Pd che erano state
presentate all’indirizzo del ministro dell’Interno, allora lo stesso Salvini,
per fare luce sulla vicenda.
L’11 luglio del 2019 ha
risposto in Aula ai parlamentari che le chiedevano conto della scelta: «Le mie
decisioni sono inappellabili», ha esordito in un’agitata seduta d’assemblea, «io
ho risposto egualmente – ha proseguito -, giustificando e dicendo che il Senato
non può essere il luogo del dibattito che riguarda pettegolezzi giornalistici».
Lo stesso giorno è arrivata la notizia che Savoini era stato indagato dalla
procura.
Il Partito democratico e il
Movimento 5 stelle, nei colloqui tra le forze politiche, continuano a dire no al
suo nome per la presidenza della Repubblica dopo Sergio Mattarella.
VANESSA RICCIARDI. Giornalista
di Domani. Nasce a Patti in provincia di Messina nel 1988. Dopo la formazione
umanistica tra Pisa e Roma e la gavetta giornalistica nella capitale, si
specializza in politica, energia e ambiente lavorando per Staffetta Quotidiana,
la più antica testata di settore.
Estratto dell'articolo di
Filippo Ceccarelli per la Repubblica il 26 gennaio 2022.
Fuori da ogni retorica e
ipocrisia, il bello della corsa per il Quirinale è che riattiva la memoria di
eventi così belli, simbolici e a questo punto densi di presagi da sembrare
finti, mentre al contrario sono avvenuti sul serio.
Era il 17 settembre del 2020
quando, lungo la strada che portava a Vo' Euganeo, nel tentativo di superare di
gran carriera il mega corteo istituzionale, una delle auto della scorta della
presidente del Senato Casellati speronò una vettura della scorta del presidente
della Repubblica che precedeva quella su cui viaggiava, in tutta serenità,
Sergio Mattarella.
Seguirono attimi di paura,
anche perché nel frattempo, sul lato opposto della carreggiata era sopraggiunta
una Panda guidata da un pensionato che, dinanzi al potenziale groviglio di
lamiere blindate, si buttò fuori strada per evitare il crash .
Casellati era in ritardo,
toccando a lei di accogliere Mattarella. Purtroppo le cronache non fanno
riferimento a eventuali sirene quale solenne colonna sonora all'incidente. Il
pensionato si salvò. Una volta sul posto, la scorta del Quirinale non fu per
nulla amichevole con quella di Palazzo Giustiniani. Ma l'episodio, che sembra
tratto da una commedia all'italiana, proietta inesorabili bagliori sull'attuale
corsa di Casellati, detta in Senato, con qualche rassegnazione, "Queen
Elizabeth". (...)
Che non c'è niente di male,
beninteso, ad accogliere riconoscimenti, e neppure a distribuirne a destra e a
manca. Però insomma, rispetto a tanti austeri predecessori (non rientra nel
novero Pera, che ricevette Totti e Miss Italia), l'impressione è che una
maggiore economia premiale, oltre che un uso più sorvegliato degli spazi e degli
aerei a disposizione della seconda carica dello Stato, uno dei quali sorpreso in
enigmatici andirivieni con la Costa Smeralda, avrebbe forse meglio protetto il
Parlamento, già così screditato e malmesso.
Ma Casellati intraprende
facile e non solo è salita anche sull'elicottero che nella prima fase del Covid
ha voluto sorvolare il Veneto con le reliquie di Sant' Antonio, ma è molto fiera
di aver aperto la bomboniera di Palazzo Madama alla cultura, dapprima
meritoriamente, arte, dramma antico, teatro, poesia; però poi in aula sono
finite per risuonare le note di Trottolino amoroso (tu-tu-tu tà-tà-tà) e la
presidente, che è mamma di un direttore d'orchestra, le ha accompagnate
oscillando il capo, come da indimenticabile video YouTube; poi è arrivato anche
Fausto Leali: Ti lascerò . Ma queste sono pruderie da babbioni che non c'entrano
tanto con la voglia che il personaggio mostra di ascendere al Colle.
E qui gli archivi a volte sono
bugiardi, ma vi si trova scritto che Salvini aveva già "promesso" il Quirinale a
Casellati nell'estate 2019, quand'era accolto sui palchi col Vincerò , prima
durante e dopo il Papeete. Se i lapsus hanno un senso, durante la crisi di
governo, sbagliandosi per ben due volte nella stessa seduta, lei chiamò lui
«presidente » (era ministro).
Quanto ai Cinque stelle,
subito dopo averla votata (in cambio di Fico alla Camera), sempre negli archivi
si legge che Gigino Di Maio si avvicinò a Casellati e con occhietto vispo e voce
flautata: «Possiamo darci del tu?» (risposta: «Sì, ti prego, sennò mi sento
vecchissima»).
Appena eletta, d'altra parte,
come prima cosa Casellati si era recata a casa di Berlusconi, che strenuamente
aveva difeso nel caso Ruby (di qui l'irresistibile appellativo makkoxiano: "La
Zia di Mubarak"), poi con piazzata sotto il tribunale di Milano (lo ricorda nel
suo libro Ilda Boccassini) e vestendosi di nero in Senato nel momento in cui il
Cavaliere decadde. Per quanto fin troppo abusata, "l'alto profilo" resta
un'espressione fin troppo impegnativa. Non sarebbe male, ogni tanto, misurarla
sulla realtà - a cominciare da quella delle strade percorse dai cortei
presidenziali.
Meriti e sogni. Quando
Maria Elisabetta Casellati diceva che Abbado, Piano, Elena Cattaneo e Rubbia non
meritassero il seggio di senatore a vita.
L'Inkiesta il 26 Gennaio 2022.
Nel 2013 l’attuale presidente
del Senato criticò la decisione del Capo dello Stato di dare un posto in
Parlamento a quattro italiani di enorme spessore e riconoscimento
internazionale. Per lei non avevano «meriti sufficienti»: la sua proposta era
Berlusconi.
Oggi per il centrodestra
sembra che la figura su cui puntare per il Quirinale sia quella di Maria
Elisabetta Casellati. La presidente del Senato era stata volutamente tenuta
fuori dall’elenco di candidati che Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio
Tajani avevano stilato in un primo momento, un piano b rispetto alla triade
Marcello Pera, Letizia Moratti, Carlo Nordio: insomma, Casellati come una
riserva di lusso.
«Casellati è candidabile senza
che Salvini la proponga», ha detto lo stesso Salvini, confidando di poter
trovare diverse decine di voti nel Movimento 5 stelle. Per il centrodestra
Casellati è candidabile in quanto già rappresentante di una delle più importanti
istituzioni italiane. Ma proprio lei in passato, da senatrice di Forza Italia,
aveva provato ad abbattere ogni parametro logico della definizione di
«candidabile».
Era il 2013. Mentre il partito
di Silvio Berlusconi provava a difendere il suo leader proponendolo come
senatore a vita, Casellati – con Lucio Malan – contestava le ultime quattro
nomine fatte dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: il
direttore d’orchestra Claudio Abbado, la ricercatrice Elena Cattaneo,
l’architetto Renzo Piano e il premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia.
«Pur rispettando il Capo dello
Stato e i quattro nominati, dalle carte trasmesse alla Giunta, non sono emersi
elementi sufficienti ad identificare gli “altissimi” meriti scientifici della
professor Cattaneo né gli “altissimi meriti sociali” attribuiti a tutti e
quattro», diceva l’attuale presidente del Senato, chiedendo un rinvio della
convalida per l’acquisizione della documentazione necessaria, non considerando
“sufficienti” i loro meriti.
Quattro italiani di enorme
spessore e riconoscimento internazionale, eppure giudicati non meritevoli.
Proprio in quei giorni di fine 2013 Berlusconi era decaduto da senatore,
condannato con sentenza definitiva e con una serie di processi in corso e
sentenze di primo grado che lo indicavano come colpevole di diversi reati.
Corrado Ocone per "Libero
quotidiano" il 27 gennaio 2022.
Sabino Cassese è sicuramente
uno che non le manda a dire. Si può non essere d'accordo con le sue tesi, vi si
può leggere a volte una impronta di intellettualismo, ma comunque si deve
ammettere la sua onestà intellettuale. Che fa tutt' uno con la sua dottrina e
preparazione giuridica, anche se di una giurisprudenza molto poco meridionale
(lui che è di Atripalda in provincia di Avellino) e molto comparativistica e
anglosassone. La sua mentalità è empiristica: dati, numeri, fatti conosciuti e
descritti con precisione, diagnosi e prognosi, ovvero proposte concrete.
"Conoscere per deliberare"
potrebbe essere anche il suo motto. E, in effetti, un timbro einaudiano
contraddistingue i suoi interventi pubblicistici, di cui per nostra fortuna è
molto generoso: come il primo Presidente della nostra Repubblica, egli sa
spiegare in modo semplice questioni complesse riducendole agli elementi più
semplici, il tutto condito da una sottile vena ironica che i lettori più attenti
non tardano a cogliere.
I suoi articoli sono in
qualche, sempre come quelli di Luigi Einaudi, delle "Prediche inutili". Il suo
pallino fisso è la riforma dello Stato, che per lui significa essenzialmente due
cose: svecchiamento della macchina burocratica, con le sue procedure arcaiche e
i suoi funzionari che assomigliano un po' ai mandarini cinesi, gelosi del loro
potere e capaci di bloccare o stravolgere ogni tipo di legge; necessità di
semplificare, ridurre, e rendere semplici nel dettato e nello spirito, quelle
migliaia e migliaia di leggi e sottoleggi, commi e codicilli, che assomigliano a
una vera e propria "selva oscura" o a un labirinto che sembra studiato apposta
per far perdere in esso l'onesto cittadino.
Ultimamente nemmeno la legge
di Bilancio del governo Draghi ha superato l'esame della sua lente
d'ingrandimento, o del suo "rasoio di Occam": "l'anno è terminato con un fuoco
d'artificio finale", ha esordito ironico, e giù ad elencare tutte le
contraddizioni e le oscurità linguistiche di quello che non ha esitato a
definire un parto mostruoso.
Cassese ha un forte senso
delle istituzioni e una conoscenza non effimera dei meccanismi parlamentari,
quella stessa che proprio stamattina l'ha portato a smascherare sui giornali il
sofisma o "cattivo ragionamento "che si vorrebbe far passar in questi giorni: e
cioè che la maggioranza che elegge il Presidente della Repubblica debba essere
per forza di cose la stessa che elegge il presidente del Consiglio.
Durante la manifestazione di
Atreju, Cassese si è anche detto favorevole ad una riforma in senso
presidenzialistico della nostra Costituzione, che lui ha sempre rispettato ma
senza esserne una "vestale". Il che andrebbe in contraddizione con la sua
allergia, molto salveminiana, alla retorica patria. Parole molto forti ha anche
usato, nel recente passato, contro certe politiche pandemiche, soprattutto del
governo Conte: pronte a non bilanciare, come era giusto che fosse, le esigenze
di sicurezza con il rispetto delle libertà individuali e della stessa
Costituzione.
Sicuramente Cassese, che fra
l'altro è amico di vecchia data di Sergio Mattarella, ricoprirebbe il ruolo di
Presidente della Repubblica con autorevolezza e imparzialità. Onestà
intellettuale però impone che qui si considerino anche alcune idee del nostro
che a chi scrive non sembrano condivisibili. Cassese crede forse troppo nelle
istituzioni sovranazionali (qualcuno ha scritto che è un "onusiano") e nel
superamento dello Stato-Nazione: poco attratto dal realismo politico, confida
troppo nei "diritti umani" e negli universali "principi morali", ed è poco
attento al monito di Machiavelli che dice che gli "Stati non si governano coi
Paternostri".
Da qui forse la sua
incomprensione delle esigenze reali di cui si sono fatti portavoce i cosiddetti
movimenti "sovranisti". Molto criticabile è anche la sua concezione del ruolo
dell'intellettuale, che per lui deve avere una voce di riguardo e una priorità
nel dibattito politico e nello stesso governo (un po' il modello platonico del
re-filosofo).
Che è una esigenza
"epistocratica", come lui stesso la chiama, che non ha molte buone ragioni dalla
sua. Né teoriche, perché gli intellettuali in quanto specialisti tendono a
mettere in primo piano gli elementi a loro cari, che radicalizzano perdendo
spesso di vista l'insieme e il buon senso; né storiche, viste le tragedie che
hanno causato tutte le volte che sono andati al potere. Non è vero che "uno vale
uno", ma chi vale più di uno non sempre è un intellettuale o un uomo di scienza.
Dagospia il 27 gennaio 2022.
Riceviamo e pubblichiamo: Stimato Roberto, se il centrodestra propone Sabino
Cassese per il Quirinale, il Pd non potrebbe negargli i voti, visto che nel 2013
lo stesso emerito giurista fu uno dei candidati piddini al Colle. Eppure, i
troppi terminali parlamentari della casta togata potrebbero azzannare lo
strenuo-temerario Sabino, che, a suo rischio e pericolo, ha più volte osato
criticare la sete di strapotere della magistratura. Giancarlo Lehner
Quirinale. L'ironia di
Cassese sull'ipotesi candidatura: "Io al Colle, perché escluderlo?"
Concetto Vecchio per repubblica.it il 27 gennaio 2022.
Telefoniamo di buon mattino a
Sabino Cassese, 86 anni, già giudice della Corte costituzionale, uno dei
giuristi più influenti del Paese.
Buongiorno professore, è vero
che ieri ha incontrato Salvini?
"Intanto mi scuso con lei se
ne le ho risposto ieri sera, ma ero impegnato con un concerto".
Un concerto per il Quirinale?
(Ride)
Mi avevano detto che lei era
impegnato in una riunione.
"Guardi, si è creata attorno
all'elezione del Capo dello Stato un'attenzione smodata. Non trova che i
problemi dell'Italia siano altri? Invece tutti parlano soltanto del prossimo
presidente della Repubblica".
Ma stiamo parlando del Capo
dello Stato.
"Ma ci sono cose più
importanti. Tra qualche decennio saremo trenta milioni, perché nessuno fa più
figli. Abbiamo il tasso più basso di laureati nella Unione europea, il minor
numero di nuovi iscritti quest'anno. La sanità territoriale è tutta da
rifondare. La scuola pure".
D'accordo, ma lei ha visto
Salvini?
"Siamo presi tutti da un
eccesso agonistico".
Professore!
"Colgo il suo mugugno".
Perché non mi risponde.
(Ridendo).
"Non è vero!"
Non vi siete visti?
"No"
E allora com'è nata la notizia
della visita di Salvini a casa sua?
"Qualcuno deve avere avuto una
visione".
Una visione?
"Ma sì. Io vivo come i monaci
stiliti, ha presente? Scelsero di vivere su una colonna. Ecco, non vedo nessuno,
manco i miei nipoti..:"
La notizia dell'incontro l'ha
anticipata Il Foglio, a cui lei autorevolmente collabora.
"Eh, capisco, capisco.
Cercherò il direttore Claudio Cerasa, e gli domanderò la fonte. Ecco, lui sì che
una volta è stato ospite a casa mia, a pranzo".
Un vicino di casa ha visto
Salvini uscire dalla sua palazzina, risulta a noi di Repubblica.
"Sopra casa mia abita un ex
senatore, che per inciso è stato anche mio studente".
Quindi è andato da lui?
"Perché no?"
Quindi smentisce?
"Salvini non lo conosco".
Professore, per molti lei
sarebbe stata una degna opzione per il Colle.
"Perché lo vuole escludere?"
Da ilriformista.it il 27
gennaio 2022.
Dopo l’editoriale di domenica
sul Corriere della Sera, il professor Sabino Cassese, giudice emerito della
Corte Costituzionale, è tornato sulle nostre pagine per commentare ulteriormente
l’ipotesi di prorogare lo stato di emergenza nel nostro Paese da parte del
Governo. Proprio sul Riformista risponde al premier Giuseppe Conte che lo ha
accusato dalla pagine del Fatto di dire “stupidaggini” e non manca anche una
sferzata al ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia:
le sue dichiarazioni hanno la stessa chiarezza di quelle della Sibilla Cumana.
Da Palazzo Chigi fanno sapere
che “non si tratta di avere pieni poteri, ma di farsi trovare pronti in caso di
recrudescenze del virus”. È un semplice gioco di parole ma la sostanza rimane la
stessa?
La dichiarazione dello stato
di emergenza richiede un attuale – sottolineo attuale – stato di emergenza. Ci è
stato detto che possiamo muoverci da casa, viaggiare, andare in ufficio, vedere
i parenti. Dov’è lo stato di emergenza? Qualora si presentasse davvero una
emergenza, quanto tempo è necessario per riunire il Consiglio dei ministri per
dichiarare lo stato di emergenza?
Domenica sera è trapelata
l’ipotesi di estendere lo stato di emergenza non più al 31 dicembre ma al 31
ottobre. Come giudica questo passa indietro?
Mi fa dubitare della serietà
del motivo, che non dovrebbe prestarsi a trattative e negoziati.
Esperti del diritto – come
Clementi – e politici – come Emma Bonino – richiamando l’articolo 77 della
Costituzione, suggeriscono l’utilizzo del decreto legge per affrontare la Fase
3, al posto dei dpcm. Lei cosa ne pensa?
Gli interventi sulle epidemie
sono regolati dalla legge del 1978 e dovrebbero essere di competenza del
Ministro della Salute. Si è preferito ricorrere alla norma del 2018 sulla
protezione civile (io ho dubbi sulla legittimità del ricorso a questa norma).
Questa richiede la sola delibera del Consiglio dei ministri.
Secondo Lei dietro l’eventuale
proroga dello stato di emergenza, c’è l’obiettivo di rinviare le elezioni di
settembre? Dunque posticipare lo stato di emergenza potrebbe essere una scelta
più di opportunità politica che di salute pubblica?
Non credo che vi siano tali
intenti secondari. Se vi fossero, sarebbe grave, dopo la discussione che c’è
stata in Parlamento sulla data delle elezioni.
Il ministro Boccia,
incontrando i giornalisti in occasione della visita in Umbria, ha dichiarato
ieri: “L’estensione dello stato d’emergenza a seguito del Covid-19 non limita la
libertà individuale delle persone ma consente di avere maggiore protezione da
parte dello Stato”. Si tratta una lettura troppo semplicistica?
La frase del ministro delle
regioni è tanto chiara quanto le profezie della Sibilla Cumana.
Il premier Giuseppe Conte in
una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano risponde al suo editoriale di
domenica sul Corriere della Sera: “Chi evoca il modello Orbàn dice una sonora
stupidaggine. Io non ho né voglio pieni poteri”. Come replica?
I fatti, perché i suoi lettori
possano giudicare. Ho scritto, al termine di un articolo sul Corriere della sera
di domenica: “Non dimentichiamo che Viktor Orbán cominciò la sua carriera
politica su posizioni liberali”. Orbán è sotto giudizio dell’Unione europea per
aver fatto adottare dal Parlamento ungherese una legge che dichiara uno stato di
emergenza senza fissare un termine.
La dichiarazione dello stato
di emergenza e i successivi decreti legge hanno consentito in Italia a una
persona sola, con dpcm, di chiuderci in casa, vietarci di andare al lavoro, non
visitare parenti, e così via. Tutto per di più selettivamente, perché intere
filiere sono state esentate.
Il primo decreto legge
disponeva queste ed altre limitazioni (innominate) senza fissare un termine
temporale e dando mano libera nel disporre limiti con dpcm. Il governo ha
successivamente capito e ha abrogato quasi tutto tale decreto, approvandone un
altro nel quale i poteri avevano un termine e i limiti un elenco. Non credo che
vi siano aspiranti dittatori. Ma temo che si possa dare il brutto esempio, cioè
creare precedenti. E si sa che i giuristi credono molto nei precedenti.
Nel 2013 fu proposto dal Pd
ma vinse Napolitano. Chi è Sabino Cassese, il giurista possibile candidato
presidente della Repubblica.
Riccardo Annibali su Il
Riformista il 26 Gennaio 2022.
Fonti della Lega smentiscono
l’incontro di Salvini nella casa romana del professore Sabino Cassese, trapelata
pochi minuti prima. Cassese, che risulta comunque uno dei nomi senza tessere di
partito e super partes, è ex ministro della Funzione pubblica nel governo
Ciampi, giudice emerito della Corte costituzionale, editorialista del Foglio e
del Corriere della Sera. Il leader del Carroccio aveva dichiarato poco prima:
“La soluzione può essere vicina” e si è reso disponibile a incontrare, come da
richiesta, il segretario del Partito democratico Enrico Letta.
Giudice emerito della Corte
Costituzionale e ministro del Governo Ciampi, Sabino Cassese è una delle
personalità più conosciute sia a livello giuridico che politico, visti i diversi
incarichi ricoperti nella sua lunga carriera. Subito dopo essere andato in
pensione, il giurista è diventato giudice emerito della Corte Costituzionale.
Nato ad Atripalda in provincia
Avellino, il 20 ottobre 1935, figlio dello storico Leopoldo Cassese e fratello
di Antonio, giurista esperto di diritto internazionale. Sabino Cassese è un
esperto giurista e celebre accademico, oltre che giudice emerito della Corte
costituzionale. Dal 1952 al 1956 è stato allievo del prestigioso Collegio
Medico-Giuridico (allora annesso alla Scuola Normale Superiore di Pisa, oggi
inglobato nella Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
Sant’Anna) e si poi è laureato con lode all’Università di Pisa e diplomato
presso la Scuola Normale Superiore – Collegio giuridico con pieni voti nel 1956.
Nel 1993 il presidente del
Consiglio Carlo Azeglio Ciampi lo ha nominato Ministro per la funzione pubblica,
un incarico ricoperto per poco più di un anno, già negli anni precedenti il
giurista era entrato in Parlamento e a Palazzo Chigi come presidente di diverse
Commissioni. Nel 2013 il Partito Democratico aveva pensato a lui come presidente
della Repubblica anche se alla fine la maggioranza ha scelto la riconferma di
Giorgio Napolitano.
Negli ultimi anni si
è dedicato all’attività di giornalismo collaborando come editorialista con il
Corriere della Sera e Il Foglio. Un’opportunità per esprimere le proprie idee
come fatto nel 2016 quando ha preso una posizione a favore del sì al referendum
confermativo della Riforma costituzionale voluto da Renzi e dall’ex ministra
Boschi.
In un’intervista
a Repubblica rilasciata lo scorso dicembre disse: “Checché se ne dica, il
Presidente della Repubblica ha un grande potere, superiore a quello di un
presidente degli Stati, se è omogeneo al governo ed è espressione della
maggioranza parlamentare. Potrebbe, nel caso di un leader politico,
potenzialmente disporre dei numeri necessari per fare passare i provvedimenti
che gli stanno a cuore. Ecco perché si è sempre evitato di scegliere un
capocorrente”. Esperto di inquilini del Quirinale, ha curato un’opera in due
volumi: “I presidenti della Repubblica – Il capo dello stato e il Quirinale
nella storia della democrazia italiana”.
L’11 dicembre scorso partecipò
ad Atreju, la tradizionale festa di Fratelli d’Italia. In quell’occasione prese
parte al dibattito ‘Analisi, necessità e prospettive di una riforma dello Stato
in senso presidenziale’. “Se intendo sostenere la proposta di riforma
costituzionale in senso presidenzialista presentata da Fratelli d’Italia? Direi
certamente”. Riccardo Annibali
La candidatura al
Quirinale. Sabino Cassese: “Ecco la prima cosa che farei da Presidente della
Repubblica”.
Aldo Torchiaro su Il Riformista il 28 Gennaio 2022.
“Attenti a non esagerare, non
fate gli ultrà”. Sabino Cassese, uno dei nomi più ricorrenti nelle trattative
tra i partiti per il Quirinale, risponde scherzosamente al Riformista. Gli diamo
conto di una dichiarazione di Giorgia Meloni che lo sostiene. Salvini si sarebbe
detto d’accordo. “Mi sostengono con forza? Non so se sia un bene”, risponde per
alleggerire con una battuta. Sul suo nome rimane una significativa convergenza,
anche il Pd non esclude di votarlo mentre Silvia Fregolent, di Italia Viva, si
espone: “Sarebbe un Presidente eccezionale”. E Carlo Calenda conferma
al Riformista: “Sì che lo voterei”. Il giurista non si lascia andare a facili
entusiasmi, tutt’altro.
“Come vivo questo momento?
Cerco di lavorare, ma mi telefonano in tanti. E cerco di lavorare tra una
telefonata e l’altra”. Sorpreso? “Non tanto”, chiosa con un sorriso il giurista.
Ricorda al telefono con noi (audio integrale qui) quella volta in cui venne
chiamato a fare il ministro. Governo Ciampi, 1993. “Ero a cena fuori, non ne
sapevo niente. Alle 23 iniziano a telefonarmi tutti, credetti fossero impazziti:
avranno scambiato la notte per il giorno? Poi capii che ero stato eletto”. Ma
per oggi, invita alla cautela. “Aspettiamo, aspettiamo”. La prima cosa da
Presidente? “Una passeggiata”. E un arrivederci: “Sentiamoci quando sarà finita,
così le dico cosa penso del neopresidente”. Forse si conoscono bene.
Aldo Torchiaro. Romano e
romanista, sociolinguista, ricercatore, è giornalista dal 2005 e collabora con
il Riformista per la politica, la giustizia, le interviste e le inchieste.
In Onda, Sabino Cassese sul
Quirinale: "Non mi ha cercato solo Matteo Salvini...", la confessione cambia il
quadro.
Libero Quotidiano il 30 gennaio 2022.
Ora che la partita del
Quirinale si è chiusa con il bis di Sergio Mattarella, parla uno dei
protagonisti della convulsa settimana che si va a chiudere: Sabino Cassese, il
costituzionalista che per una notte è sembrato vicinissimo alla presidenza della
Repubblica. Lo fa a In Onda, il programma de La7 condotto da Concita De
Gregorio e David Parenzo. E Cassese svela particolari importanti: no, non lo ha
cercato solo la Lega con Matteo Salvini, così come si pensava fino ad ora.
Il giurista premette: "È
giusto che le forze politiche abbiano cercato di lanciare dei nomi e fare degli
accordi. Dobbiamo essere però felici per l'esito di Mattarella, il nome che ha
raccolto più consensi". Dunque le lodi a Luigi Di Maio per quanto detto dopo la
conferma di Mattarella: "Teniamo presente di che mutamento radicale c'è stato
nel M5s. La dichiarazione di Di Maio poteva essere quella di un vecchio notabile
della Dc di settant'anni. Sentire quelle cose da lui mi ha fatto piacere, vuol
dire che la loro forza è a disposizione della Repubblica, è molto importante",
sottolinea (delegittimando, de facto, Giuseppe Conte).
La sesta votazione sarà quella
decisiva? Indiscrezione sulle nuove candidature: tre "condivisi" e una grossa
sorpresa
Quindi Concita chiede chi lo
abbia cercato, in questi giorni. E Cassese ammette: "Sì, ho avuto dei
contatti. Con Italia Viva, con la Lega e con Fratelli d'Italia". "È bizzarro che
la abbia cercato la destra...", commenta sorniona Concita. E lui ricorda: "Io
ero stato invitato a parlare insieme ad altre persone di tutte le altre forze
politiche ad Atreju, alla riunione conclusiva, riguardava il presidenzialismo".
La De Gregorio insiste: "FdI la avrebbe votata? Ne ha parlato con la Meloni?".
"Scusi, ma poi che senso ha fare questa storia retrospettiva?", conclude
Cassese. Resta il dato politico: stando a quel che dice, è stato cercato anche
da FdI e da Matteo Renzi. Già, al Colle ci è stato davvero vicino.
IV GIORNO DI VOTAZIONI.
Le urla di Meloni (per il
nome di Casini), l’occhiolino di Di Maio: diario di una trattativa invisibile.
Fabrizio
Roncone su Il Corriere della Sera il 27 Gennaio 2022.
Nel voto per il presidente
della Repubblica, i leader sono impegnati a rassicurare i rispettivi grandi
elettori (ma senza spiega nulla).
Ecco quello che succede qui a
Montecitorio. Un giochetto che, dopo quattro giorni, sta diventando stucchevole.
Per dire: Matteo Salvini
spunta dal nulla nel Transatlantico affollato dai grandi elettori, lo attraversa
a passo di carica, con una finta evita il leghista Claudio Borghi che vorrebbe
congratularsi a prescindere, entra nell’emiciclo, vota, esce e fila via verso il
portone principale.
Mischione di cameramen e
fotografi in attesa, microfoni a mezz’aria. La dichiarazione di Salvini è:
«Offrirò nomi noti anche a livello internazionale».
Ma quando l’ha deciso?
E dove?
E con chi?
Giorgia Meloni è d’accordo?
Hanno telefonato a Silvio
Berlusconi?
C’è un elenco di quei nomi?
Sono domande che non hanno
risposta. Circa mille grandi elettori devono accontentarsi di apprendere le
notizie dalle agenzie di stampa. Meno di dieci persone (Salvini, Letta, Meloni,
Di Maio, Conte, Franceschini, Renzi e pochi altri) stanno decidendo il nome del
nostro nuovo presidente della Repubblica incontrandosi, parlandosi, trattando e
litigando, litigando parecchio, lontani da questo salone liberty e dal
cortiletto dove bivacchiamo tutti — votanti e cronisti, portavoce e portaborse,
un tizio con il Borsalino calato sulla testa che nessuno sa chi sia, un altro
vestito da marinaio con un maglione giallo che non cambia da lunedì — tutti
fumando come non ci fosse un domani, sigari, sigarette vere e sigarette
elettroniche, con la mascherina abbassata anche chi non fuma, tra botte di noia
pazzesca e soprassalti di cupo terrore; i grillini, non appena torna a circolare
l’ipotesi che alla fine sia Mario Draghi a salire su al Quirinale, annusano il
rischio elezioni e vanno nel panico.
Luigi Di Maio lo sa: e,
infatti, viene a votare con il chiaro e unico intento di «tranquillizzare» la
fanteria a 5 Stelle, che lo adora. «Giggino caro, che ci dici?». «Giggino, ah se
non ci fossi tu...». Lui offre il corpo fasciato in un abito di sartoria
napoletana e si lascia sfiorare, accarezzare, stringe mani e incede, un po’
ministro degli Esteri e un po’ sultano, un sorriso qua, un occhietto là,
rassicurante come venti gocce di En. Ma anche Di Maio: mai visto scambiarsi
mezza parola in pubblico con Letta. O con Speranza.
Rocco Casalino, leggendaria
ombra di Giuseppe Conte, capita l’antifona, ha suggerito: «Peppino, meglio che
vieni a farti un giretto...».
E così si presenta pure Conte,
che non è un grande elettore ma sarebbe comunque il capo in carica del
Movimento. Eccolo allora comparire morbido nel suo cappotto di cashmere, saluta
un paio di giornalisti e poi va alla buvette, incontra Liliana Segre e si lascia
fotografare: quando però riparte nel suo giro pastorale non riconosce le sue
pecorelle stellate, ne liscia una dozzina che si aspettano almeno un cenno, e
invece niente, procede distribuendo sorrisi e inconsapevoli sospetti.
Guardate: non è che in
passato, per esempio nel maggio del 1992, Giulio Andreotti venisse a sedersi su
questi divanetti per trattare la sua candidatura al Colle; restava per ore
chiuso nel suo ufficio a cercare di spiegare quanto e come fosse più giusto
votare lui e non il suo avversario, Arnaldo Forlani, il Coniglio Mannaro (cit.
Giampaolo Pansa). Però poi a spiegarti la scena scendeva Paolo Cirino Pomicino,
Ciriaco De Mita blandiva le truppe scudocrociate e ti portava a bere un caffè,
arrivava Rino Formica e dava un senso ai tuoi appunti.
Stavolta, invece: tutti
distanti. Nascosti.
Certo le urla della Meloni
erano così forti che sono rotolate giù dal palazzo dei gruppi, le finestre che
affacciano su via degli Uffici del Vicario. Nella notte, Lega e FI le avevano
preparato un pacchetto. Lei l’ha scartato e dentro ci ha trovato il nome di Pier
Ferdinando Casini.
Così s’è capito anche perché,
fino all’alba, Salvini fosse sparito (certo non era tornato a casa del professor
Sabino Cassese: quelli del Foglio giurano che la visita sia avvenuta nelle ore
precedenti). Però, per intenderci: adesso le agenzie di stampa battono la
notizia che è irraggiungibile Conte.
Dove sei Conte? Che fai?
Quanto al Cavaliere: è ancora
ricoverato, ed è complicato persino parlargli al telefono (pure Mario Draghi ha
faticato un po’). Enrico Letta, invece, è poco loquace anche quando vede le
partite del Milan, figuratevi adesso (poi comunque nel Pd sono così tanti quelli
che pensano di decidere qualcosa, che alla fine vivono meglio).
Il live minuto per minuto.
Elezione Presidente della Repubblica, la diretta della quinta giornata di voto:
torna l’ipotesi Casellati.
Redazione su Il Riformista il 28 Gennaio 2022.
Si alza il sipario
sulla quinta giornata di voto, dopo l’ennesima fumata nera avvenuta ieri,
giovedì, nella quarta giornata dedicata all’elezione del 13esimo presidente
della Repubblica.
Anche questa mattina alle 11
basterà la maggioranza assoluta dei voti, 505, per eleggere il prossimo capo
dello Stato. I nomi sul tavolo sono rimasti quattro, salvo eventuali sorprese
dell’ultim’ora: il presidente del Consiglio Mario Draghi e l’ex presidente della
Camera Pier Ferdinando Casini, mentre più defilati ci sono Sergio Mattarella con
un suo eventuale bis al Quirinale ed Elisabetta Belloni, la diplomatica ora alla
guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
Il leader della Lega Matteo
Salvini ha il pieno mandato del centrodestra per avviare la conta, una prova di
forza finalizzata a puntare su un nome e cercare di trovare un’attrattiva
nell’area del centrosinistra. Il centrodestra punta su un nome di bandiera e
spunta, di nuovo, quello della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati. Ma si punta anche sul rosario di altre personalità di area
centrodestra alternative a Draghi prospettate da Salvini, Meloni e Forza Italia
dopo il ritiro di Silvio Berlusconi: Carlo Nordio, Franco Frattini, Sabino
Cassese, Letizia Moratti, Marcello Pera, Elisabetta Belloni, Giampiero Massolo.
Tutti nomi che però,
dall’altra parte del campo, Enrico Letta, Matteo Renzi, Luigi Di Maio e Roberto
Speranza hanno denunciato avere il vizio di origine di non essere candidature
condivise ma imposte. Queste scelte, infatti, nei giorni scorsi hanno fatto
infuriare i partiti di centrosinistra.
La giornata inizia con i
vertici in prima mattinata, per arrivare a eleggere il neo Capo dello Stato.
Forse con la prospettiva di creare un unicum per la storia repubblicana: mai,
infatti, è stato eletto il capo dello Stato al quinto scrutinio. Nel corso delle
precedenti 12 elezioni, il quarto voto è stato decisivo per ben quattro volte.
Il presidente della Camera
Roberto Fico comunicherà ai presidenti dei gruppi di Camera e Senato da lui
convocati, il calendario delle sedute successive, in caso di quinta fumata nera.
Sul tavolo la decisione se da stasera, oppure da domani, si inizierà a votare
due volte al giorno anzichè una.
Causa covid-19, finora si è
tenuta una sola votazione al giorno. Al massimo 50 elettori alla volta in aula
per votare. I Grandi Elettori positivi potranno votare nel parcheggio della
Camera con un seggio drive-in appositamente allestito nel parcheggio della
Camera. A votare i 1009 cosiddetti Grandi Elettori: 630 deputati, 321 senatori
(di cui 6 a vita, 5 di nomina presidenziale e un ex presidente della Repubblica)
e 58 delegati regionali, tre per ogni Regione, uno solo per la Valle d’Aosta.
Votano prima i senatori, poi i deputati e infine i delegati regionali. Il voto è
anonimo: perciò le elezioni del Capo dello Stato sono il regno dei franchi
tiratori. Solo in due occasioni, nel 1985 con Francesco Cossiga e nel 1999 con
Carlo Azeglio Ciampi, il Presidente venne eletto alla prima seduta.
Ore 08:45 – Prima del nuovo
vertice delle delegazioni di Pd, M5S e Leu, il segretario dem Enrico Letta non
nasconde la delusione per le giornate precedenti: “Abbiamo sempre lavorato per
l’unità. L’impressione è che abbiano tentato di dividerci, con idee fantasiose
con l’obiettivo di dividere e non di trovare una soluzione per il Paese”, ha
detto entrando alla Camera. E poi afferma “Chiederemo a Fico di aumentare le
votazioni e arrivare almeno a due votazioni al giorno”. E poi, con un pizzico di
amarezza, sibila: “Mi chiedo se ho fatto bene a fidarmi”. Il riferimento ricade
sul centrodestra.
Ore 08:55 – Il leader di Iv
Matteo Renzi lascia in campo l’ipotesi di un Mattarella Bis. “Non escludo
l’ipotesi che possa esservi anche un Mattarella bis, sarebbe una forzatura nei
confronti di Mattarella e oltremodo scorretto ma al venerdì mattina o la vicenda
si risolve nelle prossime ore o questa ipotesi e’ in campo con tutta la sua
forza”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi su Radio Leopolda. Per
Italia Viva non è sul tavolo la possibilità di votare il presidente del Senato
Casellati. “Noi Casellati non la votiamo come non votiamo nessun candidato
divisivo come abbiamo sempre detto. Ma il centrodestra la smetta di correre
dietro la Meloni che tenta di far saltare la maggioranza di Governo”. Lo ha
detto il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, ai cronisti della Camera.
Ore 09:00 – Il vicepresidente
di Forza Italia Antonio Tajani, arrivando a Montecitorio per il vertice di
centrodestra, assicura: “Il governo non cade. Dobbiamo lavorare molto. Vogliamo
trovare soluzioni condivise”. E nell’ostentare compattezza, punta il dito sul
centrosinistra. “E’ la sinistra che ieri si è divisa, il centrodestra è compatto
e unito. Noi scandalosi? Addirittura, dov’e’ lo scandalo. Non abbiamo mai posto
veti”.
Ore 09:10 – Dure parole della
leader di Fratelli di Italia Giorgia Meloni su Twitter: “La desolazione delle
manfrine sull’elezione del Presidente della Repubblica certifica 2 cose che
@FratellidItalia sostiene da sempre: 1. Con questo Parlamento è impossibile
decidere qualsiasi cosa. 2. Se fossero stati gli italiani ad eleggere il PdR lo
avrebbero fatto in un giorno”.
Ore 09: 21 – Il centrodestra
non ha ancora comunicato al centrosinistra il nome del candidato che oggi
dovrebbe votare per il Quirinale. E’ quanto si apprende da varie fonti mentre è
in corso il vertice di M5s, Pd e Leu. Le delegazioni stanno valutando come
comportarsi nel caso in cui il centrodestra votasse un nome di area nella quinta
votazione. L’idea ad ora prevalente sarebbe quella di uscire dall’aula o
astenersi.
Ore 09:25 – E’ iniziato, alla
Camera, il vertice del centrodestra in vista dell’elezione del presidente della
Repubblica. All’arrivo al vertice il segretario Udc Lorenzo Cesa ha detto che il
centrodestra resta orientato a votare la presidente del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati. “Sì”, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se il voto
andrà alla Presidente del Senato.
Ore 09:30 – “Proporre la
Casellati è irresponsabile? “E perché? E’ la seconda carica dello Stato. La
sinistra ha la pretesa di voler avere il monopolio dei giudizi morali, è questo
il vizio di tutta questa vicenda”. Lo ha detto il senatore di FI, Maurizio
Gasparri, arrivando a Montecitorio. E poi sul nome di Cassese uscito nei giorni
scorsi ha detto: “Cassese è stato uno dei più tenaci avversari delle idee del
centrodestra, mai potra’ essere Cassese che va cassato”. E a chi gli domandava
se è stato un errore strategico del leader leghista Matteo Salvini ha risposto:
“Non lo so, saranno stati dei comunisti a proporlo, escludo che lo abbia fatto
Salvini”.
Ore 09:45 –
Il centrosinistra potrebbe optare per la scheda bianca alla quinta votazione.
L’indiscrezione mentre è ancora in corso il vertice tra il leader Pd Enrico
Letta, quello del M5s Giuseppe Conte e Leu Roberto Speranza. Si valutano anche
candidature alternative. In corso ancora le valutazioni.
Ore 09:55 – Il segretario
della Lega Matteo Salvini ha invitato tutti i leader della maggioranza a un
vertice prima del voto al via alle 11:00.
Diretta dalla
Camera: 4° giorno di votazione per l’elezione del Capo dello Stato.
Il Corriere del Giorno il 27 Gennaio 2022.
Oggi dopo una lunga
notte di trattative tra partiti, vertici e telefonate si è tornati in Aula alle
11,. Si prova a trovare un accordo ma in mattinata il leader leghista fa sapere:
“Non sarò io a proporre nomi di sinistra”. La maggioranza richiesta è quella
assoluta, pari a 505 voti su 1009 grandi elettori.
Da oggi è
sufficiente la maggioranza assoluta (505 voti) per eleggere il nuovo presidente
della Repubblica. Ma con ogni probabilità si rischia di replicare lo scenario
delle giornate precedenti. Il Pd che cerca di imporre le proprie decisioni senza
avere i voti necessari, ha già annunciato che voterà scheda bianca, e lo stesso
farà Italia viva. Quindi al momento in cui scriviamo prima che inizi la
votazione un accordo ancora non c’è. Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Enrico
Letta continuano a lavorare su una lista di nomi. Il segretario del Pd, invece,
punta sulla giornata di domani (venerdì 28 gennaio) per una intesa con il resto
della maggioranza al governo.
Tensione nei
rapporti anche nei rapporti tra Fdi, Forza Italia e Lega: ieri in Aula il
partito di Giorgia Meloni si è staccato e ha votato per il co-fondatore Guido
Crosetto, candidato di bandiera che ha preso 114 preferenze, cioè quasi il
doppio rispetto ai 63 Grandi elettori, risultato il secondo più votato
dopo Sergio Mattarella (125 voti).
Matteo Salvini,
prima di vedere il resto della coalizione di centrodestra, ha detto: “Gli altri
leader li sento tutti i giorni, è il mio lavoro. Porto proposte, abbiamo nomi di
assoluto livello, non penso che il centrodestra che rappresenta decine di
milioni di italiani debba dimostrare qualcosa e che solo a sinistra ci siano
profili morali e istituzionali. Prima si elegge” il capo dello Stato “meglio è.
Stiamo scegliendo la più alta carica dello Stato, dobbiamo fare una scelta che
renda orgogliosi gli italiani “. E sul nome di Pierferdinando Casini il
segretario del Carroccio lascia capire il totale dissenso del centrodestra:
“Proposto da sinistra, è stato eletto con il Pd“.
Da questo scrutinio
non serve più la maggioranza qualificata di 673 grandi elettori, da ora in poi
per eleggere l’inquilino del Colle è sufficiente la maggioranza assoluta della
metà più uno, cioè 505 preferenze.
LA GIORNATA IN
DIRETTA
ore 10:13 | Conte:
“Nessuno schieramento può pensare di eleggere Presidente suo“
“Siamo sempre
fiduciosi che da questo loro incontro si apra la possibilità di un dialogo più
serrato per arrivare a una soluzione“, dice il presidente del M5S, Giuseppe
Conte, a proposito del vertice del centrodestra sul Quirinale “Noi abbiamo fatto
delle proposte ufficialmente, abbiamo anche aperto a un confronto, perché nella
situazione in cui siamo nessuno schieramento precostituito, nessuna coalizione
può pensare di eleggere il presidente della Repubblica suo, di parte, che non
rappresenti tutti”. aggiunge Conte, parlando con i cronisti all’arrivo alla
Camera, a proposito della corsa al Quirinale.
ore 10:25 | Il
centrodestra ha deciso l’astensione
“Il centrodestra ha
deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore
istituzionale. Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare
veti e contrapposizioni – e convergere per dare all’Italia un nuovo Presidente
della Repubblica – la coalizione ha deciso di dichiarare il proprio voto di
astensione nel voto odierno. Il centrodestra è pronto a chiedere di procedere
domani con la doppia votazione“. E’ quanto si legge in una nota al termine del
vertice del centrodestra. Luigi Brugnaro, fondatore di Coraggio Italia, ha
dichiarato: “Oggi alla quarta votazione per il Colle il centrodestra non
presenterà scheda bianca, ci asteniamo…“.
ore 10:30 | Vertice
Pd-M5S-Leu alla Camera
Vertice in corso
alla Camera fra il segretario del Pd, Enrico Letta, il presidente del
M5S, Giuseppe Conte, e il leader di Leu, Roberto Speranza. Alla riunione
partecipano anche i capigruppo dei rispettivi partiti. All’ordine del giorno ci
sono le scelte sulla quarta votazione per l’elezione del Presidente della
Repubblica
I leader del
centrodestra torneranno a riunirsi stasera alle 19. Lo si apprende da fonti
della coalizione.
ore 10:45
| M5S-Pd-Leu: disponibili a confronto per la ricerca di un nome condiviso super
partes
“Coerentemente con
quanto chiesto e fatto nei giorni scorsi, riconfermiamo la nostra immediata
disponibilità ad un confronto per la ricerca di un nome condiviso super partes,
in grado di rappresentare tutti gli italiani. Nel frattempo in questa votazione
voteremo scheda bianca“. Così M5S, PD e LeU in una nota congiunta.
ore 10:50 | Nuovo
vertice del centrodestra stasera alle 19
ore 11:00 | Al via
il quarto scrutinio, maggioranza 505
È iniziata nell’Aula
della Camera la quarta votazione in seduta comune integrato dai delegati
regionali per l’elezione del presidente della Repubblica. La maggioranza
richiesta è quella assoluta, pari a 505 voti su 1009 grandi elettori. Il quorum
richiesto da questa votazione è quello della maggioranza assoluta dei componenti
del Collegio Al banco della presidenza ci sono i presidenti di Camera e
Senato Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati. Si inizia con la chiama dei
senatori a vita e dei cosiddetti ‘prevotanti’ per motivi di salute. Come nei
precedenti tre scrutuini, il primo a votare è Umberto Bossi.
ore 11:05 | Italia
Viva voterà scheda bianca
Italia viva voterà
scheda bianca al quarto scrutinio per l’elezione del presidente della
Repubblica. E’ quanto riferiscono fonti del partito.
ore 11:15 | Casini
scherza entrando alla Camera: “Vicini a mio nome? No vicini alla porta”
“Siamo più vicini al
mio nome? No siamo vicini alla porta“. Scherza Pier Ferdinando Casini con i
cronisti che lo assediavano arrivando alla Camera. Casini indossava una vistosa
sciarpa rossoblu “il Bologna è una fede…“, ha aggiunto.
ore 11:25 | Tajani,
sì incontro con progressisti ma no veti
Un incontro con il
fronte progressista? “Sì, ma basta che non ci siano veti”. Lo ha detto il
coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Sull’astensione
annunciata dal centrodestra, Tajani aggiunge: “Per far vedere che il
centrodestra c’è”.
ore 11:30 | Cresce
richiesta due voti, al momento no decisioni
Cresce la richiesta
da parte dei grandi elettori di procedere dal prossimo scrutinio con due
votazioni al giorno. Ma al momento, viene spiegato da fonti di Montecitorio, non
sono previste convocazioni della conferenza dei capigruppo e, quindi, non vi è
alcuna novità in merito. Intanto si sta svolgendo la quarta votazione. I primi
ad avanzare alla presidenza della Camera la richiesta di procedere con due
scrutini al giorno sono stati i grandi lettori di Italia Viva: già martedì,
giorno della seconda votazione, la capogruppo alla Camera Maria Elena Boschi
aveva posto la questione al presidente Fico, richiesta rinnovata ieri. Oggi si
aggiunge il centrodestra e anche Leu, come ha detto il ministro Roberto
Speranza, si dice d’accordo con due votazioni al giorno.
ore 11:40 | Salvini:
vorrei candidato buono, non di bandiera
“Sono fiducioso,
sono ottimista. L’astensione è per evitare scontri, non voglio un candidato di
bandiera, vorrei un candidato o una candidata buona”. Lo ha detto Matteo
Salvini ai giornalisti presenti alla Camera. L’astensione è un modo per
contarsi? “Le prove di forza non ci interessano” ha
aggiunto Salvini interpellato dai cronisti alla Camera. “Noi le proposte le
abbiamo fatte. Speriamo di arrivare a un nome il prima possibile. La doppia
votazione di domani? Chiediamo di accelerare”.
ore 12:05 | Meloni
irritata: voleva che il centrodestra si misurarre in Aula
Molto irritata per
l’esito del vertice di centrodestra. Così è descritta Giorgia Meloni dai suoi.
La presidente di Fratelli d’Italia ha dato il via libera all’astensione nella
quarta votazione per il presidente della Repubblica per non spaccare la
coalizione. Ma non era assolutamente d’accordo, viene spiegato. “Abbiamo
insistito per votare un nostro candidato”, viene riferito. “Il centrodestra, per
noi, ieri come oggi, doveva misurarsi con l’Aula. Anche perchè, su Elisabetta
Casellati, per noi, i 50 voti in più, quelli che servono a raggiungere la
maggioranza, c’erano eccome”. “Gli alleati invece non hanno voluto contarsi“, si
aggiunge. “Non hanno voluto votare. Viene quasi il sospetto che non siano capaci
di tenere i voti“
ore 12:10 | Ora
votano i deputati
Si è conclusa
nell’Aula della Camera la votazione dei senatori per l’elezione del presidente
della Repubblica. Ora votano i deputati.
ore 12:15 | Salvini
ai suoi, su Draghi noi manteniamo posizione
Noi manteniamo la
parola data, su Draghi abbiamo spiegato ai cittadini che deve rimanere a palazzo
Chigi. Fonti parlamentari della Lega riferiscono che nella riunione con i
dirigenti del partito Matteo Salvini sia stato netto. Il suo sospetto – viene
riferito – è che anche altri nel centrodestra possano cambiare linea e virare
su Draghi. Salvini comunque ribadisce ai fedelissimi che sta lavorando ad
un’alternativa.
ore 12:40 | Renzi:
astensione centrodestra? Lo trovo scandaloso
“Davanti a questa
situazione di difficoltà trovo irresponsabile questo atteggiamento del
centrodestra di non partecipare al voto. È un atteggiamento non all’altezza
delle istituzioni, profondamente ingiusto verso i cittadini. Indipendentemente
dai nomi, trovo scandaloso che oggi il centrodestra abbia fallito l’esame di
maturità che aveva. Mancano poche ore, speriamo che per domani si recuperi
saggezza, è finito il tempo delle bambinate. Questo gioco dei nomi è
insopportabile“. Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi, parlando ai
cronisti davanti Montecitorio.
ore 12:45 | Salvini:
“Di sicuro sento Letta, non so se riusciremo a vederci“
Ci sarà un incontro
oggi con Enrico Letta e gli altri leader? “Sicuramente con Letta ci sentiremo,
non so se riusciremo a vederci…”, risponde Matteo Salvini avvicinato in
Transatlantico, a Montecitorio.
ore 14:25 | Iniziato
lo spoglio delle schede
È terminato il
quarto scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. Vengono quindi
aggiunte le schede dei grandi elettori positivi o in quarantena che hanno votato
nel seggio speciale allestito nel parcheggio esterno di Montecitorio. Il
presidente Roberto Fico ha iniziato ora allo spoglio delle schede. La
maggioranza richiesta è quella assoluta, pari a 505 voti.
ore 14:55
| Coraggio Italia: “Belloni? No a due tecnici al vertice“
“Nessun problema sul
profilo, ma è difficile spiegare come si possa accettare che i vertici delle
istituzioni siano ricoperti da due tecnici a capo della presidenza della
Repubblica e di Palazzo Chigi. E sarebbe ancora più incomprensibile che questa
proposta venga da chi aveva già problemi a spostare un tecnico da un posto
all’altro“. Lo dicono all’Ansa fonti di Coraggio Italia, commentando l’ipotesi
di una candidatura alla presidenza della Repubblica dell’
ambasciatore Elisabetta Belloni, attualmente al vertice del Dis (i servizi
segreti italiani) .
ore 14:55 | Tra i
candidati Altobelli, Veltroni e Taverna
Sono per la maggior
parte schede bianche, poi i voti per Sergio Mattarella (oltre 160 per ora) ed
oltre 50 per il magistrato Nino Di Matteo, candidato di Alternativa. Ma spuntano
voti anche per l’ex attaccante dell’Inter Alessandro Altobelli, per l’ex
segretario del Pd Walter Veltroni e per il ministro leghista Giancarlo
Giorgetti. Preferenze anche per Pierluigi Bersani, per Mario Segni, Pierluigi
Castagnetti. Rispetto ai precedenti tre scrutini, il numero dei voti dati a
personalità che sono al di fuori del mondo della politica e delle istituzioni,
al momento, risulta essere molto inferiore.
ore 14:58
| Verso nuova fumata nera, i più votati Mattarella e Di Matteo
Nello spoglio della
quarta votazione per il presidente della Repubblica, l’attuale capo dello
Stato, Sergio Mattarella ottiene 166 preferenze quando sono stati scrutinati
circa 405 voti su 1.009. Segue, a 56 voti, il magistrato Nino Di Matteo. Al
momento le schede bianche sono 261. Astenuti 433.
ore 15:05 | Finito
lo spoglio delle schede: Mattarella 166 voti, Di Matteo 56, Casini 3
Aumentano i voti per
il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quarto scrutinio per
l’elezione del suo successore, che passa dai 125 di ieri ai 166 di oggi. 56 le
preferenze per il pm Nino Di Matteo, indicato dai parlamentari ex M5S de
l’Alternativa al posto di Paolo Maddalena. Pierferdinando Casini, che ieri aveva
raccolto 52 voti, oggi, con i delegati del centrodestra che si sono astenuti, si
ferma a 3. Due altri papabili per il Quirinale indicati nelle ultime ore, vale a
dire Elisabetta Belloni e Sabino Cassese, ottengono, rispettivamente, due voti e
uno.
La candidatura per il
Colle. Mi sono candidato al Quirinale per dare un po’ di colore nella
mediocrità.
Fulvio Abbate su Il Riformista il 27 Gennaio 2022.
Può uno scrittore, sia pure in
nome del paradosso, avanzare il proprio nome per il Quirinale? E soprattutto con
parole d’ordine (o disordine) non meno paradossali, quali “Contro ogni
ambizione” e “La forza dell’irrilevanza”. Può, poiché siamo in democrazia, e
forse non sarebbe cosa ingiusta credere nell’immaginazione, soprattutto
riflettendo sul vuoto di pensiero che governa il “Palazzo”. Della politica, e
forse anche di chi la osserva con assenza di estro, di proposte, almeno ai suoi
occhi, convincenti esattamente dalla prospettiva proprio della fantasia,
dell’immaginazione, che poi sono categorie che dovrebbero affiancare i diritti
essenziali di cittadinanza.
Lo scrittore, meglio, in
questo momento esatto, prova nostalgia per il tempo nel quale era possibile
accostarsi agli elettori, (era il caso dei socialisti francesi nei giorni di
Mitterrand) con parole rubate a un poeta, Arthur Rimbaud: “Changer la vie”:
cambiare la vita. Lo spettacolo che la politica italiana sta consegnando ai suoi
spettatori, assodato che non ci sono problemi poiché non ci sono soluzioni,
appare almeno ai miei occhi, sia detto con un’immagine letteraria, sotto il
regno di Saturno, il dio della malinconia. Il candidato della destra in blazer o
tailleur non meno insignificante, al momento, ha il volto di una signora
“cattolica e conservatrice”, un’antiabortista che vorrebbe riaprire le case di
tolleranza, già cooptata da Berlusconi, una proposta irricevibile per chi
volesse, appunto, se non proprio mutare l’esistente, continuare a credere nei
valori minimi di laicità.
Lo scrittore non immagina
“l’assalto al cielo”, nel nostro caso basterebbe prendere atto della miseria
della politica indicando una semplice prospettiva progressista, libertaria:
case, scuole, ospedali (pubblici), diritti civili, tolleranza, rifiuto del
populismo razzista. Ho appena dimenticato di dire che la sinistra, meglio, il
suo fantasma, nella situazione data, mostra uno stato di auto-narcosi, assenza
di se stessa. Può uno scrittore dare risposte in questo senso? Probabilmente no,
gli rimane, forse, la semplice necessità di indicare il vuoto di un pensiero che
muova dalle aste della democrazia. Sarebbe insomma cosa giusta che le cosiddette
voci libere, ossia coloro che, sia detto un paradosso, scelgono d’essere
mediocri in proprio e non per conto terzi, mostrino un minuscolo segno di
discontinuità umana. Ancora una volta lo scrittore è costretto a rimpiangere il
coraggio di Pier Paolo Pasolini, che oggi compirebbe 100 anni.
La mia improbabile scelta di
candidarmi al Quirinale, nel suo paradosso esplicito, pretende d’essere dunque
una scelta “politica”, posto che non vi è neppure certezza che alcuni dei volti
che attualmente aspirano al Colle vogliano dare prova di antifascismo in un
Paese che vede nella tentazione autoritaria e nella semplificazione da sempre un
bene rifugio subculturale. Ho già detto che non ci sono problemi poiché non
esistono soluzioni, e forse, sempre lo scrittore già citato, si trova
altrettanto costretto a ravvisare in Mario Draghi il miglior amministratore di
condominio possibile per le pratiche correnti della sussistenza economica
nazionale. Il mio amico Paolo Cirino Pomicino giustamente parla di una politica
che ha abdicato a figure esterne il proprio mandato. Il vuoto assoluto di
fantasia che governa il nostro quotidiano ai miei occhi appare altrettanto
spettrale.
A chi ha ironizzato sui voti
ricevuti finora da Fulvio Abbate, accostandoli alle preferenze accordate
agli Amadeus e ad altre figure del teatro spettacolare, rispondo che hanno
ragione, non possiedo la stessa “rispettabilità” di quest’ultimi, e tuttavia,
sia pure nel paradosso, questa mia presenza avventurosa nella corsa
per Quirinale credo serva a mostrare che sebbene sia impossibile cambiare la
vita, si può almeno provare a renderla un po’ meno mediocre, restituirle i
colori.
Fulvio Abbate è nato nel 1956
e vive a Roma. Scrittore, tra i suoi romanzi “Zero maggio a Palermo” (1990),
“Oggi è un secolo” (1992), “Dopo l’estate” (1995), “La peste bis” (1997),
“Teledurruti” (2002), “Quando è la rivoluzione” (2008), “Intanto anche dicembre
è passato” (2013), "La peste nuova" (2020). E ancora, tra l'altro, ha
pubblicato, “Il ministro anarchico” (2004), “Sul conformismo di sinistra”
(2005), “Pasolini raccontato a tutti” (2014), “Roma vista controvento” (2015),
“LOve. Discorso generale sull'amore” (2018), "I promessi sposini" (2019). Nel
2013 ha ricevuto il Premio della satira politica di Forte dei Marmi. Teledurruti
è il suo canale su YouTube.
Le elezioni presidenziali.
Quirinale, i partiti sono interessati solo alla propria bottega.
Renato Mannheimer,
Pasquale Pasquino su Il Riformista il 26 Gennaio 2022.
Il Presidente della
Repubblica è scelto in Italia dal Parlamento, cioè dagli esponenti dei partiti
politici che grazie alle elezioni popolari lo compongono. La nomina del
successore di Sergio Mattarella ha seguito fino a questo momento una prassi
diversa, considerando il fatto che ci troviamo di fronte ad una assemblea priva
di una maggioranza e anche di una forza egemone. I partiti che compongono il
governo di unità nazionale, voluto da Mattarella e accettato dalle forze
politiche che lo compongono in virtù di un voto di fiducia ottenuto da Mario
Draghi, non sono stati in grado di preparare la nomina del Presidente della
Repubblica attraverso un accordo fra di loro. Sono invece giunti quasi alla meta
del 24 gennaio solo con una autocandidatura di Silvio Berlusconi, che l’ha
ritirata poco prima dell’inizio delle votazioni dei grandi elettori. Si è dunque
arrivati alla prima chiamata senza che fosse emerso un possibile nome comune.
A questo punto, il leader
della Lega ha provato una strada singolare per sciogliere il nodo e intestarsene
il merito. È andato a vedere, piuttosto che i leader degli altri partiti della
maggioranza, Mario Draghi, del cui possibile trasferimento da Palazzo Chigi al
Palazzo del Quirinale si è molto sentito parlare da diverse settimane,
soprattutto dopo la conferenza di fine anno del primo ministro. Non conosciamo
il contenuto dell’incontro. Ma non è difficile pensare che Salvini abbia provato
a discutere con Draghi il problema che sorgerebbe se costui lasciasse il posto
di capo del governo. Questa è però una questione che Salvini ed i partiti
dovrebbero discutere eventualmente con il successore di Mattarella e non con il
primo ministro in carica o in ogni caso con lui una volta che fosse eletto capo
dello stato. Questa sarebbe la procedura richiesta da una corretta lettura della
pratica costituzionale.
Non c’è da sorprendersi del
fatto che il colloquio non abbia sciolto il nodo. E ora i partiti e i loro
leader devono trovare un’altra strada per giungere alla elezione del presidente
della Repubblica. O trovano un accordo su un nome che non sia quello
dell’attuale capo del governo. Oppure sceglieranno Draghi e discuteranno con lui
della struttura del nuovo governo – dopo la sua elezione. La prima ipotesi non è
di facilissima realizzazione. Un nome di parte non ha serie chances di essere
accettato anche dalla sola maggioranza assoluta, che dalla quarta votazione in
poi diverrà dirimente. Un nome super partes, come si dice, vorrebbe dire,
probabilmente, affidare a due estranei al mondo della politica di professione i
vertici dello stato. Un sacrificio che i partiti non sembrano particolarmente
volenterosi di accettare. Per il momento la situazione è di stallo e intanto la
politica intesa come interesse della polis – la comunità dei cittadini –
scompare e la politica, come interesse di parti che guardano alle elezioni, si
impone senza peraltro riuscire a sciogliere il nodo.
Questo è, infatti, il volto
della politica come ci appare in questi giorni. È vero, c’è da eleggere
il Presidente della Repubblica, ed è comprensibile che il dibattito dei
partiti si concentri su questo o quel nome. Ma qual è la motivazione principale
di queste indicazioni? Difendere l’interesse della propria parte, sistemare uno
dei “propri”. Al di là delle parole su una figura di “alto profilo”, che pensi
“all’interesse del paese”, ognuno ha a cuore la propria bottega. Ciò accade
anche quando si parla di Governo, nel caso si debba
sostituire Draghi, eventualmente chiamato al Quirinale. A qualcuno è venuto in
mente di parlare di programmi, di cose da fare, di miglioramenti nell’azione
dell’esecutivo? No, tutta l’attenzione è su chi inserire dentro quest’ultimo.
Ma, una volta sistemata la pratica Quirinale, si tratterà, in un modo o
nell’altro, di andare avanti. E allora sarà dura per partiti come questi. Renato
Mannheimer, Pasquale Pasquino
Calma ragazzi. Perché mai
per eleggere il Capo dello Stato dovrebbe volerci meno che a decidere il
vincitore di Sanremo?
Francesco Cundari su L'Inkiesta il 26 Gennaio 2022.
Dal 1948 a oggi, su dodici
elezioni, solo due volte il presidente della Repubblica è stato eletto prima del
quarto scrutinio. E non siamo ancora arrivati al terzo (che comincia oggi).
Sono passati appena due giorni
dall’inizio delle votazioni per il presidente della Repubblica e già da un
giorno e mezzo autorevoli commentatori, illustri politologi, celebrità della
televisione, del teatro e di twitter lamentano l’indegno spettacolo offerto
dalle trattative e dalle schede bianche, strappandosi i capelli perché il
parlamento non ha ancora eletto il capo dello Stato. Gente che ci mette venti
minuti per ordinare una pizza, venti ore per fare una riunione di condominio
(nella migliore delle ipotesi, cioè quando non finisce in tribunale), sei mesi
per decidere dove andare in vacanza con la moglie, trova scandaloso che i mille
grandi elettori non abbiano già trovato l’accordo sulla prima carica dello
stato. Ma perché? Ma quando si è stabilito che per scegliere il capo dello stato
ci debba volere meno che a decidere il vincitore di Sanremo?
È una tendenza relativamente
recente, i cui primi segnali si sono visti nel 2013, la prima elezione
presidenziale ai tempi dei social network. È evidentemente anche una tendenza
figlia della società del tempo reale. Ma fare i conti con la modernità e con il
modo in cui nuove tecnologie e nuove abitudini ci hanno insegnato a scandire il
tempo, a riconsiderare certi ritmi e certi rituali, non significa
necessariamente che si debba comprimere anche la più delicata e solenne scelta
istituzionale nei tempi di un video su TikTok. Abbiamo già avuto le
pseudo-consultazioni in streaming, giusto nel 2013, e abbiamo visto com’è
finita.
È una tendenza che i politici
dovrebbero contrastare, invece di cavalcare, illudendosi come al solito di poter
indirizzare la cagnara contro gli altri e salvare se stessi. Un esempio a
caso? Enrico Letta, ieri sera: «Noi crediamo che dobbiamo rinchiuderci in una
stanza, pane e acqua, e buttare via la chiave finché non si trova la soluzione,
perché il paese credo non possa aspettare giorni e settimane di voti e schede
bianche». Testuale: pane e acqua, e buttare via la chiave. L’immagine
dell’autodafé della politica non potrebbe essere più efficace. Ma forse è solo
il frutto di troppe riunioni con i cinquestelle.
Intendiamoci, nessuno nega che
oggi, probabilmente, le ventuno votazioni consecutive che servirono per eleggere
Giuseppe Saragat e le ventitré che si resero necessarie per eleggere Giovanni
Leone non sarebbero sostenibili. Sta di fatto che dal 1948 a oggi, su dodici
elezioni, solo due volte il presidente è stato eletto prima della quarta
votazione (Francesco Cossiga nel 1985 e Carlo Azeglio Ciampi nel 1999, entrambi
alla prima, escludendo per ovvie ragioni Enrico De Nicola, eletto dall’Assemblea
costituente nel 1946). Dieci volte su dodici, negli ultimi settantacinque anni,
il presidente della Repubblica è stato eletto dalla quarta in poi. E noi non
siamo ancora alla terza (che comincia oggi).
Tra i mille paralogismi che si
sentono in queste ore va particolarmente forte l’invettiva contro i partiti «che
hanno avuto sette anni per mettersi d’accordo» e si sono ridotti all’ultimo,
come se si trattasse di compiti per le vacanze. E mai nessuno che chieda
all’indignato di turno che cosa avrebbe fatto al posto non già di «tutte le
forze politiche», che è facile, ma è anche una condizione che non si dà in
natura, bensì al posto di uno qualunque dei leader di partito realmente
esistenti, per risolvere il problema per tempo. Fermo restando che se il
presidente fosse eletto oggi, ripetiamolo in coro, sarebbe la terza elezione più
rapida di sempre.
Ci sono poi quelli che trovano
incresciosi i nomi a casaccio scritti sulle schede, nelle votazioni in cui la
stragrande maggioranza dei grandi elettori ha deciso comunque di votare scheda
bianca. Come se il problema fosse la scheda con su scritto «Amadeus», che non ha
alcun effetto concreto, e non le schede che hanno portato in parlamento,
davvero, rappresentanti del popolo come Sara Cunial, infaticabile attivista no
vax. Eletta con il Movimento 5 stelle, con il voto e con il sostegno di buona
parte di quelli che oggi s’indignano per l’oltraggio alle istituzioni
rappresentato dal fatto che una scheda bianca non è stata lasciata bianca (cioè
senza alcun nome scritto sopra, come precisava prudentemente l’indicazione di
voto dei vertici cinquestelle ai propri parlamentari).
V GIORNO DI VOTAZIONI
Diretta dalla Camera: 5°
giorno di votazione per l’elezione del Capo dello Stato.
Il Corriere del Giorno il 28 Gennaio 2022.
Quirinale, il centrodestra ha
scelto: giocherà la carta Casellati. Dal Pd: “Con lei si va al voto”. Il nome
proposto da Salvini per la quinta votazione. La replica dei renziani: “Noi non
la voteremo”. Vertice di centrosinistra con Letta, Conte e Speranza.
Il centrodestra ha votato
inutilmente Elisabetta Casellati nella votazione di oggi per l’elezione del
Presidente della Repubblica. La Casellati non ha superato il quorum (pari a 505
voti) e si è fermata a 382 preferenze, ben al di sotto dei numeri dei grandi
elettori del centrodestra (453) e comunque meno di 400, la soglia fissata dalla
coalizione per riproporla nella seconda votazione del pomeriggio. Il flop scuote
il centrodestra e apre la caccia al franco tiratore: Lega e Fdi assicurano di
aver votato compatti la presidente del Senato. Nel mirino finisce Forza
Italia. All’appello, infatti, mancano 71 voti della coalizione.
È il momento che si
“verifichino i numeri in aula e si ponga fine a questa cosa incomprensibile del
non voto e delle schede bianche – ha detto Giorgia Meloni al termine del vertice
– Il centrodestra dia una prova di compattezza. L’avessimo fatto prima la
situazione sarebbe già sbloccata ma sono contenta si sia arrivati a questa
decisione”. La leader di Fdi ha sottolineato che quella su Elisabetta Casellati,
“donna e presidente del Senato” è un’apertura “su una candidatura meno
politicizzata e più istituzionale. I veti sarebbero incomprensibili”.
“L’indicazione di voto per
oggi è Elisabetta Alberti Casellati”. Era il contenuto dell’sms arrivato ai
parlamentari del centrodestra per la quinta votazione del Colle.
“Oggi il centrodestra unito
voterà per Elisabetta Casellati, Presidente del Senato e seconda carica dello
Stato. Una donna ma soprattutto una figura istituzionale di alto profilo”, ha
scritto su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza
Italia. “Vediamo cosa ne pensa il Parlamento, Casellati sa che potrebbero non
esserci i voti, come capita in democrazia”, ha osservato Giovanni Toti, al
termine del vertice del centrodestra. “Andare con Casellati, che è la seconda
carica dello Stato, non è una cosa eversiva”, ha aggiunto il governatore della
Liguria.
CENTROSINISTRA. Assemblea
lampo dei grandi elettori M5S alla Camera. “State in attesa che potrebbero
arrivare messaggi anche all’ultimo”, si è limitato a dire ai parlamentari il
capogruppo a Montecitorio Davide Crippa. Per ora, quindi, nessuna indicazione di
voto: si attende l’esito del confronto tra i leader di M5S, Pd e Leu, ancora in
corso. Scheda bianca o candidatura alternativa. Queste al momento, secondo
alcune fonti del centrosinistra, le opzioni su cui stanno ragionando Letta,
Conte e Speranza. Non è escluso che prima del voto in Aula l’assemblea possa
ri-aggiornarsi.
“Mi sto chiedendo sinceramente
se ho fatto bene a fidarmi, siamo stati portati in giro per tre giorni”. Lo ha
detto Enrico Letta, arrivando alla Camera per il vertice tra Pd, M5S e Leu sulle
elezioni per il Colle, riferendosi al centrodestra e al nodo Quirinale. “Abbiamo
sempre lavorato per l’unità, l’impressione è che abbiano tentato di dividerci
con idee fantasiose con l’obiettivo di dividere, non di fare l’interesse del
Paese” ha aggiunto il segretario dem . “Chiederemo a Fico di aumentare e
arrivare almeno a due votazioni al giorno” ha detto Letta.
la diretta video delle
votazioni in tempo reale alla Camera dei Deputati
Alla quinta votazione 46
preferenze sono andate al capo dello Stato, Sergio Mattarella; 38 al pm Nino Di
Matteo, ora componente del Csm; 8 a Silvio Berlusconi, 7 alla ministra della
Giustizia, Marta Cartabia, e al coordinatore di Forza Italia, Antonio
Tajani; 6 a Pier Ferdinando Casini. Le schede bianche sono state 11, le nulle 9,
come i voti dispersi. Presenti 936, votanti 530, astenuti 406.
Alla Casellati sono dunque mancati 71 voti rispetto ai 453 grandi elettori del
centrodestra.
LA GIORNATA IN DIRETTA
ore 10:25 | Eletti Movimento
5S chiedono oggi di astenersi in Aula
Molti eletti 5 Stelle, in
questi minuti, stanno chiedendo ai vertici del Movimento di appoggiare la linea
dell’astensione oggi in Aula, nella quinta votazione per l’elezione del Capo
dello Stato.
ore 10:30 | Italia Viva
orientata a non partecipare al voto
Italia viva è orientata a
non partecipare al quinto voto sulla presidenza della Repubblica. Lo riferiscono
fonti parlamentari del partito.
Matteo Salvini e Matteo
Renzi si sono incontrati per circa dieci minuti a Palazzo Montecitorio.
ore 10:45 | Da domani due
votazioni: alle 9.30 e 16.30.
Da domani, in caso di fumata
nera nelle due votazioni in programma oggi, previste due votazioni giornaliere
alle 9.30 e alle 16.30. È quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo
congiunta a Montecitorio.
ore 10:45 | Da oggi doppia
votazione: alle 11 e alle 17
Da oggi doppia chiama a
Montecitorio per eleggere il presente della Repubblica. La seconda si terrà alle
17:00. Lo hanno deciso i capigruppo
ore 10:45 | Sospesa assemblea
grandi elettori Pd
L’assemblea dei grandi
elettori Pd è stata sospesa. Verrà aggiornata in base all’evolversi delle
discussioni sull’elezione del presidente della Repubblica. È quanto si apprende
da fonti Pd. A comunicare la decisione ai grandi elettori è stata la capogruppo
alla Camera, Debora Serracchiani.
ore 10:49 | Incontro
Salvini-Renzi alla Camera
ore 11:05 | Al via quinto
scrutinio, maggioranza richiesta 505
E’ iniziato nell’Aula della
Camera il quinto scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. La
maggioranza richiesta è quella assoluta, pari a 505 voti.
ore 11:10 | Senatori
Pd-M5S non rispondono alla prima chiama
Secondo quanto si apprende da
fonti parlamentari, Pd-M5sd e Leu parteciperanno solo alla seconda chiama
ore 11:15 | Casellati torna in
Aula durante la votazione
Il presidente del
Senato, Elisabetta Casellati, è tornata in Aula accanto al presidente della
Camera, Roberto Fico, mentre è in corso il quinto scrutinio per l’elezione del
Presidente della Repubblica.
ore 11:17 | Lega: non votare
Casellati è sgarbo a istituzioni
“Sergio Mattarella ha escluso
più volte l’ipotesi di un bis: con senso di responsabilità, il centrodestra
offre al Parlamento il nome della seconda carica dello Stato che peraltro –
essendo una donna – rappresenterebbe una svolta storica per il Paese. Se alcuni
partiti non partecipassero nemmeno al voto, non farebbero uno sgarbo al
centrodestra ma alle istituzioni”. Così fonti della Lega.
“Il Centrodestra ha trovato
l’accordo per il voto di questa mattina, su Elisabetta Casellati che da
Presidente del Senato, Seconda Carica dello Stato, diventerebbe Prima Carica
dello Stato. Io conosco Elisabetta Casellati da oltre 30 anni e posso garantire
sulla sua assoluta adeguatezza a questo eventuale nuovo ruolo super partes. Per
tale motivo mi rivolgo ai Parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere
loro di sostenere la Casellati”. Lo scrive Silvio Berlusconi. “Dobbiamo
assolutamente porre fine all’attuale spettacolo indecoroso che la politica sta
dando di sè agli italiani e che l’opinione pubblica non riesce più a capire e a
tollerare. Ringrazio di cuore tutti i Parlamentari che daranno seguito a questo
mio appello e mi auguro che finalmente il Parlamento possa dare un segnale di
responsabilità e di adeguatezza al ruolo che la Costituzione gli assegna. Lo
spero davvero“, conclude.
ore 11:31 | Pd si asterrà
alla seconda chiama
“Dovete andare e dire ‘mi
astengo’, senza prendere la scheda. Mi raccomando”. È L’indicazione di Simona
Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, ai senatori del partito prima della
seconda chiama.
ore 11:20 | Berlusconi: tutti
gli schieramenti sostengano Casellati
ore 11:36 | Meloni: tutti
parlano di donne, il centrodestra le candida
“Votiamo Casellati, è
l’indicazione del centrodestra, una candidatura istituzionale, seconda carica
dello Stato e donna. Tutti parlano delle donne ma poi le uniche donne ai vertici
le candida il centrodestra. E’ secondo noi anche un’apertura all’altra metà
campo che speriamo altri vogliano cogliere. Vogliamo decidere, perché questo
spettacolo è fastidioso per gli italiani”. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia
Meloni, parlando coi giornalisti a Montecitorio. “L’obiettivo non è spaccare il
campo del centrosinistra. Io vorrei una candidatura che venisse votata da tutti.
Mi pare che questo problema di compattezza, nel centrosinistra, ci sia“
ore 11:42
| Letta-Conte-Speranza: grave errore candidare Casellati
“Il centrodestra continua a
gestire irresponsabilmente il più importante passaggio democratico e
costituzionale, rappresentato dall’elezione del presidente della Repubblica.
Consideriamo la unilaterale candidatura della seconda carica dello Stato,
peraltro annunciato un’ora dalla quinta votazione, un grave errore“. Lo
dicono Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte in un comunicato
congiunto al termine del vertice che si è tenuto questa mattina.
ore 12:00 | Centristi verso
Casini o Draghi a sesto voto
Fonti centriste riferiscono
che, fra le opzioni in campo, si starebbe valutando seriamente l’ipotesi di
votare Pier Ferdinando Casini o Mario Draghi alla sesta votazione in programma
nel pomeriggio.
ore 12:05 | I leader di
centrosinistra disertano il vertice proposto da Salvini
I leader del fronte di
centrosinistra, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza hanno scelto di
disertare l’incontro che Matteo Salvini aveva proposto alla maggioranza alle 11
di stamattina. Le motivazioni, sottolineano fonti dem, sono state illustrate
nella nota congiunta di fine incontro, ma i tre leader hanno deciso intanto di
restare insieme al gruppo Pd della Camera per fare il punto su strategie e mosse
comuni.
ore 12:14 | Conclusa chiama
senatori, ora tocca ai deputati
Conclusa la chiama dei
senatori per il quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica.
Ora è la volta dei deputati.
ore 12:27 | Salvini, con
Casellati proposto il massimo dopo Mattarella
“Abbiamo fatto una proposta,
la massima possibile dopo Mattarella, che ha più volte ripetuto che non sarà
disponibile. Un gradino subito sotto c’è la seconda carica dello Stato. Ricordo
che ottenne il 75 per cento dei voti dei senatori” così il segretario
leghista Matteo Salvini che ha aggiunto “E’ una donna che ha anche frequentato
le aule del Csm. Non è una candidata di bandiera o divisiva, ha unito il 75 per
cento dei senatori che l’hanno eletta: più unitaria di così“
ore 12:38 | Salvini, fatto
nuova proposta incontro a centrosinistra
“Speriamo che non sia la
giornata della diserzione. Proporrò di incontrarci anche tra il primo e il
secondo voto”. Così il segretario leghista Matteo Salvini parlando della
proposta di incontro con gli alleati di governo di centrosinistra. “Chiedo alla
sinistra di trovare un accordo entro oggi pomeriggio. La sinistra che in passato
provo con Nilde Iotti, Emma Bonino, Anna Finocchiaro: può scegliere una donna”.
ore 12:48 | Conte: non
partecipiamo a atti forza. Ci asteniamo
“Non partecipiamo ad atti di
forza e per questo abbiamo deciso di astenerci. Non è possibile candidare la
seconda carica dello Stato senza condivisione“. Lo ha detto il leader di
M5s Giuseppe Conte, uscendo da palazzo Montecitorio.
ore 12:50 | Convocato un
nuovo vertice centrodestra
“Noi nel centrodestra ci
ritroviamo alle 14.30, vediamo l’esito del voto e vediamo come proseguire“,
annuncia il leader della Lega.
ore 13:14 | Salvini: ho il
dubbio che Conte o Letta vogliano far saltare il governo
“Mi pare che
siano Letta e Conte, o parte del Pd e dei 5 stelle, a dire dei ‘no‘ per far
saltare il governo. Mi viene il dubbio che a sinistra ci sia qualcuno che vuol
far saltare il tavolo, altrimenti non mi spiego questa sequela di no. Vogliono
far saltare i nervi a Draghi e far saltare il governo”. Così il segretario
leghista Matteo Salvini.
ore 14:24 | Terminato il
quinto scrutinio, al via lo spoglio
E’ terminato il quinto
scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. Ha ora inizio lo
spoglio. La maggioranza richiesta è di 505 voti. I votanti nel seggio speciale
allestito nel parcheggio esterno di Montecitorio per il voto dei grandi elettori
positivi o in quarantena sono stati in tutto 11.
ore 14:28 | Centrodestra
valuta Casellati alla sesta votazione se supera i 400 voti
Il centrodestra aspetta lo
spoglio della quinta votazione per decidere se votare Elisabetta Casellati anche
nella sesta, prevista per oggi alle 17. “Se supera i 400 voti – spiegano fonti
della coalizione – la rivotiamo alle 17, altrimenti no”.
ore 14:40 | Casellati al
fianco di Fico durante lo spoglio delle schede
E’ in corso nell’Aula della
Camera lo spoglio delle schede del quinto scrutinio per l’elezione del Capo
dello Stato. Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, candidata dal
centrodestra, segue la procedura al banco della presidenza, alla destra del
presidente della Camera, Roberto Fico. Il Partito democratico, pochi minuti
prima dell’inizio dello spoglio, aveva invitato Casellati ad astenersi.
ore 14:53 | Casellati non
supera la ‘soglia’ dei 400 voti
A spoglio del quinto scrutinio
terminato, i voti a favore di Elisabetta Casellati non superano la ‘soglia’ di
400 voti, ritenuta la soglia minima da fonti del centrodestra ad avvio
votazione. Grande soddisfazione di Anna Maria Bernini, la storica rivale interna
a Forza Italia.
ore 15:08 | 382 Casellati,
mancano all’appello 71 voti del centrodestra
I voti ottenuti da Elisabetta
Casellati, nel quinto scrutinio, sono 382. Il centrodestra ha 453 grandi
elettori. Dunque, a spoglio concluso, mancano all’appello 71 voti. Sulla carta
il centrodestra, considerato nel suo insieme, ovvero Lega, Forza Italia,
Fratelli d’Italia e partiti del centro, conta 453 grandi elettori. ieri il
centrodestra, in occasione del quarto scrutinio, si è astenuto: al termine della
votazione le astensioni sono state 441, ma va considerato che due grandi
elettori (Sgarbi e Vito) non si sono astenuti e hanno votato scheda bianca.
Dunque, i calcoli di ieri davano tra i 12 e i 14 voti mancanti all’appello. Oggi
il numero sale: mancano all’appello almeno 65 voti, considerate le assenze
giustificate e quelle fisiologiche, come spiegano fonti di centrodestra. Ad
esempio, la Lega fa sapere che dei suoi 212 grandi elettori, i 208 presenti
hanno votato tutti per Casellati.
ore 15:21 | La Russa: franchi
tiratori? Non in FdI e Lega
Dove sono i franchi tiratori
di Elisabetta Casellati ? “Scegliete voi. Non in Fratelli d’Italia e credo
nemmeno nella Lega”. Ignazio La Russa, vice presidente del Senato ed esponetene
di FdI, commenta così con i cronisti a Montecitorio l’esito del quinto scrutinio
per l’elezione del Presidente della Repubblica. “Ora dobbiamo prendere atto
della realtà. I voti che ha espresso il centrodestra sul nome autorevole del
presidente del Senato sono inferiori ai propri numeri. C’è qualcuno che se ne
frega dei valori del centrodestra e pensa ad altre cose”. “Ora dovremo vedere
insieme agli altri cosa fare. Candidare Casellati non è stato un errore –
conclude La Russa – avevamo il dovere verso gli elettori e verso noi stessi di
provare a verificare quanti voti avevamo”.
ore 15:25 | Tensione nel
centrodestra, andare ‘oltre’ Casellati
Il centrodestra pronto a
‘mollare’ la pista Casellati, dopo il risultato raggiunto al quinto scrutinio
sull’elezione del presidente della Repubblica. Accuse incrociate tra gli alleati
della coalizione. “I 208 voti della Lega sono andati compatti alla presidente
Casellati”, spiegano fonti del partito di via Bellerio. Fratelli d’Italia fa
sapere di aver votato compatta per la seconda carica dello Stato. Nel
mirino Forza Italia. Fonti parlamentari del centrodestra sottolineano che con
questi numeri in campo la ‘pista’ Casellati sarà abbandonata.
ore 15:30 | Brugnaro: “Dopo
Casellati non resta che Draghi“
“Dopo Casellati non resta
che Mario Draghi“, dichiara Luigi Brugnaro, leader di Coraggio Italia.
ore 15:43 | In corso vertice
centrodestra
È iniziato il vertice di
centrodestra convocato dopo l’esito della quinta votazione per l’elezione del
presidente della Repubblica.
ore 15:45 | Si torna ai
blocchi di partenza
Quattro ipotesi:
un mister X (o madame) che ancora non si intravede all’orizzonte; Casini minimo
comune denominatore; accordo su Draghi e nuovo premier; appello
a Mattarella. Salvini non ci sta capendo più nulla; Letta e Conte non possono
continuare a dire solo no. In realtà, la soluzione naturale (cioè Mario Draghi )
è molto complicata. I suoi sostenitori sono minoranza nei loro partiti.
Nella Lega lo vuole Giorgetti ma non Salvini, nei 5 Stelle lo vuole Di
Maio ma non Conte. E Berlusconi pare irremovibile con il suo “niet”
di Putin memoria….
ore 15:49 | Riunione
Pd-M5S-Leu alla Camera
Il segretario del Pd Enrico
Letta, il leader di Leu Roberto Speranza, e il presidente del Movimento 5
Stelle Giuseppe Conte si sono riuniti negli uffici dei gruppi del PD alla Camera
per fare il punto sull’ultima votazione per il presidente della Repubblica.
Assieme ai leader di PD, Movimento Cinque Stelle e Leu erano presenti i
rispettivi capigruppo.
ore 15:58 | Meloni: “Fdi e
Lega leali, gli altri no”
“Fratelli d’Italia, anche
alla quinta votazione, si conferma come partito granitico e leale. Anche la Lega
tiene. Non così per altri. C’è chi in questa elezione, dall’inizio ha
apertamente lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di
centrodestra. Le decine di milioni di italiani che credono in noi non meritano
di essere trattati così. Occorre prenderne atto, e ne parlerò con Matteo
Salvini, per sapere cosa ne pensa“, il commento post-voto della leader di
FdI, Giorgia Meloni.
ore 15:59 | Calenda: ora
confronto vero, abolire kingmaker
“Ora ci vuole un timeout,
nella consapevolezza che senza sedersi a un tavolo un governo di unità nazionale
che va a eleggere un Presidente della Repubblica va a sbattere facendo una
figura indegna”. Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, commentando l’esito
della quinta votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. “Stanno
in Consiglio dei ministri insieme e non riescono a sedersi due ore per trovare
una soluzione? Se non si riesce a fare questo semplice gesto – aggiunge
conversando con i cronisti davanti a Montecitorio – ne verrà fuori un Presidente
della Repubblica indebolito e un governo ancora più indebolito. La facessero
finita“. “Sono tutti aspiranti kingmaker allo sbaraglio – conclude – non lo
sanno fare, non ci riescono. Direi di abolire la figura del kingmaker per le
prossime 48 ore“.
Diretta dalla Camera: 5°
giorno, sesta votazione per l’elezione del Capo dello Stato.
su Il Corriere del Giorno il
28 Gennaio 2022.
Si sta celebrando un nuovo
vergognoso braccio di ferro fra le due coalizioni. Il rito della chiama è
ripreso per la prima delle votazioni pomeridiane di questa tornata. Forse anche
l’ultima se il surplace annunciato con le bianche e le astensioni permetterà ai
leader di confrontarsi all’esterno senza alcuna ansia da prestazione.
di Redazione Politica
Si è celebrato il sesto
scrutinio nell’Aula parlamentare di Montecitorio per l’elezione del presidente
della Repubblica. Come ben noto la maggioranza richiesta è quella assoluta, cioè
a 505 voti. . Pd-M5S-Leu avevano anticipato che continueranno a votare scheda
bianca e così anche il M5s. Al contrario Fratelli d’ Italia ha dato indicazione
di non ritirare la scheda. I votanti avente diritto 976.
la diretta video delle
votazioni in tempo reale alla Camera dei Deputati
Vi è stato un lungo colloquio
nell’Aula della Camera tra Pier Ferdinando Casini e un gruppo di parlamentari
della Lega e del Pd: tra questi ultimi si riconoscono con il senatore dem Dario
Stefano (un’ ex UdC) e l’ex capogruppo a Palazzo Madama Andrea Marcucci.
Al termine della sesta
votazione il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto 336 voti, cioè 46 voti in
meno di quanti ne aveva ricevuti nella votazione della mattinata la
senatrice Elisabetta Casellati, attuale presidente del Senato, il risultato
della votazione pomeridiana dimostra e conferma che anche l’asse del
centrosinistra (M5S-Pd-Leu) non ha i voti necessari per eleggere un Capo dello
Stato. E se Salvini ha fatto “schiantare” la Casellati, il
“trio” Letta-Conte-Speranza hanno inutilmente scomodato il Capo dello Stato
uscente, che ha più volte dichiarato di non essere disponibile ad un secondo
mandato presidenziale.
IL POMERIGGIO DELLA GIORNATA
IN DIRETTA
ore 16:49 | La Lega si astiene
alla sesta votazione
Alla sesta votazione, che
inizierà alle ore 17 alla Camera, la Lega ha deciso di astenersi.
Ore 17.15 | Sgarbi: “d’ora in
poi voterò Draghi“
Vittorio Sgarbi, già
“telefonista” per conto di Berlusconi nell’operazione Scoiattolo, ovvero la
ricerca di consensi per l’elezione del Cavaliere tra i parlamentari di altri
gruppi, annuncia che d’ora in avanti voterà per Mario Draghi. Si assume poi la
responsabilità della proposta di Casellati avanzata da Salvini: “È colpa mia,
pensavo che da presidente del Senato avesse rapporti con i gruppi…”. E
pronostica tempi ancora lunghi: «Secondo me non si fa neanche domani».
ore 17:20 | Bossi: “Salvini
farà quel che dice Berlusconi”
Anche Umberto Bossi, dopo il
flop della candidatura Casellati, si sbilancia in previsioni: “Vedo un
Mattarella bis, qui non si batte chiodo“. Già nei giorni scorsi aveva criticato
la conduzione del gioco da parte del centrodestra, chiamando in causa “dirigenti
che non pensano“. Oggi torna a punzecchiare Salvini: “Farà quello che gli dice
Berlusconi, immagino che vada a ruota di Berlusconi. Cosa dirà Berlusconi? Dirà
che la sinistra vuole uno dei suoi alla presidenza“.
ore 17:21 | I senatori di FdI
non rispondono alla prima chiama
I senatori di Fratelli d’
Italia non stanno rispondendo alla prima chiama del sesto scrutinio.
ore 17:25 | M5s, contatti tra
Conte e Centrodestra
Il leader del M5S Giuseppe
Conte sta provando a sondare il terreno in area centrodestra “che dopo questa
forzatura istituzionale e il fallimento della prova appare molto diviso e si
intensificano trattative“. Lo rendono noto fonti del Movimento che evidenziano
delle “trattative intensificate” a seguito “della forzatura istituzionale e il
fallimento della prova Casellati“. Fonti del PD a loro volta invece ci tengono a
far sapere che al momento non ci sono contatti tra il segretario dem Enrico
Letta e quello della Lega Matteo Salvini.
ore 17:26 | Centrosinistra:
astensione alla sesta votazione
Pd, M5S e Leu voteranno scheda
bianca. È quanto ha fatto sapere il capogruppo Leu Federico Fornaro ai
giornalisti
ore 17:35 | Dal fronte
progressista spinta per Mattarella-bis subito
L’indicazione arrivata al
fronte progressista è quella di votare scheda bianca, ma secondo quanto apprende
l’AGI, nel Movimento 5 stelle, nel Pd e in Leu ci saranno parlamentari che
scriveranno già oggi il nome di Sergio Mattarella in modo da spingere per
arrivare al bis domani. Secondo un big della coalizione l’attuale
presidente Mattarella potrebbe prendere oltre 200 voti al sesto scrutinio.
ore 17:42 | Bernini (Fi):
“Abbiamo aperto trattativa con il centrosinistra”
“Abbiamo aperto una
trattativa con il centrosinistra, ”vediamo”. Così la capogruppo Forza Italia al
Senato, Annamaria Bernini, ai cronisti. Dopo l’irritazione di Lega e FdI,
l’apertura di contatti a sinistra da parte degli azzurri evoca la «maggioranza
Ursula» che consentì l’elezione di Ursula von der Leyen a presidente dell’Ue. In
quell’occasione Forza italia si trovò sullo stesso fronte di centrosinistra e
pentastellati. Bernini è notoriamente considerata un’antagonista
della Casellati all’interno dell’area forzista.
ore 17:52 | Terminata la prima
chiama senatori. Via alla seconda
È terminata la seconda chiama
dei senatori per la sesta votazione per l’elezione del presidente della
Repubblica. Ora è in corso la seconda chiama.
ore 17:58 | Meloni, al voto
subito dopo elezione Colle
Ore 18:00 | Salvini ha
incontrato Draghi
A un passo dal baratro Matteo
Salvini rallenta la corsa, chiede ai grandi elettori di centrodestra di
astenersi alla sesta chiama non ritirando la scheda e cerca Mario Draghi. Da
fonti leghiste trapela che il segretario nel pomeriggio di oggi ha avuto un
colloquio con Draghi in un palazzo di via Veneto (che potrebbe essere il
ministero dello sviluppo economico dove regna Giancarlo Giorgetti) il quale è
appena rientrato nel suo ufficio di Palazzo Chigi. Dopo la bocciatura della
presidente Maria Elisabetta Casellati e il fallimento della «spallata», che ha
scatenato una guerra di nervi e accuse dentro il centrodestra, Salvini vuole
verificare in estremo la possibilità di un accordo che tenga insieme il destino
del governo e il nome del prossimo capo dello Stato.
«Riserbo assoluto», è la
consueta linea di riservatezza di Palazzo Chigi , quando Draghi alle 18 di
venerdì si trova di nuovo al lavoro nel suo studio. Ormai appare chiaro che il
centrodestra non ha i numeri e l’unica possibilità è eleggere una personalità
condivisa da tutte le forze politiche, o almeno da quelle che sostengono il
governo di unità nazionale. La rosa di cui discutono i leader ha ormai solo tre
nomi: Draghi, Casini e Mattarella. Il senatore centrista eletto con i Dem può
contare sull’ appoggio di Renzi e Franceschini, ma Salvini non si convince e
anche nel M5S: molti hanno difficoltà a votare l’ex presidente della Camera.
Draghi ha aperto un canale di
dialogo con Berlusconi, eppure in Forza Italia restano resistenze e permane la
forte ostilità di Giuseppe Conte. Ecco perché tra le tante ipotesi di queste ore
frenetiche prende largo anche la possibilità che il capo del governo, allarmato
per la tenuta della maggioranza e del Paese, possa chiedere a Sergio
Mattarella di valutare un ripensamento rispetto al “bis” Per il presidente
uscente sarebbe un grande sacrificio anche personale, ma tanti parlamentari
guardano a lui come all’unica possibilità di sbloccare lo stallo.
ore 18:06 | Terminata chiama
senatori, ora votano deputati
È terminata la chiama dei
senatori. È ora iniziata la prima chiama dei deputati.
ore 18:09 | Incontro tra
Conte, Salvini e Letta
Prove tecniche di confronto.
Dopo tanti annunci rimasti senza seguito, è finalmente in corso un incontro tra
il leader della Lega, Matteo Salvini, e quelli di M5S e Pd, Giuseppe
Conte e Enrico Letta.
Ore 18.35 | Breve sospensione
della seduta
La seduta della sesta
votazione per l’elezione del presidente della Repubblica, alla Camera, è stata
sospesa. Riprenderà alle 18.48.
ore 18:45 | Letta: “ero
ottimista, mi pare stia andando bene“
“Questa mattina ero molto
ottimista. Mi pare che stia andando bene” ha commentato Enrico Letta “Sono in
corso interlocuzioni. Ci stiamo parlando, siamo all’inizio. I preliminari sono
finiti. Ci rivedremo più tardi. Stiamo ragionando sulle soluzioni per il
dopo” ha aggiunto il segretario del Pd al termine della riunione con il
presidente 5 Stelle Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini. Letta
ha poi fatto sapere che “tra un’ora ci rincontreremo” con Salvini e Conte.
ore 18:55 | In corso incontri
tra Salvini e altri partiti del centrodestra
Sono in corso incontri
tra Matteo Salvini e gli altri partiti del centrodestra dopo il colloquio tra il
leader della Lega, Giuseppe Conte ed Enrico Letta. Salvini ha visto Lorenzo
Cesa dell’Udc e sta incontrando Antonio Tajani.
ore 19:26 | La Russa: in rosa
nomi per FdI ok Belloni
“Tra tutti questi nomi che
sento, trovo delle agenzie di qualche giorno fa in cui Giorgia Meloni diceva che
tra i nomi che non le dispiacevano c’erano quello di Sabino
Cassese ed Elisabetta Belloni. Deduco – ma la mia è solo una deduzione – che
Belloni possa essere un nome di intesa”. Così il vice presidente del
Senato Ignazio La Russa.
ore 19:28 | Letta: “Mattarella
il massimo, serve nome all’altezza“
“È sempre stato
così dall’inizio e sempre sarà così”. Lo dice Enrico Letta, alla domanda se
continui a ritenere che Sergio Mattarella sia “il massimo” come lo stesso
segretario dem aveva dichiarato alcuni giorni fa.
Letta non ha voluto fare nomi,
nè ha confermato che si stia lavorando alla terna Draghi, Casini e Mattarella
bis, “di nomi non parlo pubblicamente, in una situazione come questa qualunque
nome io faccia poi ha una difficoltà“.
ore 19:35 | Letta: “Salvini?
Discusso in modo franco e aperto”
“La soluzione passa attraverso
il fatto che tutti capiamo che siamo vincitori se tutti saremo vincitori.
Dobbiamo arrivare ad eleggere il presidente della Repubblica, molto tempo
è già passato. Abbiamo discusso in modo molto franco e aperto e continueremo a
farlo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato da La7.
“Se serve siamo pronti a
discutere tutta la notte o anche per tutta la giornata di domani per arrivare ad
una buona soluzione. L’importante è che tutti capiscano che da questa partita
dobbiamo uscire tutti vincitori, non ci può essere un solo vincitore“. Enrico
Letta si concede ai cronisti a Montecitorio e rivela di avere trovato
un Salvini pronto per la prima volta a discutere in modo franco. Il
segretario Pd si rammarica che solo oggi, al quinto giorno e dopo la quinta
votazione andata a vuoto si sia iniziato a ragionare davvero in un’ottica super
partes “perché il centrodestra doveva fare tutto un giro per arrivare a capire
di non avere i numeri per fare da sé”. Letta si dice poi «ottimista» anche se
non «molto ottimista», perché la trattativa è complicata perché si sovrappongono
il perimetro delle due coalizioni e quello della maggioranza di governo, che non
coincidono. La linea però è chiara: «Bisognerà trovare un nome, un uomo o una
donna, all’altezza di Mattarella. Ci sono varie opzioni».
ore 19:45 | Salvini riferisce
al centrodestra
Il nuovo incontro tra Salvini
e i leader di Pd e M5S annunciato per le 20 servirà per rifare il punto della
situazione dopo gli ultimi sviluppi. Matteo Salvini si starebbe confrontando con
gli alleati del centrodestra dopo avere raccolto il parere del campo avversario.
Probabile che altrettanto venga fatto in area centrosinistra. Poi verrà il
momento di tirare le somme e capire se per la prima volta ci possa essere
l’intesa su un nome condiviso
ore 19:50 | Salvini: “Lavoro
per avere una donna in gamba come presidente”
“Sto lavorando affinché si
possa avere come presidente una donna presidente in gamba“. Lo rivela Matteo
Salvini incrociando i giornalisti fuori da Montecitorio. Salvini non fa nomi, ma
il riferimento potrebbe essere a Elisabetta Belloni, oggi al vertice dei servizi
segreti, il cui nome era stato già evocato nei giorni scorsi e che avrebbe anche
il gradimento di Fratelli d’Italia. E che potrebbe trovare consensi anche
nell’area giallo-rossa.
Ore 20.00 | Conte:
“Finalmente una presidente donna“
Il leader del M5S, Giuseppe
Conte, a pochi minuti dall’annuncio di Salvini, parla davanti alle telecamere
dell’eventualità di avere per la prima volta una donna al Quirinale. «Ho
L’impressione che ci sia la sensibilità di Salvini, spero di tutto il
Parlamento, per la possibilità di una presidente donna, il M5s lo ha sempre
detto». Anche Conte non si sbilancia sui nomi ma parla di «almeno due, solide e
super partes» figure.«Non c’è stato alcun inciucio —assicura —, siamo al lavoro
per un compromesso di alto profilo»
Il live minuto per minuto.
Elezione Presidente della Repubblica, la diretta della quinta giornata. Salvini
e Conte: “Nome? Una donna in gamba”, no di FI e Renzi a Belloni.
Redazione su Il Riformista il
28 Gennaio 2022.
Sesta votazione conclusa, in
corso lo spoglio delle schede e già si conosce il colore della fumata, nera
ancora una volta. Dopo il flop della candidatura di Elisabetta Casellati di
questa mattina e la valanga di voti per Sergio Mattarella alla votazione che si
è appena conclusa (336), è arrivato il momento delle trattative e delle
proposte. Sia Salvini che Conte pensano a una donna: il nome che è sulla bocca
di tutti è quello di Elisabetta Belloni che ha preso solo 4 preferenze. I
risultati dell’ultima chiama: Mattarella ha preso il maggior numero di voti, gli
astenuti sono stati 444 e 106 le schede bianche. Le altre preferenze di rilievo
sono state per Di Matteo (41), Casini (9), Manconi (8), Cartabia e Draghi (5).
Il quorum è sempre a 505.
La quinta giornata di
voto: dopo l’ennesima fumata nera avvenuta giovedì, nella quarta giornata
dedicata all’elezione del 13esimo presidente della Repubblica, fumata nera anche
al quinto scrutinio in programma alle 11 di venerdì 28 gennaio. Lo spoglio del
sesto scrutinio, in programma dalle 17, è in corso ed è già annunciata
l’ennesima disfatta.
Anche oggi basterà la
maggioranza assoluta dei voti, 505, per eleggere il prossimo capo dello Stato. I
nomi sul tavolo sono rimasti quattro, salvo eventuali sorprese dell’ultim’ora:
il presidente del Consiglio Mario Draghi e l’ex presidente della Camera Pier
Ferdinando Casini, mentre più defilati, dopo il flop della presidente del
Senato Maria Elisabetta Casellati, ci sono Sergio Mattarella con un suo
eventuale bis al Quirinale ed Elisabetta Belloni, la diplomatica ora alla guida
del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Ma si punta anche sul
rosario di altre personalità di area centrodestra alternative a Draghi
prospettate da Salvini, Meloni e Forza Italia dopo il ritiro di Silvio
Berlusconi: Carlo Nordio, Franco Frattini, Sabino Cassese, Letizia Moratti,
Marcello Pera, Elisabetta Belloni, Giampiero Massolo.
Tutti nomi che però,
dall’altra parte del campo, Enrico Letta, Matteo Renzi, Luigi Di Maio e Roberto
Speranza hanno denunciato avere il vizio di origine di non essere candidature
condivise ma imposte. Queste scelte, infatti, nei giorni scorsi hanno fatto
infuriare i partiti di centrosinistra. La giornata inizia con i vertici in prima
mattinata, per arrivare a eleggere il neo Capo dello Stato. Forse con la
prospettiva di creare un unicum per la storia repubblicana: mai, infatti, è
stato eletto il capo dello Stato al quinto scrutinio. Nel corso delle precedenti
12 elezioni, il quarto voto è stato decisivo per ben quattro volte.
Causa covid-19, finora si è
tenuta una sola votazione al giorno. Al massimo 50 elettori alla volta in aula
per votare. I Grandi Elettori positivi potranno votare nel parcheggio della
Camera con un seggio drive-in appositamente allestito nel parcheggio della
Camera. A votare i 1009 cosiddetti Grandi Elettori: 630 deputati, 321 senatori
(di cui 6 a vita, 5 di nomina presidenziale e un ex presidente della Repubblica)
e 58 delegati regionali, tre per ogni Regione, uno solo per la Valle d’Aosta.
Votano prima i senatori, poi i deputati e infine i delegati regionali. Il voto è
anonimo: perciò le elezioni del Capo dello Stato sono il regno dei franchi
tiratori. Solo in due occasioni, nel 1985 con Francesco Cossiga e nel 1999 con
Carlo Azeglio Ciampi, il Presidente venne eletto alla prima seduta.
LA DIRETTA
Ore 08:45 – Prima del nuovo
vertice delle delegazioni di Pd, M5S e Leu, il segretario dem Enrico Letta non
nasconde la delusione per le giornate precedenti: “Abbiamo sempre lavorato per
l’unità. L’impressione è che abbiano tentato di dividerci, con idee fantasiose
con l’obiettivo di dividere e non di trovare una soluzione per il Paese”, ha
detto entrando alla Camera. E poi afferma “Chiederemo a Fico di aumentare le
votazioni e arrivare almeno a due votazioni al giorno”. E poi, con un pizzico di
amarezza, sibila: “Mi chiedo se ho fatto bene a fidarmi”. Il riferimento ricade
sul centrodestra.
Ore 08:55 – Il leader di Iv
Matteo Renzi lascia in campo l’ipotesi di un Mattarella Bis. “Non escludo
l’ipotesi che possa esservi anche un Mattarella bis, sarebbe una forzatura nei
confronti di Mattarella e oltremodo scorretto ma al venerdì mattina o la vicenda
si risolve nelle prossime ore o questa ipotesi e’ in campo con tutta la sua
forza”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi su Radio Leopolda. Per
Italia Viva non è sul tavolo la possibilità di votare il presidente del Senato
Casellati. “Noi Casellati non la votiamo come non votiamo nessun candidato
divisivo come abbiamo sempre detto. Ma il centrodestra la smetta di correre
dietro la Meloni che tenta di far saltare la maggioranza di Governo”. Lo ha
detto il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, ai cronisti della Camera.
Ore 09:00 – Il vicepresidente
di Forza Italia Antonio Tajani, arrivando a Montecitorio per il vertice di
centrodestra, assicura: “Il governo non cade. Dobbiamo lavorare molto. Vogliamo
trovare soluzioni condivise”. E nell’ostentare compattezza, punta il dito sul
centrosinistra. “E’ la sinistra che ieri si è divisa, il centrodestra è compatto
e unito. Noi scandalosi? Addirittura, dov’e’ lo scandalo. Non abbiamo mai posto
veti”.
Ore 09:10 – Dure parole della
leader di Fratelli di Italia Giorgia Meloni su Twitter: “La desolazione delle
manfrine sull’elezione del Presidente della Repubblica certifica 2 cose che
@FratellidItalia sostiene da sempre: 1. Con questo Parlamento è impossibile
decidere qualsiasi cosa. 2. Se fossero stati gli italiani ad eleggere il PdR lo
avrebbero fatto in un giorno”.
Ore 09: 21 – Il centrodestra
non ha ancora comunicato al centrosinistra il nome del candidato che oggi
dovrebbe votare per il Quirinale. E’ quanto si apprende da varie fonti mentre è
in corso il vertice di M5s, Pd e Leu. Le delegazioni stanno valutando come
comportarsi nel caso in cui il centrodestra votasse un nome di area nella quinta
votazione. L’idea ad ora prevalente sarebbe quella di uscire dall’aula o
astenersi.
Ore 09:25 – E’ iniziato, alla
Camera, il vertice del centrodestra in vista dell’elezione del presidente della
Repubblica. All’arrivo al vertice il segretario Udc Lorenzo Cesa ha detto che il
centrodestra resta orientato a votare la presidente del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati. “Sì”, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se il voto
andrà alla Presidente del Senato.
Ore 09:30 – “Proporre la
Casellati è irresponsabile? “E perché? E’ la seconda carica dello Stato. La
sinistra ha la pretesa di voler avere il monopolio dei giudizi morali, è questo
il vizio di tutta questa vicenda”. Lo ha detto il senatore di FI, Maurizio
Gasparri, arrivando a Montecitorio. E poi sul nome di Cassese uscito nei giorni
scorsi ha detto: “Cassese è stato uno dei più tenaci avversari delle idee del
centrodestra, mai potra’ essere Cassese che va cassato”. E a chi gli domandava
se è stato un errore strategico del leader leghista Matteo Salvini ha risposto:
“Non lo so, saranno stati dei comunisti a proporlo, escludo che lo abbia fatto
Salvini”.
Ore 09:45 –
Il centrosinistra potrebbe optare per la scheda bianca alla quinta votazione.
L’indiscrezione mentre è ancora in corso il vertice tra il leader Pd Enrico
Letta, quello del M5s Giuseppe Conte e Leu Roberto Speranza. Si valutano anche
candidature alternative. In corso ancora le valutazioni.
Ore 09:55 – Il segretario
della Lega Matteo Salvini ha invitato tutti i leader della maggioranza a un
vertice prima del voto al via alle 11:00.
Ore 10:17 – “Vediamo come
andrà alla prima votazione se non dovesse esserci un risultato vincente oggi
pomeriggio continueremo con Elisabetta Alberti Casellati … A buon intenditor
poche parole: i grandi lettori di Forza Italia voteranno Elisabetta Alberti
Casellati”, le parole di Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, riportate
da LaPresse.
Ore 10:23 – “Sono contenta che
si sia arrivati alla decisione di andare in aula con un candidato proposto dalla
nostra metà campo ma parliamo della seconda carica dello Stato, una donna,
presidente del Senato ed è un’apertura verso gli altri, una candidatura meno
politicizzata e più istituzionale“, le parole della leader di FdI Giorgia Meloni
al termine del vertice di centrodestra.
Ore 10:42 – Ci saranno due
sedute di votazioni: anche oggi pomeriggio si voterà per il Presidente della
Repubblica. Secondo molti sarà quella di oggi pomeriggio la votazione decisiva.
La riunione dei capigruppo di Camera e Senato ha approvato la doppia votazione
quotidiana: oggi pomeriggio alle 17:00, sabato alle 9:30 e alle 16:30.
Ore 11:00 – Italia Viva non
parteciperà alla prima chiama per l’elezione del presidente della Repubblica
mentre è ancora in corso il vertice del centrosinistra.
Ore 11:03 – È cominciata la
quinta votazione per eleggere il 13esimo Presidente della Repubblica.
Ore 11:10 – Anche il Pd e Leu,
oltre a Italia viva, hanno deciso di non partecipare alla prima chiama. Si
valuterà la posizione sulla seconda
Ore 11:23 – A pochi minuti
dall’inizio del voto arriva sui social il post di Silvio Berlusconi in appoggio
alla candidatura di Casellati. “Il Centrodestra ha trovato l’accordo per il voto
di questa mattina, su Elisabetta Casellati che da Presidente del Senato, Seconda
Carica dello Stato, diventerebbe Prima Carica dello Stato. Io conosco Elisabetta
Casellati da oltre 30 anni e posso garantire sulla sua assoluta adeguatezza a
questo eventuale nuovo ruolo super partes. Per tale motivo mi rivolgo ai
Parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere loro di sostenere la
Casellati. Dobbiamo assolutamente porre fine all’attuale spettacolo indecoroso
che la politica sta dando di sé agli italiani e che l’opinione pubblica non
riesce più a capire e a tollerare. Ringrazio di cuore tutti i Parlamentari che
daranno seguito a questo mio appello e mi auguro che finalmente il Parlamento
possa dare un segnale di responsabilità e di adeguatezza al ruolo che la
Costituzione gli assegna. Lo spero davvero”.
Ore 11:35 – Su quali numeri
bisognerà confrontarsi per capire se la candidatura della Casellati unirà
realmente il centrodestra? Quelli dei grandi elettori della coalizione, che
sono 457 suddivisi così: Lega 212, Forza Italia 136, Fratelli d’Italia 63,
Coraggio Italia 31, UDC 5, Noi con l’Italia 3, Diventerà Bellissima 1, Noi di
Centro 1, Rinascimento 1, parlamentari nel Misto (non iscritti) eletti col
centrodestra 4.
Al totale dei voti va escluso
quello della stessa presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati,
che di norma (come il presidente della Camera) non vota.
Ore 11:40 – Il ‘campo
progressista’, ovvero l’unione di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Leu,
ha deciso ufficialmente di astenersi nella quinta votazione. La formula,
spiegano dagli ‘ex giallo-rossi’, è quella del “presente non votante”.
“Il centrodestra continua a
gestire irresponsabilmente il più importante passaggio democratico e
costituzionale rappresentato dall’elezione del Presidente della Repubblica.
Consideriamo la unilaterale candidatura della seconda carica dello Stato,
peraltro annunciata a un’ora dalla quinta votazione, un grave errore”, è la
posizione espressa in una nota da Letta, Conte e Speranza.
Ore 12:25 – Salvini e il
centrodestra puntano fortissimo sul presidente del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati per il Quirinale. Casellati che per il leader della Lega “è
il miglior candidato possibile, è il massimo che la Repubblica possa mettere a
disposizione dopo Mattarella, che ha già detto di non essere d’accordo ad un
reincarico. Non è un nome di bandiera tanto per contarci”, ha spiegato Salvini
durante una conferenza stampa convocata mentre è in corso la quinta votazione.
Dal segretario del Carroccio
accuse anche al centrosinistra allargato: “Sono deluso dalla fuga della
sinistra, che diserta il voto e diserta anche le riunioni di maggioranza:
proporrò di incontrarci prima del secondo voto. Se non ci si parla e si fugge la
situazione non si risolve”.
A favore della Casellati è
anche il punto che “potrebbe essere storicamente il primo presidente donna della
Repubblica”, ha ricordato Salvini sottolineando come “fu eletta presidente del
Senato con il 75% dei voti, non un’era fa ma 4 anni fa”
Ore 12:50 – Scontro a distanza
(temporale) ravvicinata tra Salvini e Conte dopo le parole del primo sulla
candidatura della Casellati. Per l’ex premier infatti c’è un “cortocircuito
istituzionale” dopo la scelta del centrodestra di votare per la presidente del
Senato.
La soluzione, aggiunte Conte,
“non può che essere di alto profilo, pienamente condivisa e quindi super partes,
deve nascere super partes. Non si può procedere con questi strappi”.
“Tre giorni fa abbiamo detto
che rinunciavamo a fare una contro-lista di nomi – ricorda Conte – e da tre
giorni inseguiamo i nostri interlocutori di centrodestra per cercare di trovare
una candidatura condivisa. Oggi, a poche ore dal voto, veniamo a sapere che
c’era la candidatura della seconda carica dello Stato. Non partecipiamo a
questi atti di forza e alla conta su più alte cariche istituzionali. Per questa
ragione abbiamo deciso di astenerci”.
Ore 13:05 – Lo
stesso Salvini in conferenza sembra credere poco alla candidatura della
Casellati, aprendo chiaramente ad un confronto su altri nomi: ““Io non pongo
veti nei confronti di nessuno, ma se uno mi chiede di Sergio Mattarella dico che
ha già detto di no, di Roberto Fico che non ha l’età. Mario Draghi? Da italiano
sarei più tranquillo se continuasse a fare il premier. Anche perché se già
fatichiamo a fare riunioni per trovare un presidente della Repubblica,
figuriamoci per trovare un altro premier e altri ministri”, ha detto ai
cronisti.
Ore 13:15 – Una ‘bordata’
contro la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati arriva dal
Partito Democratico. Enrico Borghi, componente della segreteria, chiede infatti
che la candidata del centrodestra non presieda lo scrutinio: “È del tutto
inopportuno che la presidente Casellati nello spoglio odierno co-presieda lo
scrutinio delle schede, di fatto controllando i voti per sé stessa. Nel 1992,
quando Oscar Luigi Scalfaro si trovò in analoga condizione, si astenne dal
presiedere lo scrutinio lasciando il compito al vicepresidente Rodotà. Ci
auguriamo il medesimo rispetto delle istituzioni”, è la richiesta avanzata dai
Dem.
Il motivo? La possibilità da
parte della stessa Casellati di ‘contare’ i voti da parte della sua
coalizione sfruttando diverse formule: un solo cognome, entrambi i cognomi, nome
e cognome per esteso. Anche se il presidente della Camera Roberto Fico leggesse
una formula ‘neutra’, a controllare le schede al suo fianco ci sarebbe infatti
proprio la Casellati.
Ore 14:20 – Inizia
lo spoglio della quinta votazione: l’attenzione è ovviamente rivolta ai voti che
otterrà la presidente del Senato Casellati, la maggioranza richiesta è di 505
voti e i grandi elettori del centrodestra sono 457.
Ore 14:50 – Ancora fumata
nera. Fallisce l’operazione Casellati del centrodestra. La presidente del Senato
si ferma a 382 voti e non raggiunge il quorum dei 505 previsti per l’elezione,
al quinto scrutinio, del 13esimo presidente della Repubblica e nemmeno la soglia
dei 400 auspicata dai partiti che sostengono la sua candidatura. Il prossimo
voto, il sesto scrutinio, è in programma alle 17. Voti per l’attuale presidente
della Repubblica Sergio Mattarella e il magistrato Nino Di Matteo, indicato dai
parlamentari di Alternativa e dagli indipendenti del gruppo Misto. Preferenze
anche per Marta Cartabia, indicata da Azione e +Europa e per Silvio Berlusconi e
Antonio Tajani. Gli astenuti sono stati 406, le schede bianche 11, nulle 9.
I numeri – I grandi elettori
della coalizione di centrodestra sono 457 suddivisi così: Lega 212, Forza Italia
136, Fratelli d’Italia 63, Coraggio Italia 31, UDC 5, Noi con l’Italia 3,
Diventerà Bellissima 1, Noi di Centro 1, Rinascimento 1, parlamentari nel Misto
(non iscritti) eletti col centrodestra 4. Al totale dei voti va escluso quello
della stessa presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che di
norma (come il presidente della Camera) non vota.
Ore 16:00 – Nel centrodestra è
partita la caccia al ‘traditore’, con Lega e FdI che assicurano di aver votato
per Casellati: ma a uscire sconfitto dalla quinta votazione è Salvini, ‘volto’
del quinto nome bruciato dalla coalizione
Ore 16:06 – Forza Italia fa lo
sgambetto alla Casellati, scintille in transatlantico: “Ora si dimetta”
Ore 16:20 – Cosa succede ora?
Mentre nel centrodestra è aperta la caccia ai franchi tiratori,
con Lega e Fratelli d’Italia che accusano in particolare i centristi della
coalizione (tra cui Forza Italia, partito della Casellati), ripartono vertici e
riunioni.
Incontri ci sono nel ‘campo
progressista’, con una riunione informale tra PD, Movimento 5 Stelle e Leu, ma
anche nel fronte opposto. Il tutto in vista della sesta votazione in programma
alle 17, che dovrebbe essere comunque interlocutoria in vista della giornata di
sabato.
Ore 16:55 – Dopo il flop del
quinto scrutinio, il centrodestra, al termine del vertice, avrebbe deciso di
astenersi senza ritirare la scheda nel sesto scrutinio. Un modo per contarsi ed
evitare franchi tiratori.
Ore 16:58 – Casellati come
Prodi, Salvini brucia la candidatura e affossa il centrodestra: Bersani si
dimise, lui?
Ore 17:00 – Si riparte con
la sesta votazione: viste le mosse annunciate dai vari partiti, tra schede
bianche e astensione, neanche questa sera verrà eletto il presidente della
Repubblica.
Ore 17:15 – Secondo quanto
riferiscono fonti del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte “sta sentendo il
centrodestra” che, “dopo questa forzatura istituzionale e il fallimento della
prova” appare “molto diviso” e “si intensificano le trattative” per arrivare a
una soluzione condivisa per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica.
Ore 17:40 – Una riflessione
comune a molti nel Transatlantico: con la doppia votazione a distanza così
ravvicinata, quella del pomeriggio diventa nei fatti, come emergerà anche oggi,
inutile.
Troppo poco il tempo tra la
fine del primo spoglio e l’inizio del voto successivo per poter tentare nuovi
accordi e fare eventuali valutazioni di quanto accaduto in Aula poco prima.
Ore 18:00 – Si muove il fronte
della trattiva, sempre più larga. A riferirlo è Annamaria Bernini, capogruppo
di Forza Italia al Senato, che conferma come si è aperta una discussione “con
Pd, M5S e Leu. Vediamo”. Bernini, tra l’altro considerata come una ‘nemica
interna’ del partito azzurro alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati, evoca quindi una possibile riedizione della “maggioranza Ursula” che
consentì l’elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione
europea.
Ore 18:20 – Incontro a tre per
il Quirinale. Negli uffici del Movimento 5 Stelle della Camera è in corso
un vertice tra Giuseppe Conte, Enrico Letta e Matteo Salvini: l’obiettivo è
arriva quanto prima ad un accordo su un nome condiviso.
Salvini che, scrive l’Ansa, si
è visto col premier Mario Draghi poco prima del vertice con i due leader del
‘campo progressista’. I due sono stati visti uscire a pochi minuti di distanza
l’uno dall’altro dallo stesso palazzo nei pressi di via Veneto a Roma.
Ore 18:40 – Segnali positivi
dall’incontro a tre tra Salvini, Conte e Letta. Proprio il segretario del
Partito Democratico si è detto “molto ottimista“, con dichiarazioni dunque molto
meno ‘abbottonate’ rispetto a quelle degli ultimi giorni. “Ci stiamo parlando,
sono in corso discussioni e stiamo lavorando a una soluzione”, ha spiegato il
leader Dem.
Ore 19:15 –
Enrico Letta intervenendo alla ‘Maratona Mentana’ su La7 conferma che sono in
corso trattative per eleggere il presidente della Repubblica, anche se “non è
semplice, ci sono varie opzioni, bisogna che maturino le condizioni politiche
per fare le intese, bisogna che ognuno faccia un passo avanti”.
“La soluzione – ha aggiunto il
segretario PD – passa attraverso il fatto che tutti accettiamo che tutti siamo
vincitori e che non c’è un solo vincitore”. Quanto a Salvini “l’ho trovato bene,
abbiamo discusso in modo franco e aperto e continueremo a farlo”.
Ore 19:48 – “Riassunto della
giornata: il centrodestra ha mantenuto la parola mettendo a disposizione del
Paese la più alta carica dopo Mattarella. Dispiace che la sinistra non si sia
presentata nemmeno in aula. Avremmo avuto la possibilità di eleggere il primo
presidente della Repubblica donna. Spero che a breve eleggeremo un presidente
donna in gamba, non donna in quanto tale. Ma non faccio nomi…“. Così Matteo
Salvini all’uscita da Montecitorio ai giornalisti.
Ore 20:02 – “Un presidente
della Repubblica donna e super partes“, è quanto auspica anche l’ex premier
Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle sempre all’uscita da Montecitorio.
Il nome “caldo” resta quello di Elisabetta Belloni, a capo del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza. Sarebbe dunque questo l’accordo preso da
Pd, Movimento 5 Stelle e Lega al termine del vertice avuto poco prima delle 19.
“C’è un’apertura ad avere
finalmente una presidente della Repubblica donna. Stiamo lavorando”. Poi ha
aggiunto: “Spero che ci sia la sensibilità per avere un presidente
donna. Sarebbe la prima volta della storia“, spiegando che ci sono “almeno due,
solide e super partes“.
Ore 20:23 – Chi è la
“Presidente donna in gamba” proposta da Salvini a Presidente della Repubblica
Ore 20:25 – Chi è Elisabetta
Belloni, la diplomatica che potrebbe essere la prima donna Presidente della
Repubblica
Ore 20.43 – Matteo Renzi,
leader di Italia Viva ha fatto sapere che il suo partito non voterà il nome di
Elisabetta Belloni alla settima chiama prevista per domani mattina alle 9.30:
“Elisabetta Belloni è una straordinaria professionista la volevo ministro degli
Esteri nel novembre 2014. La stimo molto, è una mia amica ma oggi è il capo dei
servizi segreti e indipendentemente dal nome in una democrazia nel 2022 il capo
dei servizi in carica non diventa presidente della Repubblica”, ha detto a Radio
Leopolda.
Ore 20:28 – Intanto è in corso
lo spoglio del sesto scrutinio. Oltre 80 voti, per ora, sono andati a Sergio
Mattarella, l’attuale presidente della Repubblica. Pochi preferenze anche per il
magistrato Nino Di Matteo (candidato dai parlamentari di Alternativa e dagli
indipendenti del gruppo Misto) e Pier Ferdinando Casini.
Ore 21.00 – Licia
Ronzulli vicepresidente dei senatori di Forza Italia, fedelissima di Silvio
Berlusconi, intercettata dai cronisti alla Camera, si aggiunge ai contrari al
nome di Belloni: “Per noi non va bene“. Rimane forte perplessità
sull’eventualità che ci possa essere un tecnico come presidente del consiglio e
un tecnico come presidente della Repubblica fanno sapere fonti di FI.
Dello stesso avviso anche il
senatore dem Andrea Marcucci che scrive su Twitter: “Vorrei ricordare a tutti
che per volontà della direzione del Pd, tutti nomi possibili per il Quirinale
dovranno essere preliminarmente valutati e votati dall’assemblea dei grandi
elettori dem. Non si possono votare candidati a scatola chiusa“.
Contrario a Renzi il parere
di Carlo Calenda, leader di Azione “Voteremmo Belloni con convinzione. Cartabia
ha più esperienza come garante della costituzione. Belloni più esperienza come
rapporti internazionali. Entrambe sono fuoriclasse. E non possiamo perdere
l’occasione. Una donna preparata al vertice delle istituzioni. Finalmente”,
scrive su Twitter.
Ore 21.24 – Si rimpolpa la
fazione dei contrari a Belloni. “Assolutamente inopportuno che il capo dei
servizi segreti diventi presidente della Repubblica. Allo stesso modo non è
accettabile che la presidenza della Repubblica e la guida del governo siano
affidate entrambe a personalità tecniche e non politiche”. Così fonti di LeU.
Ore 21.33 – Piccolo imprevisto
alla conclusione dello spoglio: una scheda in più rispetto ai votanti. Ma il
presidente della Camera Roberto Fico tranquillizza tutti: “Tale differenza – ha
spiegato – è dovuta verosimilmente al fatto che nella distribuzione è stata
erroneamente ricevuta da un elettore una scheda in più depositata poi nell’urna.
La differenza è del tutto ininfluente al fine del risultato del voto e pertanto
sulla base del principio generale di resistenza e di analoghi precedenti la
votazione svolta deve ritenersi pienamente valida”.
Ore 21.38 – Il fondatore del
Movimento 5 stelle Beppe Grillo affida a Twitter il suo personale benvenuto alla
futura presidente della Repubblica, secondo lui Elisabetta Belloni
Ore 22.07 – Giorgia Meloni,
presidente di Fratelli d’Italia risponde sul piano della rappresentanza di
genere nelle istituzioni: “Tutti parlano dell’importanza delle donne nei ruoli
chiave, ma alla prova dei fatti quando esce il nome di una donna per un’alta
carica si assiste a un fuoco di sbarramento di una violenza inaudita. Ecco a voi
la latente misoginia italiana”.
Ore 22.28 – Il ministro
degli Esteri Luigi Di Maio si lancia contro Giuseppe Conte, al suo nuovo alleato
Matteo Salvini e forse non conscio della presa di posizione di Beppe Grillo,
boccia il nome della Belloni: “Trovo indecoroso che sia stato buttato in pasto
al dibattito pubblico un alto profilo come quello di Elisabetta Belloni. Senza
un accordo condiviso”, e aggiunge: “Lo avevo detto ieri: prima di bruciare nomi
bisognava trovare l’accordo della maggioranza Di governo. Tutto ciò, inoltre,
dopo che oggi è stata esposta la seconda carica dello Stato. Così non va bene,
non è il metodo giusto”.
Corriere.it il 28 gennaio
2022.
Fallisce la candidatura di
Elisabetta Alberti Casellati. La presidente del Senato ha ottenuto solo 382
voti, sui 453 che sulla carta avrebbero dovuto essere appannaggio del
centrodestra e una sessantina in meno rispetto ai 441 astenuti, sempre del
centrodestra, di ieri. Improbabile a questo punto che il suo nome venga
ripresentato alla prossima votazione. In ogni caso si tratta della quinta fumata
nera. La prossima votazione, la sesta, sarà oggi alle 17.
Aldo Cazzullo per corriere.it
il 28 gennaio 2022.
La Casellati: «Mi ha
telefonato mia figlia in ansia… nessuno mi ha sostenuta a braccia, semplicemente
una parlamentare che mi aveva votata mi ha abbracciata. Le schede? Fico le
leggeva e me le passava, ma io non le ho guardate».
La Casellati esce dall’aula
sostenuta a braccia da un’assistente. Un commento, presidente?
«Grazie»
La Casellati ferma a 382 voti.
Grande vittoria di Anna Maria Bernini, la rivale interna.
Aldo Cazzullo per il Corriere
della Sera il 28 gennaio 2022.
Luciano Nobili racconta la
telefonata di Berlusconi: «Caro Luciano, che piacere, ma lei verrebbe qui a cena
a parlare di Quirinale con me, Sgarbi e tre giovani amiche? Mi dicono che pure
lei è sensibile all’argomento…e poi so che ama abbracciare gli ulivi, come la
capisco, qui ho un ulivo secolare, lo potrebbe abbracciare con tranquillità…
come quali ulivi? No, non l’Ulivo di Prodi, quelli veri! Mi scusi ma lei non è
l’onorevole Ciampolillo? Ah lei è Nobili… mi scusi tanto ma Sgarbi mi fa un
casino con questi telefoni…però sia chiaro: l’invito a cena con le tre giovani
amiche è sempre valido!»
(ANSA il 28 gennaio
2022) Scintille tra Ignazio La Russa e Giovanni Toti in Transatlantico, davanti
ai giornalisti pochi istanti dopo la fine dello spoglio, caratterizzato da una
cinquantina di franchi tiratori nel centrodestra. "Hai gia' espresso la tua
soddisfazione per il risultato, stai già festeggiando?", saluta l'ex ministro
FdI il Governatore ligure, con un sorriso che celava a stento grande disappunto.
E Toti, impeturbabile,
replica: "No, vi lascio spazio, vi lascio andare avanti...". Quindi, pochi
minuti dopo, sempre davanti ai taccuini dei cronisti, un secondo scambio molto
acido tra i due, stavolta vicino agli ascensori del palazzo. Chi ha tradito?
Viene chiesto sempre a La Russa: "Guardate tra i centristi e in Forza Italia",
risponde. A quel punto, casualmente, passa di nuovo Toti. I cronisti gli
riferiscono l'accusa di La Russa: "Io sarei contento se avessi 70 parlamentari -
ribatte il dirigente di Coraggio Italia - ma non e' cosi'". Taglia corto La
Russa, masticando amaro: "Infatti, ne hai la meta'".
Tommaso Labate per
il “Corriere della Sera” il 28 gennaio 2022.
«Non ci credo, è in preda alla
sindrome da citofono». Ai piani alti del Pd, quando sui terminali delle agenzie
si materializza il lancio dell'Agi sull'incontro tra Matteo Salvini e Franco
Frattini, qualcuno si presenta da Enrico Letta e lo relaziona sull'ennesimo
candidato del leader leghista che sembra destinato a essere «bruciato».
Il segretario del Pd aveva
perso le tracce del pari grado del Carroccio da qualche ora; e anche quelle di
Giuseppe Conte, al punto che si iniziava a spargere la voce che le due vecchie
punte di diamante del governo gialloverde fossero andate insieme a caccia di
candidati per il Quirinale (circostanza poi negata dai 5 Stelle).
È stato in quel momento, siamo
nel tardo pomeriggio, che - forse per stemperare la tensione - ai vertici della
cerchia lettiana qualcuno ha tirato fuori la «sindrome del citofono», ricordando
quella sera della campagna elettorale delle elezioni regionali
dell'Emilia-Romagna in cui Salvini si era presentato al portone di un condominio
di periferia e aveva citofonato a un sospetto spacciatore. «Il meccanismo è lo
stesso ma la domanda è diversa: scusi, lei si candida al Quirinale?».
Nel perimetro temporale di
sole quattro votazioni, e trascurando il lavorio delle settimane precedenti, la
mano di Salvini ha toccato o semplicemente sfiorato una lista indefinita di
«quirinabili», regalando loro (per ora) l'atroce destino di candidature che
hanno fatto giri immensi senza mai essere tornate alla base.
Donne e uomini, freschi
sessantenni e quasi novantenni, accademici di grido e politici consumati e alte
cariche dello Stato del presente e del passato remoto, sotto l'ombrello
salviniano - in un gioco di terzine comunicate in conferenza stampa,
chiacchierate riservate e visite a sorpresa, spifferi confermati o smentiti -
hanno sfilato in ordine sparso Marcello Pera e Letizia Moratti, Carlo Nordio e
Sabino Cassese, Giampiero Massolo ed Elisabetta Belloni, Pier Ferdinando Casini,
Maria Elisabetta Alberti Casellati, Franco Frattini.
E la lista è incompleta se è
vero, com' è vero, che l'ufficio stampa leghista ha confermato altri incontri
con «avvocati e docenti universitari», quasi a dare la misura di un casting
senza fine. «Siamo a X-Factor», si lamentava ieri sera Matteo Renzi, che pure
per una lunga finestra temporale di questa campagna quirinalizia è stato per
l'omonimo leghista un compagno di viaggio a metà strada tra il confidente e il
suggeritore («Mesi fa gli mandai dei video di Cassese alla Leopolda, lui non lo
conosceva», ha spifferato il leader di Italia viva).
Il caso di Elisabetta Belloni,
che sta ai vertici dei servizi segreti, ha fatto infuriare più d'uno, a
cominciare dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Per qualche ora, ieri
mattina, Salvini aveva lasciato intendere che «su questo nome si può ragionare».
Salvo poi, dopo l'apertura di Giorgia Meloni, cambiare idea, ingranando una
pericolosa retromarcia. Già, perché Salvini è alla ricerca di un sogno
all'apparenza impossibile.
Una candidatura tirata fuori
dal suo cilindro che lo copra con la maggioranza e che non lasci margini di
protesta a Fratelli d'Italia. L'ha imparato a proprie spese Pier Ferdinando
Casini, che nella notte tra lunedì e martedì è andato a dormire avvertendo tra
le mani la consistenza di una larga investitura quirinalizia che poi gli è
scivolata come un'anguilla. «Salvini aveva fatto capire che ci rifletteva ma poi
ha cambiato idea, spaventato dalla prova di forza della Meloni con la
candidatura di bandiera di Guido Crosetto», ha confessato in giornata uno degli
amici più stretti dell'ex presidente della Camera.
Giancarlo Giorgetti, nel
frattempo, ha memorizzato nelle note dello smartphone una risposta fotocopia a
tutti i messaggi che gli arrivano e che gli chiedono conto della prossima mossa
di Salvini. «Sono ottimista» è il testo copiato e incollato a beneficio di
decine di destinatari. Qualcuno lo interpreta come il segnale che, alla fine di
un lungo giro, il dito salviniano andrà a toccare il citofono di Palazzo Chigi,
alla ricerca di Mario Draghi. Il doppio forno del segretario leghista, con
Conte&Letta e con la Meloni, è sempre più attivo. Ma le candidature che ci sono
finite dentro ne sono uscite bruciate. Per ora.
Marco Galluzzo per corriere.it
il 28 gennaio 2022.
«Ora le verrà la sindrome di
Berlusconi», sussurra con malizia e un pizzico di cattiveria una senatrice di
Forza Italia che non l’ha votata. Elisabetta Casellati — la presidente del
Senato uscita sconfitta dal «blitz» lanciato dalla sua coalizione per
conquistare il Quirinale — esce dall’Aula di Montecitorio visibilmente scossa.
Nel suo entourage non parlano: c’è sgomento, irritazione, frustrazione. E una
bella dose di disorientamento.
Peggio non poteva andare.
Doveva essere una prova decisiva, di forza, di potenziale successo. E invece è
stata quasi una catastrofe.
Ma la protagonista della
propria sconfitta, raccontano fonti di centrodestra, è stata proprio lei, la
seconda carica dello Stato.
Giovedì sera c’erano molte
perplessità sulla decisione di lanciarla in modo formale in Aula, cercando una
prova di forza con il centrosinistra.
Eppure proprio lei si è
imposta, anche alzando la voce nel corso di una telefonata con Berlusconi, uno
scambio di vedute non proprio sereno. Dentro Forza Italia sapevano che ci
sarebbero stati problemi: «In questi anni al Senato si è fatta più nemici che
amici», confida un parlamentare che la conosce bene, ma che soprattutto conosce
benissimo le senatrici azzurre che hanno con Casellati un pessimo rapporto.
Persino con Antonio Tajani,
che aveva messo sul tavolo tutte le sue perplessità, sembra che la presidente
del Senato abbia litigato. Eppure nelle ore che hanno preceduto l’inizio delle
votazioni, nel corso delle riunioni di giovedì notte, proprio lei non ne ha
voluto sapere di fare un passo indietro.
Ha sostenuto di essere certa
che avrebbe avuto anche i voti di Italia Viva. Ha mandato lei stessa messaggini
per chiedere di essere votata.
E invece le preferenze di oggi
per Mattarella, Casini e lo stesso Berlusconi sono anche la cifra di quanti le
hanno fatto sapere, chiaramente, che non erano con lei.
DAGOREPORT il 28 gennaio 2022.
Viste le nostre forze
politiche in azione per la nomina del Capo dello Stato, vien solo voglia di
sottoporli urgentemente a un T.S.O. Anche se per Salvini e Conte, un Trattamento
Sanitario Obbligatorio forse non sarebbe sufficiente perché stasera siamo giunti
alla follia totale.
Ora l’ex bagnino del Papeete,
dopo aver preso in giro il povero Cassese e stroncato in aula la Casellati, ora
tira fuori l’ennesimo coniglio dal cilindro: “Sto lavorando affinché si possa
avere come presidente una donna presidente in gamba” (una precisazione,
“quell’’in gamba”, che avrà fatto felice la Casellati).
E subito, quella cima di rapa
di Conte si è accodato: “Ho l'impressione che ci sia la sensibilità di Salvini,
spero di tutto il Parlamento, per la possibilità di una presidente donna, il M5s
lo ha sempre detto”. I due scappati dal manicomio non fanno nomi, ma tutti hanno
capito che il riferimento è ovviamente a Elisabetta Belloni, oggi al vertice dei
servizi segreti. La conferma arriva con il tweet di Beppe Grillo: "Benvenuta
Signora Italia, ti aspettavamo da tempo. #ElisabettaBelloni".
L’intesa tra i due ciucci
prestati alla politica fa fuori il Pd di Letta, Italia Viva e Forza Italia che
sul nome della Belloni già nei giorni scorsi avevano espresso il loro parere
contrario: intanto, il trasloco del capo servizi sul Colle fa venire in mente
solo la democratica Russia dell’ex Kgb Putin. Secondo: un eventuale duplex
Draghi-Belloni vuol dire due tecnici ai massimi vertici dello Stato: manco in
Nicaragua con Ortega.
Terzo: potete immaginare
Draghi che rimane a Palazzo Chigi avendo sul Colle, quindi sopra di lui, una che
è stata nominata dal suo governo? Assolutamente no: quindi tracolla il governo e
voto anticipato. Quello che sogna la Meloni. Che infatti ha si è dichiarata
subito a favore della zarina delle spie.
Il Conte a favore di Belloni
presidente è anche uno sgarbo al suo nemico più intimo, Di Maio che ha subito
sparato a zero contro Peppiniello Apulo. Da sempre sponsor dell’ambizione
quirinalizia di Draghi, l’ex bibitaro del San Paolo ora si trova al bivio: la
Belloni come segretario generale della Farnesina ha fatto da tutor a un ministro
degli Esteri che non spiccicava una parola di inglese ed era un pesciolino fuor
d’acqua nelle cancellerie internazionali.
L’uscita del Truce pro-donna
arriva dopo la Casellati trombata. Per salvare quello che gli resta della faccia
da una epica figuraccia di merda (la Meloni ha subito gridato “Al voto! Al
voto!”, Salvini fa il suo ingresso nella sede parlamentare del M5S per un
conciliabolo con Conte e Letta. Tema caldissimo: Mattarella ha preso 360 voti
pur non essendo candidato.
Un numero altissimo, mai
successo nella storia del Quirinale. Hic sunt peones! Sono loro che vogliono il
bis della Mummia Sicula per evitare la caduta del governo e l’apertura delle
urne, per arrivare alla fine della legislatura e incassare il vitalizio
parlamentare. Ma Mattarella non è uno tipino facile e un atto di forza dei
parlamentari non basta: come avvenne con Napolitano, vuole i leader dei partiti,
in fila indiana, che salgono sul Colle per chiedere il suo assenso.
E qui viene il bello: Salvini
annuncia a Letta e Conte che il centrodestra non vuole il bis del Capo dello
Stato. Gigiona Meloni è da sempre contraria al bis e il matto Matteo vuole la
siringa piena e la moglie drogata: vuole l’unità del centrodestra, malgrado
Fratelli d’Italia sia all’opposizione, e nello stesso tempo stare nella
maggioranza di governo.
Così, in una sola giornata il
Capitone è stato capace di bruciare la seconda carica dello Stato (che in
qualunque altro paese civile e incivile si sarebbe dimessa all’istante) e,
insieme all’altro scappato di casa Conte, propone il capo dei servizi segreti.
Ora gli stanno sparando contro tutti gli altri e la Belloni ben difficilmente ce
la farà. Per di più il Cavaliere è fuori di sé contro il king pippa Salvini e
medita di allearsi al Pd contro di lui. Per eleggere chi? Mattarella o Amato,
ovviamente.
Quirinale 2022, Laura
Boldrini e la frase su Elisabetta Casellati: "Non tutte le donne sono uguali".
Il Tempo il
28 gennaio 2022.
I tempi delle battaglie per
cambiare la vocale declinando tutto al femminine? Le guerre puniche contro gli
spot pubblicitari in cui la mamma porta a tavola la pirofila della pasta?
L’obiettivo dell’inclusione femminile nelle stanze dei bottoni? Tutto andato.
Se, ovviamente, c’è di mezzo il centrodestra.
Ieri Laura Boldrini, l’ex
presidente della Camera e oggi deputata Pd che aveva impostato il proprio
mandato da Terza Carica sulla valorizzazione del ruolo delle donne, ha
sonoramente bocciato la candidatura alla Presidenza della Repubblica di
Elisabetta Alberti Casellati, calata dal centrodestra e respinta dal voto
parlamentare. “E’ una candidatura di parte; anche in passato la Presidente
Casellati ha dimostrato di avere una connotazione di parte molto forte – ragiona
Laura Boldrini - è stata l’avvocato di Berlusconi, è stata eletta al Csm per il
centrodestra. Il centrosinistra chiede una figura super partes”.
Insomma, niente margine.
Niente riconoscimento, al di là delle differenze politiche, in favore di una
candidatura in rosa ufficialmente presentata da una coalizione che costituisce,
al di là dell’esito, una felice novità. Evidentemente, il dogma della
rivendicazione di genere, in qualche caso, si può anche spegnere.
Elezione presidente, lo
schianto dell’avvocatessa Casellati che si vedeva già al Quirinale.
Conchita Sannino su
La Repubblica il 29 Gennaio 2022.
I messaggi notturni ai
parlamentari della presidente del Seanto, la creazione in extremis di un gruppo
di ex 5S. E dopo il flop pensava di ripresentarsi allo scrutinio successivo.
Lui bluffava. Lei forzava. A
ogni costo. "E senza avere neanche l'airbag", chiosa il gruppetto di berluscones
lasciando il Transatlantico, mentre sul monitor scorrono le facce di Matteo
Salvini ed Elisabetta Casellati. E sarà anche cinismo da corridoio, ma diventa
subito storia di quest'avvilente vigilia il doppio schianto che - ieri mattina,
quinto scrutinio - lascia a terra il Capitano della destra senza direzione e la
presidente del Senato senza prudenza.
Casellati, cronaca di una
sconfitta: la voce alzata con Berlusconi, la lite con Tajani e le «certezze» su
Italia viva.
Marco Galluzzo su Il Corriere della Sera il 28 Gennaio 2022.
Anche dentro Forza Italia c’è
chi non l’ha votata per la carica di presidente della Repubblica: e questo ha
provocato nella presidente del Senato — che ha sperato con tutte le sue forze di
salire al soglio quirinalizio — sgomento e frustrazione.
Alla fine della votazione
sembra abbia un attimo di mancamento, lo percepiscono in pochi, ma un assistente
parlamentare si affretta a darle un sostegno fisico, offrendo il braccio. Esce
dall’Aula di Montecitorio senza dire una parola, quasi stordita per
una sconfitta prevedibile, temuta, ma che lei non si aspettava, almeno nelle
dimensioni.
Segue lo spoglio
della votazione che la dichiara sconfitta con ostentato distacco per le schede
che Roberto Fico le passa di mano: le prende ma non le guarda, ci pensano due
segretari deputati di centrodestra, dietro di lei. Il distacco però viene meno
quando scorrono quattro o cinque schede nulle, che osserva con curiosità, e
soprattutto quando uno dei voti va al suo capo di gabinetto Francesco Nitto
Palma: è una frecciata velenosa nei suoi confronti.
Incassata la
sconfitta Elisabetta Casellati , presidente del Senato, seconda carica dello
Stato, si chiude nei suoi uffici di Palazzo Madama e quasi interrompe le
comunicazioni con il mondo esterno. La botta, politica, è molto forte. Ai pochi
che la raggiungono confessa di sentirsi «tradita» dal suo partito, «sono stata
abbandonata» è la reazione carica di irritazione e insieme di delusione.
Eppure poche ore prima era
entrata a Montecitorio con almeno una speranza: «Sono una persona super partes,
non capisco perché dall’altra parte non partecipano al voto». L’obiettivo, suo
come di Casini e degli altri leader di centrodestra, era di arrivare ad almeno
410 o 420 voti, per ritentare poi alla sesta votazione. Ma l’asticella si è
fermata molto al di sotto, a quota 382 voti. Secondo i calcoli, considerando
anche gli assenti e i malati, i franchi tiratori sono stati almeno una
sessantina. Troppi, soprattutto per la seconda carica dello Stato.
Nonostante tutto, fosse stato
per lei, ci avrebbe anche riprovato nel pomeriggio. Le hanno spiegato,
rapidamente, che non era proprio il caso. «Ora le verrà la sindrome di
Berlusconi», sussurra con malizia e un pizzico di cattiveria una senatrice di
Forza Italia che non l’ha votata, subito dopo lo spoglio. Elisabetta Casellati —
la presidente del Senato che ha voluto e insieme subito il «blitz» lanciato
dalla sua coalizione per conquistare il Quirinale — ovviamente non ascolta i
sussurri che la circondano, i sorrisi di chi si compiace per l’esito,
disastroso, della sua candidatura. Nel suo entourage non parlano: c’è sgomento,
irritazione, frustrazione. E una bella dose di disorientamento.
Peggio non poteva andare.
Doveva essere una prova decisiva, di forza, di potenziale successo. E invece è
stata quasi una catastrofe. Ma in fondo la protagonista della propria sconfitta,
raccontano fonti di centrodestra, è stata proprio lei, la seconda carica dello
Stato. Giovedì sera c’erano molte perplessità sulla decisione di lanciarla in
modo formale in Aula, cercando una prova di forza con il centrosinistra. In
tanti nel suo partito non erano convinti, avevano previsto numerose defezioni,
erano a conoscenza dei rapporti deteriorati della Casellati con una parte del
suo stesso partito.
Eppure proprio lei si è
imposta, con caparbietà, anche alzando la voce nel corso di una telefonata con
Berlusconi, uno scambio di vedute non proprio sereno. Dentro Forza Italia
sapevano che ci sarebbero stati problemi: «In questi anni al Senato si è fatta
più nemici che amici», confida un parlamentare che la conosce bene, ma che
soprattutto conosce benissimo le senatrici azzurre che hanno con Casellati un
pessimo rapporto.
Persino con Antonio Tajani,
che aveva messo sul tavolo tutte le sue perplessità, avvisandola della
difficoltà dell’operazione, sembra che la presidente del Senato abbia litigato.
Eppure nelle ore che hanno preceduto l’inizio delle votazioni, nel corso delle
riunioni di giovedì notte, proprio lei non ne ha voluto sapere, fare un passo
indietro non era un’opzione.
Raccontano che agli
interlocutori che l’avvertivano di una partita in salita Casellati replicava di
essere certa che avrebbe avuto anche i voti di Italia Viva. Ha mandato lei
stessa messaggini, diverse decine, destinatari in tutto il centrodestra, per
chiedere di essere votata.
E invece le preferenze
ricevute da Mattarella, Casini e lo stesso Berlusconi sono state anche la cifra
di quanti le hanno fatto sapere, chiaramente, alla luce del sole, che non erano
con lei.
La giornata nera di
Elisabetta delusa dal "tradimento". E la sinistra va all'attacco.
Anna Maria Greco il 29
Gennaio 2022 su Il Giornale.
Casellati tra tanti dubbi e
l’orgoglio di presiedere lo spoglio. Poi la doccia gelata: a non rispettare i
patti sono stati gli amici. Lei è lì, sullo scranno più alto di Montecitorio
accanto a Roberto Fico che sta scrutinando le schede, per metterci la faccia.
Faccia impietrita dal tradimento dei suoi, reso evidente dall'astensione di
tutti gli altri. Anche Italia viva si allinea a Pd, M5S e Leu, tutti d'accordo
per non votare.
«Casellati-Casellati-Casellati-Mattarella-Casellati-Berlusconi-Casellati-Casellati-Tajani...».
I nomi scanditi dal Presidente della Camera e tra le mani di Maria Elisabetta
scivolano, una a una, le schede della sconfitta. Perché, alla fine, il conto si
ferma a 382 sì, mentre dovevano essere 450-457. Ce ne sono 8 per Berlusconi e 7
per Tajani, di azzurri che non l'hanno scelta. La pattuglia di franchi tiratori
si allarga soprattutto nell'Udc e in Coraggio Italia. E la polemica nel
centrodestra monta. «I nostri 208 voti sono stati compatti», dicono dalla Lega.
Fanno i conti grazie al modo di distinguersi tra i partiti scrivendo
diversamente il nome sulla scheda. Per loro, da Fdi e Nci sono arrivati 68
consensi, da Fi e Udc 94, invece di 139. Vittorio Sgarbi parla di 40-45 grandi
elettori di Fi e 20 di Ci che non hanno rispettato l'indicazione, dei totiani
«20 su 32 addirittura non hanno votato». E, se fosse vero che la seconda carica
dello Stato ha avuto anche voti di ex 5S, i franchi tiratori salirebbero a un
centinaio.
La presidente del Senato,
chiusa nel suo elegante tailleur pantalone blu, sembra diventare una statua di
sale mentre si delinea il quadro. Se fosse arrivata a 400 consensi sarebbe stata
riproposta alla seconda votazione della giornata, nel pomeriggio. Ma è ben al di
sotto, anche se ne servivano 505 per vincere. Eppure lei ha coraggio, ci crede
ancora, si metterebbe di nuovo alla prova, sostenendo che tra gli astenuti ci
sono voti che le erano stati promessi. Ma la coalizione decide di no, che ormai
è «bruciata».
Fino al giorno prima è stata
la stessa Casellati a insistere per misurarsi nelle urne, convinta di poter
avere anche consensi extra, si è data da fare con contatti diretti e indiretti,
telefonate e sms per assicurarsi l'appoggio nel suo partito, tra gli alleati e
oltre. La mattina di ieri, dicono, qualche dubbio l'ha assalita. Poi è arrivato
l'endorsement ufficiale di Silvio Berlusconi: «Da presidente del Senato, seconda
carica dello Stato, diventerebbe prima carica dello Stato - scrive sui social il
leader di Forza Italia -. La conosco da oltre 30 anni e posso garantire sulla
sua assoluta adeguatezza a questo ruolo super partes. Mi rivolgo ai parlamentari
di tutti gli schieramenti per chiedere loro di sostenere la Casellati». Matteo
Salvini intanto diceva: «Una donna delle istituzioni al Quirinale, un onore
proporla». E Giorgia Meloni: «Una candidatura meno politicizzata e più
istituzionale. I veti sarebbero incomprensibili».
Invece, è andata com'è andata.
E lei è amareggiata, delusa soprattutto dal tradimento degli «amici». La Meloni
fa fuoco e fiamme, chiede conto a Fi e ai centristi di quel buco di voti. La
sinistra fa polemica anche sul fatto che lei sia presente in aula mentre la
votano e allo scrutinio. «Non ci dovrebbe essere bisogno di ricordare Scalfaro
nel 1992. Il galateo istituzionale non è un optional», dice Stefano Ceccanti del
Pd. All'inizio del quarto scrutinio la presidente non arriva e si pensa che
rinunci, invece poi si siede serafica accanto a Fico e segue tutto lo spoglio.
Regge il flop con dignità, ma si vede che è provata. Infierisce l'ex 5S
Alessandro Di Battista, su Fb: «La Casellati dovrebbe dimettersi in quanto non
più meritevole di rappresentare la seconda carica dello Stato». Lei non ci pensa
proprio. Anna Maria Greco
Elisabetta Casellati, la
drammatica telefonata a Silvio Berlusconi: finisce malissimo, voci da Forza
Italia.
Libero Quotidiano il 28 gennaio 2022.
"È lei
la protagonista della propria sconfitta", si sfogano alcune fonti del
centrodestra commentando la sonora legnata che Elisabetta Casellati si è presa
durante il quinto scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica.
Doveva essere votata dal centrodestra compatto e invece ha raccolto solo 382
voto, ben al di sotto delle più pessimistiche aspettative. Del resto, pare che
la presidente del Senato non sia particolarmente amata dai colleghi
parlamentari, specialmente da quelli del centrodestra. Riporta il Corriere della
Sera in un retroscena che ieri sera 27 gennaio c'erano molte perplessità sulla
decisione di votarla in Aula, su questa prova di forza che è miseramente
fallita.
Ma sarebbe stata proprio la
Casellati a imporsi, arrivando pure ad alzare la voce durante una telefonata
con Silvio Berlusconi, con il quale ha avuto "uno scambio di vedute non proprio
sereno". Eppure all'interno di Forza Italia sapevano bene come sarebbe andata a
finire: "In questi anni al Senato si è fatta più nemici che amici", rivela un
suo collega, uno che la conosce bene e soprattutto sa quanto le senatrici
azzurre abbiano con lei un rapporto difficile.
E non solo ha discusso con il
Cavaliere ma pure con Antonio Tajani, che in tutta sincerità si era detto molto
perplesso, aveva litigato. La Casellati però era andata dritta e durante le
riunioni di giovedì notte si era detta non disponibile a fare un passo indietro.
Anzi, sosteneva di essere assolutamente certa che avrebbe ottenuto anche i voti
di Italia Viva e aveva mandato messaggi a chiunque per chiedere di essere
votata.
"Una corrida". “Chi sono i
franchi tiratori?”: caccia ai traditori di Casellati nel centrodestra in
subbuglio: “Salvini ha superato Bersani”.
Antonio Lamorte su Il
Riformista il 28 Gennaio 2022.
E adesso è caccia ai franchi
tiratori nel centrodestra. La coalizione è andata a sbattere, alla quinta
votazione per il 13esimo Presidente della Repubblica. Era stata scelta Maria
Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato, tra i fondatori di Forza
Italia. Quinta fumata nera in cinque giorni. Il centrodestra, guidato
dal kingmaker Matteo Salvini, segretario della Lega, riporta una batosta dura. È
la versione a destra dei 101 che impallinarono Romano Prodi, a sinistra, nel
2013.
La Presidente del Senato ha
ottenuto solo 382 voti sui 453 che avrebbero dovuto essere appannaggio del
centrodestra. Circa 60 in meno rispetto ai 441 astenuti, sempre del
centrodestra, di ieri. Il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, aveva
anticipato stamattina che sulla candidatura di Casellati si sarebbe insistito
anche nella seconda votazione, al via oggi pomeriggio alla Camera alle 17:00. È
improbabile a questo punto che il nome della Presidente del Senato venga
riproposto. Durissime le reazioni di alcuni esponenti del centrodestra dopo lo
scrutinio.
Duro, tra i più duri, il
commento di Osvaldo Napoli, ex azzurro e oggi deputato di Coraggio Italia: “Si è
scelto di esporre la figura della presidente del Senato, a cui va la mia stima,
nel torneo del Quirinale, nel frattempo trasformato in una corrida. Considero un
grave errore aver mandato allo sbaraglio la seconda carica dello Stato. Ho perso
il conto dei falò accesi con candidature di ogni tipo e genere, sempre e in ogni
caso espressione di una parte politica e mai una sola volta concordate con tutti
i gruppi parlamentari. Se questa era l’occasione per dimostrare la piena
legittimità del centrodestra a esprimere il presidente della Repubblica, si può
dire che è stata sprecata con grave danno per le istituzioni e il Paese”. È
invece ironico Elio Vito, deputato di Forza Italia che ha postato su Twitter la
foto del tabellone di Montecitorio che riportava la sua astensione e il
commento “spiaze …” perfino taggando la Presidente Casellati.
Il leader di Coraggio
Italia-Cambiamo Idea Luigi Brugnaro ha ammesso che “dopo Casellati non resta che
Draghi”. Fabrizio Cicchitto, ex fedelissimo berlusconiano e oggi presidente di
Riformismo e Libertà ironizza: “Salvini ha preso come esempio Bersani e dobbiamo
dire che davvero l’allievo sta superando di gran lunga il maestro”. Il
centrodestra è in subbuglio, in crisi. È andato a sbattere esponendo la seconda
carica dello Stato a una votazione disastrosa.
“Dove sono i franchi tiratori?
Scegliete voi – dice Ignazio La Russa, fondatore di Fdi – non certo in Fratelli
d’Italia e credo nemmeno nella Lega. I voti che ha espresso il centrodestra sul
nome autorevole del presidente del Senato sono inferiori ai propri numeri. C’è
qualcuno che se ne frega dei valori del centrodestra”. Sia il partito di Meloni
che quello di Salvini assicurano di aver votato Casellati. Coraggio
Italia-Cambiamo Idea conta soltanto 32 Grandi Elettori. Scintille davanti ai
cronisti tra La Russa e Toti.
“Chiediamo che Elisabetta
Casellati rassegni immediatamente le sue dimissioni da presidente del Senato”,
dichiarano i deputati di FacciamoEco Rossella Muroni, Andrea Cecconi, Lorenzo
Fioramonti, Alessandro Fusacchia e Antonio Lombardo. “Casellati si è
maldestramente prestata ad una operazione di parte, col risultato di inasprire
ulteriormente la situazione già tesa e rendere ancora più difficile il percorso
verso l’elezione di un Presidente super partes e stimato da tutti”. La prossima
votazione alle 17:00 accelera le trattative. La palla torna ai leader Salvini,
Meloni e Tajani. Berlusconi, ricoverato domenica scorsa dopo l’addio alla corsa
per il Quirinale, avrebbe sbarrato di nuovo la porta, ieri, al Presidente del
Consiglio.
Salvini oggi in conferenza
stampa, dopo il vertice di stamattina, aveva lasciato intendere che la carta
successiva poteva essere il Mattarella bis – il Presidente della Repubblica ha a
ogni occasione utile ribadito di non voler fare un altro mandato – ma anche
detto “nessun veto su Draghi”. Secondo indiscrezioni de Il Foglio adesso il
“Capitano” punterà su Elisabetta Belloni, prima donna a capo dei servizi
segreti. Gli alti nomi emersi oggi pomeriggio: quello del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, 48 voti, quello del membro del Csm Nino Di Matteo,
38. Qualche scheda a Tajani, Berlusconi e Cartabia.
Antonio Lamorte. Giornalista
professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha
frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha
collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura,
spettacoli.
Quirinale, errore a
Montecitorio: spunta una scheda in più dei votanti. Fico: "Il voto è valido".
La
Repubblica il 28 Gennaio 2022.
"È stata riscontrata una
differenza tra il numero dei votanti e il totale delle schede scrutinate di una
unità superiore a quella dei votanti, un numero superiore dovuto verosimilmente
al fatto che durante la distribuzione delle schede è stata erroneamente ricevuta
da un elettore una scheda in più depositata poi nell'urna", ma tale differenza
"è del tutto ininfluente ai fini del risultato del voto" e per questo "la
votazione svolta deve ritenersi pienamente valida". Così il presidente della
Camera Roberto Fico, prima di dare lettura dello scrutinio nell'aula di
Montecitorio.
Chi riscrive le regole a
ritroso.
Paolo Armaroli il 29 Gennaio 2022 su Il Giornale.
Tra le favole metropolitane
che circolano a Montecitorio c'è quella di un presunto precedente grazie al
quale il presidente del Senato Casellati non avrebbe dovuto sedere accanto al
presidente Fico durante lo spoglio delle schede di ieri mattina.
Tra le favole metropolitane
che circolano a Montecitorio c'è quella di un presunto precedente grazie al
quale il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati non avrebbe
dovuto sedere accanto al presidente Roberto Fico durante lo spoglio delle schede
di ieri mattina. Perché mai? Perché candidata alla presidenza della Repubblica.
Il precedente di Oscar Luigi Scalfaro non solo non è un precedente ma c'entra
come il cavolo a merenda.
I fatti nel 1992 andarono
così. Il 25 maggio 1992 il presidente Scalfaro, presidente della Camera e del
Parlamento in seduta comune, dichiara chiusa la 16ª votazione e prega il
vicepresidente Stefano Rodotà di procedere in sua vece allo scrutinio. E giù
applausi dei grandi elettori per il fatto che, nella sua veste di candidato
avviato alla vittoria, si assentasse proprio in quel momento.
Orbene, ciò che vale per
Scalfaro non poteva valere ieri per il presidente Casellati. Per la semplice
circostanza che quest'ultima è sì presidente del Senato ma in tale occasione non
è nell'esercizio delle sue funzioni. Il regolamento della Camera dispone: «Nelle
riunioni del Parlamento in seduta comune è riservato un seggio al presidente del
Senato». Non dice neppure dove debba essere collocato. Tuttavia, fin
dall'elezione di Einaudi nel 1948, il presidente del Senato, Ivanoe Bonomi,
siede accanto al presidente della Camera, Giovanni Gronchi.
Ne consegue che il presidente
Alberti Casellati potrebbe votare nella sua veste di componente del collegio
elettorale. È ben vero che una prassi in senso contrario si è affermata fin
dalla prima legislatura repubblicana. Ma essa è in contrasto con una
consuetudine che risale ai tempi in cui Francesco Crispi era presidente della
Camera. Nel 1877 si fece togliere dalla chiama per rimarcare la terzietà della
carica alla quale era stato preposto.
Se per ipotesi il presidente
Casellati si fosse assentata, non avrebbe potuto lasciare la poltrona a un
vicepresidente del Senato. Quest'ultimo non avrebbe avuto alcun titolo per
sedere vicino al presidente Fico. Il quale ha letto il solo cognome del
presidente del Senato. A dispetto del fatto che nella seduta dell'8 maggio 2006
il presidente Fausto Bertinotti aveva avvertito che è da escludersi che «la
presidenza possa dettare prescrizioni circa la forma con la quale ciascun
elettore è chiamato ad esprimere il proprio voto». Parole al vento, le sue, con
il senno di poi. Paolo Armaroli
Da Pera a Frattini, tutti i
nomi bruciati sul falò dei quirinabili.
Tommaso Labate su Il Corriere
della Sera il 28 Gennaio 2022.
«M a mica pretenderà di
parlare con me oggi? Proprio oggi, adesso?». La risposta arriva al terzo
squillo, una manciata di minuti dopo che il Parlamento ha riversato sulla
candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati una valanga di voti contrari.
Marcello Pera pare ancora inchiodato al riserbo proprio dei quirinabili, dei
protagonisti del totonomi, come se un alito di vento soffiasse ancora sulle sue
speranze di ritornare in campo; anzi di entrarci, visto che il suo nome —
incastonato nella terna ufficiale del centrodestra assieme a quelli di Letizia
Moratti e Carlo Nordio — non è mai nemmeno arrivato alla prova dell’Aula. È un
secondo, l’ex presidente del Senato si rende conto che quella finestra si è
chiusa; si rilassa, parla, come se si fosse liberato di un fardello. «A dire il
vero sono a casa, sto lavorando. Se devo essere sincero avevo la televisione
spenta, non ho seguito né i notiziari né l’ultimo scrutinio. Tutto qua, non
saprei che cos’altro aggiungerle...».
Al tramonto del giorno quattro
dell’elezione del capo dello Stato, quando il tabellone dell’Aula di
Montecitorio dà conto della sesta votazione, chiude il più clamoroso forno di
nomi quirinabili della storia repubblicana. Donne e uomini, garantisti e
giustizialisti, magistrati e avvocati, politici di medio e lungo corso, ex
presidenti del Consiglio, presidenti delle Camere attuali e del passato, ex
ministri, ex presidenti della Rai, accademici ordinari o associati o
semplicemente a contratto o in pensione, ministri di ogni ordini e grado,
vertici del Consiglio di Stato o della Corte costituzionale.
Una squadra di calcio,
panchina lunga compresa: Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio,
annunciati e mai schierati; Silvio Berlusconi, da cui i leader del centrodestra
pretendevano numeri che poi la candidata del centrodestra non ha visto nemmeno
col binocolo; Sabino Cassese e Giampiero Massolo, vittime delle citofonate a
sorpresa — a volte sussurrate, a volte smentite — di Matteo Salvini; e ancora, a
ritroso, Giulio Tremonti, nome spifferato da qualcuno del centrodestra, che
aveva e ha molti amici anche a sinistra; Franco Frattini, spuntato nel racconto
dell’ultima settimana come possibile anello di congiunzione tra Conte e Salvini;
Paolo Maddalena e Nino Di Matteo, beniamini della fronda degli ex grillini e
titolari di decine di voti validi nei primi scrutini. E poi c’è Andrea Riccardi,
il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, nome speso dal centrosinistra unito.
Che dice: «Io non sono stato un candidato di bandiera perché non sventolo la
bandiera di nessuno dei tre partiti che mi avevano indicato.
La mia candidatura era stata
proposta dai partiti di Enrico Letta e Giuseppe Conte al centrodestra. Ma, come
sapete, non è stata accolta. Vuole sapere come mi sento?», aggiunge
Riccardi. «Allora glielo dico. Sono onorato anche per il solo fatto di essere
stato indicato da un fronte rappresentativo di tanti italiani, un grande onore».
Disegnata da qualcuno come il
perverso incrocio tra l’antichissimo Dieci piccoli indiani e l’ultra
contemporanea serie tv sudcoreana Squid Game, la compilazione del TotoQuirinale
edizione 2021-2022 continua ad assomigliare più banalmente a un processo in cui
tante candidature, più che semplicemente bruciate, sono state rosolate,
scottate, biscottate, incenerite, passate e ripassate alla prova dei due forni
accesi e spenti a intermittenza da Salvini e compagnia. Ne sa qualcosa Pier
Ferdinando Casini, che resiste oltre l’ultima curva e che nella notte tra
mercoledì e giovedì era andato a dormire convinto di avere un mezzo via libera
del leader leghista. Poi c’è stato l’ennesimo ripensamento e l’ennesimo giro di
una giostra che forse si ferma e forse va avanti. Il fuoco brucia ancora, anche
se è solo una fiammella.
Fabio Martini per "la Stampa"
il 28 gennaio 2022.
Lo stallo dei Quirinale induce
Paolo Cirino Pomicino, uno dei protagonisti della fase finale della Prima
Repubblica, a concentrare il suo spirito critico: «Siamo alla caduta totale
della politica e la bulimia dei talk show aggiunge confusione a confusione anche
perché in queste sedi nessuno si interroga sulla questione essenziale: quali
sono le qualità richieste per un Presidente della Repubblica? Ecco perché escono
candidature improbabili: sei una grande avvocatessa? Sei una grande
ambasciatrice? Sì, allora puoi fare la presidente della Repubblica. Ma siamo
matti? Quanto si sente la mancanza di un neurologo in Parlamento!».
L'ipotesi che si possa passare
dalla guida dei Servizi alla Presidenza della Repubblica le pare una
sgrammaticatura?
«Con tutto il rispetto per
l'eccellente ambasciatrice Belloni, facciamo come Boris Eltsin che nominò come
successore il direttore dell'ex Kgb Vladimir Putin? Ma come si può immaginare
anche lontanamente a personalità come Paola Severino o Letizia Moratti? Ma cosa
c'entrano con la professionalità politica di un Presidente della Repubblica? Se
si va avanti di questo passo perché non chiamano il generale Figliuolo?».
Come se ne esce, secondo lei?
«Ci sono candidati adeguati,
Pierferdinando Casini, la presidente del Senato Elisabetta Casellati, il futuro
presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato. E Gianni Letta, che per
otto anni è stato sottosegretario alla Presidenza. Ma oltre a questi il più
adatto è Sergio Mattarella.
Se non si dovesse trovare
l'accordo, Mattarella non può non farsi carico dell'esigenza del Paese di avere
autorevolezza politica alla presidenza della Repubblica. Così come lui ha
chiesto un sacrificio a Draghi, devi chiedere un sacrificio a se stesso e
dichiararsi disponibile. In una situazione straordinaria, accanto ad un governo
straordinario, per ragioni straordinarie, serve un Capo dello Stato autorevole.
Col passare dei giorni sta diventando un dovere».
Mattarella vuole sinceramente
evitare il bis, ma non avendo mai detto «sono indisponibile», da uomo di Stato,
lascia uno spiraglio nel caso in cui il sistema andasse in blocco?
«Non c'è dubbio, è così. Lui
assomma un'esperienza positiva al Quirinale con una cultura
democratico-cristiana per cui in qualsiasi momento se il Paese chiama, tu
rispondi. Come ha fatto Draghi».
Soluzione "salvifica" ma al
tempo stesso non sarebbe la prova plastica di una politica impotente?
«Certamente. Nessuno può
negarlo. Ma alla crisi della politica si risponde con iniziative
straordinarie».
Pomicino, un conto sono gli
auspici, un conto le previsioni: come finisce?
«Sono convinto che se i capi
dei partiti - una volta verificato che non c'è un nome condiviso - dovessero
premere su Mattarella, io penso che il presidente non si limiterebbe al "chi ha
dato, ha dato».
Salvini ha eroso con una certa
abilità l'operazione-scoiattolo, ma potrebbe uscirne con risultati deludenti per
uno schieramento che ha la maggioranza relativa
«Se uno dovesse sintetizzare
con un'espressione un po' plebea, direbbe: non è mestiere suo. Lo ricordiamo
giovanissimo quando si dichiarava "comunista padano": non c'è più il comunismo e
neppure la Padania. D'altra parte per essere leader di un partito attorno al 20
per cento devi avere una cultura politica. Forse potrebbe mettere alla guida del
partito, un organismo collegiale, pur essendo il primus inter pares. Altrimenti
la Lega non va da nessuna parte e brucia la sua forza politica».
I protagonisti della Prima
Repubblica, come lei, avete quasi tutti un pregiudizio per Draghi al Quirinale?
«Draghi? Lo conosco benissimo,
ha lavorato per noi per quasi 2 anni. Abbiamo bisogno di un governo forte; ce
l'abbiamo e lo mandiamo via? Serve di nuovo il neurologo!».
Gli sbandati. La strategia
amatoriale di Salvini e gli egoismi dei leader sul Quirinale. Mario Lavia su
Linkiesta il 28 Gennaio 2022.
Il leader della Lega si è
autoassegnato il ruolo di regista dell’elezione del presidente della Repubblica,
ma sta combinando solo disastri. Oggi è il giorno della verità per uscire dalle
«nebbie» in cui i partiti si sono impantanati.
La mancanza di generosità: è
questo che colpisce in questa strana vicenda dell’elezione del Capo dello Stato.
È un momento che, al netto delle legittime aspirazioni di ciascuno,
richiederebbe un minimo di – non ci viene un altra parola – generosità.
Quel qualcosa che nei momenti
difficili dovrebbe essere nell’animo dei protagonisti, come è sempre stato nelle
fasi drammatiche della vita del Paese, perché sempre a un certo punto i partiti
hanno saputo guardarsi in faccia e deporre le armi. E invece non c’è generosità
perché nessuno si muove, aspettando la mossa dell’altro per farla a brandelli e
tuttavia prima che la casa bruci quel momento unitario sarà oggi, a detta di
tutti. A meno che non si voglia davvero infliggere un altro durissimo colpo alla
credibilità del sistema.
Ma come si risolve questo film
dell’orrore? Ieri sera, per riprendere il filo rosso del discorso sulla
generosità, prevalevano ancora gli egoismi, le furbizie, le bugie, peggio che su
un ballatoio di un caseggiato malfamato, un clima di tutti contro tutti, di
bocciature incrociate, sgambetti e ripicche.
Ne sono tutti responsabili ma
c’è uno che è più responsabile di tutti: Matteo Salvini, l’uomo che si è
autoassegnato il ruolo di Gianni Rivera pur essendo molto al di sotto della
bisogna, promettendo e smentendo in un colpo solo, diventando oggetto degli
strali di tre quarti del Parlamento – fino alla diagnosi di pazzia – e
marcatamente da parte di quella destra di cui si è impancato a leader.
Anche il degente Silvio
Berlusconi se n’è accorto, per esempio contraddicendolo quando il capo leghista
era parso sul punto di rimettere in pista Mario Draghi e il povero Antonio
Tajani è dovuto andare a Palazzo Chigi per spiegare al presidente del Consiglio
che «la linea di Forza Italia non è cambiata, lei deve restare a Palazzo
Chigi».
Dopodiché Salvini è tornato su
Franco Frattini, già affondato lunedì da Enrico Letta e Matteo Renzi
congiuntamente (chi se l’immaginava una sintonia così forte tra due leader che
certo non si amano), e ri-bocciato in serata dal Partito democratico, a
dimostrazione che sembra di essere in un infinito girotondo che sta estenuando
in primo luogo le centinaia di parlamentari che non hanno il benché minimo
ruolo, non sanno niente di niente e attendono disposizioni dai generali che però
si ingarbugliano tra loro e abbattono sistematicamente qualunque figura si
stagli all’orizzonte come i cecchini nelle guerre civili: e in questo Full metal
jacket recitato a Montecitorio ci hanno lasciato le penne personaggi illustri,
nomi come Sabino Cassese o Elisabetta Belloni (che resta in campo per Palazzo
Chigi nel caso Mario Draghi dovesse traslocare al Colle), dopo che quest’ultima
era parsa poter far quadrare il cerchio con il sì di Salvini, Meloni e Letta ma
bloccata da pezzi importanti del Pd, Renzi e Forza Italia a causa della sua
attuale collocazione alla guida dei servizi segreti (e il nome di Yuri Andropov,
il segretario del Pcus appunto capo del Kgb è stato fatto ironicamente da
molti).
In tutto questo non si capisce
bene cosa pensi il Movimento 5 stelle, che ormai sono tre o quattro M5s, un
gruppone di sbandati come quelli dei romanzi di Beppe Fenoglio, con un capo,
l’avvocato Giuseppe Conte, che occhieggia a Salvini e di cui il Pd con qualche
anno di ritardo comincia a diffidare ma che Letta non intende perdere per non
restare completamente solo: e però quando questa vicenda sarà chiusa è difficile
che non intervenga un chiarimento tra i due perni di un campo largo tutto da
costruire.
Oggi dunque è il giorno della
verità per uscire dalle «nebbie» (Bersani dixit). C’è sempre Draghi in campo, ma
che verrebbe eletto più per disperazione che per convinzione, con inevitabile
ammaccamento della propria immagine, ammesso e non concesso che superi
agevolmente i 505 voti necessari. Così come c’è, almeno in teoria, Sergio
Mattarella, che ieri è cresciuto ancora fino a 165 voti, un segnale netto che
molti parlamentari ritengono che a questo punto l’alternativa vera sia tra il
Presidente e il caos. E forse hanno ragione.
Capi e capetti politici non
sopportano la superiore qualità del premier.
PAOLO POMBENI su Il Quotidiano
del Sud il 27 Gennaio 2022.
I PARTITI hanno trasformato il
grande parlamento che deve eleggere il successore di Sergio Mattarella in un
labirinto da cui non si riesce ad uscire. Tutti attendono che qualcuno porga
loro il mitico filo di Arianna che li porti fuori, ma fino al momento in cui
scriviamo (martedì 25 gennaio ore 21) non vediamo traccia di qualcosa di simile.
Il problema fondamentale è,
come ormai hanno riconosciuto tutti, mettere insieme la soluzione del problema
Quirinale con quella del governo e non solo nel caso, che al momento non sembra
più molto probabile (ma in politica conta sempre l’ultimo minuto), in cui fosse
Draghi stesso a salire al Colle.
Il tema di fondo è che la
soluzione trovata a febbraio scorso da Mattarella per risolvere la crisi di
impotenza delle forze politiche rimane fortemente legata alla presenza chiave di
Draghi, personalità capace di imporsi su una coalizione molto larga, ma anche
all’equilibrio da lui trovato nella distribuzione dei ministeri. Intendiamoci:
non tutte le scelte sono state meravigliose, non tutto funziona alla perfezione,
ma non riusciamo a convincerci che ci siano le condizioni per ridisegnare in un
modo migliore la compagine dell’attuale esecutivo.
Anche se ci sono state le
smentite di prammatica, le indiscrezioni parlano del fallimento del tentativo di
alcuni partiti (Salvini, forse Conte) di negoziare con Draghi l’assetto che
avrebbe preso il futuro governo nel caso l’attuale premier fosse diventato il
successore di Mattarella. Era chiaramente un negoziato impossibile, perché il
futuro capo dello Stato non può certo impegnarsi dando garanzie che non sono nei
suoi poteri. È una leggenda che spetterebbe a lui scegliere il suo successore,
perché il presidente fa le consultazioni di cui deve tenere conto, accettando
quanto gli viene proposto se c’è una almeno relativa certezza che ci sia una
maggioranza a sorreggerlo, o interpretando quale direzione ricavarne se la
situazione si presenta confusa. Non è in suo potere distribuire i posti dei
ministeri: può esercitare qualche veto su certi profili se non corrispondessero
agli indirizzi ed impegni presi dal nostro stato, può suggerire qualche nome, ma
se non viene accolto non può imporlo.
Per queste ragioni tutti sanno
che una volta dimessosi Draghi, perché così deve fare per dettato costituzionale
nel caso di una sua elezione al Quirinale, cadrebbe l’intero governo ed i
negoziati per costruirne uno nuovo sarebbero più che difficili. Non si
dimentichi che ormai siamo entrati in un tunnel elettorale, con le
amministrative intorno a maggio e poi le politiche al più tardi nella primavera
del prossimo anno. Dunque si tratterebbe di costruire un governo che più che
essere la prosecuzione di quello oggi in carica, sarebbe un esecutivo
pre-elettorale a tempo: sappiamo bene cosa significhi una prospettiva del
genere.
Per queste ragioni mentre
scriviamo si è indebolita la prospettiva di inviare Draghi al Colle: certamente
anche per varie “antipatie” di capi e capetti politici che non sopportano la
superiore qualità del premier, ma soprattutto per il timore dei più responsabili
di cacciarsi in una trappola che potrebbe portarli ad uno scioglimento precoce e
traumatico della legislatura, perché cos’altro resterebbe da fare al nuovo
presidente della repubblica se non sciogliere le Camere di fronte ad una
ingestibilità degli equilibri parlamentari? Dunque il tema torna ad essere
quello di individuare una candidatura per il Quirinale che possa lasciare in
vita l’attuale governo e anzi possa continuare a fargli da scudo come è avvenuto
con Mattarella. L’esigenza di evitare assolutamente una figura “di parte” deriva
proprio dalla debolezza del quadro politico attuale.
Se esso avesse una sua
stabilità, non si temerebbe che dal Colle si potessero ridisegnare gli
equilibri. Ma poiché già adesso quell’equilibrio non esiste e soprattutto è più
che oscuro quello che emergerà dal voto quando saranno state chiuse le urne, è
più che comprensibile che i gruppi dirigenti dei partiti si arrovellino su come
garantirsi un Capo dello Stato che non solo non sia portato a privilegiare una
parte contro le altre, ma anche che sia alieno da tendenze per così dire
“creative” quando si misurerà con le crisi future (ci sono esperienze non felici
in casi simili …).
La scarsità di soluzioni
disponibili è un fattore da non trascurare. Se ci fossero alcune persone che
danno se non le garanzie, le aspettative di agire con l’unione di competenza,
esperienza, e saggezza di fronte ai difficili passaggi che aspettano questo
paese (per la pandemia, per i problemi dell’economia, per le situazioni di
tensione internazionale, per le tensioni sociali esistenti), sarebbe possibile
costruire un consenso trasversale. Tutti sanno che l’opinione pubblica è poco
disponibile a star a guardare i giochetti tattici dei politici, ma tutti temono
di cadere nella trappola di soluzioni insoddisfacenti da vari punti di vista.
Adesso è impossibile prevedere come andrà a finire, o almeno noi non siamo in
grado di farlo.
Temiamo che comunque vada non
avremo una soluzione che sia conclusiva dei nostri problemi di equilibrio e
stabilità: bisognerà che ci si lavori ancora e con la dovuta pazienza nel
prosieguo della nostra vita istituzionale.
Tommaso Montesano per "Libero
quotidiano" il 28 gennaio 2022.
Netto a parole. Possibilista
nei fatti. Sull'ipotesi che il presidente della Repubblica - quindi se stesso -
possa essere rieletto, il Sergio Mattarella capo dello Stato, almeno
ufficialmente, non ha mai lasciato aperto alcuno spiraglio. In ogni circostanza
pubblica, sia quella più formale che quella più conviviale (si pensi ai discorsi
tenuti di fronte agli studenti), il Presidente uscente è sempre stato netto: non
se ne parla.
Eppure, a scavare negli
archivi, salta fuori qualcosa che contraddice il "Mattarella pensiero" delle
ultime settimane. Un'intervista rilasciata al Corriere della Sera alla vigilia
del voto per la successione ad Oscar Luigi Scalfaro, ad esempio. È il 1999 e il
capo dello Stato dell'«io non ci sto», il nome più inviso al centrodestra,
allora all'opposizione come "Polo delle libertà", si avvia a concludere il
settennato sul Colle. E la maggioranza di centrosinistra, l'Ulivo, è alle prese
con la scelta del successore.
I numeri sono dalla parte dei
"progressisti", di cui Mattarella è all'epoca uno dei leader parlamentari in
qualità di capogruppo a Montecitorio del Partito popolare italiano, il Ppi, uno
degli eredi della Dc. Epperò Mattarella, forse per evitare brutte sorprese,
lancia agli acerrimi avversari guidati da Silvio Berlusconi un'offerta: «Perché
non rieleggiamo Scalfaro al Quirinale?».
Certo, ammette il presidente
dei deputati popolari, «è vero che anche da soli avremmo la possibilità di
eleggere il capo dello Stato», però «un'ampia convergenza» non è mai una brutta
cosa.
Se non altro perché taglia la
testa al toro. Così Mattarella la butta là e, pur consapevole di come il
centrodestra non ami - eufemismo - Scalfaro, lancia la proposta: settennato bis
per il Presidente uscente in cambio, ecco l'offerta, «di una rinnovata intesa
sulle riforme», a partire da quella per l'elezione diretta del presidente della
Repubblica.
Insomma: il Mattarella
intransigente di oggi sulla rielezione, 23 anni fa proponeva un patto al
centrodestra: Scalfaro ancora sul Colle in cambio di un «accordo» sulla nuova
versione della Costituzione, introducendo quel presidenzialismo tanto caro -
oggi come allora - al centrodestra. Un'offerta che cadrà nel vuoto, visto che il
13 maggio 1999 sarà eletto alla prima votazione Carlo Azeglio Ciampi.
Batosta Casellati, Matteo
Salvini cerca una soluzione. Qualunque.
La presidente del Senato
prende solo 382 voti, almeno 70 franchi tiratori. Il leader della Lega apre a
qualsiasi ipotesi: persino al trasloco di Draghi («non c’è un veto»), mentre in
Transatlantico si parla anche di Mattarella (e Casini). Adesso il boccino è in
mano all’uomo del Papeete, che sembra il più confuso di tutti. Susanna Turco su
L'Espresso il 28 Gennaio 2022.
Il verdetto dell’Aula è
impietoso. Almeno 70 franchi tiratori affossano la candidatura di Maria
Elisabetta Alberti Casellati, proposta in mattinata dal centrodestra: la
presidente del Senato si ferma a 382 preferenze, molto sotto i 452 Grandi
elettori attribuibili al centrodestra, ma anche sotto l’asticella di 400,
considerato informalmente il numero minimo per riproporre il suo nome.
«Una vera batosta», commenta
prima di tutti il dem Emanuele Fiano, che esce dall’Aula sventolando il suo
personale conteggio dei voti, prima della proclamazione ufficiale.
Quirinale 2022, l’imbarazzo
della Belloni finita nel tritacarne della politica.
Giuliano Foschini su La
Repubblica il 29 Gennaio 2022.
La direttrice del Dis
sorpresa, pensava di essere uscita dai giochi ed era andata fuori Roma.
Sono giorni che Elisabetta
Belloni prova a sottrarsi. Non dalle responsabilità, cosa che non ha mai fatto
nella sua lunga carriera da servitrice dello Stato. Ma dal tritacarne nel quale
è stata - da domenica scorsa, quando per la prima volta il suo nome venne fuori
come possibile sostituta di Mario Draghi a Palazzo Chigi - suo malgrado spinta.
Proposta da Conte al tavolo
con Salvini e Letta, la candidatura della direttrice del Dis ha mandato su tutte
le furie Renzi, Di Maio e mezzo Pd.
Rocco Vazzana su Il Dubbio il
29 gennaio 2022.
Hanno aspettato con pazienza
che Matteo Salvini andasse a sbattere contro il voto impietoso dell’Aula, Enrico
Letta e Giuseppe Conte, prima di entrare finalmente in partita. E così, dopo
cinque lunghissimi giorni di “catenaccio”, segnati dall’immobilismo e diffidenze
reciproche, il centrosinistra ha costretto il capo dello schieramento avverso a
sedersi a un tavolo per individuare insieme il prossimo presidente della
Repubblica. «I preliminari sono finiti, abbiamo finalmente iniziato a parlarci»,
ha detto soddisfatto il segretario del Pd uscendo dall’incontro col presidente
del Movimento 5 Stelle e col numero uno della Lega avvenuto subito dopo la
bocciatura di Maria Elisabetti Alberti Casellati. Un trauma per il centrodestra,
uscito con le ossa rotte dalla prima votazione con un candidato vero in campo.
E ora che i giallo- rossi
hanno mostrato l’inconsitenza numerica della coalizione guidata da Salvini,
l’obiettivo prioritario di Letta sembra alla portata: trovare un Capo dello
Stato che vada bene a tutti e, soprattutto, che non decreti vincitori e
sconfitti. Il pareggio tanto inseguito potrebbe arrivare a breve. Sempre che non
salti tutti con estrema velocità. Sì, perché dall’incontro a tre si è imposto un
nome: quello di Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza, già entrata nella rosa dei papabili qualche
giorno fa e poi accantonata per mancanza di dialogo. E di requisiti, secondo
alcuni, considerato il ruolo ricoperto dalla “candidata”, che passerebbe dalla
guida dei Servizi segreti alla guida dello Stato. Proposta al tavolo giallo-
rosso- verde da Giuseppe Conte, Belloni garantirebbe la terzietà invocata da
tutti ma per il centrosinistra non sarebbe comunque una passeggiata convincere
tutti a votarla. E non solo per l’opposizione manifesta e decisa di Matteo
Renzi, che in serata dichiara senza mezze misure: «Non penso che sia minimamente
possibile votare la capo dei Servizi segreti alla presidenza della Repubblica:
non sta né in cielo né in terra. Se è il suo nome proporremo di non votarlo»,
dice il leader di Italia viva a Radio Leopolda.
Ci sono ben altri ostacoli da
aggirare. A cominciare dalla reazione infastidita che la sua elezione potrebbe
provocare in Mario Draghi, dal primo momento candidato mai dichiarato per la
corsa al Colle, che si vedrebbe scavalcare da una dirigente da lui appena
nominata. E per lo stesso motivo il nome Belloni fa andare su tutte le furie
Luigi Di Maio, ufficialmente grande estimatore dell’ex segretario generale della
Farnesina, ma convinto sostenitore del trasloco del premier al Quirinale. Non
solo, nell’ottica della faida interna ai 5S, il ministro degli Esteri non ha
alcuna intenzione di fare uscire politicamente vico Giuseppe Conte dal Quirinal
Game. Un motivo in più per impallinare la candidata.
Lo stesso Partito democratico
reagisce con freddezza all’opzione Belloni. Gli ex renziani non sembrano affatto
entusiasti, anzi lasciano trasparire tutto il loro disappunto senza dissimulare.
E da Liberi e Uguali, formazione tenuta fuori dal summit pomeridiano, commentano
così: «Con tutto il rispetto per la competenza e la capacità di Elisabetta
Belloni, in un Paese democratico è assolutamente inopportuno che il capo dei
servizi segreti diventi presidente della Repubblica. Allo stesso modo non è
accettabile che la presidenza della Repubblica e la guida del governo siano
affidate entrambe a personalità tecniche e non politiche».
Insomma, messa così, la
candidatura di Belloni sembra già tramontata prima di nascere. Forse anche per
questo Letta non ha rinunciato a mostrare a Conte e Salvini anche gli altri nomi
appuntati sul suo foglio: Amato, Draghi e Casini. Puntando, forse, solo sul
primo, visto che il premier non gode esattamente dei favori giallo- verdi e
Casini non è lo sbocco sperato dallo stesso segretario dem, indisponibile a
incoronare presidente il candidato di Matteo Renzi.
Non resta che cercare altrove.
Per trovare un’altra donna. O per assicurarsi un garante vero. E chissà che alla
fine non convergano davvero tutti su Sergio Mattarella, che ieri ha fatto ancora
il pieno di voti nel centrosinistra ufficialmente indirizzato sulla scheda
bianca: 336 preferenze, che sommate alle 46 della prima votazione, quella a cui
ha partecipato solo il centrodestra, fanno 382. In totale gli stessi voti
ottenuti da Casellati, senza essere però candidato. Un segnale dei grandi
elettori ai loro leader.
“La forzatura. "È più
facile che una chioccia faccia un uovo che qua esca il Presidente della
Repubblica".
Mastella show tra l’uovo e l’attacco alla Lega: “Casellati
stronzata incredibile, Salvini si dimetta da leader”. Redazione su Il Riformista
il 28 Gennaio 2022.
Tra una fumata nera e
l’altra, Clemente Mastella è sicuramente uno dei protagonisti dei giorni caldi
per la politica italiana, divisa più che mai per l’elezione del 13esimo
presidente della Repubblica. Il sindaco di Benevento è ormai ospite fisso,
davanti a palazzo di Montecitorio, della maratona Mentana in onda su La7.
Presente a Roma da lunedì scorso in veste di accompagnatore della moglie, la
senatrice Sandra Lonardo, e in veste di leader del partito “Noi di centro” (che
vanta un Grande Elettore, ovvero la Lonardo), l’ex ministro della Giustizia ne
ha per tutti.
Fautore della candidatura del
centrista Pier Ferdinando Casini, Mastella ha attaccato duramente Matteo Salvini
per la candidatura, poi bruciata, della presidente del Senato Maria Elisabetta
Casellati: “Se fallisce con Casellati Salvini si dimetta da leader”
“A Berlusconi dico ‘Sta casa aspetta a tte!’. E’ un gigante rispetto al modo in
cui si stanno comportando gli altri leader”.
Poi attacca il segretario
della Lega: “Le prove di forza si fanno quando si ha la forza di mettere al
tappeto l’avversario altrimenti mettere a repentaglio un’istituzione come il
presidente del Senato è una stronzata incredibile. Se Salvini riesce a
recuperare voti da altre parti allora è un grande leader altrimenti il leader
diventa un altro – aggiunge – rispetto a questi Berlusconi è un gigante”.
Poi il siparietto durante la
maratona Mentana dove Mastella si presenta “armato” di un uovo: “Bisogna anche
un po’ sdrammatizzare perché se dovessi valutare quello che sta accadendo in
Parlamento è veramente una ipoteca alla via dell’inferno della politica e
dell’attività parlamentare”. Poi il sindaco tira fuori l’uovo e spiega: “Vede
questo uovo? L’uovo di Colombo, in questo caso l’uovo di Mastella, quindi una
tesi mia. È più facile che una chioccia faccia un uovo che qua esca il
Presidente della Repubblica”.
Poi Mentana scherza: “Resti
con noi che dobbiamo andare in pubblicità! Ci hanno detto: Mastella tira
tantissimo, tenetelo perché con lui gli ascolti vanno alle stelle. Lei è per noi
quello che Corona per la Berlinguer. Resti lì e poi stasera venga ospite qui da
noi”.
Se non sono i grillini a
lamentarsi delle accuse di demagogia alla politica.
Andrea Cangini il 29 Gennaio
2022 su Il Giornale.
Tra la quinta e la sesta
votazione, i grandi elettori dotati di piccoli poteri percepiscono che l'ora
delle decisioni fatali è prossima.
Tra la quinta e la sesta
votazione, i grandi elettori dotati di piccoli poteri percepiscono che l'ora
delle decisioni fatali è prossima. Prossima, ma ignota. Tutti comprendono che
con la settima votazione si dovrebbe aprire una strada, nessuno saprebbe dire
dove porterà. Come gattini ciechi, non ci resta che dare sfogo al malumore
crescente mettendo a nudo le rispettive contraddizioni tra una sigaretta, un
caffè e un supplì (eccellenti i supplì della Camera, addentati con malcelata
invidia dai senatori alla prima esperienza culinaria a Montecitorio). Un grande
elettore leghista di rito giorgettiano vaticina per Salvini la fine che fece
Bersani una volta dissipato il ruolo di king maker sette anni fa. «Dopo il
nobile ritiro di Berlusconi - dice - avrebbe dovuto cambiare gioco, invece, per
paura della Meloni, ha insistito sul candidato di centrodestra. E ha fallito».
Il fallimento viene descritto con accenti da tragedia greca, o, meglio, da mito
biblico. La seconda carica dello Stato, diceva un grande elettore centrista a
ridosso del primo voto, «si presenta all'Aula nel ruolo di agnello sacrificale,
propiziatorio di scenari successivi». Il centrodestra come Abramo, la Casellati
come Isacco e nessuno ad incarnare Dio che ne ferma la mano. Ma poi, quali
sarebbero gli «scenari successivi»? Sul punto, sia pure alla cieca, grandi
elettori dotati di piccoli poteri concordano: Casini o Mattarella Draghi no.
Draghi è prezioso dov'è. E, come dice un grande elettore del Pd di affiliazione
franceschiniana, «questo insistere per migrare al Colle rischia di far scadere
la sua scelta di sacrificarsi per la nazione in un calcolo di carriera
personale». Affermazione sottoscritta a malincuore da più d'uno tra i grandi
elettori draghiani presenti nel capannello in Transatlantico.
Ma l'opera di disvelamento è
solo all'inizio. Un grande elettore grillino ammettere l'incongruenza di
impallinare una donna dopo aver invocato una donna. «Che figura ci facciamo?»,
domanda senza aspettarsi una risposta. Che poi, se la Casellati ce l'avesse
fatta avremmo dovuto chiamarla «capa dello Stato»?, si interrogava in mattinata,
ironizzando sull'ossessione della parità di genere, il grande elettore forzista
Andrea Orsini. E Letta? «Enrico ha giocato di rimessa sul centrodestra per
mascherare il fatto che il Pd, come il Movimento 5stelle, era diviso e non ha
mai avuto un nome da proporre. Anche stavolta, è stato salvato da Salvini»,
ammette un dem. E Fico? «Ci sono voluti quattro giorni per fargli capire che,
con i venti di antipolitica che spirano, era necessario prevedere non una, ma
due votazioni al giorno per dimezzare i tempi e con i tempi le accuse di
cialtroneria che ormai tutti i demagoghi dei media indirizzano al Parlamento»,
lamenta un grillino. Si conclude cosi, col pentastellato che denuncia
l'antipolitica la nemesi di una giornata «storica» trascorsa nell'attesa che la
Storia si compia. Sopra le nostre teste, naturalmente. Andrea Cangini
Colle, spunta l'sms che ha
sedato la "rivolta" da cortile dei peones.
Andrea Cangini il 28 Gennaio
2022 su Il Giornale.
Nel cortile di Montecitorio,
un drappello trasversale di grandi elettori era impegnato nel passatempo tipico
di ogni peone nei giorni convulsi in cui si elegge il presidente della
Repubblica: fare a pezzi il proprio leader. Poi...
Ma chi l'ha detto che i grandi
elettori sono un branco di ignoranti, fisiologicamente preda di impulsi politici
irrazionali? Evidentemente deluso dalla gestione bicefala delle trattative
quirinalizie che caratterizza il proprio partito, un grande elettore del Pd ieri
ha stupito tutti citando nientemeno che le sagge parole del re di Sicilia Carlo
d'Angiò. Era l'ora di pranzo, ma la tensione e il disorientamento generali non
incoraggiavano al desco. Nel cortile di Montecitorio, un drappello trasversale
di grandi elettori era impegnato nel passatempo tipico di ogni peone nei giorni
convulsi in cui si elegge il presidente della Repubblica: fare a pezzi il
proprio leader, ridicolizzandone la strategia. Uno dopo l'altro, ciascuno
biasimava le scelte o le mancate scelte del proprio segretario politico o di
questo o quell'uomo forte del proprio partito, mentre gli altri annuivano
vistosamente. Poi, a turno, l'interlocutore veniva interrotto da un vicino di
capannello, che gli rubava la scena con la consueta premessa: «Hai ragione, ma
non sai cosa ha detto il mio...». E giù aneddoti e rivelazioni a rimarcare senza
pietà alcuna né umana comprensione l'inadeguatezza dell'ufficiale in comando.
Fiutata l'aria, e constatato che il comune sentire alludeva ad un male comune,
il grande elettore democratico ha così inteso alzare il livello di una
discussione ormai prossima allo sfogo isterico: «Cari amici, lo sapete cosa
rispose Carlo d'Angiò al messo che, dandogli notizia della rivolta scoppiata in
una città siciliana, gli disse che ad insorgere era stato un manipolo di
pazzi?». Con una tempistica da consumato uomo di teatro, l'oratore ha lasciato
che alcuni interminabili secondi fossero occupati dall'imbarazzato silenzio
degli astanti e poi, con tono grave, ha loro offerto l'agognata risposta: «Ma i
savi cosa facevano?"» La porta aperta fu così sfondata, le polveri infuocate.
Uno ha citato Bismark («La politica è l'arte del possibile»), un altro ha citato
Seneca («Per trovare la via a cose più grandi, il saggio farà anche quello che
non approverà»), un terzo ha citato Balzac (ma l'ha citato in francese, perciò
non ho capito nulla). Tutti noi peones abbiamo concordato sul fatto che in un
parlamento di minoranze è demenziale accreditare la possibilità di una vittoria
di parte, che leader timorosi e deboli non possono che generare soluzioni
parziali e precarie, che se le persone di buonsenso come noi di tutti i partiti
si coalizzassero avremmo già insediato il migliore tra i presidenti possibili.
Poi, uno dopo l'altro, ciascuno di noi ha ricevuto un sms di convocazione e,
infilata la coda tra le gambe, ha salutato l'indomita combriccola per recarsi a
pie' veloce dove era stato comandato. Andrea Cangini
Di Matteo al Quirinale? Il
magistrato che gli ex 5 stelle vorrebbero presidente.
VANESSA RICCIARDI su Il Domani
il 27 gennaio 2022.
Il pm che ha seguito le
indagini sulle stragi di Falcone e Borsellino e sulla trattativa stato
mafia vive sotto scorta per le minacce di morte dei padrini della mafia
siciliana. Un personaggio che divide garantisti e giustizialisti
Il gruppo degli ex 5 Stelle
che compongono “l’Alternativa” ha deciso che per il Quirinale il nome giusto è
quello di Nino di Matteo, il pm antimafia che ha indagato sulle stragi dei
giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e in seguito sulla trattativa
stato-mafia.
Segui il liveblog di Domani
sulle elezioni del presidente della Repubblica con tutti gli aggiornamenti in
diretta
Nato a Palermo nel 1961, 60
anni, vive sotto protezione per le minacce dei boss: lo stesso Totò Riina, il
«capo dei capi» durante l’ora d’aria nel carcere di Opera di Milano nel 2014
disse di volergli far fare «la fine del tonno». L’ordine di ucciderlo secondo
alcuni pentiti sarebbe stato rinnovato anche dal super latitante Matteo Messina
Denaro.
LA STORIA
Entrato in magistratura nel
1991 come sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di
Caltanissetta è poi diventato pubblico ministero a Palermo nel 1999. Nel 2019 è
diventato membro del consiglio superiore della magistratura. Il Corriere della
sera lo ha definito un «magistrato divisivo» perché in prima linea non solo
nella lotta alla criminalità ma anche sui temi che riguardano la giustizia e la
politica, da ultimo le critiche per la candidatura poi sfumata di Silvio
Berlusconi al Quirinale.
BERLUSCONI
A novembre, Di Matteo
suscitando l’indignazione di Forza Italia, ha sottolineato che il presidente
della Repubblica è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura.
Senza voler esprimere giudizi politici, il Pm invitò a riflettere se Berlusconi
fosse o no adatto a quel ruolo e ha ricordato che secondo quanto emerso da una
sentenza definitiva su Marcello Dell’Utri, che, hanno certificato i giudici, fu
intermediario di un accordo tra il 1974 e il 1992 con le famiglie mafiose
palermitane. Un patto che in cambio della protezione personale e imprenditoriale
di Berlusconi prevedeva il versamento di somme ingenti di denaro da parte del
Cavaliere a Cosa Nostra.
BONAFEDE E CARTABIA
Le critiche di Di Matteo
prescindono dal colore politico. Nel 2019, su La 7, Di Matteo ha raccontato che
a fine giugno 2018 era stato contattato dal Guardasigilli, Alfonso Bonafede
(M5s), per diventare nuovo il capo del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria (Dap) ma «il ministro mi fece capire che per la soluzione di capo
del Dap aveva ricevuto delle prospettazioni di diniego o mancato gradimento» ha
ribadito poi in commissione parlamentare Antimafia. Per lui era «gravemente
incomprensibile il comportamento del ministro».
Di recente è tornato a
esprimersi sulla riforma della giustizia che ha spaccato il Movimento cinque
stelle. Secondo Di Matteo la politica ha rinunciato alle sue responsabilità per
«usare i magistrati come alibi» e - sottolineava Di Matteo - sta discutendo
una «pessima riforma» della Giustizia presentata dalla ministra Marta Cartabia,
che «rischia di mandare in fumo tanti processi». Nel dibattito alle Camere sono
arrivati aggiustamenti ma «Io continuo a ritenere che nonostante i correttivi,
complessivamente la riforma Cartabia sia una pessima riforma».
Il gruppo di fuoriusciti del
Movimento 5 stelle ha deciso così di abbandonare la candidatura di Paolo
Maddalena, ex vice presidente della Corte costituzionale, per puntare tutto sul
magistrato simbolo del processo stato-mafia.
VANESSA RICCIARDI. Giornalista
di Domani. Nasce a Patti in provincia di Messina nel 1988. Dopo la formazione
umanistica tra Pisa e Roma e la gavetta giornalistica nella capitale, si
specializza in politica, energia e ambiente lavorando per Staffetta Quotidiana,
la più antica testata di settore.
Famosa la legge che porta
il suo nome. Chi è Paola Severino, ex ministro della Giustizia candidata a
presidente della Repubblica.
Redazione su Il Riformista il
28 Gennaio 2022.
Ex ministro della Giustizia,
73 anni, il nome di Paola Severino riemerge tra quelli dei potenziali candidati
a diventare presidente della Repubblica.
Nata a Napoli il 22 ottobre
1948, Paola Severino è un’ex ministra ed è un’accademica italiana,
vicepresidente dell’Università LUISS Guido Carli. Laureata in Giurisprudenza
presso l’Università La Sapienza di Roma. Dopo la laurea inizia la sua esperienza
accademica. Dopo l’esperienza a Perugia, nei primi anni 2000 diventa Preside
della Facoltà di Giurisprudenza alla Luiss. Dal 2016 al 2018 diventa Rettrice
dell’Università, della quale diventa poi Vicepresidente.
Severino ha portato avanti
anche la sua attività di avvocato. È storia il processo nel quale difese Romano
Prodi rimasto coinvolto nella vendita della Cirio. Ma questo è solo uno dei
processi di spicco nella carriera di Severino, che ha prestato assistenza legale
anche per colossi del calibro di Telecom ed Eni.
Tra la fine degli anni Novanta
e i primi anni Duemila, Paola Severino ha ricoperto la carica di vice-presidente
del Consiglio della magistratura militare. È stata la prima donna a ricoprire
questo incarico. Dal 2011 al 2013 Paola Severino è stata ministra della
giustizia nel governo tecnico guidato da Mario Monti. Anche in questo caso si
tratta della prima donna ad aver rivestito questa carica.
Storica la legge Severino,
così come è passata alla storia, ossia la legge che prevede l’incandidabilità e
il divieto di ricoprire cariche di governo (e cariche elettive) per soggetti
condannati in via definitiva per delitti non colposi.
A causa di una grave malattia,
Paola Severino ha subìto l’amputazione di un braccio. “So che vuol dire avere a
che fare con chi ti guarda e ti chiede: che cosa ha fatto al braccio? O dice: mi
farei tagliare un braccio per riuscire a …, oppure ti fissa e non ti toglie gli
occhi di dosso […]. Ma chi deve superare un handicap affronta la vita con lo
spirito di dire: devo fare tutto, posso fare tutto. Io senza un braccio ho anche
giocato a tennis“, aveva dichiarato Severino in un’intervista rilasciata a La
Repubblica.
Luca Mazza per “Avvenire” il
29 gennaio 2022.
Quando poco dopo le 20
Giuseppe Conte esce da Montecitorio ha l'aria sollevata di chi si sente vicino a
centrare un doppio obiettivo politico che, soltanto poche ore prima, sembrava
insperato: mantenere Mario Draghi a Palazzo Chigi e impedire una spaccatura
fragorosa del Movimento 5 stelle sul voto del nuovo capo dello Stato.
Anzi, sulla prossima
presidente della Repubblica. «Ho l'impressione che ci sia la sensibilità di
Salvini, spero di tutto il Parlamento, per la possibilità di una presidente
donna - afferma il leader dei pentastellati -. Alla fine vedrete che il M5s sarà
la forza più compatta se riusciremo a portare tutte le altre forze politiche
verso un presidente donna, che mi farebbe tanto piacere ».
Al tavolo delle trattative con
Matteo Salvini ed Enrico Letta c'è stato «non solo un nome femminile, ma più
d'uno. Perché l'Italia ha tantissime risorse che meritano di essere elevate a
quest' alta carica», precisa il capo politico. Nonostante il tentativo di tenere
coperta la carta e non svelare un nome, è evidente che in pole c'è Elisabetta
Belloni. Come alternative femminili si ragiona anche su Paola Severino
(considerata 'votabile' dal M5S) e Marta Cartabia.
Sulla direttrice generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, tuttavia, si consolida l'asse
gialloverde, mentre il Pd è più scettico. Se a Salvini la scelta di Belloni
consentirebbe di salvaguardare l'alleanza con Giorgia Meloni (la numero uno del
Dis piace a Fratelli d'Italia), per Conte rappresenta forse una delle poche
candidature non divisive tra i 236 grandi elettori. Beppe Grillo, con un tweet,
si schiera apertamente: Benvenuta Signora Italia, ti aspettavamo da tempo.
#ElisabettaBelloni.
«Voi parlate sempre di
divisioni tra i partiti e anche dentro il M5s - fa notare l'avvocato pugliese ai
cronisti - mentre io ho sempre detto che le valutazioni si fanno alla fine, le
chiacchiere le porta via il vento».
Luigi Di Maio, però, non
gradisce il metodo e i modi utilizzati: «Trovo indecoroso che sia stato buttato
in pasto al dibattito pubblico un alto profilo come quello di Elisabetta
Belloni. Senza un accordo condiviso - tuona il ministro degli Esteri - Lo avevo
detto ieri: prima di bruciare nomi bisognava trovare l'accordo della maggioranza
di governo. Tutto ciò, inoltre, dopo che oggi è stata esposta la seconda carica
dello Stato. Così non va bene, non è il metodo giusto».
Del resto a tarda sera, dalle
reazioni politiche, è evidente che non mancano gli ostacoli ad un punto di
caduta che preveda la salita al Colle per la guida del Dis. Dal 'no' di Renzi
alla contrarietà di Forza Italia, passando per la diffidenza di parte del Pd e
dei centristi, il fronte anti-Belloni è numeroso, anche se Conte continua a
crederci e sul suo profilo Instagram lancia l'hashtag #Una-DonnaPresidente. Se
ai piani alti del Movimento si tifa per il piano A (Belloni), rassicura anche il
fatto che l'opzione B permetterebbe a Conte di 'cadere in piedi'.
Quei 336 voti all'attuale
presidente della Repubblica nella sesta votazione (in cui si è astenuto tutto il
centrodestra) fanno lievitare ancora le quotazioni per un 'Mattarella bis'. Il
messaggio fatto filtrare in serata dal Pd autorizza a non escludere la
rielezione: «Invitiamo tutti a prendere atto della spinta che da due giorni e in
modo trasversale in Parlamento viene a favore della riconferma del presidente
Mattarella». Dal M5s rivendicano un primato: «Non lo dicano a noi - commentano
fonti interne -. Siamo stati tra i primi a crederci, anche quando tutti
pensavano fosse impossibile».
DAGONOTA il 29 gennaio 2022.
In qualunque altro paese
civile e incivile il presidente del Senato Elisabetta Casellati, si sarebbe
dimessa all’istante, un minuto dopo essere stata trombata la folle candidatura
al Quirinale, apparecchiata da Matteo Salvini. Non solo il cazzaro del Papeete
ha gettata così nel bidone del ridicolo la seconda carica dello Stato
mortificando le istituzioni, ma l’ha sputtanata per sempre.
Massino Giannini, ospite ieri
di “Otto e mezzo”, ha messo il dito nella piaga: "Per nascondere i suoi
fallimenti, la politica usa le donne come figurine per il Colle: un atto di
un’irresponsabilità, di una cialtronaggine senza precedenti”.
In tanto femminicidio
politico, Salvini, Meloni e Conte sono arrivati al punto di sbattere nel
tritacarne anche l’altra Elisabetta, la Belloni (vedi l’articolo a seguire).
Vedere la seconda carica dello stato e il capo dei servizi segreti che non
bloccano sul nascere, fermamente e garbatamente, i giochini sul loro nome, che
non sentono immediatamente l’esigenza di dichiarare il loro ‘’non possumus’’,
sono quasi peggio di questi politici scappati dal manicomio.
Fiorenza Sarzanini per
il “Corriere della Sera” il 29 gennaio 2022.
Per la seconda volta nel giro
di quattro giorni, il nome di Elisabetta Belloni è stato infilato nel tritacarne
dei candidati alla presidenza della Repubblica. Un minuto dopo l'ennesima
promessa fatta dal leader della Lega Matteo Salvini di fronte alle telecamere di
avere la soluzione in tasca e di aver puntato su una donna lasciando intendere
che fosse proprio lei, è partito il gioco dei veti incrociati.
Leader e gregari di formazioni
politiche ormai allo sbando si sono fronteggiati perdendo evidentemente di vista
quello che dicono di voler tutelare: il bene del Paese. Esporre in questo modo
il capo dei Servizi segreti non mette a rischio soltanto Elisabetta Belloni, ma
l'Italia intera. Svilire un ruolo così strategico, mortifica le istituzioni, fa
danno alla sicurezza nazionale, fa perdere prestigio a livello internazionale.
Sembra impossibile credere che
nessuno si sia posto questo problema, sia pur in ore così convulse. L'elenco in
realtà è lungo. Nel gioco al massacro dove sembra contare soltanto chi riesce a
proporre un nome - poco importa che sia condiviso - sono già stati usati il
presidente del Consiglio di Stato, l'attuale presidente del Consiglio, il
presidente della Repubblica ancora in carica. Tutti nel frullatore delle
trattative, senza mai interrogarsi su che cosa rimarrà quando tutto questo sarà
finito.
E nel caso di Belloni con
un'aggravante in più: utilizzarla perché donna, in modo da appuntarsi poi sul
petto la medaglia al merito di averla proposta per primi. Appena due settimane
fa, ai funerali del presidente del Palamento europeo David Sassoli, segretari di
partito, ministri, parlamentari avevano preso l'impegno di seguire i suoi valori
promettendo di sedersi intorno a un tavolo per arrivare a un'intesa che portasse
al Quirinale un nuovo capo dello Stato «senza inseguire interessi di parte o
protagonismi».
Esattamente il contrario di
quanto sta accadendo. L'Italia sta ancora combattendo contro la pandemia da
Covid 19, deve fronteggiare la crisi economica e gestire quella Ucraina con i
partner internazionali. Deve soprattutto continuare a negoziare per raggiungere
gli obiettivi imposti dal Pnrr. Sfide che vedono le cariche più alte dello Stato
in prima linea. Elisabetta Belloni è tra loro, in una veste che deve essere il
più possibile riservata e per questo preservata. Il momento per fermare lo
scempio è arrivato.
Antonio Bravetti per “La
Stampa” il 29 gennaio 2022.
Perso nel labirinto. Alla fine
di una lunga giornata iniziata nella notte tra giovedì e venerdì, col via libera
alla candidatura di Elisabetta Casellati, Matteo Salvini cerca in tutti i modi
una via d’uscita dall’angolo in cui si è messo.
Mollato da Forza Italia, ai
ferri corti con Giorgia Meloni, il segretario della Lega prova a riallacciare il
dialogo con Pd e Cinque stelle. Ma pure qui le cose non si mettono bene. Dopo
gli incontri del pomeriggio con Enrico Letta e Giuseppe Conte, fa il passo più
lungo della gamba: «Sto lavorando affinché ci sia un presidente donna e in
gamba, non in quanto donna ma in quanto persona in gamba».
Il nome che rimbalza nei
corridoi di Montecitorio è quello di Elisabetta Belloni. Ma la direttrice
generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza viene subito
bocciata da quasi tutti: Italia Viva, Forza Italia, Leu.
Salvini si ritrova così a
vagare nel suo labirinto. A postare sui social, alle 22, una foto che lo ritrae
al computer negli uffici della Lega alla Camera: «Un altro caffè e al lavoro, la
prima donna presidente della Repubblica sarebbe una straordinaria innovazione».
La giornata, insomma, finisce
com’era iniziata: con un caffè. Al mattino lo aveva preso con gli alleati di
centrodestra. In quella sede era maturato il via libera al nome della presidente
del Senato: alla quinta votazione il centrodestra indicherà Elisabetta
Casellati. Si va alla prova di forza, al muro contro muro, come chiede da giorni
Giorgia Meloni. In Transatlantico però si respira un clima ostile
all’operazione.
Si temono, giustamente, i
franchi tiratori. «Ci stiamo facendo del male da soli», si lamenta un senatore
leghista in un capannello con Centinaio e Durigon. «Se gli altri non la votano è
difficile che passi», ammette Giancarlo Giorgetti allargando le braccia a pochi
metri dall’Aula, mentre è in corso il voto.
La sconfitta di Casellati è
come il morso di un serpente: il veleno si diffonde presto. Tra gli alleati
corrono i sospetti: chi ha voluto affossarla? «Tutta la Lega l’ha votata»,
assicura il vicesegretario Lorenzo Fontana. Bossi, in Transatlantico, punzecchia
il segretario: «Ora Salvini farà quel che gli dice Berlusconi. Cosa dirà
Berlusconi? Dirà che la sinistra vuole uno dei suoi alla presidenza». Il tempo
corre, incombe la sesta votazione, bisogna decidere cosa fare. Nel vertice di
metà pomeriggio Salvini, Tajani e Meloni optano per l’astensione.
Salvini riprende a tessere la
sua tela. Vede Draghi («non pongo veti nei confronti di nessuno, ma da italiano
sarei più tranquillo se andasse avanti a fare il presidente del Consiglio»), poi
Conte e Letta. Nuova riunione con Tajani e Ronzulli. «Ognuno si comporta come
vuole - spiega - la sinistra è abituata a mettere veti, io preferisco fare
proposte, dialogare, unire. Mi auguro che domani il Parlamento dia dimostrazione
di lucidità, concretezza e rapidità, e che si chiuda».
Ma la strada è in salita. In
tarda serata, quando lascia gli uffici della Camera, torna sui suoi passi.
Rimastica le sue parole. Parla senza dire nulla. I partiti dicono no a Belloni?
«Io sono per i sì è non per i no. Lavoro per chiudere la partita già domani».
Forza Italia ha deciso di trattare autonomamente? «Il centrodestra non è
spaccato, è giusto che ognuno faccia valere le sue priorità». Sarà l’ennesima
notte di lavoro, fanno sapere i suoi, di contatti. Oggi il leader della Lega
ricomincerà vedendo i vertici del partito a Montecitorio. Ancora nel labirinto.
Alle 8.30, con il caffè.
Anche i Dem erano
d'accordo. “Votiamo tutti Belloni”, la chat interna che inchioda il Pd. Aldo
Torchiaro su Il Riformista il 29 Gennaio 2022.
Il nome di Elisabetta Belloni,
direttore del Dis che ha ballato qualche ora nelle nomination per il Quirinale,
“è stato fatto da Letta e Conte in una riunione dove me l’hanno presentata con
le sue caratteristiche positive”, ha rivelato Matteo Salvini ospite della
Maratona Mentana su La7. “Io non l’avevo considerata, ma mi hanno fatto capire
che aveva le qualità e i numeri per essere eletta”, ha detto il leader leghista
ad un Enrico Mentana visibilmente sorpreso.
Il Riformista ha avuto copia
di una chat interna dei deputati Pd, circolata ieri sera con particolare forza
tra i parlamentari dem lombardi, in cui un deputato sosteneva le motivazioni
dell’opportunità “di eleggere per la prima volta una donna Presidente. Dal
gruppo Pd esce questa indicazione, nero su bianco: “I leader si sono visti. I
nomi sono stati fatti. E la combinazione delle priorità dei diversi partiti
porta alla figura di Elisabetta Belloni, per anni segretario generale della
Farnesina e ora a capo del Dis, il dipartimento che coordina i servizi di
intelligence. Per la prima volta sarebbe una donna a diventare Presidente della
Repubblica”, prosegue l’informativa interna, che per chi l’ha scritta doveva
rimanere riservatissima.
E invece è arrivata fino a
noi. La nota si conclude: “Più tardi ci ritroveremo con i grandi elettori del Pd
per decidere“. Sappiamo poi com’è andata a finire. Ma non sapevamo, prima di
mettere mano a questo documento, da quale fonte fosse uscito il nome di
Elisabetta Belloni.
Aldo Torchiaro. Romano e
romanista, sociolinguista, ricercatore, è giornalista dal 2005 e collabora con
il Riformista per la politica, la giustizia, le interviste e le inchieste.
Massimo Gramellini per
il “Corriere della Sera” il 29 gennaio 2022.
«E adesso come dico a mia
figlia che a tavola deve spegnere il telefonino?» si chiedeva un'amica
scoraggiata, dopo avere visto la presidente del Senato incollarsi allo
smartphone durante lo spoglio di una votazione che tra l'altro la riguardava
personalmente.
Stiamo parlando di uno dei
riti più solenni della democrazia: la catena di montaggio istituzionale che si
replica ogni sette anni davanti alle telecamere richiede un'intesa perfetta fra
i due presidenti - quello della Camera legge il nome sulla scheda e la smista a
quello del Senato, che la riceve e la smista a sua volta - ma soprattutto una
concentrazione assoluta per mantenere il ritmo infernale.
Invece ieri il povero Fico era
costretto a fermarsi di continuo con la mano a mezz' aria, dato che la collega
era sempre a testa bassa, tutta presa a digitare, scrollare, compulsare. Proprio
come la figlia adolescente della mia amica, che a questo punto avrà buon gioco a
eludere le reprimende della madre: «Se lo fa la presidente del Senato nel
momento culminante del suo lavoro e forse della sua carriera, ti pare che non
posso farlo io mentre sto mangiando la pasta e tu mi chiedi come è andata la
verifica di matematica?».
Nessuno mette in dubbio
l'urgenza dei messaggi ricevuti dalla Casellati: immagino fossero tutti di
Salvini che si dava del pirla e le chiedeva scusa. Ma quando ci decideremo a
usare quell'aggeggio, anziché venire usati da lui? Ora però devo salutarvi
perché mi è appena arrivata una notifica sul cellulare.
R. R. per “Avvenire” il 29
gennaio 2022.
Candidata e «scrutatrice »
allo stesso tempo, la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati è
finita nel mirino ieri per non essersi sfilata dalla guida dell'Assemblea
durante lo spoglio del quinto scrutinio, quello nel quale il suo nome era in
lizza.
La regola prevede che a
presiedere l'assemblea per l'elezione del capo dello Stato e a leggere le schede
sia il presidente della Camera mentre il numero uno del Senato gli siede accanto
e la co-presiede. Ruolo che Casellati aveva già svolto nei primi quattro
scrutini e che ha continuato a svolgere anche durante il quinto nonostante
l'invito preventivo dei dem ad astenersi.
«È del tutto inopportuno che
la presidente Casellati nello spoglio odierno co-presieda lo scrutinio delle
schede, di fatto controllando i voti per sé stessa», aveva messo in guardia in
anticipo Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd «Sarebbe davvero
inaccettabile se dovesse scegliere di copresiedere l'Assemblea mentre si svolge
lo scrutinio che la vede candidata.
Ci auguriamo che abbia senso
delle istituzioni e non alimenti in alcun modo il dubbio che possa controllare i
voti che la interessano direttamente», ha rimarcato anche il deputato dem
Emanuele Fiano. Un fuoco di fila di dichiarazioni che sono proseguite quando poi
la presidente ha deciso di non accogliere l'invito al passo indietro. «È già
grave che la seconda carica dello Stato si presti a un'operazione di parte quale
quella in corso», ha commentato Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del
Pd, chiedendole di passare la mano.
Fino alla richiesta di
dimissioni dei deputati verdi di 'Facciamo eco' e dell'ex M5s Alesandro Di
Battista, perché «non più merite- vole di rappresentare la seconda carica dello
Stato». Il precedente evocato dal Pd per sostenere la tesi che era opportuno far
subentrare nello spoglio un vicepresidente del Senato da affiancare a Roberto
Fico, è quello che si verificò durante l'elezione al Colle di Oscar Luigi
Scalfaro, nel 1992.
Scalfaro era presidente della
Camera e, quando arrivò lo scrutinio nel quale il suo nome era in gioco, si fece
da parte e lasciò il compito di leggere le schede al vicepresidente vicario
Stefano Rodotà, come ha ricordato lo stesso Borghi «augurandosi il medesimo
rispetto delle istituzioni ». Non sempre tuttavia i candidati al Colle hanno
osservato lo stesso galateo istituzionale di Scalfaro.
Presenti durante la lettura
delle schede furono anche i presidenti del Senato Amintore Fanfani e Francesco
Cossiga quando furono candidati al Quirinale, con il secondo che si allontanò
dall'Aula solo al termine dello spoglio che decretò la sua elezione alla
Presidenza della Repubblica. A far discutere ieri sono state anche le riprese
che hanno visto Casellati armeggiare con il suo cellulare durante lo spoglio.
Mentre Fico le passava le
schede la presidente ha cercato più volte di digitare sul telefonino. Ieri
peraltro il centrodestra si è contato nel voto su Elisabetta Casellati segnando
le schede e scrivendo in modo diverso il nome della presidente del Senato, anche
se poi nello spoglio il presidente della Camera Roberto Fico ha letto solo il
cognome. Secondo quanto hanno confermato varie fonti del centrodestra, i
parlamentari della Lega hanno scritto Casellati, Fdi e Nci Elisabetta Alberti
Casellati, Fi e Udc Elisabetta Casellati, Coraggio Italia Alberti Casellati.
Elezione nuovo presidente,
il paradosso del Parlamento incapace di parlarsi.
Stefano Massini su La
Repubblica il 29 Gennaio 2022.
Più il nostro Paese avrebbe
bisogno di dialogare, più dai palazzi della politica ne arriva servita
l’antitesi.
Ci sono voluti sei scrutini,
cinque giorni, e l'impallinamento della seconda carica dello Stato,
per sciogliere il paradosso di un parlamento (etimologicamente: luogo in cui si
parla) incapace di parlarsi. Provate a pensare a una cucina in cui i cuochi
elogino il digiuno, a una basilica dal cui pulpito i preti predichino l'ateismo,
o a un ateneo dove gli insegnanti celebrino la virtù dell'ignoranza: tale è lo
spettacolo cui ci è toccato assistere, di un Parlamento che non si parlava.
Pastorelli e vecchie volpi.
Augusto
Minzolini il 28 Gennaio 2022 su Il Giornale.
Agnelli, vecchie volpi e
pastorelli inesperti. Questa edizione dei giochi quirinalizi andrebbe raccontata
così.
Agnelli, vecchie volpi e
pastorelli inesperti. Questa edizione dei giochi quirinalizi andrebbe raccontata
così. Gli agnelli sono quel 70% di parlamentari alla prima esperienza che spesso
si trovano a dover seguire indicazioni insensate.
Immaginare che Elisabetta
Belloni - grande servitrice dello Stato, con tanti anni nella burocrazia ad alto
livello, persona stimabilissima - possa passare al di là dei tanti meriti
direttamente dal ruolo di capo dei servizi segreti alla presidenza della
Repubblica in un grande democrazia occidentale, vuol dire che si è completamente
a digiuno di un minimo di sensibilità istituzionale. L'unico precedente che si
ricordi di primo acchito è in un Paese molto particolare sul piano della
democrazia: la Russia in cui Vladimir Putin diventò presidente passando per il
Kgb. Ma almeno lui è stato legittimato da un'elezione diretta: differenza non da
poco.
Ecco perché si ha l'idea che
le vecchie volpi indichino dei candidati ben sapendo che alla fine saranno
bocciati. E che dei pastorelli sbadati seguano le loro tracce perché hanno
smarrito la strada. Per cui le vecchie volpi sfogliano la rosa, petalo dopo
petalo, per arrivare al nome che è nei loro piani. E i pastorelli vanno loro
dietro pensando che quei candidati siano veri e non specchietti per le allodole.
Il problema è che per scoprire
le vecchie volpi devi disboscare il bosco dell'ipocrisia. Solo a quel punto si
rivelano i loro giochi e la loro strategia. La vecchia volpe Enrico Letta, ad
esempio, punta a Mario Draghi per andare alle elezioni. In questo giocando a
distanza con una giovane volpe come Giorgia Meloni, che per avere le urne
farebbe anche un patto con il diavolo, manderebbe sul Colle chiunque, pure
Belzebù. I pastorelli sono Giuseppe Conte e Matteo Salvini, che non si accorgono
come gli altri due seguano tattiche speculari.
Ecco perché sull'ipotesi di un
nuovo governo che dovrebbe sostituire l'attuale non si fa un passo avanti. È
impossibile: se è già difficile trovare un nome, un solo nome, per il Quirinale,
immaginate quanto possa essere complesso individuare un nuovo premier, un'intera
squadra di ministri e sottosegretari e, magari, anche un programma aggiornato su
energia e inflazione. Il tutto senza l'autorevolezza di Draghi. Non prendiamoci
in giro: il Financial Times e l'Economist lo hanno capito, i nostri giornali no.
Anche pastorelli inesperti
questo gioco non lo vedono, non si rendono conto che in una finale di coppa del
mondo come l'elezione del presidente della Repubblica, vista la posta in gioco,
sono ammessi anche trucchi e trabocchetti. Maradona segnò all'Inghilterra a
Città del Messico con una mano: non fu espulso ma fu soprannominato la Mano de
Dios. Ecco, Conte e Salvini debbono rendersi conto che la realtà non è sul
palcoscenico, ma dietro le quinte della corsa al Quirinale. Che le vecchie volpi
arrivano a farti apparire normale eleggere il capo dei servizi segreti al
Quirinale, eppoi storcono la bocca su un personaggio come Franco Frattini,
additandolo come amico di Putin e rimuovendo dalla memoria che l'ex ministro
degli Esteri fu proposto da due governi (Berlusconi e Monti) come segretario
della Nato. Ma i pastorelli debbono, soprattutto, essere consapevoli che in
questa partita non contano gli schieramenti, né le simpatie, ma solo il
risultato finale, cioè che Draghi resti al suo posto e il governo vada avanti
fino alla fine della legislatura. Altrimenti rischiano di far apparire come
fenomeni dei mediocri calciatori di serie C. Che magari farebbero meglio ad
ascoltare i consigli di qualche Maradona nella nostra politica. Augusto
Minzolini
Marco Zonetti
per vigilanzatv.it il 28 gennaio 2022.
Continua con il nulla di fatto
la corsa a nominare il nuovo inquilino del Quirinale e, ahinoi, continuano anche
le maratone televisive pomeridiane a base di fuffa. Gli ascolti di ieri, giovedì
27 gennaio 2022, vedono un nuovo flop per lo Speciale Tg1 pomeridiano condotto
dalla Direttrice Monica Maggioni, con ospiti Andrea Montanari, Marcello
Sorgi e Serena Bortone - che salta dai balletti con Memo Remigi a Oggi è un
altro giorno alle dotte disquisizioni sul Colle.
La "maratona Maggioni", dalle
14.02 alle 15.56 ha infatti ottenuto solo l'11.7% di share con 1.600.000
spettatori, distaccata nettamente dalla soap Una Vita con il suo 16.5% di share
e 2.397.000 spettatori e rasa al suolo da Uomini e donne con i suoi 2.817.000
spettatori e il 21.3% di share.
A Enrico Mentana con
lo Speciale TgLa7 non va meglio. In tutto il pomeriggio, Chicco racimola solo il
4.4% di share con 646.000 spettatori.
Oltre il danno, la beffa per
il notiziario della Terza Rete. La Direttrice Simona Sala ospite nel
suo Speciale Tg3 dedicato al Quirinale raccoglie il 6.0% con 723.000 spettatori,
mentre - ospite poco dopo da Lilli Gruber - nel talk show della concorrente
La7, si auto-surclassa ottenendo l'8.1% con 2.050.000 spettatori, peraltro
andando contro il collega Gennaro Sangiuliano, Direttore del Tg2, che con Tg2
Post ottiene solo il 3.2% con 811.000 individui all'ascolto. Cosa ne pensa
l'Amministratore Delegato Carlo Fuortes di queste ospitate dei direttori dei Tg
Rai nei programmi della concorrenza... che peraltro battono quelli della Rai?
La preghiera del senatore:
"Chiudere presto, arriva Sanremo".
Concetto Vecchio su La
Repubblica il 29 Gennaio 2022.
Capannelli. Vittorio Sgarbi re
del Transatlantico, la faccia scura di La Russa, Galliani filosofeggia, Bossi fa
previsioni su Salvini.
«Martedì comincia Sanremo»,
butta lì a sera Luca De Carlo, senatore veneto di Fratelli d’Italia. «Bisogna
chiudere prima, gli italiani non capirebbero". Due Festival contemporaneamente
sarebbero indigeribili.
Quando un giorno si racconterà
dell’esplosione del centrodestra descrivere la faccia che aveva Ignazio La Russa
mentre percorreva il Transatlantico dopo il flop Casellati sarà più indicativo
di molti libri di storia.
Concetto Vecchio per “la
Repubblica” il 29 gennaio 2022.
«Martedì comincia Sanremo»,
butta lì a sera Luca De Carlo, senatore veneto di Fratelli d'Italia. «Bisogna
chiudere prima, gli italiani non capirebbero». Due Festival contemporaneamente
sarebbero indigeribili.
Quando un giorno si racconterà
dell'esplosione del centrodestra, descrivere la faccia che aveva Ignazio La
Russa mentre percorreva il Transatlantico dopo il flop Casellati sarà più
indicativo di molti libri di storia.
Indovinare il numero dei
franchi tiratori che avrebbero affondato Maria Elisabetta Casellati è stato lo
sport preferito di ieri mattina. Ha vinto Osvaldo Napoli, l'eretico del
centrodestra: «Prenderà 380 voti».
Adriano Galliani sta lasciando
Montecitorio scuro in volto. «Nello sport chi vince festeggia, chi perde spiega.
Ma io oggi preferisco non spiegare».
Claudio Durigon, quello che
voleva intitolare il parco di Latina al fratello di Mussolini, si era detto
entusiasta della candidatura Casellati: «È perfetta».
Quel che Umberto Bossi pensa
di Salvini si capisce da questa dichiarazione: «Ora farà quel che gli dice
Berlusconi, e sarà Mattarella bis».
Il vero personaggio del
Transatlantico è Vittorio Sgarbi. Non è mai solo. Alto e basso in lui si fondono
inestricabilmente. A un certo punto si mette a discutere del suo rapporto con la
pornostar Milly D'Abbraccio. Il governatore campano De Luca lo guarda atterrito:
«Ma ti rendi conto dove stai?». Sgarbi: «Tu sei gay vero?». De Luca: «Te pozzan
accirere»
Il Colle della critica. Il
Quirinale confina con Sanremo, qui rischiamo la diretta infinita.
Guia Soncini su L'Inkiesta
il 28 Gennaio 2022.
Già sfiancati dalle maratone
televisive e da quelle su Twitter, prima ancora dell’inizio del Festival. Forse
è il caso di eleggere Morandi per acclamazione, di regalare una prima serata al
duo comico Mentana-Mastella e poi finalmente di cambiare canale.
E quindi, in questo venerdì
che da tradizione sanremese è quello dei duetti, chi sono gli ospiti nel varietà
Quirinale? È vero che Casini ha cambiato fidanzata scegliendone una più
presentabile come first lady? (Se lo eleggono, questo oltraggio al capo dello
Stato si autodistruggerà). E, se la progressione dei voti continua così (da 39 a
166 in tre giorni), vincerà Mattarella pur essendosi ritirato dalla gara? (Non
credo fosse mai successo, in tanti gloriosi anni di repubblica sanremese).
E il premio della critica?
Quello si prende nella serata dei duetti, lo sanno tutti: Sanremo non lo vinci
(moralmente) con la canzone che porti in gara, lo vinci (moralmente, e a volte
anche materialmente) con la cover che fai con l’ospite. Sanremo lo vinci quando
l’elettorato fa la cosa che più ama fare: salire in piedi sul divano a
squarciagolare canzoni note, le novità non interessano a nessuno (forse solo ai
direttori delle filiali bancarie in cui hanno il conto i cantanti).
Quindi, il Quirinale sanremese
si vince o si perde oggi. Mentre, là fuori, il quarto giorno sembra il
quarantesimo. Certo che l’elezione di Pertini ne durò dieci, ma avete presente
cosa sono dieci giorni di social compilati da gente che fino alla Zan non sapeva
esistesse il voto segreto? Ieri, la generazione «nun sape mai nu cazz’» ha
scoperto che – scandalo, indignazione, era pure donna ma non puoi mai fidarti –
Elisabetta Belloni è la direttrice (la generazione in oggetto, non sapendo un
cazzo e quindi neanche l’italiano, direbbe: direttora) del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza. Praticamente la Judi Dench di 007, la capa dei
servizi segreti in Casinò Royale o in Skyfall.
Non si può mettere la capa dei
servizi segreti a capo dello stato, cosa siamo, terzo mondo, si sa che il capo
dello stato dev’essere all’oscuro dei fatti nostri e mica a fare il discorso di
fine anno possiamo mandare qualcuno che abbia letto i miei WhatsApp, con tutte
le cosacce che dico in privato, non vorrei me le rinfacciasse mentre sono
davanti allo zampone con le lenticchie.
Quando passa di lì un adulto,
e fa notare alla generazione nun sape mai nu cazz’ che in Italia i servizi
segreti li comanda il presidente del consiglio, cioè un certo Mario Draghi alla
cui elezione alla presidenza della repubblica essa generazione non ha mai
obiettato se non nei ficcanti termini di «un altro maschio bianco etero»,
l’adulto viene accusato di cavillare. Se posso rubare la reazione proprio alla M
di Bond: Cristo, come mi manca la guerra fredda.
Ma quindi chi vince, m’hanno
chiesto l’altra sera alla radio. Se la tirano abbastanza in lungo – l’ho buttata
in vacca come mio solito – a ottobre compio cinquant’anni, requisito anagrafico
minimo per l’eleggibilità. Un brivido, e non era per l’ipotesi d’un mio discorso
di fine anno, né per il mio tentativo di battere in mitomania i Mattei: Salvini,
che va a citofonare a Cassese neanche fosse un abitante del Pilastro; e Renzi,
che dice che Salvini c’è andato perché i cd di Cassese glieli ha imprestati lui
dicendogli che aveva dei pezzi fortissimi (prego i renziani, assai più
suscettibili per interposta fandom dei salviniani, di non insultarmi:
l’appropriazione culturale renziana l’ha riportata su Twitter Stefano Cappellini
di Repubblica, io come sempre ho copiato i compiti).
Era perché, per arrivare a
ottobre, bisogna che questa elezione duri oltre lunedì. E, se non si risolve
entro lunedì mattina, voi avete già capito cosa significa, e come me già
tremate. Significa una sovrapposizione tra Quirinale e Ariston, i due edifici
più istituzionali di questo povero paese.
Significa che alle abituali
sette ore al giorno di tv (le cinque di concorso serale sanremese, e le due di
relativa conferenza stampa: queste ultime imperdibilissime), il povero
elettorato deve aggiungerne altre cinque di diretta di Mentana, minimo.
(Intermezzo. Ieri Mastella ha
detto «Sono tifoso del Napoli, per me questa è Maradona Mentana». Mentana ha
risposto: «Sono la parte viva». Non possiamo alzare un po’ il livello della tv
dando una prima serata a questi due, al posto d’uno qualunque dei talk con
pretese di serietà attualmente in onda?).
La temibile sovrapposizione,
dicevo. La si potrebbe risolvere, non vorrei ripetermi, solo eleggendo martedì
sera, in diretta dal festival, Gianni Morandi per acclamazione. Tra l’altro, io
mi sentirei tranquillissima anche se leggesse i miei WhatsApp: che impressione
vuoi che gli facciano, a Gianni che non si lascia spaventare neanche dai
commentatori di Facebook. Ed è figura più unitaria di Casini, che alla terza
dose di vaccino s’è instagrammato con una maglietta antiFortitudo che gli ha
alienato mezza Bologna.
Oltretutto il peggio non è
scongiurabile. E il peggio, lo sappiamo tutti, sono le domande dei giornalisti
delle pagine degli spettacoli. Che si riesca a eleggere qualcuno oggi grazie ai
duetti, o la settimana prossima in pieno festival, comunque ci toccherà un
numero infinito di «Amadeus, puoi dirci cosa pensi del nuovo capo dello Stato?».
Suggerirei al conduttore di Sanremo di rispondere «una figura di altissimo
profilo»: potrebbe essere l’unica volta in cui non si offende nessuno. (Mi
raccomando, Amadeus: se eleggono una donna, non dica niente sui passi indietro.
Siamo una repubblica sfiancata dalle dirette televisive: anche la polemica
sessista non ce la possiamo fare. Grazie, gentilissimo). Guia Soncini
Batosta Casellati, Matteo
Salvini cerca una soluzione. Qualunque.
La presidente del Senato
prende solo 382 voti, almeno 70 franchi tiratori. Il leader della Lega apre a
qualsiasi ipotesi: persino al trasloco di Draghi («non c’è un veto»), mentre in
Transatlantico si parla anche di Mattarella (e Casini). Adesso il boccino è in
mano all’uomo del Papeete, che sembra il più confuso di tutti. Susanna Turco
su L'Espresso il 28 gennaio 2022.
Il verdetto dell’Aula è
impietoso. Almeno 70 franchi tiratori affossano la candidatura di Maria
Elisabetta Alberti Casellati, proposta in mattinata dal centrodestra: la
presidente del Senato si ferma a 382 preferenze, molto sotto i 452 Grandi
elettori attribuibili al centrodestra, ma anche sotto l’asticella di 400,
considerato informalmente il numero minimo per riproporre il suo nome.
«Una vera batosta», commenta
prima di tutti il dem Emanuele Fiano, che esce dall’Aula sventolando il suo
personale conteggio dei voti, prima della proclamazione ufficiale.
Flop Casellati, Tajani
furibondo per i franchi tiratori. Un ex ministro azzurro: «Oggi è finita Forza
Italia».Senza
Berlusconi forzisti allo sbando. Un gruppo di senatori e deputati contro il
coordinatore: «Ci ha mandato allo sbaraglio». La presidente del Senato chiama i
ministri: «Tornate a votare il mio nome, la partita non è chiusa». Antonio
Fraschilla su L'Espresso il 28 gennaio 2022.
La caccia ai franchi tiratori
nel centrodestra è partita un secondo dopo il flop del nome di Elisabetta
Casellati nella quinta votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica.
E tutti hanno guardato solo in casa Forza Italia. «Non si fa così», ha urlato il
coordinatore Antonio Tajani uscendo dalla stanza del gruppo parlamentare preso
atto che i voti mancanti alla Casellati sono anche un atto di sfiducia interno
alla sua guida del partito.
Questo sistema politico è
in rovina. E la corsa al Quirinale lo ha dimostrato ancora una volta.
L’elezione del
presidente della Repubblica avviene nel vuoto di leadership dei partiti. L’unica
preoccupazione dei Grandi Elettori è di non finire, guadagnare tempo,
conservarsi. «E invece gli scatoloni li faremo noi» confessa un veterano. Marco
Damilano su L'Espresso il 28 gennaio 2022.
«Per il lavoro che faccio sono
sensibile alle case. E questa è la casa della democrazia, il Parlamento più
bello del mondo. Non mi rassegno a quanto sto vedendo in questi giorni…», mi
dice il senatore a vita Renzo Piano, mentre accompagna la collega Liliana Segre
all’uscita. L’unico sprazzo di luce in giorni di buio. La sirena che ulula
assordante per segnalare la votazione in corso, i volti coperti dalle mascherine
blu, viola, tricolore, gli assembramenti umani che appaiono e scompaiono come
ondate, i corpi incerti e traballanti.
"È più facile che una
chioccia faccia un uovo che qua esca il Presidente della Repubblica".Mastella
show tra l’uovo e l’attacco alla Lega: “Casellati stronzata incredibile, Salvini
si dimetta da leader”. Redazione su Il Riformista il 28 Gennaio 2022.
Tra una fumata nera e
l’altra, Clemente Mastella è sicuramente uno dei protagonisti dei giorni caldi
per la politica italiana, divisa più che mai per l’elezione del 13esimo
presidente della Repubblica. Il sindaco di Benevento è ormai ospite fisso,
davanti a palazzo di Montecitorio, della maratona Mentana in onda su La7.
Presente a Roma da lunedì scorso in veste di accompagnatore della moglie, la
senatrice Sandra Lonardo, e in veste di leader del partito “Noi di centro” (che
vanta un Grande Elettore, ovvero la Lonardo), l’ex ministro della Giustizia ne
ha per tutti.
Fautore della candidatura del
centrista Pier Ferdinando Casini, Mastella ha attaccato duramente Matteo Salvini
per la candidatura, poi bruciata, della presidente del Senato Maria Elisabetta
Casellati: “Se fallisce con Casellati Salvini si dimetta da leader”
“A Berlusconi dico ‘Sta casa aspetta a tte!’. E’ un gigante rispetto al modo in
cui si stanno comportando gli altri leader”.
Poi attacca il segretario
della Lega: “Le prove di forza si fanno quando si ha la forza di mettere al
tappeto l’avversario altrimenti mettere a repentaglio un’istituzione come il
presidente del Senato è una stronzata incredibile. Se Salvini riesce a
recuperare voti da altre parti allora è un grande leader altrimenti il leader
diventa un altro – aggiunge – rispetto a questi Berlusconi è un gigante”.
Poi il siparietto durante la
maratona Mentana dove Mastella si presenta “armato” di un uovo: “Bisogna anche
un po’ sdrammatizzare perché se dovessi valutare quello che sta accadendo in
Parlamento è veramente una ipoteca alla via dell’inferno della politica e
dell’attività parlamentare”. Poi il sindaco tira fuori l’uovo e spiega: “Vede
questo uovo? L’uovo di Colombo, in questo caso l’uovo di Mastella, quindi una
tesi mia. È più facile che una chioccia faccia un uovo che qua esca il
Presidente della Repubblica”.
Poi Mentana scherza: “Resti
con noi che dobbiamo andare in pubblicità! Ci hanno detto: Mastella tira
tantissimo, tenetelo perché con lui gli ascolti vanno alle stelle. Lei è per noi
quello che Corona per la Berlinguer. Resti lì e poi stasera venga ospite qui da
noi”.
VI E ULTIMO GIORNO DI
VOTAZIONI
Matteo Renzi: «Casini mi
fece sentire il suo discorso per l’elezione al Quirinale».
Matteo Renzi su Il Corriere
della Sera il 14 maggio 2022.
Pubblichiamo uno stralcio del
nuovo libro di Matteo Renzi («Il mostro»), in uscita martedì
Pubblichiamo un estratto del
libro di Matteo Renzi «Il mostro», in uscita martedì per Piemme.
«N ei primi giorni delle
votazioni quirinalizie mi ero tenuto prudente. Come sempre in questi casi avevo
più candidati. Dicevo a tutti che per la solidità delle istituzioni la cosa più
logica mi sembrava spostare Mario Draghi al Quirinale e rinforzare il profilo
politico del governo. Non era un passaggio facile. In molti lo temevano. Io
pensavo che Draghi per sette anni avrebbe fatto meglio al Paese di un solo anno
a Palazzo Chigi.
Certo: la sua corsa aveva
alcuni handicap. E ovviamente tra questi figurava la resistenza molto forte di
Cinque Stelle, Forza Italia e Lega. Penso, però, che tale ostilità si sarebbe
potuta tramutare in appoggio — perlomeno a destra — se solo Draghi avesse scelto
di giocarsi le carte in modo diverso. Più che Draghi, direi i suoi più stretti
collaboratori. Draghi infatti è sempre stato straordinariamente signorile. Ha
sempre dato la sua disponibilità davvero come «un nonno al servizio delle
istituzioni». Avrebbe sicuramente fatto bene al Quirinale e sicuramente farà
bene a Palazzo Chigi in questo anno. Non ha brigato. E io posso dire di esserne
testimone avendo fatto qualche incontro e telefonata con lui fin dagli anni in
cui era alla Bce.
Temo, però, che i suoi
collaboratori più stretti — soprattutto Francesco Giavazzi e Antonio Funiciello
— abbiano costruito una strategia sbagliata. L’errore dei Draghi’s Boys è stato
quello di pensare di arrivare al Quirinale contro la politica, come reazione
alla difficoltà della politica. Pensavano di essere chiamati al Quirinale come
una sorta di naturale soluzione se si fosse continuata a indebolire la
componente politica. Io avevo spiegato invece che la strada maestra era l’altra:
provare a offrire ai partiti un patto di legislatura, comprensivo dell’accordo
di un nuovo governo, magari più marcatamente politico. E su questo anche Salvini
aveva — bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare — aperto ufficialmente a
inizio gennaio. Non tanto Draghi, ma i suoi hanno insistito per caratterizzare
il premier come la soluzione da presentare contro l’inconcludenza dei partiti. È
la dimostrazione che si può essere bravi professori all’università, ma che il
Parlamento è un’altra cosa. In Italia se vai contro ai partiti puoi arrivare
ovunque tranne che al Colle: per come è fatto questo sistema istituzionale, con
l’assemblea dei grandi elettori, non si diventa presidente della Repubblica
contro i partiti. Mi è parso che Draghi lo avesse molto chiaro nei nostri
incontri di gennaio tra Città della Pieve e Roma, ma che i suoi due principali
collaboratori non lo abbiano capito per niente. Segno evidente che a Palazzo
Chigi, oggi, il più politico di tutti è proprio il premier.
Peccato perché questa
incapacità di leggere la politica dei tecnici draghiani ha impedito una
soluzione che poteva essere difficile da costruire, ma molto utile per il Paese.
Chi per qualche ora ha assaporato l’elezione è stato Pier Ferdinando Casini, il
decano dei parlamentari, un moderato apprezzato in tutti gli schieramenti. Ma
alla fine — questa è la verità — non è stato voluto da Salvini e dalla Lega,
nonostante il placet che da Forza Italia al Pd era arrivato in modo più o meno
esplicito. Sono testimone del fatto che Casini ha vissuto come sull’ottovolante
quelle ore, ma sempre con una tenuta di nervi e un rispetto istituzionale che lo
qualificano per quello che è, un galantuomo, e che fanno immaginare che avrebbe
servito benissimo il Paese alla presidenza della Repubblica come lo aveva già
fatto alla presidenza della Camera.
Quando ho capito che era tutto
finito, ho chiamato Casini e gli ho offerto una pizza e una buona bottiglia di
champagne a casa mia a Roma, con un nostro comune amico. Doveva essere la cena
della condivisione della sconfitta perché io so per esperienza diretta che
quando si vince sono tutti lì e quando si perde si è da soli. Così il giovedì
sera chiamo Pier e condivido una buona bevuta scherzando e prendendoci un po’ in
giro. Mi fa sentire il finale del primo discorso che avrebbe pronunciato a
sedute riunite: bellissimo, con una citazione toccante di papa Giovanni Paolo
II.
«Bel lavoro, tienilo per il
2029» gli dico scherzando. Lui mi manda a stendere: «Me lo hai già detto sette
anni fa». E ovviamente ci ridiamo sopra come fanno due professionisti che sanno
che in politica le cose non vanno quasi mai come vorremmo. Verso le 23, ennesimo
colpo di scena: telefonata dal quartier generale Lega-Forza Italia, Casini torna
in pista. Berlusconi e Salvini sembrano pronti a sostenerlo. La cena della
sconfitta finisce lì. Gli dico: «Amico mio, se perdi io ci sono. Ma ora che
rischi di vincere, io non servo più». E ci salutiamo allegri. La mattina dopo
ennesima doccia fredda: Salvini torna a flirtare con Conte, stavolta sulla
Belloni, Casini ripone la citazione di Giovanni Paolo II nel cassetto, l’Italia
continua ad aspettare...»
Pierferdinando Casini
"commosso al telefono con Berlusconi": Quirinale, indiscrezioni toccanti.
Libero Quotidiano
il 28 gennaio 2022.
Gira una voce:la zampata
di Silvio Berlusconi per Pier Ferdinando Casini. Mentre Gianfranco Miccichè,
grande elettore e coordinatore di Forza Italia in Sicilia, chiede al Cav di fare
subito un appello pubblico in favore del Mattarella bis, subito dopo il flop di
Elisabetta Casellati, gira voce di un caloroso e clamoroso riavvicinamento tra i
due ex alleati, divisi da tanti anni anche da un "cordiale" gelo. Stando a
numerosi retroscena incrociati, Berlusconi avrebbe dimostrato in queste
settimane la propria contrarietà alla candidatura al Quirinale di Pierferdy,
bollato senza mezze misura come "traditore". Ma ora qualcosa starebbe
cambiando.
Il disastro Casellati, che i
franchi tiratori del centrodestra hanno fatto fermare a 382 voti, ben lontani
dalla soglia minima dei 441 voti attribuiti (per difetto) alla stessa
coalizione, impone ora a Salvini. Meloni e Tajani la scelta di altri nomi su cui
convergere. Non per la sesta votazione (il centrodestra non ritirerà la scheda)
ma per sabato mattina, quando andrà in scena la settima tornata. E non è da
escludere il colpo di scena firmato Cav. Berlusconi potrebbe fare "un appello
secco dall'ospedale, per Casini", scrive Aldo Cazzullo nella sua diretta da
Montecitorio perCorriere.it. Proprio con lui l'ex premier ieri avrebbe avutouna
emozionate telefonata(andata bene, a differenza di quella con Mario Draghi) e il
quirinabile Pierferdy "si è pure commosso. B sta lavorando per lui, anche se
come extrema ratio non esclude Mattarella".
(ANSA il 29 gennaio 2022) -
"L'Italia non può ulteriormente essere logorata da chi antepone le proprie
ambizioni personali al bene del paese. Certamente io non voglio essere tra
questi.
Chiedo al Parlamento, di cui
ho sempre difeso la centralità, di togliere il mio nome da ogni discussione e di
chiedere al presidente della Repubblica Mattarella la disponibilità a continuare
il suo mandato nell'interesse del paese". Così Pier Ferdinando Casini,
intercettato dall'ANSA.
Marco Zini per tag43.it il 30
gennaio 2022.
C’è rimasto male Pier
Ferdinando Casini, e con gli amici più fidati non ha mancato di esprimere tutta
la sua amarezza.
Quando il suo nome era ancora
in corsa per prendere il posto di Sergio Mattarella, tra i più acerrimi nemici
della sua candidatura non c’erano solo leghisti e pentastellati, che in lui
vedono un emblema della Prima repubblica, ma niente meno che Mario Draghi.
Il premier infatti avrebbe
fatto sapere che in caso di elezione del pupillo di Arnaldo Forlani, recordman
di presenza in Parlamento con quasi 40 anni, un minuto dopo lui si sarebbe
dimesso.
Evidentemente Draghi, che non
aveva certo fatto mistero che al Quirinale avrebbe voluto andarci lui, mal
avrebbe sopportato che la spuntasse qualcuno che non fosse Mattarella, la cui
riconferma non suona certo come una sua diminutio.
Tant’è che a un certo punto il
premier, un po’ per sbloccare l’impasse in cui si erano infilati i partiti, un
po’ per evitare sorprese, ha preso lui l’iniziativa facendo da mediatore tra i
partiti e il Colle.
La cosa ha fatto molto
arrabbiare Casini, protagonista a un certo punto di una auto rinuncia alla corsa
che gli è valsa simpatie politiche trasversali.
Così l’ex presidente della
Camera non ha perfidamente mancato di raccontare che, quando nel 2017 fu eletto
presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle banche Draghi,
allora governatore della Bce, gli aveva reiteratamente manifestato non solo
stima e vicinanza, ma anche un certo interesse a conoscere i dossier su cui la
Commissione avrebbe indagato.
Come governatore della Banca
d’Italia infatti (il suo mandato iniziò nel 2006 entrando a via Nazionale al
posto di Antonio Fazio), Draghi dette semaforo verde a quelle che restano le due
fusioni bancarie italiane più importanti: quella tra Sanpaolo e Banca Intesa, e
successivamente il matrimonio tra Unicredit e Capitalia.
Nonché ad altre operazioni
altrettanto importanti tra cui l’aggregazione della Popolare di Novara e Verona
con quella di Lodi. Per Casini dunque il diktat del presidente del Consiglio
sulla sua figura è arrivato come un fulmine a ciel sereno.
Solo la sua proverbiale
filosofia democristiana, quella che sin qui gli ha assicurato una lunga carriera
politica anche dopo la scomparsa della Dc, gli ha fatto superare il dispiacere
magari rammentando la vecchia massima di Giulio Andreotti il quale di fronte ai
molti voltafaccia di amici e sodali di partito, ricordava sempre come la
gratitudine fosse il sentimento del giorno prima.
L’eterno ritorno (e il
ruolo decisivo) dei tanti ex Dc.
Fabrizio Roncone su Il
Corriere della Sera il 30 gennaio 2022.
Da Casini, in corsa, agli
strateghi delle coalizioni: «È un’ossatura antica e risolutiva»
L’ex presidente della Camera
Pier Ferdinando Casini, 66 anni, si è formato nella Dc. Eccolo in una foto del
1987
Il dubbio di un amico: «No,
scusa: ma hai provato a contarli?». Democristiani. Quanti. E tutti in ruoli
decisivi. Sfogliare la Moleskine, rileggere gli appunti con dentro la storia
della seconda elezione di Sergio Mattarella a capo dello Stato: trovarli. Il
primo che spunta fuori è anche quello che, per qualche ora, sabato mattina, ha
seriamente creduto di poter trascorrere i prossimi sette anni al Quirinale. Pier
Ferdinando Casini . Esemplare magnifico.
Figlio del segretario
bolognese dello scudocrociato, cresciuto nella grande Sagrestia
nazionale, lanciato alla Camera a soli 27 anni: poi una vita trascorsa un po’
nel centrosinistra, un po’ nel centrodestra. Talento, più astuzia: seduttore
politico seriale — il Cavaliere tuonò: «Casini Presidente? Mai! È uno che
tradisce» — in realtà fedele solo al proprio passato, al punto di abitare in
piazza del Gesù, di fronte al vecchio palazzo rococò che fu la sede storica
della Dc.
Casini: nella paginetta
successiva ecco subito il suo sponsor, Matteo Renzi (in calzoncini corti con i
boy scout cattolici e, appena maggiorenne, iscritto al Partito Popolare
Italiano). Il Matteo che in Parlamento sa cosa fare, e come, e quando — l’altro
Matteo, vabbé — per poco non riusciva nel colpaccio: sabato, all’alba, ha
infatti suggerito a Pierfurby (cit. Dagospia): «Cercati subito più voti
possibili, forse ci siamo». Così Casini ha cominciato l’attraversamento
pastorale del Transatlantico blandendo chiunque. «Fratello, aiuta il tuo amico
viandante...».
Lo sguardo da vescovo, una
carezza e un pizzicotto, ha risalito l’emiciclo arrivando fino ai banchi
leghisti. Molinari e Centinaio lo guardavano incantati. Graziano Delrio,
osservando da lontano, avrà invece pensato: Signore, perdonalo, Pier non sa
quello che fa (Enrico Letta — presidente dei Giovani Democristiani Europei tra
il 1991 e il 1995 — aveva ormai stabilito che si dovesse andare decisi su
Mattarella). Delrio milita nel Pd, ma è cresciuto in una parrocchia della
periferia di Rosta Vecchia in Reggio Emilia, partite di pallone interminabili e
solide lezioni di cattolicesimo democratico dossettiano. Poi è comunque chiaro
che i democristiani, tra di loro, si riconoscono a prescindere dagli studi
(anche gli ex Pci, in verità). Il vicepresidente della Camera Ettore
Rosato (Iv), per dire, viene dalla dicì triestina; il ministro Lorenzo Guerini
(Pd) faceva invece il consigliere comunale a Lodi (con il padre comunista in
un’epoca in cui girava voce che i comunisti mangiassero i bambini, pensate):
alla fine, per capire da quale vigna ideologica provengano, ti basta parlarci
cinque minuti.
Con Dario Franceschini, ne
basta anche uno. Sentite cosa si è fatto scrivere il potente ministro della
Cultura su Wikipedia: «Le figure carismatiche che fin dalla giovinezza suscitano
la sua attenzione sono, fra le altre, Benigno Zaccagnini e don Primo Mazzolari».
Riflette su Twitter un osservatore acuto come Claudio Velardi: «L’antica
ossatura democristiana del sistema ha risolto bene una situazione di crisi,
lungo l’asse @enricoletta @guerinilorenzo @matteorenzi, con @dariofrance sullo
sfondo. Le altre culture politiche sono marginali e ininfluenti». C’è poco da
aggiungere. Del resto: anche solo per capire dove stessero andando certi
cespugliosi centristi, da quelli di Coraggio Italia (Toti, Romani, Brugnaro,
Quagliariello) a quelli del gruppone Misto, i cronisti hanno sempre chiesto un
po’ di luce a Maurizio Lupi (molti di loro, quando Lupi faceva il consigliere
comunale per la Dc a Milano, occupavano il proprio liceo, in assemblea sotto i
manifesti del Che: ma adesso gli tocca sorbirsi la voce lucida e rassicurante di
Lupi, ormai sempre più simile a un volontario di certi corsi pre-matrimoniali
che si tengono nelle parrocchie). Proprio come un parroco di provincia, con lo
sciarpone stretto al collo, lo zuccotto nero, nero come il cappotto, e la sua
aria curiale, pallida, ogni mattina tutti abbiamo invece visto venir su per via
degli Uffici del Vicario Bruno Tabacci. Per capire che atmosfera ci fosse a
Palazzo Chigi, e quale fosse l’umore di Mario Draghi, bisognava confessarsi da
lui.
Democristiani. Ovunque. E
necessari. Come Gianfranco Rotondi (uno che da ragazzo invece di andarsi a
vedere l’Avellino di Juary, andava ad ascoltare i comizi di Forlani) consultato
a lungo tipo mago Otelma per intuire quali fossero le reali intenzioni del
Cavaliere. Democristiani in diretta nei migliori talk. Ospiti fissi Clemente
Mastella e Paolo Cirino Pomicino che, a 82 anni, è vera leggenda vivente
scudocrociata (Paolo Sorrentino, nel film Il Divo, cioè Giulio Andreotti, a
Pomicino/Carlo Buccirosso fa prendere una lunga rincorsa nel Transatlantico,
chiusa con una scivolata pazzesca; mai avvenuta nella realtà, però perfetta per
spiegare tutta la dimensione di onirico micidiale potere dicì). Un democristiano
di rango assoluto come Marco Follini ha scritto su La Stampa: «Non invocate il
nome della Dc invano». No, infatti. Però qualcuno — più per scaramanzia, che per
altro — è andato a rileggersi il titolo che fece il Manifesto nel 1983: «Non
moriremo democristiani».
Paolo Cirino Pomicino,''
scherzoso napoletano'', per Dagospia il 31 gennaio 2022.
Sembra che Palazzo
Montecitorio abbia allestito un ospedale da campo dopo la trionfale giornata di
sabato durante la quale è stato rieletto, a furor di peones, Sergio Mattarella
alla Presidenza della Repubblica. L’intero gruppo dirigente dei partiti ha avuto
bisogno di cure immediate.
Il più grave è subito apparso
Matteo Salvini ricoverato d’urgenza in una piccola terapia intensiva allestita
nella prima infermeria al lato sinistro dell’aula. Era la sua grande occasione
dopo il ritiro della candidatura di Berlusconi. Doveva dimostrare a sé stesso e
a tutti la sua grande capacità di guida della coalizione di centro-destra. E’
caduto subito nella trappola della sinistra che, riconoscendogli il ruolo di
maggioranza relativa, gli ha sollecitato nomi di uomini e donne.
Il povero Matteo ne ha
sfornato sfusi e a pacchetti esponendo persone di qualità alle puntuali
bocciature del campo di Agramante. Gettò nella mischia anche il Presidente del
Senato nel tentativo di mostrare la forza delle proprie falangi. E fu un altro
disastro. Ebbe disordini motori con mobilità disordinata entrando e uscendo dal
Palazzo, dichiarando e proponendo di tutto e di più salvo poi arrendersi al
democristiano Mattarella in odio al democristiano Casini.
L’incubo dei democristiani lo
aveva sfinito. Intanto Giorgia, la sua maggiore alleata, dopo un tentativo di
blitz ripristinando l’asse sovranista Conte-Salvini-Fratelli d’Italia subito
bocciato dagli altri, ebbe una crisi di nervi urlando e minacciando il povero
Matteo già sottoposto a cure urgenti in terapia intensiva.
Ma se Sparta piangeva Atene
non rideva. Mentre Luigi Di Maio, nell’ombra, riceveva diversi candidati
sottotraccia dando a tutti rassicurazioni a cominciare da Mario Draghi, Giuseppe
Conte aveva crisi allucinatorie continue per cui le 5 stelle erano diventate 55
e faceva accordi con tutti mentre girava per il palazzo cantando “ Io cerco la
Titina, la cerco e l’ho trovata” nel tentativo di candidare una donna.
Dopo una notte piena di
incontri fu anche lui ricoverato nell’ospedale da campo dentro Montecitorio pur
non essendo parlamentare. Nel frattempo Enrico Letta, frastornato e confuso,
abbracciò, cercando serenità, finanche l’odiato amico Matteo Renzi mentre nella
notte tra venerdì e sabato, tentando di trovare il bandolo della matassa, ebbero
una allucinazione collettiva e videro una folla di parlamentari, deputati e
senatori, marciare in fila per quattro issando manifesti con l’effige di Sergio
Mattarella.
Tentarono di scappare da
quelle allucinazioni ma inciamparono e finirono anche loro nell’infermeria con
contusioni multiple mentre l’aula di Montecitorio votava compatta Sergio
Mattarella insieme al suo paggetto, Carlo Nordio anonimo veneziano tanto caro
alla svenuta Meloni.
Mentre lo staff medico era
impegnato a soccorrere i capi politici di una sistema franato arrivò una
telefonata da Palazzo Chigi “il premier Mario Draghi ha grandi vertigini e
vomito, avete un posto o un medico da mandarci?”. “Mettetelo steso e lasciatelo
per un’ora immobile e vediamo se passa”, fu il consiglio del Capo staff medico
di Montecitorio, “e se le vertigini aumentano dategli una spremuta di arance
siciliane, quelle belle grandi e sanguigne”.
E così fecero. Cinque ore dopo
tutti si sentivano un po' meglio. Draghi si era già messo seduto, Letta e Conte
zoppicavano ma camminavano lentamente mentre Salvini rimaneva con prognosi
riservata. La grande armata politica che pensava di guidare il Paese verso nuovi
lidi in soli 6 giorni e 5 notti fu sconfitta dall’onda lunga dell’eternità
democristiana. Paolo Cirino Pomicino,
Federico Novella per “La
Verità” l'1 febbraio 2022.
Giuseppe Cruciani, habemus
Papam: dopo giorni di stallo, intrighi, accoltellamenti, tradimenti, sotterfugi,
siamo atterrati al punto di partenza. Mattarella bis. Tutti si affrettano a
celebrare il presidente per aver accettato con «sacrificio» il secondo mandato.
Prime impressioni?
«Io rifiuto l'idea del
"salvatore della patria". Non ho nulla contro Mattarella, però si è fatta
passare l'idea che senza di lui saremmo caduti nell'abisso. Detto alla sicula,
una minchiata».
Ma come, eravamo
drammaticamente sul ciglio del burrone. Lo stallo alla messicana, la paventata
paralisi delle istituzioni
«Guarda, la teoria
apocalittica sulla presidenza della Repubblica mi fa semplicemente ridere. La
stragrande maggioranza di quelli che hanno votato Mattarella non hanno pensato
alla cosiddetta "stabilità", ma solo alla cadrega».
Con altre figure al Quirinale,
la stabilità sarebbe stata in pericolo: o no?
«No, fosse salita al Colle la
Casellati non sarebbe cambiato un bel niente. Cosa mai doveva succedere? È una
pura questione di occupazione di potere. E mi fa ridere anche la dottrina del
"fate presto"».
Cioè?
«È ridicolo che gli
opinionisti televisivi, che peraltro vivono e ricamano sul caos, si siano
indignati perché il Parlamento si è preso sette giorni per decidere. Sette
giorni per stabilire chi va al Quirinale per sette anni, non mi sembrano
tantissimi. Insomma, non c'era nessuna emergenza».
«Non era nei miei piani», ha
detto il presidente riconfermato.
«Mattarella esercita un potere
felpato, senza intervenire troppo nemmeno sui fascicoli più scottanti. Nemmeno,
per capirsi, sul Csm delegittimato dagli scandali, o sulle storture dei
provvedimenti anti Covid.
È in sostanza un potere
invisibile, per questo piace ai parlamentari. Detto questo, l'elezione del
presidente non sposta una lira nelle tasche degli italiani. Assistiamo al
teatrino parlamentare, ci indigniamo un po', e torniamo ai nostri problemi. E la
vita continua».
Ammetterai che abbiamo
assistito, di fatto, alla resa della politica?
«Certo. Il centrodestra, o
quello che ne rimane, avrebbe fatto meglio a fare un'operazione semplicissima.
Anziché intestardirsi su un proprio candidato, dovevano sparigliare. Proporre un
Rutelli, un Gentiloni, un Veltroni agli avversari, intestandosi l'idea».
Addirittura?
«Avrebbero fatto una grande
figura, e la sinistra non avrebbe potuto rifiutare. Il centrodestra vincente
alle elezioni politiche sarebbe stato comunque garantito. Dopo il voto, una
presidenza scelta in questa maniera non avrebbe potuto negare loro il governo.
Ma insomma, è andata
diversamente: capisco che c'erano altri obiettivi, tipo prolungare la
legislatura e proteggere i vitalizi».
Ci aspettano il proporzionale
e il «grande centro»?
«Non lo so. Non mi pare che
Letta sia un grande fan del proporzionale. È vero che il centrodestra oggi è a
pezzi. Ma questo è solo ciò che vediamo oggi: tra un anno chi lo sa».
E i 5 stelle?
«Scomparsi dai radar.
Evaporati. Il tweet di Beppe Grillo che annuncia la quasi elezione di Elisabetta
Belloni è la perfetta dimostrazione che questi qua non contano più nulla».
Visto il fallimento del
Parlamento in seduta comune, cresce ancora la spinta verso una riforma
costituzionale. Ci sono serie possibilità di eleggere il prossimo presidente
attraverso un voto diretto degli italiani?
«Magari, ma non succederà mai.
Secondo te i politici italiani affidano al popolo la scelta di uno degli
strumenti di potere più grandi, cioè il Quirinale? Il presidente della
Repubblica, soprattutto nei momenti di crisi politica, ha poteri sostanziali e
spesso decisivi.
In più controlla le forze
armate e presiede la magistratura. Ce la vedete la classe politica che rinuncia
a un posto così cruciale per cedere la responsabilità agli italiani?
Impossibile. Sarebbe un'impresa titanica».
Draghi è stato in campo fino
all'ultimo, ma la candidatura non è mai decollata. Impossibile proiettarsi al
Colle senza coltivare rapporti con i partiti. Il premier ha commesso degli
errori?
«Voleva attraversare la palude
della politica senza sporcarsi delle scarpe. Prima si è chiamato fuori, poi ha
fatto una conferenza stampa sottraendosi alle domande sul Quirinale:
sostanzialmente era un'autocandidatura. Quando ti comporti così, di solito ti
bruci».
Dicono che, con la sconfitta
della politica, Draghi andrà avanti senza pietà sulle riforme. Soprattutto
quelle più scomode. Insomma basta compromessi: da oggi regnerà la tecnocrazia
ancor più di ieri?
«Non credo. Se Draghi vuole
andare giù dritto, va comunque a sbattere contro i gruppi parlamentari in
fibrillazione. Siamo già in campagna elettorale, è tutto più difficile. Non a
caso il premier voleva fuggire al Quirinale».
La riconferma di Mattarella è
il trionfo dell'assetto tecnico-politico fondato sull'emergenza perpetua?
«Non a caso il più felice di
tutti, per il Mattarella bis, è il ministro Speranza. Si è precipitato a
manifestare la sua gioia senza perdere un attimo. Non è strano, che la sinistra
interna sia quella più soddisfatta per l'elezione di un democristiano?».
Insomma, ha vinto la linea
della gestione sanitaria restrittiva?
«Sì, anche se poi dubito che
con un'altra figura al Quirinale sarebbe cambiato molto. Sarà forse la realtà
dei fatti, presto, a farci uscire da questa bolla psicologica. Quella di essere
l'unico Paese che aggiunge restrizioni, mentre gli altri le smantellano».
Presto arriverà il green pass
senza scadenza, per i vaccinati con tre dosi.
«Appunto. Noi confermiamo il
green pass, mentre gli altri lo tolgono. Aumentiamo la dose. Ci droghiamo di
green pass. Andiamo in overdose di green pass mentre nel resto d'Europa cercano,
diciamo così, di disintossicarsi».
Da domani parte la stretta
anti Covid. Servirà il certificato verde per accedere alle poste e in banca. E
all'orizzonte s' intravede la deadline sui luoghi di lavoro: dal 15 febbraio chi
non ha il green pass non incassa stipendio. Ti aspetti altre limitazioni?
«Siamo al paradosso per cui
non puoi neanche andare a ritirare la pensione senza il lasciapassare. Ripeto,
succede solo da noi. È un'incredibile lesione della libertà individuale. E tutto
senza risultati concreti in termini di contagi. Del resto il governo è fermo da
Natale: la restrizione è l'unica forma di attività politica. Di più: un metodo
di governo».
Cioè?
«Pensiamoci un attimo. A parte
il fumoso Pnrr, qual è l'unica ragione di esistere di questo governo?
L'emergenza sanitaria e la sua gestione. È l'unico fondamento di questo
governo».
Questo spiegherebbe il
protrarsi dell'emergenza?
«Sì, e inoltre questo spiega
perché, mentre negli Usa e in Spagna i tribunali supremi bocciano i
provvedimenti restrittivi estremi, da noi invece si accetta tutto.
L'establishment, ben rappresentato al vertice dall'asse Mattarella-Draghi,
funziona magnificamente».
In tutto questo, resiste un
pesante giudizio morale contro i no green pass e i no vax?
«Io non sono il portavoce dei
no vax, ma faccio notare che i non vaccinati esistono in tutte le società
occidentali. Peraltro sono molto più numerosi all'estero che non in Italia. Non
possiamo immaginare il 100% di popolazione vaccinata, per giunta con più dosi.
Alcuni diritti fondamentali di milioni di italiani sono stati compressi perché
considerati pericolosi per la salute pubblica: con il 90% di vaccinati, è
un'aberrazione».
Dunque?
«Dunque non possiamo neanche
utilizzare i no vax come capro espiatorio per salvare la faccia a chi non sa più
cosa dire. Mi sorprende che la sinistra, sempre attenta ai diritti delle
minoranze, oggi sposi a occhi chiusi questa sorta di pensiero unico».
Insomma, è anche banalmente
una questione di interessi politici?
«Se un governo di centrodestra
avesse preso gli stessi provvedimenti, sarebbero scesi in piazza sindacati,
Partito democratico e sinistra assortita contro il golpe strisciante e la
democrazia in pericolo».
Alcuni virologi sembra quasi
si stiano riposizionando sull'utilità del green pass, o sull'opportunità delle
cure domiciliari. Esistono i voltagabbana anche nel mondo scientifico?
«Nei talk show si dice di
tutto, regnano l'esibizionismo e la legittima vanità, e lo dico facendo parte di
quel mondo. Una volta che le restrizioni sono diventate insopportabili anche per
i vaccinati, che ne vedono l'inutilità, certi esperti perennemente in tv si
stanno riallineando con l'opinione pubblica. Ne percepiscono la stanchezza. In
un certo senso, anche i virologi sono diventati esperti di comunicazione. Era
inevitabile finisse così».
Quirinale, il retroscena:
Mario Draghi pronto a dimettersi se fosse passato Casini. Perché ora il premier
non avrà pietà.
Fausto Carioti su Libero Quotidiano il 30 gennaio 2022
Sergio
Mattarella confermato obtorto collo al Quirinale col voto di 759 grandi elettori
su 1.009 (l’altra volta furono 665) e determinato a restare lassù altri sette
anni, che significherebbe scavalcare l'intera prossima legislatura. Mario
Draghi inchiodato alla presidenza del consiglio, dalla quale, racconta chi ha
vissuto al telefono la notte tra venerdì e sabato, è stato a un passo dal
dimettersi: cosa che probabilmente avrebbe fatto se fosse stato eletto Pier
Ferdinando Casini. La vittoria - l'ennesima - del dipartimento di Stato
americano, della Conferenza episcopale italiana e di tutti quegli "ambienti" che
da mesi puntavano sul mantenimento dello status quo. E adesso? Adesso, avverte
chi nelle segreterie dei partiti ha tenuto i contatti col premier, inizia il
governo Draghi, quello vero. Che non è l'esecutivo visto sinora, gestito con
abbondante ricorso ai compromessi dall'ex presidente della Bce che sperava di
succedere a Mattarella e si era obbligato a trovare un modus vivendi con i
politici. Ma quello guidato da un tecnico che ha appena ricevuto dai partiti il
grande rifiuto della sua vita e quindi non ha più nulla da chiedere ai loro
segretari; semmai, ha qualcosa da dimostrare alle cancellerie europee e alle
istituzioni internazionali, visto che ora ambisce a diventare presidente del
Consiglio europeo o della Commissione Ue, due incarichi che saranno disponibili
nel 2024.
IL PNRR (E NON SOLO)
Cosa significhi questa nuova
fase, lo ha spiegato Draghi stesso ai suoi interlocutori politici, mentre
trattava con loro sui possibili (e non realizzati) "sviluppi istituzionali". Chi
lo ha ascoltato, la riassume così: «Una riforma a settimana, senza guardare in
faccia a nessuno». Regole scritte con i parametri del tecnico puro e non più di
quello "prestato alla politica". Se non è il prezzo da pagare per non averlo
eletto presidente della repubblica, gli assomiglia molto. Non c'è bisogno di
inventarsi nulla di nuovo, sono interventi dei quali si discute da tempo, molti
dei quali previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza concordato con
Bruxelles. Sinora, però, c'è stato un margine di "interpretazione" che ha
consentito a Draghi una coabitazione tutto sommato pacifica con i partiti:
dovendo scegliere tra la coerenza e la convivenza, il premier spesso ha
sacrificato la prima sull'altare della seconda. Non sarà più così. Sulle
concessioni demaniali marittime, ad esempio.
Da mesi balla la questione
della legge che dovrebbe riassegnarle mediante gare pubbliche: non è stata fatta
perché Forza Italia, Lega e Pd si sono opposti. «Dobbiamo prepararci», avvertiva
ieri sera un esponente forzista che ha a cuore la pratica, «Draghi ora non avrà
più motivi per usare il guanto di velluto». Discorso simile per la
liberalizzazione delle licenze degli ambulanti: la legge sulla concorrenza
varata nel 2021 non interviene sulla questione, ma nessuno si illude più che
l'argomento sia ignorato pure nella prossima. Fuori dal perimetro del Pnrr c'è
la riforma delle pensioni, con il superamento della legge Fornero: tutta ancora
da scrivere. Draghi aveva ipotizzato il ricalcolo integralmente contributivo
dell'assegno, secondo il criterio per cui «ognuno prende quanto ha versato»:
significherebbe una pensione più bassa per chi lascerà il lavoro nei prossimi
anni. L'idea, però, era rimasta lì, sospesa, in attesa di capire come sarebbe
finita la partita per il Colle: ora che il risultato è noto, è chiaro pure
quello che ci si dovrà aspettare. Sulla riforma del catasto e la conseguente
revisione degli estimi è stata approvata una legge delega che, a seconda di come
sarà usata dall'esecutivo, potrà portare o meno a quell'aggravio della pressione
fiscale sugli immobili che le autorità europee chiedono da tempo. Draghi si era
mostrato cauto per ragioni politiche, evaporate ieri sera. Temono anche i Cinque
Stelle: il premier sino ad oggi ha tollerato il reddito di cittadinanza,
limitandosi ad un ritocchino, perché così pretendevano loro, primo partito della
coalizione; uno scrupolo che adesso può abbandonare.
ASPETTANDO LE ELEZIONI
Se qualche partito non lo
seguirà e minaccerà di levargli la fiducia, il presidente del consiglio non se
ne farà un cruccio: il casolare di Città della Pieve, a un'ora e tre quarti da
Roma, è lì che lo attende. Spetterà a chi avrà provocato la crisi
spiegare perché gli interessi sui titoli di Stato italiani sono decollati in una
notte, o perché qualche tranche di soldi del Pnrr (tutte legate al
raggiungimento di determinati obiettivi, anche intermedi) è stata bloccata, in
attesa di chiarimenti. Anche così, con l'avvio di questa "Fase 2" nel momento
peggiore per i partiti, a un anno dalle elezioni politiche, si spiegano le voci
di «rimpasto» che sono girate ieri e i segnali inviati da Giancarlo Giorgetti:
stretto tra Draghi e Matteo Salvini e sapendo ciò che attende il governo, il
ministro dello Sviluppo ha già fatto capire di essere pronto a lasciare
l'incarico. Un "kindergarten" nel quale i partiti siano liberi di sfogarsi,
Draghi lo ha comunque previsto: è quello delle leggi sulle questioni etiche e
sui diritti civili, come il ddl Zan che tornerà di moda tra tre mesi, e della
riforma della legge elettorale. Se Pd, Lega, M5S e gli altri la preferiscono
proporzionale, si accomodino pure: non è materia di governo e sarebbe il giusto
omaggio allo sfascio dei partiti e delle coalizioni che si è visto in questi
giorni.
Mario Draghi, perché non
voleva Casini al Colle? Dossier e banche, indiscrezioni-terremoto.
Libero Quotidiano
il 30 gennaio 2022
Il nome di Pier Ferdinando
Casini come candidato al Quirinale è rimasto in bilico per diversi giorni. Pare
che a mettersi di traverso sia stato, tra gli altri, anche Mario Draghi. Lo
rivela Marco Zini su Tag43: "Il premier avrebbe fatto sapere che in caso di
elezione del pupillo di Arnaldo Forlani, recordman di presenza in Parlamento con
quasi 40 anni, un minuto dopo lui si sarebbe dimesso". Quali i motivi?
Probabilmente il desiderio del premier di approdare lui al Quirinale.
La mossa del premier non
sarebbe piaciuta a Casini. Ecco perché, continua Tag43, l'ex presidente della
Camera "non ha perfidamente mancato di raccontare che, quando nel 2017 fu eletto
presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, Draghi,
allora governatore della Bce, gli aveva reiteratamente manifestato non solo
stima e vicinanza, ma anche un certo interesse a conoscere i dossier su cui la
Commissione avrebbe indagato".
Per Casini, insomma, il
presunto no di Draghi alla sua candidatura sarebbe arrivato come un fulmine a
ciel sereno. A tal proposito Zini scrive: "Solo la sua proverbiale filosofia
democristiana, quella che sin qui gli ha assicurato una lunga carriera politica
anche dopo la scomparsa della Dc, gli ha fatto superare il dispiacere, magari
rammentando la vecchia massima di Giulio Andreotti, il quale di fronte ai molti
voltafaccia di amici e sodali di partito, ricordava sempre come la gratitudine
fosse il sentimento del giorno prima".
Elezione presidente della
Repubblica, nell'ottava votazione il Parlamento sceglie Mattarella. Draghi:
"Splendida notizia per gli italiani".
Valeria Forgnone e Laura Mari
su La Repubblica il 29 Gennaio 2022.
Per il bis 759 voti. In Aula
applauso di 4 minuti. Il giuramento del Capo dello Stato il 3 febbraio alle
15.30. Papa Francesco: "Auguri per alto compito accettato con disponibilità".
Letta: "E' vittoria di tutti". Conte: "Abbiamo un presidente garante". Salvini e
Giorgetti aprono il fronte sul governo: "Sull'esecutivo lunedì faremo la nostra
proposta". Meloni: "Bisogna rifondare il centrodestra".
Il Parlamento ha
scelto: Sergio Mattarella è di nuovo presidente della Repubblica. La
proclamazione è stata fatta dal presidente della Camera Roberto Fico: all'ottava
votazione Mattarella ha ottenuto 759 voti dai 983 votanti. E ora Fico e la
presidente del Senato Casellati hanno raggiunto il Quirinale e comunicato a
Mattarella l'esito del voto. "Sono giorni difficili che impongono di non
sottrarsi alle decisioni del Parlamento", ha detto Mattarella in un breve
discorso accettando così la rielezione al Colle. Il giuramento sarà il 3
febbraio alle ore 15.30 alla Camera. I Grandi elettori, dunque, hanno conferito
a Mattarella il secondo mandato come capo dello Stato. Subito dopo la
proclamazione in Aula alla Camera è scoppiato un fragoroso applauso simile a
quello (di oltre 4 minuti) che ha accolto il superamento del quorum di 505 voti
da Mattarella e a quello che ha accompagnato la conclusione dello spoglio delle
schede. In totale il capo dello Stato uscente ha ottenuto 759 voti. "La
rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica è una splendida
notizia per gli italiani. Sono grato al Presidente per la sua scelta di
assecondare la fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un secondo
mandato", ha commentato il presidente del Consiglio Mario Draghi. "E' una
vittoria di tutti, il merito è del gioco di squadra", ha detto il segretario del
Pd, Enrico Letta abbracciando poi, nel corridoio del Transatlantico, il
presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. "Ha vinto l'Italia, abbiamo un
presidente garante", ha sottolineato Conte. Subito dopo la proclamazione Matteo
Salvini ha chiamato Mattarella per congratularsi e al Capo dello Stato sono
arrivate le congratulazioni di Papa Francesco "per l'alto compito che ha
accettato con spirito di generosa disponibilità". Auguri al Capo dello Stato
(solo per citarne alcuni) dalla presidente della Commissione Ue Von der Leyen,
della presidente della Bce Lagarde e del presidente francese Macron.
L'intesa per il bis di
Mattarella è stata raggiunta nel vertice di maggioranza e grazie alla mediazione
del premier Mario Draghi. "Alcuni leader hanno fallito, grazie a Draghi si p
sbloccata la situazione", ha chiarito il ministro degli Esteri 5 Stelle Luigi Di
Maio. Ma ora dalla Lega Matteo Salvini e il ministro Giancarlo Giorgetti aprono
il fronte sul governo e chiedono di vedere il premier Mario Draghi. "Rimpasto?
Ne parleremo con lui lunedì", spiega Salvini. E Giorgetti conferma: "Servono una
fase nuova e un nuovo codice di comportamento degli alleati". Intanto, dopo la
decisione di Meloni di non votare per il Mattarella il bis, Salvini apre anche
un fronte nel centrodestra: "Serve una riflessione chi vive di nostalgia non lo
farà con noi".
I risultati delle votazioni
LA DIRETTA DELLA GIORNATA
Ore 8.15. E' in corso alla
Camera l'assemblea dei grandi elettori Pd in vista della settima votazione per
il Quirinale che avrà inizio alle 9.30.
Ore 8.22. "Parteciperemo al
vertice di maggioranza in mattinata per cercare di trovare una soluzione, la più
ampia possibile", dice ai cronisti il coordinatore nazionale di Forza Italia
Antonio Tajani, arrivando a Montecitorio.
In corso assemblea grandi
elettori Pd
Ore 8.27. "E' durissima.
Fortuna che c'è il Pd. Fortuna che c'è unità del Pd". Lo ha detto il segretario
del Pd, Enrico Letta, aprendo i lavori della riunione dei grandi elettori dem in
corso alla Camera. Un passaggio, quello di Letta, sottolineato dagli applausi
degli esponenti dem.
Tajani: "Parteciperemo a
vertice di maggioranza per trovare una soluzione"
Ore 8.36. È in corso alla
Camera l'assemblea dei grandi elettori di Italia Viva. Il leader Matteo Renzi fa
il punto sulle trattative per l'elezione del presidente della Repubblica.
Letta: "È durissima ma per
fortuna che c'è il Pd unito"
Ore 8.38. "Ieri grande
successo nostro la mattina. Vi ringrazio perché siete stati eccezionali nel
fidarvi della tattica. E' stata una vittoria che ci ha consentito di tornare
alla casella di partenza". Così Enrico Letta, segretario Pd, all'Assemblea dei
Grandi Elettori in corso alla Camera.
Iniziata l'assemblea dei
grandi elettori Iv
Ore 8.40. Maggior
coordinamento a partire dal voto sul presidente della Repubblica di questa
mattina. E' stato deciso ieri notte nel corso di un incontro tra il coordinatore
di Forza Italia Antonio Tajani, Lorenzo Cesa dell'Udc, Maurizio Lupi per Noi per
l'Italia e Giovanni Toti per Coraggio Italia. Insieme i gruppi "valgono" più di
180 grandi elettori.
Letta: "Vittoria ieri mattina
ci fa tornare a casella partenza"
Ore 8.41. La Lega si asterrà
al primo scrutinio della giornata per l'elezione del Presidente della Repubblica
se non ci sarà un nome condiviso? "Sì, i voti a caso non fanno fare una bella
figura al Parlamento". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, rispondendo ai
cronisti davanti a Montecitorio.
Al via il coordinamento FI con
i centristi: insieme 180 voti
Ore 8.45. "Oggi si riparte con
un metodo di confronto caratterizzato da un elemento in più: il centrodestra si
è formalmente spaccato. Politicamente è un punto essenziale", ha continuato il
segretario Pd Enrico letta, secondo quanto riferito da fonti del Nazareno,
all'assemblea con i grandi elettori in corso alla Camera.
Salvini: "Senza un nome
condiviso ci asteniamo"
Ore 8.48. E' in corso alla
Camera dei deputati la riunione con Matteo Salvini e i dirigenti della
Lega. Presenti, tra gli altri, i capigruppo del partito.
Letta: "Il centrodestra ora
spaccato, punto essenziale"
Ore 8.50. "Si è ragionato di
vari nomi, tanti, da Draghi, a Mattarella, la Cartabia, la Severino, la Belloni
e gli altri come Amato e Casini". Lo spiega il segretario Pd, Enrico Letta, alla
riunione dei grandi elettori Pd in corso alla Camera. "Attorno a tutti questi
nomi si è cominciato a discutere. Poi ciascuno ha fatto delle verifiche a casa
sua", ha aggiunto Letta. "Appena ciò è accaduto Salvini è uscito con la solita
logica del 'sono io che do le carte'. Questo ha creato un cortocircuito anche
coi Cinque Stelle".
In corso alla Camera la
riunione con Salvini e i dirigenti della Lega
Ore 8.52. "Siamo per avere al
Quirinale un personaggio politico. Abbiamo visto la rosa di cui parla la
sinistra. Siamo per avere, come abbiamo sempre detto, un politico o una
politica". Così Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, risponde ai
cronisti che gli chiedono un commento sulla possibile candidatura di Elisabetta
Belloni per il Colle.
Letta: "Nomi bruciati dalla
logica di Salvini"
Ore 9. "Io sconfitto? Se non
eleggiamo rapidamente un presidente della Repubblica all'altezza, penso che
perdiamo tutti", ha commentato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando
con i cronisti fuori da Montecitorio.
Tajani: "Forza Italia per un
nome politico"
Ore 9.13. Astensione o scheda
bianca: sono le indicazioni per i grandi elettori M5S arrivate in occasione
dell'assemblea congiunta riunita questa mattina alle 8,45.
Salvini: "Io sconfitto?
Perdiamo tutti se l'elezione non è rapida"
Ore 9.16. C'è attesa alla
Camera per la riunione, in programma a minuti, a cui parteciperanno i leader di
partiti di maggioranza. Presente anche il coordinatore di Forza Italia, Antonio
Tajani, che rappresenterà anche i partiti di centro.
Per M5S astensione o bianca
Ore 9.24. "Il mio nome può
essere sul tavolo solo se rappresenta un momento di unità e di
convergenza. L'Italia viene prima delle nostre ambizioni personali", le parole
di Pier Ferdinando Casini intercettato sotto casa, nei pressi di piazza del
Gesù.
Ore 9.35. I grandi elettori di
Forza Italia si astiene alla settima votazione per il capo dello Stato. Lo
riferiscono fonti di Fi.
Casini: "Il mio nome solo se
unisce"
Ore 9.36. Con la prima chiama
dei senatori prende il via nell'Aula di Montecitorio la settima votazione per
l'elezione del presidente della Repubblica. Anche in questo scrutinio è
richiesta la maggioranza assoluta di 505 voti.
Forza Italia si astiene
Attesa per il vertice
di maggioranza alla Camera
Ore 9.41. I senatori della
maggioranza che sostiene il governo Draghi o non hanno finora risposto alla
chiama per la settima votazione per eleggere il presidente della Repubblica o si
stanno astenendo.
Al via la settima votazione
Ore 9.45. I senatori del Pd
non stanno rispondendo alla prima chiama per il Quirinale.
Senatori di maggioranza si
astengono o non risponde a chiama
Ore 9.48. È arrivata ai grandi
elettori della Lega l'indicazione di voto per questa mattina: astensione e non
ritiro della scheda del settimo scrutinio.
Il Pd non risponde alla chiama
Ore 9.54. I grandi elettori di
Italia Viva lasciano oggi scheda bianca. "Bianca vera", è la sottolineatura dei
renziani, dal momento che - al di là delle indicazioni che stanno arrivando dai
partiti - anche oggi è attesa "una valanga" di preferenze per Sergio Mattarella.
La Lega si astiene al primo
voto
Ore 9.56. Il presidente M5S
Giuseppe Conte al vertice di maggioranza "non è venuto". Il leader di Italia
viva Matteo Renzi lo conferma in Transatlantico. "Poi se c'è qualcuno che non è
adatto a fare l'interpretazione autentica del pensiero di Conte sono io...",
conclude Renzi escludendo l'eventualità di formulare ipotesi sull'assenza di
Conte.
Italia viva lascia scheda
bianca
Ore 9.57. Il presidente del
Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, e gli altri leader, hanno convenuto di
aggiornare più tardi in mattinata il vertice di maggioranza. E' quanto fanno
sapere fonti del Movimento 5 stelle dopo che questa mattina si era diffusa la
voce, confermata dal leader di Italia viva, Matteo Renzi, secondo cui il
presidente 5 stelle non si sarebbe presentato alla riunione di maggioranza
convocata inizialmente per le 8,30.
Renzi: "Conte non è arrivato
al vertice di maggioranza"
Ore 9.58. Ad avvio seduta, era
presente a presiedere l'Aula solo il presidente Roberto Fico. Assente invece la
presidente del Senato Elisabetta Casellati. A prima chiama dei senatori in
corso, anche Fico ha lasciato i banchi della presidenza, affidando la
guida della seduta a uno dei vicepresidenti.
Rinviata la riunione di
maggioranza, si terrà in mattinata
Ore 10. "Se non ci diamo una
mossa il presidente verrà eletto non dico a furor di popolo, ma a furor di
grande elettore". Lo ha detto ai cronisti Giovanni Toti, governatore della
Liguria e vicepresidente di Coraggio Italia. Alla domanda se Mattarella sia la
soluzione, Toti ha risposto che "Mattarella è un nome presente in tutte le
rose", nelle quali vanno aggiunti quelli di Mario Draghi e Pier Ferdinando
Casini. "Se c'è qualche altro nome costruttivo noi siamo qui e lo ascoltiamo,
purché abbia una storia e un significato politico, altrimenti nelle prossime 24
ore i grandi elettori prenderanno una decisione scavalcando i loro leader".
Casellati assente ad avvio di
seduta
Ore 10.03. Anche oggi il
Movimento 5 stelle continuerà a votare scheda bianca nella votazione per il
Quirinale.
Toti: "Fare presto o decidono
i grandi elettori"
Ore 10.14. Al via nell'Aula di
Montecitorio la seconda chiama dei senatori.
M5S vota scheda bianca al
settimo scrutinio
Ore 10.20. Anche oggi, come
nella giornata di ieri, il senatore Pier Ferdinando Casini ha depositato la sua
scheda nell'urna dopo aver votato da grande elettore del Parlamento in seduta
comune per l'elezione del Presidente della Repubblica. E su Instagram
posta una foto del Tricolore e la scritta: "Prima di noi viene l'Italia".
Al via in Aula la seconda
chiama dei senatori
Ore 10.40. Mattarella bis?
"Non può essere una scelta di ripiego". Così Matteo Salvini, parlando con i
cronisti in Transatlantico. "Basta andare avanti con i veti della sinistra",
dice il leader della Lega. "Piuttosto che andare avanti altri 5 giorni con i
veti" meglio andare su "Mattarella, ma bisogna farlo con convinzione", osserva
Salvini parlando del Quirinale.
Casini ha votato. Su
Instagram: Prima di noi viene l'Italia
Ore 10.44. "Consideriamo che
non sia più serio continuare con i no e i veti incrociati e dire al presidente
di ripensarci". Così il segretario della Lega Matteo Salvini conversando con i
cronisti in Transatlantico in un ragionamento su Sergio Mattarella.
Salvini, Mattarella? Sì ma con
convinzione
Ore 10.52. "Per me Draghi è
meglio che resti a Palazzo Chigi, perché tutto il resto sarebbe rischioso. Ma ho
capito che gli altri fanno politica solo bruciando le proposte che arrivano,
mentre io non ho mai messo veti nei confronti di nessuno. Però ho capito che
prima di dire un eventuale si a un nome che arriva da sinistra, ora io sto zitto
per non finire dentro le loro guerre interne", dice il segretario della Lega,
Matteo Salvini parlando con i cronisti in Transatlantico.
Salvini: "O stop veti o dire a
Mattarella ripensarci"
Ore 10.56. Dopo l'astensione
nella prima chiama, i grandi elettori Pd e M5S parteciperanno alla seconda
chiama. "Ci aspettiamo un boom per Mattarella", è il tam tam in Transatlantico
tra i parlamentari di centrosinistra. C'è chi si scommette che si potrebbe
arrivare anche a quota 400.
Salvini: "Draghi resti premier
o si rischia"
Ore 11. Il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, si è trattenuto al Quirinale per un colloquio con il
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'auto del premier ha lasciato
il palazzo circa mezz'ora dopo la cerimonia di giuramento di Filippo Patroni
Griffi a giudice della Consulta.
Molto prima di lui erano
usciti la presidente del Senato Elisabetta Casellati, il presidente della Camera
Roberto Fico e il presidente facente funzioni della Consulta, Giuliano Amato.
Pd e M5S entrano a seconda
chiama
Ore 11.14. "Una parte del
Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di
restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia
posizione, poi non so nemmeno se c'è un vertice". Così il leader della Lega,
Matteo parlando ai giornalisti alla Camera aggiungendo che "l'importante è che
Mattarella non sia percepito come un ripiego".
Colloquio Mattarella-Draghi
dopo giuramento Consulta
Ore 11.16. Telefonata fra
Matteo Salvini e Mario Draghi. Mentre il segretario della Lega stava
raggiungendo i suoi uffici alla Camera, ha risposto al telefono con trasporto:
"Ciao Mario", portandosi il telefono all'orecchio. Poi ha camminato verso gli
uffici della Lega, soffermandosi in attesa dell'ascensore. Fra le poche parole
che sono state carpite: "Non ci farebbe una bella figura il Paese...". E poi il
saluto. "Dai, comunque ti vengo a trovare quando finiamo qui". Ai cronisti che,
al termine della conversazione, lo hanno avvicinato per chiedergli se all'altro
capo ci fosse il presidente del Consiglio, Salvini non ha risposto. Sorridendo.
Salvini: "Squadra di governo
resti e Mattarella bis"
Ore 11.22. Convocati d'urgenza
i grandi elettori della Lega, Matteo Salvini li vedrà dalle 14.
Telefonata Matteo
Salvini-Mario Draghi.
Ore 11.24. Sul Quirinale si
prevede una svolta in giornata? "Direi di sì", risponde il ministro dello
Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ai cronisti che lo interpellano
sull'apertura fatta da Matteo Salvini al Mattarella Bis. Una strada porta al
Colle? "E dove, sennò?", risponde Giorgetti.
Alle 14 riunione Salvini con
grandi elettori
Ore 11.39. E' iniziato il
vertice con i segretari dei partiti della maggioranza.
Giorgetti: "Svolta in
giornata? Direi di sì"
Ore 11.41. "Salvini propone di
andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della
Repubblica. Non voglio crederci". Così su Facebook il presidente di Fratelli
d'Italia, Giorgia Meloni.
Iniziato vertice di
maggioranza
Ore 11.48. Il leader di Italia
viva, Matteo Renzi, mostra ottimismo sulla partita del Quirinale. "Stasera si
chiude", ha detto ai suoi, a quanto si apprende da fonti del partito.
Meloni: "Salvini su
Mattarella? Non ci credo"
Ore 12.02. Al via nell'Aula di
Montecitorio la seconda chiama dei deputati.
Fonti Iv, Renzi: "Stasera si
chiude"
Ore 12.05. "Gli italiani non
meritano altri giorni di confusione. Io ho la coscienza a posto, ho fatto
numerose proposte tutte di alto livello, tutte bocciate dalla
sinistra. Riconfermiamo il presidente Mattarella al Quirinale e Draghi al
governo, subito al lavoro da oggi pomeriggio, i problemi degli italiani non
aspettano". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini.
Al via in Aula seconda chiama
dei deputati
Ore 12.16. Il presidente del
Consiglio Mario Draghi, nell'incontro di oggi al Quirinale, avrebbe chiesto al
capo dello Stato Sergio Mattarella di rimanere per "il bene e la stabilità del
paese", se il Parlamento lo chiederà.
Salvini: "Riconfermiamo
Mattarella"
Ore 12.15. "Per noi la
conferma del presidente Mattarella è una vittoria perché nel 2015 lo ha proposto
Matteo Renzi, lo abbiamo indicato quando nessuno se lo aspettava sette anni fa,
lo abbiamo votato allora e oggi lo rivotiamo con entusiasmo", ha detto la
deputata di Italia viva Maria Elena Boschi.
Draghi chiama leader dei
partiti per stringere su Mattarella
Ore 12.17. "Oggi pomeriggio
rieleggeremo un grande presidente. #Mattarella #Quirinale". Lo scrive su Twitter
il senatore Pd Andrea Marcucci
Boschi: "Per noi la conferma
di Mattarella è una vittoria"
Ore 12.20. Il premier Mario
Draghi sta contattando in queste ore i leader di tutte le forze politiche per
stringere sulla rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della
Repubblica, dopo il colloquio di questa mattina con il capo dello Stato.
Draghi media: "Mattarella
resti per il bene e stabilità del Paese"
Ore 12.29. Si è conclusa la
seconda chiama dei deputati. Avrà ora inizio la prima chiama dei delegati
regionali.
Marcucci: "Oggi rieleggeremo
il presidente Mattarella"
Ore 12.30. "Chiedo a tutti i
colleghi, ai leader e al Parlamento, di cui ho sempre difeso la centralità
nell'ambito delle istituzioni democratiche, di togliere il mio nome dalla
discussione e di chiedere al presidente Mattarella la disponibilità a continuare
il suo mandato nell'interesse dell'Italia". La richiesta arriva direttamente da
Pier Ferdinando Casini. "Credo ne vada della dignità e del decoro delle
istituzioni, se il Parlamento non è in grado di decidere non può contribuire
alla sua delegittimazione con una serie di inutili votazioni", aggiunge.
Ora votano i delegati
regionali
Ore 12.36. Si è raggiunta
un'intesa nel vertice di maggioranza sul bis per Sergio Mattarella. Lo
confermano fonti di maggioranza.
"L'intesa su Mattarella è una
grandissima gioia", ha detto Matteo Renzi lasciando la riunione
Casini: "Parlamento chieda a
Mattarella di restare"
Ore 12.41. Giorgetti via dal
governo? "È una ipotesi, magari c'è da migliorare la squadra...". Così Giancarlo
Giorgetti rispondendo sugli scenari post Quirinale. "Intanto oggi vado a casa",
conclude il ministro.
Chiusa intesa dei leader di
maggioranza su Mattarella
Ore 12.43. Uno striscione sul
portone di un palazzo nel centro di Roma che recita: "Grazie presidente
Mattarella". A immortalarlo in una foto è il segretario del Pd, Enrico Letta che
ha condiviso lo scatto su Twitter.
Giorgetti: "io via dal
governo? E' una ipotesi"
Ore 12.47. "Mantenere
Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l'unico modo per lasciare l'Italia al
riparo dalle strampalate follie e dalla mancanza di regia politica. Mattarella e
Draghi sono due scelte eccellenti, due nomi che garantiscono le Istituzioni.
Viva l'Italia". Così su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi.
Letta posta foto: "Grazie
presidente Mattarella"
Ore 12.48. "Lunga e affettuosa
telefonata tra il presidente Silvio Berlusconi e il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. Berlusconi ha assicurato al presidente Mattarella il sostegno
di Forza Italia per la sua rielezione". Lo rende noto l'ufficio stampa del
presidente di FI.
Renzi: "Con Mattarella-Draghi
Paese in sicurezza"
Ore 12.57. Si è conclusa
nell'Aula di Montecitorio la settima votazione del Parlamento in seduta comune
integrato dai delegati delle regioni per eleggere il presidente della
Repubblica. È iniziato lo spoglio, che viene effettuato personalmente dal
presidente della Camera Roberto Fico.
Berlusconi chiama Mattarella,
sostegno FI
Ore 13. "Siamo molto
soddisfatti dell'intesa sulla rielezione del presidente Mattarella, che segna un
grande successo per il Paese, per il Parlamento, per la stabilità dell'azione
del governo. La saldezza e l'unità del Partito Democratico sono state poste al
servizio della Repubblica e delle istituzioni". Lo dichiara Marco Meloni,
coordinatore della Segreteria nazionale del Partito democratico.
Conclusa la settima votazione,
al via lo spoglio
Ore 13.01. La presidente del
Senato Elisabetta Alberti Casellati è giunta nell'Aula di Montecitorio a spoglio
iniziato. Quando ha preso posto accanto a Roberto Fico, erano state spogliate
già una quindicina di schede.
Pd: grande soddisfazione, noi
a servizio della Repubblica
Ore 13.03. "Perde il
centrosinistra ma soprattutto il centrodestra. Ora metteranno una bella legge
proporzionale...". Così Ignazio La Russa sul dossier Quirinale.
Casellati arriva in Aula a
spoglio iniziato
Ore 13.07. "Sarei stupita se
Mattarella accettasse di essere rieletto presidente della Repubblica dopo aver
fermamente e ripetutamente respinto questa ipotesi. Anche perché sappiamo tutti
che il secondo mandato presidenziale non può diventare una prassi, forzando gli
equilibri previsti dalla nostra Costituzione". Queste le parole della leader di
FdI, Giorgia Meloni.
La Russa: "Perde il
centrodestra"
Ore 13.09. "Il Parlamento ha
ascoltato il Paese. Si consolida in un momento tanto difficile per il Paese un
punto di riferimento saldo per tutte le italiane e gli italiani. Grazie
Presidente Mattarella". Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro e capo
delegazione Pd al governo, Andrea Orlando.
Meloni: "Sarei stupita se
Mattarella accettasse la rielezione dopo i suoi no"
Ore 13.14. Pier Ferdinando
Casini come prima opzione o, in alternativa, la rielezione di Sergio Mattarella
al Quirinale. Questi, a quanto si apprende da ambienti vicini a Forza Italia, i
nomi che sono stati fatti da FI durante la riunione delle forze politiche di
maggioranza in vista dell'elezione del presidente della Repubblica.
Orlando: "Mattarella punto di
riferimento saldo"
Ore 13.15. "Qualche giorno fa,
per senso di responsabilità e nell'interesse del Paese, avevo rinunciato alla
mia candidatura, anche per favorire una soluzione unitaria. Quello che è
successo dopo è sotto gli occhi di tutti, ma non è questo il momento della
polemica. Questo è il momento dell'unità e tutti dobbiamo sentirlo come un
dovere. Ma l'unità oggi si può ritrovare soltanto intorno alla figura del
Presidente Sergio Mattarella, al quale sappiamo di chiedere un grande
sacrificio, ma sappiamo anche che glielo possiamo chiedere nell'interesse
superiore del Paese, quello stesso che ha sempre testimoniato nei 7 anni del suo
altissimo mandato". Così Silvio Berlusconi, dal San Raffaele di Milano dove è
ancora ricoverato, in una nota.
Da FI prima opzione Casini o
in alternativa Mattarella a riunione maggioranza
Ore 13.20. "Ancora una volta
il Parlamento dimostra di non essere all'altezza degli italiani che dovrebbe
rappresentare. Da domani Fratelli d'Italia moltiplicherà i suoi sforzi per una
riforma presidenziale della nostra Repubblica e per ribadire che la sovranità
appartiene al popolo, non agli intrighi di Palazzo". Lo dichiara in una nota il
presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.
Berlusconi: "Unità solo
intorno a Mattarella"
Ore 13.25. I capigruppo delle
forze politiche che hanno siglato l'intesa per un Mattarella bis sono attesi al
Colle attorno alle 15,30.
Meloni: "Ancora una volta il
Parlamento dimostra di non essere all'altezza"
Alle 15.30 i capigruppo al
Colle per il bis di Mattarella
Ore 13.30. Fumata nera al
settimo scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato. Terminato lo spoglio
delle schede, nessuno ha ottenuto i 505 voti richiesti.
Ore 13.36. "Per noi era
fondamentale che questo passaggio non compromettesse la necessità di un'azione
di governo forte, decisa, che non si può interrompere per un solo giorno, per
venire incontro ai bisogni dei cittadini. Questo risultato lo abbiamo
conseguito", dice ai cronisti il leader M5S Giuseppe Conte
Fumata nera al settimo
scrutinio
Ore 13.40. Il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha ottenuto 387 voti nel settimo scrutinio per
l'elezione del Capo dello Stato. 64 sono andati al Carlo Nordio, indicato da
Fratelli d'Italia, 40 a Nino Di Matteo. Presenti 976, votanti 596, astenuti 380.
Le schede bianche sono state 60, le nulle 4, i voti dispersi 9. Hanno ottenuto
preferenze anche Pier Ferdinando Casini, 10; Elisabetta Belloni, 9; Luigi
Manconi, 6, Marta Cartabia, 4, Mario Draghi 2. Prossimo scrutinio, l'ottavo,
alle 16.30.
D'Incà: "Spero che Mattarella
rinnovi la sua disponibilità a guidare il Paese"
Ore 13.42. "Spero che il
presidente accetti di rinnovare la sua disponibilità a guidare il nostro Paese e
che possa essere rieletto con la più ampia maggioranza possibile". Il tweet del
ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.
Conte: "Assicurare la
stabilità dell'esecutivo"
Ore 13.48. L'elezione diretta
del capo dello Stato? "Non può essere vista come qualcosa che da sola si innesta
in un sistema lasciandolo così com'è". Risponde così il neopresidente della
Corte Costituzionale Giuliano Amato ad una domanda durante la conferenza stampa
dopo la sua elezione.
Risultati settimo scrutinio
Ore 13.50. "Abbiamo avuto
difficoltà anche nel confrontarci con le forze di centrodestra in particolare,
le abbiamo invitate a mettere da parte candidature di area culturale fortemente
connotata, di destra, conservatrice, e le abbiamo spinte a confrontarsi su
quelle figure super partes su cui abbiamo ragionato sin dall'inizio - racconta
il leader M5S Giuseppe Conte - Questo confronto è stato intenso, io e i
capigruppo abbiamo perseguito sempre l'interesse dei cittadini cercando di
tenere alta l'asticella. È stata una trattativa molto complicata", rimarca l'ex
premier.
Amato: "Per l'elezione diretta
va cambiato il sistema"
Ore 13.51. "All'ultimo vertice
di centrodestra, l'unica cosa su cui Salvini e tutti gli altri leader della
coalizione sembravano uniti era proprio il no al Mattarella bis... In
quell'occasione c'è stato il no globale di Salvini e degli altri, quello è stato
l'unico momento in cui il centrodestra è stato unito". Lo ha detto il
vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando alla Camera.
Conte: "Trattativa complicata,
difficile il confronto con il centrodestra"
Ore 13.52. I grandi elettori
del Partito democratico sono convocati alle 14 nella sala del Mappamondo alla
Camera.
La Russa: "All'ultimo vertice
di centrodestra, tutti uniti per il no al Mattarella bis..."
Ora 13.55. "Il centrodestra è
ora in coma, bisogna vedere se si tratta di un coma farmacologico, oppure se
irreversibile - commenta Guido Crosetto le vicende di questa settimana
quirinalizia - Il centrodestra già non era in buona salute prima, si teneva
diciamo con lo scotch, negli ultimi cinque anni non è esistito" come forza
unitaria, "quasi sempre diviso, prima con Salvini al governo, con i 5Stelle, per
arrivare a oggi". "Poi la situazione sembra degenerata - dice - mi pare che dopo
la mossa di Fi di ieri, quando ha deciso di andare da sola sul Colle e quanto
successo ora, si può parlare di stato di coma. L'unica che ha cercato di tenerlo
insieme è stata Gorgia Meloni", conclude Crosetto.
I grandi elettori Pd si
riuniscono alle 14 alla Camera
Ore 14.10. Alle 16,15,
nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, il segretario del
Partito democratico, Enrico Letta, terrà una conferenza stampa.
Crosetto: "Il centrodestra ora
è in coma"
Ore 14.20. Come riferisce la
Lega, è iniziata la riunione di Matteo Salvini con i senatori e i delegati
regionali, negli uffici della Camera. Dopo vedrà i deputati.
Alle 16,15 conferenza stampa
di Letta alla Camera
Ore 14.22. Una lunga standing
ovation ha aperto l'assemblea dei grandi elettori Pd con Enrico Letta. Il
segretario del Pd, in piedi con accanto le capogruppo Simona Malpezzi e Debora
Serracchiani, insieme a tutti i grandi elettori dem ha festeggiato così
l'accordo per il Mattarella bis.
Lega: riunione Salvini con
senatori e delegati
Ore 14.25. "È
stata un'esperienza per tutti importante, formativa, nella quale siamo cresciuti
tutti e abbiamo imparato tante cose". Così - ha detto il segretario del Pd
Enrico Letta nel corso dell'assemblea dei grandi elettori dem - La dimostrazione
che giocare di squadra è la ragione del successo, non c'è protagonismo o
personalismo, c'è la volontà di dividerci i compiti: ho pensato che siamo un
grande partito".
Standing ovation apre
assemblea dei grandi elettori Pd con Letta
Ore 14.39. "Tutti i passaggi
politici hanno dimostrato, nel momento più difficile in assoluto, che il campo
largo esiste grazie al nostro lavoro. Siamo riusciti a tenere tutti attorno", ha
detto il segretario Pd Enrico Letta all'assemblea con i grandi elettori alla
Camera.
Letta: "Esperienza formativa.
Il Pd si conferma un grande partito"
Ore 14.44. "Confesso che ieri
sera tardi, stanotte, ho fatto una telefonata personale a Silvio Berlusconi, per
fargli gli auguri di pronta guarigione e per spiegargli che non c'era nulla di
personale, nelle settimane scorse ho avuto parole nei suoi confronti un
po' forti - riferisce il segretario Pd Enrico Letta all'assemblea con i grandi
elettori in corso alla Camera - In questi giorni ho dovuto fare la parte del
cattivo e sono stato attaccato e criticato, ma credo che fosse necessario".
Letta: "Dimostrato che campo
largo esiste"
Ore 14.57. "Il centrodestra
non è un partito unico, ma una coalizione e ci sono momenti in cui i diversi
partiti agiscono ciascuno per proprio conto, siamo già al governo in modo
diverso". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani ai
giornalisti che gli chiedevano se l'opzione Mattarella bis avrà effetti sulla
tenuta della coalizione.
Letta: "Stanotte ho chiamato
Berlusconi"
Ore 15.05. Il presidente dei
deputati della Lega, Riccardo Molinari, e quello dei senatori, Massimiliano
Romeo, sono arrivati al Quirinale, dove sono attesi i capigruppo dei partiti di
maggioranza per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.
Tajani: "Il centrodestra non è
un partito unico"
Ore 15.12. I capigruppo del
M5S, Davide Crippa e Mariolina Castellone sono arrivati al Quirinale per
incontrare il capo dello Stato Sergio Mattarella e chiedergli la disponibilità
alla rielezione.
Capigruppo della Lega arrivati
al Colle
Ore 15.13. Il presidente dei
deputati di Leu, Federico Fornaro, e quella dei senatori, Loredana De Petris,
sono arrivati al Quirinale per l'incontro con il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella chiesto dai capigruppo dei partiti di maggioranza. Poco dopo è
arrivata anche Julia Unterberger, capogruppo al Senato del Gruppo misto e
Manfred Schullian, capogruppo del Gruppo misto alla Camera.
Capigruppo M5S arrivati al
Colle per incontrare Mattarella
Ore 15.14. "Grazie alla
Presidente Casellati che si è messa in gioco. Ha preso 208 voti della Lega su
208. Noi siamo fatti così", dice Matteo Salvini durante l'assemblea con i
deputati.
Capigruppo Leu arrivati al
Quirinale
Ore 15.15. Anche le capigruppo
del Pd, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, sono arrivati al Quirinale per
l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiesto dai
presidenti di deputati e senatori dei partiti di maggioranza.
Salvini: "Casellati ha preso
208 voti della lega su 208"
Ore 15.50. "È andato tutto
bene". Non hanno voluto aggiungere altro i capigruppo di maggioranza lasciando
il Quirinale dopo l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.
Anche le capigruppo di Pd al
Colle
Ore 15.53. "Romanzo Quirinale.
Manco il Gattopardo, siamoi al "nulla cambi, perchè nulla cambi", scrive su
Facebook il leader di FdI Giorgia Meloni.
Capigruppo lasciano il
Colle: è andata bene
Ore 16.11. Fratelli d'Italia
continuerà a votare per Carlo Nordio alla presidenza della Repubblica e non per
Sergio Mattarella. Lo conferma la leader del Partito, Giorgia Meloni,
incontrando la stampa. Il Parlamento, ha aggiunto, è delegittimato.
Meloni: "Manco il Gattopardo,
perché nulla cambi"
Ore 16.24. "Il centrodestra
parlamentare mi pare che non esista. È ancora maggioranza nella nazione, credo
che debba avere rappresentanza politica, lavoreremo per questo. Bisogna
rifondare il centrodestra da capo. Per rispetto delle persone che si aspettano
un cambiamento". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, uscendo
dalla Camera al termine della riunione coi grandi elettori di Fdi in vista
dell'ottavo scrutinio.
Meloni: "Parlamento
delegittimato, votiamo Nordio no Mattarella"
Ore 16.34. "Mi aspettavo un
atteggiamento diverso da molte persone e che il centrodestra avesse molto più
coraggio e convinzione nel fare una cosa che era alla portata: battersi con
dignità, a viso aperto, con orgoglio per eleggere un Presidente distonico
rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni - dice Giorgia Meloni ai
cronisti - Non era un obiettivo scontato, bisognava crederci. I margini c'erano.
Questa cosa mi fa impazzire, mi fa impazzire che si sia rinunciato prima di
tentare davvero. Mi dispiace ma noi di FdI abbiamo fatto di tutto"
Meloni: "Bisogna rifondare
daccapo il centrodestra"
Ore 16.35. E' iniziata alla
Camera l'ottava votazione dei grandi elettori chiamati a votare il nuovo
presidente della Repubblica. Si va verso Mattarella bis.
Meloni: "Il centrodestra senza
coraggio, mi fa impazzire"
Ore 16.42. "La legge
elettorale deve essere oggetto di discussione. Sicuramente bisogna cambiarla ma
non sto qui a indicare una strada". Lo ha detto il segretario pd enrico letta
durante una conferenza stampa a montecitorio.
L'ottava votazione per
elezioni del capo dello Stato
Ore 16.44. "Mi fido di
Giuseppe Conte", ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta.
Letta: "La legge elettorale va
cambiata"
Ore 16.48. "Ribadisco con
grande forza e nettezza che questo scenario che oggi certificheremo col nostro
voto, Mattarella presidente della Repubblica per sette anni, Draghi presidente
del Consiglio fino alle elezioni del 2023, è lo scenario per noi ideale: è
meglio rispetto allo scenario che si sarebbe verificato con un'ascesa del
presidente del Consiglio al Quirinale e con le difficoltà di questa maggioranza
a trovare punti di riferimento diversi, di unità - commenta Enrico Letta,
segretario del Pd, in conferenza stampa alla Camera - Non so se saremmo riusciti
a negoziare su un presidente del Consiglio in grado di portare il Paese alle
elezioni. Un altro governo con Draghi al Quirinale non so se saremmo riusciti a
farlo e comunque sarebbe stato più debole rispetto a quello di Draghi. Con un
altro presidente della Repubblica il rapporto con Draghi sarebbe stato tutto da
costruire e il rapporto non sarebbe stato immediato come con quello attuale. Il
sistema ci guadagna, è la migliore delle soluzioni possibili", sottolinea.
Letta: "Mi fido di Conte"
Ore 16.51. "Penso che sia
responsabilità di Fdi salvare la faccia rispetto a quei milioni di italiani che
votano centrodestra. Perché il principio che si vuole affermare in questa
Nazione è che tra le decine di milioni di italiani di centrodestra non ci sono
figure che abbiano la dignità di ricoprire la carica di capo dello Stato. E' un
racconto al quale Fdi non si piegherà mai. Il problema è che siamo in un
Parlamento dove si preferisce barattare 7 anni di presidenza della Repubblica
con 7 mesi di stipendio...". Lo ha detto Giorgia Meloni fuori da Montecitorio.
Letta: "Con Draghi al Colle
non so se facevamo governo"
Ore 16.54. "Per quanto ci
riguarda il governo va bene così ed è nelle prerogative del presidente del
Consiglio immaginare qualsiasi forma di cambiamento - continua Enrico Letta in
conferenza stampa - La politica è stata per qualche settimana in apnea, ora è
importante che tutto funzioni al meglio", ha aggiunto.
Meloni: "Barattato per 7 mesi
stipendio"
Ore 17.02. "Una delle cose che
intendiamo fare immediatamente è rilanciare, con una raccolta firme on line
disponibile tra poco, la nostra legge di iniziativa popolare per l'elezione
diretta del capo dello Stato", ha annunciato la presidente di Fratelli d'Italia,
Giorgia Meloni uscendo da Montecitorio.
Letta: "Rimpasto? Per noi il
governo va bene così"
Ore 17.16 Il leader Matteo
Salvini e il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, dopo essersi
riuniti alla Camera hanno chiesto al premier Mario Draghi un incontro.
Meloni: "A breve petizione
online per elezione diretta"
Ore 17.19. "Dimissioni? Per
affrontare questa nuova fase serve una messa a punto: il governo con la sua
maggioranza adotti un nuovo tipo di metodo di lavoro che ci permetta di
affrontare in maniera costruttiva i tanti dossier, anche divisi, per non
trasformare quest'anno in una lunghissima, dannosa campagna elettorale che non
serve al Paese". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti al termine di un incontro con il segretario della Lega Matteo Salvini.
Salvini e Giorgetti chiedono
incontro a Draghi
Ore 17.28. Come si apprende da
fonti di Fratelli d'Italia, i presidenti delle regioni Abruzzo e Marche, Marco
Marsilio e Francesco Acquaroli, hanno ricevuto un invito dalla presidenza della
Conferenza delle Regioni per un colloquio con il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella e hanno deciso, per rispetto istituzionale, di prendervi
parte. Il presidente Fedriga ha rappresentato al capo dello Stato che una
minoranza delle Regioni non era favorevole a una sua rielezione. Posizione
ribadita dagli stessi governatori al presidente Mattarella nel corso di un loro
breve colloquio.
Giorgetti: "Dimissioni? Serve
una nuova fase governo"
Ore 17.29. Si è appena
conclusa la prima chiama dei senatori per l'ottava votazione per l'elezione del
presidente della Repubblica. Ora è in corso la seconda chiama.
Fonti Fdi: fronte governatori
ribadiscono riserve a Mattarella bis
Ore 17.31. ''Ieri ho bloccato
l'asse giallo verde nero su Belloni''. Così Matteo Renzi sulla candidatura
tramontata ieri di Elisabetta Belloni sulla quale ci sarebbe stata la
convergenza di Conte, Salvini e Meloni. ''I 5 Stelle hanno provato a fare il
congresso'' sul Colle ''ma non ha vinto nessuno. Conte ci ha provato a fare il
colpaccio ma non ci è riuscito'', ha aggiunto il leader di Italia viva.
Conclusa la prima chiama
senatori, via alla seconda
Ore 17.32 Dopo le due chiamate
dei senatori, è ora il momento della prima chiama dei deputati pre l'ottava
votazione per l'elezione del presidente della Repubblica.
Renzi: "Conte ci ha provato,
ma ho bloccato l'asse gialo-verde su Belloni"
Ore 17.35. "Ringrazio Sinistra
italiana ed Europa Verde, e quanti in questi giorni hanno sostenuto la mia
candidatura alla presidenza della Repubblica: condivido incondizionatamente la
scelta di votare Sergio Mattarella nella seduta comune del Parlamento in corso
in queste ore". Lo afferma in una nota il professor Luigi Manconi.
Via alla prima chiama dei
deputati
Ore 17.36. "Oggi l'Italia è
più forte e il nostro Paese più unito". Lo ha detto il ministro della Salute
Roberto Speranza ai giornalisti davanti a Montecitorio. "Gli italiani hanno oggi
un grande presidente della Repubblica e un governo molto forte. Da domani la
politica deve ricominciare ad occuparsi dei problemi reali", ha poi detto
Speranza.
Manconi: "Condivido rielezione
Mattarella, grazie a chi mi ha votato"
Ore 17.39. "Se mi chiedete se
Berlusconi è furioso, la mia risposta è sì, ma con i suoi penso". Lo ha detto
Matteo Salvini ai giornalisti. "In 40 non hanno votato il candidato presidente,
immagino si chiariranno al loro interno", ha aggiunto.
Speranza: "Oggi Italia più
forte e Paese più unito"
Ore 17.42. Sul futuro del
governo "faremo la nostra proposta lunedì". Lo ha detto ai giornalisti il leader
della Lega Matteo Salvini. Lui e il ministro Giorgetti hanno chiesto un incontro
al premier Draghi.
Salvini: "Berlusconi furioso?
Sì, con i suoi"
Ore 17.47. "Faremo la nostra
proposta per rilanciare il centrodestra", ha detto Matteo Salvini. "Se c'è
qualcuno che nel centrodestra non si sente a suo agio il mondo è grande - ha
aggiunto - se qualcuno vive di nostalgia, pensa ai minestroni, 'proporzionaloni'
e frittatoni, torna indietro di 40 anni non lo fa con noi".
Salvini: "Sul governo faremo
la nostra proposta lunedì"
Ore 17.48. "Cambio di passo?
Credo che conosciate esattamente i provvedimenti che ci aspettano nel prossimo
anno, i problemi sono seri e gravi. Il governo lavora benissimo ma di fronte ad
un anno così è necessario quantomeno un nuovo codice comportamento tra gli
alleati di maggioranza". Così il ministro della Lega Giancarlo Giorgetti.
Salvini: "Rilanceremo il
centrodestra"
Ore 17.50. "Penso che sia una
giornata importante, lo hanno incontrato i capigruppo e il governatore Fedriga.
Io stasera chiamerò Mattarella per fargli i complimenti, aspetto però il voto".
Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli
domandava se avesse sentito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Giorgetti: "Serve nuovo codice
comportamento alleati"
Ore 17.51. "Ma va, ma che
rimpasto...non esiste...". Così Giancarlo Giorgetti, ai cronisti, nega che ci
sia l'idea di un rimpasto dietro la sua richiesta di una nuova fase, di una
messa a punto nell'azione di governo.
Salvini: "Mattarella? Lo
chiamo dopo il voto per i complimenti"
Ore 17.53. "A me sembra che il
nome che tutti gli altri avessero proposto fino a stamattina fosse un altro. Un
nome di tutto rispetto. Mi sembra che tutti gli altri fossero d'accordo su un
altro nome, non la Belloni, sto parlando di Casini". Così il leader della Lega,
Matteo Salvini, a chi gli domandava se avesse subito la scelta di rieleggere
Sergio Mattarella al Quirinale.
Giorgetti: "Nessuna richiesta
di rimpasto di governo"
Ore 17.54. "Sono felice che la
Lega sia stata protagonista della chiusura di questa settimana di veti e conto
che da lunedì in un incontro a tre Draghi-Giorgetti-Salvini ci siano tutti i
chiarimenti necessari". Così il leader della Lega Matteo Salvini.
Salvini: "Fino a stamattina
tutti d'accordo per Casini"
Ore 17.55. "Vedo che Letta -
pronti, partenza e via - ha chiesto una legge elettorale proporzionale... Non è
una questione di rimpasto. Già i problemi sono rilevanti se siamo una squadra,
dobbiamo essere una squadra". Così Giancarlo Giorgetti parlando insieme a Matteo
Salvini con i cronisti alla Camera.
Salvini: "Incontro a tre con
Draghi"
Ore 17.58. Giorgetti ha
chiesto un incontro a Draghi sul governo: "Il governo è piu forte o più debole
oggi? Il governo è forte come ieri, perché è rimasto lo stesso quadro, con
Draghi e Mattarella". Lo ha detto il leader Italia viva Matteo Renzi, uscendo da
Montecitorio.
Giorgetti: "Se siamo squadra,
fare squadra"
Ore 18.00. "Ho scritto a
Draghi e chiesto un incontro a tre dove discutere di tutto: sicuramente però la
legge elettorale non è una priorità. Se nel giorno dell'elezione di Mattarella
il nostro alleato di governo parla di passare mesi in Parlamento per rifare la
legge elettorale allora vuol dire che abbiamo delle priorità diverse". Così il
leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le affermazioni di Enrico Letta.
Renzi: "Giorgetti vuole vedere
Draghi? Governo è lo stesso di ieri"
Ore 18.02. "Io ho posto un
tema con tranquillità e anche per serietà. Siamo contentissimi di come è finita
e poi si ricomincia a lavorare. Ma se c'è una crisi aziendale non è che la colpa
può essere della Lega di Giorgetti... Se comincia questo gioco qui non finisce
più. Sto dicendo che andiamo avanti però le cose vanno tarate". Così il ministro
dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a chi gli chiede delle voci su sue
presunte dimissioni.
Salvini: "La legge elettorale
non è la priorità"
Ore 18.08. "Sono sollevato
perché si rischiava di andare avanti tra veti litigi e beghe. E sono tranquillo
ho fatto tutte le proposte possibili, soprattutto sul fronte femminile". Così il
leader della Lega, Matteo Salvini, al Tg1. "Domani il Parlamento torna a fare il
Parlamento, il governo fa il governo: serve normalità. I litigi di questi giorni
sul Colle non si riversino sul governo".
Giorgetti: "Vado avanti, ma le
cose vanno tarate"
Ore 18.16. "Rimpasto? Ne
parleremo con Draghi, se c'è qualche ministro che non ha voglia di lavorare o di
non essere coerenti è giusto che ne parliamo, ma da lunedì". Così il leader
della Lega, Matteo Salvini, al Tg1.
Salvini: "I litigi non si
riversino su azione del governo"
Ore 18.20. "Probabilmente è
arrivato il momento di far eleggere i presidente della Repubblica dai cittadini.
Questo sistema andava bene per l'Italia che usciva dal fascismo. Spero che
Mattarella possa essere l'ultimo eletto così. Il mio sogno e vederlo eletto dai
cittadini, e questo impone riforme costituzionali". Lo ha detto Matteo Renzi
parlando con i giornalisti alla Camera.
Salvini: "Rimpasto? Ne
parleremo con Draghi"
Ore 18.25. "Con i miei
colleghi governatori di Regione davanti al Quirinale dopo la visita al
presidente Mattarella che, con grande generosità e profondo senso delle
istituzioni, ha dato la sua disponibilità a continuare il suo mandato". È il
messaggio postato da Giovanni Tori, governatore della Liguria, su Twitter
aggiungendo una foto con tutti i colleghi all'uscita dal Quirinale.
Renzi: "Spero in riforma per
prossima elezione Colle. Presidente sia scelto dai cittadini"
Ore 18.30. "Si va verso il
Mattarella bis? "Sono contenta e soddisfatta". Cosi' la senatrice a vita Liliana
Segre all'Agi, commentando l'accordo di maggioranza per il Mattarella bis.
Toti posta foto con
Mattarella: "Grazie presidente"
Ore 18.31. Siparietto a
margine della votazione di oggi pomeriggio alla Camera: il ministro Dario
Franceschini si è avvicinato al segretario del Pd Enrico Letta in Transatlantico
e, salutandolo, lo ha apostrofato con "The Winner!". Il riferimento è all'intesa
raggiunta nella maggioranza per arrivare a un secondo mandato di Mattarella al
Quirinale.
Segre: "Mattarella bis? Sono
contenta"
Ore 18.36. "Con la possibilità
di avere un presidente come Mattarella, un presidente di comprovata
autorevolezza e garanzia, non ha vinto Conte ma il Paese". A dirlo è stato
Giuseppe Conte durante la conferenza stampa del Movimento 5 Stelle.
Pd, Franceschini saluta Letta:
"Ecco the winner"
Ore 18.37. L'ipotesi di
scegliere una donna al Quirinale "non è stata una mera formalita'", ma
"quest'ultima battaglia non siamo riusciti a vincerla, abbiamo trovato degli
ostacoli", ma di fronte a cio' avevamo "un'opzione di garanzia, assolutamente
fuori quota", Sergio Mattarella. Lo ha detto il presidente M5S, Giuseppe Conte.
Conte: "Con Mattarella non ha
vinto Conte, ma il Paese"
Ore 18.38. La scelta di
chiedere che Mario Draghi restasse a palazzo Chigi è stata fatta "nell'ottica di
valorizzare il suo operato, di assicurare tempestività e efficacia all'azione di
governo". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in
conferenza stampa.
Conte: "Mattarella opzione di
garanzia"
Ore 18.39. "Avevamo una
opzione di garanzia, fuori quota, quella del presidente Mattarella, che ha
sempre ricevuto un unanime apprezzamento da parte della comunità del M5S.
Mattarella non ha bisogno di presentazioni". Lo ha detto il presidente del
Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Montecitorio, in
merito all'elezione del capo dello Stato.
Conte: "Draghi a Palazzo Chigi
per garantire efficacia governo"
Ore 18.49. "La matita con la
quale ho appena votato Mattarella. Me la tengo tra i ricordi. Belli", scrive su
Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, pubblicando una
foto della matita in questione.
Conte: "Mattarella ha sempre
ricevuto unanime apprezzamento da comunità"
Ore 18.53. "Arriverà il
momento per i chiarimenti interni in una comunità che discute con tutti i
componenti che devono rispondere non al leader ma alla comunità del partito".
Così il Presidente M5S Giuseppe Conte in conferenza stampa rispondendo in
conferenza stampa ad una domanda su una nota di ieri sera in cui il ministro
degli Esteri Luigi Di Maio definiva "indecoroso" bruciare la candidatura di
Elisabetta Belloni per il Quirinale.
Letta: "Matita con cui ho
votato Mattarella tra i ricordi pià belli. L'ho portata a casa"
Ore 18.58. "L'ho detto più
volte: trattative riservate non significa percorsi opachi e poco trasparenti".
Lo ha sottolineato il presidente M5S, Giuseppe Conte. "Sono state scritte delle
schifezze" sul fatto che "avrei fatto accordi", ad esempio per Casellati, ha
aggiunto.
"Io non ho mai fatto accordi
sottobanco", ha concluso Conte.
Conte: "Arriverà momento
chiarimenti in M5S"
Ore 19.00. "Meloni ha detto di
no a Draghi e oggi dice no a Mattarella: una scelta legittima. Ma mentre noi
siamo stati compatti, altri sono andati in ordine sparso: vuol dire che una
riflessione sull'alleanza andrà fatta. Io preferisco il gioco di squadra e non
battitore libero. Se qualcuno si sente di sinistra dovremmo riflettere ". Così
il leader della Lega, Matteo Salvini, su La7.
Conte: "Mai fatto accordi
sottobanco"
Ore 19.01. "La proposta di
Belloni non è venuta a me in mente: me l'hanno proposta Conte e Letta: poi se
Letta ha cambiato idea...". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, su
La7.
Salvini: "Serve riflettere su
centrodestra"
Ore 19.15. "L'asse
giallo-nero-verde? Attenti a non confondere i cittadini con questi effetti
cromatici! Ma insomma non diciamo o rincorriamo le fesserie che vengono
declamate a destra e sinistra: vi dico che i nomi su cui abbiamo trattato sono
stati condivisi da Pd e Leu ed io ho avuto l'incarico di negoziare con il
centrodestra". Così il presidente M5S Giuseppe Conte in conferenza stampa.
Salvini: "Belloni proposta da
Letta e Conte"
Ore 19.19. Si è conclusa la
prima chiama dei deputati all'ottava votazione per l'elezione del presidente
della Repubblica. E' ora in corsa la seconda chiama.
Conte: "Avevo delega Pd e Leu
a trattare con il centrodestra"
Ore 19.25. Dopo le chiamate
dei senatori e dei deputati, è ora in corso la prima chiama dei delegati
regionali.
Conclusa la prima chiama
deputati, al via la seconda
Ore 19.38. Si è appena
conclusa la prima chiama dei delegati regionali. Ora è in corso la seconda.
Al via la prima chiama dei
delegati regionali
Ore 19.40. E' conclusa la
seconda chiama dei delegati regionali. Il presidente della Camera Roberto Fico
ha chiuso l'ottava votazione. Ora inizia lo spoglio.
Terminata la prima chiama dei
delegati, ora la seconda
Ore 19.45. Il presidente della
Camera Roberto Fico sta procedendo allo scrutinio delle schede dell'ottava
votazione per l'elezione del presidente della Repubblica.
Conclusa la chiama dei
delegati regionali. Inizia lo spoglio
Ore 19.50. Il presidente
Sergio Mattarella, in caso di elezione, dopo che il presidente della Camera gli
avrà consegnato questa sera la lettera di elezione potrebbe parlare brevemente
dal Quirinale dove è prevista una diretta televisiva per l'evento.
Iniziato lo scrutinio delle
schede
Ore 19.56. Applausi e abbracci
da una trentina di parlamentari del M5S per il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio appena arrivato in Transatlantico. L'esponente M5S ha parlato qualche
minuto con deputati e senatori a lui vicini, mostrando soddisfazione per
l'intesa raggiunta sulla rielezione di Mattarella.
Se eletto, Mattarella parlerà
alle 21.30
Ore 20.12. La rielezione di
Mattarella fa gioire tanti anche alleati che appartengono a partiti spesso tra
di loro litigiosi. Stasera in transatlantico in tanti hanno notato un caloroso
abbraccio tra il ministro degli esteri Luigi Di Maio e il presidente Iv Ettore
Rosato, entrambi molto soddisfatti per l'esito della partita del Quirinale
Di Maio accolto da M5S con
applausi in Transatlantico
Ore 20.20. Il presidente
Sergio Mattarella ha superato nelloì'ottavo scrutinio il quprum dei 505 voti e
nell'Aula della Camera è esploso un fragoroso applauso da parte dei Grandi
elettori presenti.
In Transatlantico abbraccio
tra Di Maio (M5S) e Rosato (Iv)
Ore 20.38. Nell'Aula della
Camera sono durati più di quattro minuti gli applausi per il raggiungimento del
quorum di 505 voti da parte di Mattarella. L'atmosfera è ora decisamente più
rilassata. Non c'è più il silenzio da chiesa che ha caratterizzato la prima
parte dello spoglio. Alcuni grandi elettori conversano tra loro, mentre i
'contatori' continuano a tenere il conto delle schede.
Mattarella supera il quorum
dei 505 voti, esplode l'applauso in Aula
Ore 20.41. Il presidente della
Camera Roberto Fico ha dichiarato concluso lo spoglio delle schede dell'ottava
votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Ora è in corso il
conteggio dei voti.
Oltre quattro minuti di
applausi per Mattarella a quorum raggiunto
Ore 20.55. Il presidente della
Camera Roberto Fico ha proclamato Sergio Mattarella presidente della Repubblica.
Il Parlamento gli ha conferito il secondo mandato con 759 voti.
Spoglio terminato, al via il
conteggio dei voti
Ore 20.59. "La rielezione di
Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per
gli italiani. Sono grato al Presidente per la sua scelta di assecondare la
fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un secondo mandato." Così
il premier Mario Draghi.
Fico proclama Mattarella
presidente della Repubblica
Ore 21.00. Mi recherò
immediatamente al Quirinale con la presidente del Senato per comunicargli la sua
elezione". Lo ha annunciato nell'Aula di Montecitorio il presidente della Camera
Roberto Fico.
Draghi: "Rielezione Mattarella
splendida notizia per gli italiani"
Ore 21.01. Il presidente della
Camera Roberto Fico ha dichiarato concluso la seduta che ha portato alla
rielezione di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica.
Fico: "Mi recherò subito da
Mattarella per comunicare esito del voto"
Ore 21.02. "Buon lavoro
presidente Mattarella e grazie per il prezioso, rinnovato impegno. L'Italia,
dopo giorni preoccupanti e difficilmente tollerabili, puo' tirare un sospiro di
sollievo civile". Lo scrive su Twitter l'Anpi, l'associazione nazionale
partigiani.
Conclusa la seduta alla Camera
Ore 21.03. "Parlamentari
euforici per non aver cambiato nulla e aver costretto Mattarella a un altro
mandato. Cosa festeggiano? Che lo stipendio è salvo". Lo scrive su Facebook la
presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, postando un video degli
applausi dei parlamentari in Transatlantico per la rielezione di Sergio
Mattarella.
Anpi: "Grazie Mattarella,
prezioso impegno"
Ore 21.10. "E' una vittoria di
tutti, credo che il Parlamento abbia dimostrato saggezza perché Mattarella era
il presidente che volevano gli italiani". Lo ha detto il segretario del Pd
Enrico Letta in Transatlantico. "Il merito - si è schernito Letta con i
giornalisti - è del gioco di squadra di tutti. E' stata una settimana dura ma il
risultato è ottimo, perché è per il bene del Paese".
Alla domanda se il
centrodestra abbia perso, Letta ha glissato: "Ci sarà tempo per ragionare". A
chi gli faceva osservare che è il primo segretario del Pd che riceve una
ovazione dai propri deputati Letta ha risposto scherzando: "Allora mi devo
preoccupare".
Meloni: "Parlamentari
festeggiano stipendio salvo"
Ore 21.11. "Caro presidente
Mattarella, congratulazioni per la sua rielezione a presidente della Repubblica
Italiana. L'Italia può sempre contare sull'Ue". Lo scrive in un tweet in
italiano la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
Letta: "Rielezione Mattarella
è vittoria di tutti"
Ore 21.13. "Auguri, caro
Sergio, per la tua rielezione": comincia così un tweet di Emmanuel Macron per la
rielezione di Mattarella. "So di poter contare sul tuo impegno -
continua Macron - affinché viva l'amicizia fra i nostri paesi e questa Europa
unita, forte e prospera che stiamo costruendo". Al tweet, il presidente francese
ha aggiunto la foto delle evoluzioni delle pattuglie acrobatiche di Italia e
Francia in occasione della firma del Trattato del Quirinale: "Viva l'amicizia
tra l'Italia e la Francia!" conclude Macron, in italiano.
Von der Leyen: "Italia può
sempre contare su Ue"
Ore 21.14. La Cei esprime
"viva soddisfazione" per l'elezione di Sergio Mattarella a Presidente della
Repubblica. "Il suo mandato possa dispiegarsi all'insegna di quei valori di
libertà e di solidarietà contenuti nella Carta costituzionale di cui Ella è
sempre stato garante attivo e rigoroso", dice il cardinale presidente Gualtiero
Bassetti. "Il suo esempio di uomo e di statista - prosegue - lo spirito di
servizio e di sacrificio manifestato anche nella presente circostanza,
costituiscono un punto di riferimento per tutti i cittadini al di là delle
appartenenze politiche e degli schieramenti. Sono certo che nell'esercizio del
Suo alto incarico non cesserà di contribuire al superamento delle disuguaglianze
e delle fratture che feriscono il tessuto della comunità nazionale e che sono
acuite dall'emergenza pandemica ancora in corso".
Macron: "Auguri caro Sergio,
conta su di me"
Ore 21.17. Abbraccio e foto
tra Enrico Letta e Giuseppe Conte in Transatlantico, tra gli applausi dei Grandi
elettori, dopo l'elezione di Sergio Mattarella. "Che fatica", ha detto il
segretario del Pd avvicinandosi al presidente M5S. "Comunque grandissima cosa",
ha aggiunto.
I vescovi (Cei): "Grande
soddisfazione per elezione Mattarella"
Ore 21.19. Il presidente della
Camera Roberto Fico e la presidente del Senato Elisabetta Casellati stanno
raggiungendo in auto il Quirinale per comunicare a Sergio Mattarella l'esito
dell'ottava votazione in cui è stato rieletto presidente della Repubblica.
Abbraccio tra Letta e Conte in
Transatlantico
Ore 21.20. "Grazie presidente
Mattarella. Una scelta di grande responsabilità' contro il caos e per il bene
comune. Più forte l'Italia in Europa e nel mondo. E ora avanti con il governo
Draghi". Lo scrive su Twitter il commissario europeo per l'Economia, Paolo
Gentiloni.
Fico e Casellati lasciano la
Camera in auto per salire al Quirinale
Ore 21.24. "Mi congratulo
vivamente con l'amico Sergio Mattarella per il rinnovato incarico a presidente
della Repubblica italiana". Così su Twitter il presidente austriaco, Alexander
van der Bellen. "Le auguro il meglio per il successo del suo secondo mandato.
Penso già con piacere al nostro prossimo incontro", ha scritto van der Bellen.
Gentiloni: "Grazie Mattarella,
ora avanti con governo Draghi"
Ore 21.25. Felicitazioni per
la rielezione alla presidenza della Repubblica a Sergio Mattarella. Così su
Twitter il presidente della Svizzera, Ignazio Cassis. "Con l'Italia condividiamo
800 chilometri di confine, una lingua, importanti legami economici e numerose
convergenze in politica estera. Spero di ospitarla in Svizzera gia' nel 2022",
ha scritto Cassis nel suo messaggio di auguri.
Presidente austraco Van der
Bellen: "Congratulazioni a amico Mattarella"
Ore 21.26. Il presidente della
Camera Roberto FIco e la presidente del Senato Elisabetta Casellati sono
arrivati in auto al Quirinale. Ora nella sala del Bronzino comunicheranno a
Sergio Mattarella l'esito dell'ottava votazione che ha sancito la sua rielezione
come presidente della Repubblica.
Presidente svizzero Cassis:
"Felicitazioni a Mattarella"
Ore 21.33. Il presidente della
Camera Roberto Fico ha comunciato a Sergio Mattarella, al QUirinale, l'esito
dell'ottava votazione che lo ha rieletto presidente della Repubblica. Poi gli ha
consegnato i verbali della seduta.
Fico e Mattarella arrivano al
Quirinale
Ore 21.35. "Sono giorni
difficili che impongono di non sottrarsi alle decisioni del Parlamento". Queste
le parole del presidente della Repubblica nel suo breve discorso al Quirinale
davanti ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati.
Fico consegna a Mattarella il
verbale della seduta dell'elezione
Ore 21.40. "Io non commento
quello che sta accadendo nelle altre forze politiche, credo soltanto che anche
nel M5S serva aprire una riflessione politica interna". Lo ha detto Luigi Di
Maio parlando con i giornalisti alla Camera.
Mattarella: "Giorni difficili
che impongono di non sottrarsi alle decisioni Parlamento"
Ore 21.43. "Alcune leadership
hanno fallito, hanno alimentato tensioni e divisioni: dobbiamo lavorare per
unire, per allargare, la politica in questi giorni è rimasta vittima di se
stessa: per fortuna questo stallo l'hanno risolto il Parlamento grazie anche al
contributo del presidente del consiglio Mario Draghi". Così il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio lasciando Montecitorio dopo la rielezione di Sergio
Mattarella al Quirinale.
Ore 21.49. "Non abbiamo vinto
noi, ha vinto l'Italia. Oggi abbiamo un presidente di alto profilo, super
partes, autorevole e garante di tutti", commenta con i cronisti in
Transatlantico il leader M5S Giuseppe Conte.
Di Maio: "Alcuni leader hanno
fallito. Situazione risolta grazie a Draghi"
Di Maio: "Ora aprire
riflessione nel Movimento 5 Stelle"
Ore 21.50. "Voglio ringraziare
il presidente Mattarella per il suo senso delle istituzioni, per il suo
sacrificio. È molto importante rivolgersi un grazie". Lo ha detto il ministro
degli Esteri Luigi Di Maio fuori dalla Camera.
Conte: "Ha vinto l'Italia,
abbiamo un presidente garante"
Ore 21.51. "L'Italia è sempre
stata e continuerà essere una forza trainante all'interno dell'Unione europea.
Congratulazioni a Sergio Mattarella per la sua rielezione a Presidente della
Repubblica". Lo scrive su twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta
Metsola.
Di Maio: "Grazie a Mattarella
per i suoi sacrifici"
Ore 21.58. "Sono contento e
stanco" per un percorso di proposte di alto livello, di uomini donne, ora sono
contento per Mattarella, che forse avrebbe preferito, umanamente, stasera,
essere altrove". Così Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta.
La presidente del Parlamento
Ue Metsola: "Congratulazioni a Mattarella"
Ore 22.01. Telefonata di
gratitudine di Matteo Salvini al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Lo comunicano fonti della Lega.
Salvini: "Contento per
Mattarella che forse avrebbe preferito essere altrove"
Ore 22.09. "Congratulazioni al
presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per il suo secondo
mandato. Ha dedicato gran parte della sua vita al servizio dei cittadini e la
sua rielezione e' la testimonianza del ruolo importante che ha svolto in questi
anni in Italia. #Quirinale". Lo scrive su Twitter la presidente della Bce
Christine Lagarde.
Fonti Lega: telefonata di
gratitudine di Salvini a Mattarella
Ore 22.10. "Il Parlamento con
759 voti ha rieletto Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. A lui
vanno i miei auguri più sinceri ed il mio ringraziamento. Continuerà' a essere
garante assoluto dei valori della nostra Costituzione e un punto di riferimento
per la nostra comunità nazionale": Lo afferma il presidente della Camera Roberto
Fico.
Lagarde: "Mattarella ha
dedicato gran parte della sua vita al servizio cittadini"
Ore 22.11. "Desidero esprimere
al presidente Mattarella i più sinceri auguri per questo secondo mandato, che
gli consentirà di esercitare con rinnovata determinazione la funzione di garante
della Costituzione in una fase molto delicata per il futuro del Paese, che ci
vede impegnati ad affrontare le sfide economiche e sociali connesse alla ripresa
dalla pandemia". Lo dichiara il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.
"Sono certa che il suo autorevole esempio ci sarà di ispirazione e guida
nell'affrontare queste sfide. Buon lavoro, presidente", ha concluso.
Fico: "Mattarella continuerà a
essere garante della Costituzione"
Ore 22.21. "Desidero porgere
le mie cordiali felicitazioni per la sua rielezione alla suprema carica della
Repubblica italiana e formulare i migliori auguri per lo svolgimento del suo
alto compito, che ha accolto con spirito di generosa disponibilità". Lo
scrive Papa Francesco in un messaggio di congratulazioni per Sergio Mattarella,
rieletto alla presidenza della Repubblica. Il papa assicura al presidente la sua
preghiera "affinché possa continuare a sostenere il caro popolo italiano nel
costruire una convivenza sempre più fraterna e incoraggiarlo ad affrontare con
speranza l'avvenire".
Casellati: "Esempio Mattarella
sia guida"
Ore 22.24. "Se Letta si fida
ancora di me? Ci mancherebbe", ha detto ai cronisti in Transatlantico, alla
Camera, il leader M5S Giuseppe Conte.
Papa Francesco a Mattarella:
"Congratulazioni per alto compito"
Ore 22.25. Elisabetta Belloni
"era un profilo neutrale, una soluzione autorevole e adeguata nel caso dello
stallo". Lo ha detto Giorgia Meloni a Porta a porta su Rai1, spiegando di non
aver votato Mattarella perché "la considero una forzatura costituzionale" con
cui "barattiamo 7 anni di presidenza con sette mesi di legislatura" per la paura
dei parlamentari di andare al voto. Salvini come gliel'ha spiegato? "Non me l'ha
spiegato".
Conte: "Se Letta si fida di
me? Ci mancherebbe"
Ore 22.36. "Se la mia
valutazione su Salvini è cambiata dopo i contatti degli ultimi giorni? Abbiamo
lavorato a una soluzione per il Paese, poi ognuno ha una sua agenda politica. A
un certo punto Salvini ha voluto aprire gli spazi, cercare altri candidati, ma
secondo me non c'erano le condizioni". Così il presidente M5S Giuseppe Conte,
conversando con i giornalisti alla Camera.
Meloni: "Salvini non mi ha
spiegato la scelta di Mattarella"
Ore 22.37. "Congratulazioni e
auguri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella da tutte le donne e gli
uomini della Farnesina, in Italia e nel mondo La Sua guida sicura sarà nostra
ispirazione per affrontare sfide attuali e future". È quanto si legge in un
tweet della Farnesina.
Conte: "Salvini? Abbiamo
lavorato a soluzione"
Ore 22.41. La riunione del
Parlamento in seduta comune per il giuramento e il messaggio del Presidente
della Repubblica si terrà giovedì 3 febbraio alle 15.30.
Farnesina: "Mattarella guida
sicura e nostra ispirazione"
Giuramento Mattarella il 3
febbraio alle ore 15.30
Colloquio con Draghi e
appello dei leader dei partiti per un bis al Presidente Mattarella : “Se serve
una mano sono a disposizione”.
Il Corriere del Giorno il 29
Gennaio 2022.
Lo stallo superato con un
incontro di 40 minuti tra il Capo dello Stato e il premier al Colle. Vertice
della maggioranza e via libera alla riconferma. Salvini annuncia: “Gli italiani
non meritano altri giorni di confusione”. Berlusconi: “L’unità un dovere”.
Renzi: con Mattarella-Draghi Paese in sicurezza. L’ottavo scrutinio sarà quello
decisivo e comincerà alle 16.30.
La decisione di convergere sul
capo dello Stato arriva dopo una mattinata di incontri e consultazioni tra i
leader, il premier e lo stesso presidente della Repubblica che, raccontano in
ambienti parlamentari, avrebbe ricevuto diverse telefonate dai leader di partito
stamane mentre si trovava nella sua nuova casa di Roma. Mario Draghi ha fatto da
“trait d’union” tra il Colle e le forze politiche dopo un colloquio
con Mattarella a margine del giuramento al Quirinale di Filippo Patroni
Griffi come giudice della Corte Costituzionale. È opportuno che Mattarella resti
al Colle “per il bene e la stabilità del Paese” avrebbe affermato il premier –
secondo quanto si è appreso da fonti autorevoli – allo stesso presidente della
Repubblica e ai leader politici, che ha sentito nella mattinata. Dopo un vertice
dei leader della maggioranza l’annuncio dell’intesa per chiedere a Mattarella di
restare.
È durato circa un quarto d’ora
l’incontro fra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i capigruppo
della maggioranza, ricevuti al Colle poco prima della votazione con cui il
Parlamento dovrebbe rieleggere il capo dello Stato. Secondo quanto riferito dai
partecipanti, hanno preso la parola tre capigruppo. Al termine, Mattarella ha
ricevuto una delegazione delle Regioni.
I capigruppo della maggioranza
sono usciti assieme dal Palazzo del Quirinale, al termine dell’incontro col
presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Il Presidente Mattarella ci ha
detto che aveva altri piani per il suo futuro, ma vista la situazione ha detto
che serve una mano lui c’è, si è messo a disposizione“. Lo ha dichiarato la
capogruppo delle Autonomie al Senato Julia Unterberger lasciando il Quirinale.
“Lo abbiamo pregato, vista la situazione, di restare per un altro mandato” ha
riferito ancora Unterberger al termine del colloquio chiesto dai capigruppo al
Capo dello Stato.
“È andato tutto bene”, ha
confermato ai cronisti la senatrice Simona Malpezzi capogruppo del Pd al
Senato. Parole che hanno sbloccato lo stallo. “A questo punto Mattarella va
fatto nella votazione di oggi pomeriggio, non ha senso aspettare”, hanno detto
fonti parlamentari mentre i centristi che hanno lavorato fino all’ultimo, anche
in queste ultime ore, per la candidatura di Pier Ferdinando Casini hanno visto
sfumare la possibilità. Una previsione confermata dalle fonti della maggioranza.
“Si può chiudere su Mattarella già stasera”.
“Oggi pomeriggio rieleggeremo
un grande presidente. #Mattarella #Quirinale”. Lo scrive su Twitter il senatore
Pd Andrea Marcucci. Lunga e affettuosa la telefonata intercorsa tra Berlusconi
e Mattarella. Il presidente Berlusconi ha assicurato al presidente Mattarella il
sostegno di Forza Italia per la sua rielezione. “Questo è il momento dell’unità
e tutti dobbiamo sentirlo come un dovere. Ma l’unità oggi si può ritrovare
soltanto intorno alla figura del Presidente Sergio Mattarella, al quale sappiamo
di chiedere un grande sacrificio, ma sappiamo anche che glielo possiamo chiedere
nell’interesse superiore del Paese, quello stesso che ha sempre testimoniato nei
7 anni del suo altissimo mandato.” Così Silvio Berlusconi, dal San Raffaele di
Milano dove è ancora ricoverato.
Il segretario Pd Enrico
Letta all’assemblea con i grandi elettori alla Camera. “L’intero sistema
politico-istituzionale si regge attorno al Capo dello Stato e al capo del
Governo, che sono sopra la mischia“, ha aggiunto Letta. “Quel fragilissimo
equilibrio retto attorno a due personalità straordinarie può essere modificato
solo se c’è una intesa complessiva che tiene e, affinché ci sia, c’è bisogno
della nostra logica del né vincitori né vinti. Questa logica per adesso ispira
noi, ma non tutti gli altri“. “Altrimenti, il Parlamento ha una sua saggezza e
mi sembra che si stia esprimendo. Assecondare questa saggezza è anche questa
democrazia“.
Alle 16.30 si torna quindi in
Aula per l’ottava votazione del presidente della Repubblica. E, salvo sorprese,
sarà quella decisiva: l’intesa è stata raggiunta nel vertice di maggioranza e i
capigruppo delle forze politiche hanno incontrato e chiesto al
presidente Sergio Mattarella la disponibilità per una sua rielezione al
Quirinale.
“Romanzo Quirinale”: 6°
giorno, 8a votazione per l’elezione del Capo dello Stato.
Il Corriere del Giorno il 29
Gennaio 2022.
“È un momento difficile, lei
rappresenta l’unità del Parlamento. Grazie”. Questo il contenuto del
ragionamento fatto dai capigruppo della maggioranza al Capo dello Stato
Mattarella. “Rispetto il Parlamento anche se avevo altri programmi…”, la
risposta del presidente della Repubblica ai capigruppo.
di Redazione Politica
Dopo il settimo scrutinio di
questa mattina, al sesto giorno di votazioni per l’elezione del presidente della
Repubblica, si è giunti all’unica soluzione che mette insieme la maggioranza del
Parlamento attuale, e cioè la rielezione del presidente uscente Sergio
Mattarella. Una soluzione, sulla quale in molti sono pronti a scommettere: entro
le 20 di oggi la fumata bianca. “Stasera si chiude”, ha detto Matteo Renzi,
leader di Italia Viva ai suoi parlamentari. Quindi, salvo nuove sorprese e
virate a cui queste frenetiche giornate hanno ormai abituato, la votazione del
pomeriggio, l’ottavo scrutinio che partirà’ alle 16,30 di oggi, dopo la
sanificazione dell’Aula, potrebbe risultare quella decisiva.
“È un momento difficile, lei
rappresenta l’unità del Parlamento. Grazie”. Questo il contenuto del
ragionamento fatto dai capigruppo della maggioranza al Capo dello
Stato Mattarella. Ad intervenire, tra gli altri, sono stati i capigruppo al
Senato del Movimento 5 stelle, Castellone, di FI, Bernini, del gruppo misto De
Petris. “Rispetto il Parlamento anche se avevo altri programmi…”, la risposta
del presidente della Repubblica ai capigruppo.
LA GIORNATA IN DIRETTA
Ore 16:21 | Emiliano:
Mattarella non è sconfitta della politica
“È un momento importante, che
restituisce serenità al Paese intero, alla comunità istituzionale e soprattutto
alla gente. Tra breve potremo tornare al lavoro nelle nostre Regioni e quindi
questa comune convergenza sul presidente Mattarella non è, come qualcuno
immagina, la sconfitta della politica, anzi“. Lo ha detto il presidente della
Regione Puglia, Michele Emiliano, all’uscita dall’aula di Montecitorio a Roma.
Nel pomeriggio il governatore, con una delegazione di presidenti di Regione
(grandi elettori) per incontrare il presidente Mattarella, si è recato al
Quirinale insieme ai capigruppo della maggioranza.
“La sensazione è che ci siano
personalità e storie che riescono a tenere insieme anche punti di vista diversi,
ideologie diverse. Questo rafforza la Repubblica e naturalmente il
ringraziamento va dato anche al Presidente Draghi per il contributo che ha dato
alla chiusura di questo importante passaggio, che restituisce all’Italia anche
la serenità del Governo. Il mio augurio è che oggi pomeriggio si possa
definitivamente dare un assetto sia al Governo che alla Presidenza della
Repubblica“. ha concluso Emiliano
Ore 16:23 | “Il presidente
Mattarella è in ottima forma”.
Così’ ha commentato Attilio
Fontana, presidente della Regione Lombardia, rispondendo ai giornalisti che gli
chiedevano come avesse trovato il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella all’incontro coi presidenti di regione.
Ore 16:25 | Meloni: “Bisogna
rifondare daccapo il centrodestra“
“Il centrodestra parlamentare
mi pare che non esista. È ancora maggioranza nella nazione, credo che debba
avere rappresentanza politica, lavoreremo per questo. Bisogna rifondare il
centrodestra da capo. Per rispetto delle persone che si aspettano un
cambiamento”. Così Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia, uscendo dalla
Camera al termine della riunione coi grandi elettori di Fdi in vista dell’ottavo
scrutinio. “Mi aspettavo un atteggiamento diverso da molte persone e che il
centrodestra avesse molto più coraggio e convinzione nel fare una cosa che era
alla portata: battersi con dignità, a viso aperto, con orgoglio per eleggere un
Presidente distonico rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni – ha
aggiunto Giorgia Meloni ai cronisti – Non era un obiettivo scontato, bisognava
crederci. I margini c’erano. Questa cosa mi fa impazzire, mi fa impazzire che si
sia rinunciato prima di tentare davvero. Mi dispiace ma noi di FdI abbiamo fatto
di tutto”
Ore 16:30 | Al via l’ottavo
scrutinio: maggioranza a 505
È iniziato l’ottavo
scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. Al banco della
presidenza ci sono il presidente della Camera Roberto Fico e la presidente del
Senato Elisabetta Alberti Casellati. Il quorum richiesto è quello della
maggioranza assoluta dei componenti dell’ assemblea pari a 505 voti. In seguito
all’accordo raggiunto in mattinata dalla maggioranza dei partiti che sostengono
il governo, dovrebbe condurre alla riconferma del presidente
uscente, Mattarella.
Ore 16:37 | Letta: il governo
ne esce più forte
“Eleggevamo il presidente
della Repubblica, quindi non era in discussione il governo. Bisognava mettere
insieme tre perimetri: maggioranza di governo, perimetro delle coalizioni,
maggioranza che elegge con il capo dello Stato. Il governo esce oggi più forte.
La maggioranza è stata unita, ha lavorato assieme”. ha ha detto Enrico Letta in
conferenza stampa.
Ore 16:38 | Meloni: rilanciamo
elezione diretta Capo Stato
“Immediatamente, all’esito di
questo spettacolo indegno, rilanciamo la raccolta di firme online la proposta di
legge d’iniziativa popolare per l’elezione diretta del Capo dello Stato, che
giace in Parlamento“. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di FdI, incontrando la
stampa
Ore 16:40 | Il giuramento del
Capo dello Stato mercoledì pomeriggio
Il giuramento del nuovo Capo
dello Stato si terrà mercoledì pomeriggio tra le 15 e le 16. È quanto
apprendiamo da fonti parlamentari.
Ore 16:43 | Fedriga:
Mattarella ancora una volta uomo Stato
“Mattarella si è dimostrato
ancora una volta un grande uomo di Stato” ha detto il presidente della
Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, al termine dell’incontro col
presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Ore 16:56 | Letta: rimpasto?
Per noi va bene così
“Sono sempre stato nella mia
esperienza abbastanza ostile ai concetti di fase uno, fase due, tagliando.
Finisce sempre male. Per quanto ci riguarda il governo va bene così ed è nelle
prerogative del presidente del consiglio immaginare qualsiasi forma di
cambiamento”. Lo ha detto Enrico Letta in conferenza stampa. “La politica
è stata per qualche settimana in apnea, ora è importante che tutto funzioni al
meglio“, ha aggiunto.
Ore 17:05 | Giorgetti:
dimissioni? Serve nuova fase e metodo
“Sono felice che Mattarella
abbia accettato con senso di responsabilità l’intenzione del Parlamento di
indicarlo alla presidenza della Repubblica. Dimissioni? Per affrontare questa
nuova fase serve una messa a punto: il Governo con la sua maggioranza adotti un
nuovo tipo di metodo di lavoro che ci permetta di affrontare in maniera
costruttiva i tanti dossier, anche divisi, per non trasformare quest’anno in una
lunghissima, dannosa campagna elettorale che non serve al Paese”. Così il
ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine di un incontro
con il segretario della Lega Matteo Salvini. I due esponenti della Lega hanno
chiesto un incontro a Mario Draghi, aggiungendo “Ma va, ma che rimpasto…non
esiste…” negando che ci sia l’idea di un rimpasto dietro la sua richiesta di una
nuova fase, di una messa a punto nell’azione di governo.
Ore 17:30 | Quirinale, FdI
voterà Nordio
Fratelli
d’Italia voterà’ Carlo Nordio durante l’ottavo scrutinio per l’elezione del
presidente della Repubblica. Lo si apprende da fonti del partito
di Giorgia Meloni.
Ore 17:35 | Conclusa seconda
chiama senatori, ora votano deputati
Si è conclusa anche la seconda
chiama dei senatori. Adesso ha inizio la prima chiama dei deputati. Durante
la settimana votazione, dopo l’apertura al suo bis, i voti per il capo dello
Stato sono aumentati salendo a 387 rispetto a ieri (336).
Ore 17:35 | Legge
Elettorale, Letta: “deve essere in agenda nei prossimi mesi“
“La legge elettorale deve
essere in agenda e, per quanto ci riguarda, c’è tutto l’interesse a metterla in
agenda. Quella attuale è forse la più brutta che ci sia stata regalata. Ritengo
che nell’agenda dei prossimi mesi la legge elettorale ci debba essere“. ha detto
il segretario Pd Enrico Letta in conferenza stampa alla Camera.
Ore 17:40 | Bernini:
convergenza su Mattarella riscatto politica
“La convergenza sul nome del
presidente Mattarella non è la sconfitta, ma il riscatto della politica,
perché si è arrivati a un accordo che garantisce continuità istituzionale e
stabilità di governo. Una soluzione dunque che va prima di tutto nell’interesse
del Paese nel momento in cui la pandemia non è finita, la ripresa va
accompagnata con le riforme del Pnrr e le tensioni internazionali stanno
purtroppo crescendo. Forza Italia ha svolto il suo ruolo con responsabilità,
favorendo in autonomia, grazie alla guida del presidente Berlusconi, lo sbocco
migliore a un’impasse che rischiava di determinare una crisi di sistema. Non ci
sono nè vinti nè vincitori: oggi ha vinto l’Italia”. afferma la presidente dei
senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.
Ore 17:51 | Giorgetti: ora
nuovo codice comportamento tra alleati
“Vedo che Letta – pronti,
partenza e via – ha chiesto una legge elettorale proporzionale… Non è una
questione di rimpasto. Già i problemi sono rilevanti se siamo una squadra,
dobbiamo essere una squadra” ha commentato Giancarlo Giorgetti parlando con i
cronisti alla Camera insieme a Matteo Salvini, ed aggiunto “Credo che sappiate
perfettamente gli appuntamenti elettorali che ci sono nel prossimo anno,
elettorali, di vario ordine e natura, referendari. Il governo ha fatto benissimo
lavora benissimo ma un anno così richiede probabilmente quantomeno un codice di
comportamento tra alleati di una maggioranza. Draghi sa anche lui cosa ci
aspetta. Siccome i problemi sono importanti e socialmente impattanti se non
c’è solidarietà di maggioranza è complicato“.
Ore 18:00 | Renzi ricorda il
trasformismo e le capriole politiche della Lega e M5S
“E’ bello che in sette
anni Salvini sia passato dal tweet del 2015 ‘Mattarella non è il mio
presidente‘ a ‘Mattarella è la mia scelta‘, parole dette oggi. E’ bello che in
sette anni la Lega è passato dal ‘no a Mattarella’ al ‘si’ Mattarella‘. ha
detto Matteo Renzi parlando con i giornalisti davanti Montecitorio, ricordando
che “i 5 stelle sono passati dalla richiesta di impeachment del 2018 ad oggi…
” concludendo “noi siamo quelli che sette anni fa hanno scelto e
votato Mattarella con un sorriso e oggi scelgono e votano Mattarella con un
sorriso ancora più grande“.
Ore 18:17 | Salvini:
centrodestra compatto in 2023? Sì, ma capire chi ci sarà
“Certo, ma bisogna capire chi
è nel centrodestra“. Così il segretario leghista Matteo Salvini risponde a chi
gli chiede se il centrodestra si presenterà compatto alle politiche del 2023.
“La Lega è stata trainante e compatta qualcun altro no”, nel centrodestra.
“Berlusconi immagino fosse furioso coi suoi che in 40 non hanno votato il
candidato presidente si chiariranno al loro interno“, ha aggiunto.”Giorgia
Meloni dice che il centrodestra non esiste? È una amica, e non commento le
parole degli amici”.
Ore 18:25 | Toti posta foto
con Mattarella: “Grazie presidente“
“Con i miei colleghi
governatori di Regione davanti al Quirinale dopo la visita al presidente
Mattarella che, con grande generosità e profondo senso delle istituzioni, ha
dato la sua disponibilità a continuare il suo mandato“. È il messaggio postato
da Giovanni Toti, governatore della Liguria, su Twitter aggiungendo una foto con
tutti i colleghi all’uscita dal Quirinale.
Ore 18:31 | Pd, Franceschini
saluta Letta: “Ecco the winner”
Siparietto a margine della
votazione di oggi pomeriggio alla Camera: il ministro Dario Franceschini si è
avvicinato al segretario del Pd Enrico Letta in Transatlantico e, salutandolo,
lo ha apostrofato con “The Winner!”. Il riferimento è all’intesa raggiunta nella
maggioranza per arrivare a un secondo mandato di Mattarella al Quirinale.
Ore 18:45 | Letta: terrò
matita con cui ho votato Mattarella
“La matita con la quale ho
appena votato Mattarella. Me la tengo tra i ricordi. Belli”, scrive su Twitter
il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, pubblicando una foto della
matita in questione.
Ore 18:46 | Conte: con
rielezione Mattarella ha vinto il Paese
L’ipotesi di scegliere una
donna al Quirinale “non è stata una mera formalità“, ma “quest’ultima battaglia
non siamo riusciti a vincerla, abbiamo trovato degli ostacoli”, ma di fronte a
ciò avevamo “un’opzione di garanzia, assolutamente fuori quota”, Sergio
Mattarella. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il presidente M5s, Giuseppe
Conte.“Ci sono tanti che parlando di vincitori e vinti. Noi non ci sentiamo
vincitori o sconfitti in nessuna delle tappe. Non ha vinto Conte o M5s“, ma con
la rielezione di Mattarella “ha vinto il Paese“.
Ore 18:59 | Salvini:
“Belloni proposta da Letta e Conte”
“La proposta di Belloni non è
venuta a me in mente: me l’hanno proposta Conte e Letta: poi se Letta ha
cambiato idea…“. ha rivelato il leader della Lega, Matteo
Salvini, a #maratonaMentana su La7
Ore 19:42 | Concluso il voto
Si è conclusa l’ottava
votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. Ora il presidente
della Camera Roberto Fico procederà allo scrutinio.
Ore 20:12 | Mattarella
raggiunge il quorum
Il presidente uscente Sergio
Mattarella raggiunge il quorum dei 505 voti necessari per l’elezione: l’Aula gli
tributa un lunghissimo applauso.
Ore 20:22 | Bonomi:
“Soddisfatti per rielezione”
“Desidero esprimere
soddisfazione, da parte di tutta Confindustria, per la conferma di Sergio
Mattarella al Quirinale: la sua autorevolezza e prestigio nel ruolo di garante
della Costituzione e delle scelte europee e atlantiche è un presidio di
credibilità nazionale“. Così Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria,
sull’elezione del Capo dello Stato.
Ore 20:34 | Moratti: “Grande
apprezzamento per Mattarella”
“Grande apprezzamento a Sergio
Mattarella per aver accettato la conferma a Presidente della Repubblica. Grazie
alla generosa disponibilità del Capo dello Stato, il Quirinale continuerà nella
sua preziosa opera di tutela della Costituzione e di garante delle Istituzioni e
dei Cittadini”, così la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti.
Ore 21:48 | Mattarella:
“responsabilità e rispetto decisioni Camere“
“I giorni difficili trascorsi
per l’elezione alla presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza
sul piano sanitario economico e sociale richiamano al senso di responsabilità e
al rispetto delle decisioni del Parlamento” ha detto il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella dopo aver ricevuto dai
presidenti Fico e Casellati la comunicazione della sua rielezione. “Grazie a
parlamentari e delegati per la fiducia” ha detto in televisione il rieletto
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ringraziato “i parlamentari
e i delegati per la fiducia“. “Le condizioni di grave emergenza sanitaria,
economia e sociale che stiamo vivendo impongono di non sottrarsi ai doveri a cui
si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su
prospettive personali differenti, con l’impegno di interpretare le attese e le
speranze dei nostri concittadini”. ha concluso il rieletto presidente della
Repubblica .
(ANSA il 29 gennaio 2022) -
Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. L'ottavo
scrutinio è ancora in corso ma è stato superato il quorum dei 505 voti,
necessario per l'elezione.
(ANSA il 29 gennaio 2022) - In
Aula si leva un applauso: è il segno che i "contatori" hanno fatto capire ai
grandi elettori che è scattata la rielezione di Sergio Mattarella.
Tutta l'Aula si è levata in
piedi al raggiungimento del quorum per un lungo, liberatorio applauso. Tanti
deputati stanno facendo foto e filmati con i cellulari. Emanuele Fiano, Simona
Malpezzi ed Enrico Letta si danno il 'cinque'. Il Capogruppo M5S Davide Crippa è
abbracciato dai colleghi. Il presidente Fico sta facendo "sfogare" l'Assemblea.
A breve riprenderà lo spoglio.
(ANSA il 29 gennaio 2022) -
"La rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una
splendida notizia per gli italiani. Sono grato al Presidente per la sua scelta
di assecondare la fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un
secondo mandato". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi.
(ANSA il 29 gennaio 2022) -
"Auguri, caro Sergio, per la tua rielezione": comincia così un tweet di Emmanuel
Macron per la rielezione di Mattarella. "So di poter contare sul tuo impegno -
continua Macron - affinché viva l'amicizia fra i nostri paesi e questa Europa
unita, forte e prospera che stiamo costruendo". Al tweet, il presidente francese
ha aggiunto la foto delle evoluzioni delle pattuglie acrobatiche di Italia e
Francia in occasione della firma del Trattato del Quirinale: "Viva l'amicizia
tra l'Italia e la Francia!" conclude Macron, in italiano.
(ANSA il 29 gennaio 2022) -
"Congratulazioni a Sergio Mattarella per la sua rielezione a Presidente della
Repubblica Italiana. Credo fermamente che l'Italia continuerà a contribuire
costruttivamente alla crescita dell'Ue". Lo scrive in un tweet il presidente del
Consiglio europeo Charles Michel. (ANSA).
(ANSA il 29 gennaio 2022) - La
politica italiana rielegge un "riluttante" Sergio Mattarella a presidente della
Repubblica. E' il titolo del Washington Post che descrive Mattarella come un
ampiamente rispettato ex giudice della corte costituzionale che ha ricevuto di
recente una standing ovation di quattro minuti a La Scala.
L'elezione riflette anche "il
fallimento dei deboli e divisi partiti politici italiani", che dopo una
settimana di deliberazioni non hanno saputo trovare un accordo a sostegno di un
singolo nome. La rielezione di Mattarella, aggiunge il Washington Post, è una
"spinta alla stabilità dell'Italia di breve termine".
Il testo integrale del
discorso di Mattarella, dopo l’elezione.
Il Corriere della Sera il 29
gennaio 2022.
Nella serata del 29 gennaio
2022, dopo aver ricevuto dai presidenti della Camera, Roberto Fico, e del
Senato, Elisabetta Alberti Casellati, , ha letto un breve messaggio al Paese.
Ecco il testo integrale. Ringrazio i presidenti della Camera e del Senato per la
loro comunicazione. Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle
Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi
per l’elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza
che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico e
su quello sociale richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle
decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri
cui si è chiamati, e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su
prospettive personali differenti, con l’impegno di interpretare le attese e le
speranze dei nostri concittadini.
Quirinale, il discorso di
Mattarella dopo la rielezione: "Grazie per fiducia, accetto per responsabilità".
L'Espresso
il 29 gennaio 2022.
Ringrazia per la fiducia. E
accetta il secondo incarico al Quirinale "per senso di responsabilità". È un
discorso breve e asciutto quello che Sergio Mattarella ha pronunciato subito
dopo la sua rielezione davanti ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed
Elisabetta Casellati, saliti al Colle per comunicargli l'esito della votazione
del Parlamento. "Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati regionali per
la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per
l'elezione della presidenza della Repubblica, nei giorni dell'emergenza che
stiamo ancora attraversando, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto
delle decisioni del Parlamento. Queste considerazioni impongono di non sottrarsi
ai doveri cui si è chiamati e devono prevalere su considerazioni e prospettive
personali".
Il Mattarella bis spezza il
disastroso gioco della sedia dei partiti.
Susanna Turco su
L'Espresso il 29 gennaio 2022.
La soluzione al rebus è ovvia,
ma arriva in una maniera mai vista: i leader inseguono non tanto i Grandi
elettori, ma la paura che tutto crolli. La politica è all’anno zero. La svolta è
di Salvini, mentre alla Camera si teme di rieleggere il capo dello Stato «per
caso». Ma il centrodestra è in pezzi, Giusepppe Conte arranca. E neanche Mario
Draghi si sente tanto bene. «Oh ma non è per caso che eleggiamo Mattarella
durante questa votazione, senza nemmeno accorgercene?». Alle 12.20 in
Transatlantico un nuovo terrore misto a sollievo corre sul filo: quello della
rielezione per caso, «a loro insaputa», ultima evoluzione della più nota «a mia
insaputa» entrata nel brocardo della politica grazie a Claudio Scajola, nel
lontanissimo 2010. Un’inconsapevolezza collettiva, in questo caso: cioè il
contrario della politica, che è previsione, trattativa, sagacia, costruzione.
Il record di Enrico Letta:
per due volte ha giocato la partita del Quirinale e per due volte ha puntato sul
bis. Carlo
Tecce su L'Espresso il 29 gennaio 2022.
Il segretario si è messo in
difesa per non rompere il partito e sin da subito ha caldeggiato il secondo
mandato di Mattarella come già accaduto con Napolitano. Stavolta le condizioni
sono diverse e il Capo dello Stato potrà accettare senza date di scadenza o
dimissioni prescritte. Enrico Letta sta per registrare un imbattibile record.
Per due volte si è ritrovato a gestire il voto per il Quirinale, in condizioni
diverse, e per due volte ha propiziato la nomina del presidente della Repubblica
uscente. In soli nove anni.
Nel 2013 raccolse esanime il
Pd dopo le dimissioni del segretario Pier Luigi Bersani e il tradimento dei 101
contro il fondatore Romano Prodi e fu il primo a incamminarsi verso il Colle per
chiedere a Giorgio Napolitano quello che aspettava gli chiedessero: restare per
un po’ nonostante gli 88 anni da compiere.
Mattarella rieletto
presidente della Repubblica. Il più votato nella storia dopo Sandro Pertini.
Antonello de
Gennaro su Il Corriere del Giorno il 29 Gennaio 2022.
Mattarella bis: nel corso
dell’ottava votazione, l’attuale e dodicesimo presidente della Repubblica è
stato confermato dai grandi elettori. Draghi e Mattarella sono soli, e liberi da
ogni condizionamento. I partiti si sono sciolti, e questa non è una brutta
notizia.
Al termine del suo primo
settennato, e dopo sette scrutini andati a vuoto e sei convulsi giorni di
trattative, miseramente fallite, tra i partiti, Sergio Mattarella è stato
rieletto presidente della Repubblica. Lo ha deciso questa sera il Parlamento con
l’ottava votazione, stabilendo così il bis del Capo dello Stato uscente. Anche
sette anni fa Mattarella fu eletto di sabato: era il 31 gennaio del 2015, allora
ottenne 665 voti.
Con l’ ottava votazione,
avvenuta questa sera sabato 29 gennaio 2022, il capo dello Stato, 80 anni, ha
superato la maggioranza assoluta dei grandi elettori, fissata a 505 voti, con
circa 760 preferenze. Mattarella ha dunque superato il “bis”
di Giorgio Napolitano ed è il più votato dopo Sandro Pertini. Il superamento di
quota 505 è stato sottolineato da un lungo applauso dei parlamentari presenti
nell’emiciclo di Montecitorio.
Nonostante avesse lasciato la
sua casa di Palermo ed affittato una casa nel quartiere Pinciano a Roma, dove si
sarebbe trasferito in settimana dopo la cerimonia di fine mandato, adesso Sergio
Mattarella dovrà restare al Quirinale. Nelle votazioni precedenti all’ottava che
ha sancito la sua proclamazione, Mattarella aveva già ottenuto nei giorni scorsi
voti dai Grandi elettori. Nella prima votazione del 24 gennaio scorso il Capo
dello Stato uscente aveva ricevuto 16 voti, nella seconda 39, nella terza 125 e
nella quarta 166. Alla quinta votazione per Mattarella hanno votato in 46 e alla
sesta in 336. Fino ad arrivare alla settima (387 voti) e all’ ultima ottava
votazione che lo ha visto eleggere.
Mario Draghi resta presidente
del Consiglio e con Mattarella assicura la necessaria continuità fondamentale
per il Paese. E’ un’ottima notizia per l’Italia che avrà ancora per un
anno Mario Draghi premier a Palazzo Chigi, costituendo la coppia istituzionale
che ha gestito il Paese dopo il disastro della pandemia. Siamo di fronte ad un
vero e proprio cumulo di macerie dei partiti che escono “rottamati”.
E’ la seconda volta in poco
meno di un anno che i partiti non sono riusciti a risolvere questioni
fondamentali per il Paese; in un primo momento a non riuscire a formare un
governo dopo la crisi del Governo Conte II, ed ora a scegliere un Presidente
della Repubblica.
“La rielezione di Sergio
Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli
italiani. Sono grato al Presidente per la sua scelta di assecondare la
fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un secondo mandato” è il
commento del presidente del Consiglio Mario Draghi.
“Caro presidente
Mattarella, congratulazioni per la sua rielezione a presidente della Repubblica
Italiana. L’Italia può sempre contare sull’Ue”. Lo scrive in un tweet in
italiano la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
“Caro e stimato Amico Sergio
Mattarella ! Mi congratulo vivamente per il rinnovato incarico a Presidente
della Repubblica italiana e Le auguro il meglio per il successo del Suo secondo
mandato. Penso già con piacere al nostro prossimo incontro”. Lo scrive su
Twitter il presidente della Repubblica d’Austria, Alexander Van der Bellen a
seguito della rielezione di Sergio Mattarella a Capo dello Stato.
Su Twitter, si è complimentato
il presidente francese Emmanuel Macron: “Congratulazioni, caro Sergio, per la
tua rielezione. So che posso contare sul tuo impegno per mantenere viva
l’amicizia tra i nostri paesi e l’Europa unita, forte e prospera che stiamo
costruendo“.
I presidenti di Camera e
Senato. Roberto Fico ed Elisabetta Casellati si sono recati al Quirinale per
formalizzare il risultato delle elezioni comunicandolo al riconfermato
Presidente Mattarella. Il Capo dello Stato dopo che il presidente della Camera
gli ha consegnato questa sera la lettera di elezione ha parlato brevemente dal
Quirinale dove era stata prevista una diretta televisiva per l’evento.
Il Presidente Sergio
Mattarella con il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il
Presidente della Camera Roberto Fico, in occasione della comunicazione
dell’esito della votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica.
“Desidero ringraziare i
parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei
confronti. I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla presidenza della
Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul
versante sanitario, su quello economico, su quello sociale richiamano al senso
di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste
condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati, e
naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali
differenti, con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri
concittadini” ha dichiarato Mattarella dopo che presidenti della Camera, Roberto
Fico, e del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, gli hanno comunicato
ufficialmente il risultato.
Per i leader la convergenza
sulla rielezione del presidente Mattarella è uno “zero a zero” palla al
centro. Di fatto nessuno di loro ha vinto, o meglio tutti hanno perso.
Festeggiano i grandi elettori. La presidenza Mattarella garantisce stabilità, la
naturale conclusione della legislatura, l’ultima prima del taglio dei
parlamentari. Ad interpretare il sentimento nascosto dei parlamentari, a
settembre scatta la pensione per tutti ai 65 anni di età, un particolare non
indifferente anche se nessuno ne parla, ma in realtà quasi tutti sotto sotto ci
pensano.
La legislatura a questo punto
è salva ed il Parlamento può arrivare alla sua naturale conclusione del mandato
elettorale nel 2023. Grazie a Sergio Mattarella e Mario Draghi.
La giornata dell’elezione
di Mattarella: la svolta, i leader confusi, l’applauso liberatorio.
Aldo Cazzullo su Il
Corriere della Sera il 29 Gennaio 2022.
Le parole di Salvini, il tweet
furioso di Meloni, il catenaccio di Letta, la gioia dei peones, la processione
dei capigruppo, il caso-Giorgetti. Fino all’applauso finale, che fa calare il
sipario su una settimana surreale.
La svolta della settimana che
- per la seconda volta nella storia - ha visto la rielezione del capo dello
Stato è alle undici del mattino del sabato. Matteo Salvini ha appena annunciato
il sì alla rielezione di Sergio Mattarella. Si ferma un attimo in un angolo, al
secondo piano di Montecitorio: «Io il grande sconfitto? Ho fatto diciotto
riunioni, tutte inutili. Ho proposto nomi importanti, tutti bruciati. Ho detto
alla sinistra: fateli voi, i nomi. Hanno risposto: Belloni, e poi se la sono
bruciata loro. Basta. Mattarella resta al Quirinale, Draghi a Palazzo Chigi, i
ministri e i parlamentari al loro posto»; e che cominci la campagna elettorale,
l’unico contesto in cui Salvini dopo i disastri di questi giorni si sente
davvero a proprio agio.
Giorgia Meloni twitta:
«Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro
mandato. Non voglio crederci». Parole quasi sprezzanti per sancire che il
centrodestra non esiste più, a questo punto ognuno per sé; e la Lega potrebbe
prenderla in parola e lanciare la riforma proporzionale, graditissima ai
democristiani del Pd, ai 5 Stelle e a Forza Italia. Dal suo letto d’ospedale,
Berlusconi fa sapere che va bene così: se il capo dello Stato non può essere
lui, meglio che non sia nessun altro; si va avanti con quello che c’era già.
In Transatlantico, Enrico
Letta ha rimesso gli occhiali, che alle maratone tv si toglie perché la
mascherina li appanna. Ha adottato la tecnica del Padova di Rocco, il
catenaccio; è rimasto fermo, lasciando che gli altri andassero a sbattere. Ora
dice: «Il Mattarella bis era il nostro sogno. È diventato realtà». Draghi però
avrebbe garantito il Paese per sette anni; se nel 2023 la destra avrà la
maggioranza in Parlamento, cosa accadrà? «Cercheremo di evitare che la destra
abbia la maggioranza in Parlamento». Il ministro Andrea Orlando: «Aspettiamo a
esultare, Salvini sarebbe capace di bruciare pure Mattarella». «Sergio è
ignifugo» lo rassicura un peone. I peones, loro, sono decisamente allegri:
sentono di aver sconfitto i tecnici e soprattutto di aver salvato lo stipendio,
e pure la pensione.
Oltre a quelli del Pd, anche i
grillini votano in massa Mattarella già nell’inutile rito del mattino: alla fine
sono 387 le schede per il presidente. Dieci irriducibili votano Pierferdinando
Casini, che si fa vivo rinunciando fuori tempo massimo a una candidatura a cui
nessuno ha mai messo il veto, ma che non ha mai convinto davvero nessuno. Mario
Draghi ha due voti, gli stessi di Emilio Scalzo, leader No-Tav finito in galera
per aver picchiato un gendarme francese («se avesse picchiato uno dei nostri non
gli sarebbe successo niente» mormora il questore della Camera Edmondo Cirielli,
Fratelli d’Italia, ex carabiniere). La rielezione di Mattarella evita al premier
l’umiliazione pubblica, ma pure la sua figura esce un po’ appannata: non aveva
nascosto di tenere al Quirinale, e quasi tutti i partiti hanno fatto di tutto
per non mandarcelo.
Alle tre di pomeriggio la
penosa processione dei capigruppo – tra cui molte donne: Boschi, Bernini,
Malpezzi, Serracchiani, Unterberger… – sale al Colle per implorare Mattarella di
accettare la rielezione. Subito dopo arrivano al Quirinale pure i presidenti di
Regione, sollevati: «I nostri elettori si lamentavano, i voti per Terence Hill e
Nino Frassica li facevano molto arrabbiare». Giani (Toscana) racconta che
Mattarella non appariva poi così affranto, anzi, «mi è parso soddisfatto, pronto
ad andare avanti. I suoi collaboratori, Zampetti, Guerrini, erano felicissimi».
Al di là dell’enfasi mediatica
su scatoloni, traslochi e caparra della nuova casa , che alla lunga potrebbe non
avergli giovato, il presidente era sincero quando sperava di avere un
successore. Ha preso un Paese gonfio di risentimenti antieuropei e antisistema,
e si apprestava a lasciarlo con il più europeista dei governi, sostenuto dalle
forze un tempo antisistema. Nei mesi più duri della pandemia ha rappresentato lo
spirito di resistenza degli italiani. Dalla rielezione, per quanto storica, ha
tutto da perdere. C’è un unico precedente: nel 2013 Napolitano maltrattò i
grandi elettori che lo acclamavano, chiedendo riforme costituzionali che non
hanno fatto una bella fine, mentre lui si dimetteva dopo due anni. Mattarella è
stato chiaro su questo punto: non esiste l’istituto della rielezione a tempo; il
presidente è arbitro del proprio destino.
Alle quattro e mezza del
pomeriggio ricomincia per l’ultima volta la sequenza della chiama, delle mani da
disinfettare, delle schede: la segretaria generale del Senato Serafin le apre,
Fico le legge, la Casellati, che si è ripresa, le verifica. Ovviamente ora sono
tutti i migliori amici di Mattarella. Clemente Mastella, che non vota – lo fa
per lui la moglie senatrice – ma viene qui tutti i giorni, rievoca quando non
avevano ancora trent’anni, «io ero capufficio stampa della Dc, Sergio era
direttore del Popolo, e ci alternavamo come editorialisti. Poi lui diventò
ministro, io sottosegretario: dovevo andare agli Interni con Gava, ma Sergio mi
disse: Gava non ti vuole, perché non vai con Martinazzoli alla Difesa?».
Un capannello di parlamentari
toscani sta parlando ovviamente di Renzi: «Stavolta Matteo non ha fatto il
king-maker, ma ha bruciato prima Frattini, poi la Belloni. Questa notte la capa
dei servizi avrà sfogliato il suo dossier, alla ricerca di qualcosa che non
fosse ancora uscito…Matteo stesso l’ha detto: “Se adesso sparisco…”». Ovviamente
scherzano. Non era una burla però il trionfale tweet di Grillo — « Benvenuta
Signora Italia, ti aspettavamo da tempo» — scritto quando ormai la candidatura
Belloni era stata affossata. Insomma i leader non ci stanno capendo più nulla.
Si affaccia Conte, a esprimere soddisfazione nella sua neolingua borbonica: lui
avrebbe preferito una donna, ma i gruppi erano per Mattarella, quindi va bene
così. I 5 Stelle sono i più numerosi e i più divisi, infatti finiranno per
scindersi tra i puri e i governisti, ma per il momento hanno retto anche se in
serata esplode lo scontro Conte-Di Maio. Tra i forzisti colpiva la gioia maligna
con cui molti hanno accolto la bocciatura della Casellati.
Micciché, sicuro fin
dall’inizio della rielezione di Mattarella, spadroneggia: «Se volete vi do anche
i numeri del Superenalotto e i vincitori delle corse ippiche, la schedina
l’hanno purtroppo abolita». La Meloni apprezza meno la sicilitudine: «Siamo al
Gattopardo, tutto deve cambiare affinché nulla cambi. Noi votiamo Nordio». Alla
fine l’ex pm avrà 90 voti, 27 in più dei grandi elettori di Fratelli d’Italia:
forzisti che gradirebbero tornare in Parlamento con l’amica Giorgia. Mattarella
segue lo spoglio nel suo appartamento privato al Quirinale, insieme con i figli,
i nipoti, i collaboratori; prepara qualche parola da dire agli italiani, in
attesa di parlare alle Camere la prossima settimana. Ex deputati che proprio non
riescono a dimenticare la politica fanno l’aperitivo alla buvette.
Alla fine, quando il rito
consacra l’eletto anzi il rieletto, si crea sempre un’atmosfera, se non di
solennità, di serietà. Alle 8 e 20 si arriva a quota 505, un grande applauso
saluta idealmente Sergio Mattarella, anche se la pandemia impone pure qui il
distanziamento. Letta dà il cinque a Fiano, Malpezzi, Serracchiani e al
tesoriere Verini, che raccoglie matite elettorali per ricordo. Da destra
applausi brevi, non c’è molto da festeggiare, il leghista Claudio Borghi si
incupisce: «Molto buia è la notte». Giorgetti smentisce le voci di dimissioni ,
ma vuole portare Salvini da Draghi per parlare di un anno di governo che sarà
durissimo.
Alle 20 e 44 Fico legge il
responso, Mattarella ha 759 voti, ne mancano qualche decina. I grandi elettori
si scattano a vicenda foto ricordo. Arriva Conte, di persona è decisamente più
sciolto che in tv, abbraccia Letta, si fa i selfie – «fate presto che non riesco
più a trattenere la pancia» – con i grillini, prudentemente si fa ripetere il
loro nome; nel frattempo Di Maio chiede un «chiarimento politico».
I ministri del Pd
assicurano che non c’è stata nessuna regia occulta, che ha contato molto la
spinta dal basso del Parlamento, che ha cominciato a votare Mattarella anche
quando la consegna era scheda bianca. Il messaggio dei peones era per Draghi:
sentono di non contare molto più di nulla, sorvolati dai voti di fiducia, irrisi
dai social; ma il capo dello Stato lo eleggono ancora loro; il tempo dirà se è
stata lungimiranza oppure orgoglio.
Fuori nella notte attendono le
autoblù, che portano Casellati e Fico sul Colle. Da Mattarella poche parole: le
sue «prospettive personali» erano altre, ma l’emergenza sanitaria, economica,
sociale, la volontà del Parlamento, il senso di responsabilità impongono di «non
sottrarsi ai doveri cui si è chiamati». Nel Transatlantico ci si congratula l’un
l’altro, si ha fretta di dimenticare. Le trattorie attorno sono tutte prenotate.
La vita incombe: la pandemia, le bollette, il Pnrr, l’inflazione, pure
l’Ucraina, invocata di continuo anche se a nessuno importa nulla.
Cala il sipario, con un certo
sollievo degli spettatori, su questa settimana surreale: i superalbi di Diabolik
dell’on. Cantone, l’esilarante e melanconico resoconto sgarbiano delle
telefonate tra Berlusconi e gli scoiattoli, il deputato in Ferrari, le ambulanze
che ancora ieri mattina portavano a votare scheda bianca qualche parlamentare
positivo al Covid mentre a duecento metri da Montecitorio una donna moldava
morente aspettava un’ambulanza vera per un’ora, il leggendario Toninelli che
esordisce «oggi è il giorno del silenzio» e poi arringa le telecamere per venti
minuti, l’onorevole No Vax Sara Cunial che contesta la legittimità dell’elezione
perché lei non ha potuto votare; e i tanti dettagli della commedia del potere
impotente, i mille piccoli disgusti di se stessi – direbbe Rostand – che alla
fine non fanno un rimorso pieno, ma un malessere oscuro.
Così è nato il Mattarella
bis: le ore decisive e la lite nella notte su Belloni.
Francesco Verderami su Il
Corriere della Sera il 30 Gennaio 2022.
L’elezione del Presidente
della Repubblica e ’ultima trattativa sulla responsabile dei Servizi segreti. E
dalla rosa di Letta era sparito il nome Draghi. Lo stop dei leghisti del Nord a
Casini.
Mattarella resta. La corsa al
Colle viene interrotta all’ottavo giro per l’incapacità dei suoi protagonisti di
arrivare al traguardo. Questo è il resoconto della sfida per il
Quirinale politicamente più sgrammaticata della storia, zeppa di strafalcioni,
scarabocchi, errori da matita blu. E dalla quale tutti escono a vario titolo
sconfitti. La notte della politica è proprio l’ultima notte prima dell’esame,
quando i leader si rendono conto che devono prepararsi a consegnare il compito.
Ma il loro foglio è bianco. Nell’ansia di recuperare il tempo perso, dopo aver
detto che «c’era tempo», Salvini si fa dare l’ennesimo mandato dagli alleati di
centrodestra. Sono d’accordo che sui nomi non c’è accordo, ma su un punto si
intendono: nessuno vuole un secondo incarico al capo dello Stato uscente.
D’altronde il leader del Carroccio lo aveva anticipato all’assemblea dei grandi
elettori leghisti: «... e non accetteremo mai un Mattarella-bis». Così, dopo
aver incontrato il premier, si chiude con Letta e Conte — a loro volta divisi —
per discutere chi scegliere.
Già lì accade qualcosa di
strano, perché il segretario del Pd davanti al capo di M5S presenta una rosa di
nomi senza Draghi. Più tardi, Salvini racconterà maliziosamente che «quando con
Letta parlavamo in assenza di Conte, il nome di Draghi non mancava». Stava nella
lista insieme ad altri, compreso Mattarella. Non è proprio un esercizio di stile
confondere in un parterre di quirinabili chi siede al Quirinale. Ma Conte e
Salvini non ci fanno caso, perché nella rosa c’è il nome su cui
puntano: Belloni. E dire che nel Pd era già scoppiato il putiferio tre giorni
prima: proporre alla presidenza della Repubblica il capo dei servizi segreti non
è roba da Paese dell’Occidente democratico. Riproporlo e trovare un’intesa su
quel nome è diabolico. Eppure questo accade. E quando Conte (insieme a Salvini)
rende pubblicamente noto che stanno puntando su una donna, il gioco pare
chiuso. Franceschini sembra rassegnato: «È fatta purtroppo, perché con i voti
della Meloni hanno i numeri. E in Aula si creerà un effetto trascinamento che ci
costringerà a votarla». La De Petris, una vita passata nelle file di sinistra,
si attacca al cellulare e in romanesco avvisa i compagni del Pd: «C’avete
proprio rotto er...».
Mattarella bis, settimane in
silenzio, poi il tormento delle votazioni. Per il presidente il mandato è di
sette anni
Non proprio con queste parole,
ma con lo stesso tono di voce, Guerini spiega a Letta alcuni rudimenti di
politica. Più tardi confiderà a un deputato del suo partito: «Non ho mai gridato
così in vita mia». Grida al telefono anche con i dirigenti di Forza Italia,
perché dichiarino subito la loro contrarietà alla candidatura. Con Renzi non c’è
bisogno, si muove di suo: «Hanno provato a mettercela nel (bip) con Frattini.
Ora ci riprovano con Belloni. Se non li fermiamo lanceranno anche il generale
Figliuolo». Renzi ha appena finito di cenare con Casini, che oscilla tra
l’ottimismo e il più nero pessimismo: per questo gli ha offerto una pizza e una
bottiglia di champagne. Intanto i forzisti escono dal letargo e organizzano
insieme agli altri centristi un piano per la resistenza.
Nel retro di un ristorante
Toti chiama Di Maio, che sta alterato di suo: «È una cosa folle. Non ne sapevo
nulla. Ho sempre detto che se si deve andare su un tecnico per me c’è solo
Draghi. Se è un politico, si può fare con Casini». E allora comincia la conta
per Casini. Solo che Salvini non può starci, perché su quel nome i leghisti del
Nord sono sopra le barricate. Dirà il governatore lombardo Fontana «non sarei
più potuto andare alle feste di partito e a casa sarei arrivato solo se
scortato».
I numeri ballano e intanto i
ministri forzisti premono perché il Cavaliere vada su Mattarella. Sanno che
Draghi ha realizzato di non avere spazio e sta spingendo affinché sul Colle
resti l’inquilino in scadenza di affitto. Peraltro nel pomeriggio,
previdente, Giorgetti aveva invitato il dem Delrio a far sì che sul capo dello
Stato uscente iniziassero a «scivolare» a scrutinio segreto un po’ di voti:
«Perché vedo come si stanno muovendo questi pazzi e temo che si vadano a
cacciare in altri guai. Fermiamo questa giostra». E la giostra si ferma: i voti
per Casini non garantiscono e Berlusconi vira su Mattarella.
Per Salvini e Conte è il game
over. Il leader della Lega prova a intestarsi il bis e viene bocciato dai suoi
stessi compagni di partito: «Se era la sua prima scelta, avrebbe dovuto proporlo
alla prima votazione». E quando Franceschini incorona Letta come «the winner»,
lividamente Conte rende noto che «Letta puntava su Draghi, dunque anche lui ha
perso». Le scolaresche il giorno dopo salgono al Quirinale e ammettono di essere
impreparate: «E con minore ruvidità di Napolitano — dice Toti — ci ha
congedati». Non prima dell’ennesimo siparietto di cui si rende protagonista il
forzista Barelli, che si rivolge così a Mattarella: «Presidente, se ha bisogno
di spostare gli scatoloni, può contare su di noi». «Farò da me». E lo farà per
sette anni: «La mia non sarà una presidenza a tempo». Di Maio avrà tutto il
tempo per fare ciò che si è ripromesso: «Chiederò la verifica nel Movimento.
Perché quello è pericoloso e se ne deve andare». Fine della ricreazione.
Le pagelle dei leader nella
partita del Quirinale.
di Roberto Gressi su Il Corriere della Sera il 29 Gennaio 2022.
Risultato ottimo, ma hanno
copiato. Nessuna idea nuova è giunta in porto e i voti ne risentono. Si chiude
il trimestre: che cosa resta nella bisaccia dei capi in attesa dell’esame
elettorale di maturità?
MATTEO SALVINI
Quei nomi nel frullatore e la
coalizione si sfalda
Matteo Salvini passa da
un’ovazione bulgara all’altra dei suoi grandi elettori e di volta in volta
soavemente infila nel frullatore un ex presidente del Consiglio di Stato, un
capo dei Servizi segreti e un presidente del Senato (l’ultima ci mette del suo).
Non offre una rosa, ma addirittura un mazzo. Nomi su nomi che durano lo spazio
di un amen. Appena esce dai vertici e scemano gli applausi, nella Lega si
sentono solo mugugni. Forza Italia si stufa e tratta da sola, Fratelli d’Italia
un po’ lo preme e un po’ lo asseconda, non si sa bene se per aiutarlo o per il
gusto sadico di vederlo inciampare. In pochi giorni sotto la sua guida la
coalizione vacilla, sbanda, sbarella, litiga e divorzia. Ognuno per sé, tra
agguati, sgambetti e nostalgia per Silvio Berlusconi. Umberto Bossi inanella
rasoiate e gli tira i coriandoli, concludendo che con lui non si batte un chiodo
e azzeccando la profezia: vedrete, alla fine farà quello che gli dice il
Cavaliere. Resta in sella soprattutto perché nella Lega è il più bravo, ma forse
non come una volta, a fare la campagna elettorale.
Voto 4
GIORGIA MELONI
Ha una parola sola ma non si
mette in gioco
Il generale e filosofo cinese
Sun Tzu, vissuto mezzo millennio prima di Cristo, avverte che non si vincono le
battaglie se si pretende di uscirne così come si è entrati. Giorgia Meloni non
ci crede, evidentemente, perché non solo non riporta ferite, ma nemmeno gli
abiti si sgualciscono. È la sua forza, la donna con una parola sola, ma anche la
sua debolezza, perché non si mette mai davvero in gioco. No al governo di unità
nazionale, no all’accordo finale sulla conferma di Mattarella. Posizioni che
sottopone al giudizio degli elettori, con qualche ragione di successo,
ma nessuno l’ha vista ancora misurarsi, in senso lato, in ruoli di governo del
Paese. Però si sa muovere, eccome. Sposa e in buona parte impone il tentativo
della spallata, anche se pochi dubitano della sua capacità di prevedere che
sarebbe fallita. Salvini quasi ci lascia le penne, mezza Forza Italia si lecca
le ferite, ma lei no, non rimedia nemmeno uno schizzo di fango. Certo, non
incassa il voto anticipato, ma le elezioni arriveranno. Non si sa però se
basterà un voto in più della Lega per impugnare il timone.
Voto 5+
SILVIO BERLUSCONI
Si ritira ma continua ad
esercitare il suo ruolo
Nella dottrina morale
cattolica la superbia è considerata il peccato narcisistico per eccellenza
e Silvio Berlusconi ci inciampa, tenendo inchiodata per troppo tempo la sua
coalizione nel tentativo velleitario di salire lui sul Colle. Certo, si ravvede,
ma ormai la carta l’ha giocata ed è costretto a lasciare Matteo Salvini a
trastullarsi. La salute lo obbliga a guardare i contorcimenti della coalizione
che ha fondato, e cresciuto per un quarto di secolo, dal San Raffaele. Troppo
lontano da Montecitorio per mettere mano quando rancori, rivalità e
improvvisazioni prendono il sopravvento. Con lui distante i suoi sono poco più
che gattini ciechi, e questo gli consente alla fine di esercitare ancora un
ruolo importante, tanto che si attribuisce a lui la lucidità per convergere in
zona Cesarini su Sergio Mattarella. Lo aspetta una strada impervia, con il
centrodestra, pur favorito nei sondaggi, che non c’è più. È ancora lui l’unico
che può tentare di tenere insieme la baracca, vittima della voracità degli
alleati, sempreché non si stufi e decida di stare a guardare mentre vanno a
sbattere.
Voto 5+
GIUSEPPE CONTE
Si perde in duelli interni: la
sua guida è a rischio
Ginocchia flesse, spalla
avanti, gomito in linea con il polso. Giuseppe Conte perde il suo tempo
a duellare di fioretto con Luigi Di Maio, senza però avere il coraggio di
impugnare la scimitarra. Costringe Beppe Grillo a fare l’equilibrista, per
evitare che la sua creatura si sbricioli, si scinda e si condanni
all’irrilevanza ancora prima della sentenza delle urne. Civetta con Matteo
Salvini, dimenticando la furia del Papeete e rimpiangendo l’antica amicizia. Il
Pd lo guarda con sospetto ma lui giura che non intende tradire l’alleanza. Così
come giura che il suo è un sì convinto a Mario Draghi, un sì perché resti al
governo. Che è più o meno l’equivalente di dire ti amo come una sorella. Le
assemblee dei suoi gruppi parlamentari lo prendono più volte d’infilata,
obbligandolo a lunghi giri, tutti di corsa, per sorpassarli e mettersi di nuovo
alla testa, adeguandosi alla nuova linea. L’amico Luigi sta quasi per
strozzarlo quando goffamente contribuisce, con l’amico Matteo, a mettere in
difficoltà Elisabetta Belloni, con una candidatura improvvisata. La sua
leadership è a rischio.
Voto 4,5
ENRICO LETTA
Porta a casa il risultato,
guai tra satrapi e alleati
Nel partito dei satrapi, dove
ce n’è sempre per lo meno uno golpista, Enrico Letta riesce, con pazienza, a
portare a casa la pelle. Non malaccio per un segretario sceso in campo con
truppe scarse e a dir poco riottose. Si spende a lungo, con prudenza, per Mario
Draghi, muovendosi sul filo del rasoio, con Giuseppe Conte che vuole il premier
morto, in compagnia di Dario Franceschini, e contando sull’ambivalente sostegno
a distanza di Luigi Di Maio. E siccome non si tratta di fatti personali, ma solo
di politica, cura anche il canale con Italia viva. Azzecca la tattica
parlamentare sulla prova di forza con Maria Elisabetta Alberti Casellati,
lasciando il centrodestra a contarsi. Invita al volo a assecondare la saggezza
dei grandi elettori, dopo la prova del nove su Mattarella. Ma si muove sulle
uova. Gli fanno notare che Conte è ambizioso,e lui dice che è uomo d’onore . Lo
avvertono che Saigon, al confronto del Pd, sembra Disneyland, e lui celebra
l’unità. Lo aspetta un anno scivoloso, che si chiuderà, prima del voto, con la
formazione delle liste. Per la serie il pericolo è il mio mestiere.
Voto 6,5
MATTEO RENZI
Da pirata a corsaro arriva il
doppio passo
La goletta pirata di Matteo
Renzi si trasforma via via, nel corso della partita in una nave corsara. La
differenza è sostanziale: la prima va all’assalto con un solo obiettivo, il
bottino. La seconda seguendo un progetto. Entra nell’agone sostenendo che spetta
al centrodestra fare la prima mossa, attirandosi più di un sospetto di
intelligenza con il nemico. Non sarebbe la prima volta che mescola i suoi voti
senza pregiudizi. In realtà cerca invece di perseguire l’obiettivo di un accordo
ampio, mantenendo aperto il confronto e, udite udite, trovando anche un robusto
filo di dialogo con Letta. Guarda a Casini, spinge per Draghi, vede prima di
altri la possibilità di convergere su Mattarella. Lo aiuta anche la capacità di
mettersi alla guida di situazioni che lo sorpassano. Probabilmente si guadagna
sul campo il diritto a una legge elettorale con una soglia bassa di sbarramento.
Ma anche in caso di sconfitta ha un paracadute: i pirati, una volta catturati,
venivano giustiziati senza processo. I corsari no, erano considerati prigionieri
di guerra.
Voto 6
Quirinaleide, ecco le
pagelle dei protagonisti.
Chi vince, chi perde e chi pareggia: ecco la fine della
"occupazione" dello Stato da parte dei partiti. Lanfranco Caminiti su Il Dubbio
il 30 gennaio 2022.
La tentazione di dare le
pagelle per questa quirinaleide è forte – e chi sono io per sottrarmi.
Nell’elenco dei peggiori,
metto Salvini, un vero ganassa, un capitan sfracasso inconcludente che è
riuscito a bruciare e rendere irricevibile quella obbiettiva possibilità per il
centro-destra di fare un nome per il Quirinale e che con la stessa candidatura,
mai formalizzata e poi ritirata, di Berlusconi era stata messa nel piatto,
candidatura che lo stesso Salvini, per primo, aveva contribuito a infragilire;
Salvini non è cambiato mai da quando era un “giovane leghista” che gridava
“forza Etna”, sempre sopra le righe, passando per il Papeete, le sue tirate
allarmistiche e feroci contro gli immigrati e i meridionali – questa non è la
Lega che amministra sui suoi territori del nord, concreta e capace: prima o poi,
anche se Salvini riesce ancora a raccogliere la melma del voto degli italiani,
questa frattura si spezzerà. Non solo, ma senza questo riequilibrio della Lega,
non ci sarà ricomposizione del centro-destra: io dico che il prossimo leader
della Lega sarà Luca Zaia, non Giorgetti.
Poi, tra i peggiori,
c’è Grillo – con il suo infelice tweet su #signoraitalia, che spingeva la
candidatura della Belloni, e quindi la costruzione di un asse Conte-Salvini, nel
nome di una “candidata donna” e anche “né di destra né di sinistra”, una
retorica vieta e banale che puntava alla prova di forza in nome
dell’inamovibilità di Draghi dal suo posto che squassava però proprio il governo
con la ricostituzione di una maggioranza forte (il vecchio asse giallo-verde)
dentro una maggioranza più larga – un ragionamento insostenibile, cucinato già
prima da Grillo con il suo ultimo video, in cui non si capiva una sega, tranne
che lui mollava Draghi.
Il terzo dei peggiori
è Conte – un vanitoso avvocaticchio e professoricchio che porta bene la sua
pochette, che vanta numerose fan di signore di mezza età (maschi e femmine) per
il suo ciuffo sempre a posto, già capace di cambiare un alleato con un altro nel
passaggio da giallo-verde a giallo-rosso nel volgere di una notte pur di restare
in sella: uno scivoloso capitone. Davvero un personaggio inqualificabile, un
malfidato che indebolisce ulteriormente un centro-sinistra già scombiccherato di
suo, e che ha giocato una pessima partita per il Quirinale.
Tra i migliori
metterei Casini, un po’ per quel suo stare defilato anche se sapeva che il suo
nome era in corsa, eccome, ma soprattutto quando ha fatto sapere urbi et
orbi che pregava di cancellare ogni sua possibile candidatura mentre diventava
credibile la riconferma di Mattarella, dando così un saggio di ciò che significa
essere democristiani d’antan. Casini potrebbe essere uno dei “costruttori” di un
nuovo centro largo.
E tra i migliori c’è
sicuramente Draghi, il migliore di tutti, anzi: la sua “geometria invariata”
(«non sono possibili maggioranze diverse nell’elezione del presidente e nel
sostegno al governo») vince. Chi lo critica per avare avanzato una sua
candidatura («il nonno a servizio delle istituzioni») continua a non capire una
ceppa dell’uomo e a fare ricorso a epiteti e pregiudizi. Draghi non poteva
mettersi apertamente e “privatamente” in corsa perché questo avrebbe significato
uno sgarbo nei confronti di Mattarella, uno sgarbo e una incrinatura che si
sarebbero riversati in quella possibile “riproposizione” della squadra vincente
che non si cambia, che è poi accaduta davvero – d’altronde, lui è lì perché
Mattarella l’ha chiamato.
Poi, ci sono i pareggiatori,
quelli che non perdono ma neppure vincono, ma vanno più verso la vittoria che
verso la sconfitta: Letta, che ha giocato solo di interdizione, nella peggior
riproposizione del catenaccio all’italiana, ma poi mette la palla in
rete; Renzi, che si è tirato fuori, consapevole del suo “peso” di scarso
rilievo, ma che alla fine si ritrova con i due nomi che lui ha voluto stessero
proprio dove sono; Di Maio, che non poteva andare contro Draghi, visto che è
ministro di questo governo e in un ruolo enorme – anche se non sempre onorato
come si deve, ma il ragazzo si farà – e che comunque è un governista di natura
ma si è ritrovato alle dipendenze di un segretario, Conte, che faceva e
disfaceva per conto proprio, e ha saputo tenere botta, che poi è la cosa che gli
riesce meglio, la facciaditolla: chissà che non possa anche lui far parte di un
nuovo centro. E infine Meloni, che perde per un verso – una qualsiasi voce in
capitolo nel centro-destra – ma che incassa per un altro – intestandosi
l’opposizione dura e pura a Draghi – anche se questo non farà di lei una
possibile leader del centro-destra come area governativa e anzi la fa scivolare
verso un pericoloso estremismo o comunque verso un “fattore di esclusione”.
Detto tutto questo – che è
“colore” – io penso che l’elezione rinnovata di Mattarella sia davvero la
conclamata fine della Prima Repubblica, che poi è anche la Seconda e la Terza:
ovvero del ruolo che i partiti hanno sempre avuto nell’essere contemporaneamente
“Stato”.
Tra i partiti e lo Stato (le
istituzioni) quella sovrapposizione che ha caratterizzato, e sostanzialmente
anche “aiutato”, la costituzione materiale di questo straccio di democrazia che
abbiamo avuto dal secondo dopoguerra, si è aperta una frattura insanabile. Le
istituzioni – lo Stato – sono una cosa a sé: dal Presidente della Repubblica,
passando per il presidente del Consiglio, e poggiando sui governatori delle
Regioni e i sindaci (e aggiungerei la Consulta, fresca di nomina di Giuliano
Amato), lo Stato si va riassettando e configurando come una cosa “diversa”,
altra dai partiti, dalla politica. È un “progetto” forse coltivato con più
consapevolezza dai dem, soprattutto per il loro ruolo in Europa, ma che certo
non possono intestarsi, perché ne è contemporaneamente la loro “fine politica”,
la loro “eutanasia politica”. Direi che in questa forma si può spiegare la
“partita” di Letta e il modo con cui l’ha giocata. E forse anche la “mossa” di
Grillo verso la Belloni.
La fine della “occupazione”
dello Stato da parte dei partiti è di quelle notizie che non è facile
interpretare. Uno Stato “senza partiti”, ovvero senza politica, dove conta
l’autorevolezza del ruolo (il consenso sociale di Draghi e Mattarella) legato a
un “formalismo istituzionale” di garanzia che mette sotto il tappeto le
contraddizioni della “rappresentanza”, quindi della società – può davvero
lasciare il passo a una democrazia formale, svuotata cioè di quell’anima che
solo la sostanzia, ovvero la differenza di interessi, ovvero il conflitto. Ma
apre, nello stesso tempo, a una riflessione enorme – su cui bisognerà tornare –
tra il centro e la periferia. Ovvero: tra nuova forma dello Stato e nuova
politica.
Mattarella-bis, Enrico
Letta sconcertante: "Me la tengo tra i ricordi, quelli belli". Travolto dagli
insulti.
Libero Quotidiano il 29 gennaio 2022.
“La matita con la quale ho
appena votato Mattarella. Me la tengo tra i ricordi. Belli”. Lo ha
scritto Enrico Letta a corredo di una foto scattata subito dopo aver espresso la
sua preferenza per il bis di Sergio Mattarella al Quirinale.
Ancor prima che venisse
raggiunto il quorum, il segretario del Pd si è lasciato andare e ha esultato per
l'imminente verdetto dell'aula. Lo ha fatto sui social, dove vuole spacciare il
bis come una grande vittoria. (forse perché in tempi non sospetti è sempre stato
sostenitore del Mattarella bis?). Peccato però che Letta sia uno sconfitto al
pari di tutti i suoi colleghi.
Rieleggendo l’attuale capo
dello Stato, i leader dei partiti che compongono la maggioranza sono usciti da
questa partita con un grosso danno a livello di credibilità e capacità
politiche. Mattarella costretto a quel bis che non voleva. Non a caso sotto al
post della matita Letta ha ricevuto decine e decine di commenti di cittadini
arrabbiati e delusi per come è stata giocata la partita sul Quirinale. Tra
l’altro il segretario del Pd ha fatto registrare un record imbattibile (o almeno
si spera): quello di aver eletto per due folte di fila lo stesso presidente
della Repubblica che già era in carica.
L’ottimismo della matita:
un segno sul Colle.
Aldo Grasso su Il Corriere della Sera il 30 Gennaio 2022.
Un segno sul Colle.
La matita scrive ombre di parole, dice il poeta, ed è un peccato dilapidarla. I
«grandi elettori» che hanno nominato il presidente della Repubblica erano 1.009:
per ogni scrutinio erano a disposizione altrettante matite che, dopo l’uso,
venivano eliminate per ragioni sanitarie o, poche, portate a casa da chi le
aveva usate: fatti due calcoli, «hai risolto un bel problema/e va bene così/ma
poi me ne restano mille/poi me ne restano mille». In una filastrocca su un bosco
incantato, Gianni Rodari lamentava una sola cosa: «C’è quasi tutto, insomma, ma
non c’è, udite udite!, l’albero delle matite». Federico Fellini diceva che aveva
bisogno di avere sempre in mano una matita perché la sua immaginazione si
animasse davvero.
I «grandi elettori» (piccoli
lettori) sono entrati prima in confusione, ma infine dalla leggerezza della
matita, dalla rotondità della guaina di legno dolce e dalla punta ben temperata
sono stati costretti alla nobiltà della scrittura e della scelta. Non per caso,
nella «Storia della matita», Peter Handke esalta le doti segrete che il «lapis»
custodisce: concentrazione e silenzio.
Ebbene, queste
(e)lezioni quirinalizie passeranno alla storia per essere state caratterizzate
dal pessimismo della gomma (per cancellare) e dall’ottimismo della matita.
Dal Bla bla bla in stile
Greta all’uovo di Mastella.
Gian Antonio Stella su Il
Corriere della Sera il 30 Gennaio 2022.
ANSIA Col debito pubblico al
160%, l’impennata dei costi dell’energia sulle imprese, le famiglie angosciate
per le bollette carissime, i picchi spropositati dei morti per Covid e i venti
di guerra in Ucraina c’era davvero bisogno di caricare l’Italia di altra ansia
dovuta a uno scontro così scomposto agli occhi dell’Europa? Mah...
BLA-BLA-BLA Chissà cosa
avrebbe detto Greta Thunberg se avesse assistito alla girandola impazzita di
proposte, polemiche, chiacchiere e deliri intorno a un tema così serio in questi
tempi così seri. Potete scommetterci, avrebbe liquidato tutto come dopo il
vertice di Glasgow: «Bla-bla-bla». Sinceramente: un passaggio politico così
importante meritava di meglio.
COLEOTTERO «Quando proposi di
mandare una donna al Quirinale scrissero: bella provocazione. Manco avessi
proposto un coleottero. Sono parole che Giuliano Amato, da ieri presidente della
Corte Costituzionale, disse un quarto di secolo fa. Sia come sia, magari per i
motivi più sacrosanti, anche stavolta è andata così. Non sarà il caso di
chiedersi «come mai proprio mai»?
DONNA «Casellati non è
candidata in quanto donna ma in quanto figura istituzionale e valido
professionista e servitore dello Stato riconosciuto a livello nazionale e
internazionale» (Salvini, venerdì mattina, prima della batosta). «Sto lavorando
perché l’Italia abbia finalmente un presidente donna in gamba, non in quanto
donna, ma in quanto presidente donna in gamba (ancora Salvini, la sera, dopo il
tracollo)
ELISABETTA II «Benvenuta
Signora Italia, ti aspettavamo da tempo». Manco il tempo che Beppe Grillo
benedisse con un tweet Elisabetta Belloni, dopo il tramonto dell’omonima, e nel
M5S esplodeva il caos. Farsi una telefonata prima? Troppa fatica? Resta un
dubbio: fino a che punto Enrico Letta, confrontandosi con Salvini e Conte aveva
lasciata aperta la porta a una candidatura della stimatissima segretaria
generale della Farnesina oggi direttrice dei «servizi»?
FEDERALISMO Parola icona
sventolata per anni dalla Lega anche nella variante più bellicosa (Bossi: «Il
Nord o vede arrivare lo Stato federale o riprende la via della lotta di
liberazione, della secessione») è del tutto sparita nella settimana elettorale
quirinalizia. Neppure una citazione, in tutte le declinazioni, su tutte le
agenzie. Come un tema secondario.
GRIGLIATA Non occorre essere
Steven Raichlen, campione mondiale di barbecue, per sapere una cosa: mai mettere
troppa carne al fuoco. La destra aveva più legna di tutti: 452 grandi elettori.
Ma via via, dopo aver riscaldato a bagnomaria Silvio Berlusconi, ha messo sulla
griglia di tutto: Marcello Pera, Letizia Moratti, Carlo Nordio fino a tastare
qua e là altre ipotesi vere o fasulle, da Sabino Cassese a Franco Frattini a
Giampiero Massolo fino a incenerire Elisabetta Casellati e per poi appiccicare
le fiamme anche a Paola Severino ed Elisabetta Belloni. Il risultato è noto.
IMPEACHMENT «L’impeachment di
Mattarella non si può fare? Sbagliato, si può fare. Se la Lega non arretra,
l’impeachment è una certezza assoluta», disse Luigi Di Maio alla fine di maggio
del 2018. Ieri sera gongolava come fosse il trionfo del nonno prediletto.
LEGISLATURA Così bello è il
palazzo coi suoi stucchi, i suoi divani e le sue prebende che i 345 parlamentari
destinati a lasciare le Camere dopo i tagli hanno pesato assai sul rifiuto di
interrompere la legislatura. Al di là di ogni ideologia. Tanto da ricordare un
sonetto del Belli: «Co sta razza de mobbili a palazzo, / che maravija poi si a
li signori / je viè la voja de nun fa’ più un ca...»
MARIO (DRAGHI) «Comunque vada,
il Paese tra pochi mesi entrerà in campagna elettorale e non c’è chi ignori che
tale periodo sia di solito fatale per i governi di unità nazionale. Inoltre, il
presidente del Consiglio è troppo esperto di politica per ignorare che è quasi
impossibile attuare riforme in un tale contesto. Se Draghi dovesse inciampare
nelle elezioni presidenziali, non c’è alcuna garanzia che possa continuare a
governare. E anche se oggi è all’apice del potere, non è inconsapevole che nel
giro di pochi mesi, poche settimane o pochi giorni, potrebbe essere cacciato dai
partiti che non avranno più bisogno di lui». ( Le Monde , 26 gennaio)
NO Risposta che Matteo Salvini
dice d’aver «sempre ricevuto qualunque nome facessi».
OFFESA «Sono stata offesa e
tradita sia dal punto di vista personale sia, soprattutto, da quello
istituzionale». L’amarezza di Elisabetta Casellati per il bidone tiratole dagli
«amici» è comprensibile. Un po’ meno, perfino al di là delle polemiche sull’uso
dei voli di Stato, la sua scelta, un attimo prima che si votasse sulla sua
candidatura, di permettere la nascita d’un nuovo gruppo, «Cal», che avrebbe
doluto raccogliere fuoriusciti del M5S e forse disponibili a votare... Gruppo
sciolto, dopo la tranvata, la sera stessa. Un record.
POLITICA, POLITICA,
POLITICA Un coro: «Al Quirinale ci vuole un politico». «Il nuovo presidente deve
essere un politico». «È ora di tornare alla politica». Da destra e da sinistra.
Non è mancata qualche citazione di Massimo D’Alema: «Io non conosco questa cosa,
questa politica, che viene fatta dai cittadini e non dalla politica. La politica
è un ramo specialistico delle professioni intellettuali». Tanti anni dopo,
riecco le invocazioni. Finché, in extremis, sboccia l’appello alla prima donna
in Quirinale. Una tecnica. Ma è questa, la politica?
QUALITÀ Mai come stavolta,
forse, in tempi recenti, è stata sbandierata la scelta di persone di «Alto
Profilo». Un tormentone. Sia chiaro, non è la prima volta. Anni fa il già citato
D’Alema si vantò: «Abbiamo un problema solo: l’enorme abbondanza nel
centro-sinistra di persone di altissima qualità». Una vanteria così spropositata
che molti si chiesero: scherza? Il guaio è che sono in troppi a crederci
davvero.
RICOMINCIAMO «Gli italiani non
meritano altri giorni di confusione. Io ho la coscienza a posto, ho fatto
numerose proposte tutte di alto livello, tutte bocciate dalla sinistra.
Riconfermiamo il presidente Mattarella al Quirinale e Draghi al governo, subito
al lavoro». Un inno a Adriano Pappalardo: ricominciamo.
SERVIZI «Che il capo dei
Servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile.
Elisabetta Belloni è una mia amica. Ma dai Servizi segreti non si va al
Quirinale: chi non lo capisce ha il senso istituzionale di un Gormito». (Matteo
Renzi. Seguito a ruota da Paolo Cirino Pomicino: «Facciamo come Boris Eltsin che
nominò come successore il direttore dell’ex Kgb Vladimir Putin?»).
TRADIMENTO Forse mai come ieri
si è gridato tanto al tradimento. Su tutti, la più furente è Giorgia Meloni.
Chiudendo trionfante il festival di Atreju, un mese fa, aveva detto: «La pacchia
è finita, alle prossime elezioni il centrodestra ha i numeri per essere
determinante. Non accetteremo compromessi, vogliamo un patriota».
UOVO «Vedi questo uovo? L’uovo
di Colombo? In questo caso è l’uovo di Mastella. Dissero a Colombo che lui
sbatteva l’uovo per tenerlo in piedi che erano tutti capaci, ma nessuno ci
pensava. (...) Voglio dire che è più facile che una gallina faccia un uovo che
qui esca il presidente della Repubblica!» (Clemente Mastella, Maître à penser
presentissimo nel ruolo di marito della senatrice Alessandrina Lonardo, del
gruppo Noi Di Centro da lei medesima costituito).
VETI Lo sbarramento più duro,
forse, è stato quello alzato immediatamente contro Franco Frattini, l’ex
ministro degli Esteri berlusconiano appena diventato presidente del Consiglio di
Stato. «La scelta del Presidente della Repubblica non ha solo ricadute interne.
I venti di guerra che soffiano dall’Ucraina ci ricordano che all’Italia serve un
o una presidente della Repubblica chiaramente europeista, atlantista, senza
ombre di ambiguità nel rapporto con la Russia» ha detto il Pd. Con Matteo Renzi
che aggiungeva: «Chi ha orecchie per intendere intenda, su questo punto faremo
le barricate».
Mattarella bis, le 48 ore
di trattative che hanno sbloccato lo stallo: tra incontri, chiamate notturne e
falò di candidati.
Claudio Tito su La Repubblica il 30 Gennaio 2022.
Il tentativo finale su Casini
fermato da Salvini. Poi è Draghi a salire al Quirinale per chiedere al
presidente di dire sì al secondo mandato.
Segnatevi questa data: venerdì
prossimo, 4 febbraio. Sull'agenda di Sergio Mattarella quel giorno era segnato
con un cerchio rosso. Sarebbe andato a cena con gli amici più stretti in un
ristorante del centro di Roma. Per festeggiare. Per festeggiare la conclusione
del suo mandato presidenziale. L'appuntamento era confermato fino a ieri
mattina.
Claudio Tito per repubblica.it
il 29 gennaio 2022.
Alla fine il principio di
realtà si sta imponendo. Il Parlamento sta accogliendo la soluzione più facile e
quella più utile per il Paese. Accade però con una settimana di ritardo e con le
macerie del sistema politico.
La permanenza del "Dream team"
Mattarella-Draghi - se tutto sarà confermato dopo il sì al bis da parte di
Matteo Salvini - è una sicurezza rispetto alle sfide interne e internazionali.
Ma, appunto, tutto intorno i
partiti sembrano edifici diroccati. Più di tutti il centrodestra. Da settimane
si è fatto forte di un ritornello che semplicemente era irreale: abbiamo la
maggioranza. Non ce l'aveva e non ce l'ha.
Salvini ha inseguito soluzioni
estemporanee e soprattutto impraticabili. Con una fantasia e un distacco dal
Paese senza precedenti. Questa coalizione si ritrova a pezzi.
Per il leader leghista è un
"Papeete 2". Dopo un giro vorticoso di valzer si è piegato al bis di Mattarella.
Ne escono però a pezzi anche Forza Italia e Fdi.
La prima è ormai senza voce e
senza prospettiva. I suoi colonnelli sono già alla ricerca di nuove sponde.
Giorgia Meloni, pur con meno responsabilità, non è riuscita a frenare il suo
antagonista Interno e gli ha lasciato il pallino del gioco. Ha subito. E alla
fine si ritrova con l'assetto meno desiderato. La coalizione è a pezzi.
Anche il centrosinistra però
ha evidenziato tutte le sue debolezze. Enrico Letta è apparso come l'unico
leader normale. Ha capito di dover giocare di rimessa ma nello stesso tempo il
Pd si è rivelato fragile. Senza capacità di imprimere una svolta.
Anche per colpa di un M5S
disarmante. Giuseppe Conte è sempre è stato ad un passo dall'accordo con il
centrodestra. Anzi, con Salvini in una riedizione dei GialloVerdi. I grillini
confermano di non sapere cosa siano. Il patto di centrosinistra con questi
pentastellati è segnato e va ridefinito.
Un impasse è stata subìta pure
dal Fronte centrista, che ha tentato la carta Casini. Il sistema politico dunque
è destinato a ristrutturarsi.
Nel frattempo difficilmente al
Quirinale si vedrà la sfilata di leader che accompagnò la rielezione di
Napolitano. Adesso il rapporto è tra il capo dello Stato e il Parlamento. Anzi,
i singoli parlamentari.
Estratto dell’articolo di
Carmelo Lopapa per “la Repubblica” il 29 gennaio 2022.
(…) La trottola impazzita
Matteo Salvini ruota senza posa come i dervisci, perso in una personalissima
estasi dell'ego. È sfuggito a qualsiasi controllo, lascia esausti alleati e
avversari, si sottrae a ogni consiglio dei suoi.
Governatori e numeri due e tre
si sono chiamati fuori dai giochi ben prima della giornata apocalittica del
grande sconfitto. Pur conclusa col faccia a faccia col premier Draghi in un
palazzo di Via Veneto e poi con il vertice a tre con Enrico Letta e Giuseppe
Conte.
Ma tutto improvvisato, senza
una strategia, una mossa concordata, fosse pure una fuga ma pianificata,
raccontano peones e dirigenti in balia del capo. E allora è troppo facile
sentirli sbottare col classico "sembra tornato quello del Papeete".
(…) «Se Matteo mi convoca per
una riunione vado, per il resto mi sono già tirato fuori, com' è noto la penso
diversamente da lui», racconta in queste ore agli amici il ministro per lo
Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Lui al Quirinale vedrebbe ancora bene
l'amico bocconiano Mario Draghi.
Ma il numero uno del partito
sembra stia facendo il possibile per mandare a rotoli tutto, governo incluso. In
Transatlantico si aggirano irrequieti anche i governatori Luca Zaia e
Massimiliano Fedriga. La sortita di due giorni fa, quella visita tenuta nascosta
a tutti a casa di Sabino Cassese l'hanno considerata un affronto personale. «Ma
come? Cassese? Giusto lui che è stato nemico giurato dell'autonomia?»
(…) Ieri, nella parabola dalla
Casellati alla Belloni, il giorno della débacle. E della surreale conferenza
stampa di Montecitorio. A mezzogiorno, mentre a pochi metri la presidente del
Senato viene accompagnata metaforicamente a "schiantarsi" nell'urna, il
segretario tiene una lunare conferenza stampa sui diritti dei portatori di
handicap.
L'ex ministra Erika Stefani
alla sua destra, la neo leghista Laura Ravetto alla sinistra. Matteo ha le
occhiaie, è nervoso, parla a scatti, viso un po' gonfio, bianco. «Non dormo se
non pochissimo», si giustifica lui. Ieri mattina alle 9 era di nuovo in conclave
col resto del centrodestra. Inutilmente.
(…) Lo si vede in centro, a
piedi, sempre al telefono. «Non con noi però», dice sorridendo il senatore
amico. Forse con l'altro Matteo. Ma perfino il non ostile Renzi di questi tempi
giura di non capire più l'omonimo.
Nel partito c'è chi dice che
sia tornato all'ombra del capo Luca Morisi. (…) «Ma se ci fosse almeno Luca al
suo fianco non sbanderebbe come invece sta facendo», dice chi conosce bene
uomini e Lega. (…)
Da liberoquotidiano.it il 29
gennaio 2022.
L'operazione "scoiattolo",
quella messa in moto da Vittorio Sgarbi per reclutare qualche voto in più per
Silvio Berlusconi al Quirinale, si è dimostrata un buco nell'acqua. Eppure il
leader di Forza Italia le aveva tentate tutte, anche elargire regali. Quello che
ha fatto più clamore è il dipinto regalato a Luigi Di Maio. Eppure l'ex leader
del Movimento 5 Stelle non è il solo fortunato. A confermarlo il critico d'arte,
spiegando da dove quei cadeaux arrivano.
"È un hangar enorme - riporta
Aldo Cazzullo nella sua diretta sul Corriere.it -, grande 5 volte il
transatlantico. Ci sono 23 mila tele, ma quelle del Seicento saranno sei. Le
altre sono da arredamento. Silvio le cataloga per argomenti: racconta di avere
120 adorazioni dei pastori, 1500 madonne, tremila battaglie… invano gli ho
spiegato che non funziona così".
Stando a Sgarbi i politici
capiscono ben poco di arte. E il Cavaliere è tra questi. Ma Renzi? "Meno ancora
- conferma -. I politici di arte non capiscono nulla. Neanche Draghi, che pure
ha una figlia nei beni culturali. Solo Stefano Candiani della Lega è un grande
esperto". Quest'anno i destinatari dei "capolavori" berlusconiani sono
aumentati. Da una trentina che erano sono diventati più di sessanta, molti dei
quali proprio grillini.
Articolo del “Financial
Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione” il 31 gennaio 2022.
Il secondo mandato del
riluttante capo di stato lascia il primo ministro libero di perseguire le
riforme finanziate dall'UE
Nelle ultime settimane del suo
mandato di sette anni come presidente, Sergio Mattarella ha chiarito che non
pensava fosse appropriato servire un secondo mandato come capo di stato
italiano. Né desiderava farlo. Scrive il Financial Times.
Ma quando i tentativi dei
legislatori di concordare un successore si sono rivelati tossici - minacciando
il fragile governo di unità nazionale del primo ministro Mario Draghi - i
parlamentari hanno costretto il riluttante ottantenne Mattarella a rimanere. È
stato spinto a una vittoria schiacciante sabato sera - l'ottavo turno di voto in
un processo di selezione presidenziale iniziato lunedì scorso.
"Il dovere verso la nazione
deve prevalere sulle mie scelte personali", ha detto in seguito il presidente,
visibilmente emozionato.
I social media italiani sono
ora in fermento con meme del presidente, compreso uno in cui è legato alla sua
sedia con una corda spessa. Eppure, nonostante tutte le ambivalenze personali di
Mattarella, la sua rielezione ha deliziato gli italiani, specialmente la
comunità imprenditoriale, così come i politici e i responsabili delle politiche
di tutta Europa.
La sua proroga offre ora a
Roma la prospettiva di continuità e stabilità, lasciando Draghi - che era
considerato uno dei potenziali successori più credibili di Mattarella - libero
di portare avanti le revisioni politiche richieste dal piano di riforme e
investimenti italiano finanziato dall'UE per 200 miliardi di euro.
"Il Parlamento ha preso la
migliore decisione possibile, certamente quella più desiderata da tanti
cittadini e imprese italiane", ha detto Corrado Passera, amministratore delegato
della banca Illimity ed ex ministro delle infrastrutture. "L'attuale governo
sarà in grado di portare avanti tutte le riforme e le misure che l'Italia si è
impegnata a fare".
Mujtaba Rahman, amministratore
delegato per l'Europa di Eurasia Group, la società di consulenza sui rischi
politici, ha detto: "Rispetto a tutte le alternative possibili, è il miglior
risultato che l'Europa e i mercati avrebbero potuto sperare... crea una finestra
di sei o sette mesi in cui si può fare molto".
Il risultato permetterà anche
a Draghi di partecipare alle discussioni cruciali a livello europeo sulle
riforme dell'UE, compresi i cambiamenti relativi al patto di crescita e
stabilità del mercato unico, che stabilisce le regole fiscali per la zona euro.
Draghi, un ex capo della Banca Centrale Europea nominato da Mattarella l'anno
scorso nel mezzo di una profonda crisi economica e sanitaria, "sarà una voce
molto influente al tavolo di questa discussione", ha detto Rahman.
L'elezione presidenziale
dell'Italia è arrivata in un momento delicato, con Roma nelle prime fasi di un
ambizioso piano di riforme per riavviare la sua economia cronicamente
sottoperformante. Nei prossimi sei mesi, l'Italia deve affrontare questioni
controverse - compresa una revisione della sua politica degli appalti pubblici e
della legge sulla concorrenza - per ricevere la prossima tranche di fondi UE.
La potenziale ascesa di Draghi
alla presidenza ha sollevato ansia nella comunità imprenditoriale italiana,
nelle capitali europee e nei mercati finanziari, con la preoccupazione diffusa
che un successore meno autorevole come primo ministro avrebbe lottato per
spingere le riforme attraverso una coalizione di governo frammentata. Gli stessi
legislatori italiani hanno temuto di essere spinti ad elezioni anticipate se non
avessero potuto concordare un sostituto come primo ministro.
Ma mentre la rielezione di
Mattarella ha impedito l'implosione immediata del governo, gli analisti
avvertono che Draghi deve affrontare sfide significative nel tentativo di
attuare il prossimo ciclo di riforme.
Le elezioni presidenziali
hanno messo a nudo le tensioni all'interno del governo di unità nazionale tra i
blocchi di destra e di sinistra, in particolare dopo che il leader della Lega
Matteo Salvini ha rotto le fila per sollecitare i partiti di destra a sostenere
il suo candidato preferito.
Ma ha anche rivelato profonde
spaccature all'interno dei partiti, dato che i leader, compreso Salvini, hanno
lottato per tenere insieme le loro fazioni.
"La strada da percorrere sarà
in salita, non in discesa", ha detto Daniele Albertazzi, professore di politica
all'Università del Surrey nel Regno Unito. "Non ho mai creduto che solo perché
sei Draghi puoi fare quello che vuoi. Lui è nelle mani dei partiti politici.
Hanno il potere politico, e sono essi stessi divisi - la destra contro la
sinistra, fazioni contro fazioni. Tutto questo creerà il caos".
Ma altri hanno detto che i
conflitti interni ai partiti politici potrebbero rafforzare la mano di Draghi,
aumentando la sua capacità di spingere attraverso accordi di compromesso.
La sua arma finale, dicono gli
analisti, sarebbe la minaccia di dimettersi e staccare la spina al governo di
unità nazionale, innescando elezioni anticipate, se i partiti si rifiutano di
cooperare.
"C'è un'opportunità per Draghi
di estendere ulteriormente il suo controllo sul governo e sulla coalizione di
governo e accelerare le riforme", ha detto Wolfango Piccoli, il co-presidente di
Teneo, la società di consulenza sui rischi politici. "Può cercare di sfruttare
il totale disordine che sembra prevalere nella coalizione".
Da "la Repubblica" il 31
gennaio 2022.
La notizia della rielezione
del presidente della Repubblica Sergio Mattarella appare nelle homepage delle
principali testate internazionali. Tutte sottolineano una scelta nel segno della
stabilità dopo una settimana di caos e divisioni fra i partiti politici e
qualcuno cita lo stesso Mattarella che ha accettato «nell'interesse della
nazione», ricordandone l'età e la precedente dichiarata intenzione di ritirarsi.
Il New York Times lo definisce
il «guardrail» della «oscillante» democrazia italiana, mentre il Washington Post
parla della rielezione di un «presidente riluttante », ricordando la foto degli
scatoloni del trasloco.
In Francia, dove il presidente
Macron è stato fra i primissimi a congratularsi, Le Figaro ricorda che la
rielezione «permetterà di assicurare la stabilità del tandem Mattarella-Draghi
che gestisce da un anno il risanamento del Paese». Le Monde cita invece
«l'interesse della nazione».
Nel Regno Unito, il Guardian
parla nel titolo delle «profonde divisioni» emerse durante un «farsesco processo
di voto parlamentare », mentre il quotidiano economico Financial Times commenta
caustico: «Una classe politica egoista evita il disastro all'ultimo minuto. Con
la rielezione di Mattarella, Draghi guadagna tempo per consolidare le riforme».
Il tedesco Spiegel , definisce
le elezioni presidenziali «un teatro dell'assurdo». Lo spagnolo El Pais ricorda
che «i partiti non hanno trovato soluzioni all'abisso istituzionale» mentre El
Mundo spiega che «si sono rassegnati a lasciare tutto immutato fino alle
prossime elezioni».
Ugo Magri per "la Stampa" il
31 gennaio 2022.
Per scoprire chi è il nuovo
presidente, di quale pasta è fatto e come si propone di esercitare i suoi
poteri, non c'è bisogno di attendere il discorso che pronuncerà davanti alle
Camere, giovedì subito dopo il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Gli
italiani già conoscono Sergio Mattarella, difficilmente li coglierà di sorpresa.
Sanno che è il massimo garante della stabilità politica, che con la sua presenza
sul Colle il premier si sentirà le spalle coperte, che il governo Draghi non
verrà mollato al proprio destino nel bel mezzo di un'emergenza sanitaria,
economica e sociale.
Il presidente e il suo staff
non si sono ancora seduti intorno a un tavolo per ragionare su tutto questo, ne
è mancato il tempo perché (nonostante quello che i maliziosi seguiteranno a
pensare, e Giorgia Meloni insiste a solleticarli) davvero la rielezione era
fuori dai programmi di Mattarella; l'apparato quirinalizio era già rassegnato
all'idea, qualche consigliere stava imboccando altre strade, quasi tutti sono
tornati precipitosamente sui loro passi, cosicché ieri non si coglievano da
quelle parti segnali di speciale giubilo o di trionfo, della serie «ce l'abbiamo
fatta»; semmai la fretta di riprendere il filo là dove era stato interrotto:
cioè il 3 agosto scorso, all'inizio del «semestre bianco».
Da quel giorno Mattarella
aveva assunto (com' era giusto) un atteggiamento vigile ma via via sempre più
distaccato, anche per rispetto dei candidati alla sua successione. Tra tre
giorni però, con il nuovo giuramento, il «semestre bianco» finirà in soffitta da
dove verrà rispolverato non prima di sei anni e mezzo. Mattarella tornerà nella
pienezza dei suoi poteri comprensivi, com' è ovvio, della facoltà di sciogliere
le Camere, ma soprattutto della «moral suasion» che ogni presidente esercita con
particolare efficacia specie all'inizio del suo mandato.
Ce ne sarà bisogno nei
prossimi giorni, quando Draghi si presenterà a sottoporre le dimissioni di rito
- verranno respinte - ma l'alleanza di governo sarà sottoposta ai contraccolpi
di una partita quirinalizia confusa. Ci sarà molto da lavorare. A questo
riguardo, tra i consiglieri presidenziali nessuno si fa illusioni, anzi
prevalgono i toni preoccupati: i prossimi mesi non si preannunciano come una
passeggiata di salute.
Per non trovarsi le casse
vuote, l'Italia dovrà incassare 64 miliardi dell'Europa che a loro volta, sulla
base del Pnrr, presuppongono il raggiungimento di ben 102 obiettivi da parte di
Parlamento e governo. Il caro energia, l'aumento di prezzo delle materie prime,
la caccia sfrenata ai semi-conduttori, la fine della fase espansiva della
finanza mondiale: sono altrettanti fattori di rischio cui si aggiungono i venti
di guerra ai confini dell'Unione.
Il ritorno di Mattarella nelle
sue piene funzioni significa che Mario Draghi avrà al Quirinale un solido
interlocutore in grado di fargli scudo tanto sul piano interno, quanto nelle
relazioni internazionali. Non sono banali né scontati i messaggi di
felicitazioni giunti a Mattarella da ogni dove. Papa Francesco loda la «generosa
disponibilità» del presidente, apprezzandone il lato umano.
Due vecchi amici come il
presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e quello austriaco Alexander Van Der
Bellen non nascondono invece la soddisfazione di poter ricominciare a tessere
relazioni più salde nella vecchia e slabbrata Europa. Poi calorose felicitazioni
da Joe Biden, da Emmanuel Macron: gli interlocutori di ieri che di colpo
diventano quelli di domani.
Ma.Con. per "il Messaggero" il
31 gennaio 2022.
I più giovani, e non solo,
erano da settimane, con discrezione, a caccia di un altro lavoro. Tutti, o
quasi, con un piede già fuori dal Quirinale quando è scattato il contrordine
senza che nessuno lo azionasse materialmente. Anche se della questione dei
collaboratori del Presidente si parlerà solo dopo l'insediamento, è difficile
pensare che non saranno tutti confermati anche al secondo mandato.
A cominciare dal segretario
generale Ugo Zampetti, funzionario dello Stato di lunga e rodata esperienza che
per quindici anni ha ricoperto la carica di segretario generale della Camera, e
che ha per vice, Alfredo Guarra e Gino Onorato. Nello staff degli uffici di
diretta collaborazione con Mattarella ci sono Simone Guerrini, Daniele Cabras,
Gianfranco Astori e Giovanni Grasso. Gli ultimi due collaboratori sono più
torturati dai giornalisti perché consiglieri per l'informazione il primo e per
la stampa e la comunicazione il secondo. Guerrini è stato capo della segreteria
di Mattarella quando questi ricopriva l'incarico di vice presidente del
consiglio e quando è diventato ministro della Difesa.
Analogo percorso per Cabras,
mentre Astori, giornalista e più volte parlamentare Dc, è stato consigliere per
l'informazione di Mattarella quando questi era vicepresidente del consiglio e
ministro della Difesa. Grasso, giornalista, scrittore e attuale consigliere per
l'informazione, è stato portavoce del ministro Andrea Riccardi.
Nella squadra anche Francesco
Saverio Garofani, già parlamentare del Pd e direttore del Popolo, è consigliere
del Presidente per le questioni istituzionali. Claudio Sardo, già giornalista
parlamentare in diverse testate ed ex direttore dell'Unità, si occupa di
ricerche e studi. Unica che potrebbe partire, forse per Parigi, è la consigliera
diplomatica Emanuela D'Alessandro, già ambasciatrice in Croazia. Rolando Mosca
Moschini, già comandante generale della Guardia di Finanza, è il consigliere per
gli affari del Consiglio Supremo di Difesa.
Completano la squadra il
generale Roberto Corsini, consigliere per gli affari militari, la prefetta
Emilia Mazzuca, consigliera per gli Affari Interni e per i rapporti con le
autonomie, Giuseppe Fotia, consigliere per gli Affari finanziari (ruolo che
ricopriva già con il presidente Giorgio Napolitano) e Stefano Erbani,
consigliere per gli Affari dell'amministrazione della giustizia. Nello staff che
si interfaccia con il mondo dell'informazione, anche Martino Merigo, che
nell'ufficio stampa si occupa dei social, e Costantino Del Riccio per la
documentazione.
Vittorio Feltri per "Libero
quotidiano" il 31 gennaio 2022.
Tra qualche giorno, esauriti i
festeggiamenti per la rielezione applaudita di Sergio Mattarella, confermato
padrone del Quirinale con una votazione effettuata all'insegna della
disperazione, cominceranno presto le grane per il presidente. Il quale prima o
poi, comunque presto, sarà destinato a pentirsi di aver accettato il bis.
La nostra impressione è che
Draghi ne abbia le tasche piene dei partiti che costituiscono la sua
maggioranza. Ma su questo punto potremmo sbagliarci, voltiamo pagina. Mettiamo
pure che il premier riveli di essere dotato di una grande resistenza alla
imbecillità conclamata dei partiti. Rimane il fatto che tra un annetto gli
italiani saranno chiamati alle urne per il rinnovo del parlamento.
Quale sarà il risultato della
consultazione? Il Pd non cresce neanche se lo annaffi, il M5S ha già un piede
nella fossa e se Conte va avanti così, con la complicità di Grillo, presto
troverà la pace eterna e una degna sepoltura, Forza Italia è già una debolezza,
solo Fratelli d'Italia sembra avviato ad irrobustirsi ulteriormente grazie a una
opposizione condotta con giudizio.
Sic stantibus rebus è
difficile immaginare una coalizione di governo in grado di essere tale e di
poter reggere un esecutivo. Tra l'altro rammentiamo a Mattarella che il numero
dei deputati e dei senatori, per effetto di una legge idiota voluta dai suicidi
pentastellati, diminuirà sensibilmente per cui molti rappresentanti del popolo
rimarranno disoccupati, pertanto saranno votazioni all'ultimo sangue. Si dà il
caso che non siamo in grado di intuire quale esito sortirà dalla conta dei
suffragi.
Ci sarà da ridere per noi se
quello della Meloni sarà il gruppo che otterrà una massa di preferenze tale da
renderlo il primo nel Paese. Ovviamente la supremazia della destra non basterà a
formare la maggioranza, servirà che Giorgia riesca ad allearsi con altri partiti
per gestire il potere.
Quali? Difficile immaginarlo.
Quindi sarà un casino infernale che Mattarella, il redivivo, dovrà affrontare
con poche speranze di risolverlo. Non dico che al capo dello Stato salteranno i
nervi, ma dovrà abusare di camomilla per stare calmo e non mandare tutti al
diavolo. Il rimpasto velenoso è alle porte e sono sicuro che Sergio si pentirà
di aver accettato la conferma al Colle, perché dovrà impazzire per riuscire a
dare un governo a tutti noi, posto che Draghi nel bordello generale non ci vorrà
stare e cambierà mestiere.
Voi direte che sono
pessimista, in realtà sono realista e scommetto che i prossimi sette annidi vita
politica faranno capire a Mattarella che non doveva insistere a rimanere in un
Palazzo nel frattempo trasformatosi in un luogo di dannazione, un purgatorio in
cui si scontano peccati anche di presunzione.
Zanda a TPI: “Mattarella
non è un piano B ma una prima scelta. Conte? Nessun attrito”.
Luca Telese per tpi.it il 29
gennaio 2022.
Senatore Zanda, il Pd come
giudica il Mattarella bis?
Un ottimo risultato. Anzi, mi
consenta di dire meglio: il migliore che si potesse immaginare, anche alla luce
di quello che è accaduto nelle prime chiame.
Il Pd aveva un altro obiettivo
e il bis di Mattarella per voi è stato un piano B?
Ma scherziamo? Il nostro
segretario, Letta, è stato il primo dei leader a cogliere al balzo la palla che
i grandi elettori ci stavano offrendo, per rilanciare la candidatura del
presidente.
E il primo effetto di questa
riconferma quale sarà?
È molto semplice, e gli
italiani ci stanno già dando il segnale di averlo capito: si stabilizza il
Paese, in un momento delicatissimo.
Quale?
Quello che ho già raccontato
in un’altra intervista a TPI: una miscela pericolosa di pandemia sanitaria e
caos istituzionale.
E l’abbiamo disinnescata?
Direi proprio di sì.
Mattarella garantisce continuità, serietà e rigore.
Chi ha pagato il prezzo della
lotteria di questi giorni?
Sul piano privato un uomo che
voleva smettere con il primo mandato, ma che ha accettato il sacrificio per
disinteressato spirito istituzionale. Però sul piano pubblico il vantaggio è
stato evidente, per tutto il Paese.
E le conseguenze per il
governo Draghi quali saranno?
Se tutti si uniformano allo
spirito di questo presidente, e al segnale di unità del voto in Aula, il governo
esce più forte di prima.
Draghi ha subito un
ridimensionamento?
E perché mai? Oggi ha la
possibilità di governare sono a fine legislatura con la massima copertura
istituzionale possibile.
Mattarella però ha fatto
sapere che non accetta limiti di mandato di nessun tipo, a partire
dall’integrità del settennato.
Mi pare saggio e giusto.
Non è un mandato a termine,
dunque, come lo intendeva qualcuno? Due anni e poi dimissioni.
Ma non scherziamo! L’unico
termine che si può immaginare per Mattarella è quello imposto dalla
Costituzione.
Le Quirinarie si stavano
mettendo malissimo, confessi. Nove candidati autorevoli bruciati in sei giorni.
C’è stata un po’ di
confusione, é innegabile….
Per colpa di chi?
Tutti hanno visto le
iniziative che sono state prese, tutti hanno potuto constatare l’insuccesso di
chi ha immaginato percorsi non condivisi.
Fa il diplomatico e non cita
Salvini, e le arrabbiature che vi ha fatto prendere con la candidatura
Casellati?
Perché dovrei fare polemiche
quando l’accordo che abbiamo raggiunto è un grande successo politico? Conta il
risultato, più che la sua genesi.
Letta puntava a portare Draghi
al Quirinale?
E chi lo dice? Non ci sono mai
stati piani B. Mattarella è una prima scelta.
E la Belloni?
Donna delle istituzioni,
figura di indubbio valore. Mi è dispiaciuto che sia stata sottoposta a questo
pericoloso gioco di sovraesposizione.
Ci sono stati dei malumori con
il vostro alleato Conte?
Al di là di quello che si è
scritto nei retroscena, la coalizione non si è mai divisa in nessun voto d’Aula.
I fatti sono questi.
E la maggioranza di governo
non si è indebolita?
Non mi pare: è sempre la
stessa, anche numericamente. E come ho detto all’inizio, adesso dovrà misurarsi
con l’attuazione del programma di governo e l’impresa del Pnrr.
Mi sembra che lei stia
infiocchettando tutto con molta diplomazia.
Si sbaglia. Abbiamo ottenuto
il miglior risultato possibile. Grazie a Mattarella.
Una seconda dose di Sergio
Mattarella per il Paese.
Con 759 voti il secondo presidente più votato della storia è
richiamato a curare il virus dell’immobilismo politico. Perché nessuno più di
lui sa che questa elezione al Colle non può essere considerata un anestetico per
addormentare e congelare. Marco Damilano su L'Espresso il 29 Gennaio 2022.
Alle 20.40 Sergio Mattarella
conclude il Romanzo Quirinale 2022 con 759 voti, un record, il secondo
presidente più votato in 76 anni di storia dopo Sandro Pertini. Il Richiamo è
infine arrivato, nel corridoio dei Passi perduti di Montecitorio che sembrava un
cluster affollato e confuso, con deputati e senatori a bivaccare nel caos, e si
trasforma in questo sabato 29 gennaio in un hub vaccinale, per curare il virus
dell'inconcludenza politica e dell’immobilismo che in questi sei giorni ha messo
a rischio la tenuta del corpo democratico.
I momenti migliori del
(primo) settennato di Mattarella.
Ufficio per la Stampa e la
Comunicazione della Presidenza della Repubblica su Il Domani il 29 gennaio 2022.
Il primo mandato di Sergio
Mattarella si conclude con migliaia di immagini che hanno fatto il giro del web
e hanno reso il presidente della Repubblica, per la prima volta, protagonista
della rete, con fotografie e video trasformati in meme e pagine satiriche. Un
fenomeno che ha avvicinato la massima carica dello stato ai cittadini
Il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, oggi confermato per un secondo mandato, viene
ricordato non solo per l’alto profilo politico, ma anche per il successo che
ha avuto sui social network. Durante il suo primo settennato è stato creato il
profilo Instagram del Quirinale, per raccontare l’agenda del presidente e
diffondere i discorsi ufficiali della massima carica dello stato. Le immagini e
i tweet pubblicati hanno contribuito a creare la figura di un presidente pop,
amato da molti: dall’espressione di gioia per la vittoria dell’Italia agli
Europei, alla dichiarazione di un uomo comune durante la pandemia: «Eh Giovanni,
non vado dal barbiere neanche io». Immagini che hanno fatto il giro del web,
producendo pagine satiriche, come “Le bimbe di Sergio Mattarella” su Instagram e
“Mattarella ascolta cose” su Facebook, oltre a nuovi marchi di magliette, come
quella realizzata dal brand Mattarella Rocks. Il nome del presidente ha ispirato
la produzione di centinaia di magliette e felpe in stile Metallica, il cui
ricavato viene devoluto all’ong Sea Watch.
Ecco il video che ha fatto il
giro del web il 27 marzo 2020, all’inizio della pandemia, mandato in onda per
errore dall’ufficio stampa del presidente.
Il 25 aprile 2020, durante la
prima ondata pandemica, l’immagine di Mattarella si è distinta rispetto alle
celebrazioni degli anni precedenti, in cui presenziavano parlamentari ed
esponenti del governo. Il presidente della Repubblica ha deposto la corona
d’alloro sulla tomba del Milite ignoto all’Altare della Patria, da
solo, circondato dai due corazzieri.
Un’altra espressione nota del
presidente uscente è stata ripresa durante la finale degli Europei, l’11 luglio
2021, allo stadio di Wembley a Londra. Mattarella ha esultato nel momento della
vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra, pur mantenendo la solita compostezza.
Un video diventato virale
ritrae il capo dello stato in una sala affollata impegnato ad ascoltare una
traduzione simultanea con le cuffie. Così è nata la pagina Facebook “Mattarella
ascolta cose”, dove si trovano decine di video con musiche diverse, da Numb dei
Linkin Park, a E penso a te di Lucio Battisti.
Il pubblico social si è poi
affezionato all’immagine di Mattarella in silenzio, davanti a uno schermo,
concentrato a stampare il primo certificato digitale dell’anagrafe online.
Un presidente che più volte ha
voluto comunicare il suo essere uguale agli altri. Dalla fotografia che lo
ritrae in attesa del vaccino, in una sala d’attesa tra le altre
persone, all’immagine di Mattarella su un volo di linea Alitalia diretto a
Palermo, per una visita privata, il 14 febbraio 2015.
Sempre in volo, questa volta
sull’aereo presidenziale diretto a Bari, Mattarella saluta dal finestrino il
pilota del jet che scorta l’aereo del presidente.
E infine la t-shirt che è
stata acquistata da centinaia di persone, con il nome del presidente in stile
Metallica. Uno dei creatori di Mattarella Rocks, Michele De Paola, ha spiegato
che il ricavato viene devoluto alla Sea Watch, l’ong che si occupa di salvataggi
nel mar Mediterraneo, perché il presidente Mattarella è stata l’unica figura
istituzionale che ha chiesto una gestione più umana della questione migratoria.
Durante la carica però il
presidente, molto amato dai cittadini, è stato accusato da Luigi Di Maio di alto
tradimento. L’impeachment è stato comunicato dall’allora capo politico del
Movimento 5 stelle durante una telefonata alla trasmissione Che tempo che fa il
27 maggio 2018. Una minaccia giunta anche dalla leader di Fratelli d’Italia,
Giorgia Meloni.
Due anni dopo però è arrivato
il mea culpa di Di Maio, questa volta ministro degli Esteri. All’Aria che tira
su La7 nell’aprile del 2020 ha dichiarato: «Nella vita delle persone da grandi
errori nascono grandi opportunità. Da quell'episodio ho rafforzato il mio senso
di responsabilità istituzionale e ho imparato a credere sempre di più nel ruolo
di Mattarella».
Anatomia di una coalizione
sfasciata dal voto per il Colle. Meloni strappa: va rifondata.
Fabrizio De Feo il 30
Gennaio 2022 su Il Giornale.
L’accusa di Fdi: "L’unica cosa
su cui eravamo tutti d’accordo era il no al bis. Adesso scopriamo che le
posizioni sono cambiate". «Il presidente l'abbiamo fatto, adesso bisogna rifare
il centrodestra». I Grandi Elettori di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e
Coraggio Italia si avvicinano all'ultima votazione con umori differenti. La
giornata è stata lunga, ha seminato tensioni, allargato solchi e distanze. «Il
futuro del centrodestra? Quale centrodestra?» polemizza Ignazio La Russa. E in
Transatlantico gli eletti di Giorgia Meloni si rivolgono ai leghisti lasciando
cadere qualche provocazione: «Dai, fai uno scatto d'orgoglio, vota per
Nordio...».
Le scorie da smaltire sono
molte e si sono accumulate velocemente, in meno di 24 ore. La prima scossa
tellurica è arrivata con il flop della candidatura Casellati e con le accuse
rivolte dagli alleati verso Forza Italia e le formazioni di Centro. Una
votazione seguita da un vertice acceso nei toni in cui i vari partiti hanno
messo in fila le loro preferenze. Se Forza Italia puntava su Pier Ferdinando
Casini e in seconda battuta su Sergio Mattarella, la Lega riteneva a quel punto
che la continuità rappresentata dal presidente in carica potesse rappresentare
una soluzione. Giovanni Toti era schierato per Casini, Mattarella o Mario
Draghi, Giorgia Meloni invece aveva detto chiaramente di non essere disposta a
votare il Capo dello Stato uscente, «piuttosto andate su Draghi che io comunque
non voterò». Un quadro complesso da comporre che porta in serata al lancio delle
ipotesi rosa, Belloni e Cartabia. Una fuga in avanti che fa scattare la reazione
di Forza Italia e di Silvio Berlusconi che inizia a trattare direttamente con
Enrico Letta.
«L'unica cosa su cui eravamo
tutti d'accordo nell'ultima riunione del centrodestra era il no a Mattarella: ci
avevamo anche scherzato e invece oggi scopro che le posizioni sono cambiate»,
commenta Giorgia Meloni. «Mi aspettavo che il centrodestra avesse molto più
coraggio per eleggere un presidente distonico rispetto agli ultimi». La svolta
arriva mentre è in corso il settimo voto, quando Matteo Salvini, dopo una
telefonata con Mario Draghi dà il via libera al Mattarella bis. Berlusconi
chiama l'inquilino del Colle: «Gli ho assicurato il sostegno di Forza Italia».
La Meloni punta il dito contro Salvini: «Non voglio crederci, Salvini chiede a
tutti di pregare Mattarella di tornare». Antonio Tajani individua una nota
positiva nel «forte coordinamento dimostrato dall'area popolare, mi auguro che
possa andare avanti», dice riferendosi all'asse con Udc, Coraggio Italia e
Cambiamo, da cui nelle ultime ore ha ricevuto la delega a trattare. Nella Lega
invece si cerca di stemperare le tensioni, «con gli alleati ci sarà modo di
tornare a dialogare. Giorgetti? Le sue perplessità sono un modo per condividere
la sconfitta e ripartire insieme, la fiducia dal segretario l'ha già ricevuta».
Dentro Forza Italia a
posteriori si ragiona sull'errore tattico di aver raccontato all'elettorato che
fosse davvero possibile imporre un candidato di centrodestra, ma «anche Fratelli
d'Italia deve capire che giocare in solitaria rischia di rivelarsi la classica
vittoria di Pirro perché senza una maggioranza forte difficilmente il Capo dello
Stato assegnerebbe l'incarico alla Meloni». L'operazione Mattarella richiama a
un altro grande tema: quello della legge elettorale. Giorgia Meloni teme che
sotto traccia Forza Italia e centristi siano pronti a fare l'accordo con la
sinistra sul proporzionale e avverte: «Questo centrodestra è da rifondare».
Nella Lega, però, sotto traccia qualche riflessione sul proporzionale inizia a
farsi strada, in particolare tra qualche colonnello vicino a Giorgetti.
Difficile però comprendere ora se sia uno spiraglio reale o una minaccia da
tenere in piedi per contenere il competitor sovranista, deciso a capitalizzare
in termini di consenso la propria scelta identitaria. Fabrizio De Feo
E adesso siamo pronti a
prenderci tanti ceffoni nel discorso di apertura.
Andrea Cangini il 30 Gennaio
2022 su Il Giornale.
Come getti d'aria in canotti
sgonfi, una dopo l'altra le notizie sul progressivo rafforzamento dell'ipotesi
Mattarella rianimano i grandi elettori dotati di piccoli poteri. A ridosso
dell'ottava votazione, ci scopriamo tutti in piena forma, ringagliarditi,
carichi di energie pronte a sfogarsi. Come? Come al solito: pontificando. Tra
Transatlantico, buvette e cortile di Montecitorio è tutto un «io l'avevo detto
sin dal primo momento», un «era ora», un «ma ci voleva tanto a capirlo?».
Dirà, il lettore, che si
tratta dei soliti commenti di fine partita, delle normali spacconate da giochi
fatti, della consueta preveggenza col senno di poi. Il sospetto è legittimo, ma
infondato. C'è la prova. Chi ha avuto la pazienza di leggere il«Diario di un
grande elettore» pubblicato ieri, ricorderà, infatti, quale fosse la tesi
prevalente tra noi, per citare ancora una volta la definizione che si attribuì
il grande Enzo Bettiza nei giorni dell'elezione di Sandro Pertini, «infimi
esecutori». La tesi era questa: il voto sulla presidente del Senato Casellati ha
avuto l'effetto del sacrificio propiziatorio «in vista dell'elezione di
Mattarella o di Casini». Su Pier Ferdinando Casini, ieri, si è trattato fino
all'ultimo, e se si fosse iniziato il giorno prima sarebbe passato; a prevalere
è stato Mattarella. Niente «professori universitari», niente «donne» in quanto
tali, niente «uomini delle istituzioni» privi di esperienza politica, niente
agenti segreti e amenità del genere. Mattarella. Ancora una volta.
Ce n'è abbastanza per
rivalutare i tanto screditati peones, c'è n'è abbastanza per riqualificare la
grandissima massa dei grandi elettori. E ce n'è abbastanza per dichiarare
definitivamente tramontate le apparenti leadership di quei presunti leader che,
giocando su più tavoli e accreditando più ipotesi, incuranti delle
contraddizioni e impermeabili al buonsenso si sono avvitati su se stessi come
trivelle nel fango. L'umile estensore di questa rubrica superflua sa bene a chi
state pensando, ma non è solo a lui che ci si riferisce.
Ora, e anche questo noi infimi
esecutori lo sappiamo bene, si leverà un coro a dire che con la rielezione di
Sergio Mattarella la politica è morta e il sistema è entrato in crisi. I leader,
i pochi veri e i molti presunti, lo negheranno. Ma noi infimi esecutori possiamo
permetterci il lusso della verità. E la verità è che la politica è morta da un
pezzo, il sistema è in crisi da trent'anni e la sua crisi si è conclamata con
l'avvento, provvidenziale, sia chiaro, di Mario Draghi. Eravamo in crisi prima,
lo saremo finché non riformeremo il sistema politico e istituzionale.
PS. Noi grandi elettori dotati
di piccoli poteri siamo pronti a subire i ceffoni che doverosamente Mattarella
ci infliggerà col suo discorso di insediamento. E sin d'ora siamo in grado di
prevedere che al confronto le parole pronunciate da Napolitano in analoga
situazione sembreranno tenere carezze. Andrea Cangini
Così il Cavaliere in
clinica ha sbloccato l'impasse. "Questi sono ragazzini".
Pier Francesco Borgia il 30
Gennaio 2022 su Il Giornale.
Dal San Raffaele il leader
azzurro ha sentito prima Casini e Letta, poi il capo dello Stato.
Sono le 12.51 quando le
agenzie di stampe battono un flash: «Berlusconi sente Mattarella: c'è il
sostegno di Forza Italia per la rielezione». Ed è quello il momento in cui si
capisce che il Quirinale non cambierà inquilino. E infatti a sera, quando arriva
il crisma dell'ufficialità con la chiusura dello spoglio dell'ottava votazione,
il commento del leader di Forza Italia è di puro sollievo e di soddisfazione.
«Siamo riusciti - commenta Berlusconi con un moto di orgoglio - a confermare un
presidente che nel corso di questi sette anni ha difeso gli interessi del Paese
salvaguardandone l'unità». Un risultato che, con l'investitura di Mario Draghi
alla guida dell'esecutivo, segna sicuramente il riscatto della politica
nell'ultimo scorcio di questa diciottesima legislatura.
La lunga e tribolata pagina
delle elezioni per il quattordicesimo presidente della nostra Repubblica si
allunga tra due gesti che portano entrambi la firma di Silvio Berlusconi. Dal
suo passo indietro di sabato 22 gennaio (perché la sua candidatura era
considerata dal Pd «divisiva») per senso di responsabilità nei confronti delle
istituzioni («ho deciso di compiere un altro passo sulla strada della
responsabilità nazionale, chiedendo a quanti lo hanno proposto di rinunciare a
indicare il mio nome per la Presidenza della Repubblica»), alla telefonata a
Mattarella per annunciare il sostegno degli azzurri e quindi per esortare il
Capo dello Stato a rimanere al Quirinale in nome della «stabilità in un momento
altamente delicato».
Dalla sua stanza del San
Raffaele, venerdì sera, Silvio Berlusconi ha parlato al telefono prima con Pier
Ferdinando Casini e poi con Enrico Letta. Il leader azzurro - che oggi dovrebbe
essere dimesso - si è ripreso i panni di kingmaker dopo il passo falso della
candidatura della Alberti Casellati come candidato «istituzionale» del
centrodestra.
La telefonata più importante,
però, è quella a Mattarella. «Questi si sono dimostrati dei ragazzini» si è
lamentato il leader azzurro parlando con il capo dello Stato. Alta l'irritazione
per il modo in cui sono state condotte le trattative.
Stabilita l'impossibilità di
un dialogo tra i diversi soggetti che compongono l'arco parlamentare, Berlusconi
ha convenuto con Letta e che l'unica soluzione possibile era una candidatura che
fosse specchio dell'attuale maggioranza di governo. Quella maggioranza di unità
nazionale che lo stesso Berlusconi è stato chiamato a sostenere un anno fa per
evitare al Paese pericolosi salti nel buio.
«Questo è il momento
dell'unità - spiega in un tweet comparso ieri pomeriggio dopo che i media
avevano rilanciato la notizia della disponibilità di Mattarella per un secondo
mandato - e tutti dobbiamo sentirlo come un dovere. Ma l'unità oggi può
ritrovarsi soltanto intorno alla figura del presidente Sergio Mattarella, al
quale sappiamo di chiedere un grande sacrificio, ma sappiamo anche che glielo
possiamo chiedere nell'interesse superiore del Paese, quello stesso che ha
sempre testimoniato nei sette ani del suo altissimo mandato». Impegno che gli è
valso anche il riconoscimento da parte del leader del Movimento Cinquestelle,
Giuseppe Conte, che ieri in conferenza stampa non soltanto ha ringraziato
Berlusconi per il passo indietro ma anche per la sensibilità istituzionale con
cui ha spinto il nome di Mattarella.
Le telefonate delle ultime
ventiquattro ore dimostrano un attivismo da parte del presidente azzurro che in
verità non è mai venuto meno nemmeno nei giorni più difficili della degenza al
San Raffaele, quando è rimasto in costante contatto con i dirigenti di Forza
Italia.
Gli stessi che ieri è tornato
a ringraziare pubblicamente per il lavoro portato a termine. Ancora una volta il
contributo del leader azzurro è stato determinante per uscire da una pericolosa
impasse. Come sette anni fa quando, come ha rivelato lo stesso Gianfranco
Rotondi, Berlusconi lo invitò a fare votare il suo gruppo per Sergio Mattarella
e sbloccare la sua ascesa al Colle più prestigioso del Paese. Pier Francesco
Borgia
Da "no" a "ripensaci".
La svolta di Salvini in meno di 24 ore. Mattarella: rispondo solo al Parlamento.
Adalberto
Signore il 30 Gennaio 2022 su Il Giornale.
Draghi gioca l’ultima carta:
Giorgetti premier o vice. E Matteo si rifugia nel bis. A differenza di
Napolitano il capo dello Stato non vede i leader ma i capigruppo.
Da «il Mattarella bis è il
peggiore degli scenari possibili» al «Mattarella ripensaci» passano meno di 24
ore. Durante le quali Salvini si esibisce nell'ultima delle giravolte. Hanno la
meglio le inquietudini e i sospetti verso il fronte del Nord, che all'interno
della Lega spinge pesantemente su Draghi ormai da giorni. Una poderosa fronda
interna - non solo Giorgetti, ma anche buona parte dei governatori del Carroccio
- che si salda a una Meloni che, pur stando all'opposizione, tifa discretamente
per il trasloco del premier al Colle, anche perché potrebbe essere il viatico
per le elezioni anticipate.
Così, nel volgere di un
pomeriggio e di una nottata, Salvini decide l'ultima conversione a U. Venerdì,
al tavolo dei leader del centrodestra dopo lo scontatissimo frontale mattutino
della Casellati, il leader della Lega si dice d'accordo con la Meloni. I
presenti fanno la lista dei loro desiderata. Tajani: «Casini o, second best,
Mattarella». Toti: «Casini, Draghi o Mattarella». Salvini e Meloni, invece,
ascoltano. Ma si trovano d'accordo alla domanda «quale degli scenari sul tavolo
è quello meno auspicabile?». «Il Mattarella bis è il peggiore dei possibili»,
sentenziano all'unisono. Tanto che, racconta La Russa, «la battuta che girava
era allora votiamo non-Mattarella, così siamo d'accordo».
Le ore successive, però, sono
quelle della diffidenza. Il timore di Salvini - che prende piede di ora in ora -
è che sia in atto una congiura all'interno del suo partito, nel tentativo di
rimettere in pista Draghi. Ecco perché venerdì sera, il leader della Lega tenta
l'ultimo blitz. Esce dal vertice con Conte e Letta e annuncia la candidatura di
una donna, cioè il capo del Dis Belloni. Gli va dietro Conte. E scoppia la
bomba. Draghi è già in macchina sulla via di casa, fa inversione e torna a
Palazzo Chigi. Alza il telefono e il colloquio con Letta - che ha lasciato la
Belloni nella rosa - è di quelli che il segretario dem non dimenticherà. «Ho
contro anche il Pd?», è il senso delle parole del premier. Che dopo il frontale
della Casellati aveva convenuto con lo staff ristretto che la sua corsa al Colle
era ormai troppo in salita. Ma che come unica alternativa al suo nome ha sempre
immaginato solo quello di Mattarella. L'unico che garantisce lo stesso
equilibrio e che gli consente di restare premier senza uscire davvero sconfitto
da una partita che, solo qualche settimana fa, dava per vinta. Appena chiuso
l'accordo sul bis, infatti, Palazzo Chigi fa filtrare la «grande soddisfazione»
dell'ex numero uno della Bce. Che, recita lo spin, ha lavorato alacremente per
il bis. «Questa è l'Italia dei due presidenti», è il messaggio da far rimbalzare
sui media. Uno è Mattarella, l'altro è Draghi che lo ha incoronato.
Inutile dire che la cronaca
racconta tutta un'altra storia. Perché il premier ha provato fino alla fine a
giocarsi la partita. Ma ha perso. E ha ceduto solo ieri mattina, quando c'è
stato lo show down e al bis di Mattarella non c'erano più alternative. A quel
punto ha - giustamente - deciso di intestarsi la cosa. Ma la politica tutta è
consapevole del fatto che in una settimana di votazioni il nome di Draghi non è
mai entrato in campo. Nonostante il suo indiscusso standing internazionale e il
fortissimo pressing del diretto interessato. Che nell'incontro di venerdì
pomeriggio con Salvini, lontano dai riflettori in un palazzo di via Veneto,
avrebbe persino messo sul tavolo la poltrona di premier (o vicepremier) per
Giorgetti. In uno schema non scontato - perché poi il Pd avrebbe dovuto
accettare - che vedeva Draghi al Colle e un posto di leadership di governo per
l'attuale ministro dello Sviluppo. Proposta - quella di vedere un leghista ai
vertici di Palazzo Chigi - che invece di allettare Salvini lo ha ancor più
preoccupato. Il leader leghista, infatti, è convinto che Giorgetti e il fronte
dei governatori siano una propaggine del draghismo nel suo partito, degli
incursori in casa sua. E Draghi, non è un dettaglio, ha dimostrato di tollerare
a mala pena Salvini dal giorno in cui - lo scorso febbraio - ha bocciato tutti e
tre i nomi che aveva indicato come ministri.
Così, ieri mattina, Salvini ha
capitolato. Forse perché gli è arrivata voce che era in corso un ultimo,
disperato tentativo di rimettere in campo Draghi (nonostante il premier non si
vedesse più in gioco già dalla tarda sera di venerdì). L'intenzione era quella
di mettere sulla scheda della settima votazione il nome di Draghi, idea
trasversale che teneva insieme la Lega che fa capo a Giorgetti e ai governatori,
un pezzo di Forza Italia, una parte di Pd e M5s (quella disponibile a fare
sponda) e FdI (la Meloni aveva dato la sua disponibilità a votarlo). È a quel
punto, forse, che Salvini ha deciso di accelerare. E ha detto sì al bis agli
altri leader di maggioranza. Poi, a favore di telecamere, si è appellato a
Mattarella: «Ripensaci!».
Il capo dello Stato non ha
fatto una piega. Ma ci ha tenuto a usare un altro approccio rispetto a quello
del bis di Napolitano, quando furono tutti - leader dei partiti compresi - a
salire al Colle per chiedergli di restare. Mattarella, invece, ha voluto solo i
vertici dei gruppi parlamentari. Per mandare un messaggio inequivocabile: non
rispondo ai leader di partito e ai loro cambi di direzione, da ora in poi
rispondo solo al Parlamento.
Adalberto Signore. Classe
1972, nato a Roma. Ho cominciato a scrivere di politica un po' per caso nel
1994. Sono passati quasi trent'anni e, tra alti e bassi, sono ancora qui.
Giornalista parlamentare, scrivo sul Giornale dal 2002. Due libri - "Il boia non
molla. La pena di morte nel mondo", Ideazione Editrice (1999) e "Razza padana.
Storia, fascino e contraddizioni della Lega Nord", Rizzoli (2008) - una moglie,
una figlia, la Lazio e il Circeo.
La grande rivincita dei
peones.
Paolo Armaroli il 30 Gennaio 2022 su Il Giornale.
Filippo Turati soleva dire:
"Sono il loro capo e li seguo". Non hanno capito ma si sono prontamente
adeguati.
Filippo Turati soleva dire:
«Sono il loro capo e li seguo». Non hanno capito ma si sono prontamente
adeguati. Si tratta, manco a dirlo, dei campioni di Sua Maestà la Partitocrazia
che nell'aula di Montecitorio da lunedì scorso si sono misurati dando il meglio
del peggio e uscendo dalla tenzone chi più, chi meno con le ossa rotte. Si fa
presto a dire il perché. Come i pellirosse, avrebbero dovuto mettersi con
l'orecchio a terra e ascoltare il rumore crescente proveniente dai gregari. Ma
sì, diciamocela tutta, dai peones.
E invece niente. Fin quasi a
pochi minuti dalla ventiquattresima ora non hanno avuto l'umiltà di guardare in
basso. E sono andati dritti per la loro strada fino a sbattere la faccia al
muro. Eppure, il primo scrutinio di lunedì scorso avrebbe dovuto allarmare i
naviganti. Alla direttiva di votare scheda bianca, hanno detto di no in 304. E
quel no, per la prima volta nella storia delle elezioni presidenziali, si è
manifestato non già a volto coperto ma a viso aperto. E questo perché chi ha
detto signorsì è passato attraverso la cabina come i bersaglieri di La Marmora
alla Breccia di Porta Pia: a passo di carica. Mentre coloro che in cabina si
sono trattenuti per votare qualsiasi nome gli venisse in testa hanno dimostrato
di essere dei signornò.
Enrico Letta, che pure non è
considerato un fulmine di guerra né una volpe di Montecitorio, ha giocato
astutamente di rimessa inondando le urne di schede bianche o dichiarando
l'astensione. Anche perché più solo non poteva essere. Avendo per compagno di
sventura quel Giuseppe Conte che si rimira allo specchio non solo perché si ama
e si contraccambia ma anche per dimostrare a sé stesso di esistere. Peraltro
tormentato da Luigino Di Maio, con il tempo cresciuto ci voleva poco! a
dismisura. Di là Matteo Salvini ha bruciato nominativi in quantità industriali,
una vera e propria strage degli innocenti, e alla fine è rimasto con un pugno di
mosche. Se a manca Atene piange, di sicuro a dritta Sparta non ride. Perché
nella votazione sul presidente del Senato i franchi tiratori sono stati ben 71,
nonostante si sia cercato inutilmente di «segnare» i nomi della candidata. E,
secondo calcoli attendibili, 35 voti sono andati al capo dello Stato.
Intanto, in questo assoluto
marasma, i voti per Sergio Mattarella a poco a poco sono lievitati. 16 al primo
scrutinio, 39 al secondo, 125 al terzo, 166 al quarto, 136 al sesto, 387 al
settimo e poi il diluvio all'ottavo. Ma prima che i peones prendessero il
sopravvento, i capigruppo della maggioranza si sono fatti una passeggiata fino
al Quirinale e, con il cappello in mano, hanno implorato Mattarella a rispondere
sì come la monaca di Monza al loro grido di dolore. È stato il riscatto dei
peones, non più disposti a subire.
Una gran bella pagina: la
democrazia ha battuto l'oligarchia 2 a 0. Paolo Armaroli
La testa d'ariete dei
grandi elettori peones contro le giravolte dei leader.
Il timore è che in un anno
preelettorale la spinta propulsiva di Draghi al governo venga frenata dalle
beghe continue dei partiti. CARLO FUSI su Il Quotidiano del Sud il 30
Gennaio 2022.
Per capire cos’è successo
bisogna partire dalla fine. Sergio Mattarella che resta al Quirinale rappresenta
una garanzia per tutti, cittadini ed istituzioni. Ha svolto il suo settennato in
maniera impeccabile e i tanti che, più o meno ipocritamente, cercavano “uno come
lui” alla fine hanno dovuto arrendersi. C’è un solo Mattarella e, per come si
erano messe le cose, sta bene dove sta.
Ma sarebbe ipocrisia massima
non dire che il bis rappresenta una sgrammaticatura costituzionale come lo
stesso capo dello Stato aveva spiegato a più riprese, e le foto dei materassi e
degli scatoloni stanno lì a dimostrare che si è innestato un rewind che sarebbe
fuorviante considerare ritorno alla normalità. La verità è che Mattarella è
riconfermato dalla insipienza e dalla incapacità delle forze politiche di
trovare un sostituto all’altezza. La sua conferma non risolve bensì enfatizza la
crisi di sistema che avvolge l’Italia.
Considerazioni simili valgono
anche per Mario Draghi. La sua permanenza a palazzo Chigi fa trarre un sospiro
di sollievo all’Europa intera perché uno come lui ce l’abbiamo solo noi e
dovrebbe essere il nostro orgoglio. Ma anche qui è impossibile ignorare che
Draghi sarebbe salito volentieri al Colle e nel Transatlantico trasformatosi in
un anfiteatro di candidature tutte dilaniate dalla disinvoltura di presunti
leader, molti hanno giocato a ridimensionarlo se non addirittura ad umiliarlo.
Non ci sono riusciti, non del tutto almeno.
Adesso Draghi (ma è ancora
SuperMario?) è formalmente blindato a palazzo Chigi fino al termine della
legislatura. Il timore è che in un anno preelettorale la sua spinta propulsiva,
già fortemente affievolita, venga annullata dalle beghe continue dei partiti
della sua maggioranza. Il presidente del Consiglio non potrà che tirare dritto,
e la speranza è che non si stanchi e si faccia prendere dal desiderio di
mollare. Chi lo conosce sa che non sarà così, ma la fatica da adesso in poi sarà
doppia e doppia dose di pazienza sarà necessaria.
Il via libera a Mattarella 2 è
arrivato da un sottosopra che è ulteriore conferma delle difficoltà del Palazzo.
Nel rodeo andato in scena nell’emiciclo della Camera, i Grandi Elettori peones,
stanchi delle giravolte a vuoto dei loro leader che avrebbero dovuto dare
indicazioni e invece si sono ubriacati nel balletto dell’inconcludenza, ad un
certo punto si sono ribellati cominciando a votare Mattarella come testa
d’ariete per sfondare il labirinto nel quale si erano infilati. I parlamentari
contro i capipartito segnano forse la contorsione più eclatante di un quadro
politico ultra sfilacciato e incapace di esprimere leadership valide e
convincenti. I segnali c’erano tutti da tempo, però da adesso in poi sarà
obbligatorio tenere conto dell’insofferenza di 915 deputati e senatori, molti
dei quali per di più sanno di essere arrivati al capolinea della loro
performance politica grazie al taglio dei seggi voluto dai Cinquestelle e
pedissequamente accettato dal Pd. La ricaduta sulla governabilità non sarà di
tipo soffice.
Chi esce letteralmente a pezzi
è il bipolarismo che da più di vent’anni contraddistingue l’Italia e che nemmeno
l’exploit di Grillo era riuscito a destrutturare.
Il centrodestra è esploso a
causa delle girandole di candidature avanzate da Matteo Salvini che agognava a
diventare il kingmaker e che invece si ritrova con Mattarella ancora al Colle e
lo schieramento che teoricamente guida ridotto a brandelli. Il leader leghista
ha avvalorato le iniziative della Meloni che una sola cosa cerca: le elezioni
anticipate. La forzatura sulla Casellati rispondeva a questa logica ed è stata
fatta a pezzi nel segreto dell’urna. Berlusconi si è platealmente dissociato e
chi sogna la maggioranza Ursula può fregarsi le mani solo a patto di
sottovalutare l’inconsistenza dei Cinquestelle e le slabbrature di leadership di
Giuseppe Conte. Era già così prima, ma la partita del Quirinale ha dato un
formidabile colpo di maglio alla credibilità di uno schieramento compatto e in
grado di governare il Paese. Lega (che ha i suoi bei problemi interni, vedi la
voglia di Giorgetti di mollare), Fdi e FI sono tre soggetti che si muovono
autonomamente l’uno dall’altro. Prima della prova quirinalizia il centrodestra
aveva evidenti crepe; adesso è un campo terremotato.
Ma anche il centrosinistra ha
i suoi problemi. Il trio Letta-Conte-Speranza non è stato in grado di definire e
mettere ai voti una candidatura unitaria. Ha giocato di rimessa bocciando ad una
ad una tutte le proposte più immaginifiche che concrete di Salvini. Ma in
politica stare fermi non porta a vincere le partite. Letta è rimasto immobile
perché anche solo muovere politicamente un sopracciglio tra Renzi e Conte lo
avrebbe portato a disgregare il suo schieramento. Mattarella al Quirinale e
Draghi al palazzo Chigi è quanto di meglio potesse sperare, ma questa sorta di
congelamento istituzionale non allontana i nodi politici di una alleanza Pd-M5S
che non decolla e che anzi rischia di essere stretta al collo dalle ambivalenze
e contraddizioni grilline. Se ne potrebbe uscire solo con un’azione di governo
alla grande che porti dividendi prima sociali e poi politici da spendere nella
gara elettorale del 2023. Sicuramente Draghi andrà avanti come un treno
incurante delle liti tra i partiti della coalizione che lo sostiene. Ma in una
situazione così liquida e con interessi così forti in campo visto che ci si
gioca la leadership della prossima legislatura, dovrà fare molta attenzione. La
crisi italiana è ben lungi dall’essere risolta. Lo vedremo assai presto.
Quirinale, l'aula dei
"ribelli" ha scelto Mattarella: cosa non si fa per un anno di stipendio...Renato
Farina su Libero Quotidiano il 30 gennaio 2022
Con il sollievo di circa mille
famiglie, che avranno pane e anche parecchio companatico sicuro e garantito per
almeno altri 14 mesi, si è conclusa la grande parata democratica per l'elezione
del Presidente della Repubblica. Che è e sarà, fin quando lo vorrà, sette anni
di fila non ci crede nessuno, Sergio Mattarella (che all'ottavo scrutinio ha
ottenuto 759 voti, più dei 665 che aveva preso nel 2015). Degnissima persona,
candida come i suoi capelli, ma forse un pochino inavveduta nel sostenere che
cascasse il mondo nessuno sarebbe riuscito a trattenerla un minuto di più al
Quirinale. Sono le leggi elementari della comunicazione subliminale: lo ha fatto
troppo presto e troppe volte per non apparire come la vergine ritrosa, che alla
fine cede per dare figli alla patria (fuor di metafora: ragion di Stato). E le
sequenze di foto con i cartoni per il trasloco fatte circolare come se fossero
le avventure dei Ferragnez, iniettando, come da scuola di marketing, nostalgia
preventiva nell'animo del popolo che preferisce essere rassicurato da chi dà
garanzie che nulla accadrà, rispetto al fuoco di chi incendierà le praterie.
NIENTE DONNA
Facce meravigliate? Finzione
pura. Come i tentativi di proporre una donna, tre donne, quattro donne. Mai una
giusta. Ma anche il fatto che l'idea fosse venuta contemporaneamente a Salvini e
Conte la rendeva indigesta a quelli del Pd perché frutto della convergenza di
opinioni di "due forze estremiste". Ma non sono tutti nello stesso governo, lì
gli estremisti vanno bene, e se fanno i femministi diventano impresentabili?
Ridicolaggini. Era tutto già stabilito, non dalla volontà dei partiti o dei loro
capibastone, ma dalla logica possente dei rapporti di forza. Era persino tornato
Casini, rinfrescato dal lavacro di Silvio Berlusconi, ritornato leader di 180
centristi, deluso com' è stato dai parenti serpenti Salvini e Meloni. Eppure era
così semplice da prevedere. Draghi era il favorito, ma era pur sempre uno
spostamento dell'asse del mondo politico, ci sarebbero stati rovesciamenti,
cambi di governo, e chissà mai: elezioni! Con almeno 600 parlamentari destinati
a cambiare busta paga e a cercare di sfuggire alla disoccupazione (essere stati
deputati non funziona come referenza). Da che mondo e mondo non vincono i
sentimenti ma i rapporti di forza. E oggi la forza sta lì, nella pancia del
parlamento, intesa proprio come stomaco e già che ci siamo intestino. A essere
sconfitti sono non solo i partiti, ma i loro leader, non solo i segretari, ma
anche i capicorrente, i sottopanza. Nessuno manovra più nessuno. E le coalizioni
e le loro alleanze incollate con lo scotch risultano spiaccicate.
SAGGEZZA?
Ieri mattina quando la
sinistra ho ordinato di votare scheda bianca, Mattarella ha avuto 387 voti,
mentre il centrodestra si è astenuto. Enrico Letta con un Napoleone che si
dichiara felice della sua Waterloo dichiara: «Il Parlamento ha la sua saggezza
da ascoltare». E quale sarebbe la saggezza? Quella di puntare sul soldo, a
prescindere dalle coloriture politiche? Oppure l'aver dato il benservito al
sistema dei partiti in nome dell'accozzaglia parlamentare governata soltanto,
come la folla manzoniana, da dar l'assalto ai forni per assicurarsi la pagnotta?
C'è un sacco di roba da ricostruire. Ma da dove ripartire? Non è che gli
italiani possono puntare il dito contro i deputati e i senatori, che avrebbero
tradito chissà quale mandato popolare. Ma no: gli elettori hanno scelto proprio
loro. Non si sono truccati da geni pur di farsi votare. Hanno spedito su
internet i loro profili spesso da idioti patentati, senza arte né parte, se non
quella del tengo famiglia.
TENGO FAMIGLIA
Consoliamoci però. Forse la
gioia dell'unico partito dominante, quello dei cazzi propri, può persino non
essere una sciagura. Consente a Draghi di continuare il suo lavoro, a ministri
capaci come Brunetta e Giorgetti, Gelmini e Garavaglia, nonché un
sottosegretario come Sileri, senza dimenticare il generale Figliuolo, di
stabilizzare una ripresa economica straordinaria costruendo ripari credibili al
soffio dalla pandemia. La continuità impedisce colpi di mano dei mercati
finanziari i cui esponenti aggressivi si sono visti tagliare gli artigli rapaci
proprio da questo nulla di fatto. Con un'Italia quieta, senza tremiti
rivoluzionari, la solita Italietta del tengo famiglia. Ma a noi va bene così?
Boh.
Se una donna al Colle
diventa questione di tailleur.
Dopo la débacle Casellati, è
stata caccia grossa a un'altra donna. Purché "in gamba". Quasi a volerle
lasciare la poltrona a tutti i costi, per galanteria...di Francesca Spasiano su
Il Dubbio il 30 gennaio 2022.
A Maria Elisabetta Casellati
si è perdonato il gesto di scaramanzia che l’ha lanciata in pasto all’aula con
lo stesso tailleur blu del 24 marzo 2018, quando invece guadagnò il titolo di
prima presidente donna del Senato. Un po’ meno le si è perdonata la pelliccia di
ermellino, indossata chissà quando e ripescata a mezzo social per incorniciare
quello schianto.
Certo, la seconda carica dello
Stato poteva forse risparmiarsi, come oggi tutti le rimproverano. Ma forse non
poteva immaginare che il suo black friday si chiudesse con la formula “cerchiamo
un’altra donna”. Purché “sia in gamba”. Una formula odiosa, diciamolo, che nel
tentativo di prevenire l’altra protesta – “non basta che sia donna” – riesce a
fare anche di peggio. Si è forse detto in questa folle epopea quirinalizia che
il prossimo presidente dovesse essere almeno in gamba? Si è detto “alto
profilo”, si è detto che di “eccellenze” – persino tra le donne – ne abbiamo in
abbondanza. E si è detto che il centrodestra “sa promuovere le donne” meglio del
centrosinistra. Ma ora che l’altra Elisabetta è stata risparmiata a un passo
dalle urne, c’è il dubbio che la questione – da qualunque parte la si guardi –
resti un affare di pellicce e giacche “a taglio asimmetrico”.
Perché il dato politico è che
nell’anno delle donne il sacrificio necessario è stato di una donna. E tutti
amareggiati. Ma la verità è che il Mattarella bis dice dell’altro sul soffitto
di cristallo che è crollato sotto i piedi della guardasigilli Marta Cartabia,
per sua definizione. E la verità è che l’innovazione tanto invocata non può
essere “promossa” a colpi di primati. E di titoli concessi come omaggio al
genere. Bisogna credere che giochiamo nella stessa partita dei maschi pronti a
fare un passo indietro pur di lasciare la squisita briciola a chi rimane sempre
a bocca asciutta – quasi fosse una questione di galanteria. O almeno, per
carità, fingere di credere che un’opzione donna sia mai esistita.
L'ipocrita "phishing" sulle
donne. Marco
Zucchetti il 30 Gennaio 2022 su Il Giornale.
"Una donna al Colle" è
l'equivalente della mail che ti arriva da "Ecuittalia" dal titolo "Hai diritto a
un rimborso fiscale": puro e semplice phishing politico.
Nove. Esclusa Maria Elisabetta
Casellati, che al quinto scrutinio si è fermata a 382 voti battendo il record di
Nilde Iotti nel 1992, la donna che ha preso più preferenze in queste votazioni
quirinalizie è stata Marta Cartabia alla prima chiama. Scelta da nove elettori
su 1.009. Niente male per una scena politica che da anni utilizza le pari
opportunità come un'esca elettorale da quattro soldi.
Oggi che cala il sipario
sull'avanspettacolo e che al Quirinale salirà un Mattarella (nel tondo un meme
diventato virale sui social) di nome e non una mattarella per indole, «Una donna
al Colle» si svela per quel che è. Non una sacrosanta battaglia sociale e
nemmeno la petizione che ha raccolto 2.500 firme fra le protagoniste della scena
culturale del Paese. No, «Una donna al Colle» è l'equivalente della mail che ti
arriva da Ecuittalia dal titolo «Hai diritto a un rimborso fiscale»: puro e
semplice phishing politico. E come tale è giusto trattarlo, denunciando i
colpevoli - se non alla Polizia postale - almeno all'opinione pubblica.
Sarebbe spietato elencare
tutte le dichiarazioni sui «tempi maturi», sull'esigenza di avere queen maker in
campo, sul dovere morale di «allinearci all'Europa della Von der Leyen», di
«fornire alle bambine un esempio». Decine, centinaia di «svolte epocali»
annunciate, di «grandissimi segnali al Paese». Era «l'occasione per dimostrare
che una donna capace può raggiungere il vertice delle istituzioni». Parole
bipartisan, ma con toni più commossi e pugnaci a sinistra, dove la battaglia è
idealmente più sentita, almeno quanto l'imprescindibile ddl Zan. Peccato che
poi, finito il piccolo spazio pubblicità progresso, la politica abbia mostrato
il suo vero carattere, che nonostante il maquillage ipocrita è sempre e comunque
maschiocentrico per inerzia e comodità. Così i partiti entrati in Aula fluidi
come i Måneskin si sono magicamente rivelati retrogradi come latifondisti
dell'Ottocento. Sicché, al dunque, solo Calenda e +Europa hanno candidato la
Cartabia. Al dunque, quando il centrodestra ha tentato la carta Casellati, dalla
contraerea progressista è arrivata una (ovvia) raffica ad abbattere la candidata
femmina più votata della storia repubblicana. Al dunque, la boutade raffazzonata
della Belloni è stata gambizzata prima ancora che si alzasse in piedi.
Risultato: una strage di candidate sul selciato, un «femminicidio politico» e
nessuno, tranne la Meloni, a condannare il feroce cannibalismo dei partiti e
l'implicita misoginia dell'iter decisionale.
Tutto questo bluff, svelato
senza neppure un gioco di rilanci dietro agli occhiali da sole, dovrebbe
insegnare parecchio sulla pochezza dei giocatori al tavolo. Questo Giornale non
ha mai mostrato simpatia per il meccanismo delle quote rosa applicate a
qualsiasi campo, ma da sempre sostiene il merito come unico faro, a prescindere
dal genere, a costo di finire bollato di conservatorismo retrivo e patriarcale.
Per noi, la vera sconfitta generale è non essere riusciti a trovare un candidato
alternativo a Mattarella, non tanto non aver trovato una donna. Ma questo vale
per chi ha ben chiaro che la battaglia per l'autentica uguaglianza - che si
combatte dopo secoli di disparità - non si vince in sei mesi e soprattutto non
si vince limitandosi a tweet di propaganda. Che funzionano per ricevere like, ma
che diventano controproducenti quando vengono disattesi. Perché la prossima
volta che da sinistra si leverà il mantra della crociata femminista, a occhio
qualche donna si ricorderà di quei nove voti alla Cartabia. E alla domanda «se
non ora quando?», è probabile che risponderà: «Fosse per voi, probabilmente
mai». Marco Zucchetti
Letta si intesta la
rielezione. Ma voleva la Belloni al Colle.
Laura Cesaretti il 30 Gennaio
2022 su Il Giornale.
Anche il segretario dem
d'accordo con Conte e Salvini. Poi la virata notturna. Mistero nelle chat
democratiche.
«The winner», lo chiama Dario
Franceschini incrociandolo davanti ai cronisti in Transatlantico. Enrico Letta
si intesta politicamente il Mattarella bis: «Avevamo detto fin dall'inizio che
per noi sarebbe stato il massimo».
La rielezione è la exit
strategy migliore per un partito che si è lacerato, sia pur molto meno
platealmente di altri, fino all'ultimo tra chi puntava su Draghi (a cominciare
da Letta), chi su Casini, chi su Amato, chi sul bis. Solo che attorno alla folle
partita che si è giocata in questi giorni, e soprattutto nell'ultima notte,
restano molte macerie. «Emerge una crisi della politica, ora vanno fatte le
riforme», dice Letta, a cominciare dal proporzionale.
Il centrosinistra è imploso. I
rapporti tra Pd e Cinque Stelle (ala Conte) sono ai minimi storici, tra scambi
di accuse e veleni. «Dovremo inevitabilmente fare una profonda riflessione su
questo», dice Enrico Borghi, rivendicando invece «una forte cooperazione tra il
Pd, Renzi, Di Maio e Leu». Il riferimento è a quello che proprio Renzi,
rivendicando di averlo «bloccato», chiama «l'asse verde-giallo-nero» sul nome di
Elisabetta Belloni, capo del Dis. Aggiungendo: «Sono intervenuto ieri sera,
quando era praticamente fatta perché anche Enrico Letta aveva dato il via
libera». La ricostruzione di quelle ore convulse è confusa, perché dal Pd si
smentisce il cartellino verde del segretario alla «operazione donna» lanciata in
contemporanea da Salvini e Conte, dopo un vertice a tre con Letta, e poi
appoggiata da Meloni e Grillo: «Era solo uno dei nomi della rosa su cui si
ragionava, nessun placet», spiegavano già nella serata di sabato dal Nazareno.
Accusando Conte e Salvini di aver giocato sporco, mettendola in piazza e dandola
per fatta.
Però è vero che nelle chat
interne dei parlamentari Pd, sabato sera, si avvertiva che, un paio d'ore dopo
la debacle del centrodestra sulla Casellati, «le trattative sono ripartite, i
leader (Salvini, Conte e Letta) si sono visti, i nomi sono stati fatti». E che
«per la prima volta potrebbe essere una donna a diventare presidente», perché
«la combinazione delle priorità dei diversi partiti porta alla figura di
Elisabetta Belloni».
Eppure, di lì a poco, è
partita una fortissima manovra interdittiva. Certo non contro la persona di una
prestigiosa altissima diplomatica, stimata da tutti e tirata in ballo senza il
suo permesso in una partita tutta politica, ma per il suo ruolo delicatissimo di
capo dei servizi. Prima Renzi, poi Leu e Forza Italia, poi - pubblicamente - il
ministro degli Esteri Di Maio e - dietro le quinte - quello della Difesa
Guerini. «Una operazione inqualificabile tentata da Salvini e Conte per
accreditarsi come kingmaker, ma anche per destabilizzare tutto: governo e
legislatura, con l'obiettivo di far fuori Draghi e magari ricostituire
un'alleanza destra-Conte per il voto», dice un dirigente dem. Che spiega: «Il
blitz sulla donna, costruito mediaticamente secondo la miglior tradizione
populista» poteva avere un effetto devastante: «i gruppi Pd si sarebbero
spaccati», lei rischiava di non essere eletta e di doversi dimettere, il governo
sarebbe caduto». Uno scenario da cataclisma, «che poteva minare la stabilità Ue»
proprio mentre Putin alza la sposta. Per fermarlo «abbiamo fatto muro con Renzi,
Letta, Di Maio, Fi e centristi, e dettato il time-out». Ossia la telefonata
notturna di Enrico Letta a Berlusconi per avere luce verde al Mattarella bis, e
l'avvertimento a Conte e Salvini: domani arriveranno oltre 400 voti su
Mattarella, fermatevi. Resta il dubbio su quell'iniziale apertura Pd alla «prima
presidente donna». Laura Cesaretti
Alessandro Ferro
per ilgiornale.it il 30 gennaio 2022.
Spunta un "giallo" nella
vicenda della candidatura di Elisabetta Belloni al Quirinale. segretario del Pd,
Enrico Letta, si è in pratica rimangiato quanto affermato sulla candidatura a
Presidente della Repubblica del capo dei servizi segreti in Italia, e cioé che
la sua candidatura sia stata portata avanti dai giallorossi, quindi da Pd e
Movimento Cinque Stelle.
"Non c'era nessuna lista..."
Intervistato dalla
trasmissione "Mezz'ora in più" su Rai Tre, ha affermato che "non era stata fatta
una lista: si è cominciato a ragionare sui nomi presenti sui giornali, punto. Io
non ho obiezione che il capo dei servizi divenga Presidente della Repubblica,
nessuna norma lo impedisce ma dopodichè la discussione non era arrivata a quel
punto".
Così, però, non è andata: come
abbiamo scritto sul Giornale.it, Letta si è preso il merito della rielezione di
Mattarella ma in realtà al Colle voleva la Belloni. "Avevamo detto fin
dall'inizio che per noi sarebbe stato il massimo", aveva affermato Letta pochi
minuti dopo la proclamazione.
"Adesso è colpa dei
giornalisti..."
A far notare l'incoerenza, ci
ha pensato su Twitter Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva dal settembre
2019. "Certo Enrico Letta, tutta colpa dei giornalisti, era solo una discussione
teorica… #Belloni", ha twittato, ripostando l'endorsment di Beppe Grillo su
Elisabetta Belloni. "Benvenuta Signora Italia, ti aspettavamo da tempo", aveva
scritto Grillo alle 21.34 del 28 gennaio. Insomma, l'intesa su Belloni
era...bella e buona.
"Cortocircuito mediatico"
Per difendersi ulteriormente
dal nome Belloni, Letta ha affermato alla trasmissione televisiva che "i
rapporti con Conte i 5 Stelle sono trasparenti. Tutti hanno chiaro come sono
andate le cose e cosa è successo. Io considero che non c'è stato accordo
preventivo tra Lega e 5Stelle su quell'uscita, per me è stato un cortocircuito
mediatico, la proposta è nata e morta nel giro di 10 minuti. E si è arrivati a
Mattarella. Poi io da segretario del PD parlo con il segretario del M5S".
In pratica, il segretario del
Pd sostiene che nel pomeriggio di venerdì si era cominciato a parlare dei nomi
per capire se c'erano "veti e controveti, per vedere se era possibile fare un
passo in avanti". Ognuno doveva ragionare, tra i propri grandi elettori, sui
nomi che erano stati fatti fino a quel momento, ovviamente nella stretta cerchia
dei "papabili". "Era l'inizio di una discussione, ma tutto è stato buttato in
pasto all'opinione pubblica", conclude.
Elisabetta Belloni "sulla
lista di Enrico Letta". Ma... Quirinale, il gioco sporco del Pd sulla pelle di
Sergio Mattarella.
Libero Quotidiano il 30 gennaio 2022
Elisabetta Belloni fatta fuori
dallo stesso Partito democratico che l'aveva proposta. A spiegare come siano
andate davvero le cose sul nome della direttrice generale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza, era già stato Matteo Salvini. "La Belloni mi è
stata proposta ieri da Pd e M5s. Dato che per cinque giorni sono stato io a fare
proposte, ma non ne andava bene una, allora ho chiesto a loro dei nomi da
sottopormi - aveva detto ai microfoni della Maratona Mentana su La7 -. Quando
sono andato nell’ufficio di Conte mi sono stati fatti cinque nomi, dopo aver
parlato con gli alleati sono tornato dicendo che uno aveva il sostegno della
Lega perché aveva tutto per essere un ottimo presidente, credibile e super
partes". Quel nome era proprio la Belloni, naufragata in una sola notte. Una
mossa sporca, quella di Enrico Letta e del Pd, sulla pelle di Sergio Mattarella:
una finta sul capo degli 007 per tendere un tranello a Salvini e Conte. Il
prezzo da pagare? Il bis di Mattarella, appunto. E la rabbia del presidente
riconfermato.
Come? Ecco che i dettagli
sull'accaduto aumentano. Ad aggiungere qualche particolare in più ci pensa
il Corriere della Sera. "Nella lista di Letta - si legge in riferimento alla
rosa di candidati proposta dai dem - c'è il nome su cui puntano Conte e Salvini:
Belloni". Peccato però che proprio su quel profilo, ben tre giorni prima nel Pd
era scoppiato il caos. Il motivo? Proporre alla presidenza della Repubblica il
capo dei servizi segreti non è roba da Paese dell'Occidente democratico. "È
fatta purtroppo, perché con i voti della Meloni hanno i numeri. E in Aula si
creerà un effetto trascinamento che ci costringerà a votarla", avrebbe
commentato subito Dario Franceschini mentre M5s e Lega annunciavano il nome
della Belloni in lizza per il Colle.
E ancora, Loredana De
Petris in un messaggio ai colleghi: "C'avete proprio rotto er...". Ma a reagire
in modo più duro degli altri Lorenzo Guerini. Il ministro avrebbe riferito di
non aver "mai gridato così in vita mia". Poi è stata la volta di Matteo
Renzi: "Hanno provato a mettercela nel (bip) con Frattini. Ora ci riprovano con
Belloni. Se non li fermiamo lanceranno anche il generale Figliuolo". Ma anche
sul fronte del centrodestra Giovanni Toti non è stato da meno: "È una cosa
folle. Non ne sapevo nulla. Ho sempre detto che se si deve andare su un tecnico
per me c'è solo Draghi. Se è un politico, si può fare con Casini", avrebbe detto
nel retro di un ristorante in chiamata con Di Maio chiudendo anche lui
all'ipotesi Belloni. Per sempre.
Estratto dell'articolo di
Maria Teresa Meli per il "Corriere della Sera" il 31 gennaio 2022.
[…] Ai fedelissimi il leader
del Pd ha spiegato: «Mi hanno accusato di aver detto di sì a Belloni. Io ho
detto che non mettevo veti preventivi. Ma la verità è che lei non è mai stata in
gioco davvero perché la condizione del Pd per dire si era l'unità della
maggioranza e del no di Renzi e di Forza Italia sapevano già tutti, come era
ovvio il no dei nostri gruppi. Salvini ha tentato il blitz, Conte ha pensato che
fosse fatta e quel nome è stato dato in pasto all'opinione pubblica».
Alla Rai, ospite di Lucia
Annunziata, Letta su Belloni osserva: «Non esiste una norma che le avrebbe
impedito di fare la presidente, ma la discussione non è arrivata fino a questo
punto». […]
Carlo Bertini per “La Stampa”
il 31 gennaio 2022.
Tardo pomeriggio domenicale,
Enrico Letta si collega via Zoom con il suo stato maggiore e, nella cabina di
comando del Pd, il leader butta giù la strategia per i prossimi mesi: tenersi
distanti dal «congresso» dei 5 stelle, «che devono far presto a chiarirsi»,
stringere il dialogo con Renzi, da cui ha avuto una sponda cruciale in vari
passaggi e formare un asse anche con Forza Italia in Parlamento.
Non per farla entrare nel
campo largo, dove neanche l'ex segretario dem intende affacciarsi, ma in vista
di una eventuale «maggioranza Ursula» a futura memoria. Per questo va fatta una
legge elettorale che consenta ai centristi di sganciarsi dalla destra. Mezzo
Parlamento spinge infatti per il proporzionale.
La scelta di campo dei 5s
La prima preoccupazione sono i
5 stelle: anche se si spaccassero in due tronconi, è la convinzione del vertice
Pd, starebbero entrambi, Di Maio e Conte, nel perimetro della sinistra. Ma ciò
porterebbe tensioni.
«Ora devono chiarirsi
presto», taglia corto Letta. «Conte alla stretta finale ha rispettato le scelte
dei progressisti e l'unità della maggioranza di governo, ma non dobbiamo farci
tirar dentro nella guerra dei Roses dei 5 stelle tra lui e Di Maio», ragiona nel
day after di quella che considera una vittoria.
Terza di una serie (dopo il
successo alle amministrative nelle grandi città, dopo la conquista a pieni voti
del suo seggio a Siena), che suggerirebbe di convocare lui un congresso
anticipato per fare il pieno dei consensi e mettere tutti a tacere prima della
tornata elettorale: questo gli chiedono i suoi fedelissimi, ma lui frena. Il
congresso ha la sua scadenza naturale a inizio 2023, a ridosso delle elezioni
politiche, ma il segretario non intende anticiparlo (per ora) ritenendolo un
appuntamento divisivo. Mentre adesso il partito «è unito come non mai».
Il colosso Fiano fa la guardia
La cosa più divertente del day
after è stato il ringraziamento che Enrico Letta ha tributato al colosso
Emanuele Fiano, per essersi eretto con la sua mole in difesa degli ordini di
scuderia in aula: controllando fisicamente accanto ai banchi della presidenza
che tutti i grandi elettori dem urlassero «Presente!» senza ritirare la scheda,
senza fare scherzi e giochini tipici dei franchi tiratori. Il gioco di squadra
ha portato anche a una ricucitura dei rapporti con i ministri del governo
Draghi: i capicorrente Andrea Orlando, Lorenzo Guerini e Dario Franceschini si
sono spesi per Mattarella nella fase finale e anche per questo il leader adesso
si sente più forte.
Basta cambi di casacca
E ora spinge su un tasto: «No
ai cambi di casacca perché rendono più lontana la politica dai cittadini. Che
devono poter scegliere gli eletti, quindi va cambiata la legge elettorale,
perché quella attuale è la peggiore». E se in tivù da Lucia Annunziata fa notare
che rispetto a quando Renzi fece eleggere Mattarella, lui ha portato a casa una
partita ben più difficile («nel 2015 avevamo il 45% dei grandi elettori, oggi il
15%»), è con l'ex nemico giurato che intende siglare una tregua: mano tesa ad un
nuovo sistema anche proporzionale che tutti i centristi anelano come ciambella
di salvataggio.
E comunque, la polemica sulla
candidatura di Elisabetta Belloni, non scartata subito dal segretario del Pd
sono ancora accese. «Il capo del Dis al Colle? La norma non lo impedisce»,
risponde Letta. «Era uno dei nomi ma tutto si è fermato dopo dieci minuti quando
Salvini ha prodotto il cortocircuito mediatico
Maria Teresa Meli per
il "Corriere della Sera" il 31 gennaio 2022.
Senatore Renzi, chiedere a
Mattarella di ripensarci non è una sconfitta della politica?
«È la sconfitta di alcuni
politici, non della politica. Apprezzo il salutare ripensamento di alcuni
colleghi. Pensi a Salvini che nel 2015 twittava "Mattarella non è il mio
presidente" e ora si intesta la rielezione. Oppure ai Cinque Stelle che volevano
l'impeachment del presidente e adesso esultano come allo stadio. Il Parlamento
di sovranisti e populisti elegge il presidente scelto da noi nel 2015: hanno
perso loro, noi brindiamo».
Il bis di Mattarella, però,
non era la sua prima opzione.
«Non lo era. Mattarella aveva
chiesto di evitare il secondo mandato adducendo motivazioni serie. Aveva
spiegato che la seconda rielezione consecutiva trasformava il precedente di
Napolitano in una sorta di modifica alla costituzione sostanziale. Questa
raffinata sensibilità istituzionale, propria di un galantuomo, è destinata a
passare in secondo piano davanti allo show indecoroso di chi ha trasformato
l'elezione del capo dello Stato in una sorta di X Factor.
Quando ho visto leader
politici cercare candidati a caso, passando dal diplomatico al professore senza
alcuna logica istituzionale mi sono preoccupato. E mi sono detto: meglio
costringere Mattarella al bis che rimpiangere per sette anni le soluzioni
strampalate last minute di qualche presunto leader».
Si riferisce a Salvini?
«In primis a lui, ma non solo
a lui. Salvini ha scambiato la ricerca del presidente della Repubblica con la
ricerca del super ospite a Sanremo: cercava il nome a effetto. Quando un
pomeriggio il leader della Lega è sparito tre ore per andare a casa di Cassese,
ho sperato che almeno gli tornasse utile la lezione di diritto che il professore
avrà provato a dargli. Anche perché per me Cassese è in assoluto il migliore. E
invece nulla, Salvini si è mosso senza logica. Una volta voleva l'accordo con
Letta, poi con Conte, poi con Meloni, poi con noi. Alla fine è riuscito nel
risultato di scontentare tutti, a cominciare dai suoi».
Salvini dice che su Elisabetta
Belloni c'era l'accordo di Conte e di Letta.
«Di Letta non so. L'accordo di
Conte invece c'era. La vera novità politica della settimana presidenziale è
stata proprio il ritorno dei due compagni di viaggio del governo gialloverde.
Salvini e Conte si sono spalleggiati. Io ho cercato di far saltare il loro patto
non per antipatia personale, ma per una considerazione politica. I gialloverdi
infatti hanno individuato due nomi su cui costruire una maggioranza assieme alla
Meloni: il presidente del Consiglio di Stato Frattini prima e il direttore del
Dis Belloni poi. Volevano un presidente espressione della coalizione
giallo-verde-nera».
E perché non vi siete uniti
anche voi?
«Per ragioni istituzionali: le
tensioni geopolitiche tra Russia e Occidente non facevano di Frattini il miglior
candidato, specie in un periodo come questo, visto la sua relazione con Mosca. E
perché in una democrazia evoluta il capo dei servizi segreti non diventa
presidente della Repubblica. Quando ho sceso le scale di Montecitorio e ho
criticato in diretta tv la proposta di Salvini e Conte ero convinto che la
Belloni sarebbe stata eletta, perché avevano i numeri per farcela.
E parte del Pd stava sposando
quella scelta. Ma sarebbe stato uno sfregio alle istituzioni di questo Paese.
Non ho paura di dirlo a voce alta, senza timori, con la serietà di chi è stato
presidente del Consiglio e ricorda che prima delle amicizie bisogna rispettare
le istituzioni. Ci ho messo la faccia, ma chi ha cultura istituzionale sa che
era doveroso da parte mia farlo».
Secondo lei il governo esce
indebolito? La legislatura arriverà fino al termine?
«Spero che Draghi riprenda il
timone del governo con più forza. Che non significa ignorare il Parlamento ma
sfidare la politica in positivo. Draghi non è indebolito. Ma il suo governo oggi
può fare di più e meglio: sbloccare le infrastrutture, semplificare le regole
della dad a scuola, mettere a terra i progetti del Pnrr, combattere in Europa la
battaglia sul debito. Tutte cose che il premier farà, ne sono certo. E noi
saremo al suo fianco. La legislatura durerà fino al 2023: mai avuto dubbi a tal
proposito anche se Conte ha sognato di interromperla prima».
Ha ritrovato sintonia con
Enrico Letta?
«Sui temi di fondo siamo
sempre dalla stessa parte. Enrico si è tranquillizzato quando ha capito che non
avrei mai fatto asse sulla Casellati. In tanti pensavano che avrei votato
Casellati pur di diventare presidente del Senato. Ma io mi chiamo Matteo Renzi:
combatto contro tutti per le mie idee, non per un tornaconto personale. Quando
davanti a un caffè ho chiarito a Letta che non avrei mai accettato lo scambio di
poltrone è cambiato il clima. E abbiamo lavorato meglio».
Forza Italia si è dissociata
dal centrodestra, questo passaggio può essere foriero di novità?
«Sì. Il centrodestra non c'è
più, ha detto Meloni. E non è che i Cinque Stelle siano messi meglio. Saranno
mesi di cantieri all'interno dei vari schieramenti politici. Ma è prematuro
immaginare che cosa accadrà. La conferma di Mattarella e di Draghi portano
stabilità al Paese e questo paradossalmente consentirà l'evoluzione del quadro
partitico».
Lei propone il
presidenzialismo, che però mal si accorda con il proporzionale, verso cui invece
sembra si vada.
«Dopo il 2016 non dovrei
parlare più di riforme costituzionali e di legge elettorale: ogni giorno è
sempre più chiaro che quella riforma unita alla legge elettorale con
ballottaggio avrebbe dato stabilità al sistema e più forza al Paese. Tuttavia
andare all'elezione diretta del presidente mi sembra una necessità rafforzata
dallo show triste di questi giorni: che poi sia presidenzialismo all'americano o
semipresidenzialismo alla francese, vedremo. Ma questo tema sarà oggetto della
legislatura 2023-2028. Sulla legge elettorale, invece, si potrebbe fare nei
prossimi mesi ma inciderà la volontà dei gruppi maggiori come Cinque Stelle e
Lega che ad oggi sono dilaniati».
Salvini tra accuse e
ovazioni. Dalla sfiducia degli alleati alla vittoria sui "draghisti".
Paolo Bracalini il
30 Gennaio 2022 su Il Giornale.
Si riapre il fronte interno
nella Lega, Matteo argina le pressioni da Chigi. Un deputato: "Dai nostri
messaggi di insulti".
«Dai nostri arrivano
messaggini di fuoco. I più educati ci rinfacciano di aver messo ancora una volta
al Quirinale uno del Pd, dopo aver promesso il contrario. Di aver perso una
settimana senza portare poi a casa niente. Per non dire degli insulti...»
racconta un deputato leghista (sotto rigoroso anonimato). Il flop di Salvini nel
ruolo di king maker del centrodestra, con la serie di candidati bruciati e il
ripiegamento finale su Mattarella, provoca nuove crepe nel Carroccio (e critiche
dagli alleati Berlusconi, Meloni e dal vecchio Bossi). Giorgetti, il punto di
riferimento dell'area governista del partito, quella che ha provato a convincere
Salvini a intestarsi l'operazione Draghi al Colle, è nuovamente in
fibrillazione. Per qualche ora ieri si è parlato delle sue imminenti dimissioni
da ministro, non smentite dal diretto interessato ma anzi alimentate da una
frase sibillina («Io via? È una ipotesi, magari c'è da migliorare la squadra.
Qualcuno resta al Colle, io torno a casa...»). Poi Giorgetti ha chiarito che il
cambiamento a cui faceva riferimento non è un rimpasto di governo, ma una
«taratura» e un nuovo «codice di comportamento tra gli alleati della
maggioranza». In settimana lui e Salvini hanno chiesto un incontro con Draghi,
l'obiettivo è ottenere che il governo «faccia più squadra». La Lega teme che il
tutti contro tutti andato in scena sul Quirinale si sposti sul governo,
paralizzandolo. Di fronte c'è l'ultimo anno di legislatura e in prospettiva una
campagna elettorale, con Salvini che soffre la concorrenza interna della Meloni
all'opposizione.
Il ministro, come pure i
governatori Zaia e Fedriga, sono stati tenuti ai margini della trattativa da
Salvini che si è mosso per conto suo, confidandosi con i pochi della sua cerchia
ristretta. L'esito è considerato un fallimento. «Mattarella poteva andare anche
bene, ma non così, non al settimo giorno, diventa difficile spiegarlo poi ai
nostri elettori» raccontano nella Lega. Salvini ai parlamentari leghisti (che
comunque lo hanno accolto con una ovazione, riconoscendogli il coraggio di aver
messo la faccia in una partita difficile) ha detto che, arrivati in un vicolo
cieco, tanto valeva intestarsi Mattarella (cui dopo l'elezione ha fatto una
«telefonata di gratitudine»). Il leader non risparmia accuse a Forza Italia per
i voti mancati alla Casellati e per la decisione degli azzurri di trattare da
soli («Così mi hanno delegittimato»). Aveva provato con la Belloni («Me l'hanno
proposta Letta e Conte, ma poi Letta ha cambiato idea» racconta), prima ancora
aveva tentato la carta Casini, trovando però resistenze nel partito (e negli
alleati, la Meloni). Ma c'è un altro fronte interno che Salvini ha dovuto tenere
sotto controllo, e che alla fine lo ha fatto virare su Mattarella. E cioè il
pressing telefonico del premier Draghi su Giorgetti e i governatori leghisti. Lo
racconta il leghista Rixi: «L'unica cosa per cui avrei preferito Casini era la
sua posizione sulla giustizia. Ma con il premier che faceva incursioni da noi
non potevamo reggere. Il centrodestra? In realtà solo Berlusconi poteva guidarlo
con il suo potere economico. Non so se non valga la pena a questo punto fare una
riflessione sul proporzionale». Sull'ipotesi rimpasto Salvini non chiude: «Non
lo so, ne parleremo con Draghi. Meglio che al governo ci sia una squadra
compatta, se qualcuno non ha voglia di lavorare o ha voglia di distruggere
bisogna essere coscienti e coerenti». Non è un mistero che la Lega chieda la
testa della Lamorgese. Ma se Salvini non ci era riuscito prima, difficile lo
ottenga ora, indebolito dalla vicenda Quirinale. Paolo Bracalini
Sergio Mattarella al
Quirinale, "liti e urla nella notte": voci dalle sacre stanze, così si è
arrivati al bis.
Libero Quotidiano il 30 gennaio 2022.
La rielezione di Sergio
Mattarella è arrivata e non senza attriti. Dopo ben sette votazioni andate a
vuoto, è la settima a proclamare il presidente della Repubblica uscente nuovo
capo dello Stato. Cosa ha sbloccato l'impasse dei partiti? Una difficilissima
trattativa avvenuta la notte precedente al voto. Stando a un retroscena
del Corriere della Sera, a portare al Mattarella bis "urla e liti". Sì, proprio
così. Perché se Matteo Salvini e Giuseppe Conte erano giunti alla conclusione di
voler proporre Elisabetta Belloni, lo stesso non si può dire dei dem.
"È fatta purtroppo, perché con
i voti della Meloni hanno i numeri. E in Aula si creerà un effetto trascinamento
che ci costringerà a votarla", è quanto va sostenendo Dario Franceschini
mentre Loredana De Petris è ben più schietta e si attacca al cellulare avvisando
i compagni del Pd: "C'avete proprio rotto er...". Poi è la volta di Lorenzo
Guerini che dà qualche dritta al segretario del partito per poi confidarsi con
un altro piddino: "Non ho mai gridato così in vita mia". Secondo Il Corsera il
ministro della Difesa grida al telefono anche con i dirigenti di Forza Italia,
perché dichiarino subito la loro contrarietà alla candidatura. Dello stesso
parere Matteo Renzi: "Hanno provato a mettercela nel (bip) con Frattini. Ora ci
riprovano con Belloni. Se non li fermiamo lanceranno anche il generale
Figliuolo".
I malumori però aleggiano
anche nel centrodestra, dove Giovanni Toti telefonerebbe a Luigi Di Maio: "È una
cosa folle. Non ne sapevo nulla. Ho sempre detto che se si deve andare su un
tecnico per me c'è solo Draghi. Se è un politico, si può fare con Casini". E
così si inizia a sondare il terreno per portare al Colle Pier Ferdinando Casini,
ma i numeri sono risicati e Silvio Berlusconi fa un passo avanti: sì a
Mattarella. I giochi a quel punto iniziano a delinearsi e il presidente uscente
è l'unico nome che mette d'accordo tutti. O quasi.
Viva Mattarella. Ma 14 anni
sono un regno e la rottura di una prassi.
Nessuno pensi di sfruttare il
sacrificio del presidente Mattarella per trarne un vantaggio di parte. Nessuno
provi a intestarsi questa vittoria perché è una sconfitta per tutti. Davide Varì
su Il Dubbio il 30 gennaio 2022.
Dunque siamo tornati al punto
di partenza, siamo tornati a Mattarella. E quel che rimane di questa vicenda
sono le ceneri di leader e partiti che hanno avuto mesi e mesi di tempo per
costruire un’alternativa per Quirinale e Palazzo Chigi, salvo poi voltarsi
indietro e decidere di congelare l’esistente. Ma questo è l’esatto opposto della
politica.
La politica è visione, è
costruzione del futuro e non cristallizzazione del passato. E ora nessuno si
azzardi a dire che in realtà Mattarella sperasse da tempo in questo finale. Il
capo dello Stato è un giurista, un cultore della nostra Carta e sa benissimo che
rompere la prassi del settennato significa consolidare (è già accaduto con
Napolitano) un precedente assai delicato: di qui i suoi scrupoli che superano di
gran lunga le sue ambizioni. Ma è bene essere chiari: quattordici anni di
presidenza sono tanti, sono un regno edificato sulla forzatura di quella prassi
costituzionale. Certo, se proprio dobbiamo avere un “re” è bene che sia
Mattarella, perché il Presidente ha un rispetto sacrale del diritto e della
Costituzione, ma si tratta comunque di un’anomalia che avrà ripercussioni su un
sistema di partiti già al collasso. Insomma, la candidatura di Mattarella è una
buona notizia per il Paese ma un pessimo segnale per la nostra politica.
Del resto lo spiegò bene
l’allora presidente Giorgio Napolitano quando, in occasione del discorso di
insediamento per il suo secondo mandato, disse ai partiti che lo avevano
implorato di tornare che la sua rielezione era il segno della loro sconfitta.
«Di fronte alla gravissima crisi istituzionale – dichiarò Napolitano di fronte a
un Parlamento ammutolito – hanno finito per prevalere contrapposizioni,
lentezze, esitazioni circa le scelte da compiere, calcoli di convenienza,
tatticismi, e strumentalismi».
E qui sembra riecheggiare la
voce di don Milani: «Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio.
Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia». E poi ancora:
«Ecco cosa ha condannato alla sterilità o a esiti minimalistici i confronti tra
le forze politiche e i dibattiti in Parlamento». Parole dure e drammaticamente
attuali. La sconfitta di allora, oggi si ripete e si aggrava. E ora nessuno
provi a intestarsi la vittoria del gesto di Mattarella. Non ci provi Enrico
Letta, incapace, in questi mesi, di creare un’alternativa politica; non ci provi
Salvini, che per giorni ha portato a spasso opinione pubblica e giornalisti
bruciando candidati uno dietro l’altro e mandando allo sbaraglio persino la
seconda carica dello Stato e il capo dei servizi segreti; e non ci provino né
Conte né Di Maio, che hanno giocato uno contro l’altro ballando sulle ceneri di
un movimento allo sbando e la cui unica preoccupazione era quella di tirare
avanti fino a settembre per assicurarsi la pensione: hai capito gli anticasta? E
poi non ci provino né Forza Italia né Renzi, prigionieri di una visione
personalistica e autistica della politica e incapaci, ormai, di immaginare un
futuro per sé e per il Paese. Non ci provi neanche Meloni – ma lei in fin dei
conti non ci proverà – il cui unico scopo era minare il governo Draghi per
andare al voto e intascare il prima possibile quello che i sondaggi le
promettono da mesi.
Insomma, nessuno pensi di
sfruttare il sacrificio del presidente Mattarella per trarne un vantaggio di
parte, anche perché il gesto del Capo dello Stato si fonda sull’autonomia e
sulla indipendenza e chiunque provasse a mettere il timbro sporcherebbe quella
scelta alta, disinteressata, indipendente. Nessuno, dunque, provi a intestarsi
questa vittoria perché è una sconfitta per tutti. Tanti auguri presidente
Mattarella, sappiamo di essere in ottime mani.
Quando Napolitano spiegò ai
partiti che la sua rielezione era la loro sconfitta.
Il Dubbio il 30 gennaio 2022.
Il durissimo e inascoltato
discorso che Giorgio Napolitano pronunciò in occasione della sua rielezione il
22 aprile del 2013.
Il durissimo e inascoltato
discorso che Giorgio Napolitano pronunciò in occasione della sua rielezione il
22 aprile del 2013.
«Come voi tutti sapete non
prevedevo di tornare in quest’aula per pronunciare un nuovo giuramento e
messaggio da presidente della Repubblica. Avevo già nello scorso dicembre
pubblicamente dichiarato di condividere l’autorevole convinzione che la non
rielezione al termine del settennato è l’alternativa che meglio si conforma al
nostro modello costituzionale di presidente della Repubblica. (…).
A queste ragioni e a quelle
più strettamente personali, legate all’ovvio dato dell’età, se ne sono infine
sovrapposte altre, rappresentatemi, dopo l’esito nullo di cinque votazioni in
quest’aula di Montecitorio, in un clima sempre più teso, dagli esponenti di un
ampio arco di forze parlamentari. È emerso, nella mattinata di sabato, un
drammatico allarme per il rischio ormai incombente di un avvitarsi del
parlamento in seduta comune nell’inconcludenza, nella impotenza ad adempiere il
supremo compito costituzionale dell’elezione del capo dello stato.
(…) È a questa prova che non
mi sono sottratto, ma sapendo che quanto è accaduto qui nei giorni scorsi ha
rappresentato il punto di arrivo di una lunga serie di omissioni e di guasti, di
chiusure e di irresponsabilità. Negli ultimi anni, a esigenze fondate e domande
pressanti di riforma delle istituzioni e di rinnovamento della politica e dei
partiti, che si sono intrecciate con un’acuta crisi finanziaria, con una pesante
recessione, con un crescente malessere sociale, non si sono date soluzioni
soddisfacenti; hanno finito per prevalere contrapposizioni, lentezze, esitazioni
circa le scelte da compiere, calcoli di convenienza, tatticismi, e
strumentalismi.
Ecco cosa ha condannato alla
sterilità o a esiti minimalistici i confronti tra le forze politiche e i
dibattiti in parlamento. Quel tanto di correttivo e innovativo che si riusciva a
fare nel senso della riduzione dei costi della politica, della trasparenza e
della moralità nella vita pubblica è stato, dunque, facilmente ignorato o
svalutato e l’insoddisfazione e la protesta verso la politica, i partiti e il
parlamento sono state con facilità, ma anche con molta leggerezza, alimentate e
ingigantite da campagne di opinione demolitorie, da rappresentazioni unilaterali
e indiscriminate in senso distruttivo del mondo dei politici, delle
organizzazioni e delle istituzioni in cui essi si muovono». Attenzione: il
vostro applauso, quest’ultimo richiamo che ho sentito di dovere esprimere, non
induca ad alcuna autoindulgenza. (…) Se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità
come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le
conseguenze dinanzi al paese».
Con i “ceci” in
Transatlantico per andare in ginocchio da Mattarella.
«Io ho già comprat-to i cec-ci», sussurra un grande elettore sardo M5S in
Transatlantico poco dopo l’apertura di Matteo Salvini al bis di Sergio
Mattarella al Quirinale. Giacomo Puletti su Il Dubbio il 29 gennaio 2022.
«Io ho già comprat-to i
cec-ci», sussurra un grande elettore sardo M5S in Transatlantico poco dopo
l’apertura di Matteo Salvini al bis di Sergio Mattarella al Quirinale. E di ceci
ne serviranno parecchio, se davvero tutte le forze politiche oggi pomeriggio
saliranno al Colle per chiedere in ginocchio al presidente uscente la sua
disponibilità alla rielezione.
«Dopo cinque giorni di “no”
del centrosinistra, non vorrei andare avanti così per altrettanti, e quindi
forse sarebbe più saggio chiedere al presidente di rivedere il suo pensiero»,
aveva detto pochi minuti prima il leader della Lega ai cronisti entrando in Aula
per votare. O meglio per astenersi, come sta facendo tutto il centrodestra in
questo settimo scrutinio. «Casini? Io non metto veti su nessuno», ha poi
chiosato Salvini lasciando aperto uno spiraglio sull’ex presidente della Camera.
Che ci spera ancora, scrive su Twitter che è il suo nome è sul tavolo «solo se
frutta di un’ampia convergenza» ma poi elimina il post e pubblica su Instagram
una foto con il Tricolore. Stile di comunicazione quantomeno “rivedibile”. Il
centrosinistra opta invece per la scheda bianca, dopo che Conte non si è
presentato al vertice di prima mattina dove erano presenti tutti gli altri
leader, e come ieri centinaia di voti finiranno al presidente della Repubblica
uscente.
«Scrivete Mattarella, ma non
troppo», si legge nella comunicazione arrivata ai grandi elettori M5S, dopo il
«bianca, cioè senza nessun nome scritto sopra» di qualche giorno fa. Nel
frattempo una grande elettrice dem s’intrattiene su una poltroncina leggendo
un Diabolik. Ma chi in questo Romanzo Quirinale sia il ladro e chi l’ispettore
Ginko, chi Eva Kant e chi un semplice poliziotto incaricato di provare a fermare
il Re del Terrore. Quel che è certo è che in Transatlantico tanti volti non sono
quelli reali, come nella finzione del fumetto inventato da Angela e Luciana
Giussani nel 1962, e che con un po’ di forzature, senza arrivare all’utilizzo
della celebre Scopolamina, i peones rivelerebbero anche i segreti più nascosti.
Di ladri veri, in Transatlantico, c’è solo Renzi, che come sempre prova a rubare
la spilla a un collega. In questo caso Toni Iwobi della Lega, che stoicamente
resiste. E Renzi, per una volta, desiste.
Il ruolo del Presidente del
Consiglio. Draghi come Mr Wolf, il premier da favorito a kingmaker: altro che
Salvini e Conte.
Antonio Lamorte su Il Riformista il 29 Gennaio 2022.
Draghi partiva tra i favoriti,
poteva diventare il Presidente della Repubblica, o il grande perdente, il
Presidente del Consiglio sconfessato dalla maggioranza e non solo, è stato il
convitato di pietra a ogni incontro per l’elezione del 13esimo Capo dello Stato,
la traccia che sbucava con una telefonata o un incontro da un momento all’altro.
Alla fine è andata che è diventato invece il kingmaker della partita al
Quirinale. Il Mr Wolf della politica.
Quando il gioco si è fatto
duro, più una strage che un caos, carneficina di nomi e candidati buttati in
pasto ai media e al Parlamento, con i leader di partito incapaci di trovare una
soluzione, è stato il premier a essere decisivo per arrivare a un mandato bis di
Sergio Mattarella. I retroscena riportano che Draghi ci lavorava da due giorni:
mentre i partiti bruciavano candidati in aula o senza andare neanche al voto. La
rielezione come collante della maggioranza, salvagente del governo e della
legislatura, assicurazione per l’incasso dei circa 50 miliardi di euro di fondi
europei in arrivo tra giugno e dicembre. La rielezione anche come sconfitta
categorica dei partiti che non hanno saputo fare altro che riportare il
Presidente della Repubblica in carica. Se non è commissariamento, della politica
e dei partiti, poco ci manca.
“Si va avanti, squadra che
vince non si cambia. Abbiamo tante cose da fare, saranno sei mesi importanti …”,
le parole di ieri, venerdì pomeriggio, del premier riportate da Il Corriere
della Sera. Fine delle “operazioni scoiattolo”, è partita l’operazione “dritto
per dritto” dell’ex Presidente della Banca Centrale Europea. L’unica via
d’uscita affinché il terremoto del fallimento dei partiti evitasse uno
smottamento anche nella maggioranza. A spingerlo a scendere in campo, già nei
giorni scorsi, diversi dirigenti della maggioranza – a provare a indirizzarlo
verso il Quirinale erano stati soprattutto i governatori, Renzi, Di Maio, il
sindaco di Venezia Brugnaro. Draghi ha quindi sentito tutti i leader di partito
e sono tornati tutti alla casella di partenza.
Caduto anche il veto del
segretario della Lega Matteo Salvini, frenato dalla contrarietà assoluta di
Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, è finito il segreto di Pulcinella.
Matteo Renzi di Italia Viva fiutava da giorni la traccia. Enrico Letta del
Partito Democratico si era sempre detto favorevole. Giuseppe Conte del Movimento
5 Stelle sarebbe stato contrario ma costretto dal precipitare degli eventi.
Silvio Berlusconi avrebbe acconsentito pur di sbarrare la strada a Draghi per il
Colle – come Salvini e Conte. Questa mattina la notizia definitiva: un colloquio
decisivo di venti minuti del premier con il Capo dello Stato, a margine del
giuramento di Filippo Patroni Griffi a giudice della Corte Costituzionale.
L’Ansa aveva battuto le parole
di Draghi: “per il bene e la stabilità del Paese” era opportuno che Mattarella
restasse al Quirinale. Di certo non un finale a sorpresa. L’assenso del
Presidente – salvo clamorosi colpi di scena – è arrivato nel pomeriggio. Da lui
i capigruppo delle forze della maggioranza e i delegati delle Regioni. “Aveva
altri piani per il suo futuro” ma “lo abbiamo pregato, vista la situazione, di
restare per un altro mandato”. Le condizioni le porrà Mattarella: sarà il
secondo Presidente a essere rieletto. Giorgio Napolitano, nel 2013, restò per
due anni in più, lasciando il Quirinale proprio all’ex DC siciliano. Il
giuramento si terrà mercoledì pomeriggio tra le 15:00 e le 16:00.
Eppure Salvini insiste: dopo
aver bruciato rose a tre e a cinque, il Presidente del Consiglio di Stato Franco
Frattini, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, una
“presidente donna in gamba” non arrivata neanche al voto in aula, si è detto
soddisfatto che “la mia proposta di rieleggere Mattarella sia diventata poi una
proposta di tanti”. Anche Conte parla di “missione compiuta” per assicurare
stabilità all’azione dell’esecutivo. Per quanto potranno raccontarla, adesso
dovranno affrontare gli esami interni ai loro partiti. Debacle.
Entrambi si sono opposti
strenuamente a Draghi al Quirinale. Il premier resta al timone, al comando di
una maggioranza che già pare scricchiolare con i malumori di Giorgetti: per il
ministro dello Sviluppo Economico serve un aggiustamento per questa nuova
fase. Draghi un anno fa veniva chiamato più o meno di notte, più o meno
all’ultima spiaggia, da Mattarella per fare il governo, il “governo di unità
nazionale”. Quest’anno è stato lui a chiamare Mattarella per risolvere lo stallo
alla messicana. Le parti si sono invertite. Draghi come Mr Wolf – e non è una
buona notizia per la politica italiana.
Antonio Lamorte. Giornalista
professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha
frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha
collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura,
spettacoli.
San Michele Arcangelo, la
parrocchia palermitana del vecchio e nuovo presidente.
Riccardo Arena su La Stampa il 30 gennaio 2022.
Il presidente è un cattolico
praticante e già lunedì la sua parrocchia pregherà per lui. In sua assenza. Come
del resto tutte le chiese d’Italia, che hanno nel messale una celebrazione
liturgica prevista quando il Capo dello Stato viene eletto o, nel caso di Sergio
Mattarella, rieletto. Si pregherà anche a San Michele Arcangelo, la parrocchia
palermitana del vecchio e nuovo presidente, il tempio che Mattarella frequentava
da cittadino qualunque: «Veniva con la moglie Marisa – dice il parroco, Alerio
Montalbano – e qualche volta con i figli. Veniva spesso, ogni domenica, quando
era a Palermo. Qui ha celebrato pure i funerali della signora Chiazzese, quando
è venuta a mancare». Mattarella non era ancora presidente, la first lady poi è
stata la figlia Laura. Tra le chiese di Palermo ha frequentato le Ancelle, in
via Marchese Ugo, ma anche Sant’Espedito, in via Garzilli. E lì ci fu
l’incidente di percorso, col parroco che lo salutò pubblicamente, mettendolo in
imbarazzo. Il presidente andò via. «No, non ama queste cose – conferma don
Montalbano –. Quando viene da noi è puntualissimo e si siede come un fedele
qualsiasi. Certo, ha la scorta, ma è discreta, nemmeno si vede. Mattarella sta
tra la gente, preferisce così». Una volta gli capitò una messa al termine della
quale c’era il battesimo di un bambino: «Non conosceva i genitori ma partecipò
al clima di festa – ancora il parroco di San Michele – e volle avvicinarsi alla
coppia e al bimbo, si fermò a parlare con loro, era molto contento. Si trattava
peraltro di un papà e di una mamma palermitani, ma che per lavoro vivono a Roma,
dove abitava e abiterà ancora il presidente». Ma capita che il riservatissimo
inquilino del Quirinale si fermi a parlare con altri parrocchiani? «Sì, lo fa
spesso. O meglio lo faceva molto di più prima della pandemia. Da quando c’è il
virus viene di meno in città e anche in chiesa qui da noi». La settimana scorsa,
quando stava facendo il trasloco dalla sua casa di via Libertà – ora
praticamente inutile – Mattarella era andato in chiesa fra le più tranquille
mura della Legione carabinieri Sicilia, evitando di creare involontariamente
confusione con la propria presenza. «Come vediamo un parrocchiano così
importante? La comunità – dice ancora Alerio Montalbano – è stata felicissima e
orgogliosa di lui, dal primo momento. È come quando si ha un figlio, un parente,
che assume un incarico di primo, nel suo caso primissimo piano. Quando vedemmo
il presidente salire da solo la scalinata dell’Altare della Patria paragonammo
quei momenti alla salita del Santo Padre dalla piazza del Vaticano. Entrambi da
soli ma con tutto un Paese e una comunità cristiana mondiale, nel caso di Papa
Francesco, che erano con loro. Per Mattarella la preghiera non manca». E la
preghiera presidenziale? «È una preghiera speciale, che già facemmo sette anni
fa e che era e sarà di nuovo dedicata a lui. Ci sarà l’augurio di buon lavoro,
la richiesta al Signore di assisterlo e di aiutarlo a essere di nuovo presidente
in un mondo finalmente libero dalla pandemia».
Sergio Mattarella, gli
scatti «privati» del presidente della Repubblica
A cura di Silvia Morosi su Il Corriere della Sera il 30 gennaio 2022.
Aveva escluso più volte un suo
secondo mandato. Anche organizzando il trasloco dalla sua abitazione di via
Libertà a Palermo alla nuova casa presa in affitto a Roma, nel quartiere Parioli
(dove sarebbe entrato da senatore a vita). Invece, sabato 29 gennaio 2022, è
stato rieletto: è la seconda volta nella storia italiana che viene riconfermato
il presidente della Repubblica in carica. Tutti i partiti gli hanno chiesto di
restare, tranne Fratelli d'Italia: 759 i voti ottenuti, che lo hanno portato a
diventare il secondo Presidente più eletto, dopo Sandro Pertini (832) nella
storia della «nostra» Repubblica. «I giorni difficili trascorsi nel corso della
grave emergenza sanitaria, economica e sociale richiamano al senso di
responsabilità», ha detto il presidente salendo sabato sera al Quirinale dopo la
sua rielezione. «Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è
chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su
prospettive personali differenti, con l’impegno di interpretare le attese e le
speranze dei nostri concittadini». Poche parole, dirette e incisive, quelle
usate dal Presidente — un uomo riservato e schivo — che non si è sottratto alle
responsabilità per il bene del Paese (qui il discorso integrale). Un Presidente
che ha raccolto con garbo l'eredità dei suoi predecessori. Riviviamo insieme
alcuni momenti «privati» della sua carriera (nella foto il presidente della
Repubblica prima dell'intervento video all'iniziativa «QualeFuturo», il 13
giugno 2020; Ansa/Paolo Giandotti)
Sergio Mattarella nasce a
Palermo il 23 luglio del 1941. Si laurea in Giurisprudenza nel 1964
all’Università «La Sapienza» di Roma. Si iscrive all’Albo degli avvocati del
Foro di Palermo dal 1967. Come ricorda la biografia ufficiale pubblicata
sulla pagina del Quirinale, ha insegnato diritto parlamentare presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Palermo fino al 1983, quando prende
l'aspettativa ed entra a far parte della Camera dei Deputati (nella foto
Mattarella esce dal suo appartamento preso in affitto al quartiere Parioli,
sabato 29 gennaio 2022, dopo l'elezione, accompagnato dalla figlia Laura;
Benvegnù-Guaitoli)
Figlio di Bernardo Mattarella,
uomo politico democristiano, più volte ministro negli anni Cinquanta e Sessanta,
ha militato nell’Azione Cattolica e nella Federazione Universitaria Cattolica
Italiana (Fuci). Dopo l’uccisione nel 1980 da parte della mafia del fratello
Piersanti, all'epoca Presidente della Regione Sicilia, ha intrapreso la carriera
politica con la Democrazia cristiana. È il 1983 quando viene eletto per la prima
volta alla Camera dei Deputati, dove viene rieletto anche nelle legislature
successive (fino al 2008). Tra i promotori del Partito popolare italiano, ha
militato nelle fila prima della Margherita e — poi — dell’Ulivo
Nel 1987 è stato nominato
ministro dei Rapporti con il Parlamento nel governo Goria e nel governo De Mita.
Segue nel 1989 la nomina a ministro della Pubblica istruzione nel sesto governo
Andreotti. L'anno successivo si dimette in dissenso rispetto all'approvazione
della «legge Mammì
Mattarella viene nominato
vicepresidente del Consiglio del primo governo D'Alema (1998-99) e ministro
della Difesa del secondo governo D'Alema e del governo Amato (2000-01). Il 31
gennaio 2015 viene eletto dodicesimo presidente della Repubblica con la
maggioranza assoluta (665 voti su 995 dei votanti, al quarto scrutinio). Non si
sanno molte cose sulla sua vita privata, che ha sempre preferito tenere lontana
dai riflettori. Il Presidente ha sempre avuto un debole per l’Inter, oltre che
per la squadra della sua città natale, il Palermo. Al mare ha sempre preferito
la montagna. Tra le sue grandi passioni non poteva mancare la lettura
Sempre vicino alla Dc per
tradizione familiare, si avvicinò ancora di più alla politica dopo la tragica
morte del fratello. Il 6 gennaio del 1980, infatti, Piersanti Mattarella venne
ucciso dalla mafia: era appena entrato all'interno della sua Fiat 132, pronto
per dirigersi in chiesa per la messa dell'Epifania accompagnato dalla moglie,
dai due figli e dalla suocera. Pochi istanti prima di mettere in moto, il
presidente della Regione — un uomo simbolo del riscatto per la sua Regione —
venne freddato con diversi colpi di rivoltella calibro 38 attraverso il
finestrino. L'immagine del suo corpo, privo di vita adagiato sulle ginocchia del
fratello Sergio, accorso sul luogo, è stata catturata dalla fotografa Letizia
Battaglia. Entrando nella memoria di tutti (Ansa)
I destini di Sergio e
Piersanti Mattarella si sono incrociati non solo nella tragedia, ma anche nei
momenti felici. I due fratelli — ricorda qui Alfio Sciacca — si erano, infatti,
innamorati di due sorelle, diventate poi le rispettive mogli: Irma e Marisa
Chiazzese. Quest’ultima, moglie del presidente della Repubblica, è morta nel
marzo del 2012. Ogni anno viene ricordata con una messa nella chiesa romana di
Sant’Andrea delle Fratte
Si sa pochissimo della moglie
del Presidente, Marisa Chiazzese, morta nel 2012: la coppia teneva, infatti,
molto alla propria riservatezza. Nata a Palermo, la signora Chiazzese era la
figlia dell’accademico Lauro Chiazzese, ex rettore dell’Università di Palermo e
docente di diritto romano. Qui il racconto di Federica Seneghini
In questa immagine Sergio
Mattarella con l'allora procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, il 5
gennaio 2010 a Palermo, a margine della commemorazione di Piersanti Mattarella.
Quando fu ucciso il presidente della Regione siciliana, Grasso era il pm di
turno in Procura e fu proprio lui a effettuare il primo sopralluogo sul luogo
dell'omicidio
Il Presidente ha sempre
richiamato l'attenzione sull'importanza di fare memoria e combattere, oggi e nel
futuro, ogni germe di razzismo, violenza o antisemitismo. Qui il Presidente
della Repubblica Mattarella incontra la vedova del commissario Luigi Calabresi,
Gemma Capra, e la moglie e le figlie di Giuseppe Pinelli (Licia, Silvia e
Claudia) a Palazzo Marino in occasione della seduta straordinaria del Consiglio
comunale di Milano, nel cinquantesimo anniversario dalla strage di piazza
Fontana
Mattarella ama la vita
solitaria e quando torna a Palermo, non manca mai di fare un salto dal suo
barbiere di fiducia Franco Alfonso, in via Catania
Nonostante non sia un tifoso
«sfegatato», Mattarella in questi anni ha festeggiato con orgoglio i successi
sportivi dell'Italia. Qui si presta a un selfie con la Nazionale italiana di
calcio femminile che ha partecipato alla fase finale dei Mondiali 2019 in
Francia
Mattarella ha ringraziato
l’Italia Campione d’Europa: «Avete meritato ben oltre il punteggio», ha detto il
Presidente in occasione della cerimonia organizzata al Quirinale il 21 luglio
2021. Tra i presenti anche Matteo Berrettini, fresco reduce dall'ultimo atto di
Wimbledon, sconfitto nella finale da Novak Djokovic
«Gol», urlò Mattarella dopo
che Bonucci mise in rete il pallone del pareggio dell’Italia, nella finale degli
Europei vinta dagli azzurri 4-3 ai rigori contro l’Inghilterra. Rimanendo
composto, il Presidente alzò comunque le braccia l cielo, regalando uno scatto
passato alla storia. La sua gioia è stata da molti paragonata a quella di Sandro
Pertini, al Bernabeu di Madrid, la notte della finale del Mondiale del 1982
Un Presidente amato (anche)
dai bambini. «Caro Presidente Mattarella, ho sentito che verrà rieletto e sono
molto felice di questa sua decisione, perché credevo non volesse più essere il
nostro Presidente ed ero molto dispiaciuto di questo. Adesso sono io a farle i
complimenti, che da parte del mio fratellino Andrea», ha scritto nel giorno
della seconda rielezione di Mattarella Mattia Piccoli, il bimbo dodicenne di
Concordia Sagittaria (Venezia), che a dicembre 2021 aveva ricevuto proprio dalle
mani del Capo dello Stato l'attestato di Alfiere della Repubblica per il
supporto dato alla sua famiglia. In questa foto, Mattarella con Zaka Seddiki,
moglie dell'ambasciatore Luca Attanasio ucciso nella Repubblica Democratica del
Congo, e la loro figlia, in occasione della consegna dell'onorificenza
Arbitro delle contese, uomo
della «ripartenza» durante la pandemia, cattolico progressista. La religione è
un aspetto importante della vita del Presidente che, anche domenica 23 gennaio,
il giorno prima dell'inizio delle consultazioni, si è recato a Messa, nella
piccola chiesa di Santa Maria Maddalena (a Palermo), lontano da occhi
indiscreti. Ad accompagnarlo, due dei figli: Laura e Bernardo. All'uscita dal
condominio di via Libertà, diversi cittadini lo hanno applaudito, gridandogli:
«Grazie, Presidente». In questa fotografia, uno scambio di saluti «fraterno» con
papa Francesco, al termine della celebrazione Eucaristica in occasione
dell'Incontro «Mediterraneo, frontiera di pace»
Mattarella all'uscita dalla
chiesa di San Michele Arcangelo, insieme ad altri fedeli. In questa chiesa il
Presidente si reca per assistere alla messa della domenica quando si trova a
Palermo
Un saluto composto rivolto al
pubblico anche in occasione della partecipazione alla Prima della Scala del
2021-2022 con il «Macbeth». Il Presidente viene accompagnato dalla figlia
Laura
Nella tarda mattina di
domenica 30 gennaio 2022, il giorno dopo l'elezione, dal Quirinale Mattarella è
tornato a far visita al suo nuovo appartamento di Roma. Nella foto, gli
scatoloni «traslocati» di nuovo al Quirinale
Laura Mattarella, chi è la
first lady italiana.
A cura di Sofia Gadici su La Repubblica il 30 gennaio 2022.
Avvocatessa, 53 anni, moglie e
madre di tre figli: Laura Mattarella è al fianco di suo padre, il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, dal 2015. Lo accompagna nelle cerimonie
ufficiali quando il protocollo lo richiede. Il ruolo di first lady è solitamente
svolto dalle consorti dei capi di Stato, ma Mattarella è vedovo dal 2012. Per
stare vicino a suo padre, Laura Mattarella ha rinunciato alla propria
professione e in un’intervista rilasciata alla stampa ha affermato: "Mi piace
stare con mio padre, spero di essergli utile”.
Chi è Laura Mattarella: il
lavoro da avvocato e l’impegno da «first lady».
Paolo Conti su Il Corriere
della Sera il 30 gennaio 2022.
Sposata, tre figli, ha sospeso
la carriera di amministrativista nel 2015 per seguire il padre nel suo mandato.
Il suo stile nelle occasioni pubbliche è sobrio ed elegante.
Per mettere a fuoco il
carattere, e lo stile, di Laura Mattarella basta rivedere con attenzione i video
delle sue due più recenti e importanti apparizioni pubbliche accanto al padre
Sergio: il 7 dicembre 2021 alla Scala, per la «prima» del «Macbeth», preceduta
da quella al San Carlo di Napoli il 21 novembre per «Otello». Due
interminabili standing ovation per il presidente (a Milano sei minuti) con tutto
il pubblico in piedi per quelli che dovevano essere commiati.
L’unica a non poter applaudire
era lei (impensabile acclamare papà), immobile accanto al padre che almeno aveva
la libertà di salutare il pubblico, di agitare le mani. Lei impassibile: braccia
distese, lo sguardo sulla platea. Esercizio non semplice, con gli occhi di tutta
la sala addosso, niente male come autocontrollo.
Il bis di Sergio Mattarella ne
comporta un altro, quello della sua unica figlia femmina Laura Mattarella
Comella come first lady nelle grandi occasioni pubbliche, nei viaggi all’estero,
nei ricevimenti al Quirinale. Palermitana, classe 1967, ha sospeso dal 2015 il
suo lavoro di avvocato amministrativista per accettare lo stesso compito
protocollare sostenuto da altre due figlie di presidenti, Ernestina Saragat
Santacatterina col padre Giuseppe e Marianna Scalfaro col padre Oscar Luigi.
Esile, bionda, gli stessi
occhi azzurri del padre, Laura Mattarella ricorda molto sua madre Marisa
Chiazzese, l’amata moglie del presidente scomparsa nel 2012, a sua volta figlia
dell’accademico Lauro Chiazzese, giurista ed ex Rettore dell’Università di
Palermo: sua sorella Irma aveva sposato Piersanti Mattarella, il fratello di
Sergio, assassinato da Cosa nostra nel 1980. E così è nata una grande, unica
famiglia che ora ha in Laura un importante perno.
Per evitare stucchevoli
oleografie, va detto che chi la conosce la descrive come donna di carattere
molto deciso. Non una semplice comparsa femminile accanto al padre presidente ma
la coprotagonista di un’immagine pubblica della presidenza Mattarella: una
solida professionista, oltre che una figlia, pronta a consigliare e a sostenere
non solo affettivamente. Era pronta a riprendere il suo lavoro con la fine del
settennato paterno, dicono i conoscenti, ma il voto di sabato 29 gennaio ha
cambiato i suoi piani, per dirla con le parole del padre. È sposata con Cosimo
Comella, dirigente del Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica
del Garante per la Privacy. Hanno tre figli: Manfredi, Maria Chiara e Costanza.
Rarissime le interviste. Ma
resta famosa quella rilasciata a «Chi» nel marzo 2016 dopo un viaggio
presidenziale in Africa quando in Camerun visitò centro di rieducazione
Promhandicam, fondato a Yaoundé dal missionario trentino padre Sergio Ianeselli:
«Tutti dovrebbero visitare un campo profughi, prima o poi. Soprattutto chi dice
che bisogna lasciarli là dove stanno». Frasi e giudizi molto netti che
confermano quel carattere di cui si diceva, e quell’approccio attraversato da
una forte formazione cattolica, la stessa di suo padre.
Fin qui la sostanza della
personalità che poi spiega l’aspetto formalmente più superficiale. Cioè la
scelta, nelle apparizioni pubbliche, di toni di colore mai eccessivi: molto
beige e tanti pastello (azzurro, rosa, cenere), la sera blu e nero, tagli
classici anche negli abiti lunghi. L’immagine della presidenza Mattarella è, in
parallelo, nelle cravatte tradizionalissime del presidente e negli abiti di sua
figlia che però non sfigurano mai accanto a Letizia di Spagna, a Sonja di
Norvegia, a Brigitte Macron, a Jill Biden. Ora saranno altri sette anni al
Quirinale. Difficile che il suo sperimentato stile cambi, proprio come quello
del padre.
Il Presidente della
Repubblica. Chi sono i figli di Sergio Mattarella: il matrimonio e la famiglia
con la moglie Marisa Chiazzese e la first lady Laura.
Vito Califano su Il Riformista
il 31 Gennaio 2022
Il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha definito la moglie Marisa Chiazzese come “la
persona a me più cara al mondo”. La donna è morta nel 2012, a causa delle
conseguenze di un tumore. La coppia aveva avuto tre figli. Dal 2015, da quando è
stato eletto Presidente della Repubblica, ad accompagnarlo nelle occasioni
ufficiali è la figlia Laura, che come da protocollo continuerà ad accompagnare
il padre nelle occasioni ufficiali.
Marisa Chiazzese, nata a
Palermo, era la figlia dell’accademico Lauro Chiazzese, ex rettore
dell’Università di Palermo e docente di diritto romano, deputato della Consulta
Nazionale fino al giugno 1946. Era sorella di Irma Chiazzese, moglie
di Piersanti Mattarella, fratello di Sergio e Presidente della Regione
Sicilia ucciso dalla mafia la mattina del 6 gennaio 1980. Con la famiglia il
governatore stava andando in chiesa per la messa dell’Epifania, accompagnato
dalla moglie, dai due figli e dalla suocera. Almeno otto i colpi che lo
freddarono davanti agli occhi della famiglia.
Sul posto c’era anche il
fratello Sergio, che con la moglie Irma provò a soccorrere inutilmente Piersanti
Mattarella. Un proiettile aveva spappolato anche un dito della donna. La coppia
aveva avuto due figli, Bernardo e Maria. I fratelli Mattarella, Piersanti e
Sergio, si erano innamorati e avevano sposato due sorelle, Irma e Marisa. Quasi
una famiglia allargata. Sergio Mattarella e Marisa Chiazzese hanno avuto invece
tre figli: Laura, Francesco e Bernardo Giorgio.
La figlia Laura accompagna il
padre, dall’elezione del 2015, come first lady negli incontri ufficiali, nelle
occasioni pubbliche, nei viaggi all’estero e nei ricevimenti al Quirinale. Come
avevano fatto prima di lei Ernestina Saragat Santacatterina e Marianna Scalfaro:
la regola che vige tra i Capo di Stato prevede che se un presidente è
accompagnato dalla moglie, chi lo riceve deve essere a sua volta
accompagnato. “Ammiriamo la riservatezza della figlia del presidente”, le parole
della delegazione cinese ricevuta al Quirinale nel marzo 2021.
Bernardo Giorgio è nato invece
a Palermo il 3 marzo del 1968, primogenito, porta il nome del nonno, più volte
ministro. Si è laureato in legge, ha ottenuto un master of laws (University of
California at Berkeley) e un dottorato di ricerca in Diritto pubblico
(Università degli Studi di Firenze) è professore ordinario presso l’Università
Luiss Guido Carli, cattedra di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di
Giurisprudenza. È stato a capo del Dipartimento della funzione pubblica presso
la Presidente del Consiglio dei ministri. Del secondogenito Francesco
Mattarella non sa invece molto.
Marisa Chiazzese è scomparsa
tragicamente a causa di un tumore nel 2012. “Penso da tempo quando per seguire
la persona a me più cara al mondo ho trascorso a più riprese numerose settimane
in ospedali oncologici. Per tutte le persone in buona salute sarebbe auspicabile
che ogni tanto trascorressero qualche giorno in visita negli ospedali perché il
contatto con la sofferenza aiuterebbe chiunque a dare a ogni cosa il giusto
posto nella vita”, il ricordo della moglie durante un intervento al Quirinale in
occasione della Giornata Nazionale della Ricerca sul Cancro.
Vito Califano. Giornalista. Ha
studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive
principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di
televisione e teatro.
Il Presidente della
Repubblica. Chi era la moglie di Sergio Mattarella, Marisa Chiazzese: “La
persona a me più cara al mondo”.
Vito Califano su Il Riformista
il 31 Gennaio 2022
Ogni anno il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e la sua famiglia ricordano Marisa Chiazzese con
una messa nella chiesa di Sant’Andrea delle Fratte a Roma. La moglie del Capo
dello Stato è morta nel 2012, a causa delle conseguenze di un tumore. Sergio
Mattarella, a dispetto di quanto aveva previsto e annunciato, è stato confermato
dall’Assemblea dei Grandi Elettori per un altro settennato al Palazzo del
Quirinale.
Si sa pochissimo della moglie.
La coppia teneva molto alla riservatezza. Chiazzese era nata a Palermo, figlia
dell’accademico Lauro Chiazzese, ex rettore dell’Università di Palermo e docente
di diritto romano, deputato della Consulta Nazionale fino al giugno 1946. Marisa
Chiazzese era sorella di Irma Chiazzese, moglie di Piersanti Mattarella. I due
fratelli si erano innamorati e avevano sposato due sorelle. Il 6 gennaio 1980
Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Sicilia, veniva ucciso dalla
mafia mentre andava in Chiesa con la famiglia per la messa dell’Epifania,
accompagnato dalla moglie, dai due figli e dalla suocera. Poco prima di mettere
in moto venne freddato con diversi colpi di rivoltella, almeno otto.
Irma Chiazzese venne colpita a
un dito da un proiettile. Provò inutilmente a soccorrere il marito. Sul luogo
del delitto c’era anche il cognato, Sergio Mattarella. La coppia aveva due
figli, Bernardo e Maria. Sergio Mattarella e Marisa Chiazzese hanno avuto invece
tre figli: Laura, Francesco e Bernardo Giorgio. La figlia Laura accompagna il
padre, dall’elezione del 2015, come first lady negli incontri ufficiali, nelle
occasioni pubbliche, nei viaggi all’estero e nei ricevimenti al Quirinale. Come
avevano fatto prima di lei Ernestina Saragat Santacatterina e Marianna Scalfaro:
la regola che vige tra i Capo di Stato prevede che se un presidente è
accompagnato dalla moglie, chi lo riceve deve essere a sua volta accompagnato.
“Penso da tempo quando per
seguire la persona a me più cara al mondo ho trascorso a più riprese numerose
settimane in ospedali oncologici. Per tutte le persone in buona salute sarebbe
auspicabile che ogni tanto trascorressero qualche giorno in visita negli
ospedali perché il contatto con la sofferenza aiuterebbe chiunque a dare a ogni
cosa il giusto posto nella vita”, il ricordo della moglie durante un intervento
al Quirinale in occasione della Giornata Nazionale della Ricerca sul Cancro.
Vito Califano. Giornalista. Ha
studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive
principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di
televisione e teatro.
Porro sbrocca per il
Mattarella bis: cialtroni, vogliono solo salvare lo stipendio.
Il Tempo il 29 gennaio
2022.
Il Parlamento dopo una
settimana di scontro si affida di nuovo a Sergio Mattarella. Per Nicola Porro
dietro alla scelta del mandato bis non ci sono alte motivazioni istituzionali:
"È l'unico modo che questi cialtroni hanno di riuscire a stare in
Parlamento ancora per 9 o 10 mesi, non ce n'è un altro" attacca il conduttore di
Quarta Repubblica. Il resto sono "ca**ate, il Parlamento sovrano non ha chiesto
Mattarella, su quella scheda ha scritto 200.000 euro!".
Da lastampa.it l'1 febbraio
2022.
"Esimi onorevoli, ma ve lo
devo dire io che sono un saltimbanco che quello dell'elezione del presidente
della Repubblica è un momento sacro? È come se durante un conclave un cardinale
votasse don Matteo".
La letterina di Luciana
Littizzetto ai Grandi Elettori del Presidente della Repubblica che hanno votato
nomi "improbabili" durante l'elezione.
Luca Monticelli per "la
Stampa" l'1 febbraio 2022.
«Da spettatore resto a bocca
aperta perché a questo finale non avevo pensato». Pietrangelo Buttafuoco,
scrittore, intellettuale di destra - spesso definito "dissidente" e tutt' altro
che organico - si richiama alla sua Sicilia per decifrare la partita del
Quirinale che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella.
Che cosa è successo in
Parlamento?
«C'è un aspetto di pantomima
che riusciamo a vedere con il senno del poi, una sceneggiatura che solo
Camilleri avrebbe potuto immaginare». Si spieghi.
«È stato tutto "tiatro" per
dirla con la lingua di Vigata. E dal punto di vista della messa in scena i
frammenti adesso combaciano. C'era un che di esibizionismo in quei segnali...
gli scatoloni, il trasloco, questa abbondanza di bambini che si avvicinano con
lettere e disegni, mi ricordano la famosa scena di De Amicis della "carezza del
re"».
Si riferisce al libro "Cuore",
quando Re Umberto passa tra la folla a Torino e un padre si avvicina con il
figlio. Pensa davvero che Mattarella volesse fare un secondo mandato?
«Io faccio affidamento a
quello che mi aveva detto Totò Cuffaro: "Solo perché non lo conoscete potete
credere che ci sia un altro esito"».
Quindi ha visto una regia
nell'operazione del secondo mandato a Mattarella?
«Se fa testo l'educazione, lo
stile gesuitico della sinistra Dc, è stata l'apoteosi della dissimulazione
onesta di Torquato Accetto, ma è anche la sana sostanza della roba verghiana: i
sinistri-Dc, presentissimi nello status quo, fanno sempre il contrario di quello
che dicono. Si dice no, ma invece è sì. Dissimulazione, appunto».
Dissimulazione che il
centrodestra non ha capito, tanto che ne esce in frantumi.
«Sì è vero. C'è anche un altro
dettaglio "camilleriano", l'uomo che con il suo Mattarellum ha varato la
stagione del bipolarismo, ora si appresta a firmare il ritorno del proporzionale
e quindi la morte del bipolarismo».
A proposito, è la fine del
centrodestra berlusconiano?
«Ancora peggio. Noi dobbiamo
distinguere il berlusconismo dal centrodestra: Berlusconi non c'entra niente con
il centrodestra, è un'altra storia. Il centrodestra finisce perché
paradossalmente non c'è più quel metodo che si accompagnava al Mattarella di una
volta, cioè Giuseppe Tatarella. È venuta meno una strategia che era quella di
allargare l'area. In Italia c'è una maggioranza che per storia, sensibilità,
identità è di centrodestra, ma non riesce mai ad avere un peso politico e
culturale.
Sono convito che il ceffone
che il Palazzo ha assestato con questo colpo di "tiatro" avrà una conseguenza
ulteriore: quello di non far andare più a votare le persone, sicuramente quelle
di centrodestra. Si allargherà la forbice dell'astensione della maggioranza
silenziosa».
Però Salvini la mano di poker
sul Colle l'ha giocata male. Voleva fare il kingmaker e non c'è riuscito.
«Tutti i leader hanno giocato
su più tavoli: Letta, Conte, Di Maio, Renzi. La verità è che ne esce sconfitta
la generazione attiva. Al di là degli steccati ideologici, la malinconica
considerazione da fare è che comunque la gerontocrazia si impossessa di tutto.
L'unica vera distinzione è tra un Palazzo che sa difendere se stesso e il resto
intorno che non è in grado di affrontare la situazione».
Tra i nomi che sono stati
bruciati c'era qualcuno che avrebbe visto bene come Capo dello Stato?
«Tanti, e perfino molti
potevano essere condivisi dal centrosinistra e dal centrodestra».
Ad esempio?
«Anna Finocchiaro».
Sempre in Sicilia rimaniamo.
«Allora un "candidatone" con
un ottimo curriculum che piaceva agli americani e al Vaticano: Giulio Tremonti.
Oppure un altro profilo con una caratura internazionale poteva essere Francesco
Rutelli, il migliore sindaco di Roma. E lo stesso Antonio Martino. È stato
inconcepibile non rispondere alla richiesta della nazione di individuare
un'altra persona».
Che cosa pensa del dualismo
Salvini-Meloni?
«Devono evitare di cadere in
un errore: la pluralità dei leader deve essere un vantaggio, non uno
svantaggio».
Lei ha scritto un libro dal
titolo "Salvini e/o Mussolini": se dovesse aggiungere un capitolo, cosa
scriverebbe oggi?
«L'ho scritto prima della
pandemia, è come se fossero passati 50 anni, con il senno del poi è inaudito.
Salvini ha mollato il governo dal Papeete quando per lui andava a gonfie vele.
Ce lo siamo scordati quando Salvini e Di Maio vennero accolti con gli applausi
nella chiesa a Genova dove si celebravano le vittime del Ponte Morandi? Sembra
sia passato un secolo, visto il capovolgimento totale in cui ci troviamo».
Non c'è nulla da
festeggiare. Il partito dei Pm ha deciso il Mattarella bis, il presidente
subalterno alla magistratura.
Piero Sansonetti su Il
Riformista l'1 Febbraio 2022.
C’è un gran tripudio attorno
a Sergio Mattarella. La maggior parte dei politici, e dei giornali, e degli
intellettuali è dalla sua parte e sostiene che era la migliore delle scelte
possibili. Credo che anche l’opinione pubblica lo apprezzi, e credo che lo
apprezzi perché lo ritiene una persona estranea, e forse addirittura nemica, del
circo della politica e del potere. Io ho un grande rispetto e anche stima per
Sergio Mattarella, e seguo la sua attività pubblica da una quarantina d’anni e
con attenzione. Non penso che lui sia estraneo al mondo della politica.
Ha una lunga biografia, in
gran parte interna alla Dc e alle correnti che hanno sopravvissuto alla Dc,
piena di battaglie politiche, di colpi dati e ricevuti, di vittorie e di
sconfitte, di trofei, di ferite, di cicatrici. Non penso nemmeno che sia
estraneo al mondo del potere. Raramente un Presidente della repubblica lo
è. Mattarella è una espressione piena e legittima della prima e della seconda
Repubblica. Io però credo che non ci sia niente di male ad essere interno alla
politica. Vedo la politica come una nobile attività, non come il luogo del
malaffare e dell’imbroglio. Anche Berlusconi è interno alla politica,
anche Casini, Cassese, Violante, Draghi. Credo che sarebbero stati ottimi
presidenti della repubblica. Non lo sono perché contro ciascuno di loro ha
giocato il frullatore delle correnti, che oggi non sono più neppure racchiuse
nei partiti, sono libere, incontrollabili, spavalde.
Io però sono rimasto molto
deluso dall’elezione di Mattarella. Il perché lo abbiamo scritto tante volte su
questo giornale. Non perché non ha mantenuto la parola di rifiutare il bis. Non
perché la sua rielezione forse scalfisce la Costituzione. Non perché è un
politico-politico. Per una ragione diversa: perché Mattarella in questi anni si
è dimostrato subalterno alla magistratura e in particolare al partito dei Pm. Il
quale è intervenuto pesantemente in questa elezione presidenziale, prima
bloccando la candidatura di Berlusconi, poi quella di Nordio, di Cassese, forse
anche quelle di Draghi e di Casini. Se non ci sarà una svolta,
se Mattarella2 sarà uguale al Mattarella1, noi sappiamo che non ci sarà riforma
della giustizia, che il Quirinale proteggerà la Casta dei Pm anche da un
eventuale naufragio al referendum, che il potere delle toghe resterà
incontrastato, che lo Stato di diritto resterà in cantina, che un pezzo di
magistratura inquirente resterà arbitra incontrollata delle nostre vite. Non
festeggiamo. Non c’è niente da festeggiare. Per chi, come noi, è sempre
impegnato nella battaglia garantista, l’elezione quasi all’unanimità
di Mattarella è ragione di preoccupazione e non di gioia. Non è un bel giorno.
Piero Sansonetti. Giornalista
professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di cui è stato
vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004 al 2009, poi
di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per poi approdare
alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre 2019.
Tutti i partiti salgono sul
Mattarella bus.
LUCA BOTTURA su La Stampa il 30 gennaio 2022.
Quella che segue è la cronaca
paradossale della giornata di ieri. Alcuni eventi sono palesemente inventati,
altri sono veri, altri sono come le prime serate di Rete4: ispirati a fatti
realmente accaduti. La lettrice o il lettore scelgano a loro piacimento a quale
categoria riferirli. Intanto, presidente, grazie anche da parte nostra. Si
riguardi, le vogliamo bene e le siamo riconoscenti. Persino avendo eletto quei
mille che l’hanno costretta a restare. Ore 8 Casellati verso l’addio alla
politica: visto il traffico dati generato venerdì, Vodafone le ha offerto la
carica di Amministratore Delegato. Ore 8.10 Salvini comincia la retromarcia:
«Quando parlavo di una donna presidente, mi riferivo a Donna Summer. Apprendo
purtroppo che è defunta». Ore 8.30 Comincia l’assemblea plenaria degli elettori
di Italia Viva. Ore 8.45 Termina l’assemblea plenaria degli elettori di Italia
Viva: la cabina telefonica serviva a un altro utente. Ore 9 Elisabetta Belloni
irritata per il tramonto della sua candidatura, spinge per errore un tasto della
sua auto e sgancia un missile su quella di Conte. Nessun ferito. Ore 9.30 Enrico
Letta fa colazione. Ore 10 Enrico Letta si sveglia. Ore 10.30 Problemi per
Giorgia Meloni: dopo aver usato per la centesima volta il termine «granitico» in
meno di 24 ore, la famiglia Mussolini le chiede la Siae. Ore 10.45 Salvini, che
il giorno precedente aveva esaurito gli abbonati di Roma dalla A alla M,
comincia a candidare in sequenza tutti i candidati dalla M alla Z. Ore 10.52
Primi segnali di una convergenza su Mattarella: Tecnocasa rimette in affitto
«appartamento in zona pinciana libero subito, disponibilità vano corazzieri».
Ore 10.55 Maria Elena Boschi: «Se becco questa Maria Elena Boschi che ieri
contestava la candidatura di Mattarella, le faccio passare un brutto quarto
d’ora». Ore 11 Salvini è così in confusione che si citofona da solo. Ore 11.01
Salvini scopre con sgomento che al suo citofono risponde Giorgetti. Ore 11.05
Riemerge tweet di Salvini del 2015: «Mattarella non è il mio presidente». Ore
11.05 Salvini spiega con grande dignità l’accaduto: «Ero... rimasto senza
benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La
tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre! Era
crollata la casa! C'è stato un terremoto! Una tremenda inondazione! Le
cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio!». Ore 12.30 Casini twitta la
sua rinuncia e si ripone nel freezer in cui dimora abitualmente: «Nel caso,
svegliatemi tra un paio d’anni». Ore 15 Cominciano le manovre per intestarsi
Mattarella: la Svp sostiene di averlo visto vestito da schützen. Ore 16.01
Mattarella comincia a rassegnarsi e telefona al portavoce Grasso: «Giovanni, mi
procuri un lanciafiamme da usare martedì?». Ore 16.14 Paolo Celata de La7,
costretto da Mentana a mollare Ricciardi dei 5 Stelle per inseguire Conte,
chiede di essere dato in affido a TeleNorba. Ore 17 Breve conferenza stampa di
Letta, che mentre scriviamo è ancora in corso. Vi terremo aggiornati. Ore 17.01
Letta conferma piena fiducia nel campo largo, che tra l’altro è lo stesso sotto
il quale si è sepolto da una settimana in attesa degli eventi. Ore 17.30 Salvini
e Giorgetti chiedono incontro a Draghi per rilanciare l’azione di governo. Ore
17.31 Draghi noleggia una catapulta per rilanciare Salvini in Padania. Ore 18
Brunetta annuncia la crescita record del Pil e auspica misure ancora più
cogenti: «Reintrodurre la schiavitù non deve essere un tabù». Ore 18.29 I
mercati festeggiano la conferma di Mattarella: in rialzo le azioni della
Valeriana. Ore 19.42 Comincia lo spoglio. Alla lettura della prima scheda,
Gasparri grida «Ambo!». Ore 20.12 Quattro voti per Casellati. L’aula discute su
chi siano gli altri tre. Ore 20.19 Mattarella raggiunge il quorum. Gasparri
grida «Ambo!». Ore 20.19 Lungo applauso dell’assemblea, battuto il record di
quella volta che Toninelli azzeccò una consecutio. Ore 20.23 Ringalluzzito dai
voti di FdI, Carlo Nordio fonda il suo partito: «Prima il Nordio». Ore 20.30
Berlusconi, che ha ricevuto 9 voti, fermato all’ingresso mentre tenta di
aggiungere un sei prima del nove. Ore 20.53 Il presidente Fico proclama Sergio
Mattarella tredicesimo presidente. Gasparri spinto giù per le scale dai commessi
mentre tenta di gridare «ambo!». Ore 20.42 Di Maio abbraccia Casini e sollecita
l’applauso della sala. I due si scambiano una scatoletta di tonno. Ore 20.45 Lo
speciale Tg1 sfora e occupa lo spazio de «I soliti ignoti». Tra gli sconosciuti
da riconoscere, a sorpresa, c’è un certo Matteo da Milano che chiede di
rilanciare l’azione di governo. Ore 20.50 Meloni rilancia il presidenzialismo:
«Il capo dello Stato si scelga con una marcia da Perugia a Roma». Ore 21 In
onore dei bei tempi, Fico propone a Casellati di salire al colle in bus. Ore
21.01 Casellati dice a Fico di attaccarsi al tram. Ore 21.05 I partiti salgono
sul carro del vincitore. Anzi: sul Mattarella Bus. Ore 21.15 Mattarella accetta
la rielezione e accompagna Fico e Casellati all’uscita. Ore 21.16 Appena varcata
la soglia, gavettone colpisce Fico e Casellati. Ore 21.46 Sabino Cassese su La7
rivela che la presidenza gli era stata offerta da Lega, Fratelli d’Italia e
Italia Viva. Per una volta la Destra era rimasta compatta. Ore 24 Annullato
Sanremo: Amadeus chiede un Maneskin bis.
La battaglia del Quirinale.
“La forzatura su Casellati spettacolo penoso, dietro Draghi il nulla”, parla
Massimo Cacciari.
Umberto De Giovannangeli su Il Riformista il 29 Gennaio 2022.
«Comunque vada a finire questa
penosa vicenda quirinalizia, la cosa certa è che siamo già in campagna
elettorale, con Draghi che esce indebolito e con lui un Governo che si reggeva
sulla sua figura. Davvero un bel lavoro». Quanto alla sinistra, il suo giudizio
è lapidario: «Non esiste. Punto. Ma che soggettività vuoi che esprima chi spera
di salvarsi in extremis sperando in un democristiano di seconda fila come
Casini?». La “battaglia del Quirinale” vista da Massimo Cacciari.
Mentre parliamo la situazione
è la seguente: il centrodestra più o meno compatto sulla candidatura Casellati,
il centrosinistra che si astiene e diserta l’incontro con Salvini. Professor
Cacciari, e allora?
Lo spettacolo è penoso. E poi
c’è la pensata di qualche politico, sedicente tale, che vorrebbe tenere Draghi
“prigioniero” un altro anno a capo di un governo sempre più sfilacciato, per poi
dargli il benservito. A questo siamo arrivati. E come se non bastasse, c’è chi
tira un sospiro di sollievo per l’affossamento della Casellati. Forse Letta
potrà dire di aver scongiurato il pericolo. Ma la Casellati non avrebbe potuto
mai essere eletta a meno di un impazzimento totale del Pd e di un gioco allo
sfascio del trio Salvini-Meloni-Berlusconi. Altri sono i giochi sottotraccia.
Che dire: staremo a vedere.
Al momento quello che sembra
essere scomparso dal centro della scena è l’uomo che fino a poco tempo fa
sembrava essere il “salvatore della patria”: Mario Draghi.
Sempre che poi non ritorni
fuori se si annullano reciprocamente. O che ritorni fuori Mattarella e tutto
rimane com’è. Il problema è che questo spettacolo mostra l’assoluta precarietà
di questo governo e di questo assetto politico. Questo è fuori discussione. Il
re è totalmente nudo. Un governo di questo genere si regge esclusivamente
sull’autorevolezza di Draghi ma dietro di lui c’è il nulla.
Le chiederei di vestire per un
attimo i panni di un leader europeo: Macron, Scholz, von der Leyen, veda lei…
Che idea si farebbe di quello che sta succedendo a Montecitorio e nei palazzi
della politica italiani?
L’unica credibilità è affidata
al “loro” esponente, e non del ceto politico italiano, ma all’esponente dei
poteri forti europei. E finché c’è lui, Draghi, il rapporto con questo paese può
reggere. Finito lui, ci salvi chi può. Puoi declinarla in tedesco o in francese,
o anche in americano, ma la sostanza non cambia: stiamo facendo una figura
barbina, per usare un eufemismo. Su una decisione politica di assoluto rilievo,
anche simbolico, come l’elezione del Presidente della Repubblica, vedi in che
situazione si trovano. Ma che credibilità vuoi che abbiano? Che credibilità vuoi
che abbia il ceto politico che sostiene questo governo? Draghi e dietro di lui
il vuoto assoluto. Questa è una constatazione di fatto. Fuori dall’opzione
Draghi, il risultato sarà, se non riusciranno a convincere Mattarella, che
avremo un Presidente di serie B o C. È sconfortante assistere a questo cupio
dissolvi del sistema dei partiti. Sconfortante e preoccupante. Gli attuali
partiti, di destra, di centro e di “sinistra”, non sono assolutamente in grado
di indicare per il Quirinale una personalità di alto spessore, autorevole. Non
ce la fanno proprio. E poi si meravigliano della marea crescente di astensioni.
Il dramma è che quello a cui stiamo assistendo non è un teatrino televisivo ma
la fotografia di come sono messe le istituzioni e la politica in questo paese.
Male. Molto male.
Qual è, a suo avviso, la vera
novità di questo voto presidenziale. Che avviene ai tempi di una pandemia
tutt’altro che debellata?
Questo sarebbe un assillo per
forze politiche responsabili, in sintonia con il malessere e le aspettative
della gente, ma tant’è. La novità è che mai come stavolta, la partita del
Quirinale è legata indissolubilmente a quella del governo. C’è poco da fare, è
così. E se non riusciranno a trovare una soluzione condivisa per la presidenza
della Repubblica, vedo molto difficile la tenuta del governo. L’inghippo sta in
questo legame indissolubile tra le due partite. La cosa più ragionevole sarebbe
stata quella di mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi. Una
ipotesi che, allo stato dell’arte, non è tramontata ma appare alquanto
problematica. Certo è che se convergono su una candidatura condivisa, si apre
una prateria per elezioni anticipate. Se non fosse che bisognerà fare i conti
con l’istinto di sopravvivenza di centinaia di persone che hanno vinto alla
lotteria parlamentare e che sanno che non avranno un’altra opportunità. E quindi
proveranno a tirare a campare, e non è una metafora.
Ma in questo scenario alquanto
sconfortante, c’è ancora vita a sinistra?
Questo è un altro paio di
maniche. Ciò che si sta consumando è il passo finale di una catastrofe
culturale. È inutile che stiamo a parlare di sinistra. Una catastrofe culturale
che viene da molto lontano, che è maturata nel tempo, attraverso vari passaggi,
dai governi dell’Ulivo alla nascita del Pd nei termini in cui è nato, a Matteo
Renzi… Stiamo assistendo alla crisi definitiva di una catastrofe culturale di
ogni cultura socialdemocratica, riformista di questo paese. C’è poco da fare.
Non getto la croce addosso a qualcuno degli attori attuali. Costoro non sono
altro che gli eredi di trent’anni di disastri.
In questo scenario da
crepuscolo…
Siamo ben oltre il crepuscolo.
Siamo nella notte assoluta. Una notte che nasce dal crollo di quella timida
speranza che era emersa con Torino, il Lingotto di Veltroni, dopodiché è stato
un inanellarsi di sconfitte ed errori. E questa è la conclusione. Se non verrà
fuori Draghi, se non verrà confermato lo status quo, l’unica prospettiva che,
secondo me, ha il centrosinistra di sfangarsela è Casini. Mi dica lei: una
sinistra italiana che ha come àncora di salvataggio, oggi come oggi, il
democristiano di serie B. Più evidente di così. Un Partito, il Pd, che ha avuto
come ultimi segretari prima Renzi e adesso Letta e come ancora di salvataggio
per la presidenza della Repubblica speriamo Casini. E lei vuole ancora parlare
di sinistra? Prendiamone atto. La sinistra non esiste più. Punto.
È un problema di deficit di
leadership o di vuoto di pensiero?
Assoluto vuoto di pensiero. È
chiaro. Non si è elaborata alcuna idea di riforma istituzionale seria, alcuna
analisi di nuovi rapporti sociali, di come rapportarsi a nuovi ceti, a nuove
classi, a nuove culture. Non si è pensato assolutamente a una riformulazione
dello stato sociale, del welfare rispetto alle culture socialdemocratiche
dell’immediato dopoguerra e così via. Non si è tenuto conto di nulla di tutto
ciò. Non si è discusso di nulla. Non si è fatto un congresso degno di questo
nome da tempo immemore. Si è andati avanti praticamente da elezione ad elezione
con un unico fine…
Quale?
Cercare di essere
disperatamente al governo. Costi quel che costi, conti quel che conti, con
chiunque.
Il virus del governismo ha
attecchito definitivamente?
Che altro dire. Una forza
politica che è diventata un comitato elettorale non può avere altro fine che
quello di andare al governo, con chiunque. E l’ultimo atto è stato questo. Poi
si dice sempre che è per la salvezza della patria, per il bene comune. La
salvezza di forze politiche che non hanno strategie, che non hanno culture, è
quella di stare al governo. Quando mai potrebbero reggersi se non sullo stare al
governo?
Ma in questa notte fonda della
politica, che ne sarà dell’asse Pd-5Stelle?
Non lo so se reggerà. È chiaro
che se anche in parte i 5Stelle dovessero farsi attrarre da sirene dell’altra
parte, si squaglia tutto. Comunque è ben difficile che a questo punto, anche se
trovassero un accordo in extremis, che so, su Draghi o Mattarella, il governo
possa ancora reggere. Come può reggere dopo una prova di forza come quella che
ha proposto il centrodestra?
Bella domanda. E la sua di
risposta?
È il logoramento assoluto
anche di Draghi medesimo. Perché lui stesso si troverebbe, volente o nolente, a
governare con qualcuno che si è appena massacrato non su una questione di
dettaglio, non sulle norme sulla mascherina, ma per il Presidente della
Repubblica. Hanno indebolito tutto il quadro. Hanno reso più difficile tutto il
processo di attuazione del Pnrr. Di fatto è successo che hanno cominciato la
campagna elettorale con un anno di anticipo. Perché da questo momento in poi noi
saremo in campagna elettorale anche se il governo dovesse continuare.
Umberto De Giovannangeli.
Esperto di Medio Oriente e Islam segue da un quarto di secolo la politica estera
italiana e in particolare tutte le vicende riguardanti il Medio Oriente.
Paolo Griseri per “La Stampa”
il 30 gennaio 2022.
Professore, la rielezione di
Mattarella è una vittoria o una sconfitta della politica?
«Ma è evidentemente una
sconfitta. Intendiamoci: visto come si stavano mettendo le cose credo che questa
sia la soluzione più rassicurante, certamente il meno peggio. Ma la politica ne
esce a pezzi».
Chi ha sbagliato?
«Abbiamo un ceto politico che
non si è dimostrato all'altezza della situazione. Ma dico, dieci anni fa il
parlamento costrinse un altro presidente, Giorgio Napolitano, ad accettare un
secondo incarico. Napolitano andò in aula per l'accettazione e fece un discorso
durissimo.
Disse che quella rielezione
era la conseguenza di una crisi profonda della politica. Che era il frutto di
errori, omissioni e irresponsabilità. Sono passati dieci anni e rieccoci qui,
allo stesso punto di prima. E sa qual è l'aspetto più incredibile? Che ora c'è
la gara a presentare questo come un risultato positivo».
I partiti fanno finta di
niente secondo lei?
«Sono allibito. Non si prende
nemmeno in considerazione l'idea che siamo di fronte ad una malattia mortale dei
partiti e del Parlamento. Oltretutto dopo che il collasso del sistema costringe
i presidenti della repubblica a creare governi di emergenza per sopperire
all'assenza della politica. Tutto questo è un po' grave».
Una malattia dice. È un po'
buffo chiederlo a lei, ma esiste un vaccino contro la malattia della politica?
«Il primo vaccino sarebbe la
consapevolezza dei politici e dei partiti che c'è una malattia e che va
curata».
Sono malati a loro insaputa?
«È evidente che sarebbe
necessaria una riforma del sistema parlamentare e del modo con cui si elegge il
presidente della repubblica».
Lei è favorevole all'elezione
diretta, al sistema presidenziale?
«Si figuri se non sono
favorevole. Lo ero già trent' anni fa quando il presidenzialismo lo sosteneva il
mio maestro Gianfranco Miglio. Ma il presidenzialismo da solo non basta».
Che cos' altro ci vuole?
«Se scegliamo la strada
presidenzialista, dobbiamo equilibrarla con un federalismo più spinto di quello
di oggi. Invece noi abbiamo il difetto di non concepire mai riforme di sistema.
Facciamo una cosa sola e pensiamo che sia risolutiva.
E' come con le malattie:
troviamo il vaccino e tutto è risolto. Non si pensa al sistema sanitario, a come
funzionano gli ospedali».
Facciamo il catalogo degli
eroi come nell'Iliade. Partiamo da Salvini: come si è comportato il leader della
Lega?
«Salvini esce clamorosamente
sconfitto. Perché il centrodestra sulle questioni istituzionali, com' è
l'elezione di un presidente della repubblica, va in ordine sparso. Conta il dna.
Il centro del centrodestra, l'area moderata che ruota intorno a Forza Italia,
arriva dalla Dc.
E ha un'idea delle istituzioni
profondamente diversa da quella della Lega. Salvini ha tentato la forzatura di
tenere unite queste due anime e ha perso. Anche perché, come l'altro Matteo, ha
un carattere irruente e impulsivo».
Un altro eroe di questi giorni
è Conte. Come si è comportato?
«Beh è l'altro sconfitto di
questa settimana. Ha perso clamorosamente. Aveva un conto aperto con Draghi,
come si sa. Ha lavorato per impedirgli di andare al Quirinale. Ma ha commesso
l'errore di dare per fatta l'elezione di Belloni. Coinvolgendo anche Grillo
nell'errore. Ora nei Cinque Stelle si aprirà la notte dei lunghi coltelli tra
Conte e Di Maio».
Siamo a Letta. Ha vinto o ha
perso?
«E chi lo sa? E' stato zitto.
Gli altri proponevano, sbagliavano, bruciavano candidati ma si capiva quali
proposte avanzavano. Qual è stata invece la proposta del Pd? Non si è capito. Il
Pd è rimasto a guardare».
Il governo esce più forte o
più debole?
«Draghi è tutelato dalla
presenza di Mattarella al Quirinale. E questo lo rafforza. Anche perché non è
detto che con un'altra figura come presidente lui sarebbe rimasto a Palazzo
Chigi.
Oltretutto a guidare un
governo in cui siedono i rappresentanti dei partiti che gli hanno sbarrato la
strada verso il Quirinale».
Più forte dunque?
«Sì e no. Da domani
cominceranno le guerre interne ai partiti».
Si dividerà il centrodestra
dopo il flop di Salvini?
«Ci saranno regolamenti
interni ma non credo che si divideranno. La coalizione rimarrà. Alle politiche
credo che si presenteranno insieme. Dopo il voto su Mattarella Draghi potrà
certo arrivare alla fine della legislatura ma non credo che avrà la forza di
fare le riforme necessarie al Paese: quella della giustizia e quella della
scuola».
In una settimana si sono
bruciati i nomi di molte candidate. Perché si è persa l'occasione di avere la
prima donna presidente?
«Eh, ci sarebbe stata la
possibilità di farlo. Poteva essere davvero l'occasione giusta».
Ma…
«Ma, mi verrebbe da dire,
quelle candidature sono morte perché sono state presentate nel modo più
beceramente maschilista che ci fosse.
In modo raffazzonato e anche
irrispettoso delle loro figure. Una girandola di nomi fatta per mettere una
bandierina piuttosto che perché si era convinti che si potessero fare. Non si
presenta una candidata schieratissima come Casellati dicendo che sarà la
presidente di tutti».
Belloni è stata impallinata da
sinistra. Perché?
«Ma, io non conosco la signora
Belloni. Mi dicono che è un ottimo funzionario e credo che avrebbe fatto bene.
Certo non è educato istituzionalmente presentare alla presidenza la responsabile
dei servizi segreti. Ma c'erano altre figure su cui puntare, penso a Cartabia e
Severino».
Lei oggi ci dice che la coppia
Mattarella-Draghi è quella che tutela meglio il Paese. Come mai lo dice proprio
lei dopo i duri attacchi al governo sui vaccini?
«Perché la politica si fa con
il realismo. E l'Italia è uno degli anelli deboli nel sistema occidentale che ha
bisogno di essere guidata da una personalità credibile a livello internazionale.
Non c'è nessuno che ci possa garantire come Draghi.
Poi io non sono un ruffiano e
se il governo compie errori sulla politica sanitaria io lo dico apertamente.
Credo che Draghi apprezzi le critiche che nascono dall'onestà intellettuale».
Il bilancio finale di questa
settimana?
«Sa come dicono i cronisti
sportivi? Abbiamo visto scene che fanno male al calcio».
Giuliano Amato nuovo
presidente della Corte Costituzionale.
Il Quotidiano del Sud il 30
Gennaio 2022.
Giuliano Amato è il nuovo
presidente della Corte Costituzionale. Rimarrà in carica 8 mesi, quanti ne
mancano alla fine del suo mandato di giudice. Subito dopo la nomina, come da
tradizione, ha incontrato i giornalisti in una conferenza stampa nella quale ha
trattato alcuni dei temi centrali del lavoro della Consulta, a cominciare dalla
collaborazione tra Corte e Parlamento, che “diventa fattore essenziale, tanto
più nel caso di conflitti sui valori”, come sicurezza, libertà, famiglia e
genere.
Amato ha evidenziato che
compito dei giudici è “indicare una delle soluzioni possibili”, e ha ricordato i
casi affrontati in tempi recenti, come quello del cognome dei figli,
dell’ergastolo ostativo e del suicidio assistito, poi ha aggiunto: “Saremmo più
contenti se si trovassero soluzioni in Parlamento”.
Per quanto riguarda l’ipotesi
di elezione diretta del capo dello Stato, di cui tanto di parla, Amato è stato
netto: “Non può essere vista come qualcosa che da sola si innesta nel sistema,
lasciato così com’è. I sistemi costituzionali sono come orologi e non è detto
che se cambi una rotella puoi aspettarti che l’orologio funzioni – ha chiarito –
l’elezione diretta del presidente della Repubblica, presenta diversi benefici,
tra i quali il fatto che avvenga in un giorno, ma non puoi prenderla come tale e
collocarla all’interno del sistema”.
Il “dottor Sottile” è nato a
Torino il 13 maggio 1938 ed è stato nominato giudice costituzionale dal
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 12 settembre 2013. Docente di
Diritto costituzionale comparato, elemento di spicco del Psi della prima
Repubblica, è stato due volte presidente del Consiglio e ministro del Tesoro,
oltre che ministro dell’Interno.
Tra i nodi toccati nella
conferenza stampa c’è stato quello del sovraffollamento delle carceri e sulla
questione di genere ha detto: “Continuiamo a non essere pari, continuiamo a
vedere la donna più dalla cintola in giù”. “Anche i giovani spesso trovano
identità nella cultura machista – chiosa – noi maschi abbiamo di che vergognarci
e questo è un problema: non chiediamo al Parlamento di risolvere qualcosa che è
dentro di noi”.
Come primo atto da presidente
ha nominato vicepresidenti i giudici Silvana Sciarra, Daria de Pretis e Nicolò
Zanon, tra i quali, a settembre, sarà scelto il suo successore. E sui prossimi
mesi di lavoro ha detto: “Il tempo passa così velocemente alla Corte. L’augurio
è che rimanga sempre così coinvolgente e che io, in un baleno, a fine settembre,
andrò in pensione – conclude – l’età di 84 anni, anche considerati i nuovi
tempi, è ragionevole per andare in pensione. Fino ad allora, mi troverete qui”.
Francesco Grignetti per “La
Stampa” il 30 gennaio 2022.
E poi c'è Giuliano Amato che è
il nuovo presidente della Corte costituzionale. Proprio lui, che quando parla,
tanta è la conoscenza delle cose e del mondo, non sai se hai davanti il
professore di diritto, l'ex presidente del Consiglio, o il giudice
costituzionale.
È il Dottor Sottile e basta,
come si è visto anche ieri alla conferenza stampa da neo-presidente, quando ha
risposto a un fuoco di fila di domande su tanti temi, specie sulle riforme
istituzionali, sul ritardo verso le donne, e sui nuovi diritti su cui il
Parlamento tarda a legiferare.
«Sapete - ha esordito - che la
composizione tra gli Stati membri in Europa sta diventando più difficile che in
passato, perché erano conflitti economici e, come scrivono i malevoli, basta
dosare meglio le fette della torta.
Negli ultimi anni i conflitti
sono diventati di valori. Cos' è la famiglia? Cos' è il genere? Quanta sicurezza
e quanta libertà? Questi sono conflitti più impegnativi, nei quali ci possono
essere posizioni difficili da comporre. Bene, buona parte delle questioni che ci
siamo trovati ad affrontare in questi anni, vanno a toccare esattamente questi
temi...
Sono questioni su cui la
Costituzione dice chiaramente: la soluzione non va. Però non dice con
altrettanto chiarezza quale soluzione devi sostituire a quella. E qui la
collaborazione tra la Corte e il Parlamento diventa essenziale».
I temi sono noti: l'ergastolo
ostativo, il fine vita, il cognome materno e paterno. Le sentenze ci sono state;
manca la risposta del Legislatore. «Noi indichiamo una delle soluzioni
possibili; certo il Parlamento ne può indicare un'altra. Ma se il Parlamento non
lo fa, noi rimaniamo in questa situazione. E a volte il Parlamento per le stesse
difficoltà che incontrano gli europei, ha difficoltà a risolvere. Noi rimaniamo
con le nostre soluzioni, ma saremmo molto più contenti se fossero seguite da un
intervento del Parlamento».
Sui nuovi diritti, c'è un
crescente protagonismo della Corte. A fronte dei vostri moniti, si registra una
latitanza del Parlamento...
«Lo dicevo. Ci vuole una
collaborazione molto efficace e funzionante tra Corte e Parlamento. E io non
accuso. Permettetemi di dirlo: ho fatto politica per molti anni quindi può darsi
che verso la politica io sia più generoso di quanto non lo siano altri. Ma il
dire: "Sono questi politici... eccetera eccetera" è una risposta francamente
troppo facile.
Molto spesso la questione ha
una sua difficoltà per trovare un punto di equilibrio. Sa quanti anni ci abbiamo
messo ad arrivare a quell'ottima legge che ha introdotto le cure palliative e la
sedazione profonda? Quali conflitti veri, di valori, non interessi di bottega,
si sono dovuti superare? Alla fine ci si è arrivati. Se posso dire: il
Parlamento adotti quella legge come buono esempio. Ecco, lo dico volentieri».
In questi giorni di
fibrillazione istituzionale, molti guardano all'elezione diretta del Capo dello
Stato.
«Di certo presenta diversi
benefici, tra i quali, come ho sentito dire, che si svolge in un solo giorno. Ma
la lancetta di un orologio non la prendi e la metti in un altro orologio.
L'elezione diretta non la puoi prendere come tale e collocarla all'interno del
tuo sistema costituzionale.
Il nostro Capo dello Stato è
un organo di garanzia. Se si introduce l'elezione diretta, che cosa succede di
questi poteri? Sono ancora poteri di un organo di garanzia? L'elezione diretta
reca in sé una rappresentatività che non è così facile attribuire all'unità
nazionale, perché sarà una parte che lo elegge.
Ci saranno candidature
politiche. In Francia, l'elezione diretta porta in qualche modo al
semipresidenzialismo. Io stesso proposi l'elezione diretta nel 1978, e se ne
discusse. Insomma, secondo me, se uno decide questo, deve cambiare orologio per
evitare pasticci».
Sulla parità per le donne, ci
sono ancora ritardi. Che cosa suggerirebbe al Parlamento?
«Guardi, la legislazione
italiana è diventata una delle più avanzate nel sostenere la parità di diritti.
Eppure negli ultimi anni, a questa legislazione che non ha nulla da invidiare a
Svezia o Norvegia, ci siamo trovati a dover affiancare norme per punire in modo
più severo il femminicidio.
Il reato del maschio che
continua a considerare sua proprietà la donna, che davanti a qualunque sgarro
della donna rispetto al suo "ruolo" di oggetto di proprietà, si sente ancora
comunque legittimato ad eliminarla perché ha tradito la regola di base. E magari
ha trovato pure qualche giudice che gli dice: "Poverino, stavi attraversando una
tempesta emotiva".
Questo fa riflettere su quello
che è il limite della legge. La quale certo esprime sempre sentimenti collettivi
e opinioni condivise, ma in più casi è più avanti, se non dell'intera società,
di una parte di questa. Parte che non è stata raggiunta dal senso di questa
legislazione e che ha bisogno di essere portata alla con-sa-pe-vo-lez-za
dell'effettività parità.
Consapevolezza che manca a
coloro che uccidono la "propria" donna, ma è presente diffusamente. Insomma, se
posso alleggerire: quante volte è capitato anche a me, di costituire panel a
convegni e dire "Stiamo attenti, quante donne ci sono?". Ecco, il solo fatto che
ci domandiamo se ci sono e se sono sufficienti le donne presenti, vuol dire che
continuiamo a non essere pari.
Questo spiega molto di questo
fenomeno. Per cui, attraverso la legge, si è riusciti a immettere nelle diverse
carriere e professioni un numero adeguato di donne, ma poi c'è il collo di
bottiglia attraverso cui la cooptazione istintiva maschile finisce per
prevalere. Difficile combatterlo con la legge. C'è un lavoro ancora da fare...
Noi maschi abbiamo di che vergognarci. Quindi non chiediamo al Parlamento di
risolvere qualcosa che è dentro di noi».
Amato al vertice della
Consulta, esordio da mattatore su donne e carcere: «Sovrafollamento, pronti a
intervenire».
L’ex Capo del governo eletto stamattina all’unanimità nuovo
presidente della Corte costituzionale. Riguardo alla parità di genere, in
conferenza stampa dice subito: «Noi maschi dovremmo vergognarci, continuiamo a
vedere la donna dalla cintola in giù». Errico Novi su Il Dubbio il 29 gennaio
2022.
Che l’elezione di Giuliano
Amato a presidente della Corte costituzionale s’intrecci suggestivamente con la
tormentata sfida del Colle, lo si vede da vari piccoli segnali.
Intanto stamattina, poco prima
che verso le 12 l’ex presidente del Consiglio fosse indicato all’unanimità
(dagli altri giudici costituzionali) al vertice della Consulta, si era dovuto
procedere al giuramento del nuovo componente della Corte Filippo Patroni Griffi,
indicato dal Consiglio di Stato per avvicendare il presidente uscente Giancarlo
Coraggio, che ha concluso i propri 9 anni a Palazzo della Consulta giusto ieri.
Immaginatevi la scena: il
giuramento, come da prassi, avviene al Quirinale, dunque nelle mani del
presidente in carica, Sergio Mattarella appunto. E dunque, mentre i partiti si
consumavano nel loro fallimento e si accingevano ad andare a loro volta in
pellegrinaggio al Colle per chiedergli in ginocchio di restarci, lui il Capo
dello Stato, continuava tranquillamente a esercitare le funzioni. Vi dice nulla,
come sequenza simbolica?
A voler condire il tutto,
tenete presente che al giuramento di Patroni Griffi c’erano pure la protagonista
di uno dei tentativi più dolorosi degli ultimi giorni, Maria Elisabetta Alberti
Casellati, e la terza carica dello Stato, Roberto Fico, che presiede l’Aula nel
voto per la presidenza della Repubblica. Infine, Mario Draghi, protagonista
implicito dell’intera vicenda Colle. Una specie di pausa collettiva di
riflessione.
Poco dopo si riunisce la Corte
costituzionale al completo ed elegge all’unanimità, come detto, Giuliano Amato
presidente. È lui il giudice più anziano, la prassi vuole che sieda al vertice
della Consulta, il che non ha alcuno dei sempre presunti effetti in termini di
benefit: ai presidenti uscenti non toccano né macchine blu né altre leggendarie
ma ormai inesistenti prebende.
Amato nomina subito i
vicepresidenti, sempre da prassi: sono i giudici Silvana Sciarra, Daria de
Pretis e Niccolò Zanon. Tutti valentissimi, il terzo peraltro redattore di
alcune fra le recenti sentenze garantiste emesse dalla Corte in materia di
ergastolo e carcere ostativo.
Amato in conferenza stampa:
«Sulle donne, noi maschi dovremmo vergognarci»
Bene. A proposito delle due
vicepresidenti donne, proprio a partire dalla questione di genere Amato regala,
nell’immediatamente successiva conferenza stampa, un saggio della propria
arguzia, che fa di lui un auspicabilmente ritrovato protagonista del dibattito
pubblico, seppure i presidenti della Corte in carica tendano a parlare assai
poco, al di fuori dei tradizionali appuntamenti annuali con la stampa:
«Continuiamo a non essere pari, continuiamo a vedere la donna più dalla cintola
in giù». È sferzante, spietato: «Anche i giovani spesso trovano identità nella
cultura machista, noi maschi abbiamo di che vergognarci e questo è un problema:
non chiediamo al Parlamento di risolvere qualcosa che è dentro di noi».
E invece il legislatore
dovrebbe dare segnali su altro: «La Corte indica una delle soluzioni possibili»,
premette, in rifermento ad alcune delle questioni affrontate di recente, incluse
l’ergastolo ostativo e il suicidio assistito, e poi però avverte: «Saremmo più
contenti se si trovassero soluzioni in Parlamento».
Anche qui parla chiaro e non
fa sconti, In generale: «La collaborazione tra Corte costituzionale e Parlamento
diventa fattore essenziale, tanto più nel caso di conflitti sui valori». Ma
visto che spesso le soluzioni non arrivano, i problemi restano, innanzitutto sul
carcere: «In passato dicemmo, sul sovraffollamento, che bisognava provvedere,
perché la situazione non sarebbe stata ulteriormente tollerabile. Ora siamo
nuovamente sulle 52mila, 53mila presenze: se ci fosse riproposta una questione
su questo tema, ci troveremmo di fronte alla responsabilità di affrontarla».
Avvertimento severo, ma in
fondo rassicurante: mal che vada, c’è sempre la Consulta, per fortuna. Amato, da
“quirinabile appena scampato”, non si nega su discorsi presidenziali riferiti al
Colle («se si decide di cambiare, penserei al modello francese») e poi ricorda
che a fine settembre andrà «in pensione», come giudice e come presidente della
Consulta. «Fino ad allora mi troverete qui». Sarà breve, ma certamente intenso.
Mirella Serri per “la Stampa”
il 6 Febbraio 2022.
Parafrasando il titolo di un
celebre libro di Elsa Morante, la democrazia sarà salvata dalle donne? Potrebbe
capitare. Almeno per Giuliano Amato, certo che la presenza delle donne nelle
istituzioni «concorra ad aumentare il tasso di democrazia». Approfondiamo questa
convinzione con il neoeletto presidente della Corte Costituzionale, nel suo
studio al secondo piano di Palazzo della Consulta a Roma.
Perché le donne sono
essenziali per dare nuova linfa alla democrazia?
«Perché cambiano l'ordine del
giorno. Quella che oggi per i maschi e per i mezzi di informazione è cronaca
separata dalla politica, per le donne diventa un ineludibile compito della
stessa politica. La quale non può occuparsi solo di ristori, pur giusti, per i
ristoratori ma deve farsi carico di ragazzi abbandonati a se stessi, vittime dei
peggiori messaggi dei social, che stuprano le loro compagne di classe o
perseguitano i loro compagni più deboli; oppure di genitori che, anziché educare
i loro figli alla convivenza, li rendono aggressivi e intolleranti nelle
attività comuni. Questo è un grande, urgente, tema politico, di cui ho colto
peraltro più di una traccia nel discorso inaugurale del Presidente Mattarella».
Viene da lontano la
riflessione sul mondo femminile del Dottor Sottile, come è stato ribattezzato
Amato per la perizia con cui tira di fioretto e maneggia il diritto
costituzionale. Ne ha accennato anche nella conferenza stampa seguita alla sua
elezione, la scorsa settimana. E il due volte presidente del Consiglio non ha
avuto remore nel denunciare che la parità dei generi è ancora un miraggio per
l'Italia.
Presidente, aspettavamo da
anni la nomina di un capo del governo donna o di una donna al Colle e nessuna
delle due si è realizzata. Cosa possiamo fare per non incontrare il "soffitto di
cristallo" e far salire più donne ai vertici?
«Il posizionamento delle donne
nei ruoli apicali è condizionato dalla cooptazione maschilista. Le donne cercano
di conquistare le vette. Ma più si sale e più c'è il collo di bottiglia. Il
passaggio si fa stretto e l'aggregazione maschile finisce per prevalere. Un
atteggiamento che è difficile combattere a colpi di leggi.
Potremmo istituire, sempre
tramite una normativa, l'alternanza dei genders. Ma sarebbe offensivo per le
donne designate non in base al merito. Io, però, mi porrei anche un'altra
domanda: basta una donna al vertice delle istituzioni per garantire
l'emancipazione e l'uguaglianza delle altre donne? Il Pakistan è stato governato
da Benazir Bhutto e adesso ospita i genitori pakistani, che hanno cercato
rifugio nel loro Paese, di una ragazzina uccisa perché rifiutava il matrimonio
combinato. Indira Gandhi è stata primo ministro in India dove le bambine vengono
stuprate e buttate via dopo la violenza. Il Bangladesh ha la presidente del
Consiglio più longeva del mondo, Sheikh Hasina. Dunque, la presenza delle donne
concorre ad aumentare il tasso di democrazia, ma non necessariamente la
garantisce».
Che cosa deve fare la politica
italiana?
«L'aspetta un importante
compito. Non basta fare le leggi perché se la legge, anche buona, arriva prima
che ne siano convinti i cittadini, allora accade che venga disattesa e che like
e tweet spingano la politica in direzione opposta. La politica, invece, deve
avere una visione, una progettualità, in base alla quale deve tornare a
interloquire direttamente con le persone e deve essere capace di contrastarne le
opinioni per far valere il proprio progetto. Nella storia della sinistra, sui
temi della famiglia il Pci a volte è stato più conservatore del Psi.
Però la politica degli anni
Settanta-Ottanta ha contribuito a innovare la società italiana. Quando ero un
giovane socialista impegnato nella campagna per il divorzio, andavo nelle
sezioni a spiegare che se l'amore era finito e c'era solo il litigio era meglio
imboccare la strada della separazione. I più anziani mi rispondevano perplessi:
"Queste donne esagerano!". Discutevo con loro e cercavo di spiegare che la donna
non era una proprietà personale del maschio. Aveva cominciato a dirlo, molti
anni prima, una donna, Anna Kuliscioff, spesso in contrasto con il suo compagno
di vita e di militanza Filippo Turati.
Quando il diritto di voto
venne finalmente riconosciuto anche ai non abbienti, ma solo ai maschi che
avessero fatto il soldato, Anna disse: "Le donne non fanno il soldato, ma fanno
i soldati"».
Le donne che hanno lavorato al
suo fianco, come le ex ministre Fernanda Contri e Linda Lanzillotta, le
riconoscono di averle sostenute o addirittura di averle sollecitate ad
affrontare l'agone. Da dove nasce questo suo rapporto positivo con il mondo
femminile?
«Ho cominciato a percepire gli
effetti della disparità davanti all'evidenza che ne avevo nella mia stessa vita
privata. La ragazza che ho frequentato fin da quando avevo 14 anni, la mia
attuale moglie Diana Vincenzi, con cui studiavo al liceo e poi all'università,
nel percorso professionale è rimasta penalizzata. Il nostro comune professore mi
diceva "Diana è più intelligente e farà più strada di te". Invece dopo la
nascita dei figli, per consentire a me di andare a insegnare prima a Modena, poi
a Perugia e a Firenze, lei è rimasta indietro. Solo dopo che fui chiamato a
Roma, lei ha potuto muoversi e fare la sua carriera, mentre io mi occupavo di
più della casa».
Ma quando e come ha sentito
l'urgenza della questione femminile?
«Sono stati gli occhi di mia
figlia bambina, curiosi, indagatori, appassionati, che, mentre studiava, mi
comunicavano questo interrogativo: "Ora che ho capito, potrò fare quello che
desidero?". E io pensavo: chi le toglierà questa fiducia? Chi le darà la prima
delusione?».
Lei, invece, ha dato fiducia
alle donne che hanno lavorato con lei
«Ho dato fiducia perché sono
convinto che poste ai vertici degli apparati sappiano trasmettere la loro
autorevolezza molto meglio dei maschi. L'attuale direttrice del Dis, Elisabetta
Belloni - è solo un esempio tra i tanti - corrisponde in maniera egregia a
questa mia convinzione».
Le donne in Italia sono
indietro anche nel mondo del lavoro. La pandemia ha contribuito ad ampliare il
divario nelle retribuzioni e nell'occupazione. Cosa si può fare?
«Proprio in questi giorni è
arrivata la notizia, positiva, che il numero dei posti di lavoro stia
lievitando. Resta però il problema che le donne continuano ad essere pagate meno
degli uomini, mentre la Costituzione impone, a parità di lavoro, parità di
retribuzione. La Costituzione, non una legge qualunque».
L'addio dopo nove anni. Giuliano Amato
lascia la Corte Costituzionale: l’addio una lezione di diritto e di stile.
Claudia Fusani su Il Riformista il 14 Settembre 2022
Teme il “caos istituzionale”. Perché in questi
nove anni, quanti sono quelli che ha passato alla Corte, “il mondo è cambiato e
non è cambiato in meglio” perché sono “aumentati i conflitti tra Stati, dentro e
fuori l’Unione europea, dentro le nostre società dove i sistemi politici si sono
radicalizzati in particolare sui temi valoriali e identitari rendendo sempre più
difficili le soluzioni condivise”. Triste e amaro finale per Giuliano Amato,
intelligenza sottile, al pari della sua proverbiale ironia: ha assunto
la Presidenza della Corte il 29 gennaio scorso, nel pieno del terremoto
quirinalizio e del bis di Mattarella. La lascia alla vigilia di un voto politico
che si annuncia come un altro terremoto e di una legislatura per la prima volta
a 600. Due momenti topici osservati col necessario distacco e la altrettanto
necessaria consapevolezza.
Se il passaggio o di consegne al vertice di un
organo di garanzia come la Corte Costituzionale è quasi sempre un rito
controllato e senza scossoni quello di Amato non poteva che essere, invece,
pieno di emozioni. La cerimonia di ieri non è stato un “testamento” e meno che
mai un “epitaffi o”. Del resto “la storia di Giuliano Amato è patrimonio del
discorso pubblico italiano ed europeo” come ha detto Sciarra toccando i numerosi
incarichi della sua vita. E il suo nome tornerà presto in corsa per qualcosa.
“Buckingam palace, sputa l’ipotesi Amato” si scherzava ieri citando un meme
circolato sui social. Se ci dovesse essere ad esempio una Bicamerale per le
riforme, il suo è il nome più spendibile. “Intanto torno volentieri ospite nelle
sale della mia amata Treccani” si sarebbe confidato con i colleghi. Ancora una
volta, nella cerimonia, Amato ha voluto guardare avanti. Di 171 decisioni
assunte durante i suoi nove anni come giudice costituzionale, molte delle quali
sulla persona e la tutela dei diritti fondamentali, tutte hanno cercato di
illuminare il futuro, quello che verrà o sarà. Quando non è successo – ad
esempio sui tre quesiti referendari che la Corte da lui presieduta non ha
accolto (fine vita, cannabis e responsabilità civile dei magistrati) – la stessa
Corte, che ha dedicato molte risorse ad una corretta comunicazione, ha rotto
tutti gli schemi e ha convocato una conferenza stampa.
Quei tre No avevano un grosso impatto e andavano
spiegati. Mettendoci la faccia. A qualcuno è piaciuto. Ad altri meno. Di sicuro
ha contribuito alla comprensione dei fatti. Così come sull’invio di armi per
supportare la resistenza ucraina: il dibattito in Parlamento era forte,
trasversale, divisivo, Amato ritenne opportuno, approfittando di un incontro
istituzionale, spiegare perché, Costituzione alla mano, è giusto inviare armi.
Anche il saluto è diventato alla fi ne una lezione piena di moniti. I conflitti,
tra Stati e nei singoli sistemi politici, “portano ad innalzare o a minacciare
di innalzare barriere nazionali contro il diritto comune”. Sul fronte interno
“abbiamo camminato spesso lungo il crinale che separa la nostra giurisdizione
dalle scelte che competono al Parlamento”, ovvero situazioni in cui “le nostre
stesse legittime decisioni hanno bisogno per realizzarsi di un conforme
intervento parlamentare. È capitato spesso però di incontrare o il silenzio del
Parlamento o voci discordi che hanno impedito le decisioni”.
La Corte ha proceduto negli anni seguendo “due
bussole fondamentali: la collaborazione istituzionale come veicolo per garantire
a ciascuno di esercitare le proprie responsabilità e l’equilibrio nella ricerca
delle soluzioni”. Nel caso Taricco, ad esempio, la Corte ha saputo tutelare i
principi fondamentali interni e in particolare nella materia penale (il nodo era
la prescrizione dei reati) aprendo al tempo stesso a un diritto penale europeo.
Così come sulla maternità surrogata, di cui Amato ha ricordato come “mai sia
stato messo in dubbio il disvalore”, la Corte ha però sollecitato il Parlamento
a trovare soluzioni migliori per la tutela del bambino. Questi, ha detto Amato,
“sono i binari da seguire e su cui insistere anche nel futuro nonostante le
tentazioni che i tempi sollecitano e che già qualcuno sta raccogliendo”. Si
riferisce, il Presidente uscente, alle “tentazioni di affermare il primato del
diritto nazionale su quello comune europeo”. Un problema che non riguarda
solo Polonia, Romania e Ungheria ma anche Francia e Germania. Sul fronte interno
preoccupa che le “difficoltà decisionali del Parlamento” cominciano a “dare
fiato a tesi che ritenevo sepolte circa la giurisprudenza come fonte del diritto
al pari della legislazione”.
Questa, ha detto Amato, “è la strada che porta
dalle situazioni difficili al caos istituzionale”. C’è una foto potente scattata
nei mesi passati. Era il 3 febbraio, Mattarella giurava in Parlamento per il
bis. In Transatlantico sfilarono uno dietro l’altro, come prescrive il
cerimoniale, Mattarella, Amato e Draghi. Eravamo ancora tutti con le mascherine.
Venti giorni Putin dopo portò i carri armati in Ucraina. Quella foto
rassicurava. Tutti. E lo ha fatto più volte in questi mesi. Oggi Draghi è
dimissionato. Amato a fi ne mandato. Ci resta il Capo dello Stato. Per la Corte
adesso è corsa tre. Silvana Sciarra e Daria De Petris e Nicolò Zanon hanno la
stessa anzianità. Mattarella deciderà e nominerà nei prossimi giorni il
successore di Amato. A quel punto la Corte si potrà riunire per eleggere il
nuovo Presidente.
Claudia Fusani. Giornalista originaria di Firenze
laureata in letteratura italiana con 110 e lode. Vent'anni a Repubblica, nove a
L'Unità.
Giudici spaccati sul suo nome. Silvana
Sciarra, la nuova presidente della Consulta eletta da una Corte spaccata: Conte
la voleva al Quirinale. Angela Stella su Il Riformista
il 21 Settembre 2022
Torna una donna alla guida della Corte
Costituzionale a tre anni di distanza dall’esperienza di Marta Cartabia. La
nuova presidente è la giuslavorista Silvana Sciarra, 74 anni, originaria di
Trani. I voti favorevoli sono stati 8 su 15. In lizza con lei c’erano Daria De
Pretis e Nicolò Zanon. Proprio gli altri 7 voti sono andati alla De Petris.
Dunque una Corte spaccata, a differenza delle votazioni che elessero alla guida
della Consulta Cartabia, Amato, Coraggio, Lattanzi. Come primo atto da
presidente, Silvana Sciarra ha confermato come Vicepresidenti Daria de
Pretis e Nicolò Zanon. Sciarra, prima donna eletta dal Parlamento come Giudice
presso la Corte costituzionale italiana, ha iniziato il suo mandato nel novembre
2014, dopo aver ricoperto il ruolo di Professore ordinario di Diritto del Lavoro
e Diritto Sociale Europeo presso l’Università di Firenze e l’Istituto
Universitario Europeo.
È Professore Emerito nell’Università di Firenze.
Succede a Giuliano Amato, di cui è stata vicepresidente. Il suo mandato scadrà a
novembre del 2023. Alla fine dello scorso anno il suo nome era stato proposto
da Giuseppe Conte quale possibile nuovo Presidente della Repubblica. Dopo
l’elezione ha incontrato la stampa: dimentichiamo lo stile Amato, la neo
Presidente ha fatto capire che, pur tenendo molto alla comunicazione della Corte
– più volte ha ringraziato Donatella Stasio -, la sua sarà molto più ingessata e
moderata rispetto a quella del predecessore, che ci aveva abituato, da abile
politico qual è, ad affrontare senza filtri i temi che gli venivano sottoposti.
Noi abbiamo sottoposto e letto alla neo presidente un passaggio di un articolo
del costituzionalista Andrea Pugiotto, firma autorevole di questo giornale che
sul tema dell’ergastolo ostativo, tra l’altro, scriveva qualche mese fa: “Un
terzo rinvio priverebbe per sempre di qualsiasi credibilità i moniti rivolti al
legislatore, rivelando che la prima a non prenderli sul serio è la stessa
Consulta”. Insomma avremmo voluto sapere se c’è un limite che la Corte
Costituzionale si pone nel concedere al Parlamento nuovo rinvii per riscrivere
una legge dichiarata incostituzionale, come quella sul fine pena mai.
La presidente, ci dispiace dirlo, ha eluso la
nostra richiesta: “Ho letto l’articolo di Pugiotto ma non posso esprimermi, sarà
il collegio sovrano a prendere questa decisione”. Non abbiamo chiesto un
anticipo della decisione, ci mancherebbe. Avremmo voluto una riflessione sulla
collaborazione tra Corte e Parlamento. Speriamo che la Consulta tenga conto il
prossimo 8 novembre (entro questa data il Parlamento dovrà portare a termine la
modifica dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario per evitare un possibile
intervento dei giudici costituzionali che spazzi via definitivamente la norma)
del fatto che da un controllo effettuato tra i resoconti della Commissione
giustizia del Senato è emerso che dalla data del 10 maggio, ossia da quanto la
Consulta ha concesso il secondo rinvio, a Palazzo Madama si sono susseguiti solo
rinvii nelle poche sedute – meno di dieci – tenute sul tema. Dunque nessun passo
avanti. Difficile poi che l’8 novembre il nuovo Parlamento emanerà una legge. E
ci troveremo pure, molto probabilmente, con un Governo guidato da partiti per i
quali “certezza della pena è certezza del carcere”.
Comunque, tornando alla giornata di ieri,
l’elezione di Sciarra ha raccolto pareri trasversalmente positivi. “Un grande
augurio di buon lavoro alla neo eletta Presidente della Corte Costituzionale
Silvana Sciarra”, ha scritto su twitter il segretario del Pd Enrico
Letta. Plauso ovviamente, visto il precedente, da Giuseppe Conte: “A Silvana
Sciarra, nuova Presidente della Corte Costituzionale, auguri di buon lavoro dal
@Mov5Stelle. La sua riconosciuta competenza costituisce sicura garanzia per
l’esercizio di un ruolo istituzionale fondamentale per gli equilibri del Paese”.
Soddisfazione anche da parte di Forza Italia, con il sottosegretario Francesco
Paolo Sisto: “Autorevolissima giurista pugliese, laureatasi a Bari, nella nostra
cara Università, onorerà al meglio con la sua competenza e il suo equilibrio
l’importante incarico a cui è chiamata. È motivo di vanto per i cittadini della
Puglia poter contare sulla sua figura al vertice di un organismo che presidia il
rispetto della nostra Carta costituzionale”. “Una bella notizia: la Corte
Costituzionale ha una nuova presidente, Silvana Sciarra. Congratulazioni e molti
auguri di buon lavoro”, ha dichiarato la ministra per le Pari opportunità Elena
Bonetti.
Pure il Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale Mauro Palma ha osservato “con favore il fatto che per la
seconda volta sia stata chiamata una donna al vertice dell’autorevole
Istituzione. Giuslavorista di elevato spessore, è stata tra i giudici
costituzionali che con grande sensibilità hanno partecipato nel 2018 alla
memorabile esperienza di incontro con le persone detenute, documentata
in Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle carceri, progetto che aveva
visto l’attiva collaborazione dello stesso Garante nazionale. In
quell’occasione, la Presidente Sciarra aveva mostrato grande attenzione al tema
del lavoro in carcere, questione di cruciale importanza”. Angela Stella
"Sobrietà e trasparenza".
Chi è Silvana Sciarra, la nuova presidente della Consulta e prima donna eletta
giudice costituzionale.
Redazione su Il Riformista il 20 Settembre 2022
Dopo Marta Cartabia torna una
donna alla guida della Consulta. Silvana Sciarra, 74enne originaria di Trani, è
la nuova presidente della Corte Costituzionale. E’ stata eletta con otto
voti contro i sette andati a Daria De Pretis. Nessuna preferenza invece per il
terzo candidato Nicolò Zanoni. Subentra al costituzionalista ed ex presidente
del Consiglio Giuliano Amato. Il suo mandato scadrà tra 14 mesi, nel novembre
del 2023.
Già vicepresidente della
Consulta durante la reggenza di Amato, Sciarra nel 2014 fu la prima donna eletta
giudice costituzionale dal Parlamento. Come primo atto da presidente della
Consulta, la giuslavorista ha confermato come vicepresidenti Daria de Pretis e
Nicolò Zanon. “Ho il privilegio di avere i capelli bianchi, forse la Corte ha
voluto premiare questo criterio della anzianità. Voglio rafforzare la
collegialità” ha dichiarato la neo presidente nel corso della conferenza stampa.
Sciarra ha ricordato che “dalla sobrietà e dalla trasparenza l’istituzione
prende autorevolezza”.
“L’Italia ha un corpo di leggi
sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro molto avanzato
con regole meticolose che viene visto come un modello” ha aggiunto. “Siamo
idealmente – ha poi chiarito – in un contesto avanzato ma questo non ci può
consolare: ci sono degli errori, forse delle omissioni a monte di questi eventi.
Forse bisogna insistere ancora di più ma non siamo in un terreno privo di regole
c’è forse una scarsa attenzione nell’attuarle”.
Professoressa ordinaria di
Diritto del lavoro e di Diritto Sociale Europeo presso l’Università di Firenze e
l’Istituto Universitario Europeo, Sciarra ha iniziato gli studi a Bari. Si è
laureata in Giurisprudenza nel capoluogo pugliese, discutendo una tesi con il
professore Gino Giugni, “padre” dello Statuto dei lavoratori. Un solido punto di
partenza per una carriera universitaria che si è sviluppata sia in Italia che
all’esterno.
E’ stata Harkness Fellow
presso l’Ucla e la Harvard Law School (1974-1976); Fulbright Fellow presso
l’Ucla (1985), Visiting Professor in diverse Universita’, tra cui Warwick
(Leverhulme Professor), Columbia Law School (BNL Professor), Cambridge (cattedra
Arthur Goodhart in Legal Science 2006-2007), Stoccolma, Lund, University College
Londra, e la Luiss a Roma. Ha insegnato presso la Facoltà di Scienze Economiche
e Bancarie dell’Università di Siena. Dal 1994 al 2003 ha ricoperto la cattedra
di Diritto del Lavoro e Diritto Sociale Europeo presso l’Istituto Universitario
Europeo di Fiesole. Direttrice del Dipartimento di Diritto (1995-1996), ha anche
coordinato il programma di Gender Studies (2002-2003).
Ha collaborato con la
Commissione Europea in numerosi progetti di ricerca ed è stata designata dal
Consiglio dell’Unione Europea membro del comitato che dovrà dare un parere
sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di
avvocato generale della Corte di giustizia. Ha ricevuto il dottorato di Ricerca
in Legge Honoris Causa presso l’Università di Stoccolma nel 2006 e di Hasselt
nel 2012 ed è stata per diversi anni co-direttore della rivista Giornale di
Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali. Alla Consulta, dove dal gennaio
di quest’anno ha ricoperto il ruolo di vicepresidente, ha firmato la sentenza
che a luglio ha dichiarato indifferibile la riforma delle norme sui
licenziamenti, e la pronuncia che ha ritenuto discriminatoria la limitazione del
bonus bebè ad alcune categorie di migranti.
Guido Paglia per sassate.it il
21 settembre 2022.
Dunque, facciamo un po’ di
conti: i giudici della Corte Costituzionale sono quindici: la neo-presidente,
Silvana Sciarra, è stata eletta presidente con otto voti; mentre l’altra
candidata, la vicepresidente Daria De Pretis, si è fermata a sette suffragi.
Manco una scheda bianca, ne’ voti dispersi.
Quindi, c’è poco da
arzigogolare: le due illustri giuriste hanno votato per se’ stesse, non hanno
avuto il pudore di astenersi o magari di uscire entrambe dall’aula, lasciano
liberi gli altri tredici colleghi di scegliere l’una o l’altra. Non si sono
fidate. E il risultato è sconcertante. Perché ora abbiamo al vertice della
Consulta, cioè a capo dell’organo di controllo costituzionale delle leggi
sfornate dal Parlamento, una giurista che è lì solo perché è stata eletta con il
voto determinante per sè stessa.
E con una dei due vice, che ha
fatto altrettanto. Non proprio il massimo, non vi pare? Ai media questo aspetto
è sembrato del tutto trascurabile. Silenzio assoluto. Forse per paura di essere
accusati di “sessismo”? Ecco, nel caos pre-elettorale di questi giorni, ci
mancava questa auto-picconatura della Corte Costituzionale.
L’unica speranza è che presto
questa Consulta monocolore voluta da Mattarella e dal Parlamento controllato
dalle sinistre, sarà rinnovato per quattro quindicesimi. E saranno tutti
prerogativa di Camera e Senato. Ottima occasione per raddrizzare la baracca.
La sindrome di Stoccolma
che la politica vive al Quirinale con Mario Draghi.
Giampiero Casoni il 25/01/2022
su Notizie.it.
Mario Draghi è diventato il
solo grimaldello della possibilità che la nostra vita vada meglio. E no, il
Covid non può e non deve giustificare questa autarchia.
È un film che conosciamo poco,
quello dell’elezione del Presidente della Repubblica. Ne conosciamo molto bene
la sceneggiata ma molto poco la sceneggiatura, quella parte cioè che davvero
decide chi e come un Capo dello Stato debba insediarsi al Quirinale. E ci sono
aspetti che finiscono per sfuggirci perché noi italiani abbiamo due pecche:
primo, non riusciamo a discernere da sempre la politica dei partiti dalle
dinamiche delle istituzioni, secondo e a traino perché siamo portati a pensare
che la prima prevalga sempre sulle seconde, nel bene o nel male.
E alla fine ci facciamo
prendere la mano dallo sdegno profondo nel vedere come durante l’elezione del
Presidente della Repubblica tutti parlino con tutti e negli uffici, quelli
belli, si consumino i summit più incestuosi fra i nostri beniamini e i
rappresentanti degli schieramenti avversi. Le agenzie ci sparano dritti in
faccia i lanci di capipopolo tiroidei che si fanno passare lo zucchero da
squadernati leader moderati e noi cadiamo con tutti e due i piedi nella mistica
del “è tutto un magna magna”.
Non funziona così e se non
funziona così è perché i Padri Costituenti l’avevano pensata fina e giusta: in
Italia il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni esattamente per
il motivo che è insito nella sua mission, che è quella di essere la persona più
rappresentativa possibile di tutte le istanze di tutti gli italiani, o quanto
meno di tutti coloro che col meccanismo della democrazia parlamentare sono stati
delegati dagli italiani a prendere decisioni cruciali o “semplicemente”
importanti.
Un Capo dello Stato è una
somma, non è un prodotto, è un riassunto e non il capitolo più accattivante del
libro, è il frigo che funziona bene, non il cibo più goloso. Ed è per questo
motivo che sette anni sono il tempo minimo per consentire la sovrapposizione di
più governi, che in media ne durano quattro e che in Italia possono avere vite
molto più effimere. Perché il messaggio che deve passare è che che l’azione di
un governo e gli indirizzi politici che quel governo prende non devono avere
nulla a che fare con chi è garante di quell’azione e assieme a quella di tante
altre cose.
Garanzia istituzionale ed
azione politica perciò sono due cose in medesimo casermaggio ma con gradi,
“durata di naja” e mission diverse. Ecco perché pare ancora più miserella la
faccenda per cui in queste ore concitate ed importanti l’impressione tangibile è
che Palazzo Chigi sia il vero epicentro di tutta la faccenda, che il Quirinale
sia una dependance da cui scegliere il colore della moquette e Mario Draghi sia
la cartina tornasole di ciò che i grandi elettori dovranno decidere.
Non perché Mario Draghi sia un
premier eccellente o sopravvalutato, ma perché nel tempo e nella mistica che ci
ha presi un po’ tutti Mario Draghi è diventato il solo grimaldello della
possibilità che la nostra vita vada meglio e che le nostre faccende di governo
di sistemi complessi vadano a meta e trovino la quadra. E l’elezione al
Quirinale risente in maniera ossessiva di questa ossessionante ossessione per
una leadership che assomiglia sempre di più ad un sultanato illuminato.
Draghi e il Colle sono legati
anche senza che necessariamente Draghi al Colle ci vada perché quello che dovrà
andare al Colle dovrà garantire non di essere, come dovrebbe essere, la sintesi
delle istanze della rappresentanza politica italiana, ma la sintesi delle
possibilità che Draghi resti centrale ed accompagni l’Italia fuori dal tunnel.
Ed è un tunnel da cui, e diciamolo una volta per tutte, senza tema che i
ciambellani ci facciano carne trita, l’Italia saprebbe uscire anche con un
onesto premier che magari in Consiglio dei Ministri faccia parlare qualcun altro
o si prenda un cazziatone da un partito insoddisfatto.
No, il Covid non può e non
deve giustificare questa autarchia, questo cilicio quirinalizio con riverente
impalcatura, e di Coriolani buoni per le stagioni difficili siamo un filino
stufi tutti.
Perché la sindrome di
Stoccolma nella vita di uno Stato di Diritto è molto più che un fenomeno da film
figo e a volte è meglio essere liberi di sparare una fregnaccia che essere
ostaggi gioiosi ed ebeti degli uomini del destino che le fregnacce non le dicono
mai perché se le dicono nessuno gli va a dire che le hanno dette.
Di quelli ne abbiamo avuti
già, e non è andata molto bene.
Da la7.it il 31 gennaio 2022.
Mario Monti: "La differenza
tra me e Draghi? Io non ho abbandonato la presidenza del consiglio dopo un anno
e mezzo. L'ambizione di Draghi - di andare al Quirinale - è stata
destabilizzante. Ho votato sette volte scheda bianca e una volta Mattarella"
Ecco il vero patriottismo.
Marco
Tarquinio su Avvenire il 29 gennaio 2022.
Sergio Mattarella succede a
Sergio Mattarella. Ed è un gran bel giorno per l’Italia. Il voto della speciale
Assemblea chiamata a eleggere il Presidente della Repubblica ha corrisposto
infine all’attesa e al desiderio esplicito della stragrande maggioranza del
Paese, quella che chiedeva il «Mattarella bis» e non per calcolo ma per
gratitudine. Un’infinità di italiani che in questi tribolati anni ha trovato
saldo riferimento nel «presidente concittadino», nel suo senso del dovere e del
limite, nell’amore per le Istituzioni, nella stima molte volte dimostrata per
coloro che fanno e danno lontano dai riflettori.
Patriottismo, come qualcuno,
anzi qualcuna, la leader della destra d’opposizione a tutto, aveva evocato quale
"prova del sangue" del nuovo inquilino del Colle? Sì, patriottismo. Patriottismo
vero: civile, antiretorico, inclusivo, costituzionale. Patriottismo italiano ed
europeo. Sanamente laico perché di profonda radice cristiana. E chi conosce sul
serio la storia della nostra democrazia sa che questo non è un gioco di parole,
ma una cultura preziosa e una costante qualità politica, che Sergio Mattarella
ha interpretato con appassionata coerenza per tutta la sua vita.
Un servizio politico così
lungo che, a ottant’anni, avrebbe voluto non concludere, ma rallentare, dandogli
ritmo e intensità molto differenti. Lo sappiamo tutti, anche perché nel
Messaggio di fine 2021 ce lo ha detto, con un sorriso e a chiare note, che si
sentiva all’ultima riflessione e all’ultimo augurio da Presidente. E questo,
ovviamente, anche per ragioni personali ma, soprattutto, per alto convincimento.
Aveva spiegato che cosa l’abbia portato a mutare avviso rispetto a qualche
decennio fa, argomentando che non è bene che Capi dello Stato che durano nella
carica per sette anni vengano rieletti e che sarebbe stato ancora meno positivo
se questo fosse avvenuto per due volte consecutive, dopo il bis imposto, in una
impasse diversa e altrettanto seria, a Giorgio Napolitano nel 2013. Eppure,
Mattarella si è inchinato all’indicazione pressoché unanime del Parlamento e dei
delegati delle Regioni. E anche questa è una dimostrazione esemplare: andare
oltre i limiti che si riconoscono e che si vorrebbe tener cari, proprio per il
senso del proprio limite che porta a onorare un dovere urgente, stavolta simile
a quello per cui – giusto un anno fa – chiamò Mario Draghi a governare il
necessario e l’indispensabile con una coalizione giudicata impossibile.
Si dice spesso, e in questi
giorni lo si è fatto più volte per commentare lo sfiorire di ambizioni e di
"rose" e il moltiplicarsi delle spine sulla via del Quirinale, che in Italia
alla Presidenza della Repubblica «non ci si candida, ma si viene candidati». Si
dice, ma magari non ci si crede del tutto.
Stavolta, però, non ci sono
dubbi: è stato eletto il Non Candidato per eccellenza. E l’amplissimo consenso
di sabato sera conferma che di scelta eccellente si è trattato. Più di qualcuno,
magari, dirà che è stata anche la scelta disperata di leader politici che
avevano sbagliato troppo e che rischiavano di mettere in crisi pure il governo
Draghi, dopo aver discusso malamente, mentre si sgambettavano a vicenda, del
trasloco dell’attuale premier al Colle. L’importante è che non abbiano sbagliato
tutto.
L’Assemblea, del resto, aveva
cominciato a votare "Mattarella" in crescendo e senza aspettare permessi dai
gran capi. Generali che, al sesto giorno di giri a vuoto, si sono accodati
infine alle truppe parlamentari (memori forse di quel sindacalista francese che
sentenziò: «Sono il loro capo, perciò li seguo»). Alcuni più acciaccati di
altri. Altri meno. Altri ancora per nulla. Ma questo è un bilancio che qui,
oggi, non interessa fare. Questo è davvero un bel giorno per l’Italia, grazie al
Parlamento e al nostro Presidente.
Quei 46 voti centristi per
Mattarella erano un segnale cifrato per il Pd.
Giovanna Casadio su La
Repubblica il 30 gennaio 2022. L’orologio di Montecitorio segna le 14 e 51 di
venerdì 28 gennaio: è l’ora da cui non si torna più indietro. Non tanto
perché Maria Elisabetta Alberti Casellati soccombe sotto il fuoco incrociato di
71 franchi tiratori che provengono dalle stesse file del centrodestra che l’ha
proposta. Ma soprattutto perché il presidente della Camera, Roberto Fico dà
conto di un altro numero, apparentemente insignificante: Sergio Mattarella ha
ottenuto 46 voti.
DAGOREPORT il 29 gennaio 2022.
A questo punto, il ciccione
shakespeariano Falstaff direbbe: “La politica italiana? Un'ignobile farsa”. Da
Salvini a Conte, dalla Meloni a Renzi, da Berlusconi a Letta, ecco leader senza
leadership capaci solo di unire l’incapacità all’arroganza. La caotica e
grottesca farsa quirinalizia, che sta per risolversi con un Mattarella bis, è
stata però utilissima: pensavamo che i vari capataz dei partiti fossero tipini
mediocri, invece ora sappiamo che sono delle autentiche nullità.
Dopo aver inanellato una
stronzata dopo l’altra, da Casellati a Belloni, la schizofrenia della king-pippa
Salvini è stata ricondotta al sano buon senso e stamattina ha balbettato ai
cronisti: "Invece di andare avanti per giorni con veti incrociati, consideriamo
se non sia il caso di chiedere a Mattarella 'ripensaci'".
Il Bis della Mummia Sicula è
stato auspicato, in primis, dagli applausi e standing ovation degli italiani in
ogni manifestazione pubblica del Capo dello Stato. Secondo: “Mattarella, il
ritorno” è stata la prima opzione di Enrico Letta, Matteo Renzi e di tutti i
tantissimi peones parlamentari timorosi di perdere con il voto anticipato il
vitalizio di fine legislatura. Viceversa, apertamente contraria Gigiona Meloni
che sogna le urne h24.
Invece, l’inesistente
Peppiniello Conte ha coperto con il suo sbrodolante bla-bla da leguleio la
voglia matta di andare al voto anticipato, di formare con i suoi fedelissimi le
liste elettorali, sfanculando così Di Maio e i suoi, i suoi nemici più intimi.
Alla Ducetta e alla Pochette
con le unghie, si è quindi accodato quella mezzasega di Salvini che, nel
conciliabolo con Letta e Conte di ieri, ha detto no alla permanenza di
Mattarella, continuando a inanellare una cazzata dopo l’altra, dalla trombatura
annunciata della seconda carica dello Stato per finire con la folle candidatura
del capo dei servizi segreti – con una Belloni che, in barba al suo status
istituzionale, non ha sentito l’opportunità di fare un comunicato all’Ansa per
dire a Salvini, Meloni e Conte solo tre parole: “Non sono disponibile”.
E qui l’incapacità del Truce
del Papeete di fare politica, anche senza l’hangover di alcolici mojitos, è
saltata agli occhi di tutti: uno che è sempre stato contrario al voto anticipato
non si è minimamente reso conto che una Belloni sul Colle, senza il voto
dell’attuale maggioranza di governo, voleva semplicemente dire dimissioni di
Draghi, crisi e l’apertura delle urne.
Alla fine della farsa
quirinalizia ci sono tre dati lampanti. Il primo è la schizofrenia da T.S.O. del
Capitone, mai un leader si era mostrato tanto piccolo a fronte di una partita
così importante. Del resto si è visto, eccome, il ritorno di Luca Morisi.
Il secondo è la mezza vittoria
di Draghi, che ha congelato la sua prorompente ambizione di salire al Colle fino
al 2023. Non è ciò che voleva, ma in fin dei conti si intesterà lui in Europa la
riconferma di Mattarella.
Infatti, oggi, nella mezzora
di colloquio a margine del giuramento di Filippo Patroni Griffi a giudice della
Corte Costituzionale, prima di accettare la richiesta dei partiti di fare il
bis, la Mummia Sicula ha chiesto e ottenuto da Draghi garanzie della sua
permanenza a Palazzo Chigi.
Contemporaneamente, durante la
cerimonia di stamattina, Giuliano Amato, nella sua qualità di presidente della
Corte Costituzionale, ha sollecitato fortemente il Presidente della Repubblica
ad accettare la richiesta dei partiti di restare al Quirinale.
Il terzo dato è la guerra
aperta tra Conte e Di Maio e la resa dei conti tra Salvini e Giorgetti che si
aprirà da qui ai prossimi giorni. Giuseppi ha provato a incastrare Giggino con
la candidatura della Belloni, Di Maio gli ha risposto per le rime. Sarà
impossibile tornare indietro. Se il M5S sarà liquefatto entro la fine
dell’estate, anche la Lega che fa a capo a Giorgetti e ai governatori Zaia,
Fontana e Fedriga presenterà il conto dei fallimenti al cazzaro del Papeete.
DAGOREPORT il 30 gennaio 2022.
Mattarella bis, varie ed
avariate. Non è vero il “Draghi decisivo” (Corriere della Sera e Repubblica). E’
vero che Draghi effettivamente ha chiesto a Mattarella di rimanere in quanto
sarebbe stato l’unico capace di dare forza al governo, nonché è l’unico che
potrebbe lasciare il posto in anticipo (ma la staffetta col Siculo sarà tutta da
vedere).
E’ altrettanto vero che l’ex
SuperMario si è deciso di bussare alla porta di Mattarella solo all’indomani
della sua sconfitta. Quando era certo che non sarebbe stato lui il Capo dello
Stato. Così, in “zona Cesarini” ha cambiato copione, si è aggrappato al
salvagente Mattarella ed è diventato il “garante della stabilità”, colui che “ha
ricompattato una maggioranza allo sbando”. Un abile mossa: non poteva certo fare
la figuraccia di mollare la guida del governo, con l’eventuale ascesa al Colle
di un Casini o di una Belloni.
Difatti, il Grande Gesuita,
che è ancora infuriato, ci ha sperato (e brigato) fino all’ultimo respiro perché
alle cazzate dei giornaloni e dei talk (uno per tutti, il Mago Mieli: “L’esito è
scontato: sarà Mario Draghi il prossimo Capo dello Stato”) ci aveva creduto pure
lui. Non altrettanto il suo maggior sponsor, Enrico Letta.
Svela un gustoso episodio oggi
Francesco Verderami sul Corriere: “Salvini, dopo aver incontrato il premier, si
chiude con Letta e Conte - a loro volta divisi - per discutere chi scegliere.
Già lì accade qualcosa di strano, perché il segretario del Pd davanti al capo di
M5S presenta una rosa di nomi senza Draghi. Più tardi, Salvini racconterà
maliziosamente che «quando con Letta parlavamo in assenza di Conte, il nome di
Draghi non mancava». Stava nella lista assieme ad altri, compreso Mattarella.
Non è proprio un esercizio di stile confondere in un parterre di quirinabili chi
siede al Quirinale”.
Davanti al collasso delle
“scorze” politiche, il discorso si è chiuso. Dal basso del Parlamento (“Hic sunt
peones”), è partito un prorompente “ci avete rotto er cazzo” alla giostra di
Casellati, Casini, Nordio, Cassese, Frattini, Belloni, Massolo etc. messa in
scena dal capocomico Salvini in combutta con i Conte e le Meloni.
E Letta cambia musica. «La
strategia del Pd –racconterà a cose fatte Debora Serracchiani a Maria Latella a
radio24 – è stata far salire i voti per il presidente Mattarella,
quotidianamente, a ogni votazione, e lo abbiamo fatto con maggior evidenza
quando si è trattato di votare per la presidente del Senato Casellati» (Iacoboni
su “La Stampa”).
E’ solo a quel punto che parte
la mediazione di Draghi: “…le telefonate a Berlusconi, ai due Letta (Enrico e
Gianni), a Salvini e a Conte, infine il faccia a faccia decisivo. Mezz' ora è
durato il colloquio tra Draghi e Mattarella, al quale il premier ha confidato
l'angoscia per la «situazione grave» determinata dall'impazzimento dei partiti:
«Per la stabilità del Paese e per rassicurare l'opinione pubblica è necessario
restare» (Monica Guerzoni, Corriere).
Quei circa 400 voti spontanei
a Mattarella hanno convinto i leader vari e avariati a dare, sottobanco, il via
libera ai loro parlamentari di votare il bis della Mummia Sicula. In maniera
esplicita non potevano farlo perché c’è un percorso istituzionale da seguire.
Infatti al Quirinale si sono presentati non i leader ma i capigruppo in
rappresentanza dei parlamentari.
Ancora. Non è vero che tutto,
in modalità ‘’Gattopardo’’, rimane come prima. Draghi e il Bis-presidente si
sono rassicurati a vicenda: io resto se tu resti. Ma il premier sa benissimo che
pagherà la sua improvvida autocandidatura e da domani, quando presiederà il
primo Consiglio dei ministri post-Colle, sarà più debole. Ma non finirà
prigioniero dei partiti che non lo hanno voluto al Colle: perchè da SuperMario
passeremo a SuperSergio.
Sarà il Siculo a dare forza,
protezione e indirizzo all’esecutivo draghiano. E’ il solo che adesso può
intimare “mi avete voluto di nuovo e ora fate quello che vi dico io” a quella
banda di scappati di casa che fino a ieri erano tutti d'accordo solo su una
cosa: mai un secondo incarico al capo dello Stato uscente. Ora il pugno di
Mattarella sarà durissimo e se prima potevano alzare un ditino adesso dovranno
solo chinare la testa e assecondare SuperSergio senza proferire verbo. E per la
gioia di Draghi, la Mummia Sicula sta a pallettoni e ha già chiarito: ‘’La mia
non sarà una presidenza a tempo’’.
Mario Draghi, i tre
"infiltrati" nei partiti che hanno fallito: perché non è arrivato al Quirinale.
Libero
Quotidiano il 30 gennaio 2022.
La voce su Mario Draghi e sul
suo desiderio di approdare al Quirinale per il post Mattarella si era diffusa
ben prima dell'inizio delle votazioni. E pur non essendoci mai stata nessuna
conferma da parte del presidente del Consiglio, tranne una frase sibillina -
"sono un nonno al servizio delle istituzioni" -, in molti hanno finito per
crederci. Stando a un retroscena del Giornale, il premier si sarebbe avvalso
addirittura di un "tridente d'oro" per conquistare il Colle: tre ministri
"infiltrati" nei partiti che potessero fargli da trampolino di lancio. Di chi si
trattava? Giancarlo Giorgetti nella Lega, Lorenzo Guerini nel Pd e Luigi Di
Maio, il più governista all'interno del M5s.
I tre ministri, però, non sono
riusciti nell'impresa, visto che alla fine l'assemblea ha deciso di tornare
sulla figura di Sergio Mattarella. Secondo Pasquale Napolitano del Giornale, i
fedeli di Draghi avrebbero lavorato per mesi per consentire il trasloco dell'ex
banchiere al Quirinale. La strada, però, si sarebbe rivelata difficile fin
dall'inizio, con lo stesso Draghi che alla fine ha mediato per il Mattarella
bis. Quand'è che sarebbe iniziata la partita del premier per arrivare al
Colle? Un anno fa, dopo l'approdo a Palazzo Chigi. Draghi avrebbe pensato di
poter fare un anno di governo prima del salto.
"Lo sponsor numero uno, per
l’operazione Draghi, è stato, fin dall’inizio, il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti", scrive il Giornale. Di Maio invece sarebbe
stato arruolato nel fronte pro Draghi il 21 dicembre scorso, alla conferenza
degli ambasciatori, quando il premier stesso pronunciò parole di apprezzamento
nei suoi confronti. Sia Giorgetti che Di Maio, però, si sono dovuti scontrare
con i "no" dei loro leader. Uguale Guerini, che avrebbe combattuto contro le
resistenze non solo di Letta, ma anche di Dario Franceschini e Andrea Orlando.
Infine, a mettere definitivamente un punto al suo sogno sono stati anche e
soprattutto l'incertezza sul governo e l'incubo delle elezioni anticipate.
I moribondi di Montecitorio
costretti a rieleggere il Civil servant Sergio Mattarella.
PARIDE LEPORACE su Il
Quotidiano del Sud il 29 Gennaio 2022.
Sergio Mattarella, un civil
servant nel senso più ampio del termine. Nonostante le 14 dichiarazioni con le
quali ha ribadito di non voler essere rieletto, i moribondi di Montecitorio sono
stati costretti a chiedergli di tornare al Quirinale per tenere in piedi un
sistema che oggi si regge tra il riconoscimento internazionale di Mario Draghi e
quello di un presidente chiamato per forza di causa a salvare lo stellone della
Repubblica.
Un’ipotesi che avevamo già
ipotizzato in occasione dell’ottantesimo compleanno del capo dello Stato, nel
luglio del 2021. Modalità simili alla rielezione di Giorgio Napoletano, a
riprova che la crisi di sistema italiano viene da lontano. Mattarella, già
quando fu eletto la prima volta, si comprendeva che sarebbe stato un arbitro
imparziale della infinita emergenza italiana.
Un monaco bianco di
provenienza Dc. Impacciato all’inizio del mandato nel suo essere poco mediatico
con lo zoppicare parole e pause mentre leggeva il messaggio agli italiani a
Capodanno. Con il passare del tempo ha conquistato la fiducia degli italiani
come un novello Pertini.
Tutti con Mattarella, anche
quei Cinquestelle che con Di Maio ne avevano chiesto l’impeachment. Dopo due
anni il leader grillino ha dovuto ammettere di aver sbagliato. Mattarella centro
di gravità permanente. Anche quando ha risolto la crisi diplomatica con la
Francia provocata dai Giamburrasca Di Maio e Di Battista solidali con i gilet
gialli.
È stato lui a mettere l’Italia
nelle sicure mani di Mario Draghi conquistando nuovi consensi per Quirinale e
Palazzo Chigi e il dissenso di rumorose minoranze. I moribondi di Montecitorio
volevano disfarsi, sono stati costretti a tornare da Mattarella e Draghi.
Sergio cuore d’acciaio contro
Boris Johnson che all’esplodere della pandemia giustificava il numero maggiore
dei contagi del Regno Unito rispetto all’Italia perché popolo che non può essere
costretto a ubbidire “in modo uniforme perché amiamo la libertà”. E il
presidente Mattarella rispose: “Anche noi italiani amiamo la libertà”.
Indimenticabile icona di tutti
gli italiani il 25 aprile 2020, da solo all’Altare della Patria nel pieno della
pandemia. Il fuori onda dal suo barbiere in quei giorni drammatici lo elesse
amico di tutti. Di moltissimi ragazzi che si scatenarono con i meme.
Primo presidente della
Repubblica siciliano. Uno cresciuto a pane e politica. Figlio di Bernardo,
perenne ministro discepolo di De Gasperi. Uno tirato per la giacca da Pisciotta
e cresciuto elettoralmente nel feudo mafioso di Castellamare del Golfo, patria
di Cosa Nostra. Danilo Dolci, pacifista, presenterà dossier contro di lui
ricavandone una condanna per diffamazione. Ben altro percorso quello di
Piersanti, il fratello di Sergio. Morirà nelle sue braccia ucciso dal piombo
della Cupola. Il presidente della Regione Sicilia si era messo a scrutare
appalti e a chiedere conto a Roma. Sergio il professore in conseguenza di quella
morte violenta ne eredita l’impegno. Sarà lui a determinare il successo di
Leoluca Orlando nella trincea di Palermo.
Sergio Mattarella è da sempre
figura istituzionale di altissimo prestigio. Ciriaco De Mita gli affida compiti
di pulizia i in Sicilia e anche a Reggio Calabria. Non era personaggio da
politica spettacolo. Parlamentare serio e rigoroso. E’ ministro nel 1990 nella
Prima Repubblica.
In quel caldo agosto per le tv
di Berlusconi la sinistra Dc segna un dato storico nell’album di famiglia che la
contrapporrà alla destra prossima ventura. Cinque ministri del governo si
dimettono. Sergio Mattarella lascia insieme a Misasi, Mannino, Martinazzoli e
Fracanzani. Pattuglia diversissima per antropologia politica ma con uomini
compatti nell’attuare un clamoroso gesto molto raro nel Palazzo italiano. Ferita
ormai rimarginata anche per i berluscones dei giorni nostri.
Mattarella ha una coerente
storia politica. Sartori battezzò Mattarellum la legge elettorale da lui
concepita, quella che con i collegi ha dato dignità al popolo elettore. Combatte
Buttiglione, apre all’Ulivo, fonda il Partito Democratico. Ha grandi intese con
D’Alema come suo ministro e vicepresidente. Abolisce la naia obbligatoria e
determina la scelta militare per il Kosovo. Come ministro dell’Istruzione ha
introdotto i tre maestri alla scuola elementare. Poi si rinchiude alla Corte
Costituzionale non rilasciando mai una dichiarazione.
Un Cincinnato chiamato per due
volte al Colle senza nessun suo strepito personale. L’ultimo trionfo a Wembley
per la finale agli europei. Mattarella che esulta ai rigori vincenti ed entra
nella storia dell’immaginario collettivo come Pertini al Bernabeu. Come
calabresi siamo molto grati al Presidente anche per aver scelto l’Istituto
Nautico di Pizzo come sede dell’inaugurazione dell’anno scolastico in corso.
Sergio Mattarella ora resterà al Colle per altri sette anni. I moribondi di
Montecitorio non potevano altro che consegnarsi nelle sue mani e in quelle di
superMario Draghi. L’anno prossimo gestirà delle complicate elezioni politiche.
Buon lavoro presidente. Il presidente di tutti.
Premier spendaccione,
Draghi ci costa più di Conte.
Francesco Storace su Il Tempo
il 31 gennaio 2022.
Nascondete all’Europa le spese
di Mario Draghi. C’è il rischio che si accorgano che per il personale in
servizio presso la Presidenza del Consiglio si dilapidano più quattrini che al
tempo di Giuseppe Conte. Ci costa un botto. C’è una tabella che suscita qualche
impressione rispetto al cosiddetto processo riformatore e allo snellimento della
Pubblica Amministrazione. Nel 2020 lo stanziamento per il personale in servizio
per i dipendenti della presidenza del Consiglio era di circa 212 milioni di
euro, simile quello per il 2021, balzato a ben 236 milioni e spicci per il 2022.
La manovra di bilancio di Palazzo Chigi ha beneficiato anzitutto i suoi
inquilini. Si potranno pagare più comodamente le bollette che capitombolano tra
capo e collo di famiglie e imprese, come se fossero una specie di ristori per
chi lavora con SuperMario prescindendo da quello che si fa, sia in ufficio che a
casa propria.
Non è esattamente la sorpresa
che ci si aspettava da un premier che voleva salire addirittura al Quirinale. Il
«funzionamento» di Palazzo Chigi ora arriva in totale a più di 266 milioni di
euro. Saranno felici collaboratori, esperti, pupilli vari. Si parla di 150 unità
in più. Un altro milione e seicentomila euro è previsto per il personale non
dirigenziale. «Risparmieremo» poco meno di 400.000 euro per le retribuzioni dei
ministri e sottosegretari semplicemente perché c’è un numero minore di esponenti
del governo non parlamentari, mica per generosità. L’unico a non costarci – va
detto – è proprio Draghi che ha rinunciato all’indennità di carica prevista per
i membri del governo non parlamentari. Oltre 4 milioni e mezzo di euro, con i
relativi oneri pari a circa un milione e mezzo di euro, sono stanziati per il
trattamento economico accessorio per il personale. Arrivano 150 unità – rende
noto la relazione – in seguito a procedure di mobilità, più un dipendente
proveniente dalla Croce Rossa e altri 15 appartenenti alle categorie protette.
Ancora: «Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione delle
autorità politiche sono pari ad euro 18.870.291». Nel 2021 erano pari a 16
milioni, l’aumento è consistente, oltre due milioni di euro. Sarà interessante
conoscere dal premier a chi va tanto bottino tra gli staff delle cosiddette
autorità politiche. Le previsioni di spesa sono state effettuate considerando «i
costi effettivi derivanti dagli incarichi già attribuiti nell’ambito delle
strutture di diretta collaborazione» e dai «costi teorici, previsti dai decreti
di organizzazione delle medesime strutture, per gli incarichi non ancora
conferiti». Quindi, più strutture, più personale, più soldi da spendere. Alla
faccia della riduzione dei quattrini...
2.684.000 euro spesi nel 2021
per il personale di diretta collaborazione del premier e del sottosegretario
alla presidenza salgono di 159mila euro, impennandosi a 2.844.000 circa. Per
quello dei ministri senza portafoglio si passa dai 4.687.000 euro del 2021 ad
una previsione maggiorata di ben 746.000 per il 2022. Per il personale di ruolo
l’aumento delle retribuzioni aumenta da 100 milioni a 114. Quasi un milione in
più per gli oneri riflessi. Aumenta anche la spesa per il personale assegnato
alle cosiddette strutture di missione: circa cinque milioni e mezzo con un
aumento di oltre un milione rispetto allo scorso anno, il 20 per cento in più.
Draghi sia lodato. L’attenuante, in questo caso, è legata alla finalizzazione
dello stanziamento per la segreteria tecnica per le politiche in materia di
disabilità e all’istituzione delle strutture dedicate all’attuazione del Pnrr.
Il vocabolario è psicosovietico però: segreteria tecnica del Pnrr, unità per la
razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. Non oseremo avventurarci
nel consuntivo... Le cifre offrono ulteriori elementi di riflessione, a leggerle
tutte. Quel che colpisce è l’assenza di consapevolezza del momento che vive il
Paese. Non vogliamo certo deprimere il lavoro che svolgono gli uffici di Palazzo
Chigi, spesso in grado di risolvere i problemi più complessi, ma tutto questo in
tempi comunque difficili per il popolo italiano appare difficilmente
comprensibile. La pubblica opinione magari vorrà capire meglio dal governo, dal
suo premier, il perché di tutti gli aumenti elargiti da SuperMario a chi lavora
al suo fianco. Chi non ha questa «fortuna» non merita, evidentemente,
altrettanta generosità.
L'ITALIA DA COMPARSA A
PROTAGONISTA.
LA DOPPIA GUERRA MILITARE E ECONOMICA - I due segnali forti a
Putin dell'Europa di Draghi, Macron e Scholz. ROBERTO NAPOLETANO su Il
Quotidiano del Sud il 16 giugno 2022.
Il primo segnale è che
l’Europa è unita. Il secondo è che c’è una troika che guida l’Europa costituita
dai capi (Scholz e Macron) delle due potenze più rilevanti che sono Germania e
Francia e da un terzo (Draghi) che è un tecnico che ha qualcosa da insegnare a
tutti e governa oggi il terzo Paese fondatore (l’Italia) indebolito dalla sua
ventennale caduta di peso economico e politico. Altrimenti l’Italia non sarebbe
stata lì con Germania e Francia, addirittura con ruolo di primo attore, a dire
tutti insieme che vogliono l’Ucraina in Europa e, come Draghi ha sostenuto prima
di tutti, che vogliono che acquisisca da subito lo status di candidato
all’ingresso nell’Unione europea. Per la prima volta l’Europa sta cercando una
sua nuova guida non solo in un gioco combinato ristrettissimo di potenza
economica degli Stati, ma anche di peso delle persone che nel caso di Draghi è
il ruolo svolto con maestria alla guida della Bce che lo accredita oggi da
premier italiano come un leader istituzionale del sistema europeo. Per questo su
gas, grano e mercati l’Europa alla fine presterà ascolto a Draghi così come in
Italia le riforme vanno comunque avanti
L’Europa ha dato due segnali
forti nella giornata di ieri con Draghi, Macron e Scholz che incontrano Zelensky
a Kiev davanti agli orrori di Irpin e parlando tutti insieme il linguaggio della
pace. Il primo segnale è che l’Europa è unita. Il secondo segnale è che c’è una
troika che guida l’Europa costituita dai capi (Scholz e Macron) delle due
potenze più rilevanti che sono Germania e Francia e da un terzo (Draghi) che è
un tecnico che ha qualcosa da insegnare a tutti e governa oggi il terzo Paese
fondatore (l’Italia) indebolito in tutti i campi dalla sua ventennale caduta di
peso economico e politico. Come dimostra la tradizione bilaterale
franco-tedesca, consolidatasi in quest’ultimo ventennio, di direzione strategica
esclusiva delle grandi questioni e dei grandi appuntamenti europei con
occasionali, rarissime eccezioni.
Con tutto il rispetto per
Conte, che come premier non ha fatto male, se c’era ancora lui, l’Italia non
sarebbe stata lì con Germania e Francia, addirittura con ruolo di primo attore,
a dire tutti insieme con la Romania che vogliono l’Ucraina in Europa e, come
Draghi ha sostenuto prima di tutti, che vogliono che acquisisca da subito lo
status di candidato all’ingresso nell’Unione europea. A ribadire che il mondo è
con l’Ucraina e con la “resistenza eroica” del suo popolo. Che i valori della
resistenza Ucraina sono i valori della democrazia europea e sono, dunque, i
valori fondanti della comunità occidentale. Che nel momento in cui la storia
chiede agli uomini di Stato scelte impegnative che decidono il futuro dei loro
popoli, i capi di governo italiano e, a seguire, francese e tedesco si sono
schierati dalla parte giusta.
Che è quella della democrazia
contro l’autocrazia. Che è quella del conflitto di civiltà che senza una presa
di coscienza collettiva può portare l’Occidente al suo suicidio e consegnare le
chiavi del mondo a un domino autocratico di fatto già esistente ancorché
disomogeneo e diviso al suo interno. Che vuol dire dare agli ucraini le armi per
difendersi e costruire la pace che non può non essere la pace che lo Stato
aggredito vuole, non quella voluta dallo Stato aggressore. Perché altrimenti il
conflitto di civiltà segna la sconfitta di chi ha ragione e la vittoria cupa di
chi ha torto.
Tutto questo e molto altro
significa la giornata di ieri che chiede alla coscienza mondiale di fare i conti
senza ipocrisie con le atrocità russe sgomberando il campo da presunte
resistenze tedesche e ponendo l’Europa di fronte alle sue responsabilità nel
grande gioco delle materie prime energetiche e agricole che sono l’altra faccia
dei carri armati russi e di cui parleremo bene dopo.
Quello che non può sfuggire
agli osservatori esterni e interni purché in buona fede è che per la prima volta
l’Europa sta cercando una sua nuova guida non solo in un gioco combinato
ristrettissimo di potenza economica degli Stati, ma anche di peso delle persone
se ti rendi conto che di quella persona hai bisogno anche se si trova alla guida
di un Paese che le due potenze economiche storiche dell’Europa non ritengono, di
certo sbagliando almeno potenzialmente, alla loro altezza in questo momento e
che invece lo ridiventa a tutti gli effetti ripercorrendo di fatto la stagione
fondatrice che vedeva insieme Monnet, Adenauer e De Gasperi. Erano tutti e tre
uomini di confine, ma erano dichiaratamente e orgogliosamente uno francese, uno
tedesco, uno italiano. Parliamo di settanta anni fa.
Risuccede oggi dopo un periodo
così lungo, guarda caso, perché alla guida dell’esecutivo italiano c’è un
tecnico accreditato dal suo ruolo europeo reale svolto con maestria assoluta per
otto anni alla guida della Banca centrale europea, che era e resta il ruolo
europeo più importante oggi ancora più riconoscibile con la vistosa differenza
di autorevolezza e incisività che emerge giorno dopo giorno tra chi lo esercita
oggi (Lagarde) e chi lo ha esercitato prima di lei (Draghi). Tutto questo,
perdonateci, per cercare di spiegare perché il tecnico italiano vale
politicamente tantissimo anche se tutti o quasi i politici italiani non hanno
capito niente e gli sputano addosso con la consueta inelegante faciloneria. Non
hanno capito che questo non è un capo-partito e, tanto meno, aspirante, ma è ed
è visto e apprezzato nel mondo per le qualità di un uomo che si è accreditato
come un leader istituzionale del sistema europeo.
Se fosse rimasto il direttore
generale del Tesoro ed il governatore della Banca d’Italia o anche l’apprezzato
presidente del Financial Stability board, Draghi non avrebbe potuto esercitare
in Europa e nel grande scacchiere globale dove si gioca la partita del nuovo
ordine mondiale il ruolo politico che esercita. Anche da Presidente del
Consiglio italiano, purtroppo, sarebbe stato così. Sono stati il ruolo di
presidente della Bce e il riconoscimento mondiale dell’azione svolta di
salvatore dell’euro che legittimano questo ruolo internazionale del Draghi di
oggi. Paradossalmente sono la sua credibilità personale e la debolezza
strutturale italiana ricevuta in eredità che giocano entrambe a suo favore.
Perché non deve fare una
politica di potenza, come devono fare tedeschi e francesi che alcuni temono e
altri desiderano, ma può mettere la sua conoscenza dei meccanismi internazionali
e un patrimonio di competenza che uniti a oggettiva intelligenza politica
rendono la bandiera italiana una stella nel firmamento politico del nuovo corso
europeo che dovrà contribuire alla definizione degli equilibri del nuovo ordine
mondiale. Vedete quando la Russia sostiene che, siccome ci sono le sanzioni
messe dall’Occidente, mancano pezzi di componenti e sono costretti a ridurre le
forniture di gas di due terzi alla Germania e in misura minore ma significativa
all’Italia, è evidente a tutti che sono penose bugie e che c’è un uso politico
del gas, e a quel punto acquisisce naturalmente la forza di leadership politica
europea la proposta lanciata da Mario Draghi in tempi non sospetti di fare
cartello e porre un tetto europeo al prezzo del gas russo che si è scontrata con
le miope resistenze tedesche e quelle pelose olandesi.
Hanno ottenuto il capolavoro
che le forniture sono diminuite e la Russia incassa di più perché diminuendo i
flussi i prezzi volano alle stelle, ieri si è arrivati fino a 148 euro a
megawattora dagli ottanta delle ultime settimane e i venti di prima di Covid e
guerra. È ovvio che, in questo contesto, al prossimo Consiglio europeo la
proposta Draghi acquisisce molta più forza e tutti hanno modo di afferrarne la
capacità tecnica di anticipare le cose. Quella stessa capacità tecnica che è
servita per fare le uniche sanzioni che hanno fatto molto male all’economia
russa e hanno riguardato il congelamento delle riserve estere della sua banca
centrale. Sono tutte capacità tecniche che rivelano l’intelligenza politica di
Draghi e danno peso politico all’Italia.
Come si fa a non notare, se si
è in buona fede, che è stato Draghi il primo leader europeo a porre con forza il
tema urgente di sminare i porti ucraini e di mettere in campo la risoluzione
delle Nazioni Unite per evitare il dramma di una carestia mondiale e la fame del
popolo africano? Che è stato il primo ad annunciare che formalizzerà la
richiesta al rappresentante delle Nazioni Unite al prossimo G7? Perché c’è
consapevolezza che il tempo stringe e non ci sono più di due settimane a
disposizione per evitare che il raccolto di grano vada disperso.
Quando Draghi non commenta le
scelte di politica monetaria della BCE perché ha speso otto anni della sua vita
a difenderne l’indipendenza dai commenti dei politici, ma ti fa una brevissima
lezione sulla differenza tra l’inflazione americana e quella europea che vuol
dire tutto si percepisce il peso politico di quella competenza operativa di cui
hanno vitale bisogno oggi l’Europa quanto l’Italia.
Che è quella per cui l’Italia
torna alla guida di una nuova Europa che vuole tornare ad essere protagonista
nel conflitto in corso e dentro la nuova globalizzazione per cui anche i
tedeschi hanno fornito e forniranno armi all’Ucraina. Per cui sulla politica
monetaria ci possono essere sbandamenti di leadership, ma la politica richiama
tutti alla realtà che esige di combattere il rischio di frammentazione se si
vuole combattere davvero il mostro inflazione. Per cui al ricatto energetico e
agricolo dei russi si saprà rispondere partendo da chi ne capisce e ha tracciato
la rotta mentre tutti si nascondevano. L’Europa finalmente esiste sui campi di
battaglia militari e su quelli della pace e, forse, anche per questo, è ripreso
il dialogo tra Usa e Cina e la telefonata di Xi Jinping a Putin si muove nella
direzione della pace o del cessate il fuoco, non della guerra lunga.
Noi riteniamo che
l’intelligenza politica di Draghi di cui vi abbiamo raccontato genesi e
espressione possa e debba essere messa a frutto con l’esperienza del governo di
unità nazionale. Ogni processo riformistico all’inizio è incompleto, ma proprio
l’esperienza storica dei governi De Gasperi del Dopoguerra a cui quello di
Draghi di oggi molto assomiglia ci dimostra che in politica ciò che conta è
iniziare. Anche l’ultima delle riforme della giustizia della Cartabia da ieri è
legge e questo significa che il cammino sulla strada del riassetto strutturale
del Paese sta proseguendo. Le riforme dei Paesi seri non si fanno in un colpo
solo, quelli vanno bene per i comizi o per il cabaret, ma avviando dei processi
che poi vengono implementati. Questo hanno fatto le grandi democrazie
occidentali ogni volta che hanno cambiato segno e passo alle loro economie.
La qualità dell'informazione è
un bene assoluto, che richiede impegno, dedizione, sacrificio. Il Quotidiano del
Sud è il prodotto di questo tipo di lavoro corale che ci assorbe ogni giorno con
il massimo di passione e di competenza possibili.
Abbiamo un bene prezioso che
difendiamo ogni giorno e che ogni giorno voi potete verificare. Questo bene
prezioso si chiama libertà. Abbiamo una bandiera che non intendiamo ammainare.
Questa bandiera è quella di un Mezzogiorno mai supino che reclama i diritti
calpestati ma conosce e adempie ai suoi doveri.
Un’altra Italia. La fortuna
di avere uno come Draghi che sa governare nonostante gli italiani.
Iuri Maria Prado su
L'Inkiesta il 18 Giugno 2022
Lasciati a noi stessi siamo
brutta gente, vigliacchi, fortemente e prontamente proclivi ad accettare che la
libertà, il diritto, la vita altrui siano spazzati via dall’aguzzino di turno.
Questo è il nostro paese e il presidente del Consiglio ha il merito di saperlo
guidare nonostante tutto
Evidentemente c’era bisogno di
un “vile affarista”, di un servitore dello Stato imperialista delle
multinazionali, di un guerrafondaio neanche troppo ripulito, per impedire che
l’Italia si dimostrasse per quel che è profondamente e per quel che avrebbe una
voglia matta di poter rivendicare sé quel sabotatore non glielo impedisse: e
cioè niente di meno e niente di meglio che uno Stato-canaglia.
L’ignominia italiana del
secolo scorso, mai veramente riconosciuta né condannata, mai fatta oggetto del
rendiconto che ne avrebbe permesso una dignitosa digestione civile, e invece
rinnegata e assolta dall’enorme bugia del Paese che per vigore e convinzione
propri ritrovava la luce, si squaderna dopo ottant’anni in una perfettissima
reiterazione identitaria.
Lasciati a noi stessi siamo
brutta gente, vigliacchi, fortemente e prontamente proclivi ad accettare che la
libertà, il diritto, la vita altrui siano spazzati via dall’aguzzino per il
quale nemmeno soltanto indifferenza proviamo, ma in profundo ammirazione e brama
quasi orgasmica di assoggettamento.
È solo consolante, ma
fuorviante, obiettare che un’altra Italia starebbe facendo mostra di non
appartenere a quella rinnovata tradizione di vergogna civile e di moralità
ammaccata, perché in questo modo – sia pure a comprensibili fini profilattici e
di auto-conservazione, perché c’è da starne male, da disperarsene, da morirne –
in questo modo si rinuncia a guardare in faccia la verità del male, che non è
meno nostra e di cui non siamo meno responsabili giusto perché non siamo noi a
farla vera.
L’Italia che gira la faccia
dall’altra parte non solo mentre si scrivono, ma anche quando si mettono in
attuazione le leggi razziali, si è sviluppata in quella che oggi fa persino
peggio quando scopre qualche ragione di fondatezza dell’operazione speciale,
qualche sia pur vago motivo di comprensibilità dell’aggressione e – questo è il
culmine dell’oscenità – qualche oggettiva responsabilità di chi la subisce.
Senza far nulla, o quanto meno
senza fare abbastanza, noi stiamo accettando che passi ancora una volta una
versione contraffatta di ciò che siamo, in particolare facendo credere
innanzitutto a noi stessi, per quel fine auto-protettivo, che si tratti tutt’al
più del negazionismo di qualche menestrello in malversazione accademica, di
qualche malvissuto sindacalista, di qualche impresentabile da comizio
Rosario&Ruspa, col supplemento indulgente secondo cui il problema non sono
neppure loro ma quelli che li invitano e gli danno spazio.
Ma non è così e non è questo.
Perché quelli non usurpano, sfigurandola, l’immagine del Paese: quelli, tutti,
la rappresentano fedelmente. Non si dica che il Paese si merita questa gente,
perché anche questo è dopotutto assolutorio: il Paese “è” questa gente.
Mario Draghi sta governando
contro il proprio Paese, ed è un merito incommensurabile.
Da lospiffero.com il 30
gennaio 2022.
“Sette anni fa ero qui per
l’elezione di Mattarella e adesso sono di nuovo qui a votare Mattarella, non ho
capito cosa sia successo nel frattempo”. Uno sconsolato Stefano Allasia, nel
frattempo da deputato di lungo corso della Lega è diventato il presidente del
consiglio regionale e come tale vagola da grande elettore in Transatlantico con
il rovello.
Ma, forse, più che chiedersi
cosa è successo, lui come gli altri suoi compagni di partito si chiede cosa
succederà. L’implosione del centrodestra, nel Romanzo Quirinale dal finale
copia-incolla diventa psicodramma nel partito di Matteo Salvini aspirante king
maker finito, dopo l’ennesimo inciampo, col timbro della “cultura istituzionale
di un gormito”, come da velenosa definizione di Matteo Renzi.
Lui, il Capitano, dice di aver
“peccato di sincerità e generosità”, non propriamente le doti di un grande
manovratore, ruolo che adesso molti dei suoi non gli perdonano di aver svolto
nella maniera più improvvisata e sconclusionata possibile, ma senza manlevare
responsabilità pure del suo stato maggiore.
E qui, la pattuglia di grandi
elettori leghisti calata dal Piemonte con baldanza ripiega in una Caporetto dove
certo non riconosce ardimentose gesta al suo comandante, nel caso di specie
anche (e vi par poco) capogruppo alla Camera. “Mai una riunione, lunedì
addirittura siamo andati a votare solo con un sms”.
Nelle chat spesso non viene
neppure citato, intanto è implicito di parli di lui, Riccardo Molinari, per anni
uomo ombra di Matteo in Piemonte e non solo, adesso nell’8 settembre di coloro
che furono lumbard, ombra quasi invisibile durante la settimana di tregenda
conclusasi ieri sera con il ritorno al passato che tormenta il povero Allasia.
Al loro presidente non pochi
deputati piemontesi, ma con loro anche qualche senatore, imputano una
“latitanza” sottolineate pure da qualche parlamentare del centro-sud addirittura
invidioso dell’attenzione che avrebbe riservato più ai piemontesi e ai lombardi,
aggiungendo velenoso, per via della fidanzata (la deputata Rebecca Frassini), a
conferma che quando la pelle brucia scappa pure un colpo sotto la cintura.
Brucia nel corpaccione
parlamentare leghista quella corsa senza freni contro il muro di Matteo che,
forse chissà, s’interrogano, Riccardo avrebbe potuto rallentare. “Ma va, sempre
muto”, viaggia in chat l’indiretta risposta.
“In casa Lega non ci sarà
mezza fibrillazione” assicura da Porta a Porta Salvini, ma tra i suoi si
chiedono se ci crede, almeno lui. Rientrata la voce di possibili dimissioni di
Giancarlo Giorgetti, resta il segnale lanciato dal ministro a Mario Draghi, ma
da molti interpretato come l’ennesima segnatura della differenza tra lui e il
segretario, non ultima proprio quella sul premier al Colle, ipotesi che sarebbe
stata assai gradita all’eminenza grigia della Lega, decisamente meno al Capo.
C’è chi tra i parlamentari
della regione che esprime il capogruppo (ben guardatosi dall’esprimersi troppo
in questi giorni) la butta giù pesante parlando, sia pure sottovoce, di “resa
dei conti” lasciando da capire se in generale o restringendo il campo ai confini
di pertinenza. “Comunque dopo questa brillante prova di Matteo nessuno potrà più
lamentarsi delle gesta dei nostri vari Preioni”, commenta al vetriolo un
parlamentare riferendosi al capogruppo leghista a Palazzo Lascaris, Alberto
Preioni, non propriamente un fulmine di guerra nelle trattative politiche.
“Anche il centrodestra al suo
interno ha perso pezzi”, ammette Salvini, ma subito precisa: “Non la Lega”. E
però ci sono quei 37 voti più del previsto presi dall’ex magistrato Carlo
Nordio, candidato di Fratelli d’Italia che nessuno può escludere, almeno in
parte, arrivino proprio da forti mal di pancia leghisti e partano come segnali
verso Giorgia Meloni che potrebbe continuare a drenare non solo voti, ma anche
parlamentari dall’alleato, si fa per dire. C’è chi parla di “feroci pizzini”
indirizzati proprio a Salvini. Altro motivo di allarme, anche in un Piemonte
dove i rapporti tra Lega e Fdi non sono certo idilliaci, come testimoniato dalle
tensioni non rare nel governo della Regione e come altre situazioni da oggi in
avanti potrebbero ulteriormente confermare.
“Non possiamo fare regali al
Pd” diceva Molinari una settimana fa. Venerdì sera mentre Salvini (e con lui
Giuseppe Conte) annunciava coram populo di lavorare per un presidente donna, “in
gamba”, il capogruppo spiegava che “quello di Elisabetta Belloni è un nome che
sta uscendo dai vari incontri e di cui si parla ma non c’è ancora nessun accordo
chiuso”. Nel frattempo onorevoli e senatori cercavano di capire, addormentandosi
con l’idea di votare il capo dei Servizi e risvegliandosi con la foto di
Mattarella sul comodino.
Salvini era partito col
mandato di arrivare a un presidente d’area ed è finito per sposare il bis di
Mattarella. L’impressione è che alla fine sia andata come pronosticato
ventiquattr’ore prima da Umberto Bossi, “Salvini andrà a ruota di Berlusconi”,
prevedendo un Mattarella bis. Magra consolazione l’avverarsi della profezia del
Senatur per chi ancora deve ingoiare “la balla della sala capiente che non si
trovava”, a giustificazione di quegli incontri non fatti dal capogruppo mentre
tutto veniva giù. E Allasia che si chiedeva cos’era successo in questi sette
anni. Cosa succederà da domani.
Quirinale, Alessandro
Sallusti: centrodestra, un imbarazzante disastro. Era tutto chiaro già da
martedì...Alessandro
Sallusti su Libero Quotidiano il 30 gennaio 2022
Chi più e chi meno, alla fine
tutti tranne Giorgia Meloni, hanno calato le brache e addio nuovo Presidente
della Repubblica, tanto più un primo presidente non di sinistra. Ci avevamo
creduto e in questi giorni non lo abbiamo nascosto anche se, ora dopo ora, era
chiaro che i giocatori in campo, pur impegnandosi, non erano in grado per
mancanza di esperienza e in parte di numeri di raggiungere l'obiettivo.
All'ultimo, un po' tutti, proprio in zona Cesarini come si dice nel calcio,
hanno preferito - grazie a un intervento su Salvini di Silvio Berlusconi al
quale perdere non è mai piaciuto - un pareggio a una sconfitta.
Bene, ma a che prezzo per il
Centrodestra? Sul terreno sono stati sacrificati sei illustri rappresentanti
della classe dirigente (Pera, Moratti, Nordio, Frattini, Belloni, Cassese) la
cui credibilità è stata bruciata in cambio del nulla, a terra resta la
presidente del Senato, Elisabetta Casellati, azzoppata e ridicolizzata vittima
un po' di se stessa e un po' di chi l'ha illusa. Ecco, non era questo lo
scenario che ci eravamo immaginati. Siamo onesti: è stato un disastro, non tanto
per il risultato finale a quel punto inevitabile, ma per il modo pasticciato e a
tratti imbarazzante con cui ci si è arrivati, tanto valeva per il centrodestra
intestarsi da subito Mattarella o Draghi come era chiaro già da martedì.
Un disastro le cui conseguenze
non saranno indolori. Se fino a ieri Mario Draghi passava per un dittatore
illuminato, da domani è possibile che si comporti da despota, probabilmente un
bene per l'economia meno per la democrazia. Se fino a ieri si poteva immaginare
una proficua collaborazione fra i tre parenti serpenti Meloni, Salvini e
Berlusconi da domani - e chissà per quanto - l'attuale Centrodestra sarà una
coalizione soltanto formalmente.
E infine, se la quarta gamba
del Centrodestra (Toti, Brugnaro e soci) si poteva sperare fosse un sicuro e
leale compagno di viaggio, oggi sappiamo che per loro il Centrodestra è
soprattutto un bus su cui salire solo per essere eletti governatori o sindaci.
Può una coalizione oggi così
messa candidarsi a guidare il Paese? Matteo Salvini avrà ancora la forza e
l'autorevolezza per guidare il centrodestra essendosi giustamente intestato il
comando delle operazioni? Non tocca a noi dare risposte, ma al più presto
qualcuno dovrà darle. Perché il fatto che il ciclone Quirinale abbia travolto
anche e di più sia i Cinque Stelle che la sinistra di Letta, che questa
volta Matteo Renzi si sia perso nei suoi intrighi senza toccare una palla buona
se non per stopparla è una amara consolazione. Auguri di buon lavoro al
presidente Sergio Mattarella. Chissà quante dovrà vederne nei prossimi sette
anni.
I cinque errori di Salvini
sul Quirinale. E quattro consigli non richiesti.
Benedetta Frucci su Il Tempo
il 31 gennaio 2022.
C’è un fattore prepolitico con
cui Matteo Salvini, nella sua battaglia per il Colle, non ha fatto i conti e che
ha determinato, più di altri, la débâcle: la convinzione di una presunta
superiorità morale che attraversa la sinistra dal centro fino ai suoi estremi e
che la porta a non riconoscere mai fino in fondo il valore di chi gioca
nell’altra metà campo. Esiste poi una caratteristica profondamente politica del
centrosinistra: una capacità strategica e tattica, un’intelligenza che ha saputo
dimostrare soprattutto negli ultimi 10 anni, quando è riuscita a governare
sempre pur quando era tecnicamente minoranza nel Paese. È dalla sottovalutazione
prima di tutto dell’avversario, che nasce il primo grande errore del leader
leghista.
Centrosinistra arroccato in
trincea
Il centrosinistra ha dapprima
fatto credere a Matteo Salvini che, sgomberando dal campo il nome di Berlusconi,
l’unica vera fonte di preoccupazione degli avversari, consci delle sue capacità
strategiche e da fantasista che ha dimostrato, concavo e convesso, sempre in
grado di restare in sella nonostante tutto e tutti, avrebbero potuto accordarsi
su un nome. Ha sbagliato a pensare che il problema fosse Silvio Berlusconi, il
divisivo, l’impresentabile e non qualunque nome avesse, anche lontanamente, una
connotazione di centrodestra. Salvini avrebbe dovuto capire che, disponendo di
una maggioranza esigua, le strade percorribili erano due: o farsi kingmaker fin
da subito di un nome apparentemente super partes, come quello di Mario Draghi,
sottraendolo da un lato alla sinistra e dall’altro, distruggendo i piani
elettorali di Giorgia Meloni, accordandosi prima del voto quirinalizio sulla
formazione di un altro esecutivo, oppure portare avanti compatto il nome di
Berlusconi fino al quarto scrutinio per poi lanciare la palla a Letta e mettere
lui nelle condizioni di proporre nomi su cui, a quel punto, il leader leghista
avrebbe potuto esercitare veti.
Tradita la volontà popolare,
Paragone a valanga sul bis di Mattarella
Così non è andata e dopo
Berlusconi, sono cominciati i niet: Frattini il filorusso, la Casellati la
sgrammaticatura istituzionale perché attuale Presidente del Senato- dimenticando
il precedente Fanfani- e via così. Il centrosinistra è rimasto fermo, immobile,
nella trincea, lasciando che Salvini sparasse tutte le cartucce a disposizione.
Ha abbandonato ogni scrupolo, come si fa in guerra, ed è andato dall’attaccare
il centrodestra per l’astensione in terza chiama ad utilizzare senza scuotersi
lo stesso metodo ventiquattrore dopo, per affossare la candidatura di Elisabetta
Casellati. Capolavoro tattico.
Partita giocata sul fronte
sbagliato
Secondo errore: non
distinguere fra la strategia elettorale e quella parlamentare. Salvini ha
parlato troppo con la stampa, pensando di parlare ai suoi elettori, dimenticando
che la partita del Quirinale, quando non si siede comodamente all’opposizione
con una truppa ristretta di parlamentari come Giorgia Meloni, si gioca tutta nei
palazzi. Lo ha fatto con la crisi del governo Conte I, lo ha ripetuto con
l’elezione del Presidente della Repubblica.
Terzo errore: assumere il
ruolo di guida del centrodestra, in una partita difficile da vincere. Quarto
errore: fidarsi degli alleati. Di una Forza Italia in cui la dirigenza è
distante anni luce dai gruppi parlamentari, ancora infuriati per l’uccisione
prematura del leader Silvio Berlusconi. Si racconta che i voti arrivati al
Cavaliere, siano di una piccola truppa di coraggiosi, un segnale alla dirigenza
che li vorrebbe schiacciati sulla Lega, un moto d’orgoglio e di autonomia.
Di una Giorgia Meloni che
aveva, come obiettivo della partita, le elezioni in primis e in secundis,
l’affossamento di Matteo Salvini. Che poi sono in fondo la stessa cosa. Il
giorno dello schianto di Elisabetta Casellati, non a caso, c’era un particolare
attivismo di parlamentari Pd con i meloniani e chissà che qualche siluro non sia
partito proprio da quelle fila.
Di un gruppo, quello di Toti e
Brugnaro, che può sorgere solo se diventa parte di un polo centrista.
Quinto errore: il dialogo con
Conte, leader solo sulla carta di un Movimento balcanizzato, mosso nelle sue
scelte solo dal risentimento.
Errori e sottovalutazioni di
un leader giovane, che ha ancora però cartucce da sparare.
La separazione dalla Meloni
Quattro consigli non
richiesti: abbandoni le velleità sovraniste, lasciando a Giorgia Meloni le sue
posizioni antivacciniste e le urla dal talk show. L’ala di ultradestra è già con
lei e lo dimostra quell’eccesso di voti a Carlo Nordio, per cui si racconta che
la dirigente di Fdi sia stata molto attiva fra le fila dei salviniani no euro.
Si accrediti e comporti come un leader di una destra europea, guardando al
modello gaullista e non a Marine Le Pen o Zemmour; ascolti, insomma, i consigli
di Silvio Berlusconi e si faccia traghettare nel PPE. Infine, giochi d’astuzia:
dia il via libera a una legge proporzionale, rendendo di fatto impossibile a
Giorgia Meloni, qualora risultasse vincitrice delle elezioni, la premiership.
Come? Proponendo che il prossimo parlamento sia un’assemblea costituente che
vari, finalmente, il semipresidenzialismo. Con un governo magari a guida Draghi,
che condannerebbe la sua avversaria a un’opposizione perenne. Non è cattiveria,
ma strategia.
Malumori su Salvini:
"Doveva battersi di più". Gran parte lo difende: ha ottenuto il massimo.
Chiara Giannini il
31 Gennaio 2022 su Il Giornale.
I mal di pancia interni alla
Lega, il giorno dopo l'elezione di Sergio Mattarella nuovamente a capo dello
Stato, sono un dato di fatto.
I mal di pancia interni alla
Lega, il giorno dopo l'elezione di Sergio Mattarella nuovamente a capo dello
Stato, sono un dato di fatto. In molti accusano il segretario Matteo Salvini di
aver ceduto troppo presto, decretando così la crescente delusione negli elettori
del partito che in futuro potrebbe portare a una perdita di consensi. Se
pubblicamente i parlamentari leghisti difendono il Capitano, nelle chat interne
qualche problemino inizia a rilevarsi, con senatori e deputati che lo accusano
di essere «mal consigliato». Da chi? C'è chi ipotizza dal suocero Denis Verdini,
chi ancora da una non meglio definita «vecchia guardia». E qualcuno nelle
retrovie minaccia anche di passare a Fratelli d'Italia. A stemperare gli animi
arriva il fedelissimo Claudio Borghi, che con un video postato su YouTube spiega
senza peli sulla lingua l'accaduto, in sostanza ammettendo anche la sua
arrabbiatura per la scelta di Mattarella, ma chiarendo che Salvini più di così
non poteva fare. Ancora racconta che si è arrivati alla conta dei voti,
dimostrando che mentre i grandi elettori di Lega e Fratelli d'Italia hanno
votato tutti la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, in Forza
Italia si sono smarcati 50 votanti e tra i centristi 20 su 30. Oltre a questo il
rischio che il premier Mario Draghi, impegnato in una campagna di promozione
personale per il Colle, al Quirinale ci andasse davvero. Insomma, impossibile
per Salvini riuscire a vincere la battaglia. E mentre sui social arrivano
insulti da ogni dove, dall'interno del partito del Carroccio una riflessione
sale e in qualche chat si legge: «Per la destra si apre un periodo di profonda
riflessione. Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo?». Se la dirigenza è
compatta intorno al Capitano, lo è forse meno qualche consigliere regionale che
si sfoga sottobanco: «Ok, sarebbe stata dura, ma ci sono presidenti eletti alla
sedicesima votazione, forse Salvini avrebbe dovuto battagliare un po' di più».
Cosa certa è che qualcuno inizia a sposare la proposta del senatore Manuel
Vescovi, che nel 2020 depositò un disegno di legge sul presidenzialismo, che
avrebbe previsto l'elezione del presidente della Repubblica da parte del popolo.
Ma a Pd e 5 stelle non conviene. Perché sanno che continuando su questa strada
si riesce persino a far perdere credibilità a chi si impegna davvero e con
responsabilità per il Paese.
Chiara Giannini. Livornese, ma
nata a Pisa e di adozione romana, classe 1974. Sono convinta che il giornalismo
sia una malattia da cui non si può guarire, ma che si aggrava con il passare del
tempo. Ho iniziato a scrivere a cinque anni e ho solcato la soglia della prima
redazione ben prima della laurea. Inviata di guerra per passione, convinta che i
fatti si possano descrivere solo guardandoli dritti negli occhi. Ho raccontato
l’Afghanistan in tutte le sue sfumature e nel 2014 ho rischiato di perdere la
vita in un attentato sulla Ring Road, tra Herat e Shindand. Alla fine ci sono
tornata 13 volte, perché quando fai parte di una storia non ne esci più. Ho
fatto reportage sulle missioni in Iraq, Libano, Kosovo, il confine
libico-tunisino ai tempi della Primavera araba e della morte di Gheddafi e
sull’addestramento degli astronauti a Star City (Russia). Sono scampata
all’agguato di scafisti a Ben Guerdane, di ritorno da Zarzis, tre le poche a
documentare la partenza del barconi. Ho scritto due libri: “Come la sabbia di
Herat” e l’intervista al leader della Lega, dal titolo “Io sono Matteo Salvini”,
entrambi per Altaforte. Sono convinta che nella vita contino solo due cose: la
verità e la libertà. Vivo per raccontare il mondo, ma è sempre bello, poi,
tornare a casa e prendere in mano un giornale e rileggere il tuo articolo.
"Altri hanno tradito e non
avevo scelte", lo sfogo di Salvini.
Francesco Storace su Il Tempo
il 30 gennaio 2022.
Chissà quante notti in bianco
per arrivare poi a dover dare il suo consenso a Sergio Mattarella. E il giorno
dopo non scappa, non si rifugia in casa ma affronta le telecamere a viso aperto.
Matteo Salvini sente di aver fatto ciò che doveva e poteva fare. Ed è orgoglioso
dei suoi grandi elettori, «deputati e senatori, governatori e delegati
regionali, tutti compatti, davvero una grande squadra». In effetti non è mancato
un solo voto, non c’è stata una sola voce stonata.
Ovviamente ci sarà sempre chi
si cimenta nel tiro al piccione. Come se - ragiona deluso - fosse stato lui a
ordinare a mezzo gruppo parlamentare di Forza Italia di non votare Elisabetta
Casellati. Ma non vuole reagire a muso duro, neppure quando legge le parole di
Giorgia Meloni contro di lui in un momento di indubbia difficoltà politica. «È
un’amica, non commento».
«Ho creduto fino in fondo che
il centrodestra fosse unito graniticamente, ma ho creduto male perché i fatti mi
hanno dato un’altra dimostrazione», racconta il leader della Lega: e fa notare
che «qualcuno nel centrodestra è scomparso nel senso che la Lega ha sempre
votato compatta le proposte della coalizione, qualcuno in Forza Italia e in
Coraggio Italia no, mi sembra evidente e questo andrà chiarito sicuramente».
Qualcosa da rimproverarsi? «Io ho lavorato per fare sintesi, la Lega ha cercato
di essere collante tra chi voleva andare da una parte e chi dall’altra. Noi
siamo stati centrali, e non abbiamo mai sgarrato di un millimetro».
Salvini spiega anche che cosa
è successo l’ultima notte, quella in cui sembrava destinata al Quirinale
Elisabetta Belloni. Su di lei c’erano Pd e Cinque stelle ed era gradita a
Giorgia Meloni. E anche lui se ne era convinto. Poi la retromarcia di Enrico
Letta, che ha subito l’arrabbiatura di Matteo Renzi. Al voto per Mattarella si è
arrivati dopo peripezie e delusioni, probabilmente forti anche sul piano umano.
Non credeva lui, invece, quando ha visto i grandi elettori di Fdi votare
solitariamente per Guido Crosetto, nonostante la presentazione il giorno prima
della «rosa» composta da Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. Non se
lo aspettava dalla Meloni.
Poi, Forza Italia, con quei
troppi voti negati alla «sua» Elisabetta Casellati. E i dubbi sull’operazione, e
su chi l’avesse pilotata. Ma Salvini in quei giorni ha scelto di non litigare
con quelli che considerava alleati. Giorno dopo giorno, il Pd respingeva ogni
proposta per il Colle da parte del centrodestra. Voleva evitare il trasloco di
Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale - e non era il solo - il premier
sarebbe stato travolto dai franchi tiratori, e il governo sarebbe crollato. E
voleva evitare Pierferdinando Casini, non per antipatia personale ma per
un’operazione politica che non condivideva. Quali alternative credibili a
Mattarella dopo tutto questo?
Nella testa del leader della
Lega non frullano vendette, né risentimenti. Riflette su un’alleanza che non ha
tenuto e legge amaro proprio quel che ha detto la Meloni. Forse è quel che gli
ha fatto male, ma vuole lasciarsi alle spalle l’amarezza. Magari la tentazione
di spedirle un messaggio, una brutta parola, ma a che serve litigare. Sarebbe
uno spettacolo comunque indegno, anche se vissuto in una conversazione a due. E
non è neppure il momento di scherzarci su, in queste ore non si capisce neanche
l’ironia...
Bisogna già pensare al domani.
«Se c’è qualcuno che nel centrodestra non si sente a suo agio il mondo è grande,
se qualcuno vive di nostalgia, pensa ai minestroni, "proporzionaloni" e
frittatoni, torna indietro di 40 anni, non lo fa con noi». E le elezioni del
2023? «Ci sarà chi ci sarà». Tra domani e martedì assieme a Giancarlo Giorgetti
vedrà Mario Draghi. Nel governo qualcosa dovrà cambiare. Un rimpasto? E chi lo
può dire, oggi, se il governo è più forte o più debole. Ma certo è che non si
può continuare ad andare avanti cosi: «Ragioneremo di tutto, sicuramente la
priorità della Lega, del governo, del paese, non è una legge elettorale
proporzionale». Che semmai può arrivare se si arriva al tutti contro tutti nelle
coalizioni.
E Giorgetti? Non ci sono
problemi che non si risolvono, dice il segretario, che ha visto sinceramente
vicino in questa vicenda il suo vicesegretario. Ci preoccupa l’Italia, «non è
questione di rimpasto. Ma i problemi sono rilevanti. Se il governo è una squadra
deve essere una squadra». «Non ci possono essere ministri che fanno e alleati
che disfano».
E il partito? Non ci sarà la
resa dei conti che i media rilanciano ogni giorno. Da una parte perché la Lega è
saldamente nelle mani del leader e poi perché il domani va costruito insieme.
Anche perché tutti sono rimasti scottati dagli alleati. Meglio rimettere a posto
gli arredi che non vanno più che pensare a traslocare. Anche perché davanti ci
sono nuove battaglie in cui credono tutti, a partire dai referendum sulla
giustizia. La politica non si è conclusa ieri. Magari si troveranno nuove
alleanze.
(ANSA il 30 gennaio 2022) -
"Fra le centinaia di insulti e attacchi della stampa sinistra, questo lo voglio
offrire alla vostra riflessione. Non è un attacco politico dei soliti: razzista,
cretino, fascista, imbecille o simili.
No. Nell'articolo del
Riformista del 29 gennaio a firma di tale Angela N. si legge di "commenti
pesanti sulle frequenti necessità di Salvini di assentarsi un attimo, giusto un
attimo, per poi tornare rinfrancato e pimpante".
Ho capito io quello che avete
capito voi? Uscirei spesso dall'ufficio, durante le riunioni, per andare a
drogarmi in bagno e tornare pimpante… Accetto tutto, ma non questo".
Lo scrive su Facebook -
postando uno stralcio dell'articolo citato - il leader della Lega Matteo
Salvini. "In questi giorni - scrive ancora Salvini - mi hanno accusato di essere
ingenuamente leale e troppo generoso, di fare tante proposte e di fidarmi delle
persone, mentre altri - da destra e sinistra - tradivano, fuggivano, dicevano
solo No. Accuse che accetto, e di cui anzi vado orgoglioso.
Ma drogato proprio no: questo
non fa parte della contesa politica, questo va oltre, vorrei chiedere a questi
"giornalisti" di ricordarsi che fuori dai palazzi della politica ho due figli
che rispettano e amano il loro papà, che con tutti i suoi difetti è per loro un
modello.
Non chiedo rispetto, per
qualcuno sarebbe troppo, ma almeno un po' di pudore e vergogna pensando ai
bambini, questo sì. Buona domenica a voi amici, comunque la pensiate. E per la
signora e il suo "giornale" invece, una bella querela e tanti soldi da dare in
beneficenza ai ragazzi di San Patrignano".
Pronta la solidarietà dei
gruppi leghisti di Camera e Senato: "Il vergognoso articolo apparso ieri su Il
Riformista in cui si insinua che Matteo Salvini sia uscito frequentemente dal
suo ufficio per andarsi a drogare in bagno è quanto di più meschino, triste e
raccapricciante sia stato scritto in questi giorni.
Anche l'odio politico deve
avere un limite. La droga rappresenta dramma e morte e nessuna insinuazione del
genere è tollerabile. Il giornale si scusi immediatamente o mostri le prove. C'è
chi gioca a inventarsi notizie per avere un briciolo di notorietà, ma su questi
temi non si scherza", scrivono Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.
(ANSA il 30 gennaio 2022) -
"Gli attacchi personali, conditi da insinuazioni di basso livello, mossi nei
confronti di Matteo Salvini, sono assolutamente inaccettabili. Per quanto aspro
possa essere il confronto, non deve mai valicare l'ambito delle idee per colpire
le persone".
Lo dichiara il governatore
Massimiliano Fedriga commentando un articolo pubblicato sul Riformista nel quale
si sosterrebbe, come interpreta Matteo Salvini in un post sul proprio profilo
Facebook, che lo stesso segretario della Lega faccia uso di sostanze
stupefacenti.
Nel suo post di un paio di ore
fa, Salvini riporta una frase di un articolo pubblicato sul quotidiano il 29
gennaio in cui "si legge di 'commenti pesanti sulle frequenti necessità di
Salvini di assentarsi un attimo, giusto un attimo, per poi tornare rinfrancato e
pimpante'.
Ho capito io quello che avete
capito voi? - chiede Salvini nel messaggio su Fb - Uscirei spesso dall'ufficio,
durante le riunioni, per andare a drogarmi in bagno e tornare pimpante… Accetto
tutto, ma non questo". Il segretario del Carroccio ha annunciato "per la signora
(che firma l'articolo, ndr) e il suo 'giornale', una bella querela e tanti soldi
da dare in beneficienza ai ragazzi di San Patrignano". (ANSA).
(ANSA il 30 gennaio 2022) -
"Le insinuazioni de 'Il Riformista' su Salvini sono inaccettabili". Lo dichiara
il presidente del Veneto, Luca Zaia, in relazione all'articolo pubblicato oggi
dal quotidiano nel quale si legge - cita lo stesso Zaia - di "commenti pesanti
sulle frequenti necessità di Salvini di assentarsi un attimo, giusto un attimo,
per poi tornare rinfrancato e pimpante".
"Per chi fa politica sulla
carta stampata, purtroppo, gli attacchi e gli insulti verso gli avversari sono
all'ordine del giorno" aggiunge il presidente veneto. Ma quelle frasi riportate
nell'articolo "sono parole inaccettabili, perché diffondono insinuazioni che
lasciano volutamente libere interpretazioni anche estreme sulla condotta di una
persona, fino al punto che si potrebbe pensare che ci si assenti per drogarsi".
"Questo modo di informare e
scrivere ai cittadini - conclude Zaia - è da condannare fermamente, senza se e
senza ma. Esprimo vicinanza a Matteo Salvini, uomo, padre e politico per bene
che da sempre si batte nella lotta contro la droga".
(ITALPRESS il 30 gennaio
2022) - "Trovo inconcepibile e triste che ieri, in un retroscena che chiama in
causa un commentatore anonimo, sul Riformista si insinui che Matteo Salvini
abbia fatto uso di strane sostanze. È odioso costruire una infamia del genere
nascondendosi dietro una fonte anonima.
È vergognoso rivolgere una
accusa così grave a Matteo, che ha fatto della lotta a qualsiasi droga uno dei
suoi capisaldi politici. Si deve riflettere seriamente su come i media, vivendo
in una spirale competitiva permanente, possano provocare danni non solo alle
singole persone - fatto gravissimo - ma anche alla qualità del dibattito
politico. Il Riformista dovrebbe scusarsi". Lo afferma in una nota il
governatore della Lombardia Attilio Fontana.
Siamo il giornale che più
di tutti ha difeso Luca Morisi. Il Riformista non ha mai insinuato che Salvini
si droghi.
Piero Sansonetti su Il Riformista il 30 Gennaio 2022.
Nella Lega c’è un clima di
grande tensione. E’ normale dopo la sconfitta subìta alle elezioni
presidenziali. Sulla pagina facebook di Salvini fioccano i commenti polemici,
spesso pieni di rabbia. Centinaia e centinaia.
In questo clima di tensione,
prima Salvini, poi i capigruppo della Lega in Parlamento, poi altri esponenti
hanno in diversa misura protestato per un articolo uscito due giorni fa
sul Riformista, nel quale si riferiva di alcuni ragionamenti ant-Salvini
scambiati tra due parlamentari leghisti in dissenso con il loro leader.
Nell’articolo si presentavano questi ragionamenti come “velenosi”, quindi non
gli si dava nessun peso, li si indicava solo come sintomi del malessere.
Nel comunicato diffuso dagli
onorevoli Romeo e Morelli si sostiene che Il Riformista avrebbe scritto che
Salvini spesso esce dal suo ufficio per andarsi a drogare in bagno. Beh, questa
è una pura falsità. In nessun suo articolo Il Riformista ha parlato di droga o
di bagni e neppure di ufficio di Salvini. Semplicemente abbiamo riferito di un
colloquio tra due suoi parlamentari nel quale si accennava alle “frequenti
necessità del segretario di assentarsi un attimo per poi tornare rinfrancato e
pimpante”. Il riferimento è all’ipotesi che Salvini sia eterodiretto, e che per
prendere le decisioni abbia bisogno di ricevere indicazioni e rassicurazioni
dall’esterno. Questa ipotesi – assolutamente politica – è stata definita
dal Riformista “velenosa”, dunque in nessun modo presentata come credibile. Il
Riformista si è limitato a raccontare quanto sia infuocato il clima dentro la
Lega, cosa, peraltro, largamente comprovata dalla pagina facebook dello stesso
Salvini.
Non è una cosa saggia da parte
di esponenti politici di rilievo, come Romeo e Morelli, attribuire ad altri –
persino ai giornali – parole e cose che non sono mai state scritte.
Del resto che in
quell’articolo non ci fosse nessun intento scandalistico è dimostrato dal fatto
che il riferimento al colloquio tra i due leghisti non era né nel titolo, né nel
sommario, né nell’occhiello. Era in tre righe nel corpo dell’articolo.
Noi non abbiamo neppure
lontanamente immaginato che Salvini faccia uso di droghe. Anzi, conoscendolo un
po’, lo escludiamo nel modo più assoluto. E oltretutto non abbiamo mai
considerato l’uso di droghe – da parte di chi realmente le usa – un delitto o
una cosa riprovevole. Siamo il giornale che più di tutti ha difeso Luca
Morisi quando si è scatenata contro di lui una indegna campagna di stampa. E
faremmo la stessa cosa se si aprisse una campagna contro Salvini o qualunque
altro esponente o leader politico.
Piero Sansonetti. Giornalista
professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di cui è stato
vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004 al 2009, poi
di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per poi approdare
alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre 2019.
Paola Di Caro per il “Corriere
della Sera” il 30 gennaio 2022.
Confessa di sentirsi «oggi più
sola nel Palazzo, ma magari fuori no». Ma non ha nessuna intenzione di «lasciare
soli i milioni di italiani che votano e credono nel centrodestra - ancora
maggioranza in questo Paese - che hanno diritto ad essere rispettati,
considerati e rappresentati.
Oggi il centrodestra per come
lo abbiamo visto non c'è più. Ma lo prometto: lo ricostruiremo». A sera Giorgia
Meloni non ha ancora superato la delusione per «l'enorme occasione sprecata», la
possibilità di eleggere per la prima volta al Quirinale una figura d'area. E pur
«orgogliosa del mio partito, Fratelli d'Italia, che si è mosso con compattezza
totale, che è entrato in questa partita con una posizione e con quella è
uscito», ancora non si capacita di come «non si sia voluto nemmeno provare a
vincere».
Chi non ha voluto?
«Avevamo i numeri, come
maggioranza relativa, almeno per dare le carte. Ma nella coalizione molti non lo
hanno voluto. I centristi di Cambiamo lo hanno in pratica dichiarato, una parte
di Forza Italia non lo voleva».
Berlusconi?
«Non lo so, non l'ho sentito
molto in questi giorni, se non fugacemente».
E Salvini, che voleva fare il
kingmaker?
«Difficile fare il maker se
rimetti lo stesso King...».
Non se lo aspettava da lui?
«No. Non l'ho capito, lo trovo
incomprensibile. Ho scoperto dalle agenzie che avrebbe votato Mattarella.
L'unica ipotesi alla quale tutti i leader del centrodestra avevano detto no con
apparente convinzione. Ed è la seconda volta che apprendo dalle agenzie di
scelte su cui sembravamo d'accordo poi totalmente disattese: prima l'ingresso di
FI e Lega nel governo Draghi e ora questa».
Vi siete sentiti, chiariti?
«No. D'altronde non credo ci
sia molto da chiarire».
Ma con Berlusconi e Salvini
oggi siete ancora alleati?
«In questo momento no. Mi
sembra che abbiano preferito l'alleanza col centrosinistra, sia per Draghi sia
per Mattarella. Se per fare una prova manca un terzo indizio, quello è la legge
elettorale: c'è chi cercherà di cambiarla in senso proporzionale. Se ci
staranno, ci sarà poco da aggiungere, perché con il proporzionale si riproduce
la palude degli ultimi governi».
Ma perché secondo lei nel
centrodestra non si è voluto tentare la partita? Per strategia o paura?
«Per paura. Non solo dei
partiti del centrodestra, ma di tantissimi in Parlamento. Hanno barattato sette
anni di presidente della Repubblica con sette mesi di legislatura, o se vogliamo
di stipendio».
O forse voi non davate
garanzie o nomi giusti?
«Abbiamo presentato nomi
rispettabilissimi, con tutte le carte in regola. Ma qualunque candidato di
centrodestra è considerato a sinistra inaccettabile o impresentabile. Hanno un
complesso di superiorità non democratico.
È stato assurdo sentire dire a
Enrico Letta che qualunque candidato avessimo proposto avrebbe "fatto la fine di
Berlusconi". Io esigo rispetto per i nostri elettori e la cultura che
rappresentiamo».
Voi però parlavate di
maggioranza relativa, ma l'unica volta che avete posto un nome unitario al voto,
quello della Casellati, avete preso 382 voti. Una minoranza.
«È vero. Siamo stati noi a
farci male. Anche se in quel caso FdI ha votato compatta e anche la Lega ha
votato bene. In qualche modo avevano ragione gli avversari che dicevano che
sulla carta eravamo maggioranza, ma non nel voto sul presidente...».
Quindi alla fine eravate
impantanati...
«Questo Parlamento è
impantanato da mesi su qualsiasi cosa, non rappresenta più il Paese, come
abbiamo chiesto noi andava sciolto mesi fa. Ma se ci fosse stata l'elezione
diretta del presidente, su cui noi abbiamo presentato una proposta di legge
anche online, ci sarebbero voluti comunque cinque minuti per avere un presidente
della Repubblica. Col voto degli italiani».
Mattarella è comunque il
politico più amato dagli italiani. Perché per lei è inaccettabile la sua
rielezione?
«Al di là del fatto che non ho
condiviso alcune sue scelte politiche, è inaccettabile perché è l'ennesima grave
anomalia: abbiamo un premier che non ha avuto alcun mandato popolare, un capo
dello Stato rieletto quando la Costituzione non esclude formalmente il bis solo
per permettere che possa avvenire in caso di emergenze straordinarie, e questa
non lo è.
E aggiungo che sono
meravigliata che Mattarella, che aveva anche fatto sapere di non volere un
secondo mandato, lo abbia accettato. E pure con un'elezione di risulta, un
ripiego al settimo scrutinio, non al primo. Al suo posto non lo avrei fatto,
anche per rispetto alla decisione presa, alle modalità, alla carica».
Ora che succede del fu
centrodestra?
«Va ricostruito. Non mi
dimentico che nella Nazione milioni di elettori lo chiedono. Inizio dal mio
partito, percepisco la solitudine di tanta gente che non ha compreso, che non
voleva finisse così».
Si può ricostruire solo da
destra, riallacciando i rapporti con la Lega, ma senza i centristi, FI, un
baricentro moderato?
«Ma noi non siamo solo destra,
siamo conservatori, e non di poltrone, come altri... FdI ha già allargato il suo
campo d'azione. E i "centristi" non sono una cosa a sé. In tutte le grandi
democrazie c'è un partito conservatore e uno progressista, in cui ci sono
esponenti che vanno da un estremo all'altro dello schieramento. Quello che negli
altri Paesi non esiste è un "centro" trasformista, che può formarsi col
proporzionale, spregiudicato e pronto a stare ovunque dove si governa. Questo
non può esserci nel nuovo centrodestra che ricostruiremo».
Governate in molte regioni e
città: che succederà?
«Sul territorio le dinamiche
sono diverse, sono modelli che funzionano. Vedremo nelle prossime ore che
succederà, ma ricostruiremo quello che oggi si è rotto, in modo migliore. È una
promessa, e io sono una che, come si è visto, mantiene la parola data».
Da liberoquotidiano.it il 30
gennaio 2022.
"Non è vero quel che dice
Giorgia Meloni". Antonio Tajani, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su
Rai 3, smentisce la sua alleata sulla candidatura di Sergio Mattarella, rieletto
presidente della Repubblica ieri sera all'ottavo scrutinio. Il numero due di
Forza Italia ha spiegato che il centrodestra non ha mai escluso il capo dello
Stato uscente a priori.
Cosa che invece ha dichiarato
la leader di Fratelli d'Italia. "Mattarella era l'ultima ipotesi, se ci fosse
stato l'accordo tra tutti avremmo votato per Casini perché è un politico,
indicato dalla sinistra e non da noi - ha chiarito Tajani -. Tramontata
l'ipotesi di un accordo, non potevamo accettare un tecnico. Due tecnici
avrebbero dimostrato che in Italia la politica non conta nulla. Mattarella non è
un commissariamento della politica, è una scelta".
Parlando invece della
possibilità di un rimpasto nel governo, l'ex presidente del Parlamento europeo è
stato molto chiaro: "Non abbiamo proposto il cambiamento di alcun ministro o
sottosegretario. Se la Lega vuole sostituire un ministro, ne parlino col
presidente del Consiglio, vedano loro. Per noi vanno bene quelli che abbiamo.
Abbiamo sempre detto in tutte le assemblee che Forza Italia era soddisfatta del
lavoro che facevano i tre ministri, il viceministro e i cinque sottosegretari".
Infine, sulla carta Elisabetta
Belloni, lanciata la sera prima della settima votazione, Tajani ha ribadito: "A
Salvini avevamo detto chiaramente che noi non potevamo andare sulla figura della
signora Belloni o su altre figure tecniche. E non per un giudizio sulle persone,
ma perché volevamo un politico al Quirinale".
Giorgia Meloni, la
foto-sfottò sul Quirinale: "Il perfetto riassunto degli ultimi giorni".
Libero Quotidiano
il 31 gennaio 2022
Giorgia Meloni non nasconde
una certa indignazione per come è finita la partita per il Quirinale. E così,
tra le ultime uscite, spunta su Twitter una foto che ha ben poco bisogno di
didascalie. Nell'immagine diffusa dalla leader di Fratelli d'Italia si vede una
sfilza di parlamentari con in mano le poltrone e sotto un "grazie presidente".
Anche il commento non ci va per il sottile. "Il perfetto riassunto degli ultimi
giorni", scrive la Meloni.
Un vero e proprio attacco a
quei parlamentari che hanno permesso il Mattarella bis. Tra questi ci sono anche
gli alleati di centrodestra su cui la Meloni si è già ampiamente espressa. "Le
posizioni di tutti gli altri cambia, la nostra no. Ora bisogna ricominciare
daccapo. Bisogna rifondare il centrodestra daccapo. Il centrodestra parlamentare
non esiste. Il centrodestra è maggioranza nel Paese e noi lo vogliamo
rappresentare", commentava appena Roberto Fico, presidente della Camera,
annunciava la rielezione di Sergio Mattarella.
Ancora una volta la Meloni non
nega che dal centrodestra, ossia da Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si
aspettava "un po' di coraggio in più. Questa cosa mi fa impazzire, mi fa
impazzire che si sia rinunciato prima di tentare davvero. Mi dispiace ma noi di
FdI abbiamo fatto di tutto". Una dura accusa che vede d'accordo anche Fabio
Rampelli: "Il centrodestra deve rifondarsi, darsi nuove regole, fare scelte
comprensibili per il popolo italiano. La decisione di Salvini e Berlusconi di
convergere su un Mattarella bis", ha tuonato il vicepresidente alla Camera di
FdI.
L'aria che tira, Silvio
Berlusconi al Quirinale: "A dire di no è stata Giorgia Meloni": il centrodestra
finisce qua?
Libero Quotidiano il 31 gennaio 2022.
Si parla ancora di Quirinale
a L'Aria Che Tira, il programma di La7 condotto da Myrta Merlino. In
collegamento nella puntata di lunedì 31 gennaio c'è Maurizio Gasparri. Il
senatore di Forza Italia si lascia andare a un lungo sfogo, raccontando anche un
retroscena su quanto accaduto con la candidatura, poi ritirata, di Silvio
Berlusconi. "Forza Italia ha tenuto la stessa posizione di sempre: Mario
Draghi doveva rimanere a Palazzo Chigi e al Colle non ci doveva andare un
tecnico". Ma a quel punto è la conduttrice a incalzare Gasparri, chiedendo
di Elisabetta Casellati che in Aula non è riuscita a ottenere neppure tutti i
voti del centrodestra.
"Allora - replica il senatore
-, è una cosa che va approfondita perché sicuramente sono mancati voti del
centrodestra, alcuni di Coraggio Italia e altri nostri. Però - e qui arriva il
retroscena -, la sera prima si era deciso di riproporre il nome di Berlusconi ma
qualcuno non ha voluto". E ancora: "Dico la verità, tutta la verità. Al nome del
leader azzurro mi pare che Giorgia Meloni ha detto no".
D'altronde la numero uno di
Fratelli d'Italia a riguardo era stata chiara: "Penso che se anche se Silvio
Berlusconi decidesse di non concorrere o si stabilisse che, essendo una figura
molto caratterizzata... se lui dovesse rinunciare comunque il centrodestra ha il
diritto e dovere di avanzare una proposta, più proposte" . In ogni caso secondo
Gasparri il nome di Berlusconi non sarebbe passato perché grillini e dem non
avrebbero partecipato al voto.
Meloni contro tutti. Il
vizio della Destra di chiedere solo il voto.
Filippo Ceccarelli su La
Repubblica il 31 gennaio 2022.
Nel gennaio del 2021, un anno
fa, durante la presentazione del governo Draghi, la presidente di Fratelli
d’Italia si lasciò prendere dall’ira e usando anche le mani e le braccia
espresse insofferenza e cattivi pensieri. Interpretando il sentire di parecchi,
il giornalista primatista dei social, Andrea Scanzi, la qualificò come
“pescivendola”.
Più interessante la reazione,
naturalmente social, che portò immediatamente Giorgia Meloni da un grossista di
pesce e qui, raccolta da terra una cassetta di orate e spigole, sotto le luci al
neon di quel gelido stanzone, l’unica esponente dell’opposizione parlamentare,
con aria di sfida, si mise a gridare: “Pesce fresco! Pesce fresco! Avvicinatevi,
ottimi prezzi!”.
Non si alzerà il sopracciglio
radical-chic perché l’odierna politica vive di questi spettacoli. Proprio ieri
oltretutto, sempre sui suoi profili, Meloni è apparsa con un bel maglione bianco
e alle spalle una candida orchidea. Con garbata vivacità, per 32 minuti, forse
un po’ troppi, ha raccontato come il centrodestra abbia sbagliato tutto e la sua
incredulità quando Salvini si è convertito al Mattarella bis. In fondo, nel gran
circo quirinalizio, lei si è mantenuta in seconda fila e ha fatto quello che ci
si aspettava, compreso dire, pressoché unica, che i deputati hanno rieletto
Mattarella per salvare stipendi e pensioni. In tal modo è apparsa coerente,
essendo la coerenza il must, l’obbligo concettuale, su cui lavora il suo
giovanissimo social media manager Tommaso Longobardi, oltre sul lato pop: remix,
autobiografie, animali, frutta, bamboline e pupazzetti.
Illustri scienziati della
politica, Dahl, Duverger, Sartori, hanno passato la vita a studiare
l’Opposizione riconoscendone l’utilità nel funzionamento delle istituzioni. Un
successivo filone di studiosi è arrivato a chiedersi se, oltre che elemento
costitutivo della teoria democratica, il sistema abbia bisogno non solo di una
semplice minoranza quanto di un “forte” opposizione.
Ora, è evidente che la crisi
parallela della Lega e dei cinque stelle apre da oggi grandi orizzonti a
Fratelli d’Italia. Ma per quanto la politologa Sofia Ventura sostenga che Meloni
sia più “brava” e “cattiva” del “bamboccione” Salvini, il punto cruciale è che
fare l’opposizione, ma farla sul serio, è maledettamente difficile; oltre a
comportare la più grave responsabilità.
Nel congedarsi dai suoi fan,
poco prima di schioccargli un bacio, ieri Meloni ha fatto il gesto di
rimboccarsi le maniche. Sarebbe interessante capire se ha compreso che tocca a
lei spalare le macerie del centrodestra. O se restando in ambito ittico, non sia
tentata da quella che a destra è da decenni la peggiore attitudine e abitudine:
la pesca delle occasioni. In questo senso Giorgio Almirante, nella cui stanza
Giorgia ha voluto insediarsi a via della Scrofa, chiedeva sempre e comunque le
elezioni. Meloni pure, con l’aggiunta di qualche Atreju per finire sui tg e di
un patriottismo abbastanza innocuo, quando non sono i presepi e gli immigrati.
Vero è che il tempo fa vedere
meglio ciò che prima sembrava fasullo. Ma Gianfranco Fini, dopo tutto, qualche
sforzo teorico a suo modo l’aveva pur fatto; mentre l’impressione è che Meloni,
cui Galli della Loggia ha riconosciuto “vivida intelligenza politica e personale
simpatia (che in politica conta, eccome!)”, più che un partito capace di fare
opposizione si ritrovi una palla al piede. La faccenda oltrepassa il buon
rapporto con Enrico Letta e il tenero dileggio con cui immancabilmente li si
assimila a Vianello e alla Mondaini. È qualcosa di più. La dissoluzione della
classe politica non si ferma a chiacchiere e siparietti. Nel salvare il
salvabile tocca guardare fuori e lontano – magari anche ricordandosi che quando
un professore un po’ chiacchierone le diede ancora della pescivendola, e anche
peggio, il presidente della Repubblica volle esprimerle di persona la sua
vicinanza, anche perché l’opposizione è una cosa seria.
La candidatura di Belloni e
il baco del sistema.
Carlo Bonini su La Repubblica il 31 gennaio 2022.
Tra le lezioni di una
settimana che il Paese non dimenticherà ce n’è una, per certi aspetti persino
più rivelatrice di altre, che ha che fare con la qualità della nostra democrazia
e l’integrità di una delle sue infrastrutture più delicate: gli apparati di
sicurezza e intelligence. Con l’urgenza di metterla al riparo dal collasso della
cultura politica della nostra classe dirigente. E con un baco del nostro sistema
che va rapidamente corretto.
Che nella notte di venerdì
scorso, intorno al nome di Elisabetta Belloni, direttore generale del Dis, il
Dipartimento per le informazioni e la sicurezza, il vertice dei nostri Servizi
(e prima di lei a quello di Giampiero Massolo, anche lui ex direttore del Dis),
si sia consumata l’avvilente coda di un “casting” che ha degradato la scelta del
candidato alla presidenza della Repubblica alle selezioni per un talent
rappresenta già in sé, un catastrofico danno per la reputazione e i
delicatissimi equilibri che regolano gli interna corporis dei nostri apparati. E
che alla trovata abbiano lavorato con spregiudicato entusiasmo e con la
collaborazione di un condannato in via definitiva detenuto ai domiciliari (Denis
Verdini), un ex ministro dell’interno e vicepresidente del consiglio (Matteo
Salvini) un altrettanto spregiudicato ex presidente del Consiglio (Giuseppe
Conte), e la leader di una destra con ambizioni di governo (Giorgia Meloni),
senza avvertire, neppure per un istante, l’enormità di un passaggio senza
soluzione di continuità di un’eccellente civil servant, quale la Belloni è, dal
vertice dei Servizi al ruolo di garante dell’unità nazionale e della
Costituzione, è il segnale della catastrofe del rapporto tra politica e
apparati. Orfana di legittimazione, la politica, che un giorno sì e l’altro pure
rivendica il proprio primato e riscatto, sceglie infatti la pericolosissima
scorciatoia che, nella disperata ricerca surrogata di autorevolezza e
competenza, porta a travolgere il confine che deve separare e proteggere la
“terzietà” degli apparati di sicurezza dal gioco politico. Ad alimentare un
pericoloso, opaco e tossico milieu tra chi detiene per statuto notizie coperte
da segreto e attinenti la sicurezza nazionale e coloro a cui quegli apparati
rendono conto. Parliamo di chi, nelle istituzioni, siede per volontà popolare e
con libertà di mandato.
Non erano del resto mancati
segnali in questo senso ben prima della settimana scorsa. Sarebbe sufficiente
ricordare l’incestuoso rapporto coltivato da Matteo Salvini e Giuseppe Conte con
una figura come l’ex dirigente del Dis Marco Mancini (lo 007 che per una vita ha
sussurrato all’orecchio della politica, cui era stata promessa la vicedirezione
dell’Aise, il nostro spionaggio estero, e spedito in un autogrill della
Roma-Firenze nei giorni della crisi del governo Conte per sondare le intenzioni
di Matteo Renzi). O la disinvoltura nell’interpretazione del suo ruolo dell’ex
direttore del Dis (e predecessore di Elisabetta Belloni) Gennaro Vecchione che
di fronte al Copasir (il comitato di controllo parlamentare sui Servizi)
discettava di emendamenti alla legge di bilancio per portare a casa, fuori da
ogni cornice normativa, una fondazione per la cyber security. Per non dire
dell’inedito di un eccellente direttore dell’Aise, Luciano Carta, transitato
senza soluzione di continuità dal vertice del Servizio a Leonardo.
E’ dunque necessario e
urgente, di fronte all’incapacità di self restraint della politica, all’evidente
rottura di un argine cruciale della dialettica democratica, che il Parlamento
metta mano alla legge di riforma dei nostri Servizi colmando un vuoto esiziale e
non più sostenibile. Disciplinando dunque con cura, intelligenza, e spirito
bipartisan, un regime di ineleggibilità e incompatibilità degli appartenenti o
ex appartenenti ai nostri apparati di sicurezza e intelligence. Il Pd,
attraverso il suo responsabile sicurezza e membro del Copasir, Enrico Borghi, ha
annunciato ieri un’iniziativa in questo senso. E’ una buona notizia. Che non
deve essere lasciata cadere. Perché se è vero che la salute di una democrazia si
misura anche e soprattutto dalla sua capacità di manutenere e sorvegliare il suo
sistema di checks e balances, di controllo ed equilibrio tra istituzioni e corpi
dello Stato, questo è il momento per farlo. Con lo stesso senso di urgenza che,
nei mesi scorsi, ha accompagnato la discussione di fronte a un altro baco di
sistema, quello che non prevede l’incompatibilità tra l’esercizio della funzione
giudiziaria e quello di rappresentante eletto nei consigli comunali.
Darsi delle regole, lì dove le
regole mancano, non è mai una cattiva idea. A maggior ragione quando le regole
servono a presidiare snodi decisivi nella vita delle istituzioni. Darsele alla
vigilia di uno scorcio di legislatura che comincia con gli auspici della
settimana appena trascorsa diventa un imperativo.
Marco Travaglio durissimo
contro Luigi Di Maio: "Mia sorella? Ecco perché va espulso dal M5s".
Libero Quotidiano
il 30 gennaio 2022
Il nome di Elisabetta
Belloni come possibile candidata per il Quirinale ha letteralmente spaccato a
metà il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte da una parte e Luigi Di
Maio dall'altra. Mentre il primo, insieme a Matteo Salvini, decideva di
spiattellare l'ipotesi Belloni ai giornalisti la sera prima della votazione, il
secondo sosteneva invece la necessità di non buttare in pasto ai media un alto
funzionario pubblico. Il rischio, infatti, era quello di bruciarlo. Cosa che poi
è successa.
L'ex capo politico del
Movimento, allora, se l'è subito presa con Conte, criticando il suo modo di
fare. Un attacco non inaspettato, anche perché già nei giorni precedenti Di Maio
si era raccomandato sulla Belloni, considerata da lui come una sorella dopo i
mesi trascorsi assieme alla Farnesina. Marco Travaglio non ha preso bene questa
critica da parte del ministro degli Esteri. E non ha mancato di farglielo sapere
nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano: "Di Maio è il Renzi dei 5 Stelle.
Beniamino dei giornaloni (quelli che gli davano del bibitaro), ma non più degli
elettori (vedi insulti sui suoi social), ha giocato fin da subito per
Draghi (che un anno fa voleva 'uccidere in Parlamento'), contribuendo a mandarlo
al massacro, contro il suo leader e il suo movimento".
Parole molto dure quelle di
Travaglio, che poi ha continuato: "Ha incontrato, sentito e promesso voti a
tutti, anche a quelli che quattro anni fa non voleva vedere neanche in
cartolina. Ha definito 'mia sorella' la Belloni, poi ha fatto di tutto per
impallinarla. Per molto meno, se fosse ancora il capo dei 5Stelle, si sarebbe
già espulso". Al momento, insomma, tra i grillini non si respira proprio una
bella aria.
Estratto dell’articolo di
Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano” il 30 gennaio 2022.
[...] Di Maio. È il Renzi dei
5Stelle. Beniamino dei giornaloni (quelli che gli davano del bibitaro), ma non
più degli elettori (vedi insulti sui suoi social), ha giocato fin da subito per
Draghi (che un anno fa voleva "uccidere in Parlamento"), contribuendo a mandarlo
al massacro, contro il suo leader e il suo movimento.
Ha incontrato, sentito e
promesso voti a tutti, anche a quelli che quattro anni fa non voleva vedere
neanche in cartolina. Ha definito "mia sorella" la Belloni, poi ha fatto di
tutto per impallinarla. Per molto meno, se fosse ancora il capo dei 5Stelle, si
sarebbe già espulso.
Emanuele Buzzi per
il “Corriere della Sera” il 30 gennaio 2022.
Una tregua durata una giornata
e poi di nuovo guerra. E senza mezze misure. Il Movimento non conosce pace.
Dimaiani e contiani si punzecchiano tutto il giorno. Un ping pong di stoccate.
«Belloni? Non la abbiamo eletta per colpa di chi ha manie di protagonismo».
«I piani di chi voleva Draghi
al Colle sono falliti». Poi si scontrano direttamente i pesi massimi. Giuseppe
Conte punta Di Maio dopo le parole sulla direttrice del Dis: «Ci saranno
occasioni nella comunità del M5s per tutti i chiarimenti necessari. Sono state
ore febbrili, finora non c'è stato modo di chiarire il significato di alcune
uscite».
Il ministro degli Esteri in
serata si fa sentire: «Alcune leadership hanno fallito, hanno alimentato
tensioni e divisioni». Poi l'affondo. «Nel Movimento 5 Stelle serve aprire una
riflessione interna».
Conte preferisce non replicare
all'attacco diretto, ma chi è vicino al leader fa presagire che «presto» ci sarà
la resa dei conti tra i due. Fonti autorevoli contiane, invece, ribattono: «Si
tratta di un gesto di disperazione dopo la sconfitta di non aver portato Draghi
al Quirinale». I vertici intanto lavorano a una «fase due»: rilancio del ruolo
di governo, legge elettorale, oltre al confronto con alleati e big M5S.
Il Movimento dopo l'elezione
del capo dello Stato prova voltare pagina. Conte nei prossimi mesi cercherà di
costruire il percorso in vista delle Politiche del 2023 e di rilanciare l'azione
dei Cinque Stelle in seno all'esecutivo. Non a caso il presidente M5S già
annuncia: «Con Draghi ho chiesto un chiarimento. Non possiamo limitarci ad
assicurare la stabilità del governo, dobbiamo essere promotori di un confronto
per siglare un patto per i cittadini in cui individuare quali possano essere le
priorità» del Paese. Il no all'investitura del premier al Colle è vissuto come
un risultato, ma la rielezione di Mattarella lascia strascichi anche nei
rapporti con il Pd, ora ai minimi termini.
Le ultime ore della trattativa
sono condite da retroscena e voci. Si parla di un asse nella notte con Lega e
Fratelli d'Italia e altri (con 561 voti e più a disposizione sulla carta) per
provare il blitz su Elisabetta Belloni nonostante i veti dem. «Ma no, solo
tattica e controtattica», minimizzano nel Movimento. «Non diciamo fesserie»,
commenta Conte. Così come si racconta di un tentativo di un'ala del Movimento di
sgonfiare al penultimo scrutinio le preferenze per Mattarella.
Indiscrezioni senza conferma,
che sono il preludio alle dichiarazioni che seguiranno in giornata. Intanto, i
parlamentari festeggiano: molti sostengono che ha vinto la linea del gruppo e
che questo deve essere un segnale per il futuro del Movimento. Ma a tenere banco
tra deputati e senatori è anche il rapporto - scricchiolante - con i dem. Viene
contestata la lettura di un Pd vincente: «Volevano Draghi al Colle e hanno
perso». I nodi riguardano soprattutto la tenuta della coalizione dopo i sospetti
e le tensioni su Belloni. «Non ci faremo mettere i piedi in testa dal Pd», dice
un grande elettore. «Che vadano pure da soli, noi non abbiamo poltrone da
perdere».
L'idea è quella di rilanciare
presto, già in primavera, la riforma della legge elettorale con il ritorno al
proporzionale. Il clima è teso. Dai vertici del M5S si riannodano le trame della
giornata di venerdì e filtra l'indiscrezione che durante la trattativa tra i
leader sia stata sottoposta a Matteo Salvini una lista di tre nomi, tra cui
Belloni e Severino, lista che aveva avuto il placet di Leu e Pd. «Quando Salvini
ha dichiarato di essere d'accordo sulla candidatura di una donna al Quirinale,
Conte ha accolto con favore questa disponibilità a nome del fronte
progressista», spiegano nel M5S.
E argomentano:
«Successivamente, poi, è stato il Pd, e in particolare Guerini, che si è messo
di traverso e ha scelto di defilarsi». Tuttavia, ai piani alti dei Cinque Stelle
si dicono convinti che «nelle prossime settimane la situazione si chiarirà».
Dopo le accuse la replica
dell'ex premier: "Era anche lui in cabina di regia".
Conte e Di Maio alla resa dei
conti, le ragioni della rottura e il ruolo di Di Battista. Redazione su Il
Riformista il 30 Gennaio 2022.
Conte e Di Maio separati in
casa. Lo erano già da tempo, secondo alcuni rumors, ma con il Mattarella bis e
la gestione della scellerata settimana della politica italiana la frattura è
stata definitivamente cristallizzata. Prima le accuse del ministro degli Esteri,
che ieri sera, in contemporanea con le prime parole del “nuovo” presidente della
Repubblica, aveva accusato, senza fare nomi alcuni “leader” perché “hanno
fallito” per poi annunciare che anche “nel Movimento va aperta una riflessione
interna”.
A distanza di alcune ore,
arriva la replica di Giuseppe Conte, capo politico del Movimento. Intercettato
sotto casa dai cronisti, l’ex premier dichiara: “Di Maio parla di fallimento” di
alcune leadership. “Se ha delle posizioni le chiarirà perché anche lui era in
cabina di regia. Ne ha preso parte e chiarirà i suoi comportamenti. Siamo una
comunità grande che può affrontare le discussioni”.
Sul chiarimento chiesto da Di
Maio, Conte rivendica: “L’ho chiesto prima io e ci sarà senz’altro. Di Maio avrà
modo di chiarire il suo operato e la sua agenda”. Operato che è sembrato non
proprio in linea con le decisioni adottate dall’ex premier. Lo scontro è
degenerato dopo la candidatura, concordata con Salvini, Meloni e Letta (che poi
ha fatto retromarcia dopo i malumori interni al Pd) di Elisabetta Belloni, la
numero uno dei servizi segreti italiani bruciata nel giro di poche ore da Renzi
e dallo stesso Di Maio (“Trovo indecoroso che sia stato buttato in pasto al
dibattito pubblico un alto profilo come quello di Elisabetta Belloni. Senza un
accordo condiviso”).
Ma già in precedenza, nel
corso dell’imbarazzante settimana dei partiti politici, Conte e Di Maio
viaggiavano su binari diversi, con quest’ultimo che nel tempo, anche per il
ruolo istituzionale che ricopre, avvicinatosi più al premer Draghi e a posizioni
moderate.
In soccorso di Conte arriva
anche Alessandro Di Battista, sempre più vicino al ritorno alla politica attiva
(manca poco più di un anno alle elezioni). L’ex grillino, i cui rapporti con Di
Maio sono precipitati da tempo, difende il capo politico del Movimento: “Da anni
è necessaria una riflessione politica all’interno del Movimento ma è vigliacco
mettere oggi sul banco degli imputati l’ultimo arrivato che al netto d’idee
diverse su alcune questioni considero persona perbene e leale”.
Parole che vengono accolte
positivamente da Conte: “Stimo Alessandro Di Battista. E’ una persona genuina,
possiamo avere diverse opinioni politiche, ma lo rispetto e lo stimo. In
politica, la qualità di essere persona perbene è importante per garantire che i
traguardi siano ambiziosi, che ci sia l’etica pubblica. Ma essere perbene non è
sufficiente. La politica deve esprimere delle battaglie e occorre anche tanta
determinazione e coraggio”.
(ANSA il 30 gennaio 2022)
- "Decisioni in cabina di regia? Non si è mai parlato di fare annunci roboanti
su presunti accordi raggiunti con Pd e Lega, oggi smentiti anche dal segretario
dem Letta. Non si provi a scaricare le responsabilità su altri. È chiaro che ci
sono diversi aspetti che vanno chiariti". Così il ministro degli Esteri del M5s,
Luigi Di Maio.
Da corriere.it il 30 gennaio
2022.
La rielezione di Sergio
Mattarella, che ha avuto un’accelerazione con il fallimento dell’opzione Belloni
su cui i pentastellati puntavano, continua ad avere ripercussioni nelle forze
politiche.
Oltre ad avere spaccato il
centrodestra «che ora deve essere ricostruito» (copyright Giorgia Meloni), sta
creando una frattura anche all’interno del Movimento 5 Stelle, dove sempre più
evidente è la frattura tra le due anime, quella che guarda al ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio, ex capo politico del Movimento; e quella che fa
riferimento a Giuseppe Conte, oggi presidente.
Quest’ultimo è al centro delle
polemiche per la conduzione della trattativa sul Quirinale e, soprattutto, per
il suo epilogo che ha lasciato insoddisfatti molti nella galassia
pentastellata.
Di Maio ha parlato oggi della
necessità di «aprire una riflessione politica interna». E sulla stabilità del
governo ha commentato caustico: «Alcune leadership hanno fallito, hanno creato
tensioni. Invece noi dobbiamo lavorare per unire».
Piccata la replica dell’ex
premier, intercettato dai cronisti mentre usciva di casa: «Se Di Maio ha delle
posizioni le chiarirà, perché lui era in cabina di regia, come ministro l’ho
fatto partecipare. Chiarirà i suoi comportamenti, ma non a Conte, agli
iscritti». E ha aggiunto: «Il M5S non è Conte e non è Di Maio, è una comunità di
iscritti che partecipa attivamente. È giusto render conto sempre del nostro
operato e confrontarsi internamente».
Nel botta e risposta si
inserisce anche Alessandro Di Battista, ex deputato e ormai sempre più
osservatore distaccato delle vicende del Movimento. Che in questo caso,
tuttavia, prende le parti di Conte: «È da anni che è necessaria una riflessione
politica all’interno del movimento, ma è da vigliacchi mettere sul banco degli
imputati l’ultimo arrivato che, al netto di idee diverse su alcune questioni,
considero persona perbene e leale».
(ANSA il 30 gennaio 2022) -
Dopo la corsa per Quirinale "occorre un chiarimento politico" all'interno del
Movimento 5 Stelle per "capire le motivazioni che hanno fatto emergere
comportamenti non lineari".
Così il vicepresidente dei
pentastellati Riccardo Ricciardi a La Repubblica. Le accuse sono rivolte in
particolare all'ex capo politico Luigi Di Maio.
"Dovrà rendere conto al
Movimento di alcuni passaggi", afferma Ricciardi, il quale ribadisce che "c'è
una piccola minoranza con i quali dovremo chiarire alcuni passaggi".
Se "ci sono gruppi che
ritengono di fare politica dentro i palazzi, questo non rappresenta il vero
M5S", afferma il vicepresidente. Secondo Ricciardi "il Movimento è uno e Conte
ha una legittimazione forte degli iscritti".
Riguardo all'esito delle
votazioni, il cinquestelle si dice soddisfatto. "Il nostro obiettivo era
garantire la stabilità di governo". "Mattarella è sempre stato sul tavolo e
abbiamo contribuito a farlo crescere di voto in voto con una chiara regia",
sostiene Ricciardi.
Di Maio e Conte, scambio al
veleno: nel Movimento 5 stelle parte il processo al capo.
Emanuele Buzzi su Il Corriere
della Sera il 29 gennaio 2022.
Il ministro: certe leadership
hanno fallito, serve una riflessione interna. L’ex premier: le parole di Luigi?
Arriverà il momento per i chiarimenti.
Una tregua durata una giornata
e poi di nuovo guerra. E senza mezze misure. Il Movimento non conosce pace.
Dimaiani e contiani si punzecchiano tutto il giorno. Un ping pong di stoccate.
«Belloni? Non la abbiamo eletta per colpa di chi ha manie di protagonismo». «I
piani di chi voleva Draghi al Colle sono falliti». Poi si scontrano direttamente
i pesi massimi. Giuseppe Conte punta Di Maio dopo le parole sulla direttrice del
Dis : «Ci saranno occasioni nella comunità del M5s per tutti i chiarimenti
necessari. Sono state ore febbrili, finora non c’è stato modo di chiarire il
significato di alcune uscite».
Il ministro degli Esteri in
serata si fa sentire: «Alcune leadership hanno fallito, hanno alimentato
tensioni e divisioni». Poi l’affondo. «Nel Movimento 5 Stelle serve aprire una
riflessione interna». Conte preferisce non replicare all’attacco diretto, ma chi
è vicino al leader fa presagire che «presto» ci sarà la resa dei conti tra i
due. Fonti autorevoli contiane, invece, ribattono: «Si tratta di un gesto di
disperazione dopo la sconfitta di non aver portato Draghi al Quirinale».
I vertici intanto lavorano a
una «fase due»: rilancio del ruolo di governo, legge elettorale, oltre al
confronto con alleati e big M5S. Il Movimento dopo l’elezione del capo dello
Stato prova voltare pagina. Conte nei prossimi mesi cercherà di costruire il
percorso in vista delle Politiche del 2023 e di rilanciare l’azione dei Cinque
Stelle in seno all’esecutivo. Non a caso il presidente M5S già annuncia: «Con
Draghi ho chiesto un chiarimento. Non possiamo limitarci ad assicurare la
stabilità del governo, dobbiamo essere promotori di un confronto per siglare un
patto per i cittadini in cui individuare quali possano essere le priorità» del
Paese. Il no all’investitura del premier al Colle è vissuto come un risultato,
ma la rielezione di Mattarella lascia strascichi anche nei rapporti con il Pd,
ora ai minimi termini.
Le ultime ore della trattativa
sono condite da retroscena e voci. Si parla di un asse nella notte con Lega e
Fratelli d’Italia e altri (con 561 voti e più a disposizione sulla carta) per
provare il blitz su Elisabetta Belloni nonostante i veti dem. «Ma no, solo
tattica e controtattica», minimizzano nel Movimento. «Non diciamo fesserie»,
commenta Conte. Così come si racconta di un tentativo di un’ala del Movimento di
sgonfiare al penultimo scrutinio le preferenze per Mattarella. Indiscrezioni
senza conferma, che sono il preludio alle dichiarazioni che seguiranno in
giornata.
Intanto, i parlamentari
festeggiano: molti sostengono che ha vinto la linea del gruppo e che questo deve
essere un segnale per il futuro del Movimento. Ma a tenere banco tra deputati e
senatori è anche il rapporto — scricchiolante —con i dem. Viene contestata la
lettura di un Pd vincente: «Volevano Draghi al Colle e hanno perso». I nodi
riguardano soprattutto la tenuta della coalizione dopo i sospetti e le tensioni
su Belloni.
«Non ci faremo mettere i piedi
in testa dal Pd», dice un grande elettore. «Che vadano pure da soli, noi non
abbiamo poltrone da perdere». L’idea è quella di rilanciare presto, già in
primavera, la riforma della legge elettorale con il ritorno al proporzionale.
Il clima è teso. Dai vertici
del M5S si riannodano le trame della giornata di venerdì e filtra
l’indiscrezione che durante la trattativa tra i leader sia stata sottoposta
a Matteo Salvini una lista di tre nomi, tra cui Belloni e Severino, lista che
aveva avuto il placet di Leu e Pd. «Quando Salvini ha dichiarato di essere
d’accordo sulla candidatura di una donna al Quirinale, Conte ha accolto con
favore questa disponibilità a nome del fronte progressista», spiegano nel M5S. E
argomentano: «Successivamente, poi, è stato il Pd, e in particolare Guerini, che
si è messo di traverso e ha scelto di defilarsi». Tuttavia, ai piani alti dei
Cinque Stelle si dicono convinti che «nelle prossime settimane la situazione si
chiarirà».
(Adnkronos il 31 gennaio 2022)
- "Stiamo facendo le opportune verifiche per capire da dove parte la campagna di
tweet-bombing contro Di Maio". È quanto affermano, parlando con l'Adnkronos, gli
esponenti M5S vicini al titolare della Farnesina, i quali, alla domanda su un
possibile 'fuoco amico', aggiungono: "Speriamo di no, sarebbe molto grave".
Da adnkronos.com il 31 gennaio
2022.
Lo scontro tra Giuseppe Conte
e Luigi Di Maio si sposta sui social a colpi di tweet. Nelle ultime ore è
entrato nelle tendenze di Twitter l'hashtag #DiMaioOut, con cui molti utenti
stanno chiedendo la 'cacciata' del ministro degli Esteri dal Movimento 5 Stelle,
accusandolo di aver 'tramato' contro il leader Conte nella partita per il
Quirinale. Si tratta di una sommossa 'spontanea' o di un'operazione studiata a
tavolino?
Per Pietro Raffa, esperto di
comunicazione social e amministratore delegato della 'MR & Associati
Comunicazione', la risposta è semplice: "E' un tweet-bombing contro Di Maio".
"Ho effettuato un'analisi quantitativa e qualitativa dei tweet #DiMaioOut: sono
andato a vedere quante persone avevano utilizzato l'hashtag, si tratta di 289
account. E' chiaramente un'operazione studiata, che viene fatta da chi vuole
modificare la percezione su alcuni temi", spiega Raffa all'Adnkronos.
"Il tweet-bombing funziona
così: ci sono profili 'bot', falsi, coordinati da una persona: un argomento
utilizzato da pochi soggetti finisce così nelle tendenze nazionali di Twitter.
L'effetto è dare la sensazione che un tema sia molto più discusso di quanto in
realtà lo sia. Ho visto che circa la metà di questi profili twittava contro Di
Maio dall'America, un po' dall'America del Nord e un po' da quella del Sud.
Questi utenti assumono il
tipico comportamento dei profili fake: producono un numero troppo elevato di
tweet sugli argomenti discussi. E' probabile che ci sia qualcuno dietro che ha
deciso di fare questa operazione. Si tratta inoltre di profili che in passato
intervenivano in altri Stati su altri temi. Ad esempio risultavano molto attivi
in Francia, per sostenere le posizioni dei gilet gialli, ma anche in Germania a
sostegno dei partiti dell'ultradestra", aggiunge l'esperto. (di Antonio Atte)
"Nel M5S vige purtroppo la
regola 'o sei con me o sei contro di me'. Tutto così si riduce a tifoseria
comunicativa, tutto sta nel fare uscire la notizia prima degli altri,
'intestarsela', gestire la comunicazione in maniera unilaterale e zero voci in
dissenso. Questo modello può funzionare forse stando all'opposizione, con una
manciata di parlamentari. Ma il M5S ha preso il 33% alle ultime elezioni e di
parlamentari ne ha molti di più.
Il sistema delle parlamentarie
ha fatto sì che entrassero in Parlamento sensibilità diverse, anche opposte su
molte questioni. Luigi Di Maio ci ha messo sempre e per primo la faccia (mentre
altri hanno preferito non prendersi alcuna responsabilità profetizzando sui
social) con intuizioni incredibili e, per carità, anche errori, ammettendo poi
di aver sbagliato (cosa rara in politica) e soprattutto ha sempre tenuto
rapporti umani con le persone (mentre altri nemmeno ti rispondono al telefono)".
Lo scrive sui social Sergio Battelli, deputato 5 Stelle e presidente della
Commissione Politiche Ue alla Camera.
"Detto ciò, oggi abbiamo un
problema: molti, io per primo, vogliono spiegazioni. Spiegazioni, non teste
rotolanti. Parlare di ciò che è successo nella lunga settimana appena trascorsa.
Io non ho accuse da fare ma sicuramente dubbi da dirimere", aggiunge il
pentastellato. "Il MinCulPop interno - rimarca Battelli - l'ho sempre detestato
e non inizierò certo a farmelo piacere oggi. Perché il non detto e il subito
possono fare danni enormi. Ecco perché una richiesta di confronto seria e non di
facciata, dura, forte non è uno sfregio, non è una 'lesa maestà', non è un
insulto ma l'unico modo per dissipare le frizioni".
"È incredibile che il
Movimento che ha fatto della Democrazia il proprio mantra usi le picconate
social (con tweet che lanciavano hashtag gestiti da profili fake) Nei partiti
esiste questa dialettica, esistono gli scontri forti, esistono teste pensanti
che mettono alle strette il 'capo'. Fa parte della vita politica di ogni grande
gruppo, si litiga in una riunione condominiale, figuriamoci qui. Le repressione
o la genuflessione davanti al capo non fa parte del mio modo di fare. Di solito,
dopo queste forti discussioni, si esce sempre migliori oppure a pezzi ma qui non
esiste chi ha ragione e chi ha torto ma solo chi ha idea diverse per arrivare
allo stesso obiettivo", conclude.
"È la solita strategia
dell'odio. Adesso sfruttano account fake per orientare gli utenti. Quella della
macchina del fango contro Di Maio è una pratica già esistente, ci facciamo i
conti da anni". Rispondono così all'Adnkronos i parlamentari vicini al ministro
degli Esteri a chi chiede un commento sull'hashtag #DiMaioOut: una campagna
mirata, secondo i 'dimaiani' - che riportano le dichiarazioni di alcuni esperti
social tra cui Raffa -, "portata avanti con account falsi su Twitter".
"Questa nuova trovata non ci
stupisce - continuano i dimaiani -, ciò non toglie che sia un fatto molto grave.
Così si apre a quelle manifestazioni d'odio sui social che, specialmente negli
ultimi tempi, purtroppo conosciamo bene. Recentemente abbiamo visto cosa
provocano questi fenomeni, che nelle loro degenerazioni estreme possono portare
ad escalation di violenza e minacce", concludono.
"Stiamo facendo le opportune
verifiche per capire da dove parte la campagna di tweet-bombing contro Di Maio".
È quanto affermano, parlando con l'Adnkronos, gli esponenti M5S vicini al
titolare della Farnesina, i quali, alla domanda su un possibile 'fuoco amico',
aggiungono: "Speriamo di no, sarebbe molto grave".
Matteo Pucciarelli per “la
Repubblica” il 31 gennaio 2022.
C'è solo una cosa che al
momento mette d'accordo le due tribù del M5S, i "contiani" e i "dimaiani":
stavolta bisogna andare fino in fondo, perché così è impossibile andare avanti.
Tra i due, alla fine, ne rimarrà solo uno. Giuseppe Conte si sente tradito e per
Luigi Di Maio vorrebbe una sorta di processo pubblico, non solo davanti ai
parlamentari, ma di fronte a tutti gli iscritti.
Il ministro ed ex capo
politico invece non ha alcuna intenzione di scusarsi di qualcosa e anzi, tesse
la tela in quelle che prima erano le "sue" truppe, gente da lui messa in lista
nel 2018, nella convinzione che sia possibile scalzare l'attuale presidente o
comunque relegarlo in un angolo. Già provato dall'affare Riccardo Fraccaro nella
settimana prima del voto per il Quirinale, con il già ministro sospettato di
aver tramato alle spalle di Conte per mandare al Quirinale Giulio Tremonti, il
presidente del Movimento si sente accerchiato. I take delle agenzie di stampa
sul M5S non direttamente riconducibili ai vertici, i retroscena sui giornali:
ogni commento o critica al suo operato è vista come una trama dei dimaiani. E
così, a mali estremi estremi rimedi.
La parola "espulsione",
riecheggiata già per Fraccaro, ora torna per Di Maio. «Ora basta, vanno cacciati
tutti, meglio pochi ma uniti », si è sentito dire negli ultimi giorni - più
volte - da esponenti vicini all'attuale vertice. «La situazione è fuori
controllo, serve un chiaro atto di sfiducia contro Conte e i suoi», promettono
invece i dimaiani. Loro non se ne vogliono andare né gli basta fare la corrente
di minoranza. I giochi per il Quirinale sono stati una sorta di pre-congresso,
la convinzione del ministro è di poter contare su almeno 70-80 parlamentari, ad
oggi (sono solo 20, replicano dall'altra sponda).
È difficile dire come andrà a
finire, perché al di là degli schieramenti in chiaro - i pesi massimi con Di
Maio sono la viceministra all'Economia Laura Castelli e l'ex ministro Vincenzo
Spadafora; i fedelissimi di Conte sono il capodelegazione al governo Stefano
Patuanelli e l'ex reggente del Movimento Vito Crimi - c'è una vasta area grigia
dentro il M5S che non ha ancora preso una posizione e che resterà alla finestra
in attesa di fiutare l'aria. E poi ci sono le variabili. La prima: Grillo, il
garante acciaccato ma ancora capace di spostare gli equilibri. Da tempo viene
tirato per la giacca da entrambi i versanti, la sua assenza complica le cose
perché ognuno gli mette in bocca tutto e il suo contrario.
Ora viene descritto in piena
sintonia con Conte, ora infuriato per essere stato ingannato sempre da Conte
facendolo esporre su Belloni. Nessuno però dimentica la plateale demolizione di
Conte, la scorsa estate, che stava facendo anche allora saltare in aria il M5S.
Arrivarono proprio Di Maio e Roberto Fico a riportarlo a più miti consigli. Il
presidente della Camera in questi giorni si è tenuto distante dalla contesa e
tale resterà almeno fino al nuovo insediamento di Sergio Mattarella, di sicuro
un suo coinvolgimento produrrà degli smottamenti in un senso o nell'altro.
Dopodi ché Di Maio gode ormai di ampia stima nel cosiddetto establishment e non
solo politico, ma Conte ha (o avrebbe) i voti fuori dal palazzo grazie ad un
ancora alto consenso personale.
E come dimenticare infine
Alessandro Di Battista, ex di lusso oggi svincolato ma che se tornasse in
partita potrebbe ancora fare la differenza? Sui social non manca mai di
attaccare il M5S per i suoi "tradimenti" ma intanto ha comunque difeso Conte.
Chi perderà il duello rusticano potrebbe anche decidere di andarsene, fondando
altro. Un esito che complicherebbe la vita a molti: al centrosinistra e poi al
governo stesso, peraltro alla Farnesina si continua a ritenere che Conte in cuor
suo voglia farlo cadere. Commenta un big di primo piano: «Andremo in guerra, ci
saranno morti e feriti. E però obiettivi, esigenze, linguaggi e target sono
ormai troppo diversi». Chi conosce bene Di Maio lo racconta come avveduto nelle
cose di partito, pronto a ingaggiare battaglia quando è certo di vincerla.
Altrimenti chissà, dopotutto il Parlamento sembra orientato a varare una legge
proporzionale e il destino di Mario Draghi in politica potrebbe non esaurirsi al
2023.
Raffaele Barberio per
key4biz.it il 31 gennaio 2022.
Il presunto scoop lanciato
ieri sera con un tweet, si rivela all’analisi dei fatti debole e scarsamente
fondato. Sorgono invece i dubbi ed i quesiti sul perché si sia soffiato cosi
pesantemente su un caso, senza che alcuno si sia preso la briga di verificare.
Tanto rumore per nulla? Forse,
ma a giudicare da quanto accaduto sembra che il vero bombing sia stato fatto da
agenzie e giornali che si sono avventati su una notizia non verificata, che fa
invece sorgere più di un quesito.
La notizia è quella
dell’attacco via Twitter contro il ministro Luigi Di Maio, attacco che viene
definito come premeditato, realizzato tramite Bot e proveniente prevalentemente
dall’America.
È per questo che abbiamo
cercato di vederci chiaro e abbiamo sottoposto i dati a un severo controllo
rivolgendoci a WaterOnMars, che ha utilizzato la propria piattaforma di
intelligence di rete Metatron, una delle più sofisticate al mondo.
Ma partiamo dall’inizio.
Ieri sera il tweet di Pietro
Raffa
Tutto nasce da un tweet di
Pietro Raffa pubblicato ieri sera in cui si descrive un presunto tweet-bombing
contro Luigi Di Maio, all’insegna dell’hashtag #DiMaioOut.
Il tweet riscuote immediato
successo.
Stamane agenzie e testate si
avventano sul tema e inseguono Raffa, esperto di comunicazione social e
amministratore delegato della MR & Associati Comunicazione, il quale dichiara
con sicurezza:
“E’ un tweet-bombing contro Di
Maio…Ho effettuato un’analisi quantitativa e qualitativa dei tweet #DiMaioOut:
sono andato a vedere quante persone avevano utilizzato l’hashtag, si tratta di
289 account. È chiaramente un’operazione studiata, che viene fatta da chi vuole
modificare la percezione su alcuni temi”.
Tweet-boombing contro Luigi Di
Maio: I dati dicono il contrario
Ci siamo incuriositi e abbiamo
verificato che dall’analisi di WaterOnMars emergono dati del tutto differenti.
Non risulta alcun disegno di
bombing, tutt’al più di campaign, che per essere considerato tale deve affidarsi
a dei Bot, ovvero ad account generati da computer.
Al contrario, gli account
usati sono tutti riferibili a persone in carne ed ossa. Water On Mars ha
riscontrato e analizzato 884 account per un totale di 2371 tweet.
Nessun Bot
Non figurano Bot, ma
cosiddetti sock puppets, ovvero account usati poco e in un certo senso
risvegliati dopo lungo letargo oppure account multipli che appartengono alla
stessa persona (si tratta di un fenomeno tipico tra militanti politici).
Si tratta, nel nostro caso, di
account aperti nel corso degli anni dal 2010 in poi, con solo gli ultimi due
account aperti a gennaio 2022. Solo poco meno del 10% degli account coinvolti ha
twittato più di 10 tweet, con la punta massima di un account (Simo) che ha
twittato ben 128 volte tweet con #DiMaioOut.
Quindi, con buona pace del
presunto scoop, nessun tweet-bombing, né bot creati da computer, ma azioni di
persone vere, magari mobilitate da un ordine concertato, come spesso accade in
rete, specialmente in ambito politico e di militanza.
Nessun attacco dall’America
Nel presunto scoop, Pietro
Raffa parla anche della geo-localizzazione degli account usati: “Ho visto che
circa la metà di questi profili twittava contro Di Maio dall’America”.
Si tratta di un dato non
riscontrabile in alcun modo. Al contrario, tutti gli account usati del nostro
caso sono localizzati per la quasi totalità in Italia.
La controprova sta nel fatto
che ad un controllo dell’orario di attivazione degli account, figurano tutti
posizionati ad un’ora di differenza da Greenwich.
Quindi nessun attacco
proveniente da account localizzati in America: un secondo elemento, quindi, che
inficia l’attendibilità dell’analisi presentata come uno scoop e ripresa con il
pieno di fanfare dalla stampa stamane.
Luigi di Maio: Tweet-bombing?
No, news-bombing
Per la verità va anche
registrato che tutte le uscite della stampa italiana (La Repubblica, La Stampa,
Il Giornale ecc.) si colloca nell’arco di 60 minuti, tra le 12,18 e le 13,20, a
solo titolo di curiosità. Per cui più che di tweet-bombing si tratta di una vera
e propria campagna di news-bombing, ma voluta da chi?
Ci fermiamo qui con le prime
osservazioni rilevate e domani daremo seguito ad altri commenti e alla
pubblicazione delle figure, tabelle che sono state tratte in corso di
rilevazione e che sono in via di elaborazione.
Estratto dell'articolo di
Federico Capurso per "la Stampa" il 31 gennaio 2022.
«È guerra aperta». […] È
questa l’idea che circola tra i big vicini al leader M5S. Vogliono portare delle
accuse contro Di Maio, per aver tramato nell’ombra, durante la partita
quirinalizia, per aver puntato su altre candidature rispetto a quelle della
cabina di regia e per aver creato una corrente, vietata dallo Statuto. In gioco,
ci sarebbe una sentenza di espulsione. Ma a emetterla dovrebbero essere gli
iscritti M5S con un voto in Rete, perché Conte non vorrebbe sporcarsi le mani di
sangue. È quello che traspare dalle parole dell’ex premier, quando gli si chiede
di rispondere alle accuse di Di Maio sul fallimento della sua leadership nella
partita del Quirinale: «Di Maio era in cabina di regia, lo avevo coinvolto. E
ora – sottolinea - dovrà chiarire i suoi comportamenti agli iscritti, non a me».
Il ministro replica piccato:
«Non si è mai parlato di fare annunci roboanti su presunti accordi raggiunti con
Pd e Lega, oggi smentiti anche dal segretario dem Letta. Non si provi a
scaricare le responsabilità su altri». Il processo, a questo punto, è qualcosa
di più di una tentazione. […] i pontieri – come il presidente della Camera
Roberto Fico – sono alla ricerca di una mediazione pacifica. Se si andrà allo
scontro finale, invece, sembra difficile che Di Maio si presti ad un gioco al
massacro. Non vuole arrivare a una scissione […] Tantomeno vorrebbe lasciare il
Movimento che ha contribuito a costruire, ma se mai fosse costretto, gli è stato
già offerto, alcune settimane fa, un porto sicuro in cui approdare.
Il leader di Coraggio Italia,
Luigi Brugnaro, durante il faccia a faccia tra i due alla Farnesina avrebbe
offerto riparo: «Se ci sarà bisogno, potrai riunire il tuo gruppo e unirti a
Coraggio Italia», la proposta. Segno che già allora, il ministro degli Esteri
aveva annusato il pericolo. […] I contiani credono che Di Maio voglia evitare un
rimpasto, perché avrebbe paura di vedere sostituita la sua fedelissima Laura
Castelli, viceministra all’Economia, con il braccio destro di Conte, Mario
Turco. […] Dall’altra parte, gli uomini del ministro degli Esteri agitano lo
spauracchio di un ritorno all’opposizione: «Conte vuole uscire dal governo o al
massimo concedere un appoggio esterno passando da un voto della Rete». I vertici
M5S smentiscono questa ipotesi […]
Emanuele Buzzi per
il "Corriere della Sera" il 31 gennaio 2022.
Veleni incrociati e un nuovo
botta e risposta. Nel Movimento le acque restano in tempesta e nel mirino
finiscono altri esponenti M5S. I contiani temono che Luigi Di Maio voglia
spaccare il M5S per far naufragare il nuovo corso e riprendere la leadership, i
dimaiani a loro volta hanno il sospetto che Giuseppe Conte voglia far cadere il
governo e andare al voto anticipato (recuperando un volto storico come
Alessandro Di Battista) […] in settimana potrebbe esserci un incontro tra i due.
Il clima rimane tesissimo e inizia a coinvolgere anche altri soggetti dei
vertici. Il numero dei bersagli cresce. Diversi parlamentari difendono Conte ma
attaccano alcuni vice, in particolare Mario Turco e Alessandra Todde,
definendoli «non all'altezza del ruolo».
«Serve una riflessione e forse
anche dei cambi», spiegano nel Movimento. L'accusa velata (ma non troppo) è
quella di aver mal sostenuto il leader nella trattativa. I due vice - assicurano
fonti - «hanno la coscienza a posto e sono pronti a chiarire le loro scelte, che
sono state condivise collegialmente, davanti a tutti». […] ci sono malumori
anche verso il ministro degli Esteri , preso di mira anche sui social con un
hashtag, che viene accusato di essersi «venduto al nemico».
[…] Nella partita entra
Alessandro Di Battista. L'ex esponente del direttorio si schiera a fianco del
presidente contro Di Maio. «Da anni è necessaria una riflessione politica
all'interno del Movimento ma è vigliacco mettere oggi sul banco degli imputati
l'ultimo arrivato che al netto di idee diverse su alcune questioni considero
persona perbene e leale», scrive l'ex deputato. […] Conte e Di Battista si sono
sentiti anche nelle ultime settimane e il rapporto tra i due è buono.
Ecco allora che spunta l'idea
nel M5S di un asse, dell'ipotesi di reclutare nei Cinque Stelle contiani anche
l'ex in chiave antidimaio, rafforzando al tempo stesso l'ala barricadera in caso
di Movimento all'opposizione. Di sicuro - dicono i ben informati - «non sarà un
passaggio rapido», ma probabilmente servirà «un percorso condiviso» di
riavvicinamento. Per la prima volta dopo molto tempo, però, le strade di Di
Battista e dei Cinque Stelle sembrano più vicine.
Sebastiano Messina per "la
Repubblica" il 31 gennaio 2022.
Uno teneva in tasca la laurea
di «punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste », l'altro
era l'indimenticato autore della filippica in rete contro «il partito di
Bibbiano, quello che toglieva i bambini alle famiglie con l'elettroshock per
venderseli». Eppure le cose cambiano, e tra le spiazzanti novità della
Quirinaleide 2002 c'è il ribaltamento delle parti tra Giuseppe Conte e Luigi Di
Maio. Il nuovo è diventato vecchio, il vecchio è diventato nuovo.
Ora naturalmente si incrociano
dietrologie e sospetti - c'è chi dice che Giuseppi puntasse al voto anticipato e
c'è chi sospetta che Giggino aspirasse alla poltrona di Draghi - ma l'onestà
impone di attenersi agli atti, dai quali il presidente del Movimento oggi
risulta un alleato inaffidabile che tramava in segreto col nemico mentre il
giovane ministro degli Esteri emerge come il difensore decisivo contro
l'invasione di campo inutilmente tentata dal pasticcione Salvini.
Conte esce a pezzi dalla sei
giorni di Montecitorio. Pochi avrebbero immaginato di assistere a una
trasmutazione così repentina dell'ex premier, a lungo corteggiato, lusingato e
accarezzato dagli eredi della Ditta che vedevano in lui addirittura il nuovo
Prodi, il domatore democratico dei grillini selvatici, il campione da schierare
contro il centrodestra.
Dopo l'ormai celebre
definizione di Nicola Zingaretti - che forse se ne sarà pentito cento volte -
Massimo D'Alema lo ha incoronato «l'uomo più popolare d'Italia», il Richelieu
rosso Goffredo Bettini gli ha privatamente regalato i suoi raffinati consigli,
Pier Luigi Bersani ne è diventato il difensore d'ufficio nei talk show, perché
«ha una sua popolarità che bisogna esser ciechi o malintenzionati per non
vederla», e anche Enrico Letta lo ha sempre trattato come l'indispensabile
partner con cui disegnare il suo Campo Largo. Poi è cominciata la partita del
Quirinale e l'azzimato Avvocato del Popolo con la pochette a quattro punte è
improvvisamente sparito dai radar del Pd.
Per tre volte si è sparsa la
voce di un patto segreto tra lui e Salvini - il suo ex ministro al quale il 20
agosto 2019 mise la mano sulla spalla, sui banchi di un governo cadente,
facendogli l'elenco degli errori commessi - e su Twitter qualcuno ha
perfidamente dedotto che «Letta è alleato di Conte, ma Conte non è alleato di
Letta». Due anni e mezzo di lavorìo mediatico con il Nazareno e con i compañeros
gettati alle ortiche con l'improvvisazione di un maldestro praticante di studio
che si fa beccare mentre telefona alla controparte.
La parabola discendente di
Conte incrocia quella di Di Maio, che ora punta di nuovo verso l'alto. Il
rampante "capo politico" che dopo la rottura con Salvini non voleva l'accordo
con i vecchi nemici del Pd, l'arrogante candidato premier che invocava
l'impeachment di Mattarella, lo spregiudicato capopopolo che andava in macchina
a Parigi con il subcomandante Dibba per solidarizzare con i gilet gialli contro
il feroce Macron è come se fosse stato inghiottito da un buco nero.
Al suo posto c'è un altro Di
Maio, che parla il linguaggio felpato dei dorotei, però ha dimostrato la lealtà
di un ministro moroteo ma anche l'astuzia di un luogotenente andreottiano.
Insomma, sembra un democristiano del Terzo Millennio. Saranno stati i due anni
di tirocinio alla Farnesina, sarà stata la sua spettacolare capacità di
adattamento, fatto sta che l'ex ragazzo di Pomigliano d'Arco - che con i 189
voti raccolti alle "parlamentarie" pentastellate riuscì nel 2013 a diventare
addirittura vicepresidente della Camera oggi ha dimostrato di aver imparato
rapidissimamente le regole della politica: ha fatto fallire i piani di Salvini,
si è schierato con Draghi, ha dato per primo l'ordine di votare Mattarella e ora
sfida Conte nel Movimento. Così toccherà a quelli che chiamavamo grillini
decidere quale dei due è Nuovo e quale è il Vecchio. (ANSA il 31 gennaio 2022) -
Lo scontro tra Conte e Di Maio? "Credo che a Luigi interessi più salvaguardare
il suo potere personale che la salute del Movimento", dice intervistato da 'Il
Fatto Quotidiano' Alessandro Di Battista, per il quale "o si arriva a una resa
di conti, o faranno prima a cambiare il nome del M5S in Udeur. I 5Stelle che mi
chiamano sono preoccupati. Ma ciò che sta accadendo io lo avevo già previsto due
anni fa".
"Conte - afferma l'ex deputato
- è l'ultimo arrivato nel M5S, per così dire. Se il capo politico fosse stato Di
Maio, Draghi sarebbe stato il presidente della Repubblica. E io, che non avrei
votato Mattarella, proprio come hanno fatto gli ex del M5S, reputavo Draghi al
Colle lo scenario peggiore". A suo avviso, però, anche Conte si è mosso male
nella partita per il Quirinale: "Avrebbe dovuto far votare la Belloni in Aula, a
qualunque costo", "se c'era davvero l'accordo tra Pd e M5S su quel nome, non
vedo il problema".
E aggiunge: "Io avrei
preferito altre soluzioni. Ma certamente Belloni avrebbe rappresentato un
segnale di discontinuità in un Paese gattopardesco". Un suo rientro? "Adesso -
risponde - la sola cosa che mi interessa è supportare i referendum popolari. E
proseguire nella de-santificazione del messia Mario Draghi".
Fango M5s su Di Maio:
pioggia di tweet (falsi). E pure Dibba lo attacca.
Domenico Di Sanzo l'1 Febbraio
2022 su Il Giornale.
Il "Fatto" addita il nuovo
nemico: il ministro degli Esteri. L'ira di Grillo contro Giuseppi.
Giuseppe Conte e Luigi Di
Maio, parlamentari e profili twitter, la base e il Fatto quotidiano. La
battaglia tra i due leader del M5s è a un punto di non ritorno. E in tanti, tra
deputati e senatori, sono convinti che alla fine ne resterà soltanto uno. Le vie
d'uscita per evitare una scissione dolorosa sono due: un intervento
provvidenziale di Beppe Grillo oppure uno strappo allo statuto, con
l'introduzione della possibilità di creare delle vere e proprie correnti, fino a
ora vietate.
La polemica del giorno che
contrappone dimaiani e contiani è il linciaggio via social a cui è stato
sottoposto il ministro degli Esteri. La shitstorm coinvolge due hashtag,
#DimaioOut e #Dimaiofaischifo. Una valanga di tweet di insulti indirizzati
all'ex capo politico. Accusato di essere un «traditore», un «venduto», il «Renzi
dei Cinque stelle». Definizione, quest'ultima, coniata dal direttore del Fatto
quotidiano Marco Travaglio nel suo editoriale di domenica. «Il problema è il
Fatto - dice un deputato grillino di area Di Maio - per i nostri elettori
Travaglio è la bibbia». E infatti il quotidiano vicino a Conte ieri sforna due
pagine di attacchi al titolare della Farnesina. A pagina 2 un retroscena con un
titolo eloquente: «Promesse al Caimano, Casini, Casellati&C: 50 sfumature di
Gigino». Per i dimaiani si tratta «di una narrazione che vuole dipingere Luigi
come il cattivo». Il fuoco di fila prosegue a pagina 3, con un'intervista ad
Alessandro Di Battista. «Luigi pensa al potere», spiega Dibba. Ed è proprio il
«bacio» tra l'avvocato e l'ex parlamentare a preoccupare la truppa sbandata che
teme l'instabilità, il ritorno all'opposizione e la crisi di governo.
Se l'attacco del Fatto è
deliberato, restano i dubbi sull'origine dei tweet contro Di Maio. «Se fosse
fuoco amico sarebbe grave», spiegano all'Adnkronos fonti vicine al ministro
degli Esteri. I dimaiani parlano di «macchina del fango e strategia dell'odio».
Anche secondo l'esperto di social Pietro Raffa siamo davanti a «una chiara
operazione di tweet bombing contro Di Maio». Per l'analista l'hashtag #DimaioOut
è stato usato da pochi profili, tra cui alcuni che twittavano dall'America. In
pratica si tratterebbe di bot, account falsi programmati per twittare
automaticamente. I contiani invece fanno girare nelle chat uno studio che
dimostrerebbe l'autenticità dei messaggi.
Siamo al muro contro muro,
anche se il capogruppo alla Camera Davide Crippa smentisce ipotesi di scissione.
Girano voci di un faccia a faccia imminente tra i due rivali. «Luigi spiegherà
agli iscritti», dice la vice di Conte Alessandra Todde. Chi è vicino a Conte
chiede l'espulsione del ministro. I parlamentari che conoscono bene Di Maio
scommettono che l'ex capo politico andrà fino in fondo. Si parla di un'assemblea
in cui Conte potrebbe decidere di far votare agli iscritti un documento in cui
ribadisce la correttezza del suo operato. Sullo sfondo la questione in sospeso
del limite dei due mandati. Se Conte usasse la conferma della regola come una
clava interna, impedirebbe a Di Maio di ricandidarsi, ma sbarrerebbe la strada
del Parlamento anche ad alcuni contiani come Paola Taverna.
Tra i due contendenti c'è
Beppe Grillo, che viene descritto come molto irritato con l'avvocato perché
l'avrebbe convinto a scrivere il discusso tweet pro-Belloni. Il giallo della
notte di venerdì viene già definito nei gruppi come «il casus Belloni» che ha
fatto scoppiare la guerra tra Conte e Di Maio.
Domenico Di Sanzo
Qualcuno salvi Luigi dal
"metodo Travaglio".
Francesco Maria Del Vigo l'1 Febbraio 2022 su Il Giornale.
Qualcuno salvi Di Maio dal
grillismo. Il ministro degli Esteri in queste ore è al centro di quella che è
una vera propria aggressione mediatica.
Qualcuno salvi Di Maio dal
grillismo. Il ministro degli Esteri in queste ore è al centro di quella che è
una vera propria aggressione mediatica. I più moderni la chiamano con inglesismo
molto efficace, ma decisamente poco raffinato: shitstorm. I più tradizionalisti
la chiamano «macchina del fango». Ma il risultato non cambia. Ieri tra gli
hashtag più diffusi su Twitter troneggiava l'esplicitissimo #dimaioout, una
tempesta perfetta (e sospetta) che si abbatte sull'ex leader pentastellato
colpevole, secondo i suoi, di aver tramato contro Conte.
Così Di Maio finisce vittima
dello stesso sistema di disinformazione che i Cinque stelle per anni hanno
foraggiato e alimentato. Le squadracce che oggi seminano odio sul web contro di
lui, sono le stesse che per anni lo hanno fatto contro ogni avversario politico.
Non serve la scientifica per rilevare le impronte digitali. C'è già la firma del
metodo Cinque stelle, che è un parente stretto del metodo Fatto quotidiano:
colpire e insultare chi è contro la linea ufficiale. E le purghe staliniane si
applicano tanto all'esterno quanto all'interno dello stesso partito. Anzi, come
dimostra la ferocia degli attacchi all'inquilino della Farnesina, è proprio tra
le mura di casa che i colpi diventano più feroci. La strategia è rodata: si fa
girare una voce, un sospetto, una maldicenza che molto spesso tracima
nell'isteria complottista e poi basta avere delle truppe digitali pronte a
spammare odio in ogni angolo del web o anche, come parrebbe in questo caso, dei
semplici bot, dei pacchetti di account dormienti risvegliati alla bisogna. Il
gioco è fatto.
In men che non si dica si
entra nelle tendenze di Twitter e il caso creato a tavolino diventa un
tormentone nazionale. Se poi si ha anche la sponda di un quotidiano compiacente
è pure meglio... Il meccanismo è tanto semplice quanto vigliacco, specialmente
quando chi agisce è coperto dall'anonimato di profili inesistenti. Ma, come
dicevamo, è tradizione della casa.
Se i grillini decidessero di
scrivere una autobiografia corale sotto forma di trattato potrebbero intitolarla
«Teorie e tecniche dello sputtanamento digitale», un'arte nella quale nel corso
degli anni hanno dimostrato di eccellere. Però, questa volta, nel colpire senza
scrupoli quello che era il loro leader, c'è un passo ulteriore verso l'abisso. I
tweet sguaiati contro Di Maio sono i selfie di un partito diviso per bande, di
una guerra fratricida che rischia di essere l'ultimo esausto capitolo della saga
a Cinque stelle.
Francesco Maria Del Vigo è
nato a La Spezia nel 1981, ha studiato a Parma e dal 2006 abita a Milano. E'
vicedirettore del Giornale. In passato è stato responsabile del Giornale.it. Un
libro su Grillo e uno sulla Lega di Matteo Salvini. Cura il blog Pensieri
Spettinati.
La crisi dei partiti
spiegata attraverso i manifesti.
Corrado Ocone su Il Riformista
il 30 Gennaio 2022.
Assieme ai comizi,
il manifesto è stato il principale strumento della comunicazione e della
propaganda politica nell’Italia repubblicana. I partiti ne hanno considerato
sempre il valore, la forza comunicativa racchiusa in uno slogan e in una
immagine studiati appositamente per colpire al cuore militanti ed elettori.
Questa funzione simbolica è risultata tanto più efficace quanto più la politica
si rinchiudeva spesso in linguaggi esoterici, gergali, allusivi, francamente
incomprensibili a chi non faceva parte della ristretta cerchia dei politici di
professione (si pensi solo alle “convergenze parallele” di Aldo Moro).
Attraverso i manifesti, il
loro contenuto e la loro evoluzione anche stilistica, è possibile perciò
ricostruire la storia non solo dell’Italia politica, ma di tutta la società
italiana del dopoguerra: dalla fondazione della Repubblica al boom economico,
dagli “anni di piombo” fino a Mani Pulite e oltre. È con questo intento che è
stato costruito un affascinante libro per immagini appena edito da Carocci e di
cui è autore Edoardo Novelli, docente di Comunicazione politica a Roma III: I
manifesti politici. Storie e immagini dell’Italia repubblicana (pagine 263, euro
24). Per prima cosa, Novelli ha selezionato più di cento manifesti politici, non
necessariamente i più importanti o i più diffusi. La scelta è avvenuta in base
al criterio, indubbiamente personale, della significatività, in modo però da
coprire le varie aree politiche e i vari stili espressivi. Poi ha diviso il
materiale cronologicamente per decenni, dagli anni Quaranta del secolo scorso
agli anni Duemila, alternando la riproduzione di ogni manifesto (è un libro da
gustare anche visivamente) con una pagina di descrizione e di acute osservazioni
sia storiche sia estetiche.
In generale, può dirsi che la
stagione dei manifesti politici ha avuto due fasi, suppergiù corrispondenti alle
cosiddette Prima e Seconda Repubblica. Fino poi a scemare con l’avvento dell’era
digitale, che per certi versi può considerarsi una continuazione con altri
mezzi, e maggiore intensità, di quel “parlare per immagini” che è stato proprio
dei manifesti. Nella prima fase, il predominio è stato quello del classico
foglio 70X100, che è stato affisso sui muri d’Italia soprattutto in occasione
degli scontri elettorali, a cominciare da quelli del referendum per la
Repubblica del ‘46 e delle elezioni politiche del ‘48. Le quali ultime, per la
virulenza dello scontro fra comunisti e anticomunisti, rappresentano forse il
momento più alto e intenso di questa storia (classico resta il manifesto
democristiano che afferma perentorio che “nel segreto delle urne Stalin non ti
vede ma Dio sì”).
Inutile dire che fra i
militanti delle diverse parti sui manifesti si è scatenata una vera e propria
concorrenza, fatta anche di colpi bassi: i manifesti degli uni venivano, ad
esempio, spesso strappati o ricoperti di notte da quelli degli altri. Man mano
che avanzano gli anni Ottanta e poi soprattutto negli anni Novanta, il manifesto
politico diventa spesso un enorme cartello pubblicitario, il più delle volte con
il volto sorridente dei leader come testimonial. È il portato dell’avvento del
maggioritario e della personalizzazione della politica e dei partiti. Nonché di
un certo populismo di fondo (il “meno tasse per tutti” o il “milione di posti di
lavoro” di Silvio Berlusconi da questo punto di vista ha fatto scuola). Molto
vitale è stato anche il decennio dei Settanta, con l’esplodere di sigle
extraparlamentari e con l’avanzare invece, a livello politico più istituzionale,
delle battaglie per i diritti civili, sfociati nelle
due campagne referendarie per il divorzio e l’aborto.
Man mano avanzano anche i temi
ambientalisti, fra nucleare e caccia, e si fa strada persino l’animalismo, con
una Marina Ripa di Meana che nel 1996 posa completamente nuda mostrando una
folta peluria nelle parti intime sovrastata dalla scritta: “L’unica pelliccia
che non mi vergogno d’indossare” (oggi forse una immagine del genere sarebbe
impossibile, o sarebbe accusata di essere sessista). Gli ultimi manifesti
politici riprodotti sono quelli per la campagna elettorale del 2018 e fanno
davvero impressione per l’elementarità del messaggio e per l’impoverimento
culturale che testimoniano. Si può dire che “la fine del manifesto politico” di
cui parla Novelli è la fine, o almeno la profonda crisi, dei partiti politici. È
la crisi in cui siamo sprofondati del sistema politico italiano. Corrado Ocone
Alessandro De Angelis
per huffingronpost.it il 2 febbraio 2022.
Ebbene sì, non resisto, anche
questa e la violazione di un segreto professionale. Pero e per dare una
medaglia. Anzi il titolo di “migliore Cassandra” degli ultimi tempi. A insaputa
dell’interessato che, temo, potrebbe sinceramente arrabbiarsi. La Cassandra e
Marco Minniti uomo colto, esperto, incorruttibile.
Ma carattere spigoloso,
speriamo bene. Sapete, l’attività di un giornalista e fatta di una miriade di
contatti, incontri, chiacchierate anche per capire come vanno le cose.
Facciamola breve: in questi due anni, incredibili, e dopo l’ultima settimana sul
lotto volante, si e sentito di tutto.
Sfogliando il taccuino degli
appunti informali, la conclusione e che e l’unico, con cui il sottoscritto ha
parlato che, come si suol dire, le ha azzeccate tutte. C’è anche chi le ha
sbagliate tutte, ahime, tra i gruppi dirigenti dei partiti.
Ne racconto un paio, che tanto
dettagli non sono. Piena pandemia, prima ondata, contismo imperante, - ricordate
“il punto di riferimento dei progressisti europei”? – sbornia collettiva da
casalinismo: “La pandemia – recita il taccuino – ha dato al governo un ubi
consistam che non aveva, ma le contraddizioni saranno inevitabilmente destinate
a esplodere con l’aggravarsi della crisi che sta andando fuori controllo. Il
punto e che i gruppi dirigenti dei partiti si muovono scomposti, nell’illusione
di determinare gli eventi, ma ne saranno travolti, girano a vuoto”.
Si sente il Pci di una volta,
grande scuola: l’attenzione al processo reale delle cose, il movimento di fondo
e non il tweet di giornata. Sei mesi prima dell’arrivo – giuro: sei mesi - c’è
scritto: “Si arriverà a un punto in cui Mattarella sarà chiamato a un’assunzione
di responsabilità. Perchè quella che e in atto non e una normale crisi politica
strisciante, ma una crisi di sistema conclamata, in cui nessuno degli attori e
in grado di prospettare una soluzione. Arriverà Draghi”.
Prima di questa chiacchierata,
Minniti ha lasciato il Parlamento, si e traferito a Leonardo, ex Finmeccanica,
la grande azienda a partecipazione pubblica impegnata nei settori della difesa,
della sicurezza e dell’aerospazio. Li gli hanno affidato la presidenza di una
fondazione Med-Or, che ha il compito di formare classi dirigenti e promuovere
relazioni economiche e culturali nel Mediterraneo.
Vai sul sito a vedere quello
che ha fatto, pare un ministro degli Esteri. Fuori dal Parlamento c’è più
politica di quanto si possa pensare, peccato che se ne vanno quelli bravi. O
forse sono costretti ad andarsene proprio in quanto bravi. Vabbe, lo conoscete,
da palazzo Chigi fino al Viminale. Si dice: l’uomo che ha fermato gli sbarchi.
Meglio dire: colui che ha avuto un’idea di governo dell’immigrazione. Rinnegata
dal Pd. Nel dubbio tra linea sua e quella di chi lo ha criticato, ha scelto di
non averne nessuna acconciandosi su una onesta prefetta.
La sera che arriva Draghi, lo
cerco. Talvolta l’impresa e titanica. Affezionato al mare e alle radici, ogni
fine settimana torna sempre nella sua casa sul mare, vicino Reggio Calabria.
Spartana, praticamente un faro sul mare. Tocca chiamare il fisso, con tutto il
rispetto per la Calabria, le infrastrutture telefoniche non sono i punti di
eccellenza.
“Mattarella ha convocato
Draghi al Colle per domani mattina”. Risposta: “Bene, ma una cortesia: possiamo
sentirci dopo che sto guardando l’Inter?”. Per molti sarebbe un vezzo, in questo
caso e fatto proprio così. Per inciso: nessuna intervista pubblica, in questo
periodo.
Ti chiedi: ma se un semplice
cronista, che nel frattempo e diventato amico, almeno credo, ascolta e si fida
delle sue analisi, come mai non sta nelle stanze della direzione politica di un
partito dove e stato per una vita? Misteri. Cambiamo taccuino, e avviamoci alle
conclusioni. In autunno invita a riflettere: “Siamo gia dentro una curvatura
“presidenzialista” del sistema politico e della democrazia italiana. L’Italia,
per come si e dispiegata la crisi, e, in questo momento, il paese dei “due
presidenti”, Draghi e Mattarella.
Loro si occupano
dell’interesse generale. Attorno un sistema partitico ancora dentro il default
che ha reso necessaria la soluzione di emergenza. Per capire la partita del
Quirinale si deve partire da qui”. Voi capite che, nella perenne ricerca di
bussole, un giornalista, ossessionato dal racconto ma anche dal come va a
finire, non resiste alla tentazione.
E, dopo la conferenza stampa
di Draghi, quella dell’auto-candidatura, rieccoci sul telefono fisso. Mi becco
una lezione, severa e pedagogica, sentendomi come quei segretari delle
federazioni provinciali che incontravano, per la prima volta a Botteghe oscure,
il dirigente della segreteria del Pci: “Non essendo nelle condizioni di fare un
governo per il dopo, Draghi sarà costretto a chiedere Mattarella di rimanere.
Perchè un altro governo non c’è, e Mattarella e l’unico in grado di tutelare
l’equilibrio politico e il paese.
E Mattarella sarà costretto a
rimanere, anche contro la sua volontà. Ripeto: anche contro la sua volonta”.
C’ha pensato il tanto vituperato Parlamento, in un atto di autogestione, mentre
la crisi di sistema ha travolto anche la discussione sul Quirinale, in un remake
dello scorso anno di questi tempi. Ultima telefonata, sabato mattina, quando
finalmente e fatta. Neanche il tempo di dire “pronto”: “Adesso, andate tutti
affanculo. Devo dare da mangiare ai cani”. Clic.
Antonello Piroso per "La
Verità" l'1 febbraio 2022.
«Sono due o tre sere che ti
avrei dato la stessa risposta, l'esito a mio avviso è scontato». Apperò. E in
virtù di quale riflessione? «Guardo queste cose dall'alto, come se vivessi in un
altro Paese, senza seguire nevroticamente il minuto per minuto, e mi sembra che
è la cosa che ha più senso, e più passa il tempo e più me ne convinco».
Sì, vabbè, ma cioè? Quale
«cosa»? Per caso il nome del prossimo capo dello Stato? «Esatto. Che quindi
sarà... Mario Draghi». E difatti. Esibirsi in una granitica previsione a 48 ore
dal fischio finale dimostra una fiducia nelle proprie facoltà divinatorie che in
pochi possono permettersi. Paolo Mieli può.
È lui il Branko(lo) di cui
sopra, ospite in tv su La 7 giovedì sera. Uno svarione su cui ha maramaldeggiato
Augusto Minzolini, direttore del Giornale: «Giorni fa ho sentito Mario Calabresi
(ex direttore di Repubblica, nda) e Paolo Mieli dire in coro: il prossimo
presidente è Draghi, sicuro. A quanto pare il mago Otelma ci azzecca di più.
Succede quando si scambiano desideri per dati della realtà».
Che è ciò succede a Minzo
quando legge i dati di vendita del quotidiano che dirige, ma non satireggiamo
troppo, ché il tema è altro, e ben più «alto». Ovvero, la tendenza di alcune
vacche sacre - absit iniuria verbis - del giornalismo italico, cui io «non sono
degno neppure di slegare i lacci dei sandali» (la citazione è dai Vangeli), a
emettere sentenze con il timbro della inappellabilità. Intendiamoci: alzi la
mano chi non ha mai preso una topica. Ci caschiamo tutti, prima o poi, e i
politici in questo fanno scuola.
Ma si sa: loro, sbilanciandosi
tra promesse e profezie, sono abituati a pensare una cosa, dirne una seconda,
farne una terza, per poi giurare di essere stati fraintesi. Noi iene
dattilografe non potremmo però evitare? Mieli è pure recidivo.
L'8 gennaio 2018, a due mesi
dalle elezioni politiche, ospite su La 7 con Matteo Renzi, a precisa domanda su
come sarebbe andata per il Pd, di cui il Toscano del Grillo («Io so' io, e voi
eccetera...») era allora segretario, replicò: «Non sono catastrofista, è messo
meglio di quanto lo danno i sondaggi, dovessi scommettere direi che i risultati
saranno migliori».
Va bene, però dimmi la morale,
pardon: la percentuale, lo incalzò maligna Lilli Gruber, e lui: «Il 25% sarebbe
un voto clamoroso» (la regia, perfida, staccò sulla faccia di Renzi tra il
perplesso e lo spiazzato). E difatti.
Così clamoroso che, per la
cronaca, il Pd andò peggio del peggior sondaggio di quei mesi, la rilevazione di
Tecnè che all'inizio dell'anno lo dava al 20,7%, inchiodando nelle urne al
18.8%. Anche a Enrico Mentana è toccato inciampare in un errore di valutazione.
Mentre si occupava del romanzo
Quirinale, in un fuori onda durante un servizio su Giuseppe Conte si è lasciato
andare: «È quello che se la sta giocando meglio di tutti».
Per completezza va aggiunto
che aveva premesso: «Non l'avrei mai detto». Che è stata la mia reazione quando
ho sentito quel giudizio: 'a Enrì, ma che stai a dì? Mai avrei pensato che tu
potessi anche solo lontanamente immaginarlo, un Conte che contasse.
Tant' è che quando Giuseppi si
è esposto su un possibile voto del M5s a favore di Draghi al Quirinale, la
nemesi ha voluto che la telefonata di smentita di Beppe Grillo, «ipotesi che non
esiste», sia arrivata proprio a Mentana mentre era in onda. Da Grillo all'aedo
dei grillonzi - e «vedova di Conte» - Marco Travaglio è un attimo.
Ecco come, su La 7 (e dove
sennò?, dicembre 2020), pontificava con la consueta aria di umile superiorità:
«Il governo Draghi? Una simpatica barzelletta. A me non risulta lui voglia fare
il premier. E poi non esiste una maggioranza pronta a sostenerlo. Il M5s non lo
voterebbe, la Lega non lo voterebbe. Lo chiamino, così scopriranno la sua
indisponibilità e la pianteranno con 'sta storia».
E difatti (messo peggio di
lui, sul tema, ci fu solo Carlo De Benedetti - non è un giornalista, ok, ma è
pur sempre un editore, prima di Repubblica ed Espresso, oggi di Domani - che
ancora su La 7, settembre 2020, pronosticava: «Escludo nel modo più categorico,
conoscendolo bene, che Mario Draghi possa fare il presidente del Consiglio»).
Quando non giochiamo al
«gràttati e, magari, vinci» a casa nostra, ci avventuriamo a commentare il voto
degli altri: «La campagna elettorale di Donald Trump è ufficialmente finita
stanotte, al terzo dibattito con la rivale Hillary Clinton», era il fulminante
incipit di un post su Facebook a due settimane dal voto del 2016 (se non lo
trovate, il sito Dagospia lo ha in archivio) firmato da Gianni Riotta - già
direttore del Tg1 e del Sole 24 Ore, uno dei 39 esperti selezionati per il
«Gruppo di alto livello contro la disinformazione», promosso dalla Commissione
europea per combattere le fake news - che condiva il de profundis con un
verdetto apodittico: «Hillary vincerà». E difatti. Per questo, fossi in Giorgia
Meloni, davanti al tweet di Vittorio Feltri, a rielezione di Sergio Mattarella
ufficializzata: «Il centrodestra si è sfasciato. Un suicidio.
L'unica che si salva è Giorgia
Meloni, grande donna che non si piega e non si spezza. Alle prossime elezioni il
suo sarà il primo partito», ringrazierei per la stima (reciproca: lei lo ha
candidato nel 2021 a Milano con un'esternazione tracimante entusiasmo: «Sono
estremamente fiera di annunciare che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di
iscriversi a Fratelli d'Italia e che lo abbiamo convinto a guidare la lista di
Fdi alle prossime elezioni amministrative»). Ma terrei a portata di mano un
corno napoletano.
Giulia Cerasoli per “Chi” il 2
febbraio 2022.
Forse il fattore umano del
presidente della Repubblica più amato dalla gente, che negli ultimi mesi, quelli
dei saluti, era stato applaudito alla Scala e acclamato per strada dai cittadini
che gli chiedevano un bis, sta proprio nella sua eccezionale normalità.
Sergio Mattarella ha accettato
il secondo mandato per senso del dovere e perché la situazione del Paese lo
richiede, anche se aveva davvero altri piani per il suo futuro.
Da poco aveva preso in affitto
un appartamento in una strada a metà tra il quartiere Parioli e Villa Ada,
accanto all’abitazione della figlia Laura che sempre lo ha seguito nel primo
settennato mettendo da parte la sua professione di avvocato.
L’aveva arredata anche con
alcuni mobili trasferiti dalla celebre casa di via Libertà a Palermo e già aveva
fatto amicizia con alcuni condomini.
Voleva stare più vicino alla
famiglia, agli altri due figli, Francesco e Bernardo Giorgio, e ai nipoti che
ormai sono grandi (alcuni studiano a Londra), ma che il Presidente nonno ha
sempre seguito molto da vicino.
Sergio Mattarella, compiuti
gli 80 anni, aveva voglia di una vita normale. Ma il suo senso del dovere ha
sempre prevalso sulle scelte personali. E così domenica scorsa ha fatto il
trasloco al contrario.
Con l'aiuto dei servizi della
presidenza della Repubblica è andato a riprendersi le sue cravatte, il suo
guardaroba, i dischi di Mina che ama tanto, i suoi libri, le lettere dei bambini
di tutta Italia, i documenti privati e li ha rimessi negli scatoloni per
riportarli al Quirinale.
Nato a Palermo il 23 luglio
del 1941, ha studiato a Roma, ma ha sempre conservato un at-taccamento viscerale
verso la sua terra d'origine, la Sicilia.
Studioso e costituzionalista
avrebbe preferito, per il suo carattere riservato, una carriera esclusivamente
accademica rispetto a quella politica e pubblica. Ma la morte del fratello
Piersanti, presidente della Regione Sicilia, assassinato dalla mafia il 6
gennaio 1980, cambiò i suoi piani.
Quel giorno in cui si ritrovò
nel mezzo di via Libertà a Palermo, con il fratello agonizzante tra le braccia,
capì che la sua vita avrebbe preso una strada diversa.
Il senso del dovere, anche
allora, e il rispetto per il sacrificio del fratello, lo spinsero a impegnarsi
politicamente.
Quell'episodio drammatico pesa
sul suo cuore insieme con una tragedia privatissima di cui non parla mai: la
scomparsa della moglie Marisa Chiazzese nel 2012 a causa di un tumore. Ogni anno
tutta la famiglia ricorda quella donna amatissima, sorella della moglie di
Piersanti e che il capo dello Stato descrisse come «la persona per me più cara
al mondo».
Da cattolico osservante e
siciliano doc, il Presidente ha un grande senso della famiglia. Ha cresciuto
come suoi i figli del fratello scomparso (Maria e Ber-nardo) e ha una spiccata
sensibilità verso l'universo femminile, al punto che prima di diventare
Presidente, in occasione delle feste di compleanno, pare usasse far recapitare
un omaggio a ciascuna delle donne di famiglia.
Un uomo normale e perbene che
sognava di ritirarsi nella sua normalissima casa (tra l'altro non aveva una casa
sua dalla morte della moglie) per godersi il meritato riposo.
Che cosa succederà adesso che
è stato rieletto per un altro settennato sul Colle più alto? Qualcuno ha
ipotizzato che avendo già arredato il nuovo appartamento, lo terrà per andarci a
trascorrere del tempo con la famiglia, magari nei fine settimana. Anche il suo
predecessore, Giorgio Napolitano, ha sempre conservato la sua casa nel quartiere
Monti anche quando era capo dello Stato.
Qualcuno ha persino azzardato
l'ipotesi che Mattarella abbia il diritto di chiedere di esercitare i suoi
poteri di Presidente in smart working, da casa sua, visto che l'hanno costretto
a restare più del dovuto, quando la sua volontà diceva altro... Insomma,
Mattarella deciderà e sarà una scelta oculata come al solito.
Saggio, patriota, sempre con
un pensiero per i più deboli: tutto questo nel caso del Presidente coincide
anche con uno straordinario consenso popolare.
Nonostante il carattere
riservato e non esuberante (condiviso dalla figlia-first lady Laura, che ha
concesso a “Chi” la sua unica intervista durante una missione diplomatica in
Africa), Sergio Mattarella ha progressivamente conquistato un ampio consenso
mediatico, grazie al suo carattere e ad alcune curiosità inattese.
Prima fra tutte il famoso
fuorionda in cui confessò al suo portavoce Giovanni Grasso, che anche lui, nel
corso del lookdown non aveva potuto tagliarsi i capelli.
L' idea che anche il
Presidente in lockdown avesse dovuto affrontare i problemi quotidiani che
avevano colpito tutti gli italiani - compreso, banalmente, non poter andare dal
barbiere - ha conquistato tutti e lo ha trasformato in una star su Instagram.
Di barbieri comunque
Mattarella dovrebbe averne almeno due: uno a Palermo, che si chiama Franco
Alfonso, e uno a Roma, che si reca al Quirinale ogni 15 giorni per tagliargli i
capelli.
Capigliatura a parte, è il
primo capo dello Stato influencer in Italia. Oltre a essere seguitissimo sui
social, il Presidente ha diversi profili a lui dedicati, compreso "le bimbe di
Mattarella" (come i divi dei reality), che crea me-me e vignette a raffica su
tutto quello che fa. E che ha sbancato proprio in occasione di questa
rielezione.
Cosa che pare faccia sorridere
molto anche i suoi nipoti adolescenti, fieri dell'amore del loro nonno per la
tecnologia.
Tra le sue passioni, oltre a
quella per la musica classica e per l'opera lirica, è esplosa quella per lo
sport nel suo complesso.
Una volta era solo tifoso del
Palermo, mentre ora segue la Nazionale, di persona quando possibile, nelle
trasferte più importanti. E ha sostenuto gli atleti olimpionici che hanno
portato medaglie e onori al nostro Paese.
Nel corso del primo settennato
chi, come noi, ha avuto il privilegio di seguirlo in alcuni viaggi di Stato
all'estero, ha potuto osservare il suo grande interesse per l'arte, lo stupore
per le meraviglie del mondo come il tesoro di Petra, quando fu ospite del re e
della regina di Giordania sotto una tenda a sorseggiare tè, o l'energia con cui
saliva rapidamente le scale delle chiese rupestri di Lalibela in Etiopia a
tremila metri di altezza.
«Papà, vai piano, mica
riusciamo a starti dietro se corri così», gli sussurrò quella volta la figlia
Laura, arrancando come tutti dietro al Presidente in doppio-petto blu anche in
quella curiosa situazione nel centro dell'Africa. E aveva ragione.
Nessuno riesce a stargli
dietro. Perché, sotto quell'aria mansueta e quell'ironia tutta siciliana, si
nasconde la fermezza della serenità. «Ricordate sempre che mio zio è un uomo
dolcissimo e rassicurante, per questo piace tanto ai giovani», ci confidò un
giorno la nipote Anna Adragna, aprendoci il suo inedito album fotografico.
Stasera Italia, Giovanni
Minoli e la "messinscena Mattarella": "Cosa mi dicevano gli amici siciliani".
Libero
Quotidiano il 02 febbraio 2022
Giovanni Minoli, ospite
di Stasera Italia in onda su Retequattro, ha parlato della rielezione di Sergio
Mattarella al Quirinale. Alla domanda della conduttrice Barbara Palombelli, se
fosse tutta una messinscena, Minoli risponde che: "troppe fotografie del
trasloco. Molti miei amici siciliani erano tutti molto tranquilli, perché
sapevano che Mattarella sarebbe rimasto", afferma il conduttore di Mixer. Tu
chiamale se vuoi "sensazioni", ma la verità forse è che il meccanismo mediatico
scelto dallo staff del Capo dello Stato uscente (e rientrante) aveva un sottile
e astuto obiettivo. Perfettamente centrato, alla luce di quanto successo sabato
scorso.
La Palombelli ricorda che
nella sua trasmissione il quirinalista Marzio Breda, giornalista del Corriere
della Sera: "Dobbiamo riavvolgere i nastri. Anche lui qui in trasmissione aveva
previsto che l'attuale Capo dello Stato sarebbe stato riconfermato". Una scelta
arrivata dopo sei giorni di trattative e di votazioni tra i partiti su nomi che
non hanno mai trovato la quadra. Minoli insiste sulla scelta anche comunicativa
di Mattarella: un profilo basso che ha aiutato anche ad accettare un bis che
sembrava non potesse succedere. E il dubbio che, in fondo, molti dei
protagonisti di quella trattativa fin dall'inizio proprio a questo esito
puntassero, facendolo passare per extrema ratio e mossa obbligata, è più che
lecito.
La deriva dell'immaturità.
Pier Luigi
del Viscovo il 31 Gennaio 2022 su Il Giornale.
È intollerabile la cagnara
degli italiani contro i loro rappresentanti politici, iniziata nei giorni
dell'impasse e esplosa dopo la rielezione di Mattarella
È intollerabile la cagnara
degli italiani contro i loro rappresentanti politici, iniziata nei giorni
dell'impasse e esplosa dopo la rielezione di Mattarella.
Cosa si aspettavano di
diverso? Che pensassero al bene supremo del Paese? Che almeno mantenessero nelle
forme una statura politica elevata, non sguaiata? Che riuscissero a dialogare e
ad accordarsi come impone la Costituzione, visto che il loro mestiere, la
politica, altro non è che l'arte del possibile? In una parola, che si
comportassero da statisti? E perché? Credono forse gli italiani di aver eletto
un Parlamento composto da persone del calibro di Moro, Giolitti, Andreotti,
Berlinguer, Fanfani, Craxi, Croce ed Einaudi? Uomini che interpretavano delle
idee di società e di sviluppo, diverse e più o meno condivisibili, con metodi a
volte discutibili, ma erano visioni compiute dove tutto si teneva.
Qual è la cifra politica degli
attuali rappresentanti? Bloccare cento sciagurati su una nave? Offrire lo ius
soli o il ddl Zan nel mezzo di crisi epocali? Cavalcare i no vax e ogni altro
corteo che passa per la strada? Sintetizzare tutto in un «vaffa»? Se una di
queste è più o meno la visione che gli italiani hanno comprato, è a loro che va
presentato il conto di questi giorni e degli ultimi 30 anni. Ma com'è che siamo
diventati così immaturi? Cosa c'è successo?
Quando abbiamo regolato i
conti con la prima Repubblica, condannandone la degenerazione, abbiamo buttato
via anche le idee che la sostenevano. Erano linee politiche strutturate, ricette
solide benché alternative, che imponevano la coerenza del pensiero articolato.
Le abbiamo rifiutate perché rispondevano ai bisogni indicando una strada. Ma
quella spinta propulsiva il Paese l'aveva esaurita da tempo e non voleva
camminare. Da quel momento è stato un continuo andar dietro al salvatore di
turno, che promette di risolvere i nostri problemi in cambio di un semplice
voto. Nessun disegno e dunque nessuna coerenza. Abbiamo accettato di buon grado
politici che votavano le riforme di Monti, giuste o sbagliate che fossero, e poi
le ripudiavano facendo campagna elettorale contro.
Così siamo arrivati alla
settimana scorsa quando, tra l'informazione sui venti di guerra in Ucraina e lo
spettacolo travestito da giornalismo dei nani della politica, gli italiani hanno
scelto il secondo in attesa di Sanremo. Eppure, 50 anni dopo il film non l'hanno
fatto sull'elezione di Leone ma sulla crisi di Cuba, perché da lì è passata la
storia.
Pier Luigi del Viscovo
Mediaset, Giorgia Meloni
"cancellata"? Dagospia: "Dopo le critiche a Salvini e Berlusconi da Porro...".
Un grosso caso.
Libero Quotidiano il 02 febbraio 2022
"Parecchi mal di pancia a
Mediaset" dopo l'ospitata di Giorgia Meloni a Quarta Repubblica. A riferirlo
è Dagospia che parla di più di una lamentela dopo la presenza nello studio di
Rete 4 della leader di Fratelli d'Italia. La Meloni è stata ospite di Nicola
Porro nella puntata del 31 gennaio e non - sembrerebbe - senza creare malumori.
Nello studio la leader di FdI
si era tolta più di un sassolino dalla scarpa, spiegando la sua versione sulle
elezioni del Quirinale. "Secondo me - aveva detto - quello che ha fatto Matteo
Salvini è folle, folle per lui. Una cosa che non ho capito, eravamo d'accordo
che la rielezione di Mattarella fosse l'ultima cosa da fare". Poi l'uscita
su Silvio Berlusconi che ha sciolto la riserva ritirandosi dalla corsa per il
Colle: "Quando ho dato l'ok a Berlusconi non l'ho fatto per deferenza, io a
Berlusconi non devo niente, ho fatto una scelta politica".
Parole forti che avrebbero
generato qualche scontento. Qualcuno - scrive Dago - sta spingendo "per tenere
fuori da Mediaset gli esponenti di Fratelli d'Italia, con il pretesto di voler
dare voce soprattutto ai partiti di governo (cioè tutti, tranne Fdi). Si
registrano già le prime ritorsioni: cancellate le ospitate di esponenti del
partito della Meloni da Zona bianca di Giuseppe Brindisi e Dritto e
rovescio di Paolo Del Debbio…".
Dagonews il 2 febbraio 2022.
Si vocifera che l'ospitata di
Giorgia Meloni a "Quarta Repubblica" su Rete 4, lo scorso 31 gennaio, abbia
innescato parecchi mal di pancia a Mediaset. A masticare amarissimo sono state
due "zarine": Siria Magri condirettore di Videonews, la testata giornalistica di
Mediaset, nonché moglie di Giovanni Toti, e la "badante" di Berlusconi e grande
amica di Salvini, Licia Ronzulli.
Le parole della "Ducetta", che
ha infilzato il leader della Lega per i suoi errori nella partita del Quirinale
e ha rintuzzato il Cav ("Non gli devo nulla"), hanno innescato la contraerea.
Gli "addetti ai livori"
sostengono che il tandem Magri-Ronzulli stia spingendo per tenere fuori da
Mediaset gli esponenti di Fratelli d'Italia, con il pretesto di voler dare voce
soprattutto ai partiti di governo (cioè tutti, tranne Fdi). Si registrano già le
prime ritorsioni: cancellate le ospitate di esponenti del partito della Meloni
da "Zona bianca" di Giuseppe Brindisi e "Dritto e rovescio" di Paolo Del Debbio…
Estratto dell'articolo di
Alessandro Di Matteo per “La Stampa” il 2 febbraio 2022.
[…] Raccontano che Silvio
Berlusconi si sia molto irritato, lunedì sera, sentendo la Meloni che sulla sua
Rete 4 ha detto di non «dovere niente» al leader di Fora Italia. Antonio Tajani
ieri, non a caso ha fatto un Tweet citando Aristotele sulla «gratitudine».
La Russa replica: «Il primo
ingrato è Tajani.Che forse nella sua testa pensava di poter fare il presidente
della Repubblica. Ce lo ha detto lui, non lo dico io».
Di certo, la Meloni non
intende più aspettare gli alleati, come dimostra il sostegno annunciato per il
bis di Nello Musumeci in Sicilia quando ancora Lega e Fora Italia non hanno
deciso cosa fare.
Giorgia
Meloni, "cancellata da Mediaset si consola così". Dagospia, la bomba: si dice
che Crosetto...Libero
Quotidiano l'08 febbraio 2022.
Fratelli d'Italia
"oscurati" a Mediaset? "E Giorgia Meloni si consola con Massimo Giletti a
La7". Dagospia conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla "vendetta"
delle reti del Biscione dopo le durissime dichiarazioni della leader di FdI
lunedì scorso, ospite di Quarta repubblica da Nicola Porro su Rete 4. Accuse
a Silvio Berlusconi e a Matteo Salvini che avrebbero provocato una certa
irritazione ai piani alti di Cologno Monzese. Secondo Dago, così sarebbe partita
la "rappresaglia" guidata da Lincia Ronzulli e da Siria Magri, moglie
di Giovanni Toti, che avrebbe portato al "siluramento degli esponenti di
Fratelli d'Italia dalle trasmissioni del Biscione" e al "cancellamento di tutte
le ospitate previste a Zona Bianca di Giuseppe Brindisi e Dritto e
Rovescio di Paolo Del Debbio". I diretti interessati hanno smentito qualsiasi
intervento "dall'alto" ma Dago tira dritto.
E il Fatto
quotidiano parla anche di una certa sorpresa dentro Forza Italia per la
telefonata partita dalla stessa Ronzulli (che però si dice estranea nella
maniera più assoluta) e "accettata" da Fedele Confalonieri. In ogni caso, i
retroscena parlano di presenze saltate all'ultimo del meloniano Galeazzo
Bignami a Zona Bianca, di Elisabetta Gardini a Diritto e Rovescio e di Guido
Crosetto a Stasera Italia. Motivazione ufficiale? La "contemporaneità con
il Festival di Sanremo". Per Crosetto si prospetta un ritorno mercoledì
sera a Stasera Italia perché, spiega il Fatto, "non viene considerato un
esponente politico di FdI, ma in quota 'commentatori e giornalisti'".
D'altronde, non è più parlamentare dal 2018.
La Meloni però
non sta ferma e probabilmente si prenderà la sua rivincita bombardando Mediaset
via La7, l'altra grande tv generalista con talk politici in prima serata.
Domenica sera è sta da Massimo Giletti a Non è l'arena, tornata alla sua
collocazione originale dopo aver saltato il mercoledì proprio per colpa di
Sanremo. E ora si attendono nuovi interventi, anche per interposta persona,
a L'aria che tira da Myrta Merlino, la mattina, Otto e mezzo da Lilli
Gruber, DiMartedì da Giovanni Floris. Più difficile ipotizzare una presenza
a Piazzapulita, visti gli scontri violentissimi con Corrado Formigli dopo
l'inchiesta "a martello" sulla Lobby nera.
Estratto dell'articolo di
Gianluca Roselli e Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano” il 7 febbraio 2022.
(…) A prendere una decisione
del genere, a Cologno Monzese, può essere solo Mauro Crippa , direttore generale
dell'informazione Mediaset che con Ronzulli ha ottimi rapporti. Secondo alcuni
la telefonata è stata ispirata proprio da Berlusconi, ma in Forza Italia
accusano Ronzulli di essere stata "più realista del re". La senatrice azzurra,
contattata dal fattoquotidiano.it, ha negato che sia stata lei l'autrice della
chiamata (…) ma a quanto risulta al Fatto, sarebbe stata proprio lei ad alzare
la cornetta. Una decisione che non è piaciuta per niente a Gianni Letta - che ha
pessimi rapporti con il cerchio magico di Arcore - e che Fedele Confalonieri,
presidente Mediaset, "ha accettato". Ma tant' è, restano i fatti: in poche ore
salta la partecipazione del deputato meloniano Galeazzo Bignami a Zona Bianca
condotto da Giuseppe Brindisi (mercoledì) e di Elisabetta Gardini a Diritto e
Rovescio di Paolo Del Debbio (giovedì), entrambi su Rete 4. Il conduttore
lucchese però ha smentito che sia arrivato un ordine dall'alto di questo genere.
Venerdì sera invece viene annullata la presenza di Guido Crosetto a Stasera
Italia, talk di Barbara Palombelli. Il motivo ufficiale delle tre esclusioni
sarebbe la "contemporaneità con il festival di Sanremo" e le ospitate vengono
rinviate: "Ci risentiamo presto", si sono sentiti dire gli addetti stampa di
Fratelli d'Italia. Crosetto tornerà già mercoledì a Stasera Italia ma con una
motivazione singolare: non viene considerato un esponente politico di FdI, ma in
quota "commentatori e giornalisti" in quanto non è più parlamentare dal 2018.
Insomma, il diktat di escludere esponenti meloniani dai talk Mediaset resta. Se
l'esclusione andrà avanti anche la prossima settimana lo si scoprirà solo
vivendo. (…)
Il dopo Quirinale e i
luoghi comune. Chi sono i peones, i deputati simbolo di nullafacenza cui
dobbiamo la rielezione di Mattarella.
Giuliano Cazzola su Il
Riformista il 2 Febbraio 2022.
Salvate il soldato peone. Per
un’intera settimana i “grandi elettori” anonimi hanno ricevuto i più acuminati
strali dell’antipolitica, sono stati proposti all’opinione pubblica come dei
nullafacenti che gozzovigliavano per i ristoranti vicini alla Ztl del potere,
senza riuscire a svolgere il loro compito: eleggere un nuovo capo dello Stato.
Mancava poco a che nei talk show si proponesse la decimazione. Come se fossimo
tutti nati ieri, si sono sentite, nelle maratone dei passi perduti, frasi prive
di senso come questa: “Hanno avuto sette anni per pensarci, si sono ridotti a
farlo all’ultimo momento?”; come se non fosse sempre stato così e non ci si
rendesse conto di quanto sia stata scombinata la XVIII legislatura, proprio per
responsabilità primaria di quanti hanno esercitato, il 4 marzo 2018, il diritto
di elettorato attivo.
Che cosa altro avrebbe potuto
fare un esercito sbandato, consapevole dell’inadeguatezza degli stati maggiori,
privo di ordini che non fossero la diserzione dal seggio o la scheda bianca?
Anzi, se non fosse stato la modalità di queste espressioni di voto rischiava di
essere eletta una signora Bianca Scheda, purché cinquantenne. Qualche grande
elettore si è concesso un po’ di cazzeggio goliardico. Eppure tra i suffragi
per Amadeus o per qualche attrice o per il vicino di banco (nessuno ha definito
“nano maledetto” un candidato non gradito), vi è stato chi ha dato un voto che
denotava un bel po’ di consapevole perfidia. Mi riferisco a chi ha
scritto “Nitto Palma” sulla sua scheda quando era in corso la “spallata” (con
relativa lussazione) a favore della presidente Elisabetta Casellati, essendo
noti i dissapori che esistono tra la personalità che ricopre la seconda carica
dello Stato e il suo capo di gabinetto.
A pensarci bene, la “congiura
dei peones” non ha sbagliato una sola mossa, sia pure con protagonisti diversi
ma tenuti insieme dalla medesima intelligenza strategica. I congiurati hanno
agito al momento giusto, approfittando lucidamente degli errori dei loro
capobastone. Nel caso della canditura della presidente Casellati non si sono
soltanto limitati a non aggiungere quel pacchetto di suffragi in più che Matteo
Salvini aveva garantito agli alleati, ma hanno fatto chiaramente capire che
sarebbe stato inutile insistere o provare con altre proposte simili. In quella
votazione non era in ballo solo il profilo della candidata, ma la tenuta della
maggioranza (quello di Salvini era stato veramente un sgarbo nei confronti degli
altri gruppi) e la continuità del governo e della legislatura. E a questo punto
è doveroso fare i conti con un altro luogo comune più volte ribadito anche
nell’ultima settimana: “Costoro pensano solo a salvarsi il posto ancora per
qualche per riscuotere lo stipendio e la pensione”.
Sarà anche vero; ma non vi è
stato, in questa vicenda, alcun conflitto tra interesse dei parlamentari
attaccati alla poltrona e quello del Paese. Non sarebbe stata sicuramente una
prospettiva migliore quella di sfasciare tutto nell’anno in cui – cosa che non è
ancora avvenuta – il Pnrr deve “atterrare” nella realtà, il ciclo economico
potrebbe invertirsi determinando il superamento di una politica monetaria e di
bilancio espansiva, la pandemia potrebbe riservare altre sorprese, soffiano
venti di guerra nel cuore dell’Europa. Ma il vero capolavoro è emerso nella
sesta votazione, quando, dopo il flop della presidente Casellati in quella
precedente, Sergio Mattarella ha ottenuto una valanga di voti (336) benché gli
ordini di scuderia, di vari gruppi, fossero diversi. Poi nell’ottava votazione
si è verificata un’incomprensibile discrepanza tra gli stati maggiori e
il collegio elettorale. Le aperture dei telegiornali, mentre erano in corso le
operazioni di spoglio, annunciavano che si era trovata l’intesa su di una
presidente e lanciavano – con orgogliosa sicurezza – il nome di Elisabetta
Belloni, ne tracciavano il profilo e ne esaltavano la novità.
Mentre le immagini scorrevano
sugli schermi e le parole dei conduttori – a partire dall’infortunio di Enrico
Letta che ha azzardato persino una percentuale (il 99%) – continuavano con la
solita solfa, compariva in sovraimpressione che Sergio Mattarella aveva ottenuto
386 voti, senza essere portato da nessuno. E a questo punto, sarebbe bastata un
po’ di intelligenza per capire che, se qualcuno dei capataz non si fosse assunto
la paternità di quella candidatura, Mattarella i peones lo avrebbero eletto da
soli. Nulla da fare. I leader hanno trascorso un’intera notte a gettare nel
tritacarne altri nomi (le cronache hanno riportato quelli di Casini, Cartabia,
Severino, sui quali non si è trovata l’intesa) fino a quando non hanno deciso di
arrendersi e di mettere l’operazione nelle mani di Mario Draghi. Pierfurby è
uscito dalla trappola con eleganza. Il resto lo conosciamo. Magari è il caso di
cominciare a riflettere sulle conseguenze della “settimana del loro scontento”;
che poi è finita bene, perché lassù qualcuno ci ama. In primo luogo i leader dei
partiti devono assumersi le loro responsabilità senza gettare la palla sulle
gradinate.
Non ha alcun senso prendersela
con il metodo di elezione e proporre di passare al suffragio popolare diretto.
Su quest’argomento ha ragione il neo presidente della Consulta (altro ottimo
evento la sua elezione) Giuliano Amato: «Non può essere vista come qualcosa che
da sola si innesta in un sistema lasciandolo così com’è. I sistemi
costituzionali sono come orologi. Le rotelle sono tutte collegate e l’orologio
funziona se gli ingranaggi si incastrano. L’elezione diretta del capo dello
Stato presenta benefici perché avviene in un giorno. Ma non puoi trasferirla
così com’è in un sistema”. In sostanza, smettiamo di trattare la Costituzione
come un Frankestein di norme purchessia. Come quando si è ritenuto di passare
dalla Prima alla Seconda Repubblica grazie a una nuova legge elettorale. Se il
presidente deve rappresentare l’unità nazionale – e non una parte politica – è
molto meglio un processo di mediazione tra i partiti, come poi è sempre
avvenuto, a volte anche in modo più complesso che con l’elezione del tredicesimo
capo dello Stato. Poi è bene convincersi che le istituzioni sono organismi
vitali, e come tali evolvono nel tempo, senza perdere la loro natura.
Il secondo mandato
di Mattarella è pienamente legittimo, ma introduce un elemento di forte novità;
perché è chiaro che il neo presidente ha davanti a sé altri sette anni durante i
quali intende svolgere le funzioni a cui è stato chiamato. Prosegue dunque una
fase politica che è iniziata con un sodalizio (Matterella-Draghi) che potrebbe
essere definito come un semipresidenzialismo biunivoco, caratterizzato da una
linea politica comune, in grado di mettere in sicurezza, a lungo, il
Paese. Mario Draghi resta a Palazzo Chigi, ma ha le spalle coperte
dal Quirinale. In queste condizioni il premier dovrebbe fare un pensierino in
vista delle prossime elezioni, soprattutto se si tornerà finalmente a un sistema
proporzionale dopo decenni sprecati con un bipolarismo innaturale in un paese
come l’Italia. Perché non una lista Draghi? Giuliano Cazzola
(ANSA il 4 febbraio 2022) -
Quanto sia arrivato inatteso per Sergio Mattarella il suo secondo mandato da
presidente della Repubblica emerge anche da un suo breve dialogo con il
presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato e il premier Mario Draghi,
prima del giuramento alla Camera.
"Hai visto che è finita come
dicevamo noi. Non come dicevi tu. E va be' succede, insomma", si sente dire
Amato nella scena ripresa dalle telecamere, mentre Mattarella risponde: "È una
cosa piuttosto... che altera programmi e prospettive".
La cattiva coscienza delle
Camere.
Paolo Armaroli il 4 Febbraio 2022 su Il Giornale.
Sergio Mattarella a
Montecitorio si è trovato dinanzi ai suoi grandi elettori nelle stesse
condizioni di Giorgio Napolitano non appena accettato il bis.
Ieri Sergio Mattarella a
Montecitorio si è trovato dinanzi ai suoi grandi elettori nelle stesse
condizioni di Giorgio Napolitano non appena accettato il bis. Ma ognuno ha la
propria personalità e il proprio stile. Di qui comportamenti se non
diametralmente opposti, di sicuro diversi. Nella seduta del Parlamento del 22
aprile 2013 Napolitano ha accenti degni di un Giovanni Gronchi. Così enfatizza
la fiducia e l'affetto che ha visto in quegli anni crescere verso di lui e verso
l'istituzione. Al pari di Mattarella, anche il suo predecessore non prevedeva di
tornare nell'aula di Montecitorio per pronunciare un nuovo giuramento. E non ha
difficoltà a riconoscere che la non rielezione al termine del settennato è
l'alternativa che meglio si conforma al nostro modello costituzionale.
Ma poi Napolitano si arma di
un nodoso bastone e non ha pietà per nessuno. Denuncia, con accenti degni di un
Sandro Pertini, l'inconcludenza e l'impotenza di un'intera classe politica. Così
come mette il dito sulla piaga delle omissioni e dei guasti, delle chiusure e
delle irresponsabilità. La cosa stupefacente è che più lui picchia duro, più è
sommerso dagli applausi. Una scena sadomasochistica in piena regola. Come se le
paternali di Napolitano non riguardassero proprio loro.
Mattarella no, anziché il
bastone ha usato la carota. Più che prendere di petto l'uditorio in malo modo,
cose che non sono da lui, ha preferito mettersi sulla stessa lunghezza d'onda
delle dichiarazioni programmatiche dei presidenti del Consiglio, considerate da
Giovanni Malagodi niente più che brevi considerazioni sull'universo. In effetti,
di cose Mattarella ne ha dette tante. Si è fatto portatore di quell'indirizzo
politico costituzionale del quale era solito parlare un giurista del valore di
Paolo Barile. Musica per le orecchie degli astanti.
È arcinoto che Mattarella, per
usare termini scolastici, rende meglio nello scritto che nell'orale. È
tutt'altro che un fine dicitore. Ma pochi sanno comunicare con i silenzi come
lui. Quegli scatoloni pronti a partire. Quelle cose care prese dalla casa di
Palermo. Quell'affitto dell'abitazione nei pressi di Piazza Ungheria. Quei
commiati che non finivano mai. Tutti silenzi cantatori. Come quelli dinanzi
all'Altare della Patria e fianco a fianco del suo omologo sloveno davanti alla
foiba di Basovizza. Eppure, ieri a Montecitorio è accaduta una cosa
straordinaria. Il capo dello Stato è stato subissato dagli applausi qualsiasi
cosa dicesse. La verità è che gli applausi non erano tanto per le sue parole ma
per lui, la leopardiana quiete dopo la tempesta dei giorni scorsi.
Un tifo da stadio. Applausi
scroscianti. Standing ovation a ripetizione. Applausi liberatori. Segno
diciamocela tutta di cattiva coscienza. Paolo Armaroli
Si dice dignità, si legge
umanità.
Stefano Zecchi il 4 Febbraio 2022 su Il Giornale.
Mattarella nel suo discorso ha
toccato tutti i temi sensibili del momento, dall'economia alla sanità, al ruolo
del Parlamento ed ha ringraziato le istituzioni dello Stato.
La dignitas è la base
dell'humanitas. Così spiega il filosofo latino Seneca a Lucilio, governatore
della Sicilia, a cui dedica 124 lettere dove sono trattati i temi fondamentali
dell'educazione morale. Mattarella come Seneca? Ho contato che nel suo discorso
di insediamento la parola «dignità» è stata ripetuta 18 volte, ma la cosa
interessante non è soltanto il numero, pur considerevole, in cui è pronunciata
la parola, ma l'ordine concettuale in cui è inserita nel discorso e la struttura
sintattica con cui la parola dignità costruisce le singole frasi dove essa
appare.
La dignità è una qualità
morale con la quale la persona chiede rispetto per sé e, a sua volta, rispetta
gli altri. Essa ha una relazione determinante con il concetto espresso dal verbo
rispettare. Questa relazione è il fondamento dell'humanitas.
Mattarella nel suo discorso ha
toccato tutti i temi sensibili del momento, dall'economia alla sanità, al ruolo
del Parlamento e della politica, alla scuola e agli studenti, ha salutato e
ringraziato le istituzioni dello Stato... E poteva finire qui, non avendo
trascurato niente e nessuno. E invece no. Come se si fosse accorto che mancava
l'architrave al suo discorso, ecco lo scarto filosofico, profondamente etico.
Possiamo anche essere
d'accordo su tutto quello che ho affermato - sembra dirci Mattarella - ma nulla
resta vero se non si comprende «la dimensione della dignità; c'è un significato
etico e culturale che riguarda il valore delle persone e chiama in causa
l'intera società. La dignità». E così il suo discorso, finora imperniato in una
burocratica attenzione alle componenti del Paese e alle sue problematiche,
prende il volo. Con una sintesi sferzante, degna di un grande moralista della
scuola stoica, attacca l'immoralità di una società che trascura la dignità verso
se stessa, ignorando i bisogni e le fragilità di chi fa parte di questa stessa
società.
Allora si potranno prendere in
una considerazione politica, amministrativa, giuridica i problemi relativi alle
morti sul lavoro, al razzismo e all'antisemitismo, alla violenza sulle donne,
alle migrazioni, alla tratta e alla schiavitù degli esseri umani, al diritto
allo studio, al rispetto degli anziani, al contrasto della povertà, all'obbligo
dell'ignobile scelta tra lavoro e maternità, alle carceri sovraffollate, al
rispetto delle disabilità, al contrasto di mafia e criminalità, alla necessità
di un'informazione libera. Dunque, si potrà prendere in considerazione tutto ciò
(ho citato tutte le declinazioni dei problemi sollevati da Mattarella in cui
appare la parola dignità), ma se non si comprende che la loro esistenza
rappresenta un vulnus alla dignità della società e del singolo cittadino, tali
problemi non verranno mai risolti e resteranno una ferita sanguinosa al senso di
humanitas di una civiltà. Stefano Zecchi
Applausi record: più di uno
al minuto Salvini assente, è positivo al Covid.
Pasquale Napolitano il 4
Febbraio 2022 su Il Giornale.
Clima da primo giorno di
scuola, volano le Frecce tricolori su Montecitorio. Saluto di benvenuto della
Casellati: è la prima volta.
Cinquantatrè, 55, 52:
l'applausometro va in tilt. L'unica certezza: il discorso, che apre
ufficialmente il bis del presidente Sergio Mattarella, centra il record di
applausi e alzate in piedi da parte dei grandi elettori riuniti a Montecitorio
per il giuramento. Gli applausi sono stati più di 50 nei 37 minuti di discorso.
Più di uno ogni minuto. Un record per le cronache quirinalizie. Una dura prova
di «ginnastica» per i parlamentari, che già in mattinata sono stati costretti al
tampone per presenziare al giuramento del capo dello Stato. Per 19 volte i
grandi elettori si alzano in piedi per una standing ovation. Il tripudio per
Mattarella è quasi unanime. L'unico partito, Fratelli d'Italia, che non ha
votato per la rielezione, si associa ai festeggiamenti solo in due circostanze:
nel momento in cui il Presidente Mattarella varca l'ingresso dell'Aula e durante
il discorso, quando richiama la centralità del Parlamento e i diritti da
garantire alle opposizioni. Nelle altre circostanze Fdi si astiene dagli
applausi. Nell'Aula è un continuo spellarsi le mani. Gli applausi più rumorosi
arrivano dai banchi del Pd e da quel M5s che aveva iniziato la legislatura con
la richiesta di impeachment per il Capo dello Stato. La legislatura si chiude
con l'estasi grillina per il Mattarella bis. Miracoli della politica. Il
presidente batte tutti gli ex inquilini del Colle sugli applausi: 6 erano stati
per Sandro Pertini, 29 per Giorgio Napolitano. L'Aula riserva un applauso anche
al premier Mario Draghi nel momento dell'ingresso tra i banchi del governo.
Rispetto alla tabella di marcia, l'entrata di Mattarella in Aula avviene con
qualche minuto di ritardo. La chiusura del discorso è salutata da 5 minuti di
applausi. I leader sono tutti presenti. Tutti tranne uno: Matteo Salvini. Il
capo del Carroccio risulta positivo al Covid ed è costretto a disertare il
giuramento: «Ai 10 milioni di italiani positivi e poi guariti, da oggi mi
aggiungo io».
Il protocollo è rigido. Per la
sfilata di Mattarella, la buvette di Montecitorio è chiusa. Il picchetto
accoglie l'ingresso in Aula del Capo dello Stato. Clima da primo giorno di
scuola per i parlamentari grillini che cercano di imbucarsi nei corridoi di
Montecitorio per assistere da vicino al passaggio del nuovo Capo dello Stato. Il
presidente della Camera controlla che non vi siano falle nell'organizzazione.
Prima dell'inizio della cerimonia Fico effettua un sopralluogo e posta su
Twitter la foto dell'Aula con un commento: «Sopralluogo in Aula e ultimi
preparativi per il giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella davanti
al Parlamento in seduta comune». L'attesa è tanta.
Una curiosità: per la prima
volta nella storia della Repubblica al Quirinale è la presidente del Senato
Maria Elisabetta Alberti Casellati a rivolgere il saluto di benvenuto al capo
dello Stato, Sergio Mattarella. Di solito è il presidente uscente e anche nel
caso di Napolitano il saluto fu solo abolito. Dopo il discorso, Mattarella
continua il suo tour istituzionale fino al Quirinale. Sul cielo di Montecitorio
volano le frecce tricolori. La corsa è sui terrazzi della Camera per video e
foto da riversare sui social. E su Facebook, Twitter e Instagram finiscono anche
le foto dei parlamentari che ricevono l'esito (negativo): il pass per il
Mattarella party. Pasquale Napolitano
Intervento in stile Dc che
accontenta tutti. Ma senza scadenza: resterà sette anni.
Paolo Bracalini il 4 Febbraio
2022 su Il Giornale.
Toccati i temi cari a ciascun
partito. Non ci sono le stoccate che riservò Napolitano.
Per i parlamentari una
giornata di festa per lo scampato pericolo: una crisi di governo con probabili
elezioni alle porte e, per molti di loro, addio per sempre al seggio
parlamentare. Guardando Mattarella invece vedono la prosecuzione dello status
quo, altri dodici mesi di stipendi e futura pensione (la maturano il prossimo 24
settembre), perciò si spellano le mani dagli applausi, più di uno al minuto - 55
applausi in 40 minuti per la precisione - durante il discorso del presidente. E
anche lui del resto non sembra afflitto dal secondo gravoso incarico, di durata
settennale, che pure aveva in tutti i modi spiegato di non voler fare. Dalle sue
parole, e dal suo tono, invece traspare la gratificazione per essere stato
richiamato per acclamazione più che il sacrificio, che invece era stato palese e
dichiarato nel discorso del bis di Giorgio Napolitano (un vero atto di accusa
alle forze politiche per l'incapacità di trovare un successore). Nel caso di
Mattarella bis invece nessun rimprovero ai partiti che l'hanno costretto a
restare al Quirinale mentre aveva «altri piani», il presidente è sorridente,
sereno. Il capo dello Stato ha una buona parola per tutti i partiti, dosa con
sapienza democristiana i passaggi del discorso e i temi per conquistare tutto
l'arco costituzionale, da destra a sinistra (e persino, sembrerebbe, le frange
complottiste del Misto quando dice che «poteri economici sovranazionali, tendono
a prevalere e a imporsi, aggirando il processo democratico»).
Con una architrave retorica
fatta di richiami talmente universali da non scontentare nessuno: il diritto
allo studio, il «rispetto per gli anziani che non possono essere lasciati alla
solitudine», il «sostegno ai processi di pace», la cultura «elemento costitutivo
dell'identità italiana», il problema dei giovani «costretti in lavori precari e
malpagati», il compito di costruire «un'Italia più moderna», la riconoscenza a
medici e operatori sanitari.
Mattarella si fa presidente di
tutti i partiti, nel senso che li accontenta uno per uno, toccando tutti i tasti
del pianoforte politico. Le ali più giustizialiste del Parlamento (soprattutto
il M5s) si uniscono al saluto che Mattarella invia alle «nostre Magistrature,
elemento fondamentale del sistema costituzionale e della vita della nostra
società». Ma subito dopo, rassicurando quelle più critiche sulla magistratura
italiana (centrodestra ma anche renziani), Mattarella ricorda che «un profondo
processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia. Per
troppo tempo è divenuta un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di
vista gli interessi della collettività» e che le correnti del Csm «devono
rimanere estranee all'Ordine giudiziario». Applausi a sinistra quando ammonisce
che «la nostra dignità è interrogata dalle migrazioni, soprattutto quando non
siamo capaci di difendere il diritto alla vita», ma è contenta anche la destra
quando sottolinea che «la nostra dignità ci impone di combattere, senza tregua,
la tratta e la schiavitù degli esseri umani» (infatti Giorgia Meloni apprezza,
osservando con ironia la «significativa discontinuità con il presidente
precedente»). Viene ringraziato il governo Draghi, che sta «ponendo le basi di
una nuova stagione di crescita sostenibile del Paese e dell'Europa». Ma con
riguardo anche ai critici del governo per l'eccessivo ricorso ai decreti legge,
perchè «è cruciale il ruolo del Parlamento, come luogo della partecipazione». La
sinistra applaude per i passaggi sulla «lotta alle diseguaglianze e alle
povertà» e sull'«ambiente», a destra fa breccia l'apprezzamento per le forze
dell'ordine «garanzia di libertà nella sicurezza». Una lunga serie di impegni
per «costruire, in questi prossimi anni, l'Italia del dopo emergenza». Altro che
mandato a termine, l'orizzonte del presidente è lungo sette anni. Paolo
Bracalini
Il discorso del Presidente
della Repubblica.
Mattarella bacchetta politici (che lo applaudono) e magistrati:
“Manca progettualità, la giustizia così perde credibilità”. Redazione su Il
Riformista il 3 Febbraio 2022.
Sergio Mattarella inizia il
suo mandato bis alla guida del Colle
bacchettando politici e magistrati, colpevoli da una parte di mancata
progettualità dall’altra di aver dato vita a “un terreno di scontro che ha
sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività” mettendo in
secondo piano le “pressanti esigenze di efficienza e di credibilità”. Il
Presidente, completo scuro e cravatta blu, ha giurato “di essere fedele alla
Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione” alle 15.30 alla Camera, tra
gli applausi dei Grandi Elettori, protagonisti della scellerata settimana
politica appena trascorsa. Settimana che lo stesso Mattarella, interrotto più
volte da lunghi applausi, soprattutto quando ha affrontato il tema della riforma
della Giustizia, ha definito “travagliata” anche per lui.
Mattarella, salutato dal
presidente della Camera Roberto Fico e dalla presidente del Senato Maria
Elisabetta Casellati (che ha coltivato per qualche ora il sogno di sostituirlo
al Colle), ricorda gli ultimi sette giorni della politica italiana, quelli che
hanno portato nuovamente alla sua elezione, sottolineando che mentre gli
italiani “si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti,
rassicurazione, sostegno e risposte concrete al loro disagio”, le stesse attese
“sarebbero state fortemente compromesse dal prolungarsi di uno stato di profonda
incertezza politica e di tensioni, le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a
rischio anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del Paese impegnato
a uscire da una condizione di grandi difficoltà”. Poi la mazzata ai partiti e
alle divisioni croniche: “Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento
che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana. E’ questa stessa
consapevolezza la ragione del mio sì e sarà al centro del mio impegno di
Presidente della nostra Repubblica nell’assolvimento di questo nuovo mandato”.
Poi l’attacco, più che
appello, al potere giudiziario italiano che da anni è chiamato a un “profondo
processo riformatore”. Parole durissime quelle del capo dello Stato e presidente
del Consiglio Superiore della Magistratura: “Rivolgo un saluto rispettoso alla
Corte Costituzionale, presidio di garanzia dei principi della nostra Carta.
Nell’inviare un saluto alle nostre Magistrature – elemento fondamentale del
sistema costituzionale e della vita della nostra società –mi preme sottolineare
che un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della
giustizia”.
“Per troppo tempo – incalza
Mattarella – è divenuta un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di
vista gli interessi della collettività. Nella salvaguardia dei principi,
irrinunziabili, di autonomia e di indipendenza della Magistratura – uno dei
cardini della nostra Costituzione – l’ordinamento giudiziario e il sistema di
governo autonomo della Magistratura devono corrispondere alle pressanti esigenze
di efficienza e di credibilità, come richiesto a buon titolo dai cittadini”.
“È indispensabile – aggiunge
il capo dello Stato – che le riforme annunciate giungano con immediatezza a
compimento affinché il Consiglio superiore della Magistratura possa svolgere
appieno la funzione che gli è propria, valorizzando le indiscusse alte
professionalità su cui la Magistratura può contare, superando logiche di
appartenenza che, per dettato costituzionale, devono rimanere estranee
all’Ordine giudiziario. Occorre per questo che venga recuperato un profondo
rigore”.
Mattarella ha ricordato che
“in sede di Consiglio Superiore ho sottolineato, a suo tempo, che indipendenza e
autonomia sono principi preziosi e basilari della Costituzione ma che il loro
presidio risiede nella coscienza dei cittadini: questo sentimento è fortemente
indebolito e va ritrovato con urgenza. I cittadini – ha concluso – devono poter
nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l’Ordine
giudiziario. Neppure devono avvertire timore per il rischio di decisioni
arbitrarie o imprevedibili che, in contrasto con la doverosa certezza del
diritto, incidono sulla vita delle persone. Va sempre avvertita la grande
delicatezza della necessaria responsabilità che la Repubblica affida ai
magistrati. La Magistratura e l’Avvocatura sono chiamate ad assicurare che il
processo riformatore si realizzi, facendo recuperare appieno prestigio e
credibilità alla funzione giustizia, allineandola agli standard europei”.
Il discorso integrale del
presidente della Repubblica Sergio Mattarella
"Signori Presidenti della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,
Signori parlamentari e
delegati regionali,
il Parlamento e i
rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta.
E’ per me una nuova chiamata –
inattesa – alla responsabilità; alla quale tuttavia non posso e non ho inteso
sottrarmi.
Ritorno dunque di fronte a
questa Assemblea, nel luogo più alto della rappresentanza democratica, dove la
volontà popolare trova la sua massima espressione.
Vi ringrazio per la fiducia
che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare
l’unità della Repubblica.
Adempirò al mio dovere secondo
i principi e le norme della Costituzione, cui ho appena rinnovato il giuramento
di fedeltà, e a cui ho cercato di attenermi in ogni momento nei sette anni
trascorsi.
La lettera e lo spirito della
nostra Carta continueranno a essere il punto di riferimento della mia azione.
Il mio pensiero, in questo
momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età, di
ogni Regione, di ogni condizione sociale, di ogni orientamento politico. E, in
particolare, a quelli più in sofferenza, che si attendono dalle istituzioni
della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte
concrete al loro disagio.
Queste attese sarebbero state
fortemente compromesse dal prolungarsi di uno stato di profonda incertezza
politica e di tensioni, le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio
anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del Paese impegnato a uscire
da una condizione di grandi difficoltà.
Leggo questa consapevolezza
nel voto del Parlamento che ha concluso i giorni travagliati della scorsa
settimana.
E’ questa stessa
consapevolezza la ragione del mio sì e sarà al centro del mio impegno di
Presidente della nostra Repubblica nell’assolvimento di questo nuovo mandato.
Nel momento in cui i
Presidenti di Camera e Senato mi hanno comunicato l’esito della votazione, ho
parlato delle urgenze – sanitaria, economica e sociale – che ci
interpellano. Non possiamo permetterci ritardi, né incertezze.
La lotta contro il virus non è
conclusa, la campagna di vaccinazione ha molto ridotto i rischi ma non ci sono
consentite disattenzioni.
E’ di piena evidenza come la
ripresa di ogni attività sia legata alla diffusione dei vaccini che aiutano a
proteggere noi stessi e gli altri.
Questo impegno si unisce a
quello per la ripresa, per la costruzione del nostro futuro.
L’Italia è un grande Paese.
Lo spirito di iniziativa degli
italiani, la loro creatività e solidarietà, lo straordinario impegno delle
nostre imprese, le scelte delle istituzioni ci hanno consentito di ripartire.
Hanno permesso all’economia di raggiungere risultati che adesso ci collocano nel
gruppo di testa dell’Unione. Ma questa ripresa, per consolidarsi e non risultare
effimera, ha bisogno di progettualità, di innovazione, di investimenti nel
capitale sociale, di un vero e proprio salto di efficienza del sistema-Paese.
Nuove difficoltà si
presentano. Le famiglie e le imprese dovranno fare i conti con gli aumenti del
prezzo dell’energia. Preoccupa la scarsità e l’aumento del prezzo di alcuni beni
di importanza fondamentale per i settori produttivi.
Viviamo in una fase
straordinaria in cui l’agenda politica è in gran parte definita dalla strategia
condivisa in sede europea.
L’Italia è al centro
dell’impegno di ripresa dell’Europa. Siamo i maggiori beneficiari del programma
Next Generation e dobbiamo rilanciare l’economia all’insegna della sostenibilità
e dell’innovazione, nell’ambito della transizione ecologica e digitale.
La stabilità di cui si avverte
l’esigenza è, quindi, fatta di dinamismo, di lavoro, di sforzo comune.
I tempi duri che siamo stati
costretti a vivere ci hanno lasciato una lezione: dobbiamo dotarci di strumenti
nuovi per prevenire futuri possibili pericoli globali, per gestirne le
conseguenze, per mettere in sicurezza i nostri concittadini.
L’impresa alla quale si sta
ponendo mano richiede il concorso di ciascuno.
Forze politiche e sociali,
istituzioni locali e centrali, imprese e sindacati, amministrazione pubblica e
libere professioni, giovani e anziani, città e zone interne, comunità insulari e
montane. Vi siamo tutti chiamati.
L’esempio ci è stato dato da
medici, operatori sanitari, volontari, da chi ha garantito i servizi essenziali
nei momenti più critici, dai sindaci, dalle Forze Armate e dalle Forze
dell’ordine, impegnate a sostenere la campagna vaccinale: a tutti va riaffermata
la nostra riconoscenza.
Questo è l’orizzonte che
abbiamo davanti.
Dobbiamo disegnare e iniziare
a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza.
E’ ancora tempo di un impegno
comune per rendere più forte l’Italia, ben oltre le difficoltà del momento.
Un’Italia più giusta, più
moderna, intensamente legata ai popoli amici che ci attorniano.
Un Paese che cresca in unità.
In cui le disuguaglianze –
territoriali e sociali – che attraversano le nostre comunità vengano meno.
Un’Italia che offra ai suoi
giovani percorsi di vita nello studio e nel lavoro per garantire la coesione del
nostro popolo.
Un’Italia che sappia superare
il declino demografico a cui l’Europa sembra condannata.
Un’Italia che tragga vantaggio
dalla valorizzazione delle sue bellezze, offrendo il proprio modello di vita a
quanti, nel mondo, guardano ad essa con ammirazione.
Un’Italia impegnata nella
tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, consapevole della
responsabilità nei confronti delle future generazioni.
Una Repubblica capace di
riannodare il patto costituzionale tra gli italiani e le loro istituzioni libere
e democratiche.
Rafforzare l’Italia significa
anche, metterla in grado di orientare il processo per rilanciare l’Europa,
affinché questa divenga più efficiente e giusta; rendendo stabile e strutturale
la svolta che è stata compiuta nei giorni più impegnativi della pandemia.
L’apporto dell’Italia non può
mancare: servono idee, proposte, coerenza negli impegni assunti.
La Conferenza sul futuro
dell’Europa non può risolversi in un grigio passaggio privo di visione storica
ma deve essere l’occasione per definire, con coraggio, una Unione protagonista
nella comunità internazionale.
In aderenza alle scelte della
nostra Costituzione, la Repubblica ha sempre perseguito una politica di pace. In
essa, con ferma adesione ai principi che ispirano l’Organizzazione delle Nazioni
Unite, il Trattato dell’Atlantico del Nord, l’Unione Europea, abbiamo
costantemente promosso il dialogo reciprocamente rispettoso fra le diverse parti
affinché prevalessero i principi della cooperazione e della giustizia.
Da molti decenni i Paesi
europei possono godere del dividendo di pace, concretizzato nell’integrazione
europea e accresciuto dal venir meno della Guerra fredda.
Non possiamo accettare che
ora, senza neppure il pretesto della competizione tra sistemi politici ed
economici differenti, si alzi nuovamente il vento dello scontro; in un
continente che ha conosciuto le tragedie della Prima e della Seconda guerra
mondiale.
Dobbiamo fare appello alle
nostre risorse e a quelle dei paesi alleati e amici affinché le esibizioni di
forza lascino il posto al reciproco intendersi, affinché nessun popolo debba
temere l’aggressione da parte dei suoi vicini.
I popoli dell’Unione Europea
devono esser consapevoli che ad essi tocca un ruolo di sostegno ai processi di
stabilizzazione e di pace nel martoriato panorama mediterraneo e
medio-orientale. Non si può sfuggire alle sfide della storia e alle relative
responsabilità.
Su tutti questi temi –
all’interno e nella dimensione internazionale – è intensamente impegnato il
Governo guidato dal Presidente Draghi; nato, con ampio sostegno parlamentare,
nel pieno dell’emergenza e ora proiettato a superarla, ponendo le basi di una
nuova stagione di crescita sostenibile del Paese e dell’Europa. Al Governo
esprimo un convinto ringraziamento e gli auguri di buon lavoro.
I grandi cambiamenti che
stiamo vivendo a livello mondiale impongono soluzioni rapide, innovative,
lungimiranti, che guardino alla complessità dei problemi e non soltanto agli
interessi particolari.
Una riflessione si propone
anche sul funzionamento della nostra democrazia, a tutti i livelli.
Proprio la velocità dei
cambiamenti richiama, ancora una volta, il bisogno di costante inveramento della
democrazia.
Un’autentica democrazia
prevede il doveroso rispetto delle regole di formazione delle decisioni,
discussione, partecipazione. L’esigenza di governare i cambiamenti sempre più
rapidi richiede risposte tempestive. Tempestività che va comunque sorretta da
quell’indispensabile approfondimento dei temi che consente puntualità di scelte.
Occorre evitare che i problemi
trovino soluzione senza l’intervento delle istituzioni a tutela dell’interesse
generale: questa eventualità si traduce sempre a vantaggio di chi è in
condizioni di maggior forza.
Poteri economici
sovranazionali, tendono a prevalere e a imporsi, aggirando il processo
democratico.
Su un altro piano, i regimi
autoritari o autocratici rischiano ingannevolmente di apparire, a occhi
superficiali, più efficienti di quelli democratici, le cui decisioni, basate sul
libero consenso e sul coinvolgimento sociale, sono, invece, ben più solide ed
efficaci.
La sfida – che si presenta a
livello mondiale – per la salvaguardia della democrazia riguarda tutti e
anzitutto le istituzioni.
Dipenderà, in primo luogo,
dalla forza del Parlamento, dalla elevata qualità della attività che vi si
svolge, dai necessari adeguamenti procedurali.
Vanno tenute unite due
esigenze irrinunziabili: rispetto dei percorsi di garanzia democratica e,
insieme, tempestività delle decisioni.
Per questo è cruciale il ruolo
del Parlamento, come luogo della partecipazione. Il luogo dove si costruisce il
consenso attorno alle decisioni che si assumono. Il luogo dove la politica
riconosce, valorizza e immette nelle istituzioni ciò che di vivo cresce nella
società civile.
Così come è decisivo il ruolo
e lo spazio delle autonomie. Il pluralismo delle istituzioni, vissuto con
spirito di collaborazione – come abbiamo visto nel corso dell’emergenza
pandemica – rafforza la democrazia e la società.
Non compete a me indicare
percorsi riformatori da seguire. Ma dobbiamo sapere che dalle risposte che
saranno date a questi temi dipenderà la qualità della nostra democrazia.
Quel che appare comunque
necessario – nell’indispensabile dialogo collaborativo tra Governo e Parlamento
è che – particolarmente sugli atti fondamentali di governo del Paese – il
Parlamento sia sempre posto in condizione di poterli esaminare e valutare con
tempi adeguati. La forzata compressione dei tempi parlamentari rappresenta un
rischio non certo minore di ingiustificate e dannose dilatazioni dei tempi.
Appare anche necessario un
ricorso ordinato alle diverse fonti normative, rispettoso dei limiti posti dalla
Costituzione.
La qualità stessa e il
prestigio della rappresentanza dipendono, in misura non marginale, dalla
capacità dei partiti di esprimere ciò che emerge nei diversi ambiti della vita
economica e sociale, di favorire la partecipazione, di allenare al confronto.
I partiti sono chiamati a
rispondere alle domande di apertura che provengono dai cittadini e dalle forze
sociali.
Senza partiti coinvolgenti,
così come senza corpi sociali intermedi, il cittadino si scopre solo e più
indifeso. Deve poter far affidamento sulla politica come modalità civile per
esprimere le proprie idee e, insieme, la propria appartenenza alla Repubblica.
Il Parlamento ha davanti a sé
un compito di grande importanza perché, attraverso nuove regole, può favorire
una stagione di partecipazione.
Anche sul piano etico e
culturale, è necessario – proprio nel momento della difficoltà – sollecitare
quella passione che in tanti modi si esprime nella nostra comunità. Occorre che
tutti, i giovani in primo luogo, sentano su di loro la responsabilità di
prendere il futuro sulle loro spalle, portando nella politica e nelle
istituzioni novità ed entusiasmo.
Rivolgo un saluto rispettoso
alla Corte Costituzionale, presidio di garanzia dei principi della nostra Carta.
Nell’inviare un saluto alle
nostre Magistrature – elemento fondamentale del sistema costituzionale e della
vita della nostra società –mi preme sottolineare che un profondo processo
riformatore deve interessare anche il versante della giustizia.
Per troppo tempo è divenuta un
terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della
collettività.
Nella salvaguardia dei
principi, irrinunziabili, di autonomia e di indipendenza della Magistratura –
uno dei cardini della nostra Costituzione – l’ordinamento giudiziario e il
sistema di governo autonomo della Magistratura devono corrispondere
alle pressanti esigenze di efficienza e di credibilità, come richiesto a buon
titolo dai cittadini.
È indispensabile che le
riforme annunciate giungano con immediatezza a compimento affinché il Consiglio
superiore della Magistratura possa svolgere appieno la funzione che gli è
propria, valorizzando le indiscusse alte professionalità su cui la Magistratura
può contare, superando logiche di appartenenza che, per dettato costituzionale,
devono rimanere estranee all’Ordine giudiziario.
Occorre per questo che venga
recuperato un profondo rigore.
In sede di Consiglio Superiore
ho sottolineato, a suo tempo, che indipendenza e autonomia sono principi
preziosi e basilari della Costituzione ma che il loro presidio risiede nella
coscienza dei cittadini: questo sentimento è fortemente indebolito e va
ritrovato con urgenza.
I cittadini devono poter
nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l’Ordine
giudiziario. Neppure devono avvertire timore per il rischio di decisioni
arbitrarie o imprevedibili che, in contrasto con la doverosa certezza del
diritto, incidono sulla vita delle persone.
Va sempre avvertita la grande
delicatezza della necessaria responsabilità che la Repubblica affida ai
magistrati.
La Magistratura e l’Avvocatura
sono chiamate ad assicurare che il processo riformatore si realizzi, facendo
recuperare appieno prestigio e credibilità alla funzione giustizia, allineandola
agli standard europei.
Alle Forze Armate, sempre più
strumento di pace, elemento significativo nella politica internazionale della
Repubblica, alle Forze dell’ordine, garanzia di libertà nella sicurezza,
manifesto il mio apprezzamento, unitamente al rinnovo del cordoglio per quanti
hanno perduto la vita nell’ assolvimento del dovere.
Nel salutare il Corpo
Diplomatico accreditato, ringrazio per l’amicizia e la collaborazione espressa
nei confronti del nostro Paese.
Ai numerosi connazionali
presenti nelle più diverse parti del globo va il mio saluto affettuoso, insieme
al riconoscimento per il contributo che danno alla comprensione dell’identità
italiana nel mondo
A Papa Francesco, al cui
magistero l’Italia guarda con grande rispetto, rivolgo i sentimenti di
gratitudine del popolo italiano.
Un messaggio di amicizia invio
alle numerose comunità straniere presenti in Italia: la loro affezione nei
confronti del nostro Paese in cui hanno scelto di vivere e il loro apporto alla
vita della nostra società sono preziosi.
L’Italia è, per antonomasia,
il Paese della bellezza, delle arti, della cultura. Così nel resto del mondo
guardano, fondatamente, verso di noi.
La cultura non è il superfluo:
è un elemento costitutivo dell’identità italiana.
Facciamo in modo che questo
patrimonio di ingegno e di realizzazioni – da preservare e sostenere – divenga
ancor più una risorsa capace di generare conoscenza, accrescimento morale e un
fattore di sviluppo economico. Risorsa importante particolarmente per quei
giovani che vedono nelle università, nell’editoria, nelle arti, nel teatro,
nella musica, nel cinema un approdo professionale in linea con le proprie
aspirazioni.
Sosteniamo una scuola che
sappia accogliere e trasmettere preparazione e cultura, come complesso dei
valori e dei principi che fondano le ragioni del nostro stare insieme; volta ad
assicurare parità di condizioni e di opportunità.
Costruire un’Italia più
moderna è il nostro compito.
Ma affinché la modernità
sorregga la qualità della vita e un modello sociale aperto, animato da libertà,
diritti e solidarietà, è necessario assumere la lotta alle diseguaglianze e alle
povertà come asse portante delle politiche pubbliche.
Nell’ultimo periodo gli indici
di occupazione sono saliti – ed è un dato importante – ma ancora tante donne
sono escluse dal lavoro, e la marginalità femminile costituisce uno dei fattori
di rallentamento del nostro sviluppo, oltre che un segno di ritardo civile,
culturale, umano.
Tanti, troppi giovani sono
sovente costretti in lavori precari e malpagati, quando non confinati in
periferie esistenziali.
E’ doveroso ascoltare la voce
degli studenti, che avvertono tutte le difficoltà del loro domani e cercano di
esprimere esigenze, domande volte a superare squilibri e contraddizioni.
La pari dignità sociale è un
caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo.
Le diseguaglianze non sono il
prezzo da pagare alla crescita. Sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di
crescita.
Nostro compito – come
prescrive la Costituzione – è rimuovere gli ostacoli.
Accanto alla dimensione
sociale della dignità, c’è un suo significato etico e culturale che riguarda il
valore delle persone e chiama in causa l’intera società.
La dignità.
Dignità è azzerare le morti
sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ciascuno di noi. Perché
la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore, riguarda il valore che attribuiamo
alla vita.
Mai più tragedie come quella
del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto scuola-lavoro.
Quasi ogni giorno veniamo
richiamati drammaticamente a questo primario dovere della nostra società.
Dignità è opporsi al razzismo
e all’antisemitismo, aggressioni intollerabili, non soltanto alle minoranze
fatte oggetto di violenza, fisica o verbale, ma alla coscienza di ciascuno di
noi.
Dignità è impedire la violenza
sulle donne, profonda, inaccettabile piaga che deve essere contrastata con
vigore e sanata con la forza della cultura, dell’educazione, dell’esempio.
La nostra dignità è
interrogata dalle migrazioni, soprattutto quando non siamo capaci di difendere
il diritto alla vita, quando neghiamo nei fatti la dignità umana degli altri.
E’ anzitutto la nostra dignità
che ci impone di combattere, senza tregua, la tratta e la schiavitù degli esseri
umani.
Dignità è diritto allo studio,
lotta all’abbandono scolastico, annullamento del divario tecnologico e digitale.
Dignità è rispetto per gli
anziani che non possono essere lasciati alla solitudine, privi di un ruolo che
li coinvolga.
Dignità è contrastare le
povertà, la precarietà disperata e senza orizzonte che purtroppo mortifica le
speranze di tante persone.
Dignità è non dover essere
costrette a scegliere tra lavoro e maternità.
Dignità è un Paese dove le
carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei
detenuti. Questa è anche la migliore garanzia di sicurezza.
Dignità è un Paese non
distratto di fronte ai problemi quotidiani che le persone con disabilità devono
affrontare, e capace di rimuovere gli ostacoli che immotivatamente incontrano
nella loro vita.
Dignità è un Paese libero
dalle mafie, dal ricatto della criminalità, dalla complicità di chi fa finta di
non vedere.
Dignità è garantire e
assicurare il diritto dei cittadini a un’informazione libera e indipendente.
La dignità, dunque, come
pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile.
A questo riguardo –
concludendo – desidero ricordare in quest’aula il Presidente di un’altra
Assemblea parlamentare, quella europea, David Sassoli.
La sua testimonianza di uomo
mite e coraggioso, sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare le
istituzioni democratiche ai livelli più alti, è entrata nell’animo degli
italiani.
“Auguri alla nostra speranza”
sono state le sue ultime parole in pubblico.
Aveva appena detto: “La
speranza siamo noi”.
Ecco, noi, insieme,
responsabili del futuro della nostra Repubblica.
Viva la Repubblica, viva
l’Italia!"
Giustizia, sono finiti gli
anni "timidi": Mattarella vuole subito la riforma.
Nel suo intervento il capo
dello Stato fa la voce grossa per ottenere la revisione di un sistema che non
solo è il più lento d’Europa, ma negli ultimi anni si è anche rivelato
arbitrario e corrotto. VITTORIO FERLA Il Quotidiano del Sud il 5 Febbraio 2022.
Le abbiamo contate: sono 278
le parole che Sergio Mattarella ha dedicato alla riforma della Giustizia nel suo
discorso. Un’inezia rispetto alla vastità e puntualità dei temi toccati. Eppure,
la parte del messaggio del Presidente dedicata alla giustizia è pari a circa il
10% del totale. Perché, tra tutti gli argomenti citati, Mattarella ha insistito
così a lungo sul ruolo della magistratura? Lo capiremo meglio nei prossimi mesi,
quando potremo verificare se, all’appello del Presidente, corrisponderà un suo
concreto impulso per le riforme.
DAGLI ANNI ‘90 LA DERIVA
Negli ultimi anni, il peso
della magistratura sulla vita pubblica italiana è cresciuto in maniera
spropositata. Il fenomeno affonda le sue radici nel crollo della Prima
Repubblica e nel trauma di Tangentopoli. Fu allora che la magistratura sferrò il
colpo di grazia al sistema dei partiti del dopoguerra, superato storicamente
dalla fine del bipolarismo Est-Ovest (e dalla caduta del Muro di Berlino) e
guastato dalla corruzione diffusa. Proprio in questo mese si celebrano i 30 anni
dall’inizio di Tangentopoli: sarebbe l’occasione buona per una rilettura
spassionata di quella stagione.
Nel corso di questo
trentennio, la magistratura si è sempre più autoeletta tutore univoco della
Costituzione, supplendo al progressivo declino dei partiti. I giudici sono
spesso entrati pesantemente nella vita pubblica: decine e decine di politici e
amministratori pubblici sono caduti sotto la pressione di indagini che hanno
interrotto la loro vita politica e distrutto la loro reputazione personale.
Spesso, i processi si sono risolti in un nulla di fatto, con un numero elevato
di assoluzioni. Ma la fine del tormento è avvenuto sempre dopo un tempo
lunghissimo, spesso ultradecennale, tale da impedire la riabilitazione
tempestiva degli imputati.
Questi casi non sono isolati,
bensì sono il frutto di un’ondata giustizialista che affonda le sue radici
culturali negli anni di Tangentopoli, si consolida nella lotta
politico-giudiziaria contro Silvio Berlusconi, si alimenta con la trasformazione
dell’antipolitica delle origini in un movimento populista organizzato che, alla
fine, è sbarcato nelle aule parlamentari.
L’argomento della certezza
della pena si è fatto strada a scapito dell’argomento della certezza del
diritto: il ministro grillino Alfonso Bonafede è stato il campione di questa
linea che salda la pervasività del potere della magistratura all’aspettativa di
una crescente severità delle pene. In questo clima, le antiche deficienze del
sistema giudiziario resistono o, perfino, si aggravano.
L’EUROPA E LA SPINTA DEL COLLE
Secondo i dati del Consiglio
d’Europa, la giustizia italiana è la più lenta nel confronto con gli altri Paesi
europei. La durata media di un processo civile è pari a sette anni e tre mesi
circa. In confronto, i processi durano circa la metà in Francia e in Spagna,
mentre circa un terzo in Germania.
In generale, per i cittadini
italiani avere a che fare con il sistema giudiziario è come fare una gita
all’inferno. Le cronache degli ultimi anni – ivi comprese le confessioni di Luca
Palamara, già presidente dell’Associazione nazionale magistrati – rivelano
numerosi casi di abusi della magistratura, un sistema di autogoverno arbitrario
e corrotto, la moltiplicazione delle faide tra le correnti dei giudici: il
potere giudiziario appare irrimediabilmente autoreferenziale e sempre più
intossicato. A quanti hanno denunciato le derive di questi anni, l’azione di
Sergio Mattarella – che, in qualità di capo dello Stato, è anche presidente del
Consiglio superiore della magistratura – è apparsa troppo timida, se non
addirittura subalterna alla magistratura e al cosiddetto “partito dei Pm”.
Forse è per questo che,
l’altroieri Mattarella ha scelto di fare la voce grossa. I principi di autonomia
e di indipendenza – il cui presidio, avverte il presidente «risiede nella
coscienza dei cittadini» – vanno rispettati, certo. Ma «l’ordinamento
giudiziario e il sistema di governo autonomo della magistratura devono
corrispondere alle pressanti esigenze di efficienza e di credibilità, come
richiesto a buon titolo dai cittadini», aggiunge il capo dello Stato.
Mattarella chiede «che le
riforme annunciate giungano con immediatezza a compimento» e che siano superate
«le logiche di appartenenza che, per dettato costituzionale, devono restare
estranee all’ordine giudiziario».
Per Mattarella il potere
giudiziario è vincolato al rispetto dei diritti dei cittadini. I quali «devono
poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e
l’ordine giudiziario» e non «devono avvertire timore per il rischio di decisioni
arbitrarie o imprevedibili che, in contrasto con la certezza del diritto,
incidono sulla vita delle persone».
Al Parlamento, investito di
questo appello, resta appena un anno di lavoro. Ma le resistenze dei magistrati,
unite all’insufficienza della riforma Cartabia, allontanano ancora la soluzione
del problema.
Il discorso di insediamento
del Presidente. La forza del presidente Mattarella e le critiche di Travaglio e
del Fatto.
Gian Domenico Caiazza su Il Riformista il 6 Febbraio 2022.
Il ruolo del Presidente della
Repubblica nel nostro sistema costituzionale – ruolo di garanzia e di
orientamento costituzionale dell’autonoma attività parlamentare e di governo –
condanna tradizionalmente il Capo dello Stato a discorsi, come dire, di alto
profilo istituzionale ma di prudente genericità contenutistica (fatto salvo il
peculiare ed eccezionale strumento del messaggio alle Camere, naturalmente).
Dunque sappiamo da sempre cosa sia lecito attendersi dai discorsi ufficiali del
Presidente, anche dai più solenni quali quello di insediamento, o quelli
consueti di fine anno: richiami ai principi costituzionali, sollecitazioni nella
scala delle priorità valoriali, moniti sull’etica pubblica e sulla doverosa
nobiltà della politica, solidarietà ed attenzione verso i più deboli.
Ferme queste premesse, è
difficile non cogliere nelle parole che il Presidente Mattarella ha rivolto alle
Camere riunite in occasione del suo secondo insediamento al Quirinale, un
segnale di novità proprio sullo specifico tema della riforma della giustizia.
Non fosse altro perché, al contrario, sul tema questo Presidente è stato sempre
molto parco. Salvo errori, non ho ricordo di significativi interventi del
Presidente Mattarella, in questi primi sette anni, che ponessero al centro della
sua attenzione i principi costituzionali del giusto processo, della presunzione
di non colpevolezza, della eccezionalità della privazione della libertà
personale prima di una definitiva sentenza di condanna, della finalità
rieducativa della pena. Sulla stessa riforma dell’ordinamento giudiziario egli,
pur presiedendo il Consiglio Superiore della Magistratura nel periodo certamente
di più grave crisi nella storia repubblicana, non è in realtà mai andato oltre
generici richiami di principio ad un riscatto etico e morale del potere
giudiziario.
Anche per contrasto con questo
suo consolidato atteggiamento, le parole sulla riforma della giustizia spese in
questa seconda cerimonia di insediamento, pur sempre costrette nella cornice
istituzionale propria del ruolo, colpiscono per la loro inedita forza. Le
sollecitazioni circa la necessità che la magistratura recuperi credibilità agli
occhi dei cittadini (“sentimento fortemente indebolito”) non sono certo nuove.
Lo è molto di più, invece, la riflessione successiva, per la quale i cittadini
«neppure devono avvertire timore per il rischio di decisioni arbitrarie e
imprevedibili che, in contrasto con la certezza del diritto, incidono sulla vita
delle persone». Una riflessione secca, dura e chiara che considera finalmente la
giustizia penale anche dal punto di vista di chi ne subisce l’esercizio. Se
rimanete scettici rispetto a questa mia riflessione, vi invito a leggere
il Fatto Quotidiano di oggi: “Mattarella bis: 55 applausi, soprattutto contro i
giudici”. E di lato, il direttore Travaglio riserva nel suo editoriale commenti
astiosi esattamente alle stesse parole che vi ho ora riportato.
Mattarella bacchetta politici
(che lo applaudono) e magistrati: “Manca progettualità, la giustizia così perde
credibilità”
Non solo: per la prima volta
il Presidente sottolinea come «Magistratura ed Avvocatura sono chiamate ad
assicurare che il processo riformatore si realizzi, facendo recuperare appieno
prestigio e credibilità alla funzione giustizia». È un richiamo esplicito al
ruolo cruciale dell’Avvocatura in ogni serio percorso di riforma della
giustizia, che sarebbe sciocco non apprezzare e valorizzare. Soprattutto
considerando che proprio sulla riforma dell’ordinamento giudiziario,
diversamente che in tema di riforma del processo
penale, Governo e Parlamento hanno scelto di escluderci da ogni tavolo di
discussione, percorrendo la strada, sterile e pericolosa, del confronto
esclusivo con la magistratura associata, chiamata dunque, contro ogni logica, a
riformare sé stessa.
Se infine consideriamo il
richiamo al sovraffollamento carcerario come intollerabile offesa alla dignità
umana, possiamo a buona ragione salutare con vivo apprezzamento nelle parole del
Presidente della Repubblica il segno di una nuova attenzione ai temi della
giustizia penale, declinata anche sul versante di chi ne subisce i morsi, e non
più solo delle virtù di chi l’amministra. Il tempo ci dirà se si tratta di una
rinnovata sensibilità del supremo garante della nostra Costituzione, come la
solennità dell’occasione ci autorizza a credere, e comunque a sperare.
Gian Domenico Caiazza.
Presidente Unione CamerePenali Italiane
Giustizialisti in lutto.
Mattarella lancia l’allarme sulle carceri e scatena la furia di Travaglio.
Piero
Sansonetti su Il Riformista il 5 Febbraio 2022.
Il fronte giustizialista, dopo
la gaffe dell’altro ieri in Parlamento, è stato preso per le orecchie e
richiamato all’ordine da Marco Travaglio. Il quale in questi giorni ha un bel da
fare a tenere uniti i suoi che scappano da tutte le parti: cinquestellati
indisciplinati, dimaisti diventati liberal, Conte che sbaglia le dichiarazioni,
magistrati che ci capiscono poco e vanno appresso alla corrente esultando invece
di fischiare. Un vero casino. Adesso, sembra, il fronte si è ricompattato (salvo
i traditori” come Di Maio, che quello è più infido di Galeazzo Ciano…), ed è
sceso in trincea contro il trio delle streghe: Mattarella-Draghi-Cartabia.
Travaglio è stato molto rude
sul suo giornale: si è disperato per l’insipienza di un bel drappello di 5
Stelle, anzi di tutti, che si son spellati le mani senza accorgersi
che Mattarella stava attaccando i magistrati. Il povero direttore, che ormai ha
assunto stabilmente la direzione di quel che resta del grillismo, li ha
bastonati. Deve aver pensato che se gli tocca andare avanti con questi qua non
va molto lontano. Nel suo richiamo all’ordine, anche per farsi capire dalle
teste dure del suo seguito, ha menato fendenti contro Mattarella, accusandolo
anche di avere tradito la Costituzione. Come? Non accettando la nomina di Paolo
Savona a ministro dell’economia e poi accettando le dimissioni di Conte e
conferendo l’incarico a Draghi. Travaglio ritiene che la Costituzione su questo
punto sia moto chiara: il premier deve essere Conte. Comunque il grande equivoco
dell’altro giorno è stato assai divertente. Vedere mezzo fronte giustizialista
(molto più di mezzo) battere le mani a Mattarella che picconava la magistratura,
è stato abbastanza spassoso. E certo non si può dare torto a Travaglio e alla
sua furia. Pensate che persino Gratteri ha omaggiato Mattarella, e che
oltretutto il suo omaggio è stato valorizzato proprio dal Fatto, probabilmente
all’insaputa del direttore.
Quindi oggi si festeggia? No,
per una semplice ragione. Quel Parlamento che ha passato il pomeriggio ad
applaudire Mattarella è lo stesso parlamento di conigli che negli anni scorsi si
è sempre piegato ai diktat della magistratura. Voi conoscete molti parlamentari
che si sono battuti contro lo strapotere dei Pm e per il ritorno allo stato di
diritto (invocato da Mattarella)? Io al massimo una decina. Tutti gli altri sono
sempre rimasti zitti, non hanno speso un centesimo del loro tempo per occuparsi
dei problemi della giustizia. Molti hanno fatto silenzio persino difronte agli
orrori di Bonafede, alle leggi borboniche, alle spazzacorrotti e spazza diritto,
alla consacrazione dell’eternità dei processi con l’abolizione della
prescrizione, all’affossamento della riforma carceraria, alla liberalizzazione
dei trojan tedesco-orientali, alle autorizzazioni ai processi politici ai
ministri; i più anziani di loro non si erano opposti all’arresto del
senatore Caridi (dichiarato dopo alcuni di carcere del tutto innocente), né
all’espulsione dal Senato di Augusto Minzolini (condannato da un giudice ex
sottosegretario del partito avversario) né di Berlusconi, avevano votato
la legge Severino, che è una mostruosità, e avevano in tutti i modi contribuito
al disfacimento del nostro sistema giudiziario, trasformato in una casamatta del
potere senza controllo di un gruppetto di magistrati.
Perché allora applaudivano
quando Mattarella denunciava questi misfatti? Certo, i misfatti più gravi sono
da attribuire alla magistratura, ma i parlamentari erano stati complici
convinti. Perchè erano stati complici? Solo per paura, per codardia? Può darsi.
E può darsi che ascoltando il “capo” che dava via libera a una riforma moderna
del catafalco giustizia, abbiano pensato: ma allora si può!. Sarà anche così, ma
proprio per questo: c’è da fidarsi? Io non mi fido. Non c’è bisogno di un
Parlamento che faccia piccole riforme. Occorrono colpi d’ascia con l’obiettivo
di riportare sotto controllo un potere assoluto che ha maturato una
degenerazione correntizia e soprattutto sovversiva. Servono molte leggi che
spezzino questa capacità di sopraffazione che inquina la modernità e la civiltà
e la libertà.
Separazione delle carriere,
responsabilità civile dei magistrati, fine del controllo del Csm da parte della
corporazione e delle correnti, prescrizione, introduzione di elementi che
stabiliscano la reale parità tra difesa e accusa, divieto di porte girevoli tra
politica e magistratura, fine dell’ergastolo e dell’inumano 41 bis, e molto
altro ancora. Ma soprattutto serve una riforma che tolga ai Pm e
ai Gip (spessissimo loro sodali taciturni) il potere quasi fisico di esercitare
una inaudita violenza sugli indiziati, sequestrandoli e sottoponendoli a
ricatto, paura, demolizione psicologica, talvolta vera e propria tortura. E
privandoli di ogni diritto umano e civile. Oggi nelle nostre carceri ci sono più
di 15 mila detenuti in attesa di giudizio. Cioè mai condannati. Cioè innocenti.
Più della metà di loro sarà assolta in primo grado, dicono le statistiche, un
altro 20 o 30 per cento in appello o in Cassazione; resta una piccola minoranza
che in gran parte sarà condannata a piccole pene.
Capite l’enormità di questa
ingiustizia? E voi lo sapete perché sopravvive questa ingiustizia medievale?
Perché senza questo potere i Pm e i Gip diventerebbero dei semplicissimi
inquirenti, costretti a trovare gli indizi e le prove, i riscontri, a lavorare
duro, a cercare i delitti e non a mettere nel mirino i sospetti (questa cosa la
dice addirittura Antonio Di Pietro). Proibire la carcerazione preventiva se non
nei casi estremi di violenza (poche centinaia all’anno) sarebbe davvero il primo
passo. E sarebbe la prova che Mattarella parlava sul serio. Se non si fa neanche
questo vuol dire che quel discorso era una messa in scena, erano una messa in
scena gli applausi, ed è spiegabile la reazione cauta di molti magistrati:
indispettiti, sì, ma sicuri che alla fine la spuntano loro, come sempre. Gli ha
fatto un baffo il clamoroso scandalo Palamara, figuratevi un discorsetto del
Presidente…
Piero Sansonetti. Giornalista
professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di cui è stato
vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004 al 2009, poi
di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per poi approdare
alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre 2019.
L’agenda Mattarella, un
memorandum destinato a proiettarsi oltre l’emergenza. Marzio
Breda su Il Corriere della Sera il 3 febbraio 2022.
Le parole vanno al di là del
governo Draghi e guardano ai sette anni. I richiami sulla giustizia e sui
vantaggi della «stabilità operosa».
Non dà lezioni e non assesta
frustate, ma non cauziona o compiace nessuno, Sergio Mattarella. Neanche le
Camere che lo hanno rieletto il 29 gennaio, e che adesso lo applaudono con
sollievo per ben 55 volte. Battimani che non sembrano distrarlo minimamente.
Serio e senza sorrisi, lo sguardo che a tratti si perde forse all’idea di come
la sua vita sta per cambiare contro i propri progetti, si lancia in un discorso
che è un’agenda per il Paese. Un memorandum destinato a proiettarsi oltre
l’emergenza di questo momento e anche oltre Draghi, sull’Italia che verrà.
Un testo dall’impianto
sofisticato e da leggere in filigrana , nel quale mette pure il Parlamento con
le spalle al muro, comunque elogiandolo — assieme alle autonomie — per il ruolo
di perno del sistema e cuore di ogni legittimazione politica. Spetta infatti in
primo luogo a Montecitorio e a Palazzo Madama sostenere l’opera del governo
Draghi, «nato con ampio sostegno parlamentare nel pieno dell’emergenza e
proiettato a superarla», ponendo le basi di una nuova fase «di crescita». Il che
si traduce in un richiamo al valore della «stabilità operosa». E dunque, per
estensione, alla responsabilità e alla lealtà verso l’esecutivo (inventato da
lui), ma soprattutto verso gli italiani. Che restano purtroppo «in difficoltà»
su tanti fronti.
È una riflessione che va
considerata su un orizzonte lungo almeno per i canonici sette anni, quella del
presidente, ciò che smentisce qualsiasi ipotesi di un mandato più breve. Perché
certe esigenze, compresa quella di un «indispensabile» adeguamento di pezzi
decisivi dello Stato, non possono essere affrontate e risolte in poco tempo.
Tuttavia, il presidente lascia intendere chiaramente che il cantiere va
inaugurato al più presto. Ed esorta ad aprirlo, forte dell’energia istituzionale
offertagli dalla larghissima maggioranza che lo ha confermato sul Colle.
Il capitolo sul quale
Mattarella non si preoccupa di mostrarsi ansiogeno per qualcuno (in questo caso
le toghe) è quello della giustizia, «terreno di scontro che ha sovente fatto
perdere di vista gli interessi della collettività», e nel quale lui stesso è
stato a più riprese chiamato in causa. Lo affronta, dopo aver glissato un po’
altri temi delicati («non spetta a me indicare percorsi riformatori da
seguire»), mettendosi — come altre volte in suoi interventi del passato — nei
panni dei cittadini. E rivendicando nel contempo il ruolo di capo del Consiglio
superiore della magistratura, con una allusione alla riforma annunciata dal
governo, che chiede sia completata «subito».
Ricorda che, fermi restando i
principi di «autonomia e indipendenza della magistratura», l’ordinamento
giudiziario deve «corrispondere alle pressanti esigenze di efficienza e
credibilità» richieste dalla gente comune. Il che troppo spesso non accade, e
questa non è una percezione distorta per un riflesso politico condizionato, ma
una realtà fattuale. Basta riandare alle vicende che hanno visto di recente il
Csm coinvolto in clamorose e delegittimanti polemiche per il mercato delle
carriere, favorito anche da perverse influenze delle correnti.
Ne fa esplicito riferimento,
il presidente, specificando che «le logiche di appartenenza, per dettato
costituzionale, devono rimanere estranee all’ordine giudiziario». E premendo
affinché sia «recuperato un profondo rigore», condizione indispensabile anche
per riconquistare «fiducia e non diffidenza» verso la giustizia, da parte dei
cittadini. È una questione di «credibilità», insiste con nettezza. Non è un
ammonimento di poco conto, in una fase storica in cui si affacciano nuovi poteri
(per esempio quelli che rimandano alla sfera del digitale), verso i quali la
funzione equilibratrice di una magistratura efficiente potrà risultare
essenziale.
Altro snodo, quello del
Parlamento, di cui sempre più spesso si lamenta la mortificazione durante il
processo di formazione delle leggi. Critica che Mattarella, dopo aver confermato
la centralità delle Camere, condivide, con una critica ad alcune prassi adottate
anche dal governo Draghi, e che va invece informato e coinvolto di più e meglio.
Perché «non è accettabile la forzata compressione dei tempi parlamentari», ciò
che rende necessarie «nuove regole» anche per favorire «una stagione di
partecipazione». Ragionamenti prescrittivi, quasi un programma, come quelli
sollevati da Mattarella per rendere «più moderna» e «più giusta» l’Italia — che
«è un grande Paese», sottolinea, come per dare coraggio a tutti — combattendo
grazie ai vaccini la lotta, «non ancora conclusa», contro il virus e
impegnandoci per la ripresa economica «con il concorso di ciascuno». Perno di
questo passaggio cui «siamo tutti chiamati», deve essere una «stabilità fatta di
dinamismo, lavoro, sforzo comune».
C’è molto da fare, dopo che
abbiamo attraversato la fase più acuta, luttuosa ed economicamente
destabilizzante dell’emergenza. A partire dalla conferma del nostro ancoraggio
all’Europa, della quale dobbiamo orientare «il processo di rilancio»
dell’Unione, in modo di rendere «stabile e strutturale la svolta compiuta con la
pandemia» e che ci vede nella veste di maggiori beneficiari del programma Next
generation. Serve quindi un nostro ruolo attivo, su tale fronte. E l’inevitabile
sottinteso è che nessuno meglio di Draghi può garantirlo. Come pure servono idee
chiare nella delicatissima partita in corso sull’Ucraina, dove non possiamo
permetterci un clima da nuova guerra fredda.
Per il resto, il discorso
d’insediamento è carico di cenni a una società in sofferenza e a troppi diritti
negati. Così è fatale che «la pietra angolare» della riflessione del presidente
sia riassunta dalla parola «dignità», ripetuta per 18 volte.
Dignità nel mondo del lavoro e
per i giovani sempre più sospinti verso «le periferie esistenziali», contro le
morti bianche, le disuguaglianze di genere, il razzismo e l’antisemitismo, la
violenza sulle donne, la povertà, le carceri sovraffollate, le mafie. Insomma,
un appello di matrice progressista che contempla la sua sensibilità e cultura di
cattolico sociale.
Mattarella bacchetta il
premier sulla riforma del Csm.
GIULIA MERLO su Il Domani il
03 febbraio 2022.
Il testo è fermo perchè mai
calendarizzato in cdm da palazzo Chigi. Ora, però, è corsa contro il tempo per
approvarlo in tempo per le elezioni del prossimo Csm a luglio 2022.
«Un profondo processo
riformatore deve interessare anche il versante della giustizia», ha detto
Mattarella, aggiungendo che «è indispensabile che le riforme annunciate giungano
con immediatezza a compimento affinché il Consiglio superiore della Magistratura
possa svolgere appieno la funzione che gli è propria».
La piramide di
responsabilità, infatti, arriva fino a Draghi e Mattarella ne è al corrente. Lì,
infatti, è da cercare la ragione del fatto che il ddl non abbia ancora
cominciato il suo iter di commissione vero e proprio.
GIULIA MERLO. Mi occupo di
giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla
Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato.
Riccardo Barenghi per “TPI -
The Post Internazionale” il 4 febbraio 2022.
Rino Formica e un uomo, un
socialista, che ha vissuto da protagonista tutta la nostra storia politica, dal
dopoguerra in poi. E’ stato un dirigente del Psi di primo piano, più volte
ministro, con sei presidenti del Consiglio (allora non si chiamavano premier):
Cossiga, Spadolini, Andreotti, Craxi, Goria e De Mita, deputato e senatore per
decenni. Oggi che ha 95 anni segue quotidianamente le vicende italiane,
politiche e non solo. E ha qualcosa da dire.
Allora Formica, e contento
della rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale?
«Contentezza e felicita sono
sentimenti che attengono alla sfera personale, non alla politica. Politicamente
sono soddisfatto che sia stato rieletto un uomo che appartiene alla storia, la
cultura e la tradizione del cattolicesimo democratico, una storia che e stata
fondamentale per la costruzione della democrazia italiana. Con Mattarella al
Quirinale e stato bloccato un tentativo di involuzione democratica».
Addirittura?
«Certo, anzi dico di più:
abbiamo rischiato la disgregazione del sistema politico, sociale ed economico
del Paese, che avrebbe portato a uno sbocco autoritario. Causato dalla
concentrazione dei poteri nelle mani di un solo uomo».
Sta parlando di Mario Draghi?
«Esattamente. Non nutro
un’ostilità personale verso il premier, ma se fosse stato eletto, avremmo
rischiato di smentire nei fatti l’essenza della democrazia, che e pluralità,
equilibrio e divisione dei poteri sotto la guida del Presidente della
Repubblica, da una parte, e della Corte costituzionale (oggi presieduta da uno
serio e bravo come Giuliano Amato) dall’altra, che vigila sulla costituzionalità
degli atti legislativi».
Invece con Draghi?
«Intanto c’è da notare con
rammarico che tutto il governo, tutti i ministri si sono trasformati in un
partito politico, appunto il partito di Draghi. Indipendentemente dalla loro
appartenenza originaria.
Si sono perfettamente
amalgamati con la componente tecnocratica del governo, composta da Draghi e
dagli altri ministri tecnici. Si tratta di una degenerazione profonda: il
governo che si fa partito, palazzo Chigi che diventa un centro politico della
gestione dell’elezione del Presidente della Repubblica.
Prima con la candidatura dello
stesso premier e poi con quella di Elisabetta Belloni: ma quando mai si e visto
un capo dei servizi segreti che diventa Capo dello Stato?».
Pero tutti la stimano, tutti
hanno detto che è una persona adatta a quel ruolo.
«Non la conosco e non dubito
che sia una persona straordinaria. Tuttavia chi dirige i Servizi deve garantire
la neutralità, deve tutelare il Paese da interventi esterni. Non può e non deve
diventare parte del gioco politico. Magari poi si sarebbe comportata benissimo,
ma e l’origine che conta».
E mai capitato nella nostra
storia qualcosa di analogo?
«Per fortuna no. Vi immaginate
cosa sarebbe successo, dopo la malattia di Segni, se il generale De Lorenzo si
fosse presentato in Parlamento chiedendo di essere eletto al Quirinale? Ecco,
pochi giorni fa stava per succedere che la Belloni incontrasse i gruppi
parlamentari per discutere della sua candidatura.
Se non ci fossero stati Renzi,
Forza Italia e qualche giornalista, avremmo visto tutta la politica in ginocchio
di fronte alla responsabile dei Servizi segreti, pronta a eleggerla al
Quirinale. E dopo quasi 80 anni di vita democratica...
Io sono di una generazione che
sa cosa vogliono dire la perdita della democrazia e la sua riconquista. La
perdita avviene in un attimo e ha un effetto immediato, la riconquista invece e
difficile, lunga e spesso sanguinosa. La nostra storia sta li a ricordarcelo».
La democrazia, almeno quella
italiana, si basa anche sui partiti politici, che oggi sono in profonda crisi. E
una crisi irreversibile?
«No no, nulla e irreversibile,
perchè quando la politica si trova faccia a faccia con la società la reazione
arriva.
Almeno si spera. Ma la crisi
più grave e quella delle nomenklature dei partiti, basta vedere come si sono
comportate durante la settimana di passione per l’elezione del Presidente. Ed e
una crisi che porterà ad abbattere simboli e frontiere, nulla insomma sarà come
prima».
Ma cosa intende quando parla
di “società”?
«Intendo la questione sociale.
La crisi colpisce tutti, tranne i profittatori piccoli e grandi, e quando parlo
dei grandi mi riferisco agli istituti finanziari mondiali. Ma il resto della
società e in sofferenza, il lavoro e le imprese operose.
Costrette a ricorrere a
sussidi pubblici, nonostante si siano sempre dichiarate contrarie a questa forma
di aiuto pubblico. Il potere politico non e stato in grado di gestire questa
situazione, ma si e limitato al paternalismo fatto di ristori e bonus oppure
all’imposizione antidemocratica che rischia di sfociare nella limitazione della
libertà di tutti».
Insomma, per citare una sua
frase famosa, la politica oggi e più merda che sangue?
«Io intendevo dire sangue e
passione, ma oggi non vedo passione nelle classi dirigenti, che non sono capaci
di capire quanto sia grave la sofferenza delle masse popolari».
Invece in passato ne sono
state capaci?
«Direi di sì, quando uscimmo
dalla guerra le forze repubblicane sono state in grado di accompagnare le masse
popolari, che provenivano da un regime monarchico-fascista, nella nuova era
democratica, di farle partecipare alla costruzione dello Stato nella cornice
della Costituzione.
Ovviamente non sono mancati i
conflitti politici e sociali, ma erano conflitti che si autoregolavano.
Smussando gli angoli più acuti che avrebbero potuto portare a esiti
imprevedibili e molto pericolosi. Invece negli ultimi trent’anni questo ruolo
delle classi dirigenti e totalmente mancato».
Perchè trent’anni?
«Perchè abbiamo assistito a
una dissociazione tra sviluppo politico e sviluppo sociale. Perchè lo Stato non
si è organizzato per intervenire nei conflitti sociali attraverso altri mezzi
che non fossero la promozione o la punizione».
Può spiegarcelo meglio?
«Negli ultimi trent’anni e
stato abolito l’intervento pubblico nell’economia, drasticamente smantellato il
rapporto virtuoso tra il mondo delle imprese, quello del lavoro e quello della
politica. E proprio quando siamo di fronte a una crisi globale, e le aziende
liberalizzano i loro capitali investendoli dove vogliono, nella finanza o nei
paesi nei quali il costo del lavoro e molto più basso che da noi, la politica
non fa da argine. Ma le lascia fare».
Neanche questo governo di
unità nazionale sarà in grado di risolvere una situazione così critica? «Si
tratta di un governo anomalo, mai esistito in Italia...».
Nella seconda metà degli anni
Settanta c’è stato un governo simile.
«Neanche per sogno, a
quell’epoca c’era una maggioranza parlamentare di unità nazionale, che sosteneva
il governo. Ma il governo era comunque di parte. Non c’erano ministri comunisti
per fare un esempio. La differenza con quello di oggi e sostanziale».
Insomma, non sembra così
radicale questa differenza.
«Invece lo e, eccome. Perchè
nel governo di unità nazionale la partecipazione degli avversari politici
richiede una grande fusione di intenti e di comportamenti per sostenerlo.
Qualsiasi ministro, da
qualsiasi partito provenga, diventa automaticamente responsabile di tutti gli
atti dell’esecutivo. La maggioranza e un’altra cosa, uno può votare la fiducia
al governo ma poi dissentire su questo o quel decreto. In quel caso i partiti
mantengono la loro autonomia politica, cosi come fece il Pci 45 anni fa».
E secondo lei questo governo
riuscirà a reggere nei prossimi mesi?
«Mah, non saprei prevederlo.
Certamente sconterà la presenza di ministri che appartengono a partiti diversi e
tra loro conflittuali. Vedrete cosa accadrà quando in primavera si andrà a
votare per i referendum e l’anno prossimo per le elezioni politiche. Con alcuni
ministri che sono stati mobilitati nel partito di Draghi, il quale poi pero non
e riuscito a prendere il potere».
Palazzo Chigi durante il voto
per il Colle si è trasformato in un centro politico per la candidatura del
premier. Mai vista una degenerazione così profonda guardato, e ancora riguarda,
la legge elettorale. Lei preferisce il proporzionale o il maggioritario?
«Possiamo anche adottare il
maggioritario, che pero rischia di diventare una semplice aggregazione tra
diversi, che subito dopo le elezioni si spacca come e già successo in passato».
Meglio il proporzionale?
«Certo, in teoria e virtuoso.
Ma se poi finisce che in Parlamento entrano cento partiti dell’un per cento
ognuno, allora...».
Siamo bloccati allora?
«Bisogna tornare al pensiero
politico: i nostri attuali leader ce l’hanno un pensiero politico? A me non pare
siano all’altezza, così come non lo e la società civile che loro rappresentano.
Sono tutti svogliati e inadeguati. Ma almeno loro si sono sottoposti al voto
degli elettori.
I tecnici invece ci propongono
la loro spocchia elitaria senza neanche chiedere un giudizio alla società che
governano, dimostrando un razzismo imbarazzante. Sono la casta non eletta».
Veramente e ancora il capo del
governo...
«Certo, ma Draghi sta a
palazzo Chigi, che dipende dal Parlamento e che può sfiduciarlo quando vuole. Se
fosse riuscito a farsi eleggere al Quirinale invece, sarebbe stato inamovibile
per sette anni».
A proposito, lei e favorevole
a un cambio radicale del nostro sistema istituzionale, pensa che dovremmo
diventare una Repubblica presidenziale?
«Prima mi devono spiegare
bene, possibilmente utilizzando un pensiero politico, le ragioni per superare la
democrazia parlamentare. Che non e un abito, oggi lo metto e domani lo cambio.
Ma e la nostra struttura ossea. E allora se un osso si spezza, puoi mettere una
protesi, ma mi devono dire che si e spezzato. Altrimenti, se l’osso e sano, non
si mette una protesi».
Ed e sano?
«E’ ovvio che c’è una
degenerazione del sistema, ma bisogna capire quali sono stati i fattori che
l’hanno provocata. Invece nessuno si cimenta nell’analisi della crisi, si va
avanti per tentativi tecnici senza riflettere sul motivo per cui qualcosa non ha
funzionato».
Uno dei tanti tentativi
tecnici ha riguardato, e ancora riguarda, la legge elettorale. Lei preferisce il
proporzionale o il maggioritario?
«Possiamo anche adottare il
maggioritario, che pero rischia di diventare una semplice aggregazione tra
diversi, che subito dopo le elezioni si spacca come e già successo in passato».
Meglio il proporzionale?
«Certo, in teoria e virtuoso.
Ma se poi finisce che in Parlamento entrano cento partiti dell’un per cento
ognuno, allora...».
Siamo bloccati allora?
«Bisogna tornare al pensiero
politico: i nostri attuali leader ce l’hanno un pensiero politico? A me non pare
siano all’altezza, così come non lo e la società civile che loro rappresentano.
Sono tutti svogliati e
inadeguati. Ma almeno loro si sono sottoposti al voto degli elettori. I tecnici
invece ci propongono la loro spocchia elitaria senza neanche chiedere un
giudizio alla società che governano, dimostrando un razzismo imbarazzante. Sono
la casta non eletta».
Giulio Gambino per “TPI - The
Post Internazionale” il 4 febbraio 2022.
Hic sunt peones, femminicidio
politico, da SuperMario a SuperSergio. Copyright: Roberto D’Agostino, fondatore
di Dagospia, che ha seguito l’elezione del Quirinale da vicino anticipando sul
suo sito notizie e indiscrezioni, sempre con un taglio critico e originale.
Lo abbiamo incontrato per
conoscere il suo punto di vista sulla settimana che ha aperto la peggiore crisi
istituzionale della Repubblica.
Roberto, come va?
«Sempre a corre’... comunque
guarda, ho appena titolato un pezzo del Financial Times: “Meno male che
l’ambizione sbagliata di Draghi e fallita”».
Cosi netto?
«Altro che “Gattopardismo”
(“Se vogliamo che tutto rimanga come e, bisogna che tutto cambi”): i sei giorni
della elezione del Quirinale hanno cambiato il Paese».
Ecco, partiamo da qui...
«Non c’era altra via
percorribile che la rielezione di Mattarella, sono stato tra i primi a dirlo, e
a scrivere “Salutamm’ a Draghi’’, in barba all’opinionismo a la carte dei Mieli
e dei Giannini. Non aveva i numeri, ma ha dato i numeri, quelli
dell’arroganza».
Perchè no?
«Intanto dovremmo chiederci:
come nasce questa sua ambizione? Uno pensa che dietro ci siano chissà quali
progetti, strategie poteri forti... invece essendo Draghi un soldato del Sistema
con la S maiuscola, di alto grado se vuoi, ma pur sempre un soldato, questa
autocandidatura al Colle durante la conferenza stampa di Natale ha lasciato
tutti a bocca aperta e con i capelli dritti».
Disse che la sua missione era
compiuta e che era «un nonno al servizio delle istituzioni»...
«Peggio: disse “ho lasciato
tutto a posto, le riforme sono state fatte, il Pnrr partirà, basterà spingere un
bottone”.
Intanto, finora, non e stato
aperto nemmeno un cantiere per le riforme chieste dall’Europa in cambio dei 209
miliardi del Pnrr.
Abbiamo solo fogli di carta,
ben scritti, ma fatti zero. Secondo: lo stato rissaiolo dell’alleanza
governativa non avrebbe mai permesso un premier di parte.
Quindi un Daniele Franco al
suo posto avrebbe rimboccato la lapide alla democrazia parlamentare fondata sui
partiti: due tecnici ai vertici dello Stato. Cosa mai vista».
Eppure, fino a qualche
settimana fa, pareva che Draghi potesse fare e dire tutto, anche auto-candidarsi
al Quirinale...
«Ma se n’e fregato bellamente
di seguire i canoni istituzionali. Perchè come tutti sanno non ci si può
candidare alla presidenza della Repubblica, non e previsto dalla nostra
Costituzione. Come giustamente ha detto Sabino Cassese: “Le cariche pubbliche
non si sollecitano, nè si rifiutano”».
E come mai ha creduto di
poterlo fare?
«Intanto partiamo col dire che
la più grande sponsor della autocandidatura di Draghi al Colle e stata
Serenella, sua moglie.
In tutti gli anni in cui il
premier era presidente della Bce a Francoforte non ha mai convissuto con il
marito, andava solo per gli incontri importanti, e nel weekend era lui a
scendere a Roma.
Ora lei era decisissima a far
si che il suo Mario restasse in Italia. E cosa c’è di meglio di sette anni al
Quirinale?».
Non posso credere che sia
stata solo la moglie...
«Quando il Governo Conte Bis
stava per implodere e ci fu il colloquio risolutore tra Mattarella e Draghi in
cui quest’ultimo accetto di fare “l’Uomo della Provvidenza”, di prendere in mano
patria e governo dopo la cacciata di Conte, in quella circostanza ci fu -
raccontano - una sorta di patto.
Sergione (Mattarella, ndr)
avrebbe proposto a Draghi: “Stai un anno e mezzo a Chigi, metti sulla retta via
questo disgraziato Paese, e poi io ti lascerò il mio posto”. Ma non avevano
fatto i conti con i partiti».
E poi?
«Nel pieno dell’emergenza
Covid e della gestione del Pnrr, davanti all’inadeguatezza e all’inaffidabilità
del governo Conte, Merkel e compagni telefonano a Mattarella, il capo dello
Stato interviene in maniera assertiva e Draghi diventa premier, eccitato anche
dal “patto” con trasloco al Colle».
Il peccato originale per la
candidatura al Colle di Draghi origino in quel momento?
«Durante il mio apprendistato
politico con Cossiga, ho sempre fatto tesoro di questa lezione: il potere non e
quello che vedi. E invisibile. Sta dietro, tira i fili, e dà i suoi input».
Eppure c’era chi sosteneva che
non ci voleva molto perchè nascesse un Conte ter, bastavano una decina di
parlamentari “responsabili”...
«Può darsi ma qualcuno
dall’alto, immagino dal Quirinale e dal Deep State, ha chiamato i vari Tabacci
(che poi e stato non a caso premiato, diventando sottosegretario), i vari Cesa,
i vari Rotondi, coloro che tengono le fila del Gruppo misto, e ha detto ‘’Alt!”,
dando l’ordine di stare a cuccia».
Spiegati meglio.
«Se tu ti ricordi, in quei
giorni era attesa una conferenza stampa della moglie di Mastella (Sandra
Lonardo, ndr) a favore della nascita del Conte ter. C’erano già i giornalisti
seduti col taccuino in mano, ma lei non si presento mai. Chiedete a Mastella per
quale motivo. Semplicemente dall’alto arrivo un input diverso».
Alcuni dissero che fu un
complotto internazionale...
«Ma no, quale complotto! La
politica si fa anche in base a quello che dicevo prima, a quel “potere
invisibile”, a quel Deep State che tira i suoi fili. E cosi accadono o meno
certi eventi, certe strategie, certi governi».
C’entrano anche gli Usa?
«C’entrano sempre. La fine di
Conte e l’arrivo di Draghi e avvenuto soprattutto perchè arrivo un nuovo
inquilino alla Casa Bianca.
Il soprannome ‘’Giuseppi’’
nasce da un tweet di Trump dedicato alla gloria di Conte. Il cambiamento
politico che avviene negli Usa e un cambiamento che non può non rimbalzare anche
in Italia.
Siamo un piccolo paese ma come
“espressione geografica” ha una sua importanza essendo piazzato dalla mano di
Dio in mezzo al Mediterraneo».
Quel cambio di Governo fu il
risultato anche di un sostegno eccessivamente sbilanciato da parte di Conte a
favore della Cina?
«La parola che conta in
politica e una sola: affidabilità. Se lo sei, puoi permetterti di avere un
colloquio o di fare una trattativa o un’alleanza. Se non lo sei, il discorso si
chiude e devi cambiare mestiere.
Il governo Berlusconi, a
dispetto di quello che raccontavano i giornaloni, cadde per i rapporti d’affari
che il Cavaliere aveva all’epoca con Putin, più che per le sue prodezze
sessuali. Non era affidabile e a colpi di spread e stato accompagnato all’uscita
di Palazzo Chigi...».
Il Sistema vince sempre e su
tutto. E cosi?
«Sempre. Magari in seconda
battuta, ma alla fine prevale. Del resto, ogni potere e costruito su una rete di
rapporti e alleanze dotata di regole ferree. Prendi Roma, nel suo piccolo e
“fondata” sui circoli cosiddetti sportivi: al Circolo del Tiro a Volo trovi la
nomenclatura massonica del Deep State, al Circolo Aniene troneggia la borghesia
Malago - Vanziniana, il Circolo degli Scacchi e in mano ad alti esponenti dello
Stato, eccetera. E tutto si regge sull’affidabilità e rispetto delle regole».
E succede mai che il Sistema
perda?
«No. E lo hai visto in questi
giorni quirinalizi. Colpito da un leggero attacco di follia (mollare il governo
e traslocare nel palazzo dei Papi), pur essendo lui “uno di loro”, uno del
Sistema per intenderci, l’ambizione sbagliata di Draghi e stata legnata e
cancellata dai giornali del Sistema: dal Financial Times a The Economist.
L’elite finanziaria aveva già
deciso che il loro soldatino dovesse restare a Chigi a governare la stabilita
finanziaria-economica del Paese».
Certo che l’immagine di Draghi
che legge The Economist - il settimanale liberista per eccellenza - e si vede
bocciato dagli “amici di casa” fa impressione...
«Poverino, dopo anni di
salamelecchi e pigiamini di saliva, e dura... Pero lui si e giocato davvero
tutto con quella idiozia dell’auto-candidatura. Se continuava a fare il Draghi
decisionista, del “Whatever it takes” dei primi mesi, andava bene, perchè aveva
la liberta di dire no a chi voleva.
Quando, calzata la maschera
del Marchese del Grillo, gli e presa la stoltezza di decidere da solo che
avrebbe fatto il capo dello Stato e caduto dal pero...».
E la politica si e ribellata.
«Dopo che i partiti avevano
preso calci e schicchere, a cui lui rispondeva con un ghigno sprezzante dicendo
loro “parlate col mio capo di gabinetto”, quando poi e stato lui a bussare ai
leader per avere i voti del Colle, il re appare improvvisamente nudo e loro
l’hanno mazzolato».
Ma politicamente qual e il
giudizio che possiamo trarre su questo anno di Draghi?
«E emerso un grosso problema,
tipico dei tecnici prestati al potere politico: i Dini, i Monti, i Draghi sono
abituati a dare ordini ai loro dipendenti di Bankitalia o della Bce.
Nella politica invece non
funziona per niente cosi. Se i tecnici ubbidiscono, con i politici devi
trattare».
Comunque il Sistema, come lo
chiami tu, alla fine ha fermato persino Draghi.
«Lo ha fermato, in maniera
anche netta. Già durante il G20 a Roma, da Biden a Macron, tutti gli avevano
chiesto di restare a Chigi. Poi e stata la volta dei mercati. E le cancellerie
hanno iniziato a telefonare... e a muoversi»
Qualcosa era evidentemente
cambiato.
«E stata una bella botta... ma
Draghi e un tipino talmente pieno di se che può stare tre mesi senza
mangiare...
Quella arroganza tipica di chi
non e abituato alla mediazione, alla trattativa, a quello che io chiamo
“attovagliamento” in modalità Andreotti: della serie, questa e la torta, una
fetta per uno e siamo tutti felici e contenti.
Mariopio non ha l’attitudine e
la capacita politica di poter trattare con questi scappati di casa, alcuni anche
fuggiti dal T.S.O...».
Pero gli scappati di casa sono
stati gli unici, ben più dei loro leader di partito, a trovare una soluzione
politica che ha portato alla ri-elezione di Mattarella...
«Attenzione: e stato rieletto
a furor di peones... i leader di partito, anche quelli che non volevano farlo,
sono stati obbligati fisicamente a votare Mattarella da una massa di
parlamentari che una volta veniva schifata e identificata come “i franchi
tiratori”.
Non si era mai visto in tante
elezioni del Quirinale, per di piu senza una precisa indicazione politica, che
un nome ricevesse cosi tanti voti, come e stato nel caso di Mattarella. E non
solo per continuare a prendere lo stipendio e per raggiungere il settembrino
vitalizio della legislatura...».
E quindi ora e tutto di nuovo
come prima?
Per nulla! Anzi, nulla sarà
come prima. Se Draghi e azzoppato, non c’è un partito – a parte quello della
Meloni – che non sia spaccato o alla deriva come Lega e 5Stelle. Si sono salvati
solo grazie al ritorno in forze della Prima Repubblica: Amato alla Corte
Costituzionale, Mattarella al Quirinale, Draghi a palazzo Chigi. La Democrazia
Cristiana, grazie al cielo, non muore mai».
Formigli nella sua
PiazzaPulita ha mostrato altri due esponenti della Prima Repubblica, Mastella e
Cirino Pomicino, che per questa elezione al Quirinale sono tornati sul ring a
combattere...
«E hanno annichilito Mieli e
Calabresi. Una capacita di ragionare sul potere, che oggi pochissimi hanno, ha
nanificato l’attuale classe politica. Le terribili interviste rilasciate dal
socialista craxiano Rino Formica, i vari Salvini e Conte e Letta dovrebbero
ritagliarle e studiarle. Te l’ho detto... e la rivincita della Prima Repubblica.
“Mastella il mozzarellaro”,
com’era liquidato all’epoca mia, e sembrato un gigante. E dobbiamo ringraziare
quella tanto vituperata democristianeria se oggi sul Colle c’è il mattarello di
Mattarella».
Chi ha mostrato il peggio di
se?
«Salvini ha sbagliato di
tutto, di più. Un uomo-sola- al comando. Era un ubriaco, senza la scusa dei
mojitos del Papeete (“Voglio i pieni poteri”). Ha bruciato un nome dopo
l’altro.
Non puoi mandare a sbattere
cosi la seconda carica dello Stato, come avvenuto con la Casellati. E non lo
dico certo per simpatia personale verso la presidente del Senato, ma per
rispetto delle istituzioni».
Forse lei pero si sarebbe
dovuta tirare indietro anzichè inviare messaggini a raffica per chiedere di
ritentare il voto su di lei...
«Quella e la vanita, l’inferno
di ogni persona, uccide chiunque. Non c’è niente da fare. La delusione che ho
avuto quando Draghi si e messo in testa di salire al Quirinale...guarda,
credimi, avevo rispetto e ammirazione, e invece anche lui... siamo tutti
fragili».
A questa confusione generale
hanno contribuito anche quelli che noi abbiamo chiamato i signori della
Draghicrazia.
«Pensa a Paolino Mieli... ha
detto tutto e il contrario di tutto. Ogni giorno ne sparava una. Fino all’ultimo
giorno utile giurava che Draghi sarebbe diventato capo dello Stato. Chi tifava
per Belloni, chi per il premier...».
I 5 Stelle tifavano proprio
per la numero uno dei servizi segreti.
«Di che meravigliarsi? I
grillini sono stati capaci di prendere un avvocato che camminava per strada e
l’hanno incoronato premier.
A Conte chiederei: “Era
consapevole che con la Belloni sul Colle, Draghi si sarebbe ovviamente dimesso
con le conseguenti elezioni anticipate?”.
A parte che la Belloni era
stata nominata a capo del Dis da Draghi per poi ritrovarsela superiore di grado,
ma nessun Paese mette il capo dei servizi a fare il Presidente della Repubblica,
nemmeno in Sud America. In realtà, Conte voleva andare al voto».
Si ma prendeva poco mi sa...
«Ma nelle liste avrebbe
piazzato i suoi fedeli contiani, levandosi di torno tutti i Di Maiani. Conte,
comunque, avrebbe dovuto fare il suo partito, subito dopo l’uscita da palazzo
Chigi. Aveva ragione Casalino».
E oggi da SuperMario siamo
arrivati a SuperSergio.
«Con Draghi azzoppato, chi ha
il coltello dalla parte del manico oggi e Mattarella. Lui terra per le palle i
partiti. A ogni rissa e screzio dira: “Siete venuti in ginocchio a chiedermi di
rimanere, ora fate come dico io”. Chi sarà davvero importante affinchè Draghi
possa andare avanti col suo governo fino alla fine della legislatura 2023 sarà
proprio il capo dello Stato».
Diamo i voti anche agli altri.
Enrico Letta?
«E riuscito a fare il miracolo
di far cadere quella king-pippa di Salvini. Dopo la penosa rinuncia di
Berlusconi, Salvini ha preso in mano il centrodestra e Sotti-Letta, giocando di
rimessa (“Hai la maggioranza dei voti, devi essere tu a proporre un nome”) ha
vinto a meta, perchè il candidato di Enrichetto, altro soldatino del Sistema,
era appunto Draghi.
Ma era inviso all’altra metà
del Pd: Franceschini, Base Riformista di Lotti e Guerini, e i “Giovani turchi”
di Orfini».
Giorgia Meloni diventerà la
prima donna premier del Paese?
«Se per caso lo diventa, può
durare un quarto d’ora, credo. La Gigiona nella stanza dei bottoni a Palazzo
Chigi ha fatto ridere pure Berlusconi. A parte dire no-no-no, ha mai fatto un
governo ombra? Con quale classe dirigente? E poi, con le sue alleanze
sovraniste, e massimamente invisa all’Unione Europea...».
Guido Crosetto?
«Uno stipendiato dal governo,
tramite la Federazione delle Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la
Sicurezza (Aiad) di cui e presidente, e che pero al contempo fa l’ideologo
d’opposizione e il consigliere-tutor della Meloni minando lo stesso governo che
lo paga».
Luigi Di Maio?
«Ha cambiato sesso tante di
quelle volte... Era il fratello gemello di Di Battista, voleva l’impeachment di
Mattarella, incontrava i Gilet gialli. Poi improvvisamente, da buon napoletano
tendenza Gava, ha capito com’e il sistema del potere.
Ha passato il suo tirocinio
alla Farnesina ed ora e un ottimo pompiere (non a caso tifava Draghi). Comunque
mi sembra che nel M5s la scissione sia ormai nell’ordine delle cose...».
Giancarlo Giorgetti?
«Non vuole più essere il
burattino di Salvini. Il Truce ha due opzioni: o cambia cervello o verrà messo
da parte prima o poi...».
Goffredo Bettini?
«Consigliere segreto di
Giuseppe Conte, anello di congiunzione tra “vecchia sinistra” post-comunista e
post-cattolica e “nuovi progressisti” post-populisti, Bettini ha toccato il
climax quando, insieme a Zingaretti, ha incoronato Conte “punto fortissimo di
riferimento di tutte le forze progressiste”. Conte capisce di politica meno del
mio labrador Zen».
Ma esiste oggi un buon
politico?
«E una brutta domanda. Uno che
io stimo, dai tempi di Cossiga, e Luigi Zanda...».
L’elezione del Quirinale e
stata un flop non solo per i partiti ma anche per alcuni talk show e dirette
tv...
«Quando la mattina vedo i dati
televisivi della sera prima e leggo di trasmissioni con share al 7-8 per cento
mi domando: ma nessuno di questi si chiede dove sta l’altro 92 per cento degli
italiani?
Perche i cittadini non sono
interessati in un momento cosi sacro per il Paese? Fanno il 5 per cento e
stappano lo champagne.. Ma hanno ragione i telespettatori perche i talk oggi
sono pieni di opinionisti senza opinione, ma bravissimi a far scomparire le
notizie».
Cosa ti rimane di questa
partita per il Quirinale?
«Oggi non stiamo assistendo a
un collasso improvviso: trattasi di una lunga malattia che viene da lontano,
epoca Tangentopoli. E se oggi ad averla vinta e un democristiano c’e da
riflettere su questo sistema di potere giunto alla frutta. Moriremo
democristiani? Mille volte meglio di salviniani, meloniani o contiani: quella si
che sarebbe una brutta morte».
Francesco Verderami per
il "Corriere della Sera" il 10 febbraio 2022.
«C'è una ragion di Stato che
impone di chiudere subito la vicenda». Parlò di «ragion di Stato» il ministro
della Difesa la notte in cui prese quota la candidatura di Elisabetta Belloni al
Colle. Era l'ultima notte di quei «giorni travagliati». A colloquio con il
leader del Pd Enrico Letta, Lorenzo Guerini urlò come mai gli era capitato
prima, perché «non si doveva arrivare dove si è arrivati», perché «non si doveva
inserire il nome del capo del Dis nella rosa per il Quirinale», perché «va
tenuto conto della delicatezza del suo ruolo», perché «non si possono tenere in
fibrillazione gli apparati della sicurezza».
E per quanto sorpreso dalla
«coda bislacca» della trattativa sul capo dello Stato, il ministro dem pose
soprattutto l'accento sulla «ragion di Stato». Ed è proprio seguendo la logica
della «ragion di Stato» che ieri il Copasir ha dato prova di un ritrovato senso
delle istituzioni, se è vero che - durante l'audizione della responsabile dei
Servizi segreti - i membri del Comitato per la sicurezza della Repubblica si
sono concentrati sulla crisi ucraina e non hanno posto domande sulla questione
quirinalizia che l'ha coinvolta.
Lo avevano fatto anche il
giorno prima con il ministro degli Esteri, che pure era stato parte dell'affaire
opponendosi alle modalità con cui la Belloni era stata infilata nel tritacarne
dei quirinabili. È stato un segno di resipiscenza (quasi di riscatto) del
Parlamento, dopo la sbornia di una settimana surreale che - per effetto di
mediazioni senza soluzioni - avrebbe infine portato alla rielezione di Sergio
Mattarella.
In quei giorni, a detta di
Matteo Salvini, il nome della Belloni «mi venne proposto da Enrico Letta e
Giuseppe Conte», che a sua volta inserì tra i promotori della candidatura «anche
Roberto Speranza». Nel Palazzo non sono ancora certi su chi sia stata la mente
del progetto, diciamo, ma è agli atti la reazione immediata di quanti lo hanno
combattuto: dalla maggioranza del Pd a Forza Italia, da un pezzo di M5S ai
centristi di ogni latitudine, dalla senatrice di sinistra Loredana De Petris a
Matteo Renzi che disse «l'Italia non è l'Egitto».
E tutti insieme, per «ragion
di Stato», evitarono di dar corso a una polemica che - come rileva Guerini -
sarebbe stata «dannosa verso l'immagine di strutture così importanti e
delicate»: «L'improvvisazione di quei giorni ha già fatto abbastanza danni. La
politica deve avere l'intelligenza di non trascinare nell'agone persone e
istituzioni che vanno tutelate nell'interesse del Paese».
Una risposta indiretta a chi
ha continuato a sostenere che sia stata «un'occasione persa non portare una
donna al Colle», o a chi ha provato a giustificarsi spiegando come non ci
fossero «norme di legge» che ne impedissero l'elezione. Ma ci sarà un motivo se
il sottosegretario con delega ai Servizi è dovuto intervenire due volte in pochi
giorni, per dire che «su certe cose non si può giocare».
Anche ieri, e sempre per
«ragion di Stato», Franco Gabrielli è stato costretto a rompere il riserbo che
pure attiene al suo incarico: un fatto senza precedenti, perché non ha
precedenti quanto è avvenuto. Preoccupato di preservare il Dis, oltre che la
persona posta al suo vertice, si è presentato a Porta a Porta per ribadire «la
mia fiducia personale e quella di Mario Draghi» verso Belloni.
E siccome in Transatlantico si
erano sparse voci sul fatto che il capo del Dis avesse messo a disposizione il
suo mandato, ha affermato che «non è mai stata in discussione la sua rimozione».
Di più. Gabrielli ha offerto una ricostruzione dell'ultima notte della corsa al
Colle.
Ha raccontato di essere stato
«informato» dalla responsabile dei Servizi e di aver seguito «passo passo» la
storia, rivelando che «l'ambasciatrice da grande servitrice dello Stato» ha
vissuto gli eventi «con molto fastidio e con particolare partecipazione
emotiva»: «Lei è stata vittima di questa vicenda. E ora bisogna imparare dagli
errori».
Per decrittare l'ultimo
passaggio, viene utile l'intervista che Gabrielli aveva concesso giorni fa a
Zapping : per il futuro «credo sia opportuna una limitazione dell'elettorato
passivo per tutte le cariche che hanno un ruolo così importante». Era una regola
non scritta della politica, che un gioco irresponsabile costringerà a
trasformare in norma di legge. Per «ragion di Stato».
Yoda per “il Giornale” il 4
febbraio 2022.
Il sogno di Pier Ferdinando
Casini di salire sul Colle più alto di Roma, il Quirinale, è tramontato per
colpa di una cioccolata calda. Di prodotti culinari che hanno caratterizzato i
momenti politici nodali della storia recente ce ne son stati tanti: dal
celeberrimo patto della crostata a casa di Gianni Letta sulle riforme tra Silvio
Berlusconi e Massimo D'Alema; a quello delle sardine in cui Umberto Bossi e
«Baffino» organizzarono il ribaltone contro il primo governo del Cavaliere;
all'ultimo delle «pere cotte» a Villa Grande, sulla candidatura di Berlusconi al
Quirinale.
Ora è venuto il turno della
cioccolata calda. Venerdì 28 gennaio, in un appartamento di via Veneto,
dépendance del ministero per lo Sviluppo Economico, padrone di casa Giancarlo
Giorgetti, Mario Draghi ha incontrato Matteo Salvini e - sorseggiando appunto
una cioccolata calda - gli ha spiegato perché per lui Casini non poteva andare
bene come capo dello Stato.
«Un conto è la conferma di
Mattarella - gli ha spiegato -, un altro è avere un politico sopra di me al
Colle». E il leader della Lega che fino ad allora aveva dato un mezzo assenso su
Casini, o, comunque, non aveva detto di «no» a quella candidatura a Silvio
Berlusconi, a Matteo Renzi e, addirittura, a qualche esponente del Pd dell'area
vicina a Dario Franceschini, ci ha ripensato.
Così quella cioccolata è
diventata estremamente amara per l'ex presidente della Camera. È stata proprio
quella riserva sul nome «politico» espressa dal premier a permettere che
entrassero in pista due donne, anche se solo per dodici ore: prima Elisabetta
Belloni, eppoi, durante la notte tra venerdì e sabato, Marta Cartabia.
Fuochi di paglia, certo, ma
che sono serviti ad archiviare il nome di Casini. E pensare che qualche giorno
prima quest' ultimo aveva chiamato il premier per chiedergli: «Caro Mario, ma tu
sei contro la mia candidatura?». Ricevendo da Draghi una risposta in tipico
stile gesuita, secondo i preziosi insegnamenti ricevuti in collegio: «Ma ti
pare? Certo io preferirei il bis di Mattarella o un nome come quello di Giuliano
Amato, ma non pongo veti su nessuno».
Invece, il veto è arrivato
eccome. Accompagnato dalle pressioni di Giorgetti e di alcuni governatori, la
vera corrente draghiana dentro la Lega. E pensare che Casini aveva dato una
serie di rassicurazioni a Salvini: sull'incarico di formare un governo in caso
di vittoria del centrodestra alle elezioni («Lo darei a te, non certo alla
Meloni»); e, ancora, sulla giustizia, argomento su cui il leader della Lega è
estremamente sensibile. Salvini, però, non si aspettava un'opposizione così
ferma da parte di Draghi. E nemmeno la sua capacità di manovrare dentro i
partiti con i ministri del suo governo.
In più, non aveva calcolato a
dovere il particolare anagrafico: Casini è troppo giovane per un premier che in
futuro potrebbe anche essere tentato di riprovarci. E ha ceduto di fronte alla
cioccolata. Certo il «siluramento» della candidatura Casini non ha giovato più
di tanto al premier. A parte gli endorsement di nove decimi della stampa
nazionale a favore del suo trasloco al Quirinale, per molti il suo fallimento
era segnato.
In un sms inviato ad un amico
di vecchia data il 24 gennaio, cinque giorni prima della conferma di Sergio
Mattarella, il neo presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, si era
lasciato andare ad una previsione secca: «Draghi non andrà neppure in
votazione». Più preciso di Nostradamus.
Otto e mezzo, Beppe
Severgnini smonta gli applausi a Mattarella: "Solo per il posto". Lilli Gruber
scoppia a ridere.
Giada Oricchio su Il Tempo il 03 febbraio 2022
Mattarella rockstar? E Lilli
Gruber scoppia a ridere. Sergio Mattarella è di nuovo presidente della
Repubblica. Con un discorso di 38 minuti è rientrato al Quirinale per un secondo
mandato di 7 anni. Parlamento entusiasta (per non dire genuflesso), leader
politici al settimo cielo. Un atteggiamento che Beppe Severgnini, giornalista
del “Corriere della Sera” ha messo alla berlina. Ospite di “Otto e
Mezzo”, giovedì 3 febbraio, la conduttrice Lilli Gruber gli ha chiesto: “C’era
più ipocrisia o sollievo nei parlamentari che si sono alzati ad applaudire il
presidente interrompendo ben 55 volte il discorso di insediamento? Un record
assoluto” e lo scrittore con la tipica ironia: “Beh, c’è un’inflazione anche
negli applausi. C’era il sollievo di chi ha mantenuto il posto che è stato un
elemento importante di questa scelta, c’era il sollievo di chi non ha visto
l’odiato rivale in quel posto. Ad esempio c’erano dei 5 Stelle strafelici di non
vedere lì Draghi. E poi Mattarella ha detto una cosa importante: il Parlamento
deve avere tempo di vedere le leggi, questa è stata una sgridata la governo,
sulla legge di bilancio non hanno avuto tempo di guardare niente”.
Severgnini ha concluso con una
battuta fulminante: “Mattarella è la rockstar della politica e davanti aveva
persone che a un concerto al massimo possono suonare un triangolo!”. E Gruber ha
riso di cuore.
Gli applausi meritati e
quelli fuori tempo.
Aldo Grasso su Il Corriere della Sera il 5 febbraio 2022.
A scena aperta. Alla
fine, Sergio Mattarella è stato , mai così tanti nella storia della Repubblica
per un discorso presidenziale. Tutti meritati, sia chiaro, tuttavia è la prima
volta che un evento istituzionale ottiene un consenso caloroso a tal punto.
Ormai si applaude dappertutto, in ogni situazione, tanto da far nascere il
dubbio che stia cambiando il concetto stesso di applauso come se i talk show
(dove si applaude di continuo e a comando) ci avessero inculcato un format
comportamentale. Abbiamo preso l’abitudine di applaudire fuori luogo, fuori
tempo, fuori scena. Applaudiamo in chiesa, applaudiamo ai funerali
(l’orchestrazione funebre del battimano è diventata un’indecorosa usanza),
applaudiamo durante il minuto di silenzio, applaudiamo per paura del silenzio,
applaudiamo per i famosi 92 minuti fantozziani. Un applauso non lo si nega a
nessuno, proprio perché il gesto è stato svuotato di senso: può anche
trasformare una tragedia in commedia. Aveva capito tutto Carmelo Bene quando
sosteneva che l’applauso è una specie di arroganza mascherata, «nella
convinzione che, con un po’ di prove, quelli in platea farebbero meglio di
quelli in scena». La fine del mondo sarà accolta da grandi applausi credendo si
tratti di un colpo di teatro.
La rielezione di Sergio
Mattarella è stata pianificata a tavolino.
Benedetta Frucci su Il Tempo
il 07 febbraio 2022.
Era il 28 agosto del 1998 e,
avvicinandosi le votazioni per rieleggere il nuovo capo dello Stato, Francesco
Verderami intervistava sul Corriere della Sera l'allora capogruppo del Ppi. La
proposta che ne scaturiva era: perché non rieleggiamo Scalfaro per un secondo
mandato? Il cronista chiedeva: una figura come lui? L'intervistato rispondeva:
«No, io penso proprio a Scalfaro». Il politico intervistato rispondeva al nome
di Sergio Mattarella. Ventitre anni dopo, da Presidente della Repubblica, sembra
aver cambiato idea e, nell'ultimo anno del suo mandato, fa trapelare con
fermezza di non essere disponibile a un eventuale bis. Niente di male, passano
gli anni, cambiano le posizioni, come è normale che sia. E, senz' altro, la
contingenza del quadro politico. Eppure, qualcosa fa sorgere il dubbio che il
racconto dell'uomo mite, quasi naïf, costretto al sacrificio di un secondo
mandato a causa dell'insipienza della scolaresca che popola l'aula parlamentare,
non sia esattamente corrispondente al vero. Mancano pochi giorni a Natale e, nei
corridoi di Palazzo Madama semideserti, un senatore dem si lascia andare a una
confessione: «Per me, il prossimo capo dello Stato sarà Sergio Mattarella».
L'interlocutore è dubbioso:
«Ma come, ha chiaramente escluso la sua rielezione!». Protesta. Il senatore
abbassa la voce e racconta: «Hai presente quella proposta di legge depositata
dal Pd, che vieta il doppio mandato presidenziale? Ebbene, sappi che è stata
suggerita dall'entourage di Mattarella». L'interlocutore non capisce ed esclama:
«A maggior ragione, a conferma che il Presidente è assolutamente contrario alla
rielezione». Il senatore sorride con l'aria di chi la sa lunga: «Eh no, è
proprio questo il punto. Il deposito di quella proposta di legge è la condizione
che dal Quirinale chiedono perché Mattarella possa aprire al bis».
L'interlocutore è confuso, il senatore perde la pazienza ed esclama: «È chiaro
no? È la logica dei vecchi democristiani di sinistra, sopravvissuti a
Tangentopoli prima e alla seconda Repubblica poi. In questo modo l'accettazione
di un secondo mandato sarebbe vista come l'ultima forzatura, il sacrificio
finale». «E tu che fai, la firmi?», chiede l'interlocutore. «Non la firmerò, ma
vedrai come andrà a finire... voi, Mattarella, non l'avete proprio capito»,
risponde il senatore. E in effetti, i firmatari di quella proposta di legge,
Zanda, Parrini e Bressa, coincidono anche con quell'ala dem che da sempre e a
carte scoperte aveva tifato per un bis di Mattarella. Insomma, con il senno di
poi qualche altro indizio c'era stato.
Pensiamo alla comunicazione.
Il Quirinale non ha mai optato per una comunicazione che non fosse
ultraistituzionale, eccezion fatta per la scelta di mostrare il volto umano del
Presidente, che come tutti gli italiani, non può andare dal barbiere.
All'improvviso però, alla scadenza del mandato, inizia a trapelare di tutto:
dagli scatoloni segno dell'imminente trasloco, alla ricerca dell'appartamento ai
Parioli. Per poi passare, durante le prime votazioni dove inizia ad emergere il
nome di Mattarella, al silenzio. Un silenzio eloquente perché, se davvero il
Presidente non avesse voluto il suo nome in lizza, siamo certi che avrebbe
trovato il modo per fermare le matite dei senatori. Infine, a distruggere del
tutto il racconto dell'uomo politico che subisce gli eventi, il discorso di
insediamento. Mattarella non sferza come fece Napolitano il Parlamento: anzi,
rivendica la centralità di quello stesso organo che l'ha portato per la seconda
volta alla guida del Paese. Traccia le linee guida e il percorso per l'Italia
dei prossimi anni e, spiazzando anche i più critici, mena fendenti alla
magistratura. Parla della necessità di un «profondo processo riformatore» che
deve interessare la magistratura, di efficienza e credibilità. Soprattutto,
sferza le correnti, dicendo esplicitamente che occorre superare le «logiche di
appartenenza che, per dettato costituzionale, devono rimanere estranee
all'Ordine giudiziario». Si preoccupa del sentimento dei cittadini nei confronti
della magistratura e della sua credibilità. Parole inedite nel settennato
precedente, chiuso senza neppure un accenno alla questione giudiziaria durante
il discorso di fine anno. La sensazione insomma, è che il Mattarella fine
politico, rimasto nascosto tanto da dipingerlo come un mite «nonno delle
istituzioni», utilizzando le parole che usò Draghi per lanciarsi nella corsa
quirinalizia, sempre alle prese coni partiti discoli, sia venuto a galla e che
questo settennato non abbia alcuna intenzione di svolgerlo nel ruolo di notaio,
come è stato essenzialmente quello precedente, dove anche l'avvento di Draghi è
stato determinato dalle mosse della politica, dall'attivismo di Renzi e dalla
decisione di appoggiarlo di Salvini e Berlusconi, processo che Mattarella ha
senz'altro agevolato ma non guidato come la narrativa sembra suggerire.
A giudicare dalla partenza
però, la sensazione è che in questo secondo mandato vedremo più il Mattarella
del niet a Paolo Savona, che resiste nelle sue volontà anche alle richieste di
impeachement e alla campagna social scatenata dal M5S contro di lui, che il
volto benevolo e taciturno a cui siamo stati abituati. Non sarà forse mai un
Giorgio Napolitano, sovrano assoluto che trasforma la Repubblica parlamentare in
una presidenziale senza passare dall'investitura popolare, ma, probabilmente, un
arbitro ben deciso a far rispettare le proprie volontà.
Lorenzo De Cicco per “la
Repubblica” il 5 Febbraio 2022.
Il tono fa subito molto agente
immobiliare: «Sono l'uomo del momento? Sono sempre l'uomo del momento». Risata.
Francesco De Micheli, dirigente romano di Forza Italia e amministratore della
Gregoriana Immobiliare, è l'uomo della trattativa Mattarella-Parioli: ha trovato
casa al presidente della Repubblica, prima che il Parlamento votasse il bis,
bloccando il trasloco dal Quirinale. Il presidente ora ha scelto il Colle, ma,
da quanto trapela, passerà un po' di tempo nell'alloggio preso in affitto.
«La caparra - racconta De
Micheli - è già stata versata e incassata dalla proprietà, ormai il presidente
si è trasferito. C'è un contratto. Quindi non ha senso parlare di restituzione.
Poi lo voglio dire: per me uno vale uno».
Berlusconi sognava il
Quirinale. E invece un berlusconiano ha trovato casa a Mattarella
«È il mio lavoro, a
prescindere da Berlusconi e Mattarella. Diciamo che è stato anche un modo di
servire le istituzioni. Ormai peraltro non mi sento più molto un dirigente di
Forza Italia».
Non è il coordinatore del
partito nel Centro di Roma?
«Sì, ma lo faccio per
aiutarli».
Parliamo del tema che scalda i
social: che fine fa la caparra di Mattarella?
«Ho visto tante ironie, la
vignetta di Osho, molto divertente. Ma ho capito che in Italia non c'è molta
chiarezza su cosa sia una caparra. E cosa comporti».
Quindi dica, come stanno le
cose?
«La caparra viene data al
momento dell'offerta e in caso di accettazione della proposta viene trattenuta
dal proprietario. Ormai il contratto con il presidente è stato firmato, quindi
la caparra è stata incassata. Fine. Il presidente è anche entrato
nell'appartamento. Ora ci sono i depositi cauzionali, le garanzie che si possono
chiedere».
Insomma ormai i proprietari la
caparra se la sono presa.
«Sì».
Si è mai parlato, nella fase
delle trattative, di una disdetta causa rielezione?
«No. In genere se si viene a
sapere che il nuovo affittuario vuole lasciare casa, ma comunque prima
dell'inizio della locazione, il proprietario può decidere di restituire la
caparra. Ma anche in questi casi si dà mandato a un'agenzia immobiliare, serve
tempo, 2-3 mesi di affitto sono comunque persi».
Com' è trattare per una casa
col presidente della Repubblica?
«È stata la trattativa più
facile della mia vita. Oltre che un onore. La figlia è venuta a vedere
l'appartamento. Poi è tornata con il papà. E hanno subito trovato un accordo con
la proprietà. Tutti molto carini, niente lungaggini».
Si vocifera di 2.500 euro di
affitto.
«Posso dire che ho fatto un
contratto tradizionale. Tutto quello che è stato proposto dall'agenzia, gli è
andato benissimo. Ci tengo ad aggiungere una cosa: per me tutti i clienti sono
importanti, che sia il presidente della Repubblica o la vecchietta che vende la
nuda proprietà a Capannelle. È un trascorso che mi porto dalla politica: uno
vale uno».
L’agente immobiliare che ha
affittato casa a Mattarella: “Caparra ormai incassata”.
Giampiero Casoni il 05/02/2022
su Notizie.it.
Parla e parla molto chiaro
l’agente immobiliare che ha affittato casa a Mattarella: “La caparra ormai è
stata incassata dai proprietari dell'immobile"
Su Repubblica parla l’agente
immobiliare che ha affittato casa a Sergio Mattarella quando il
rieletto Presidente della Repubblica non pensava ancora di dover accettare un
bis al Quirinale: “La caparra ormai è stata incassata”. Insomma, Francesco De
Micheli, coordinatore di Forza Italia di Roma centro ed intemediario del
locatore di Sergio Mattarella ai Parioli, spiega che “uno vale uno” e che il
contratto ormai è stato firmato.
Che significa?
Sergio Mattarella e la caparra
ormai incassata ai Parioli, incassata e persa
Che mentre il presidente ha
fatto sapere che passerà un po’ di tempo nell’appartamento ma che la sua
residenza sarà fissata al Colle c’è un dato che vale per utti, capi di Stato
inclusi. Eccolo: “La caparra è già stata versata e incassata dalla proprietà,
ormai il presidente si è trasferito. C’è un contratto. Quindi non ha
senso parlare di restituzione.
Poi lo voglio dire: per me uno
vale uno”.
Contratto firmato e chi si è
visto si è visto, la regola che vale per tutti, anche per il Presidente
E il prezzo? Si era parlato di
2500 euro al mese ma in merito non ci sono conferme ufficiali. Ha spiegato
ancora De Micheli: “La caparra viene data al momento dell’offerta e in caso di
accettazione della proposta viene trattenuta dal proprietario.
Ormai il contratto con il
presidente è stato firmato, quindi la caparra è stata incassata. Fine”. Anzi No:
“Il presidente è anche entrato nell’appartamento. Ora ci sono i depositi
cauzionali, le garanzie che si possono chiedere”. Tradotto: i proprietari la
caparra se la terranno.
Cosa può decidere il
proprietario in caso di mancata locazione
Poi la chiosa: “In genere se
si viene a sapere che il nuovo affittuario vuole lasciare casa, ma comunque
prima dell’inizio della locazione, il proprietario può decidere di restituire la
caparra.
Ma anche in questi casi si dà
mandato a un’agenzia immobiliare, serve tempo, 2-3 mesi di affitto sono comunque
persi”.
Gli audio segreti del
grande elettore nelle mani delle Iene.
REDAZIONE su Il Domani il 14
febbraio 2022
Domani ha rivelato che un
grande elettore, impegnato nell’elezione del presidente della Repubblica,
ha registrato i giorni concitati del voto, munito di un dispositivo introdotto
senza autorizzazioni all’interno dell’aula della Camera dei deputati.
A Domani risulta che le
registrazioni ci sono e sono state consegnate alle Iene, la trasmissione della
berlusconiana Mediaset. Abbiamo chiamato la redazione che ha confermato
l’indiscrezione.
Dalle Iene oltre a confermare
non rivelano altri particolari, ma soprattutto non è chiaro quando e se andrà in
onda il servizio.
Domani ha rivelato che un
grande elettore, impegnato nell’elezione del presidente della Repubblica,
ha registrato i giorni concitati del voto, munito di un dispositivo introdotto
senza autorizzazioni all’interno dell’aula della Camera dei deputati.
A Domani risulta che le
registrazioni ci sono e sono state consegnate alle Iene, la trasmissione della
berlusconiana Mediaset. Abbiamo chiamato la redazione che ha confermato
l’indiscrezione. Il servizio, che al momento non è andato ancora in onda, è
curato dall’inviato Ismaele La Vardera. Quegli audio documentano i
momenti concitati che hanno portato alla riconferma di Sergio Mattarella come
presidente della Repubblica.
Dalle Iene non rivelano altri
particolari, ma soprattutto non è chiaro quando e se andrà in onda il servizio.
Di certo c’è solo una cosa. Un grande elettore è andato in giro per un’intera
settimana con un registratore nascosto sotto la giacca d’ordinanza mentre
bisbiglia ora con questo deputato ora con un senatore incrociando anche
personalità di primo piano della politica.
Mentre i capi dei partiti
cercavano l’intesa sfogliando improbabili rose di nomi, tutti gli altri
onorevoli “semplici” aspettavano le indicazioni dall’alto, ma intanto parlavano
e tanto. Negli audio segreti di quei giorni ci sono di certo le ore concitate
che hanno preceduto la prima votazione quando era ancora in corso l’operazione
scoiattolo, poi tramontata.
Si tratta del tentativo di
Silvio Berlusconi di diventare presidente della Repubblica. Il deputato e
critico d’arte, Vittorio Sgarbi, ha chiamato personalmente decine di grandi
elettori per convincerli della bontà dell’operazione con l’obiettivo di
allargare il fronte a sostegno dell’ex primo ministro, pregiudicato per frode
fiscale.
SCOIATTOLO E FUGHE
Matteo Salvini e Giorgia
Meloni hanno archiviato l’opzione, ma di passaggi, telefonate e cambi di casacca
si sarà discusso tra la buvette e il transatlantico di Montecitorio. Non c’è
solo quella fase, subito dopo arriva l’attivismo di Matteo Salvini che cerca una
soluzione.
L’ex ministro dell’Interno
prometteva di dare al paese il primo presidente della Repubblica di
centrodestra, attività conclusasi con un fallimento totale e la riedizione
invernale del Papeete, quando mezzo nudo in spiaggia diede l’estrema unzione al
governo Conte.
Dai malumori del centrodestra
alle strategie del Partito democratico, dalla guerra tra bande nel M5s al sogno
di una donna al Quirinale. Sono tanti i temi che potrebbe aver trovato spazio
negli incontri del grande elettore munito di registratore.
L’elezione del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella è arrivata all’ottava votazione con tanti
applausi liberatori, nel giorno del messaggio alle camere per l’insediamento.
Quello che non sapevano deputati e senatori è che quel capitolo non si è ancora
chiuso. Ci sono gli audio segreti e il dietro le quinte del secondo storico bis
ora nelle mani delle Iene.
Nello Trocchia
per editorialedomani.it il 14 febbraio 2022.
In parlamento corre una voce
in modo insistente che getta nel panico deputati e senatori. Un grande elettore,
impegnato nell’elezione del presidente della Repubblica, avrebbe registrato i
giorni concitati del voto, munito di un dispositivo introdotto senza
autorizzazioni all’interno dell’aula della Camera dei deputati.
Domani può confermare quelle
voci, le registrazioni ci sono e sarebbero state consegnate a una troupe
televisiva impegnata nella realizzazione di un servizio sui giorni concitati che
hanno portato alla riconferma di Sergio Mattarella come presidente della
Repubblica.
Ma quel servizio non è andato
in onda, perché? Sarà stato bloccato oppure solo rimandato? Si tratta di un
grande elettore in giro per un’intera settimana con registratore nascosto sotto
la giacca d’ordinanza che si ferma a parlare, bisbiglia ora con questo deputato
ora con un senatore incrociando anche personalità di primo piano della
politica.
Mentre i capi dei partiti
cercavano l’intesa sfogliando improbabili rose di nomi, tutti gli altri
onorevoli “semplici” aspettavano le indicazioni dall’alto, ma intanto parlavano
e tanto. Negli audio segreti di quei giorni ci sono di certo le ore concitate
che hanno preceduto la prima votazione quando era ancora in corso l’operazione
scoiattolo, poi tramontata.
È stata ribattezzata dalle
cronache politiche “operazione scoiattolo” il tentativo di Silvio Berlusconi di
diventare presidente della Repubblica. Il deputato e critico d’arte, Vittorio
Sgarbi, ha chiamato personalmente decine di grandi elettori per convincerli
della bontà dell’operazione con l’obiettivo di allargare il fronte a sostegno
dell’ex primo ministro, pregiudicato per frode fiscale.
Operazione svanita per la
contrarietà di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ma della quale si sarà discusso
tra la buvette e il transatlantico di Montecitorio. In quei giorni dal popoloso
gruppo Misto, dove stazionano molti ex del Movimento 5 Stelle, ci sono stati
movimenti verso altri partiti, spostamenti che potrebbe aver generato voci e
tensioni.
I giorni successivi sono stati
caratterizzati, invece, dall’attivismo di Matteo Salvini con il leader leghista
alla ricerca di una soluzione. L’ex ministro prometteva di dare al paese il
primo presidente della Repubblica di centrodestra, attività conclusasi con un
fallimento totale e la riedizione invernale del Papeete, quando mezzo nudo in
spiaggia diede l’estrema unzione al governo Conte.
Sono tante le questioni
politiche che si sono concentrate in quei giorni: i malumori del centrodestra,
le strategie del Partito democratico, la guerra tra bande nel M5s, quella fedele
a Giuseppe Conte e quella cara a Luigi Di Maio e il tema dell’opzione donna.
La presidente del Senato Maria
Elisabetta Casellati, la numero uno dei servizi segreti Elisabetta Belloni, la
ministra della Giustizia Marta Cartabia hanno sfiorato il sogno quirinalizio,
poi svanito. In quegli audio ci sarà il racconto di quelle ore concitate, ma
anche le attese, le illusioni, i litigi e, di certo, le parole in libertà dei
peones, i senatori e deputati semplici.
Alla fine è arrivata
l’elezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’ottava
votazione. Un bis che ha salvato il paese, la pensione dei parlamentari, ma li
ha anche liberati dalla stressante attesa durata otto votazioni e chiusasi di
sabato con parziale compromissione del fine settimana.
Poi è arrivato il discorso di
Mattarella che ha parlato di dignità ed è stato lungamente interrotto e
applaudito, ma il capitolo ‘elezione del presidente della Repubblica’ non è
ancora chiuso. Ci sono gli audio segreti e il dietro le quinte del secondo
storico bis.
Da leggo.it il 3 marzo 2022.
Sergio Mattarella si riduce lo
stipendio. Il presidente della Repubblica, infatti, ha chiesto al Mef di ridurre
il suo assegno personale, stabilito per legge, in misura pari al trattamento
pensionistico che riceve dall'Inps per i suoi anni da professore universitario.
Per cui la prevista somma
annuale di 239.182 euro lordi viene ridotta di circa 60 mila euro, portando
l'importo lordo annuo da percepire a 179.835,84 euro. Lo si legge in un
comunicato del Quirinale.
Contestualmente, continua il
comunicato, il presidente Mattarella ha confermato la rinuncia anche per il
nuovo settennato all'adeguamento dell'assegno personale all'indice dei prezzi al
consumo (adeguamento Istat) che avrebbe comportato un aumento di circa 16 mila
euro. Infine, in base alle norme vigenti, il Presidente della Repubblica non
percepisce (né percepirà in futuro) il pagamento della pensione (vitalizio) come
ex parlamentare.
·
Storia delle presidenziali.
Presidenti della
Repubblica. Da Einaudi a Mattarella bis quanti terremoti sotto il Quirinale.
Stefano
Ceccanti su Il Riformista il 9 Marzo 2022.
Paolo Armaroli non ci delude
neanche stavolta e con la sua consueta prosa brillante, in cui scioglie anche i
tecnicismi del diritto, ci porta tra Montecitorio e il Quirinale. L’inizio è
sulla prima elezione di Mattarella per iniziativa di Matteo Renzi sette anni fa
e lo svolgimento ha come momento più teso, forse anche più drammatico, il veto
alla nomina di Paolo Savona come ministro dell’Economia nel governo Conte 1,
autore di un piano per l’uscita surrettizia dall’Euro. Sembra un racconto di un
secolo fa, visto che attualmente Lega e M5s sostengono un governo guidato
da Mario Draghi e che i parlamentari M5s sono stati obiettivamente tra i
protagonisti della rielezione del Presidente. Eppure Armaroli ricorda molto bene
e con pignoleria a pagina 28.
Mentre Conte e Salvini subiscono la decisione del Presidente egli mette in atto
la “manovra diversiva” dell’incarico a Cottarelli (p. 28) che li costringe a una
precipitosa marcia indietro, tornando indietro anche rispetto alla reazione
emotiva e insensata del M5s di chiedere addirittura la messa in stato di accusa
del Presidente (p. 29). Relativamente più tranquilli, ma fino a un certo punto,
i passaggi gestiti da Mattarella tra Conte 1 e 2 e, infine, a Draghi. Armaroli
passa quindi a raccontarci il bis di Mattarella e la congiunzione astrale con
l’elezione simultanea alla presidenza della Corte costituzionale di Giuliano
Amato che, insieme a Mario Draghi alla guida del Governo, formano un trittico
fondamentale per la tenuta del Paese. La rielezione di Mattarella, per una
spinta dal basso dei parlamentari recepita solo dopo dai vertici, come
puntualmente spiegato, specie a pag. 47 (ma anche a p. 64 con la notazione che
da Mattarella vanno solo i capigruppo parlamentari e non anche i segretari)
consente la continuità dell’azione di Draghi. L’autore ha qualche momento di
sincero stupore per la totale approssimazione con cui il centrodestra gestisce
l’operazione Casellati, il cui esito è appunto definito “catastrofico” (p. 52).
Di suo Armaroli ci aggiunge qualche elemento di stupore per il fatto che
la Casellati, pur potendo, non abbia mai votato (p. 53).
Obiettivo polemico dell’autore
è soprattutto il confuso e scriteriato movimentismo di Salvini (p. 57). Bilancio
positivo, invece, per Draghi, che avrebbe potuto rischiare altrimenti un
ombrello “meno solido per ripararsi dalla pioggia” (p. 63) di partiti così
diversi uniti nella maggioranza. Finita la parte di stretta attualità Armaroli
torna indietro nella storia repubblicana e ci propone un ritratto dei vari
Presidenti che si sono succeduti. Si passa quindi dalla tendenza di De Nicola a
presentare spesso dimissioni, il monarchico alla guida della repubblica per
unire il Paese (p. 80) a Einaudi, facitore del primo Governo del Presidente,
quello di Pella nel momento di difficoltà del centrismo dopo le elezioni del
1953 (p. 88), a Gronchi “uomo del Parlamento per eccellenza” (p. 94) e che
finisce per avere rapporti “altalenanti” coi governi che si succedono finché non
matura pienamente il centro-sinistra (p. 97) e allora esso va accompagnato da un
bilanciamento moderato al Quirinale individuato in Segni (p. 101). Si passa
quindi a Saragat che salva la formula di centrosinistra (p. 116), a Leone, il
cui mandato invece inizia con una flessione verso il centrodestra
dell’equilibrio politico (p. 131) ma che rapidamente vede il quadro politico
maturare verso la solidarietà nazionale col Pci.
Ritratti azzeccati nella
sintesi anche quelli di Pertini , il primo ad accompagnare la nascita di
esecutivi non a guida dc, di Cossiga che accresce il proprio interventismo solo
dopo la fine obiettiva del primo sistema dei partiti del 1989 che però tenta
invano di sopravvivere nell’immobilismo, nonostante l’invito al cambiamento nel
messaggio presidenziale del 1991, rivalutato giustamente solo ma solo di recente
(p. 165). Infine Scalfaro, eletto per riaffermare con forza il primato del
Parlamento ma che poi si trova a espandere ben oltre Cossiga la fisarmonica dei
poteri presidenziali (p. 172), Ciampi, con un’elezione da unità nazionale per
molti versi inaspettata e Napolitano, il primo ad avere un bis a causa
dell’impotenza del sistema dei partiti. Non sarebbe stato l’ultimo. Il problema,
ma qui andiamo oltre Armaroli, è se il Governo Draghi, anche con l’ombrello
di Mattarella, si rivelerà solo una cronicizzazione dell’emergenza, con
inamovibilità dei tecnici e della stampella presidenziale o avremo poi una nuova
fisiologia dell’alternanza in cui le forze politiche, una volta messi in
sicurezza i fondamentali, potrebbero finalmente alternarsi con riforme coerenti
con l’Eurozona e senza dinamiche stagnanti o distruttive.
Paolo Armaroli, “Mattarella 1
e 2. L’ombrello di Draghi. Ritratto a matita di 12 Presidenti”, La Vela, Lucca
2022 Stefano Ceccanti
Quando il Quirinale era la
corte dei Papi.
Andrea Muratore il 25 Gennaio 2022 su Il Giornale.
Il Quirinale è simbolo del
potere da prima della Repubblica italiana. Da quando, cioè, i Papi lo usarono
per ricordare al mondo di essere sovrani, non solo pontefici.
Il Quirinale è luogo fisico
associato alla continuità del potere di Roma. Non mera metonimia, contenente per
il contenuto indicato a simboleggiare il suo inquilino, il presidente della
Repubblica italiana, ma centro nevralgico dell'autorità che nei secoli si è
irradiata dall'Urbe. Sede nell'ultimo settantennio dei capi dello Stato
dell'attuale Repubblica, per settantacinque anni (dal 1871 al 1946) residenza
dei Re d'Italia, nei secoli precedenti il Quirinale ha ospitato le autorità che
più a lungo, dopo la caduta dell'Impero, hanno avuto il controllo della Città
Eterna, i Papi.
Il Vaticano è, naturalmente,
associato al governo della Chiesa cattolica, all'istituzione pontificia,
all'autorità dei Vescovi di Roma e Primati d'Italia. Ma per diversi secoli,
dall'era carolingia alla breccia di Porta Pia (1870), i Papi sono stati anche, e
in certe fasi soprattutto, sovrani. E a partire dal ritorno dei Papi da Avignone
dopo il Grande scisma d'Occidente e la "cattività" in terra francese tennero a
ribadire questa loro caratteristica nell'Urbe e nei suoi domini.
Per legittimarsi di fronte
all'influenza delle famiglie romane, per inserirsi nel quadro della tendenza
europea a consolidare corti e seguiti importanti per i sovrani, per mostrare un
volto chiaro della loro importanza i Papi iniziarono a incentivare la
straordinaria fase di creatività architettonica e artistica che fu carburante
fondamentale per il Rinascimento. E soprattutto i grandi pontificati del
Cinquecento furono i più attivi a incentivare la corsa allo sviluppo
architettonico che culminò proprio nell'edificazione del Palazzo del Quirinale,
inaugurato nel 1573 per fungere tanto da epicentro della corte politica del Papa
quanto per grande struttura amministrativa.
Il compianto storico Antonio
Menniti Ippolito (1960-2016) ha lasciato prima della sua precoce scomparsa in
eredità un'importante opera sulle motivazioni che diedero, di fatto, al
Quirinale la sua valenza politica attuale. Il libro I papi al Quirinale: Il
sovrano pontefice e la ricerca di una residenza racconta di come i Sommi
Pontefici, focalizzati sulla necessità di dare strutturazione a un apparato
amministrativo sempre più ampio e ipertrofico, ebbero nel corso degli anni
sempre maggior agio nell'identificare col Palazzo del Quirinale e i suoi 110mila
metri quadrati di estensione (sesto palazzo più grande al mondo ancora oggi) il
cuore pulsante dello Stato Pontificio.
Con la distinzione tra
Quirinale e Sacri Palazzi il Papa poté affermare la sua natura complementare ma
distinta delle due figure che ricopriva, quella del pontefice della Chiesa
universale e quella del sovrano di uno Stato posto al centro dell'Italia. "Il
Papa è al vertice di due strutture completamente distinte", ha scritto Menniti
Ippolito. "La prima e più antica è quella che vede impegnati nella gestione di
Roma, dello Stato e della Chiesa universale il Papa e il Concistoro",
l'assemblea dei cardinali. La seconda, affermatasi dal Cinquecento in forma
concorrenziale e in via sempre più sostitutiva della prima, è quella fondata su
una "più strutturata rete in cui il Papa, che conserva piena e assoluta autorità
sulla gestione degli affari", delega competenze e responsabilità "alla rete
delle congregazioni e a altri uffici e magistrature" come il Sant'Uffizio,
aventi nel Quirinale il loro centro politico, amministrativo, geografico.
Il Quirinale si sviluppò quale
palazzo secolare, quasi senza simboli religiosi visibili e soprattutto (unico
tra i palazzi apostolici con questa particolarità) senza una Chiesa aperta al
pubblico. E se il Palazzo Apostolico rimase la residenza ufficiale del papa a
lungo, a partire dal pontificato di Paolo V Borghese il Quirinale emerse come
residenza stabile dei papi. Esso ha ospitato complessivamente una trentina di
papi, da papa Gregorio XIII a papa Pio IX, ultimo pontefice-Re, distinguendosi
in tal senso da tenute come Castel Gandolfo rimaste semplici residenze di
villeggiatura.
All'inizio del Seicento col
pugnace Paolo V, tra i maggiori propugnatori della Controriforma e del rilancio
politico del papato "il Quirinale cessò di essere un luogo di rifugio dalla
calura estiva" e "diveniva un funzionale luogo di lavoro per il pontefice".
Luogo che condensò l'esercizio del potere sistemico della corte papale nel
palazzo nel cuore della nuova Roma, a tre chilometri di distanza dalle Mura
Leonine e dal Vaticano. Nel Quirinale ci fu l'epicentro di un potere
amministrativo che mirava a pulire la tendenza al nepotismo, alla simonia, alla
corruzione che infestava le corti papali. Per una strana eterogenesi dei fini,
la Roma opulenta dei Papi rinascimentali generò la macchina che ne emendò le
conseguenze più problematiche per l'immagine della Chiesa. Elevando il Quirinale
a luogo prediletto del potere romano. Tanto importante per i pontefici che
rimase l'ultimo presidio del potere papalino nella Roma non "sacra" dopo
l'ingresso delle truppe italiane. Il palazzo, anche dopo la breccia di Porta
Pia, restò occupato dalle guardie svizzere al servizio di Pio IX fino al 1º
ottobre 1870, finché il generale Raffaele Cadorna, comandante del corpo di
spedizione italiano, le fece allontanare con la forza.
I Re d'Italia prima e i
presidenti della Repubblica poi, risiedendo al Quirinale, ne valorizzarono il
peso sistemico agli occhi dell'Italia e del mondo. Confermando la felice
intuizione dei Papi dei secoli precedenti di individuare un luogo simbolo del
potere nella Città Eterna, nella metropoli che col potere più era stata
impastata e identificata nella storia. Ieri come oggi, il Quirinale è stato
centro dello Stato e cuore degli Stati profondi. Garanzia della continuità
istituzionale. E del ruolo di Roma come capitale, come città inevitabilmente
posta al centro, crocevia dei destini d'Italia.
Andrea Muratore.Bresciano
classe 1994, si è formato studiando alla Facoltà di Scienze Politiche,
Economiche e Sociali della Statale di Milano. Dopo la laurea triennale in
Economia e Management nel 2017 ha conseguito la laurea magistrale in Economics
and Political Science nel 2019. Attualmente è analista geopolitico ed economico
per "Inside Over" e svolge attività di ricerca presso il CISINT - Centro Italia
di Strategia ed Intelligence e il centro studi Osservatorio Globalizzazione.
«Il Colle più alto»: in
mostra le fotografie dei dodici Presidenti.
Federica Manzitti su Il
Corriere della Sera il 23 Gennaio 2022.
Da De Nicola a Mattarella:
nello Spazio 5 di via Crescenzio le immagini dei capi dello Stato che si sono
avvicendati dal 1946 a oggi, provenienti dall’archivio Riccardi.
Sandro Pertini e l’iconica
pipa, l’incontro tra Michail Gorbaciov e Francesco Cossiga, quello tra Oscar
Luigi Scalfaro e Yasser Arafat, Luigi Einaudi e il suo bastone, ma anche Antonio
Segni al balcone insieme a Paolo VI oppure Saragat che premia una luminosa
Sophia Loren. In una settimana cruciale per la storia della Repubblica, quella
dell’elezione del nuovo Presidente, l’archivio Riccardi propone una ricognizione
fotografica sui dodici capi dello Stato che si sono avvicendati dal 1946 ad
oggi.
Il Colle più alto è una
selezione di cinquanta scatti, tutti realizzati da Carlo e Maurizio Riccardi,
allestita allo Spazio 5 di via Crescenzio 99/d e aperta al pubblico fino al 31
gennaio, salvo prolungamenti delle votazioni. Carlo Riccardi, classe 1926, è
stato tra i primi paparazzi della «Dolce Vita». Amico di Ennio Flaiano, Federico
Fellini e Totò, ha raccontato settant’anni di vita italiana con scatti esposti
in mostre permanenti a Pechino o San Pietroburgo. Il figlio Maurizio, nato nel
1960, è direttore dell’Agenzia di documentazione fotografica Agr e ha pubblicato
diversi libri, il più recente dei quali è L’Europa unita e i suoi
protagonisti (2020). Nella storia professionale di questi esponenti del foto
giornalismo italiano, gli inquilini del Quirinale sono stati protagonisti di
molte occasioni alcune delle quali, immortalate prima e dopo il digitale,
restituiscono dettagli, umanità, ufficialità e contesti con cui leggere passato
e presente del nostro paese.
Cominciando da Enrico De
Nicola, eletto capo provvisorio dello Stato nel giugno 1946 e promulgatore della
Costituzione, arrivando a Sergio Mattarella il cui settennato è cominciato nel
2015 dopo il doppio mandato di Giorgio Napolitano, la mostra racconta il lungo
percorso della democrazia. Ai ritratti presidenziali si aggiunge uno scatto
realizzato dall’astrofisico Gianluca Masi che raffigura un plenilunio sul
tricolore e sul Palazzo del Quirinale, foto che sarà donata a Mattarella a
esposizione conclusa.
Sul Colle più alto
d'Italia. Segreti, veti e aneddoti.
Federico Bini il 14 Gennaio
2022 su Il Giornale.
Il libro di Valdo Spini fa
rivivere storie, regole e segreti dell'elezione di tutti i capi di Stato del
nostro paese.
L’elezione del presidente
della Repubblica italiana, negli anni ha assunto un significato sempre più
importante per la stabilità e la tenuta delle istituzioni a seguito della crisi
del sistema politico-parlamentare. La storia repubblicana, o più precisamente
“quirinalizia”, ci ricorda fin dal suo esordio, la presenza di capi di Stato
controversi, carismatici, interventisti, decisi ad andare oltre la semplice
“moral suasion”. Per comprendere questa delicata e sottile partita a scacchi,
giocata più nelle retrovie del palazzo, ecco che Valdo Spini, docente, fine
intellettuale, ex vicesegretario e ministro socialista, racconta vita, storie e
segreti dell’elezione più attesa e seguita del paese. Sul Colle più alto è
infatti il suo nuovo libro (Solferino) che esce in concomitanza con l’elezione
del successore del presidente Mattarella. Una delle novità più interessanti che
si colgono nel libro è l’aver inserito in apertura un capitolo su De Gasperi.
Valdo Spini, citando il Prof. Giuseppe Tognon inserisce lo storico presidente
del Consiglio come primo presidente della Repubblica. All’indomani dell’esito
referendario vi fu uno scontro durissimo tra il governo e la casa reale (si
racconta che il marchese Falcone Lucifero avesse addirittura tirato gli occhiali
al leader democristiano).
De Gasperi il 12 giugno 1946
convocò un urgente Consiglio dei Ministri, proclamò la Repubblica e “allora come
prescriveva il decreto luogotenenziale”, in quanto presidente del Consiglio
assunse anche la carica di capo provvisorio dello Stato che rimise il 28 giugno
nelle mani di De Nicola. Nel 1948, dopo le elezioni, vissute come uno scontro
civile, il governo De Gasperi, su indicazione del presidente del Consiglio,
decise per la prima volta di nominare un capo di Stato votato non più a larga
maggioranza – come accaduto per De Nicola – ma con voto politico delle forze
governative, con l’esclusione delle sinistre. L’elezione premiò Einaudi, ma De
Gasperi inizialmente aveva puntato sul conte Sforza, fermato dalla comparsa per
la prima volta dei famosi “franchi tiratori”, si suppone la sinistra DC
dossettiana. Einaudi fu il primo a fare uso dell’articolo 59 della Costituzione
nominando cinque senatori a vita tra cui Toscanini e Trilussa. Antonio Segni, fu
voluto da Moro per bilanciare l’ “apertura a sinistra” della DC e fu eletto al
nono scrutinio con i voti anche del MSI. La nomina di un terzo presidente della
Repubblica di area democristiana si scontrò con i veti su Leone e Fanfani.
Pare che quest’ultimo fosse
stato fermato da Papa Montini tanto che un folto gruppo di DC contestò
l’accaduto scrivendo sulla scheda “Montini”, cognome riconducibile anche al
fratello del Santo Padre, essendo parlamentare (DC). Al ventunesimo scrutinio,
il 29 dicembre 1964 con 646 voti su 963 veniva eletto il socialdemocratico
Saragat. Atlantista, rispettoso della volontà parlamentare, nominò senatore a
vita il suo storico rivale Nenni. In uno dei suoi personali incontri, Valdo
Spini racconta che l’ex presidente gli parlò di Carlo Rosselli, con il quale
aveva trascorso l’esilio a Parigi, e gli aveva donato una copia del celebre
Socialismo liberale con una dedica del tutto particolare: “Il più marxista dei
liberali al più liberale dei marxisti”. Se ventuno scrutini sembrano tanti,
ancora più dura fu la successiva elezione, quella di Leone che raggiunse le
ventitré votazioni. Leone riesce a vincere il dualismo della DC in cui si erano
manifestate due candidature forti, quella vera di Fanfani e quella più nascosta
di Moro che avrebbe ottenuto sicuramente un largo consenso nelle sinistre.
Decisivo fu il voto del MSI
tanto che scrive Spini, Ugo La Malfa aveva consigliato a Berlinguer di non
mettere in difficoltà la DC che rischiava una profonda crisi interna. Risposta
del segretario comunista: “Ma se la DC va in crisi, io mi devo mettere la
cravatta nera?”. Il candidato ideale per succedere a Leone doveva essere Ugo La
Malfa, storico leader dei repubblicani. I partiti, tra cui la DC, fortemente
scossa dall’uccisione di Moro, giocano ognuno una propria partita e ad
approfittare di tutto ciò è lo scalpitante nuovo leader socialista Bettino
Craxi, deciso a portare un socialista al Quirinale. Strada impervia che tuttavia
portò a termine. Ovviamente non fece il nome di Pertini ma presentò una terna di
nomi tra cui Vassalli e Giolitti. Ma alla fine lo storico combattente socialista
acquistava quota e l’8 luglio 1978 al sedicesimo scrutinio con 832 voti su 995
divenne presidente. Il MSI di Almirante votò scheda bianca, ma dopo il messaggio
presidenziale il leader missino disse: “Ci ha costretti ad applaudirlo”.
L’elezione di Pertini è la prima vera vittoria politica di Craxi. Sotto la
presidenza Pertini nacque il primo governo a guida non DC con il repubblicano
Spadolini e socialista con Craxi. Al termine del settennato, Pertini aveva
ottantanove anni, e De Mita, segretario della DC, voleva rompere l’asse
socialista tra Quirinale e Palazzo Chigi, tanto che come racconta Spini alla
fine Craxi sostenne Cossiga e l’anziano presidente incontrando De Mita alla
buvette disse: “De Mita, hai vinto. Offrimi almeno un cappuccino!”. C’è spazio
ancora per tanti ricordi, come la “bella collaborazione” con Scalfaro e
l’amicizia con Carlo Azeglio Ciampi di cui fu anche ministro. Spini rivela un
piccolo segreto che caratterizzava Ciampi e il suo impegnativo lavoro. Ovvero
una pennichella breve dopo pranzo per ricaricarsi. Dall’ampia convergenza su
Ciampi, i partiti si spaccheranno (la prima volta) sul nome di Napolitano, unico
presidente a essere rieletto due volte, nonché primo post-comunista a salire al
Quirinale. Quindi il ritorno di un “democristiano”, Sergio Mattarella, di cui
Spini apprezza la saggezza con cui ha sciolto le tante crisi che si sono
succedute sotto la sua presidenza. Il libro di Spini è dunque uno spaccato di
storia e ricordi personali di chi ha vissuto da dentro il palazzo, con serietà e
passione, una parte importante della vita politica e istituzionale italiana che
culmina appunto Sul Colle più alto d’Italia.
Federico Bini. (Bagni di Lucca
1992) maturità classica e laurea in legge. Lavoro nell’azienda di famiglia, Bini
srl materie prime dal 1960, come membro del commerciale e delle pubbliche
relazioni. Liberale e un po’ conservatore. Lettera 22 sulla scrivania,
Straborghese, cultore dell’Italia di provincia. Svolgo da quando
Quirinale, da Sofia Loren a
Rocco Siffredi e Francesco Totti: storia semiseria dei voti-burla.
Concetto Vecchio su
La Repubblica il 23 Gennaio 2022.
Ad ogni occasione spuntano
nell'urna i nomi provocatori scelti da Grandi elettori che si fanno beffa del
rito quirinalizio. Ma nella Prima Repubblica non succedeva.
L’ultima volta, con Giancarlo
Magalli, fu una delusione. Su Twitter pareva che dovesse diventare lui il
prossimo presidente della Repubblica. Fece pure un flash mob al Colle. Poi, nel
segreto dell’urna, venne fuori l’amara realtà: due voti. Gli stessi di Ezio
Greggio. Meno di quelli che presero Claudio Sabelli Fioretti (otto) e Francesco
Guccini (quattro). Una preferenza la ottennero Il Capitano, Francesco Totti, che
però non aveva l’età, e Sofia Loren.
Quirinale e i trucchi al
voto segreto per eleggere il presidente della Repubblica.
DAVIDE MARIA DE LUCA su Il
Domani il 17 Gennaio 2022.
Nel Parlamento italiano c’è
una lunga tradizione di tecniche per aggirare la norma costituzionale che impone
di mantenere segrete le preferenze dei grandi elettori, ma ci sono anche
escamotage si possono mettere in pratica per evitare che accada
La Costituzione italiana
stabilisce all'articolo 83 che l’elezione del presidente della
Repubblica avviene con voto segreto, così da garantire a ciascun elettore la
possibilità di esprimersi in libertà, senza dover temere le conseguenze di
votare in maniera differente rispetto alle indicazioni del suo partito.
A una settimana esatta
dall’inizio delle votazioni per sceglie il successore di Sergio Mattarella, si
parla sempre più spesso delle tecniche per “aggirare” questa regola, quello che
in gergo si chiama “segnare le schede”.
I partiti, infatti, hanno
tutto l’interesse a sapere come votano i propri elettori. Questo giro, è Silvio
Berlusconi il più preoccupato di tutti e quello che, raccontano i giornali, è
più impegnato a escogitare metodi per tenere i suoi alleati sotto controllo. Ma
allo stesso tempo si parla anche delle contromisure che la presidenza della
Camera potrebbe escogitare per bloccare questi tentativi.
COME SEGNARE LE SCHEDE
La consuetudine prevede che
l'elezione del presidente della Repubblica avvenga con voto “a chiamata”. Il
presidente della Camera fa l’appello, i deputati, senatori o delegati regionali
chiamati si recano in un “catafalco”, una struttura chiusa da tendine
posizionata sotto lo scranno del presidente della Camera (la storica struttura
questa volta sarà sostituita da una nuova cabina con dispositivi di areazione
anti Covid).
Qui, al riparo da sguardi
indiscreti, scrivono su un foglio il nome del loro candidato e all’uscita lo
depositano in un’apposita urna, chiamata in gergo “insalatiera”. Al momento
dello scrutinio, il presidente della Camera pesca uno a uno i biglietti e legge
ad alta voce i vari nomi indicati.
Il metodo più semplice per
“segnare le schede” sfrutta proprio quest’ultimo passaggio, la lettura dei nomi
indicati nel biglietto. Dando indicazioni sulla formula con cui scrivere il
nome, i capi partito possono aggirare il sistema del voto segreto.
Immaginiamo una coalizione che
si accorda per votare il candidato Mario Rossi. I due partiti che la compongono,
però, non si fidano l’uno dell’altro e temono che nel segreto dell’urna qualcuno
possa cercare di sabotare il candidato.
Per sapere se qualcuno
tradisce, quindi, si posso dare indicazioni come ad esempio: il partito A
scriverà “Mario Rossi” il partito B “Rossi Mario”. Quando le votazioni saranno
lette ad alta voce diventa quindi possibile, contando le formulazioni diverse
del nome, verificare se quanti elettori di un partito hanno votato il candidato
in questione e chi invece tradito.
Durante le prime votazioni,
quelle in genere considerate interlocutorie, in cui partiti e schieramenti sono
più che altro impegnati a contare le forze su cui possono contare si può
applicare un’altra tecnica: dare ai propri elettori l’indicazione di votare un
candidato simbolico. Ad esempio, un gruppo di elettori potrebbe decidere di
votare Mario Rossi anche se non c’è alcun Mario Rossi con possibilità di essere
eletto. Così facendo però può dimostrare di disporre di un certo numero di voti
e su questa base trattare con gli altri schieramenti.
Questo giro, sembra che il più
interessato a questi trucchi sia Silvio Berlusconi. Il leader di Forza
Italia sta seriamente pensando di candidarsi ufficialmente e gli altri due
leader del centrodestra, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, spergiurano che il suo
è l’unico nome che il centrodestra intende presentare.
Ma persino i più stretti
collaboratori di Berlusconi, come il critico d’arte Vittorio Sgarbi, uno degli
“esploratori” incaricati di assicurarsi i voti necessari all’elezione, temono
defezioni tra gli alleati e nella stessa Forza Italia.
Ascolta “Il grande gioco del
Quiriale”, il podcast di Giulia Merlo sull’elezione del presidente della
Repubblica
L’idea di Berlusconi e del suo
staff sarebbe quindi quella di assegnare un modo differente di indicare il suo
nome a ciascuno dei partiti della coalizione. Ad esempio: Silvio Berlusconi alla
Lega, Berlusconi Silvio a Fratelli d’Italia, presidente Berlusconi a Forza
Italia e così via.
In questo modo, al momento
dello spoglio, sarebbe possibile individuare quale partito sta facendo mancare i
voti e tentare quindi delle contromisure. Naturalmente questa tecnica non
assicura la disciplina degli elettori, ma è la cosa che ci si avvicina di più.
LE CONTROMISURE
Così come si parla delle
tecniche per aggirare il voto segreto, nei corridoi del parlamento si parla
anche degli escamotage che il presidente della Camera Roberto Fico e i suoi
funzionari potrebbero adottare per bloccarli.
Secondo quanto scritto oggi da
Repubblica, lo staff del presidente della Camera avrebbe presentato tre
precedenti che contengono ognuno una soluzione diversa. Il primo è non fare
niente. Limitarsi a leggere per intero quanto scritto sulla scheda durante lo
scrutinio e lasciare quindi libertà ai partiti di utilizzare tutti i trucchi che
desiderano. Si tratta della soluzione adottata dalla presidente Laura Boldrini
nel 2015, quando è stato eletto Sergio Mattarella.
Altrimenti, per bloccare ogni
giochino, è possibile limitarsi a leggere il solo cognome del candidato, come
aveva fatto l’allora presidente della Camera Luciano Violante quando nel 1999
venne eletto Carlo Azeglio Ciampi.
Infine, c’è una soluzione
“mediana”, utilizzata ad esempio in occasione dell’elezione del presidente della
Camera nel 2018 (un’altra carica che viene scelta con voto segreto). All’epoca,
il vicepresidente Roberto Giachetti che presiedeva la seduta aveva deciso di
leggere soltanto il nome e cognome presente sulla scheda, senza includere altri
appellativi. Questa tecnica elimina alcuni trucchi (ad esempio indicare
“presidente Berlusconi”), ma ne consente altri: come l’inversione di nome e
cognome, la scrittura del solo cognome o l’inclusione anche del nome. Fico
dovrebbe comunicare la sua decisione il 24 gennaio, prima dell’inizio delle
votazioni.
Fabio Martini per “La Stampa”
il 17 gennaio 2022.
È l'unica, vera ansia che in
queste ore assilla tutti i leader, ma proprio tutti. Matteo Salvini ha dovuto
chiedere bruscamente al Cavaliere: «Silvio scusami: io garantisco sui voti della
Lega ma tu li controlli tutti i tuoi?».
Dall'altra parte della
barricata, la stessa angustia dei franchi tiratori preoccupa Enrico Letta, che
per le prime votazioni previste per il capo dello Stato ha ipotizzato:
«Decideremo più avanti, ma sinché i giochi non sono chiari, potremmo restare
fuori dall'aula». Il che, detto con altre parole, è l'unico modo per controllare
i propri "grandi elettori" e impedirgli di fare di testa propria.
Come la giri, sempre lì si
torna: il terrore del nemico in casa, che ti colpisce dalla tua stessa trincea.
Già, perché persino in anni di memoria corta, i leader si ricordano che in 76
anni di elezioni presidenziali, quasi tutti i Capi dello Stato sono stati
"fatti" non dai leader di partito, ma dai franchi tiratori. Mica per modo dire:
dal 1948 i candidati-Presidente voluti dai più importanti leader sono stati
bocciati in prima battuta dai grandi elettori grazie all'arma concessa dalla
Costituzione: «L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto».
Ed ecco il paradosso della
storia: il franco tiratore è sempre stato associato (spesso a ragione) col
tradimento, ma i tanti voti segreti per il Quirinale hanno finito per temperare
lo strapotere dei partiti e della partitocrazia, portando al Quirinale outsider
che hanno poi costruito sul Colle il proprio carisma.
La legge del voto segreto ha
costretto al ripensamento, se non alla resa, fior di leader, da Alcide De
Gasperi fino a Giulio Andreotti. La prima volta risale al 1948. De Gasperi aveva
appena vinto contro il Fronte popolare la sfida più importante nella storia
repubblicana e dunque spettava a lui scegliere il primo candidato alla
presidenza della Repubblica. De Gasperi indica il suo ministro degli Esteri
Carlo Sforza, un laico poco amato dai peones Dc.
Non piace ai "professorini"
della sinistra, perché Sforza è un tombeur de femmes e d'altra parte per la sua
altezzosità non piace neppure ai deputati della destra di cultura provinciale.
Morale della storia: alla prime votazioni Sforza ottiene meno voti (353)
rispetto ad Enrico De Nicola, candidato dello sconfittissimo Fronte popolare.
Uno smacco per De Gasperi che però tiene su Sforza.
Ma niente da fare: non sfonda
neppure al secondo giro. De Gasperi capisce l'antifona: fa ritirare Sforza e il
candidato del centrismo vincente diventa Luigi Einaudi. L'esito della "prima" è
chiaro: persino il gigante De Gasperi è stato costretto ad arrendersi ai franchi
tiratori. Sette anni dopo il leader emergente della Dc, Amintore Fanfani,
scommette su un altro laico: Cesare Merzagora, presidente del Senato, benvisto
dal mondo imprenditoriale, ma assai meno dentro la Dc.
Il primo scrutino ha esiti
disastrosi: Merzagora ottiene 228 voti, nientedimeno che 80 in meno del
candidato delle sinistre, Ferruccio Parri. La fronda Dc è stata imponente. Si
insiste su Merzagora ma con effetti disastrosi: il candidato "ufficioso" di
mezza Dc, Giovanni Gronchi ottiene più voti (281) rispetto ai 245 di quello
"ufficiale". Morale della storia: Merzagora è costretto a ritirarsi e viene
eletto Gronchi, il candidato dei "cecchini" Dc. Imparata la lezione? Per nulla.
Nel 1964 la maggioranza della Dc è schierata al fianco di Giovanni Leone, che
però è osteggiato da Fanfani, che guiderà i franchi tiratori ad una guerra di
logoramento memorabile.
Una battaglia raccontata dal
numero di voti ottenuti da Leone nelle varie votazioni, un'altalena che
diventerà memorabile e (da quel momento) irripetibile. Una striscia che merita
di essere ripercorsa. Leone ottiene 319 voti al primo scrutinio e poi 304, 298,
290, 294, 278, 313, 312, 305, 299, 382, 401, 393, 406 e 386. Sfinito dai franchi
tiratori, Leone si ritira e viene eletto Giuseppe Saragat.
Per il professor Paolo
Armaroli, costituzionalista e storico del Quirinale, «il voto segreto ha
consentito di consumare la "vendetta" delle istituzioni sui leader e sui
partiti, che in Costituzioni sono citati una volta sola». Imparata la lezione?
Non dal Pd. Nel 2013 il segretario Pierluigi Bersani, d'accordo con Berlusconi,
mette in campo Franco Marini: più di 100 franchi tiratori dem non lo votano e il
Pd lo fa ritirare precipitosamente, nonostante l'ex presidente del Senato abbia
ottenuto 521 voti, che alla quarta votazione, se ripetuti, sarebbero stati
sufficienti per essere eletto.
Marini commenta amaro: «Una
cosa volgare e ingiusta». Ma il Pd in poche ore fa il bis: calcola di nuovo male
le forze in campo e lancia Romano Prodi, che ottiene addirittura 126 voti in
meno di Marini. Da quel momento, col Napolitano-bis e con Mattarella, ai franchi
tiratori non sarà più consentito di toccar palla. Ma dal 24 gennaio si riaprono
le danze e loro sono pronti.
Quirinale. L’elezione a
Colle sempre sfumata per le donne.
Il Corriere del Giorno il 17
Gennaio 2022.
“Il paese ormai è maturo” per
un presidente donna, si sente ripetere a ogni cambio di presidenza. Nei giorni
scorsi un gruppo di intellettuali, tutte donne, hanno lanciato un appello per
l’elezione di una donna alla guida dell’istituzione più alta: “Vogliamo dirlo
con chiarezza: è arrivato il tempo di eleggere una donna” al Colle hanno scritto
. Soltanto quando si riunirà il Parlamento in seduta comune si capirà se
l’appello verrà raccolto.
di Redazione Politica
Le prime donne a essere votate
seppure senza esito durante uno scrutinio per l’elezione del Presidente della
Repubblica sono state Camilla Cederna, Eleonora Moro e Ines Boffardi, in una
corsa che si è svolta finora sempre tutta tra uomini, nonostante il solito
ritornello che ormai da anni precede ogni cambio di presidenza: “il Paese ormai
è maturo” si sente ripetere, anche in questa elezione un gruppo di intellettuali
ha lanciato un appello per l’elezione di una donna. Ma il Parlamento sembra
sordo.
Era l’anno 1978, Giovanni
Leone si era appena dimesso dopo l’infuriare della campagna di stampa del
settimanale l’Espresso con articoli di Camilla Cederna sullo scandalo Lockheed,
dopo che l’Italia aveva vissuto un mese e mezzo prima il dramma del rapimento
iniziale durato 55 giorni e successivo assassinio di Aldo Moro ad opera delle
Brigate Rosse.
L’elezione avrebbe portato
Sandro Pertini al Quirinale, dopo sedici scrutini, e alla prima votazione
nell’urna comparvero 4 voti per la giornalista dell’Espresso, tre per Eleonora
Moro, moglie dello statista Dc, due per Ines Boffardi, partigiana
democristiana, prima donna nominata sottosegretario alla Presidenza della
Repubblica. Il voto alla politica democristiana scatenò qualche risata
nell’emiciclo e toccò proprio a Sandro Pertini, che in quel momento era ancora
Presidente della Camera, redarguire e zittire i propri colleghi: “non c’è nulla
da ridere, anche una donna può essere eletta”.
Alle successive elezioni, che
con un solo scrutinio portarono Francesco Cossiga al Quirinale, oltre
a Camilla Cederna, raccolse tre voti anche Tina Anselmi, partigiana ed esponente
politica della Democrazia Cristiana, prima donna a diventare ministro della
Repubblica. Nel 1992 Tina Anselmi venne nuovamente votata, ottenendo fino a 19
voti.
Ma soprattutto per molti
scrutini (ce ne vollero sedici per eleggere Oscar Luigi Scalfaro), il Pds indicò
come sua candidata, per la prima volta, una donna, Nilde Iotti che giunse a
raccogliere il massimo di 256 voti, ovviamente insufficienti per superare il
quorum. Dall’undicesima votazione le verranno preferiti come candidati di
bandiera Francesco De Martino e Giovanni Conso e infine il Pds decide di
convergere su Scalfaro.
Alle elezioni del 1999 che
incoronarono con un solo scrutinio Carlo Azeglio Ciampi , furono depositate
nell’urna 16 schede per Rosa Russo Iervolino e 15 per Emma Bonino. Quest’ultima
era stata protagonista di una campagna di opinione ‘Emma for president‘, che
aveva raccolto molti consensi nei sondaggi ma che non si concretizzò in uno
speculare consenso in Parlamento. Nel 2006 circolarono i nomi di Emma
Bonino ed Anna Finocchiaro come candidate; Antonio Di Pietro, all’epoca leader
di Italia dei Valori candida Franca Rame, che ottenne 24 voti. Due voti andarono
a Lidia Menapace. Il Parlamento votò ed elesse Giorgio Napolitano.
Nel 2013, all’indomani di
elezioni politiche che non avevano espresso alcuna maggioranza autosufficiente,
il Parlamento in seduta comune si riunì e in rapida successione impallinò
prima Franco Martini e poi Romano Prodi. Al di fuori dalle aule parlamentari
il M5s aveva organizzato le “quirinarie” per scegliere il suo candidato: la più
votata era stata Milena Gabanelli, la quale molto intelligentemente e sopratutto
eticamente però si rese indisponibile.
Il M5s a quel punto virò su
Stefano Rodotà, anche perchè Gino Strada, secondo più votato dagli iscritti
grillini, si era ritirato. Al primo scrutinio Emma Bonino ottenne 13 voti e Anna
Finocchiaro 7. Nei successivi scrutini raccolsero una manciata di voti
anche Rosy Bindi, Paola Severino, Alessandra Mussolini, Daniela Santanchè. Al
quarto scrutinio Scelta civica candida Annamaria Cancellieri, ministro
dell’Interno, che ottenne 78 voti. Al sesto scrutinio, dopo aver rischiato una
crisi istituzionale oltre che politica, i partiti rieleggono Giorgio
Napolitano.
Nel 2015 le acque si erano
calmate, la legislatura procedeva con il governo Renzi. Al primo
scrutinio Emma Bonino ottenne 25 voti, Luciana Castellina, candidata da BI, ne
ottenne 37.
Nei giorni scorsi un gruppo di
intellettuali, tutte donne, Dacia Maraini, Edith Bruck, Liliana Cavani, Michela
Murgia, Luciana Littizzetto, Silvia Avallone, Melania Mazzucco, Lia Levi, Andrèe
Ruth Shammah, Mirella Serri, Stefania Auci, Sabina Guzzanti, Mariolina Coppola,
Serena Dandini, Fiorella Mannoia hanno lanciato un appello per l’elezione di una
donna alla guida dell’istituzione più alta: “Vogliamo dirlo con chiarezza: è
arrivato il tempo di eleggere una donna” al Colle hanno scritto . Soltanto
quando si riunirà il Parlamento in seduta comune si capirà se l’appello verrà
raccolto.
In realtà la prima donna
votata dai grandi elettori era stata Ottavia Penna di Buscemi , candidata nel
1946 dal Movimento dell’Uomo Qualunque, guidato dal commediografo Guglielmo
Giannini. Politica, eletta all’Assemblea costituente con sole altre 20 colleghe,
di nobili origini, fu sempre chiamata ‘la baronessa’. Il 28 giugno del ’46
ottenne 34 voti, ma si trattava delle elezioni del Capo provvisorio dello Stato,
fu eletto Enrico De Nicola e l’idea di votare una donna non fu più accarezzata
da nessuno per 32 anni.
I veleni postumi di Craxi
sul candidato Amato. "Le menzogne dell'opportunista Amatissimo".
Fabrizio Boschi il 17
Gennaio 2022 su Il Giornale.
Le carte segrete dell'ex
premier: critiche anche a Scalfaro e Napolitano.
Parlando di Mino Martinazzoli,
lo definì «un becchino». Antonio Di Pietro veniva deriso per il modo di parlare:
«Fa talmente a botte con i congiuntivi che non può neanche essere chiamato al
processo di Biscardi». E di Giulio Andreotti diceva: «È una volpe. Ma prima o
poi tutte le volpi finiscono in pellicceria».
È il Bettino Craxi che abbiamo
imparato a conoscere, tagliente come la lama di un rasoio, acuto osservatore
degli altri, avendo incrociato la sua vita politica e personale con i principali
personaggi del suo tempo.
Proprio in questi giorni
precedenti all'elezione del nuovo presidente della Repubblica spuntano appunti
inediti dell'ex leader socialista datati 1999, conservati presso la Fondazione
Craxi, in cui parla di sé in terza persona, visionati da AdnKronos, nei quali
analizza vizi e virtù proprio di chi poi finì al Colle, come il socialista
Sandro Pertini (al Quirinale dal 1978 al 1985), il democristiano Oscar Luigi
Scalfaro ('92-'99) il comunista Giorgio Napolitano (2006-2015). E di chi negli
ultimi 20 anni quasi ogni volta è stato in pole per finirci (anche questa
volta), ma senza successo, ovvero il suo ex delfino Giuliano Amato, che oggi ha
83 anni.
Napolitano «non poteva non
sapere» dei soldi arrivati al partito comunista dai regimi di oltre-cortina.
Scalfaro che cerca in tutti i modi di nascondere un assegno elargito «da
industriali per la sua campagna elettorale», che vanta pure appoggi nei servizi
«che gli mettono a disposizione pure un aereo della Cai». Poi Pertini
(«socialista della migliore specie»), che disse subito, appena eletto capo dello
Stato, che sarebbe divenuto «il presidente di tutti».
E poi Amato, che lui chiama,
«Amatissimo». Craxi è un uomo malato, depresso, lontano dall'Italia che può solo
vedere dall'altra parte del Mediterraneo, dalle sponde tunisine. «Amato è un
genio elettronico di opportunismo. A differenza di altri della sua generazione
che sono sempre rimasti più o meno al loro posto senza girovagare per i
labirinti politici Amato se ne andò un bel giorno dal Psi per finire nel Psiup.
Scomparso il Psiup Amato tornò con altri nel Psi», dice Craxi, descrivendo il
dottor Sottile come un voltagabbana per interesse.
Sulla vicenda che travolge il
Paese, e il Psi, all'inizio degli anni '90 scrive che dicendo che non ne sapeva
nulla «mente spudoratamente. Viveva sulle nuvole anzi sulla luna».
Poi l'amarezza personale
«perché - scrive Craxi - questi anni, e ne sono passati ben cinque da quando
Craxi vive come un esiliato, il signor Amato non si è mai fatto vivo una sola
volta anche quando risalivano verso l'Italia le voci inequivocabili riguardanti
le precarie condizioni di salute del leader socialista. Si faceva vivo semmai
ogni qualvolta girava per l'aria la sua candidatura ad alte cariche dello Stato
e sempre per interposti e semi ufficiali messaggeri per vedere di che umore
Craxi era verso di lui». E anche un anno prima di morire il leader del garofano
rosso tacciava Amato circa la «sua ennesima prova di opportunismo e di
vigliaccheria». Una voce dall'oltretomba dispensa consigli anche alla politica
di oggi. Fabrizio Boschi
21 maggio 1992. L'ultima
intervista a Falcone: "La mafia non è una piovra, ma una pantera agile, feroce.
E non dimentica".
La Repubblica il 17 gennaio 2022.
Questa è l'ultima
testimonianza ufficiale del giudice antimafia. Uscì nell'inserto di Repubblica
Napoli "La galleria del giovedì" nel quale si parlava delle mafie. Due giorni
dopo, il 23 maggio 1992, Falcone sarà ucciso. Il colloquio, pubblicato il giorno
seguente alla strage sull'edizione nazionale di Repubblica, è stato poi ripreso
dal Wall Street Journal, da altre testate e in seguito in alcuni volumi come
Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi (Paul Ginsborg, Einaudi). Giovanni Marino
su La Repubblica il 15 gennaio 2022.
"Cosa nostra non dimentica.
Non l'ho mai concretamente vista come una piovra. La mafia è una pantera. Agile,
feroce, dalla memoria di elefante. Per questo bisogna fare in fretta e mettersi
d'accordo sulla Superprocura, uno strumento essenziale per arginare l'espansione
dei boss. Il nemico è sempre lì, in attesa, pronto a colpire. Ma noi non
riusciamo neppure a metterci d'accordo sull'elezione del presidente della
Repubblica...".
Un'altra vigilia di tutti
contro tutti. E ricorda l'Italia del 1978 e del '92.
Concetto Vecchio su La
Repubblica il 21 Gennaio 2022.
Tra i partiti prevale lo
stallo. È accaduto spesso. I precedenti rivelano che poi si è andati incontro a
lunghe votazioni: per eleggere Leone furono necessari sedici giorni, dieci per
Pertini e tredici per Scalfaro. E stavolta?
"Sono tutti contro tutti"
campeggia sulla prima pagina di Repubblica il 13 maggio 1992. Un mercoledì. È la
vigilia del primo scrutinio per il nuovo Capo dello Stato. Le elezioni del 5
aprile hanno fatto scendere la Dc sotto il trenta per cento. Il sistema sta per
crollare, dopo oltre quarant'anni. I partiti si presentano in ordine sparso al
gran ballo del Quirinale, Norberto Bobbio ha rifiutato la candidatura avanzata
da Mario Segni, il Pds voterà per Nilde Iotti.
Il Quirinale, lo stallo,
l'esplosione. 1992: la strage di Capaci e l'elezione di Scalfaro.
Concetto Vecchio su La
Repubblica il 15 gennaio 2022.
Oscar Luigi Scalfaro percorre
i Fori imperiali sulla Flaminia presidenziale al termine di un'elezione tra le
più drammatiche della Repubblica. Era il 25 maggio 1992, due giorni dopo la
strage di Capaci. Il Paese viveva giorni sconvolgenti e i partiti di massa
sentivano vicina la loro fine. A febbraio, con l'arresto del socialista Mario
Chiesa, era scoppiata Tangentopoli. Il 5 aprile le elezioni politiche avevano
rivelato una protesta profonda. La Dc arretrava e irrompeva la Lega di Umberto
Bossi a incrinare i tradizionali equilibri parlamentari. Il presidente della
Repubblica Francesco Cossiga si era dimesso anzitempo, il 23 aprile, con qualche
settimana d'anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, aggiungendo un
ulteriore elemento di incertezza. Quindi si andò alla conta per il Quirinale
senza una bussola. La Dc e il Psi erano la somma di due debolezze. La Dc, divisa
al suo interno in tre fazioni, era indecisa se suggerire Giulio Andreotti e
Arnaldo Forlani, poi ai blocchi di partenza ogni partito scelse un candidato di
bandiera: la Dc Giorgio De Giuseppe, Pds e Rifondazione Nilde Iotti, i Verdi
Norberto Bobbio, il Psi Giuliano Vassalli, la Lega Gianfranco Miglio, i radicali
Oscar Luigi Scalfaro, La Rete di Leoluca Orlando votò Tina Anselmi. Al quarto
scrutinio la Dc puntò su Forlani, che si ritirò però al sesto dopo aver ottenuto
soltanto 479 preferenze. Lo stallo proseguì così per altri dieci giorni. La
svolta sotto l'urgenza per l'uccisione di Giovanni Falcone e della sua scorta,
il 23 maggio. "Non un giorno in più può durare la ricerca del nuovo Capo dello
Stato" scrisse Eugenio Scalfari su Repubblica. Vennero fatti i nomi di Scalfaro,
che il mese prima era stato eletto presidente della Camera, e di Giovanni
Spadolini. La spuntò Scalfaro, un galantuomo dal profilo morale specchiato, ciò
che serviva in quell'Italia corrosa dagli scandali. Alla fine, sostenuto dalla
maggioranza (Dc, Psi, Psdi, Pli) e dall'opposizione, dal Pds alla Rete, dai
Verdi a Pannella, venne eletto al sedicesimo scrutinio.
Giuseppe Salvaggiulo
per lastampa.it l'11 febbraio 2022.
Semel presidente, sempre
presidente. Variante repubblicana della regola benedettina. «Presidente!», si
sente chiamare nel centro di Roma. «Si girano in quindici», esordisce Michele
Ainis, costituzionalista pop, nel saggio Presidenti d’Italia. Atlante di un
vizio nazionale (La nave di Teseo, 224 pp). Non solo in quindici.
Non solo a Roma. L’Italia è
una Repubblica di presidenti, «della più varia risma: ogni autorità pubblica ne
ha uno, spesso più di uno». E come la dignità di abate, anche il titolo di
presidente resta a vita, a decenni di distanza dalla cessazione della carica.
Tanto che, per distinzione, è ormai invalso il «supertitolo» di presidente
emerito, sebbene mandasse su tutte le furie il dimissionario presidente della
Repubblica Giovanni Leone. «Sapete come si dice a Napoli? Emerito stronzo!»,
protestava con gli addetti al cerimoniale.
La regola ruffiana della
nomina
Il saggio di Ainis dalla
dottrina giuridica e dalla politologia sconfina nell’antropologia. La famelica
antropologia dei «posti da presidente, tanti come gli appetiti perché c’è
un’intera nazione da sfamare». Senza concorso: per le presidenze vale la regola
ruffiana della nomina, del circuito ristretto, delle conventicole come
denunciava un inorridito Sergio Castellitto nel film di Virzì Caterina va in
città (Roma, ça va sans dire). E dire che «la malattia presidenziale non
accompagna la storia italiana dai suoi albori. È un fenomeno più tardo, un
disturbo dell’età senile».
Nell’antica Roma il presidente
del Senato era chiamato Princeps senatus. Di presidenti se ne trova traccia per
la prima volta in Boccaccio, nel XIV secolo, ma con eccezione di leadership di
gruppo. Oggi «il culto del presidente è diventato una religione nazionale».
Frutto (degenerato?) della democrazia pluralistica. Molte istituzioni, molti
incarichi, un potere diviso e quindi reciprocamente controllato. Ma anche
fabbrica di competenze sovrapposte, ambiguamente deresponsabilizzanti. Tutti
generali senza truppe, in un paese in cui qualche anno fa la Corte dei conti
stimava quasi 240mila dirigenti pubblici, quanto l’intera popolazione di
Venezia.
Almeno 70714 presidenti
Quanti sono dunque gli
italiani che possono a buon diritto girarsi di scatto sentendo chiamare
«Presidente!» in via del Corso? La ricerca di Ainis, condotta con Andrea
Carboni, Antonello Schettino e Silvia Silverio, arriva a contarne 70174 «ma è un
numero approssimato per difetto giacché il censimento non comprende una miriade
di istituzioni minori, che altrimenti l’avrebbero trasformato in una biblioteca
di Babele, senza inizio e senza fine». In questo «paesaggio multiforme, spesso
abitato da creature eccentriche e bislacche», Ainis sguazza come un bambino il
primo giorno di mare, incasellando i presidenti in una galleria di profili
(comprensivi di poteri, staff e stipendi) non di rado simile a un bestiario
repubblicano che costa al contribuente 390 milioni di euro l’anno. Dagli 11,36
euro di indennità mensile lorda del presidente del tribunale regionale delle
acque pubbliche ai 432mila euro annui del presidente della Corte costituzionale.
Troppi soldi, troppi posti, troppe leggi: è la malattia del troppo, della
superfetazione che incrina la solidità delle istituzioni.
Dall’Aeroclub al Colle
Altro che Quirinale: l’Italia
dei presidenti non si staglia sugli alti colli, ma sopravvive negli interstizi
del potere. Negli anfratti meno illuminati si scrive quotidianamente
un’autobiografia nazionale. Aero Club d’Italia, prima voce del dizionario
presidenziale di Ainis: ente di promozione delle attività aeronautiche a
carattere turistico-sportico, istituito nel 1911, ente morale sotto il fascismo,
dal 1954 ente pubblico.
Primo presidente Ludovico
Spada Veralli Potenziani, futuro governatore di Roma e senatore del Regno.
Mandato presidenziale di 4 anni, rinnovabile due volte. Quindi in tutto massimo
12 anni. Nel 2018 Giuseppe Leoni, ex presidente ed ex commissario che aveva
cumulato ben 17 anni di mandato, fu commissariato (il commissario
commissariato!) dal governo.
Ne seguì una polemica
furibonda, con inevitabile strascico giudiziario fino al Consiglio di Stato. E
dire che l’incarico di presidente è a titolo gratuito, mentre quello di
direttore generale (indicato dal presidente) vale 128 mila euro annui.
Bizzarria? No, sovente regola.
Con paradossi come quello
dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa, negli ultimi due anni diventata
centrale nella lotta al Covid), dove il presidente non riceve emolumenti,
trattandosi di un professore universitario in pensione, mentre il direttore
generale nel 2016 aveva percepito la bellezza di 647mila euro.
La Repubblica presidenziale
(nel senso patologico di Ainis) è anche una immaginifica fucina di acronimi:
Ales, Ansv, Anvur, Arera, insieme ai più noti Anac, Anpal, Anas, Anci, Apt, Aran
e Art per citare solo quelli di una pagina del libro. Sarebbe interessante un
quiz tra i parlamentari: quanti saprebbero indicarne l’esatto significato?
Eppure ogni sigla ha una storia, una struttura, un perimetro di competenze, una
carta intestata, un usciere e naturalmente un presidente.
Luca Monticelli per "la
Stampa" il 18 febbraio 2022.
Lo scontro tra Mario Draghi e
la maggioranza rischia di ripercuotersi sulle nomine pubbliche. Il risiko
prenderà il via a primavera, ma le grandi manovre sono già iniziate.
E il premier sembra deciso ad
andare avanti con il suo «metodo» sempre che i partiti non si mettano di
traverso.
Secondo un report appena
diffuso da Inrete ci sono 350 persone da individuare per le posizioni nei
consigli d'amministrazione di 49 società e di 41 collegi sindacali.
Uno degli obiettivi
politicamente più ambiti riguarda la governance di Invitalia, l'agenzia
nazionale per lo sviluppo, controllata al 100% dal Mef.
L'amministratore delegato è
Domenico Arcuri, portato da Romano Prodi nel 2007.
Sotto la sua gestione sono
passati per Invitalia i dossier più delicati, e Arcuri ha vissuto l'apice della
sua carriera con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Con l'appoggio dell'allora
presidente del Consiglio, il manager calabrese è stato il protagonista della
trattativa sull'Ilva e della gestione dell'emergenza Covid.
Per lui sembravano aprirsi le
porte del vertice di Cassa depositi e prestiti, ma poi tutto è cambiato molto
rapidamente: la caduta di Conte, l'inchiesta per peculato sulle mascherine
cinesi e un progressivo allontanamento dai riflettori. Il rinnovo del consiglio
dell'agenzia è fissato entro il 30 giugno, ma al momento è difficile trovare
qualcuno dentro i palazzi che scommetta sulla permanenza di Arcuri.
Pesa l'indagine della
magistratura e in più i suoi sponsor politici non sono forti come un paio d'anni
fa, sia tra i pentastellati che nel Partito democratico.
Il manager calabrese è dato in
uscita da Invitalia pure per le pressioni che arrivano dal centrodestra che l'ha
sempre criticato aspramente, Matteo Salvini per primo.
In questo scenario, cresce
trasversalmente la candidatura di Bernardo Mattarella, numero uno di
Mediocredito Centrale e nipote del presidente della Repubblica, molto apprezzato
per il lavoro fatto a sostegno delle imprese durante la fase più acuta della
pandemia. Presidente di Invitalia è Andrea Viero, uomo legato al Pd, arrivato
nel 2019, con un passato nelle multiutility quotate.
Il Tesoro ha già cominciato il
domino delle partecipate silurando Guido Bastianini dal Monte dei Paschi di
Siena, sostituendolo con Luigi Lovaglio.
Le prime scadenze sono
stabilite entro il 30 aprile se si considerano, ad esempio, Consip, Eni, Sogin,
PagoPa, Enav, Banca del Mezzogiorno. Poi ci sono Snam, Italgas e Fincantieri.
Le nomine verranno realizzate
osservando la legge sul rispetto della parità di genere, che prevede almeno i
due quinti dei posti nei cda riservati alle donne. La competizione è apertissima
e c'è ancora tempo prima della presentazione delle liste, eppure qualcosa si sta
muovendo.
Sace, la società che si occupa
del settore finanziario delle realtà imprenditoriali, è passata dal perimetro di
Cassa depositi e prestiti al Mef, e attualmente vede amministratore e presidente
rispettivamente Pierfrancesco Latini e Mario Giro.
Per sostituire il primo si fa
il nome di Federico Merola, componente indipendente del consiglio, al posto del
secondo un alto dirigente del ministero dell'Economia, ma non sarà il direttore
generale Alessandro Rivera. Probabile la riconferma per Pasquale Salzano e Mauro
Alfonso a Simest, così come per l'ad di Snam, Marco Alverà.
Stesso discorso per Giuseppe
Virgone alla guida di PagoPa. Su Fincantieri, impresa leader nella cantieristica
navale, la partita appare molto complessa. Giuseppe Bono è destinato a rimanere
in azienda, ma come presidente del gruppo, poltrona attualmente occupata da
Giampiero Massolo, ex direttore del Dis comparso anche nelle rose del
centrodestra per il Quirinale.
Diversi i profili sul tavolo
come capo azienda: Fabrizio Palermo (già rimosso da Draghi da Cdp), Fabio Gallia
(ora direttore generale), Claudio Gemme (manager del gruppo ed ex Anas).
Dopo la tornata del 2021 che
ha portato alla nomina dei nuovi vertici delle big di Stato come Fs e Cdp, anche
quest' anno il premier, affiancato dal consigliere Francesco Giavazzi, sembra
intenzionato a proseguire sulla linea dell'indipendenza dalla politica, ma dovrà
fare i conti con gli appetiti dei partiti, a un anno dalle elezioni.
Da true-news.it il 18 febbraio
2022.
Parità di genere e “metodo
Draghi”. È la partita delle nomine 2022: sono circa 350 i nomi da individuare
complessivamente per le posizioni nei consigli d’amministrazione e nei collegi
sindacali delle società pubbliche e partecipate dallo Stato, a cui vanno
aggiunti quelli per le posizioni di amministratori delegati e presidenti dei
consigli di amministrazione.
È quanto emerge da “Il domino
delle nomine – Il rinnovo delle cariche nelle società partecipate dallo Stato
nel 2022”, dossier a cura del Centro Studi Inrete rilasciato il 17 febbraio che
offre un prospetto delle cariche scadute al 31 dicembre 2021 e ancora da
rinnovare.
Nomine 2022: Poste, Enel, Eni,
Leonardo, Sace, Consip
Da Invitalia a Sogin, da Poste
Italiane a Eni passando per Monte dei Paschi, Enav, Leonardo, Enel, Sace,
Consip, Sport & Salute e tante altre. È ripartita anche quest’anno la stagione
cruciale delle nomine per le società partecipate dallo Stato, suddivise fra
società di 1° livello, partecipate direttamente dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze (o, raramente, da un altro Dicastero) e le società di 2° e 3°
livello, di matrice indiretta, le cui quote sono possedute da una società
partecipata a sua volta da uno dei Ministeri.
Nei primi mesi del 2022 –
entro la metà dell’anno – saranno da individuare i nomi per quelle cariche
scadute nel 2021 non ancora rinnovate. Successivamente, il focus passerà alle
nomine per le cariche in scadenza il 31 dicembre 2022.
Nomine 2022: parità di genere
e “metodo Draghi”
A livello di approccio
probabile una riedizione di quanto già avvenuto nel 2021. Per le nuove nomine
verrà osservato il criterio stabilito dalla Legge 12 luglio, n. 120 sul rispetto
della parità di genere, la quale prevede che almeno i 2/5 delle nomine dei
consiglieri di amministrazione e dei sindaci delle società quotate vengano
riservati a donne.
C’è anche chi parla di
alternanza di genere fra presidenti e amministratori delegati dove possibile,
con un metodo già sperimentato in alcune società pubbliche. A farla da padrone
resterà comunque il cosiddetto “metodo Draghi”, ispirato alla discontinuità
gestionale lasciando meno spazio alle manovre dei partiti.
Lo strano caso di Bonomi,
presidente di tutto imprenditore di niente.
GIOVANNA FAGGIONATO su Il
Domani il 19 febbraio 2022
Che lavoro fa Carlo Bonomi?
Qualcuno inizia a chiederselo, considerando la candidatura offertagli su un
piatto d’argento dal presidente del Milan, Paolo Scaroni, alla presidenza della
Lega calcio di Serie A e subito sfumata.
Negli ultimi anni l’assetto
delle sue partecipazioni è cambiato molto, la sola cosa che non è cambiata è che
Bonomi continua a non avere ruoli operativi, ma solo a sommare incarichi di
presidenza.
Nel 2020 Marsupium srl una
delle società di cui Bonomi è presidente ha registrato utili per 3,9 milioni.
Come? Cedendo una partecipazione e comprandone un’altra sempre all’interno della
galassia delle sue partecipate.
GIOVANNA FAGGIONATO.
Giornalista specializzata in economia e affari europei. Prima di arrivare a
Domani, ha lavorato a Milano e Bruxelles, per il Sole 24 Ore e Lettera43.
Giovanna Fagionato per
“Domani” il 20 febbraio 2022.
Che lavoro fa Carlo Bonomi?
Qualcuno inizia a chiederselo, considerando la candidatura offertagli su un
piatto d’argento dal presidente del Milan, Paolo Scaroni, alla presidenza della
Lega calcio di Serie A e subito sfumata, poche settimane dopo che Il Sole 24 Ore
aveva dato spazio agli appelli al governo per evitare il fallimento.
Un caso davvero particolare,
considerando che né Bonomi ha commentato, com’è noto il presidente si trovava
alle Maldive, né alcun commento è arrivato da Confindustria, nemmeno quando è
stato chiesto direttamente.
I precedenti crearono molte
più polemiche: Giorgio Fossa, nominato nel consiglio di amministrazione della
Sea, la società degli aeroporti di Milano, dal sindaco, Gabriele Albertini, a
sua volta imprenditore, per privatizzare la società pubblica, fu investito di
accuse di conflitto di interessi.
Fossa fu nominato quando già
il suo mandato era in scadenza, Bonomi è appena a metà del suo e intanto ha già
un altro incarico, quello di presidente della Fiera di Milano, circa 100mila
euro di compenso, su cui ancora una volta non si sono levate particolari
contestazioni.
La sua nomina all’ente
fieristico è arrivata quasi contemporaneamente al balzo alla presidenza di
Confindustria e agli inizi del mandato solitamente il clima è da luna di miele:
un mese dopo la nomina, la Sidam, società di forniture biomedicali di cui Bonomi
è presidente, fu anche premiata dalla Confindustria di Bonomi, con il premio
Pininfarina per l’innovazione.
La sua elezione nel 2020
rispondeva alla voglia dei grandi elettori del nord di riportare il timone della
organizzazione degli industriali al settentrione e un presidente di Assolombarda
ambizioso, ipercomunicatore, dalla battuta pronta e puntuta, faceva al caso
loro.
Pochi mesi dopo le industrie
dell’alimentare si sarebbero ricredute, con la maggioranza delle federazioni che
forti dei proventi portati da pandemia e lockdown firmavano i rinnovi dei
contratti coi sindacati, disubbidendo alla linea di Bonomi che considerava quei
rinnovi aumenti troppo alti rispetto all’inflazione. Una frattura amplissima tra
la teoria e i proclami politici del presidente e la pratica delle aziende che
negoziavano coi lavoratori.
Le battute di Bonomi sugli
scioperi «sbagliato», «mi rattrista», è «un rito identitario», hanno segnato il
tempo della sua permanenza alla presidenza, più di altri risultati di sorta.
Le battute, però, non le fa
solo Bonomi. Quelle sulla sua reale consistenza imprenditoriale sono frequenti,
anche all’interno degli ambienti confindustriali. Per diversi anni Bonomi è
stato a capo di una filiera di scatole cinesi che controllavano una piccola
società di forniture biomedicali.
Ma negli ultimi anni l’assetto
è cambiato molto, la sola cosa che non è cambiata è che Bonomi continua a non
avere ruoli operativi, ma solo a sommare incarichi di presidenza. Attualmente
oltre alla presidenza di Fiera e Confindustria, infatti, Bonomi è presidente di
Sidam la società di forniture biomedicali la cui quota di maggioranza nel
settembre 2020 è stata acquisita dal fondo Mandarin Capital di Alberto
Forchielli.
A vendere era stata la Synopo,
sempre riconducibile a Bonomi. Il presidente di Confindustria è rimasto però
socio della Sidam tramite la Marsupium srl: in Marsupium Bonomi è presidente e
detiene il 40 per cento del capitale tramite un’altra società, la Ocean srl.
Della Ocean, di cui è ancora una volta presidente, Bonomi detiene un terzo del
capitale, gli altri due terzi sono divisi equamente tra due dirigenti della
Sidam.
Marsupium nel 2020 ha
registrato un utile di 3,9 milioni di euro rispetto alla perdita di 4910 euro di
fine 2019. Un ottimo risultato di cui però si spiegano le origini nel resoconto
dell’assemblea 2021 riportata nei documenti di bilancio: «Il presidente (Bonomi,
ndr) evidenzia che l’ottimo risultato raggiunto è da ricondurre principalmente
alla vendita a favore di Stanislao srl della propria partecipazione in New
Horizon srl – pari al 34 per cento del capitale di New Horizon srl – ed al
conseguente investimento fatto in Medtech holding Spa rappresentative del 20,4
per cento del capitale».
Si dirà che è un ottima cosa
lasciare una partecipazione poco redditizia e investire in una maggiormente
redditizia, sono cose per cui ci vuole fiuto. Peccato che si tratti di giri di
quote in società di cui sempre Bonomi gioca un ruolo: New Horizon srl è stata
incorporata in Sidam nel marzo del 2021 e per questo la sua partecipazione nella
stessa Sidam è stata annullata e data in capo al socio della Sidam che è appunto
la Medtech holding Spa.
E chi è il presidente di
Medtech holding Spa che controlla Sidam? Sempre Bonomi che ne è socio sia
attraverso la Marsupium che in persona, l’altra socia è Annalisa Azzolini che è
l’amministratrice delegata di Sidam, con una lunga tradizione di imprenditoria
alle spalle visto che è la figlia del fondatore dell’azienda.
Nell’anno della pandemia il
valore della produzione di Sidam è aumentato di 3,6 milioni da 14,2 milioni a
17,8 e i dipendenti cresciuti da 87 a 102. In più dal 17 gennaio 2022 Sidam ha
incorporato la Btc medical europe srl che aveva acquisito nel 2016 e a dicembre
di quest’anno ha acquisito anche la Emotec: il fatturato così sale a 26 milioni
e i dipendenti a 130.
Secondo il comunicato di
Mandarin Capital Partners, Emotec mantiene il suo storico amministratore
delegato, Francesco Schittini, mentre Bonomi ne occupa la presidenza. Prima di
essere acquisita da Sidam, secondo le visure camerali Emotec era controllata
dalla microimpresa L’impronta srl, 5 dipendenti, e un presidente: indovinate
chi?
Tra microimprese e giochi di
partecipazioni, Bonomi è più un frequentatore di cda che un imprenditore. Forse
è per questo che gli industriali di fronte all’incarico della Lega di serie A
non hanno trovato niente da ridire.
Todos caballeros. La
specialità dell’Italia è produrre presidenti.
Michele Ainis su L'Inkiesta il
15 gennaio 2022.
Sono tantissimi, hanno
funzioni diverse, paghe variabili e poteri che cambiano a seconda del ruolo. Il
titolo, però, rimane lo stesso. Nel suo ultimo libro (pubblicato da La Nave di
Teseo) Michele Ainis si impegna del compito gravoso di metterli in fila,
indicando per ciascuno ruoli e prerogative.
Ma che mestiere svolge il
presidente? C’è un potere, una funzione, una prerogativa che lo distingua
rispetto a tutte le altre cariche? Su frasicelebri.it si trova la risposta: «Il
lavoro di un presidente è quello di presiedere». Definizione ineccepibile, ma
forse un po’ elusiva. Qual è infatti il significato di “presiedere”, in quale
attività consiste? Risponde, questa volta, la Treccani online: «Presiedere è
essere a capo in qualità di presidente».
Insomma, un circolo vizioso.
Però la colpa non è delle parole, è della cosa. Dipende dall’ambiguità della
figura, dalla grande varietà di modi con cui viene disegnata nei singoli
settori.
In via generale, potremmo
anche fissarne taluni attributi ricorrenti: per solito, ogni presidente ha
infatti il potere di convocazione del collegio; di stabilire l’ordine del giorno
e dirigerne i lavori; di rappresentanza esterna, spesso anche in giudizio,
dell’ente che presiede. Tuttavia è molto di più ciò che li divide, che distingue
l’uno dall’altro i vari presidenti. E il censimento offerto in questo libro ne
offre la prova. Viaggiando fra i 57 presidenti dei Consorzi Bim e i 17
presidenti dei Teatri stabili, fra gli scranni presidenziali in un municipio o
in un’azienda di Stato, s’incontra una fauna variegata: i nostri presidenti
avranno in comune la poltrona, ma sono diversi per criteri di nomina, per durata
dell’incarico, per retribuzioni, per regime d’incompatibilità, per somma di
poteri.
Cominciamo da qui, dai loro
poteri. Talvolta formali, da maestro di cerimonie o poco più; talvolta simili ai
poteri d’un re. Così, in vari casi il presidente può sostituirsi al collegio che
presiede, adottando provvedimenti monocratici da sottoporre poi a ratifica.
Accade nei tribunali, ma accade altresì presso varie autorità amministrative,
dall’Agcom all’Anpal, dalle Camere di commercio agli Enti parco, e poi nei
Consorzi interuniversitari di ricerca, in Federculture, Ismea, Inrim, Inaf, e
via elencando. In altri casi ancora, a parità di voti il suo voto vale doppio:
un potere che accomuna il presidente della Corte costituzionale, quello
dell’Antitrust, quello della Commissione sullo sciopero. Il presidente
dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, può proporre al prefetto il
commissariamento di un’impresa. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità
ha una quantità di uffici alle sue dirette dipendenze, dalla Segreteria al
“Servizio conoscenza” (qualunque cosa voglia dire), dall’Unità di bioetica
all’Ufficio stampa, per finire con le Relazioni esterne e i Rapporti
internazionali. Il presidente della Corte dei conti è un presidente al cubo,
giacché presiede pure il Consiglio di presidenza e le Sezioni riunite. Ma il
presidente più presidenzialista è quello dell’Invalsi: conferisce deleghe,
adotta tutti i provvedimenti urgenti, reclama pareri dalle authority e dal
Consiglio di Stato, ci manca solo che benedica le folle a piazza San Pietro.
Anche il regime giuridico dei
nostri presidenti appare ondivago come una libellula. Il presidente dell’Arera
(Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), per esempio, non può
esercitare alcuna attività professionale, né ricoprire uffici pubblici di
qualsiasi natura; e l’incompatibilità si estende ai due anni successivi alla
cessazione dell’incarico. Come lui altri presidenti, ma i più non soffrono di
limitazioni. E la riconferma? Qualche volta è ammessa, qualche volta no. Puoi
fare il presidente dell’Art (Autorità di regolazione dei trasporti) una volta
sola nella vita; quello di Federbim (Federazione nazionale dei consorzi di
bacino imbrifero montano) anche vita natural durante, tanto che nel 2020 il suo
presidente ha ricevuto il quinto mandato consecutivo, un’avventura cominciata
nel 2000. Mentre rimangono presidenti fino alla pensione i vertici della Corte
dei conti e del Consiglio di Stato.
Sulla durata della carica,
infatti, il nostro ordinamento gioca i numeri al lotto: 3 anni per l’Agenzia
italiana del farmaco; 4 anni per l’Autorità di sistema portuale; 5 anni per il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; 6 anni per l’Ufficio
parlamentare di bilancio; 7 anni per la Privacy; fino a 12 anni per il Coni, il
Comitato olimpico nazionale. Sempre che il presidente non venga revocato
anzitempo, quando la legge lo consente. È il caso dell’Istituto per la finanza e
l’economia locale, il cui presidente può venire destituito in ogni momento dal
presidente dell’Anci, senza necessità di motivare la decisione.
Invece il presidente della
Camera dei deputati non può mai ricevere un voto di sfiducia, come mostra la
vicenda di cui fu protagonista Gianfranco Fini durante la XVI legislatura, in
seguito allo scontro con il presidente del Consiglio Berlusconi. Si dirà: ma
questa garanzia discende dal suo ruolo, giacché chi presiede un’assemblea
legislativa è come un arbitro, staremmo freschi se i giocatori potessero
cacciarlo dal campo di gioco. Vero, ma allora non si spiega perché mai in
Toscana il presidente del Consiglio regionale possa subire una mozione di
sfiducia, a norma di statuto. Misteri statutari.
Insomma, s’incontrano
presidenze effimere e presidenze fin troppo durature. Questa carica ha una
doppia valenza, e d’altronde sono doppie le stesse forme del verbo presiedere
(si può dire “presiederono” ma anche “presiedettero”). Sicché diventa un po’
come un elastico, si lascia stirare o restringere a piacere. Presso la Consulta,
per esempio: la presidenza più lunga venne incarnata da Gaspare Ambrosini (5
anni, 1 mese e 25 giorni), la più breve da Vincenzo Caianiello (44 giorni). O a
Palazzo Chigi, dove siede il presidente del Consiglio. Qui la palma della
longevità spetta al secondo Governo Berlusconi, che sopravvisse per 1412 giorni,
quasi 4 anni (2001-2005). Mentre il record negativo di durata risale al primo
Governo Andreotti, nel 1972: 8 giorni appena. Un’esperienza che rievoca
l’epistate dei pritani, antica istituzione della democrazia ateniese; era una
sorta di capo dello Stato, ma durava un solo giorno, e si poteva ricoprire
questo ruolo un’unica volta nella vita. Giulio Andreotti, viceversa, guidò sette
governi; e come lui Alcide De Gasperi.
E c’è poi la retribuzione che
spetta al presidente, ammesso che gli spetti. Giacché in vari casi la sua
funzione viene svolta gratis, senza ricevere il becco d’un quattrino. Accade,
fra l’altro, nei Consorzi fra enti locali, alle Camere di commercio, presso la
Conferenza Stato-Regioni, all’Aero Club d’Italia come all’Upi e all’Uncem.
Contravvenendo alla regola costituzionale secondo cui chi lavora va pagato,
sempre che quello del presidente sia un lavoro. Ma i dubbi restano, a giudicare
dalla diversità di trattamento.
Si viaggia così dai 165 euro
al mese che spettano al presidente d’un Consiglio comunale nei piccoli paesi,
fino ai 295.000 euro l’anno per il presidente della Cassa depositi e prestiti,
ai 400.000 euro per il presidente dell’Ivass, ai 432.000 euro versati a chi
presiede la Consulta. Nel 2014 il Governo Renzi stabilì un tetto di 240.000 euro
per gli stipendi pubblici, ma il tetto dev’essersi bucato. D’altronde il nostro
legislatore è un cacadubbi, come mostra l’indennità del presidente della
Provincia: prima corrisposta, poi negata, poi introdotta di nuovo (nel 2020).
Sarà per questo, sarà per una forma di pudore, che la loro retribuzione viene
spesso calcolata in gettoni di presenza (11.115 euro, all’Azienda regionale per
il diritto allo studio universitario di Padova). E dopotutto, meglio poco che
niente. Ne sa qualcosa il presidente del Tribunale regionale delle acque
pubbliche, cui spetta un’indennità mensile di 11,36 euro, naturalmente al lordo
delle tasse.
Infine: come si diventa
presidenti? Dipende dai costumi locali; in America il presidente è eletto, in
Italia viene nominato. Da chi? Sovente dal ministro: è il caso di Enea, Inapp,
Aran, Inl, Formez, Cnr, e delle molte altre sigle dettate da un legislatore
balbuziente. Per converso, ogni ministro viene a sua volta nominato da un
presidente, quello del Consiglio.
E qualche ministro è a sua
volta presidente, recitando due parti in commedia. È il caso, per esempio, del
ministro della Cultura, che presiede l’Osservatorio nazionale per la qualità del
paesaggio; o di quello per le Disabilità, che presiede un altro Osservatorio. Ma
si dà pure il caso opposto, quando è il presidente a trasformarsi in un
ministro. Succede ai presidenti delle Regioni a statuto speciale che partecipano
al Consiglio dei ministri, se si decide su materie di loro competenza. Doppia
qualifica, doppia divisa. Come quella che indossa il sindaco, al contempo
presidente della Giunta comunale; o il direttore generale della Banca d’Italia,
che diventa in automatico presidente dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni.
In altri casi, tuttavia, la
legge reclama l’uso del concorso, come avviene per i presidenti di tribunale e
per varie altre figure. Ma i requisiti per concorrere non sono affatto uguali.
Se vuoi presiedere un Consiglio d’istituto devi essere un papà o una mamma, devi
dar prova, insomma, delle tue capacità riproduttive. Se ti candidi a un ente di
ricerca dovrai esibire qualità di competenza, esperienza, indipendenza.
Requisiti stringenti, benché non sempre applicati in modo restrittivo. Nel 2012,
per esempio, un professore di ginnastica divenne direttore generale
dell’Istituto nazionale di geofisica; e in quel caso il direttore conta più del
presidente. Sennonché, talvolta, il requisito stesso è inapplicabile. Accade
alla Consip, il cui presidente dev’essere scelto “nel rispetto dell’equilibrio
di genere”. E come si fa, se la poltrona è una? Cercasi candidati ermafroditi.
Per evitare abusi, resta però
una via d’uscita: far nominare il presidente dal presidente. Di chi altri
dovremmo mai fidarci? E infatti questa soluzione si pratica in Sicilia, dove il
presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni viene scelto personalmente dal presidente della Regione. Si
pratica, altresì, in Campania, rispetto al presidente dell’Osservatorio
regionale sulla gestione dei rifiuti, indicato anch’esso dal presidente della
Regione. E qualche volta il presidente è costretto ad autonominarsi, a designare
sé medesimo. Succede nei Consigli comunali, dov’è ammessa la formazione di
gruppi costituiti da un unico membro. Succede nel Consiglio provinciale di
Trento, dove nel 2021 si contavano 13 gruppi consiliari, di cui 7 con un solo
componente, presidente di se stesso. Condizione invidiabile: nessun dibattito,
nessun contrasto sulle decisioni. Ma diventerà presto la regola, dato che in
Italia i presidenti sono ormai più dei presieduti.
da “Presidenti d’Italia.
Atlante di un vizio nazionale”, di Michele Ainis, con Andrea Carboni, Antonello
Schettino, Silvia Silverio, La Nave di Teseo, 2021, pagine 224, euro 19
La figura del capo dello
Stato in un saggio illuminante. Il discreto fascino del Quirinale, storia dei
nostri Presidenti della Repubblica.
Stefano Ceccanti su Il
Riformista il 13 Gennaio 2022.
Il libro di Gianluca
Passarelli Presidenti della Repubblica, appena edito da Giappichelli, si compone
soprattutto di una serie di ritratti ben elaborati, secondo i filtri
metodologici della scienza della politica, degli inquilini che si sono succeduti
al Quirinale. La competizione per il Colle è tradizionalmente caratterizzata da
lotte fratricide e candidature dissimulate, premette in modo giornalisticamente
brillante Eva Giovannini, a partire dall’episodio del 2013, con la bocciatura
di Marini e Prodi e col discorso di Napolitano rieletto che i parlamentari
applaudivano senza capirlo fino in fondo o, forse, facendo finta di non capirlo.
I singoli ritratti sono
preceduti da una parte introduttiva dell’Autore che inquadra la figura del capo
dello Stato a partire dalle particolari modalità di elezione. In
particolare Passarelli richiama l’importanza decisiva del voto segreto, a cui
non siamo più di tanto abituati perché nell’ordinaria vita parlamentare, almeno
dal 1988, siamo soliti confrontarci con prevedibili votazioni di tipo palese.
Anche dopo quella riforma regolamentare, però, il voto segreto è rimasto
obbligatorio per l’elezione di persone, rispetto alle quali massima deve essere
la libertà dell’elettore, soprattutto per le istituzioni di garanzia, presidente
della Repubblica e giudici costituzionali. La larghissima convergenza
sull’elezione indiretta, come ben spiega l’Autore, non era scontata all’inizio
della Costituente, ma lo divenne, in forma di garanzia reciproca, dopo la crisi
di governo della primavera 1947 lungo la linea di frattura della Guerra
fredda, con un ruolo decisivo del presidente del Consiglio De Gasperi (p. 3), a
testimonianza di come sia palesemente erronea l’immagine di un governo distante
dai lavori della Costituente, pur costruita con l’intento positivo di
sedimentare il consenso sulla Carta.
Tutte le principali decisioni
della Costituente sulla Seconda parte furono rigorosamente e altamente
politiche, e derivanti da una lettura puntuale del contesto lacerato di
allora. Passarelli passa quindi alle caratteristiche che portano all’elezione,
indagando sulle regolarità e sulle discontinuità tra i vari inquilini
del Quirinale. Quale la sintesi? Che si tratta di uomini, per lo più anziani,
non leader politici di primo piano in termini di Governo, con cariche
istituzionali importanti e prestigio internazionale (p. 12). Non si può però non
rilevare uno scarto tra i ritratti dei primi Presidenti, interventisti in fasi
limitate e comunque reversibili, col periodo che segna lo spartiacque del
sistema dei partiti, il 1989, e che ricompone la frattura del 1947. Non a caso
Passarelli ci descrive la presidenza Cossiga come segnata da una discontinuità
interna pre e post-1989, come se si trattasse di due persone diverse perché, al
netto di caratteristiche personali, erano state messe in discussione le fratture
del sistema dei partiti ed era immaginabile una ricomposizione su basi diverse
(p. 56 e ancor più p. 58).
Anche per questo, forse, si
trattò di un Presidenza non del tutto compresa allora in alcuni sui slanci
positivi, come il messaggio sulle riforme costituzionali del 1991. Che quello
sia stato il punto di passaggio chiave, con un indebolimento strutturale del
sistema dei partiti, solo debolmente arginato sul piano nazionale dalla riforma
elettorale a Costituzione invariata, e quindi con un Presidente stabilmente più
interventista, lo dimostra il suo successore Scalfaro, che pur l’aveva
ampiamente criticato. Interventismo significa anche, almeno potenzialmente,
entrare in scelte opinabili, in particolar modo sul potere di scioglimento
anticipato, ed esporsi di più alla polemica politica di chi se ne senta
danneggiato, come accadde appunto a Scalfaro col centrodestra (p. 65).
Ancor più dopo il fallimento
del referendum costituzionale del 2016, che puntava a chiudere la transizione
lungo l’asse maggioranza parlamentare (ed elettorale)-Governo-Presidente del
Consiglio, questa linea di tendenza è stata ampiamente confermata, come
dimostrato in particolare da uno dei momenti chiave del settennato, il rifiuto
della nomina di Paolo Savona all’Economia nel Conte I in quanto autore di un
piano di uscita surrettizia dall’Euro (p. 84). Nella parte finale, dopo i
ritratti, Passarelli affronta la questione della possibile rielezione e anche
qui la collega in modo stretto alla forza del sistema dei partiti: quando esso
era strutturato i vertici delle forze politiche riuscivano a escluderla
nonostante che tutti gli uscenti abbiano provato a perseguire quella strada; una
volta imboccata la strada della destrutturazione sono essi che invece finiscono
per chiederla a capi di Stato riluttanti (pp. 96-97). Con Napolitano la
ottennero, vedremo stavolta. Stefano Ceccanti
Congiure, bugie e dossier:
la spietata commedia del potere chiamata corsa al Quirinale.
Bruno Manfellotto su
L'Espresso il 10 Gennaio 2022.
La battaglia intorno
all’elezione del Presidente della Repubblica non si è mai svolta secondo le
regole che da una così alta liturgia ci si aspetterebbe. Lo racconta il libro di
Marco Damilano “Il Presidente” in edicola da domenica 16 gennaio con L’Espresso
e Repubblica.
Mettiamola così. Il Parlamento
ha perso la sua centralità; i governi nascono e muoiono deboli; la giustizia è
in piena «crisi di fiducia»; la stampa è accusata di «conformismo e faziosità»;
perfino il Papa è contestato… In questa generale caduta degli dei, resiste
invece il presidente della Repubblica, l’istituzione alla quale si continua a
guardare come ultimo punto di equilibrio e stabilità.
Sarà anche per questo che ogni
sette anni intorno all’elezione del Capo dello Stato cresce la curiosità e
spasmodica si fa l’attesa che il rito si compia. Stavolta, poi, la corsa è
cominciata mesi prima, forse nel momento stesso in cui Sergio Mattarella, un
anno fa, ha affidato il governo a Mario Draghi con tanto di larga maggioranza.
Solo che in 76 anni e dodici corse presidenziali (magari tredici considerando il
bis di Giorgio Napolitano, così il destino di chi verrà non sarà segnato dal
fatidico numero), la battaglia non si è mai svolta secondo le regole che da una
così alta liturgia ci si aspetterebbe. Mai. Piuttosto è stata contrappuntata da
congiure, bugie, dossier, dispetti, bocciature, «pugnale e veleno» (copyright
Carlo Donat Cattin).
Una spietata commedia del
potere che, come si dice, si alimenta del suo stesso racconto. Fino a diventare
romanzo. Bene, se volete partecipare al sabba, o almeno assistervi da un punto
d’osservazione privilegiato, allora leggete il libro di Marco Damilano “Il
Presidente” che troverete in edicola domenica 16 gennaio con “L’Espresso” e “la
Repubblica” (a 12,90 euro più il prezzo del giornale).
Pagina dopo pagina, un
cronista attento e acuto che mastica politica da sempre - quando seguì la sua
prima elezione presidenziale, quella di Francesco Cossiga, aveva 16 anni - svela
i segreti, i protagonisti e le misteriose alchimìe del Grande Evento: da De
Nicola a Mattarella, da Gronchi a Pertini, da Leone a Scalfaro, da Einaudi a
Ciampi.
Il rituale, in fondo, non è
mai stato del tutto uguale a se stesso. Certo, qualche regola c’era, ma si è
dissolta con la Prima Repubblica. Allora lo schema prevedeva il coinvolgimento
del Pci; l’alternanza tra un laico e un cattolico; il no ai capi partito, meglio
le seconde file (tranne che nel caso di Segni, potente leader della corrente più
potente della Dc, i dorotei, e di Saragat, segretario del Psdi).
I presidenti, poi, non sono
stati tutti uguali: Damilano li divide in “rispettosi dei confini” (De Nicola,
Einaudi, Leone, Ciampi); “impositivi” (Gronchi, Segni, Saragat, Scalfaro);
“antagonisti” (Pertini, Cossiga) e per ciascuno ci regala retroscena, aneddoti,
carte segrete. In quanto a Napolitano e Mattarella, figli della crisi dei
partiti, sono stati costretti ad aprire al massimo la fisarmonica dei loro
poteri, fino a praticare quel semipresidenzialismo di fatto che sbuca ogni tanto
in questa storia.
Damilano non può certo dirci
come il romanzo Quirinale andrà a finire, ma oltre a fornirci un manuale di
memoria e testimonianza indispensabile per comprendere la cerimonia misterica
che sta per compiersi, dedica qualche pagina al candidato più accreditato (nel
capitolo “Drag King”, titolo espressese), ma anche il più condizionato,
dall’eccezionalità (mai finora un premier ha traslocato al Quirinale) e, per
paradosso, dal suo stesso carisma: «Al Quirinale arriverebbe per la prima volta
il massimo esponente dell’Italia politica, il punto di equilibrio del governo di
unità nazionale, il riferimento europeo atlantico e internazionale», scrive
Damilano; «il presidente della Repubblica diverrebbe il garante dell’indirizzo
politico e il presidente del Consiglio avrebbe una funzione puramente esecutiva
di questo indirizzo»; sul Colle si realizzerebbe «la coincidenza tra potere
formale e potere sostanziale». Una stagione nuova nella quale il Presidente
prevarrebbe sull’Istituzione.
Per comprenderla, per
prepararsi a viverla o, al contrario, per ricordare ciò che non è stato e
sarebbe potuto essere, prendete in mano questa guida. In attesa che la storia si
concluda.
Il grande gioco del
Quirinale: “Le maledizioni delle donne e dei segretari Dc”.
GIULIA MERLO su Il Domani il
13 Gennaio 2022.
Per dodici presidenti che sono
stati eletti al Quirinale, molti altri ci hanno provato senza riuscirci, anche
più di una volta. La maledizione si è accanita soprattutto sui segretari della
Dc. Non solo loro: nessun nome femminile è mai riuscito a sfondare il tetto
della maggioranza assoluta
“Nano maledetto, non verrai
mai eletto”, c’era scritto su una delle tante schede nulle votate dai grandi
elettori durante le 23 votazioni dell’elezione al Quirinale, nel 1971.
Il nano maledetto si riferisce
Amintore Fanfani. Basso di statura, il segretario della Dc e presidente del
Senato è candidato ufficiale del suo partito al Colle.
Durante lo scrutinio è seduto
accanto al presidente della Camera, Sandro Pertini e fa in tempo a leggere la
scheda. Quel distico perfido sarebbe stato scritto da uno dei franchi tiratori
democristiani aizzati da Giulio Andreotti.
Amintore Fanfani è uno dei
grandi delusi del Quirinale, che per lui è stato una vera maledizione. Nato ad
Arezzo nel 1908, Fanfani fa parte della corrente sinistra della dc, prende il
potere del partito nel congresso del 1954. Il suo amico e compagno di corrente,
Giuseppe Dossetti, lo definisce “un uomo nato sotto il segno del comando” e la
carriera di Fanfani lo conferma: 6 volte presidente del consiglio, 5 volte
presidente del senato, due volte segretario della dc, undici volte ministro e
l’unico presidente italiano dell’assemblea generale Onu. Tanto da venire
soprannominato dal giornalista Indro Montanelli “il rieccolo”.
Al Quirinale, però, non c’è
mai arrivato. E non perché non ci abbia provato.
La prima occasione arriva nel
1964: l’assemblea dei parlamentari della Dc si è riunita e ha votato il suo
candidato ufficiale. è Giovanni Leone, ma già dalle prime votazioni il suo nome
non decolla: i franchi tiratori hanno colpito e sta prendendo quota il nome di
Fanfani. Quando però si rende conto che comunque non avrà i voti dei comunisti,
Fanfani telefona a Leone e gli comunica che si ritira. I voti non bastano
comunque e al Quirinale viene eletto Giuseppe Saragat.
L’occasione si ripresenta,
sette anni dopo. Nel 1971 è lui il candidato ufficiale della Dc ed è convinto di
venire eletto. Glielo dice anche il suo avversario politico di sempre
all’interno della Dc, Giulio Andreotti. Le cronache raccontano che la frase sia
stata “Ti abbiamo scelto e verrai eletto, perché non ci sarai più tu a manovrare
i franchi tiratori”. Fanfani, infastidito, avrebbe detto ad Andreotti di
occuparsi dei voti degli altri partiti, lui si sarebbe assicurato di avere
quelli della Dc.
Proprio l’arroganza, però, gli
ha fatto perdere il Colle.
Un’altra delle regole non
scritte è quella di non inimicarsi la stampa, durante i delicati giorni del
voto. Invece, Fanfani accusa uno dei più importanti giornalisti politici del
tempo, Vittorio Gorresio, di averlo rappresentato scorrettamente nei suoi
articoli sulla Stampa. In Transatlantico, davanti a tutti, gli dice che i suoi
articoli vengono tagliati dai suoi padroni. Gorresio, d’accordo con il
direttore, scrive il dialogo sul giornale insieme a una nota di tre righe”Il
linguaggio del senatore fanfani non si addice a un presidente, anche solo del
Senato.
Il giorno dopo si conclude la
corsa di Fanfani al Colle, sotto i colpi della stampa e dei franchi tiratori Dc.
ANDREOTTI E FORLANI
I franchi tiratori sono sempre
stati uno degli incubi della democrazia cristiana, che ha sempre avuto una
disciplina di partito meno rigida rispetto a quella del partito comunista e la
divisione in correnti ha fatto maturare vendette e agguati. Non è un caso che
nessuno dei segretari del partito siano mai stati eletti: sempre espressioni di
parte, è stato il loro partito a non garantirgli il consenso necessario.
Il fenomeno si è acuito a mano
a mano che ci si avvicina alla fine della prima repubblica. Per il quirinale
come per il paese, l’anno maledetto è il 1992.
Dopo le dimissioni del
presidente Cossiga, la Democrazia cristiana è ancora il partito più numeroso
nonostante il crollo di cinque punti alle elezioni politiche. Quell’anno, ad
aspirare al quirinale sono due personaggi di primo piano: il primo è l’attuale
segretario della Dc, Arnaldo Forlani. Il secondo è Giulio Andreotti, il Divo
giulio come era già soprannominato, ex segretario democristiano e abile
manovratore di franchi tiratori. Entrato in parlamento nel 1946, nell’assemblea
costituente, è stato artefice di cinquant’anni di storia della repubblica e ha
ha giocato una parte nell’elezione di tutti i presidenti della repubblica, da
Luigi Einaudi in poi.
Tra Forlani e Andreotti la
spunta Forlani, che sembra avere l’appoggio dei socialisti guidati da Bettino
Craxi.
Nell’aula del parlamento,
però, mancano all’appello più di cinquanta voti. I franchi tiratori hanno
colpito di nuovo.
Sembra allora arrivato il
tempo di Andreotti, che si mette al lavoro per trovare interlocutori tra i
socialisti. Ma la sua candidatura, mai nemmeno annunciata, muore il 23 maggio
1992.
La strage mafiosa di capaci,
in cui muore il giudice istruttore Giovanni Falcone, invade anche l’assemblea in
seduta comune. La strage viene letta anche come un colpo contro la candidatura
Andreotti. I fatti dicono che gli ex comunisti del Pds chiudono ogni trattativa
e avvertono la Dc: bisogna andare su un nome istituzionale.
E’ così che prende forma la
candidatura del presidente della Camera democristiano, Oscar Luigi Scalfaro.
NILDE IOTTI
L’elezione di Scalfaro, però,
è un passaggio nevralgico nella storia della repubblica anche per un’altra
ragione. E’ il momento in cui una donna va più vicina all’elezione e quella
donna è Leonilde Iotti, detta Nilde, la prima donna e la più longeva presidente
della Camera.
Originaria di Reggio Emilia,
eletta in assemblea costituente con il Pci, è stata deputata ininterrottamente
dal 1948 al 1999. Per tredici anni e tre legislature ha presieduto Montecitorio.
Nella sua lunga carriera
politica, è anche la prima donna a ottenere il mandato esplorativo per
costituire un governo. Glielo assegna nel 1987 il presidente della Repubblica
Francesco Cossiga e fa di lei la prima esponente del partito comunista ad
arrivare vicino alla presidenza del consiglio.
Nel 1992, il nome di Iotti è
nella rosa dei nomi per salire al Quirinale e lei è pronta alla sfida. Eppure
non è lei la candidata ufficiale degli ex comunisti, che scelgono invece il
candidato di bandiera Giorgio Amendola.
Nel IV scrutinio ottenne 256
voti, ancora oggi il più alto numero di consensi ottenuti da una donna nel
collegio elettorale. Oltre non andrà e al ventiseiesimo scrutinio viene eletto
Scalfaro.
Nilde Iotti muore nel 1999 ed
è stata sepolta, come da suo desiderio, nel cimitero del Verano a Roma, nella
tomba del Pci, accanto Palmiro Togliatti, morto trentacinque anni prima.
Iotti è stata si compagna di
vita del segretario del Pci, ma non si è mai fatta oscurare dal Migliore. Anzi,
nonostante le iniziali maldicenze è stata capace di essere orgogliosamente
entrambe le cose: la compagna di togliatti e una dirigente comunista capace di
guadagnarsi spazio in un partito e in parlamento ancora a prevalenza maschile.
Dopo di lei, nessuna donna è
arrivata così in alto nel cursus delle cariche istituzionali, né così vicina
alla presidenza della repubblica. Chissà per quanto il suo primato rimarrà
ineguagliato: speriamo ancora per poco.
Si conclude così il mio
racconto sulla storia, i segreti e le strategie che ruotano intorno al colle più
alto di Roma.
Ogni elezione è stata una
storia politica a se e racchiude un pezzo della nostra Repubblica. Se esiste
però una regola generale, che vale per tutti i presidenti, è quella enunciata da
uno dei grandi sconfitti. Diceva Giulio Andreotti che non c’è nessun metodo che
garantisca la vittoria, ci sono solo errori da non commettere.
GIULIA MERLO. Mi occupo di
giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla
Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato.
Tommaso Labate per il Corriere
della Sera il 13 gennaio 2022.
«Nano maledetto, non sarai mai
eletto», impresso con inchiostro nero su carta intestata bianca del Parlamento
in seduta comune e timbri di autenticità di Camera e Senato. Il messaggio si
materializza per primo davanti agli occhi del presidente dell'Aula di
Montecitorio Sandro Pertini, che sgrana gli occhi.
Il reale destinatario è il
presidente del Senato, che sta seduto al suo fianco. E così, in una fredda
giornata del dicembre 1971, Amintore Fanfani scopre sulla sua pelle quanto può
essere sottile, fino a diventare di fatto inesistente, il confine tra la più
vile delle lettere anonime e la più solenne delle schede, quella che serve a
eleggere il presidente della Repubblica.
«Nulla!», cioè scheda nulla,
gridò Pertini. Ma visto che attorno era pieno di testimoni, la più celebre delle
schede non valide dell'elezione per il Colle - un messaggio rivolto a Fanfani
con tanto di insulti - è rimasta impressa nella memoria collettiva dei cultori
del Palazzo. A distanza di oltre mezzo secolo, il Parlamento si prepara al rito
settennale della scheda pazza, con quelle bizzarrie dialettiche che servono a
«segnare» il voto e a verificare quanto l'accordo su un nome può «reggere»
oppure no. In vista della quarta votazione, se ci si arriverà, tutti coloro che
hanno sottoscritto il patto per «Silvio Berlusconi al Quirinale» misureranno la
tenuta delle truppe attribuendo al soldato di ciascuna divisione un modo diverso
per votare.
Magari sarà «Berlusconi» per
gli elettori di Forza Italia, «Berlusconi Silvio» per i leghisti, «Silvio
Berlusconi» per Fratelli d'Italia e «Berlusconi presidente Silvio» per i
centristi. Ma attenzione. Quest' ultima formula, di fronte a una presidenza -
diciamo così - inflessibile, potrebbe non passare, visto che Berlusconi non
ricopre alcuna carica istituzionale. Durante l'elezione del presidente del
Senato, anno 2006, Oscar Luigi Scalfaro - che presiedeva la seduta in quanto
senatore anziano - annullò i voti «Francesco Marini» semplicemente perché Franco
Marini si chiamava per l'appunto «Franco» e non «Francesco». Per gli amanti del
dettaglio, «Francesco Marini» era la firma degli elettori dell'Udeur di Clemente
Mastella; nella votazione successiva, l'unico «Francesco Marini» fu considerato
voto valido, nonostante anagraficamente non corretto.
Perché all'interno di ogni
elezione del Parlamento, in seduta comune e non, ogni scrutinio fa storia a sé.
Sempre Scalfaro, nel bel mezzo della votazione del presidente della Repubblica
del 1992, fece montare il catafalco che nei primi scrutini non c'era. Un trucco
per facilitare la scrittura dei franchi tiratori? Arnaldo Forlani, che era in
campo, la intese così. E infatti si ritirò. «La presidenza ha sempre margini di
manovra molto ampi durante il voto», ricorda il costituzionalista e deputato pd
Stefano Ceccanti.
Potrebbe, per esempio,
diramare delle prescrizioni sulla modalità di espressione del voto, limitando
alla sola indicazione del cognome, inapplicabile all'epoca di Franco Marini (che
aveva degli omonimi tra i parlamentari); oppure il presidente della Camera, in
sede di spoglio, potrebbe limitarsi a enunciare la preferenza espressa senza
entrare nel dettaglio di com' è stata scritta, mettendo così a rischio ogni
controllo preventivo. Laura Boldrini, sette anni fa, lesse le schede per intero,
«Mattarella», «Sergio Mattarella», «Mattarella esse puntato». E così si è fatto
quasi sempre anche per le schede nulle. «Nani maledetti» esclusi, ovviamente.
Presidenti della
Repubblica: tutti i Capi di Stato dal 1948 a oggi.
Carlo Musilli il 15 Gennaio
2022 su firstonline.info. Da Einaudi a Saragat, da Pertini a Ciampi e
Napolitano: mentre sale l’attesa per l’elezione del tredicesimo presidente
italiano (la procedura inizierà il 24 gennaio), ecco un breve ritratto dei primi
12.
In 74 anni di storia l’Italia
ha avuto 12 presidenti della Repubblica e a breve – il 24 gennaio – parlamentari
e delegati regionali si riuniranno per eleggere il tredicesimo. Prima di
scoprire chi salirà al Colle dopo Sergio Mattarella, volgiamo lo sguardo
all’indietro e ripercorriamo (in sintesi) la strada che ci ha portati fin qui.
Dal primo presidente
provvisorio, De Nicola, al grande economista Einaudi, dal primo democristiano
Gronchi al primo socialdemocratico Saragat, passando per la malattia di Segni. E
ancora Leone, forse il presidente più controverso, Pertini, di sicuro il più
amato, e poi Cossiga “il Picconatore”, per arrivare infine ai nomi più recenti:
Scalfaro, Ciampi, Napolitano (1 e 2). Ecco chi sono stati, fino a oggi, i
presidenti della Repubblica italiana.
1) ENRICO DE NICOLA 1946-1948
Giurista liberale, Enrico De
Nicola fu eletto capo provvisorio dello Stato il 28 giugno 1946 dall’Assemblea
costituente, grazie all’accordo fra democristiani, socialisti e comunisti.
Il primo gennaio 1948 assunse
il titolo di Presidente della Repubblica Italiana, mantenendolo fino al
successivo 12 maggio.
Nella storia del nostro Paese,
De Nicola è stata l’unica persona ad aver ricoperto quattro delle cinque
maggiori cariche dello Stato, avendo ottenuto in carriera anche le presidenze
del Senato, della Camera e della Corte costituzionale.
2) LUIGI EINAUDI 1948-1955
Economista, di estrazione
liberale come il suo predecessore, Luigi Einaudi fu ministro del Bilancio nel
quarto governo De Gasperi (1947-1948), il primo da cui furono estromesse le
sinistre. In quei mesi realizzò una manovra economica durissima, che agì su tre
livelli: inasprimento fiscale, svalutazione della lira e restrizione del
credito. In questo modo furono raggiunti diversi obiettivi – calo
dell’inflazione, recupero della stabilità monetaria, risanamento del bilancio
statale – ma l’operazione ebbe forti costi sociali, soprattutto sul fronte della
disoccupazione.
Dopo l’anno passato al Tesoro,
Einaudi fu eletto Presidente della Repubblica, carica che ricoprì nella prima
fase del centrismo, quando i democristiani governarono con liberali,
repubblicani e socialdemocratici. Furono gli anni della riforma agraria (per
l’esproprio e il frazionamento di una parte delle grandi proprietà terriere),
della Cassa per il Mezzogiorno, della legge Fanfani sul finanziamento delle case
popolari e della riforma Vanoni, che introdusse l’obbligo della dichiarazione
annuale dei redditi.
3) GIOVANNI GRONCHI 1955-1962
Già sottosegretario
all’Industria nel governo Mussolini, Giovanni Gronchi fu ministro
dell’Agricoltura, dell’Industria e del Commercio nei governi Bonomi II, Bonomi
III e De Gasperi I, per poi diventare il primo democristiano a essere eletto
Presidente della Repubblica. In quanto esponente della sinistra Dc, fu sostenuto
da una parte del partito contro le indicazioni della segreteria e ottenne anche
l’appoggio di socialisti e comunisti.
La presidenza Gronchi coincise
quasi perfettamente con gli anni del miracolo economico italiano, fase
culminante del processo di crescita iniziato dopo il 1950. Nello stesso
settennato, però, ebbe luogo anche la crisi prodotta dal governo Tambroni, che –
sostenuto dal Movimento Sociale Italiano – nel 1960 autorizzò i missini a tenere
a Genova il loro congresso nazionale, innescando una serie di rivolte
popolari che causarono una decina di morti. Tambroni si dimise dopo essere stato
sconfessato dalla Dc, che formò un nuovo governo (Fanfani III) grazie
all’astensione del Psi, inaugurando così la stagione del centrosinistra.
4) ANTONIO SEGNI 1962-1964
La presidenza Segni durò
solamente due anni e mezzo e fu la seconda più breve nella storia della
Repubblica dopo quella di De Nicola. Le dimissioni arrivarono il 6 dicembre del
1964 per ragioni di salute: quattro mesi prima, infatti, Segni era stato colpito
da trombosi cerebrale durante una discussione concitata con Saragat e Moro. I
contenuti del colloquio rimasero segreti.
Quell’estate si erano diffuse
voci di un progetto di colpo di Stato (Piano Solo) promosso dal numero uno
dell’Arma dei Carabinieri, il generale De Lorenzo, che era particolarmente
vicino a Segni. Secondo Giorgio Galli e Indro Montanelli, tuttavia, il Capo
dello Stato non puntava a mettere in atto un golpe, ma solo ad agitarne lo
spauracchio a fini politici.
5) GIUSEPPE SARAGAT 1964-1971
Giuseppe Saragat fu il primo
Presidente della Repubblica socialdemocratico e per la sua elezione furono
determinanti i voti dei comunisti. Leader storico del Partito Socialista
Democratico Italiano, prima di salire al Colle Saragat era stato presidente
dell’Assemblea costituente, vicepresidente del Consiglio e ministro degli
Esteri. Il suo settennato si inserì nella cornice del “centrosinistra organico”
(Dc, Pri, Psdi e Psi), conobbe la contestazione giovanile del 1968 e l’autunno
caldo del 1969, ma anche le grandi riforme del 1970: l’istituzione delle
Regioni, il varo dello statuto dei lavoratori e il via libera alla legge sul
divorzio, poi confermata dal referendum del 1974.
Sempre nel 1970 si svolse il
tentativo di colpo di Stato organizzato da Junio Valerio Borghese. Il piano –
annullato dallo stesso Borghese mentre era in esecuzione, per motivi mai
chiariti – prevedeva la cattura e il rapimento di Saragat, operazione da portare
a termine sotto la cura di Licio Gelli, maestro venerabile della Loggia
massonica P2.
6) GIOVANNI LEONE 1971-1978
Dopo aver guidato due governi
monocolore e “balneari” a marca Dc (1963 e 1968), nel 1971 Giovanni Leone fu
eletto al Quirinale da una maggioranza di centrodestra, al termine della
procedura più lunga di sempre (23 scrutini in 15 giorni). La sua presidenza
attraversò in larga parte una delle pagine più buie della storia repubblicana,
quella degli anni di piombo, con gli attentati del 1974 (a Brescia, in Piazza
della Loggia, e sul treno Italicus), la stagione della solidarietà nazionale, il
sequestro e l’uccisione di Aldo Moro.
Accusato di comportamenti
opachi sotto il profilo fiscale e di connivenze con gruppi affaristici (anche se
il suo coinvolgimento nello scandalo Lockheed non fu mai provato), Leone si
dimise nel giugno del 1978, a poco più di sei mesi dalla fine del mandato.
7) SANDRO PERTINI 1978-1985
Antifascista perseguitato dal
Regime e figura di primo piano della Resistenza, a 82 anni l’ex partigiano
Sandro Pertini fu eletto con i voti di tutto l’arco costituzionale. Incassò
l’82,3% delle preferenze, un record ancora imbattuto, e divenne così il primo
socialista a ricoprire la carica di presidente della Repubblica. Il suo mandato
fu caratterizzato da un’impronta personale che gli procurò in poco tempo una
vasta popolarità, tanto che in molti lo ricordano ancora come il “presidente più
amato dagli italiani”.
Diversi i momenti del suo
settennato che hanno lasciato traccia nella memoria collettiva: la commozione
per la strage di Bologna del 2 agosto 1980, l’indignazione per i ritardi dei
soccorsi dopo il terremoto in Irpinia del 23 novembre dello stesso anno, ma
anche l’esultanza al Santiago Bernabeu nel 1982, quando l’Italia sconfisse la
Germania Ovest nella finale dei Mondiali di calcio.
8) FRANCESCO COSSIGA
1985-1992
Il democristiano Francesco
Cossiga fu eletto a larghissima maggioranza nel pieno dell’epoca del
pentapartito (Dc, Pri, Pli, Psi e Psdi), diventando il Capo di Stato più giovane
di sempre (58 anni).
Nel 1991 cambiò
improvvisamente lo stile di comportamento seguito nei primi cinque anni del
mandato e si rese protagonista di una serie di polemiche sia con i partiti
(compresa la Dc) sia con altri organi dello Stato (soprattutto il Consiglio
superiore della magistratura, accusato da Cossiga di arrogarsi poteri che non
gli spettavano). La veemenza delle sue esternazioni gli valse il soprannome di
“Picconatore”. In realtà non si riprese mai dallo shock del rapimento di Aldo
Moro durante la sua gestione del Ministero dell’Interno.
Nel febbraio 1992 sciolse le
Camere con lieve anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Si dimise il
28 aprile di quello stesso anno, due mesi prima della fine del settennato.
9) OSCAR LUIGI SCALFARO
1992-1999
Magistrato, parlamentare dagli
anni dell’Assemblea costituente, Oscar Luigi Scalfaro fu chiamato a
rappresentare la tradizione positiva di una classe politica gravemente
screditata dallo scandalo Tangentopoli, scoppiato alcuni mesi prima. Non solo:
mentre erano in corso le votazioni per il Quirinale, il Paese fu sconvolto dalla
strage di Capaci, in cui perse la vita il magistrato Giovanni Falcone. Meno di
due mesi dopo, la mafia uccise anche Paolo Borsellino. Quello stesso anno
Scalfaro affidò il governo a Giuliano Amato, che evitò la bancarotta dello Stato
con una delle manovre più severe della storia repubblicana (quella del prelievo
forzoso sui conti correnti). Oltre alla nascita della Seconda Repubblica e alla
“discesa in campo” di Silvio Berlusconi, con il quale si scontrò ai tempi del
primo governo dell’ex Cavaliere (1994-1995), Scalfaro vide anche l’ingresso
dell’Italia nell’euro.
10) CARLO AZEGLIO CIAMPI
1999-2006
Il nome più legato alla moneta
unica è però quello di Carlo Azeglio Ciampi, che – dopo essere stato governatore
di Bankitalia dal 79 al 93 e presidente del Consiglio nel 93-94 – fu anche
ministro del Tesoro nel primo governo Prodi. In quella veste firmò la manovra
del 1997, che in un anno abbatté il deficit dal 7 al 2,7% del Pil, permettendo
all’Italia di rispettare i parametri di Maastricht e di entrare così nel gruppo
di testa dei Paesi aderenti all’euro. Ciampi approdò al Quirinale su proposta di
Walter Veltroni e la sua elezione avvenne al primo scrutinio. Da Capo dello
Stato, si oppose all’idea che l’Italia potesse partecipare alla guerra in Iraq
al di fuori di una cornice di cooperazione internazionale: una posizione diversa
da quella del capo del governo, Silvio Berlusconi, favorevole a un’alleanza
totale con gli Usa. In quegli anni, altri motivi di attrito fra il Colle e
Palazzo Chigi furono la legge Gasparri sulle telecomunicazioni e la riforma
dell’ordinamento giudiziario del ministro Castelli, entrambe rinviate da Ciampi
alle Camere.
11) GIORGIO NAPOLITANO
2006-2013 E 2013-2015
Giorgio Napolitano è stato
finora l’unico presidente della Repubblica a ottenere un secondo mandato, che
però è durato meno di due anni. Esponente della corrente “migliorista” del Pci,
nel 1978 fu il primo dirigente comunista italiano a ricevere un visto per andare
negli Stati Uniti. Ha ricoperto gli incarichi di presidente della Camera durante
la crisi del 1992 e di ministro dell’Interno nel primo governo Prodi, quando
promosse una legge per la regolamentazione dei flussi migratori.
Da Capo dello Stato ha
affrontato prima la crisi finanziaria globale del 2008-2009, poi quella del
debito sovrano europeo iniziata nel 2010. Nell’aprile del 2013, alla Camera,
Napolitano rimproverò con voce rotta dall’emozione i parlamentari e i delegati
regionali che non erano stati in grado di scegliere il suo successore.
12) SERGIO MATTARELLA
2015-2022
Fratello di Piersanti,
presidente della Regione siciliana ucciso dalla mafia nel 1980, Sergio
Mattarella ha ricoperto più volte la carica di ministro e, tra il 2011 e il
2015, quella di giudice della Corte costituzionale.
È stato il relatore della
riforma elettorale che, recependo l’esito del referendum del 1993, introdusse il
maggioritario per il 75% dei seggi. La legge, ribattezzata Mattarellum dal
politologo Giovanni Sartori, fu impiegata per le elezioni politiche del 1994,
del 1996 e del 2001. Da Presidente della Repubblica ha nominato una senatrice a
vita: Liliana Segre, superstite di Aushwitz e testimone della Shoah. Carlo
Musilli
DA MERZAGORA A PRODI, I
GRANDI SCONFITTI ILLUSI E CADUTI SOTTO IL TIRO DEI CECCHINI.
Filippo Ceccarelli su La Repubblica l'11 gennaio 2022.
Il vero bello, la grazia
sublime e il fascino segreto delle elezioni presidenziali è che non vi sono
sconfitti, ma sempre Grandi Sconfitti; là dove il racconto e la leggenda della
fatale caduta segnano e insegnano, più che la fine di ogni ambizione, un monito
e una definitiva verità sul potere.
Poco o nulla indagata è la
componente sadica del giornalismo politico, che pure mai come nelle cronache
della corsa per il Quirinale incontra la suspense e l'apprezzamento del
pubblico, pure a sua volta assetato di crolli, disfatte e rovine. Di qui il
goloso compiacimento nel soffermarsi e nel ricordare ogni volta quali, quanti,
come e perché sono stati feriti, poi uccisi e comunque travolti dal contropotere
dei franchi tiratori o “deputati-lupara”, come li chiamava Montanelli.
Ecco dunque, 1948: il Conte
Sforza, che “portava la sua testa come in processione il Santissimo”, che al
momento del congedo viene sorpreso nottetempo a declamare il discorso che non
terrà mai; oppure, 1955, ecco Merzagora, uomo di grande ricchezza e fama, appeso
a una vetrata del Transatlantico, lo sguardo perduto in quel vuoto che nessuno
osava varcare con una parola di conforto. Rispettivamente illusi e mandati allo
sbaraglio da De Gasperi e da Fanfani.
Riconoscerà poi il politico e
banchiere: “Mi feci giocare come un bimbo a mosca cieca”. Là dove, impietosa e
memorabile, la figuraccia va al cuore dell'immaginario nazionale: nel paese dei
furbi, chi perde è due volte che viene fatto fesso; non solo, ma solo in quel
caso si capisce che forse lo è sempre stato, comunque proprio per questo non
meritava di ascendere alla Suprema Magistratura dell'Astuzia.
Così' si comprendono meglio,
1992, gli occhi al cielo di Forlani posto sui carboni ardenti dalle “spinte
dispersive”, preziosa perla politichese per dissimulare “le perduranti
defezioni”, idem, insomma i cecchini, i sicari, i pugnalatori, i massacratori
del Mattatoio Montecitorio. E qualche giorno dopo pare di rivedere su un divano,
col suo bastone, Leo Valiani, insieme esterrefatto e rassegnato dinanzi a quello
che al giovane cronista definì un “vecchietticidio”, mentre nel catafalco veniva
ricomposta la salma della Prima Repubblica. E così via, di sconfitto in
sconfitto, fino alle cicatrici di Prodi per i 110, “che poi erano molti di più”.
In italiano non esiste una
parola per esprimere, come in tedesco “Schaudenfreude”, la gioia malevola per
l'altrui disgrazia. Ma il concetto esiste, eccome, e nell'acquario dei piranha
delle presidenziali ampiamente e di cuore si esercita anche nei confronti dei
vinti di secondo grado, gli aspiranti nascosti che con tutte le loro forze
agognano il Colle, tutti lo sanno, amici e nemici: ma poi nemmeno arrivano al
giudizio dell'aula, bruciati prima della battaglia: Nenni nel 1964, Moro nel
1971, Giolitti e La Malfa nel 1978, Andreotti e Spadolini nel 1992 o D'Alema nel
2006; di quest'ultimo malignamente Cossiga a lungo si divertì a enfatizzare la
“sofferta rinuncia”, a vantaggio di Napolitano, che pure i giovanotti del Pds
avevano anzitempo – ebbene sì: - rottamato.
Tanto più crudele la
soddisfazione quanto più rinomate le figure dei Grandi Sconfitti e vendicativi.
Così nel 1971 Fanfani - “Maledetto nanetto non sarai mai eletto – schiumava di
rabbia, faceva il diavolo a quattro, tempestava di minacce giornalisti ed
editori; così come ancora oggi rimane esemplare nel linguaggio politico “la fine
di Prodi”, e non c'è volta, non c'è intervista in cui non gliela ricordino e
gliela facciano ricordare, mentre pochi rammentano che due o tre giorni prima
quella fine fu preceduta da quell'altra di Franco Marini, che già l'abito da
cerimonia si era fatto confezionare, povero “Scintillone” (vedi il noir di
Concita De Gregorio, Nella notte, Feltrinelli, 2019).
Sin dagli albori della
Repubblica, sui cadaveri dei quirinabili, si registra in effetti un gusto tutto
italiano, quindi teatrale, un feroce miscuglio di commedia e melodramma,
equivoci, lacrime, intrighi e sghignazzi, che rende appetibile la cerimonia
cannibale e sacrificale. Sfrondati gli allori e arrotolate le guide rosse sui
marmi dei palazzi, è qui che meglio il potere si rivela per quello che è: non
solo una spada affilata sulla testa, ma anche una meraviglia quando cala sulla
vittima designata le cui insegne del dominio, ormai inutili, rovinano anch'esse
nella polvere.
Che poi quest'ultima sia la
materia di cui tutti siamo fatti – presidenti eletti, politici trombati,
parlamentari fedeli e omicidi, giornalisti più o meno efferati, spettatori
debitamente rifornitosi di popcorn – è materia narrativa che nel gran rodeo
lascia un po' il tempo che trova. Più ansiogeno e perciò degno di audience quel
misterioso flusso o influsso che si avverte stracco nelle estenuanti votazioni e
concentrato e infernale al momento della resa dei conti. “Nei conclavi le
ambizioni e i calcoli sono strumentalizzati dallo Spirito Santo – fu l'argomento
con cui nel 1964 il cardinal Dell'Acqua cercò di far desistere Fanfani - a
Montecitorio dal diavolo”. Con tale premessa si riattiva il brivido allorché,
nel 2013, Alessandra Mussolini ascese alla maxi tribuna della presidenza
ostentando una t-shirt su cui anche da lontano si poteva leggere: “Il diavolo
veste Prodi”.
A distanza di qualche anno
sarebbe ingiusto pensare che il Signore delle Mosche sia andato in
prepensionamento. Ci faccia un pensierino Berlusconi, che al grande spettacolo
italiano ha già dato più di ogni altro.
LE CLASSIFICHE (fonte:
Quirinale.it)
Quante votazioni sono state
necessarie per eleggere Leone? Su quanti voti ha potuto contare Cossiga? E chi è
stato il presidente più giovane? Ecco alcune curiosità sulle passate elezioni al
Quirinale
DA NORD A SUD. I TORINESI,
I NAPOLETANI E I DUE SASSARESI: DA DOVE VENIVANO I CAPI DELLO STATO
Giuseppe Saragat 1964 - 1971:
nato a Torino
Oscar Luigi Scalfaro 1992 –
1999: nato a Novara
Luigi Einaudi 1948 – 1955:
nato a Cuneo
Carlo Azeglio Ciampi 1999 –
2006: nato a Livorno
Giovanni Gronchi 1955 – 1962:
nato a Pontedera (Pisa)
Sandro Pertini 1978 – 1985:
nato a Stella (Savona)
Enrico Di Nicola 1948: nato a
Napoli
Giorgio Napolitano 2006 –
2013: nato a Napoli
Giovanni Leone 1971 – 1978:
nato a Napoli
Francesco Cossiga 1985 -1992:
nato a Sassari
Antonio Segni 1962 – 1964:
nato a Sassari
Sergio Mattarella 2015 – 2022:
nato a Palermo
57 ANNI IL PIÙ GIOVANE, 88
IL PIÙ ANZIANO: LE ETÀ DEI PRESIDENTI APPENA ELETTI
Giorgio Napolitano 2006 –
2013: nato a Napoli 81 – 88 anni 29 – 06 - 1925
Sandro Pertini 1978 – 1985:
nato a Stella (Savona) 82 anni 25 – 09 - 1896
Carlo Azeglio Ciampi 1999 –
2006: nato a Livorno 79 anni 9 – 12 - 1928
Luigi Einaudi 1948 – 1955:
nato a Cuneo 74 anni 24 – 03 - 1874
Sergio Mattarella 2015 – 2022:
nato a Palermo 74 anni 23 – 07 - 1941
Oscar Luigi Scalfaro 1992 –
1999: nato a Novara 74 anni 9 – 09 - 1918
Antonio Segni 1962 – 1964:
nato a Sassari 71 anni 2 – 2 1891
Enrico Di Nicola 1948: nato a
Napoli 70 anni 9 – 11 - 1877
Giovanni Gronchi 1955 – 1962:
nato a Pontedera (pisa) 68 anni 18 – 09 - 1887
Giuseppe Saragat 1964 - 1971:
nato a Torino 66 anni 19 – 09 - 1898
Giovanni Leone 1971 – 1978:
nato a Napoli 63 anni 3 – 11 -1908
Francesco Cossiga 1985 -1992:
nato a Sassari 57 anni 26-07-1928
DAL PRIMO COLPO AL 23ESIMO
SCRUTINIO: LE SEDUTE NECESSARIE PER ELEGGERE I PRESIDENTI
Enrico Di Nicola 1948: nato a
Napoli 70 anni 9 – 11 – 1877 1
Carlo Azeglio Ciampi 1999 –
2006: nato a Livorno 79 anni 9 – 12 – 1928 1
Francesco Cossiga 1985 -1992:
nato a Sassari 57 anni 26-07-1928 1
Luigi Einaudi 1948 – 1955:
nato a Cuneo 74 anni 24 – 03 – 1874 3
Giovanni Gronchi 1955 – 1962:
nato a Pontedera (pisa) 68 anni 18 – 09 – 1887 3
Giorgio Napolitano 2006 –
2013: nato a Napoli 81 – 88 anni 29 – 06 – 1925 3
Sergio Mattarella 2015 – 2022:
nato a Palermo 74 anni 23 – 07 – 1941 3 - 4
Antonio Segni 1962 – 1964:
nato a Sassari 71 anni 2 – 2 1891 9
Sandro Pertini 1978 – 1985:
nato a Stella (Savona) 82 anni 25 – 09 – 1896 16
Oscar Luigi Scalfaro 1992 –
1999: nato a Novara 74 anni 9 – 09 – 1918 16
Giuseppe Saragat 1964 - 1971:
nato a Torino 66 anni 19 – 09 – 1898 21
Giovanni Leone 1971 – 1978:
nato a Napoli 63 anni 3 – 11 -1908 23
DAL PLEBISCITO ALLA
MAGGIORANZA RISICATA: CON QUANTI VOTI SONO STATI ELETTI I PRESIDENTI
Enrico Di Nicola 1948: nato a
Napoli 70 anni 9 – 11 – 1877 1 94%
Sandro Pertini 1978 – 1985:
nato a Stella (Savona) 82 anni 25 – 09 – 1896 16 83%
Giorgio Napolitano 2006 –
2013: nato a Napoli 81 – 88 anni 29 – 06 – 1925 3 54 - 74%
Francesco Cossiga 1985 -1992:
nato a Sassari 57 anni 26-07-1928 1 76%
Giovanni Gronchi 1955 – 1962:
nato a Pontedera (pisa) 68 anni 18 – 09 – 1887 3 79%
Carlo Azeglio Ciampi 1999 –
2006: nato a Livorno 79 anni 9 – 12 – 1928 1 71%
Giuseppe Saragat 1964 - 1971:
nato a Torino 66 anni 19 – 09 – 1898 21 67%
Oscar Luigi Scalfaro 1992 –
1999: nato a Novara 74 anni 9 – 09 – 1918 16 67%
Sergio Mattarella 2015 – 2022:
nato a Palermo 74 anni 23 – 07 – 1941 3 – 4 66%
Luigi Einaudi 1948 – 1955:
nato a Cuneo 74 anni 24 – 03 – 1874 3 59%
Antonio Segni 1962 – 1964:
nato a Sassari 71 anni 2 – 2 1891 9 52%
Giovanni Leone 1971 – 1978:
nato a Napoli 63 anni 3 – 11 -1908 23 52%
PROGETTO DI Stefano
Cappellini, Annalisa D'Aprile, Paolo Festuccia, Emanuele Lauria, Lavinia Rivara,
Alessio Sgherza, Daniele
Milena Gabanelli, Simona
Ravizza e Alessandro Riggio per il "Corriere della Sera" il 10 gennaio 2022.
Ogni cittadino italiano che ha
compiuto i 50 anni di età e che gode dei diritti civili e politici, e non ha
subìto nessuna interdizione dai pubblici uffici nei cinque anni precedenti, può
essere candidato dai partiti alla Presidenza della Repubblica. Vuol dire che
anche Silvio Berlusconi possiede tutti i requisiti di candidabilità, poiché l'11
maggio 2018 ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza la riabilitazione che
estingue ogni effetto penale della condanna.
Resta semmai un tema di
opportunità, ma in quanto tale non è regolamentata da leggi. Per essere eletto
al primo turno ci vogliono 673 voti, ovvero i due terzi del Parlamento,
integrato da 58 rappresentanti delle Regioni, che in totale fanno 1.009 votanti:
per arrivare a questo numero va coperto con le elezioni suppletive di Roma (in
calendario per il 16 gennaio) il posto alla Camera lasciato libero da Roberto
Gualtieri, neosindaco della Capitale; e l'Aula del Senato deve convalidare il
subentro di Fabio Porta a quello di Adriano Cario, decaduto.
Dal quarto scrutinio in poi
basta la maggioranza, cioè 505 voti, che corrisponde alla metà più uno degli
aventi diritto. In entrambi i casi indipendentemente dal numero di presenti. La
carica dura sette anni, ed è incompatibile con qualsiasi altra.
Nella storia della Repubblica
solo Francesco Cossiga e Carlo Azeglio Ciampi sono stati eletti al primo turno
con il 70% dei voti grazie a precedenti accordi bipartisan. Per il resto, i nomi
dei candidati di bandiera proposti nei primi tre scrutini non sono mai andati a
buon fine (tranne per Antonio Segni). In quattro casi si è arrivati alla quarta
tornata: Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, Giorgio Napolitano e Sergio
Mattarella.
Nelle altre cinque elezioni si
è dovuti ricorrere a 6 votazioni per Napolitano bis, 9 per Antonio Segni, 16 per
Sandro Pertini e Oscar Luigi Scalfaro, 21 per Giuseppe Saragat e 23 per Giovanni
Leone. Gli impallinati dal proprio partito: 46 franchi tiratori hanno impedito
nel 1948 l'elezione di Carlo Sforza, nel 1992 sono stati in 29 ad abbattere
Arnaldo Forlani e in 101 contro Romano Prodi nel 2013. Soltanto Ciampi sale al
Quirinale senza una precedente esperienza alle Camere, ma dopo essere stato
premier e governatore della Banca d'Italia. Nessun leader di partito in carica
al momento del voto è mai stato eletto presidente.
Sono 19 gli articoli della
Costituzione che riguardano il presidente della Repubblica e ne regolamentano i
numerosi poteri. Vediamoli. Nomina: il presidente del Consiglio e i ministri
proposti dal premier; i senatori a vita; cinque giudici costituzionali; i
segretari generali dei ministeri, i prefetti e gli alti gradi militari (anche se
in quest'ultimo caso si tratta solo di ratificare decisioni nate in seno alle
rispettive amministrazioni).
Convoca e scioglie le Camere;
promulga le leggi o le rinvia; comanda le Forze armate; presiede il Csm;
rappresenta l'Italia e l'unità nazionale; ha potere di grazia; manda messaggi al
Parlamento per rimetterlo in riga. Il suo ruolo può essere interpretato in modo
largo o stretto, dipende dalla personalità del singolo e dai partiti: più sono
inconsistenti e più i poteri del presidente si estendono.
Li ripercorriamo con l'aiuto
dei politologi Luca Verzichelli e Francesco Marangoni (Centro interuniversitario
di ricerca sul cambiamento politico dell'Università di Siena) e Alice Cavalieri
(Università di Torino).
I primi tre presidenti della
Repubblica Einaudi, Gronchi e Segni hanno un ruolo sostanzialmente notarile. Con
Pertini e, soprattutto, con Cossiga c'è una fase interventista. Poi inizia
quello che gli esperti definiscono il «pro-attivismo presidenziale».
Ci sono presidenti della
Repubblica che giocano un ruolo da pilota con i «governi del Presidente»,
tenendo in piedi una legislatura o rinviando le elezioni anticipate. Oppure
opponendosi alla nomina di determinati ministri. Scalfaro rinvia le elezioni
anticipate per due volte, sostituendo il governo Amato con quello Ciampi (1993)
e il Berlusconi I con quello Dini (1995): le due legislature vengono poi sciolte
prima del termine. Per Forza Italia il governo Dini è un ribaltone, motivo per
cui il partito minaccia (senza poi dar seguito) la messa in stato di accusa del
capo dello Stato.
Sempre nel Berlusconi I
Scalfaro stoppa anche la nomina a ministro della Giustizia dell'avvocato Cesare
Previti che poi diventa ministro della Difesa. Napolitano allunga la vita del
governo Prodi II rinviandolo con decisione propria il 24 febbraio 2007 alle
Camere per la fiducia, e poi tenta un ulteriore prolungamento della legislatura
con il mandato (fallito) a Marini nel gennaio 2008. Nel novembre 2011, con la
crisi del governo Berlusconi IV, Napolitano pilota il lancio del neosenatore a
vita Mario Monti e lo porta a diventare premier meritandosi l'appellativo di re
Giorgio dall'Economist .
Napolitano mette anche un veto
alla nomina del magistrato Nicola Gratteri a ministro della Giustizia (governo
Renzi), probabilmente considerandolo una personalità troppo autonoma dalla
politica. Mattarella blocca, invece, la nomina di Paolo Savona a ministro
dell'Economia (Conte I) per le sue posizioni critiche nei confronti dell'Ue e
della moneta unica. Infine, sostituisce il Conte II con Mario Draghi.
Il presidente della Repubblica
può scendere in campo con i veti alle leggi e il rinvio motivato al Parlamento
per nuove delibere: Einaudi lo fa 4 volte, Gronchi 3, Segni 8, Leone 1, Cossiga
22, Pertini 7, Scalfaro 6, Ciampi 8, Napolitano e Mattarella una, per un totale
di 61 veti. Ecco i casi più eclatanti. Nel febbraio 1992 Cossiga rinvia al
Parlamento la nuova legge sull'obiezione di coscienza perché a suo avviso è
un'alternativa troppo facile al servizio militare. La legge arriverà solo nel
1998 con Scalfaro.
Nel dicembre del 2003 Ciampi
rinvia alle Camere la legge Gasparri sulle telecomunicazioni e il passaggio al
digitale terrestre, paventando un rischio per il pluralismo dell'informazione. I
rilievi sono in parte raccolti dal governo. Il 6 febbraio 2009 Napolitano si
rifiuta di firmare il decreto destinato a fermare l'interruzione
dell'alimentazione forzata a Eluana Englaro, definendolo incostituzionale,
ponendo così fine alla tragedia umana della ragazza in stato vegetativo da 17
anni.
La legge sul biotestamento
sarà varata nel 2017.
Dei 12 messaggi politici
inviati dai presidenti della Repubblica, alcuni sono particolarmente incisivi.
Nel 1975, in tempi di consociativismo, Leone fa un accorato appello sulla
necessità che il governo si presenti come un organismo omogeneo e coordinato.
Cossiga ne invia sette, cinque
sono dedicati all'indipendenza dei magistrati e alle contraddizioni del pianeta
giustizia. Scalfaro interviene sull'importanza dell'Unità nazionale all'indomani
di un celebre discorso secessionista del leader della Lega Umberto Bossi. Ciampi
preme sulla necessità di pluralismo dell'informazione in piena era Berlusconi.
Napolitano dedica il suo unico messaggio alla situazione invivibile delle
carceri invitando il Parlamento ad agire.
Negli anni ci sono stati
scontri istituzionali anche sulla decisione di concedere la grazia a questo o
quel detenuto. Nel 1991 il ministro della Giustizia Claudio Martelli ha
minacciato il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale dopo
che Cossiga aveva manifestato l'intenzione di graziare il brigatista Renato
Curcio. Cossiga decide di non procedere e Martelli rinuncia al ricorso.
Successivamente è lo stesso
presidente della Repubblica Ciampi a sollevare il conflitto di attribuzione nei
confronti del ministro della Giustizia Roberto Castelli, contrario alla
concessione della grazia a Ovidio Bompressi, condannato in via definitiva a 22
anni di carcere per l'omicidio Calabresi.
Nel maggio 2006 la Consulta dà
ragione a Ciampi: il potere di concedere la grazia spetta al presidente della
Repubblica e il ministro della Giustizia deve solo attestare la regolarità
dell'istruttoria. In sostanza il ruolo del presidente è quello di garante
estremo, per questo la sua nomina non può mai prescindere da un alto grado di
reputazione e indipendenza, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Paolo Conti per il “Corriere
della Sera” l'8 gennaio 2022. In Italia può capitare di ritrovarsi votati per la
Presidenza della Repubblica, con un’espressione passata alla storia del nostro
costume nazionale, “a propria insaputa”. E’ successo nel 2006 al professor
Giuseppe De Rita, storica colonna del Censis ed ex presidente del Cnel.
Professor De Rita, torniamo al
9 maggio 2006, secondo scrutinio di un’elezione che al quarto avrebbe portato,
il 10 maggio, Giorgio Napolitano al Quirinale….
“Si, ricordo benissimo.
Improvvisamente mi ritrovai quel giorno 19 voti. Non c’era alcuna ragione
possibile perché accadesse, non ne sapevo nulla, nessuno mi aveva detto
alcunché, l’ho saputo seguendo lo scrutinio come tutti e domandai in giro cosa
fosse successo”
E’ riuscito a saperlo?
Napolitano era già il candidato dell’Unione e ovviamente dei Democratici di
Sinistra: per votarlo si aspettava il quarto scrutinio, era già deciso….
“Guardi, ho saputo con
precisione che Napolitano, vedendo quei 19 voti che nessuno aveva previsto, si
era arrabbiato con Piero Fassino, il segretario dei Ds. E che Fassino aveva
risposto a Napolitano di non saperne assolutamente niente nemmeno lui e che
avrebbe cercato di capire”.
Lei non apparteneva certo alla
lista di quei voti attribuiti un po’ per sorridere, come i tre voti per Maria
Gabriella di Savoia, la figlia dell’ex re Umberto I. E Fassino cosa scoprì?
“A forza di chiedere, scoprì
di cosa si trattasse: di Clemente Mastella…”
Ai tempi leader dell’Uder.
“Certo. Mastella lo disse con
la massima serenità a Fassino: “ho scelto il nome di De Rita per contare i voti
di cui dispongo in questa partita per il Quirinale, così posso capire il peso
che ho… tutto qui, non vi dovete assolutamente preoccupare”. Clemente Mastella,
che è vivo e vegeto, può sicuramente testimoniare in proposito”
E lei cosa ha pensato sapendo
tutto questo?
“Beh, lo ammetto, è stato un
po’ umiliante per me scoprire di essere stato votato non per meriti ma per
permettere a Mastella e ai suoi di contarsi. Qualsiasi nome sarebbe andato
bene”
Ma lei è non è un nome
qualsiasi…
“Diciamo che per l’elettorato
mastelliano non creavo alcun problema, per procedere a questa conta di votI:
quanti siamo veramente? votiamo De Rita per capirlo!”
Magari, chissà, ci sarà un bis
per lei nel 2022.
“Ma no, è stata una sorta di
congiunzione astrale irripetibile. Piuttosto penso che saranno in tanti, con
questo Parlamento, a immaginare un metodo Mastella. Chi è sicuro dei propri voti
in questo momento?”
Deluso per non essere stato
davvero eletto, magari per caso?
“A ciascuno il proprio
lavoro...”
L’addio al Quirinale. Il
bastone, la canzone e gli abbracci: così saluta un presidente.
Marzio Breda su Il
Corriere della Sera il 15 Gennaio 2022.
Cossiga scelse un pezzo di
Burt Bacharach, Scalfaro fece un commento in latino. Il «no» di Franca Ciampi al
bis del marito Carlo Azeglio.
Quando Luigi Einaudi entrò al
Quirinale, il 12 maggio 1948, disse che nella sua vita sarebbe cambiata solo una
cosa: «Poiché ora dovrò sempre salutare, dovrò passare il bastone dalla mano
destra alla mano sinistra». Sette anni dopo, tornando a Dogliani, il gesto con
cui segnalò che il mestiere di presidente era finito per lui fu di riportare il
bastone nella destra, battendolo energicamente sul suolo «come per dominare uno
stato d’animo che minacciava di commuoverlo fino alle lacrime». Un cedimento che
non voleva permettersi. Fu Alberto Cavallari a raccontare questo dettaglio
sul Corriere. Un piccolo segno e nessuna frase da affidare alla storia. Nulla di
plateale, tranne la dignità. Che era impossibile non cogliere.
Anche il teatro lo insegna:
uscire di scena è un’arte difficile. E lo è ancora di più se si tratta di dare
l’addio a un potere, magari il più alto che la Costituzione preveda. Quello di
chi è inquilino del Colle e, almeno per dovere d’ufficio se non per indole,
dovrebbe sentirsi vincolato a comportamenti misurati come li ebbe Einaudi, che
anche per questo rimane sempre il paradigma del buon capo dello Stato.
I fuochi d’artficio del finale
cossighiano
Per stare ai presidenti degli
ultimi trent’anni, il finale di partita di Francesco Cossiga è incendiato da un
crescendo di effetti speciali. Uno spettacolo politico-mediatico che tramortisce
gli italiani. Visto che il Quirinale è un palazzo chiuso e al quale la stampa è
ammessa soltanto su inviti mirati, anticipa il proprio congedo con una serie di
viaggi. Un “farewell trip”, così lo chiama, con civetteria anglofila, durante il
quale imbarca i giornalisti sui voli dell’aeronautica militare, in modo che
raccolgano — e rilancino — la «profezia della catastrofe» con cui bombarda i
partiti, in particolare il suo, la Dc, che voleva spodestarlo in anticipo. In
tre mesi fa tappa a Washington, Londra, Lisbona, Parigi, Mosca, Zagabria e
Bruxelles, dove parla sempre e unicamente di politica interna. Al momento di
lasciare, Cossiga s’impone il silenzio, incrociando le dita sulla bocca davanti
alle telecamere. Ma resiste pochi giorni. Fuggito in Irlanda come per un esilio,
quando i cronisti lo raggiungono a casa del nostro ambasciatore a Dublino, li
accoglie accendendo un giradischi e proponendo un indovinello: «Parlerò a patto
che indoviniate il titolo di questo brano di Burt Bacharach».
Come un attore shakespeariano
È facile azzeccare le note
di Raindrops keep falling on my head e innescare così, in un sottofondo di
fasulla allegria, nuove picconate. «Forza, fatemi domande, dico tutto», ripete,
ed è l’immagine della disperazione. Ha un crollo nervoso e intanto rilancia
anatemi sui leader della partitocrazia che «non hanno capito niente» e saranno
«presi a pietrate per le strade». Ricorda la tragedia di Moro (e sua), piange e
si colpisce la bocca con il pugno fino a farla sanguinare. Infine, lascia la
stanza come un attore shakespeariano. Il clima irlandese è troppo deprimente,
per lui. Non passa neppure una settimana e si sposta in Costa Azzurra, ospite
nella villa del segretario liberale Renato Altissimo. Alcuni quirinalisti
suonano il campanello, ingolositi all’idea di seguire assieme a lui in tv il
voto della Camera per il suo successore. Stavolta non li riceve.
Poco male, perché recuperano
un’esternazione per interposta persona: un ristoratore napoletano di Cap Ferrat
al quale il presidente ha consegnato aspri giudizi sui «capipartito mariuoli»
messi sotto inchiesta dai magistrati di Milano. E all’oste raccomanda: «Mi
chiami professore, con la politica ho chiuso». Una bugia. Infatti, di quella
passione non si libererà mai e lo dimostra dopo pochi anni l’iniziativa di
fondare una nuova formazione parlamentare, l’Udr, per consentire la nascita del
governo D’Alema ed essere ancora un jolly risolutivo. Altro che serena
quiescenza da «emerito». Per Cossiga, diventare un ex qualsiasi dopo essere
stato il numero uno, è insopportabile. E, a parte la patologia bipolare che lo
tiene in bilico tra euforie e cupezze, a spingere il suo ondivago protagonismo
in quel passaggio politico c’è la speranza di essere rieletto.
Nessuno chiese a Scalfaro
«mane nobiscum»
È quello che capita pure
a Oscar Luigi Scalfaro, negli ultimi mesi sul Colle, mentre l’ennesima
commissione bicamerale tenta di cambiare la Carta costituzionale prevedendo, tra
l’altro, l’elezione diretta del capo dello Stato. Lui non si dichiara contrario
e sono in parecchi — come oggi con Mattarella — a ipotizzare di prolungargli il
mandato «per un altro po’ di tempo». Il Pds adduce «esigenze di continuità», in
attesa che le norme siano perfezionate e varate. E perfino il sempre ostile
Berlusconi concede che il bis «non sarebbe un dramma né un problema». Quando la
riforma naufragherà, Scalfaro usa una visita in Cina per filosofeggiare sul
tema, evocando l’espressione chiave della parabola evangelica dei discepoli di
Emmaus: advesperascit. Insomma, scende la sera sul suo incarico e nessuno più
gli chiede mane nobiscum, resta con noi. «Meglio così», sbotta agrodolce. «Ogni
giorno che passa è uno di meno da trascorrere lì». Bada molto a contenersi in
una sfera riservata, il presidente, quando abbandona il Quirinale. Tuttavia,
anch’egli rifiuta il pensionamento. Si fa sentire spesso in Senato e nelle
piazze, perché lo scelgono per coordinare le forze politiche e sociali che si
oppongono al «capovolgimento della nostra Costituzione». Cioè la nuova riforma,
proposta da Berlusconi nel suo terzo governo. Alla vigilia del referendum che la
boccerà, Scalfaro diventa un idolo dei girotondini, ai quali confessa: «Tra voi
ritrovo gli ideali della giovinezza», e aveva quasi novant’anni.
La moglie di Ciampi: non
potete pretendere altro
Un viaggio dentro se stesso,
tra il presente e la memoria remota, è anche quello di Carlo Azeglio Ciampi nel
periodo in cui si prepara a far ritorno a casa. Ma senza crisi d’identità e
senza residue ambizioni. A chi lo incita ad accettare una rielezione (pure a lui
tocca questa lusinga), la moglie Franca sillaba, rovesciandone il significato, i
versi di Orazio: «Dulce et decorum est pro patria mori». Come a dire basta, dopo
47 anni a Bankitalia e sette sul Colle, senza contare quelli da premier e
ministro, non si può pretendere altro da lui. «Volete farlo morire?». L’ex
banchiere ed ex presidente cambia vita con umiltà. Accetta la condizione di
semianonimato, senza mostrare un visibile senso di perdita. Non rincorre gli
omaggi che vengono offerti alle glorie nazionali. Soffre di vecchi guai e anche
di Parkinson, quindi si muove pochissimo. Mette in ordine i propri diari.
Incontra gli amici e chi gli parla scopre che il suo carisma non si è appannato.
Solo l’umore è virato in una cifra di avvilita malinconia, per la deriva presa
dall’Italia. Guarda caso, uno dei suoi ultimi libri s’intitola Non è il Paese
che sognavo.
Napolitano obbligato a due
diversi addii
Un po’ diversa la sorte
di Giorgio Napolitano, obbligato a due diversi addii al Colle, essendo l’unico
capo dello Stato rieletto nella storia repubblicana. Almeno finora. Per lui, che
ha fama di essere freddo e saper governare le passioni («sono un atarassico»,
conferma), il giorno dei saluti coincide con un inaspettato disgelo dei
sentimenti. «Ho sorriso poco, mi dispiace», si scusa con i consiglieri,
lasciandoli sbigottiti con abbracci e baci che non si era mai permesso. Qualcuno
suggerisce il concetto di “grazia di Stato” per spiegare il senso
di compostezza, autocontrollo e mediazione che assume colui che ricopre un
incarico come quello presidenziale. Atteggiamenti che sono l’esatto contrario di
certe melodrammatiche e sgangherate “ubriacature” in cui il potere può sfociare.
Napolitano queste doti le possiede naturalmente, quasi per via ereditaria, anche
se non escludono scatti caratteriali. Perciò, quando molla definitivamente la
carica, non fa nulla di pirotecnico. Si limita a prendere possesso dello studio
da senatore a vita a Palazzo Giustiniani, dove si reca ogni mattina, lavorando
ai dossier che gli stanno più a cuore: la politica italiana e le riforme, oltre
alla rotta dell’Unione europea. C’è da scommettere che altrettanto farà Sergio
Mattarella dal prossimo 3 febbraio.
30 anni fa l’addio di
Cossiga al Quirinale: “Mi dimetto per servire la Repubblica”.
Redazione CdG 1947 su Il
Corriere del Giorno il 24 Aprile 2022.
Non a caso di lì a breve si
parlerà di "picconate" e di "picconatore" per descrivere gli interventi del
Presidente della Repubblica, proprio per i suoi toni forti, nella forma e nella
sostanza, che in certi casi diventano accorati, tanta è la volontà di far capire
che nuovi assetti politico-istituzionali debbono sostituire quelli che per oltre
40 anni si sono fondati sugli equilibri prodottisi dopo la fine della seconda
guerra mondiale
Sono le 18.38 del 25 aprile
del 1992 e Francesco Cossiga, rivolgendosi a “cittadine e cittadini di questo
meraviglioso Paese”, con un discorso televisivo a rete unificate che durerà
complessivamente 45 minuti, annuncia la scelta di lasciare il Quirinale, in
anticipo rispetto alla scadenza naturale fissata per il successivo 3 luglio: “Ho
preso la decisione di dimettermi da Presidente della Repubblica, spero che tutti
lo consideriate un gesto onesto, di servizio alla Repubblica“.
È il momento culminante di due
anni che hanno visto il Capo dello Stato uscire dal suo tradizionale riserbo che
aveva caratterizzato i primi cinque del mandato e rendersi protagonista di una
serie di esternazioni, per spingere la classe politica ad attuare riforme
radicali non più rinviabili, dopo i cambiamenti epocali verificatisi alla fine
degli anni Ottanta, a partire dalla caduta del Muro di Berlino.
Assegnare l’ultimo periodo del
suo mandato è il “caso Gladio”: nel 1990 Cossiga rivendica con orgoglio di aver
organizzato negli anni ‘60 la struttura paramilitare “Gladio“, facente parte
della rete “Stay Behind” varata dalla Nato. Si trattava di un’organizzazione
clandestina pensata per salvaguardare la sicurezza nazionale da possibili
attacchi ma soprattutto dalla presa di potere della sinistra.
“Talvolta ho gridato ma se ho
gridato è perchè soltanto temevo di non farmi sentire” ricordava Cossiga nel suo
messaggio agli italiani. Non a caso di lì a breve si parlerà di “picconate” e di
“picconatore” per descrivere gli interventi del Presidente della Repubblica,
proprio per i suoi toni forti, nella forma e nella sostanza, che in certi casi
diventano accorati, tanta è la volontà di far capire che nuovi assetti
politico-istituzionali debbono sostituire quelli che per oltre 40 anni si sono
fondati sugli equilibri prodottisi dopo la fine della seconda guerra mondiale.
“Dalle elezioni aprile 1992
conferma forte domanda cambiamento”
“Superata una serie di
ostacoli, interni ed internazionali, che avevano fortemente caratterizzato e
condizionato, nei decenni trascorsi, il funzionamento del sistema italiano, si è
giunti ad una fase della nostra vicenda – ad esempio Cossiga aveva scritto nel
suo messaggio sulle riforme istituzionali inviato il 26 giugno del 1991 alle
Camere – che al Capo dello Stato appare particolarmente propizia per coagulare
intorno alla questione delle riforme un vasto e costruttivo consenso, un vero e
proprio nuovo patto nazionale che permetta di raccogliere, attraverso una
profonda trasformazione del modo di fare politica del nostro Paese, la richiesta
di cambiamento che sale dalla società civile“.
Una domanda, ribadirà il
Presidente nel suo discorso del 25 aprile del 1992, confermata dai risultati
delle elezioni svoltesi il 4 e il 5 aprile di quello stesso anno: Democrazia
cristiana e Partito comunista, “simbolo di un tipo di società politica, sono
stati fortemente penalizzati con il voto e con questo voto credo si sia voluto
aprire uno spazio al rinnovamento del nostro sistema politico. Le elezioni hanno
posto una forte domanda di governo, di cambiamento e di riforme“.
Da qui un’analisi spietata
sulla situazione del Paese, con “gravi ed importanti problemi da affrontare e da
risolvere: i nostri appuntamenti con l’Europa, perché Maastricht non è soltanto
il nome di una bella cittadina dei Paesi Bassi, non è solo il nome di un
Trattato, Maastricht non è qualcosa che noi abbiamo raggiunto, un risultato che
noi abbiamo conseguito, è un obiettivo che dobbiamo guadagnare e che non è
facile guadagnare, non un esame superato, un esame solo rimandato e che ci sarà
fatto secondo prove sicure e prove difficili”.
“Chiare resistenze a cambiare
e tentazioni forti di conservazione”
Cossiga elenca poi la
necessità di “evitare il disastro della finanza pubblica, la tutela del
risparmio, anche nelle forme del debito pubblico che sono la ricchezza, certo
anche delle banche, ma sono soprattutto la ricchezza dei poveri, dei piccoli, di
voi che avete fiducia nello Stato e poco sapete di azioni e di obbligazioni. Il
rilancio della produzione interna e sui mercati internazionali, difendere
l’occupazione, promuoverla, il risanamento dei servizi pubblici, la guerra dura
ma intransigente alla criminalità organizzata, con la vittoria definitiva,
perché il diritto sconfigga la mala società“.
Questioni che
rendono “necessario e urgente risolvere la crisi di governo, chiamare i partiti
alla loro responsabilità, promuovere la formazione di un Governo che impegni il
Parlamento sulle cose serie”. Esigenze che si scontrano, denuncia Cossiga, con
“chiare resistenze a cambiare, tentazioni forti di conservazione, incertezze
gravi nelle forze politiche, incognite sulla probabilità di formare in
Parlamento maggioranze vere, omogenee, responsabili, soprattutto se le se
ricerchi con i vecchi sistemi: con le armate Brancaleone si possono anche
eleggere oneste persone, persone capaci, persone per bene, ma non si governa il
Paese e soprattutto non si può cambiare“.
Ma c’è soprattutto una
contingenza istituzionale che preoccupava il Capo dello Stato: “per promuovere
la formazione di un Governo nuovo e forte -spiega- occorre un Presidente forte,
occorre un Presidente forte politicamente e forte istituzionalmente. Ed allora
io non è che abbia il diritto, ho il dovere di pormi davanti a voi, e pongo alla
mia coscienza, se voglio essere fedele al giuramento che ho prestato sette anni
fa, un interrogativo: posso essere io questo Presidente?”.
“Per risolvere crisi governo
c’è bisogno di un nuovo Presidente forte’
“Il mio mandato scade il 3
luglio, dal 3 giugno il presidente della Camera può convocare il Parlamento in
seduta comune per l’elezione del mio successore, dal 3 giugno o almeno dal
giorno in cui il presidente della Camera convocherà il Parlamento, un elementare
dovere di correttezza mi imporrebbe di astenermi da ogni attività di rilievo
politico e istituzionale“.
Quindi, sottolinea
Cossiga, “io non sono un Presidente forte” e “ho un dovere, quello di permettere
che venga qui un Presidente forte, che sia almeno forte perché eletto dal nuovo
Parlamento. E quindi la mia scelta dovrebbe essere quella per le mie dimissioni
anticipate e per permettere al nuovo Parlamento di dare al Paese un Presidente
che forte per la sua elezione e per l’ampiezza temporale e di contenuti del suo
mandato, possa affrontare questa grave crisi politica e istituzionale e
promuovere la formazione di quel Governo che voi con il vostro voto avete
voluto”.
“Allora ho preso la decisione
di dimettermi da Presidente della Repubblica. – questo l’annuncio
di Cossiga – C’è chi approverà il mio gesto, c’è chi questo gesto non approverà.
Spero che tutti lo consideriate un gesto onesto, di servizio alla Repubblica“.
L’addio al Quirinale, “per assicurare un ordinato trapasso di poteri” avverrà
formalmente il 28 aprile successivo con la firma dell”atto di dimissioni”.
“Giovani amate la Patria,
siamo un Paese con grandi energie”
Commosso fino alle lacrime e
costretto a bere per stemperare la tensione, il Capo dello Stato quando si
rivolge ai giovani, ai quali “voglio dire di amare la Patria, di onorare la
Nazione, di servire la Repubblica, di credere nella libertà e di credere nel
nostro Paese“. Quindi un ultimo accorato appello: “questo è un Paese che non
sarà una grande potenza politica, che non sarà una grande potenza militare,
forse questa è una benedizione di Dio, ma che è un Paese di grande cultura, di
grande storia, è un Paese di immense energie morali, civili, religiose e
materiali“
“Si tratta di saperle mettere
assieme e si tratta di fondare delle istituzioni che facciano sì che lo sforzo
di ognuno vada a vantaggio di tutti. Che Dio protegga l’Italia, viva l’Italia,
viva la Repubblica”.
Francesco Cossiga ci ha
lasciato nel 2010, a venticinque anni dalla sua elezione a Presidente. E
continuiamo a non dimenticarlo. Redazione CdG 1947
Un presidente molto
discusso. Il 17 agosto 2010 la morte di Cossiga.
Annabella De Robertis il 18
Agosto 2022 su La Gazzetta del Mezzogiorno.
«Addio a Cossiga, il
picconatore»: così «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 18 agosto 2010 annuncia la
scomparsa dell’ottavo presidente della Repubblica italiana. Nato a Sassari nel
1928, cugino di Enrico Berlinguer, fu deputato e senatore della Democrazia
Cristiana. Ricoprì le cariche di ministro, presidente del Consiglio dei ministri
e presidente del Senato: nel 1985 venne eletto capo dello Stato, succedendo a
Sandro Pertini. «Cossiga ha lasciato quattro lettere destinate al presidente
della Repubblica Napolitano, ai presidenti delle Camere e al presidente del
Consiglio», si legge sul quotidiano. «Non lettere personali, quanto un
testamento politico consegnato alle istituzioni, per chiedere tra l’altro che i
funerali si svolgano in forma privata. Giallo su quella indirizzata a Silvio
Berlusconi: il premier non ne ha autorizzato la divulgazione. Il contenuto
ricalcherebbe quella inviata a Schifani, se non per qualche dettaglio relativo
alle ultime volontà.
«Due» Cossiga hanno
attraversato la storia del Paese. Il primo si è occupato di servizi segreti ed è
stato tra i propugnatori di Gladio, la rete militare segreta legata alla Nato e
destinata a guidare forme di resistenza armata in caso di invasione di una
potenza comunista. Ministro degli Interni durante la tragica vicenda Moro,
combatté il terrorismo negli anni di piombo. I militanti del movimento
studentesco scrivevano negli anni ‘70 il suo nome sui muri con il «K» e le due
«s» runiche dei nazisti. Un secondo Cossiga prese il sopravvento negli ultimi
due anni al Quirinale e da allora divenne «un implacabile fustigatore del quieto
vivere politico». Era il 1990, infatti, quando Cossiga, fino ad allora potente
ma silenzioso uomo politico, si trasformò di punto in bianco nel «picconatore».
«Intendo togliermi qualche
sassolino dalla scarpa», fu la frase-manifesto con cui annunciò il cambio di
passo. I suoi bersagli furono la Corte costituzionale, il Csm, i democristiani,
i comunisti, il sistema istituzionale, i magistrati. Per la vicenda Gladio fu
messo in stato d’accusa su proposta del Partito democratico della sinistra,
unico capo di Stato a dover affrontare la richiesta di impeachment nella storia
dell’Italia repubblicana: autodenunciatosi alla magistratura ordinaria, fu poi
prosciolto nel 1994. Intanto, nel 1992 aveva rassegnato le dimissioni con un
lieve anticipo sulla scadenza naturale del settennato.
Dopo alcuni anni fuori dalle
vicende partitiche, nel 1998 promosse la costituzione dell’Unione democratica
per la repubblica (Udr), formazione autonoma di centro sorta con l’obiettivo di
aggregare una vasta area di forze moderate, con cui sostenne il primo governo
D’Alema.
"Quando Cossiga telefonava
dal Quirinale alle sei del mattino".
Paolo Armaroli l'8 Gennaio
2022 su Il Giornale. Enrico Mattei sosteneva che la storia d'Italia poteva
apparire noiosa ma le storielle d'Italia sono chicche imperdibili. Enrico Mattei
sosteneva che la storia d'Italia poteva apparire noiosa ma le storielle d'Italia
sono chicche imperdibili. Il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda
ha avuto dimestichezza con gli ultimi cinque presidenti della Repubblica. E nel
libro Capi senza Stato (Marsilio, pp. 223, 18 euro), tanto per fare il paio con
i capi senza partito, ne racconta davvero di belle. Dopo tutto, i primi
cittadini della Repubblica non differiscono dagli uomini politici che si muovono
a valle. Come le banche, non ce ne voglia Antonio Patuelli, ti offrono
l'ombrello quando il sole spacca le pietre e immancabilmente te lo tolgono
quando piove a catinelle.
La cornice di Breda è
inappuntabile. Valgano le citazioni di Carlo Esposito di Giuseppe Ugo Rescigno e
di altri ancora. Spiega perché la fisarmonica del Quirinale, secondo
l'indovinata metafora di Giuliano Amato, si restringe o si allarga.
Ma a ingolosire sono
soprattutto i retroscena e le storielle raccontati da par suo da Breda.
Imperdibile la telefonata di Cossiga alle 6 del mattino. Vuole sapere se il
Corriere ha montato a regola d'arte l'intervista che Breda gli aveva fatto il
giorno prima. Ma a quell'ora Breda non ha ancora sotto mano il giornale. Signore
com'è, non lo manda al diavolo. S'infila le pantofole, si mette qualcosa
indosso, va nello studio, accende il computer e legge le sue domande e le
risposte del Picconatore. Che, soddisfatto, si frega le mani. Un modo come un
altro per dargli un bel trenta e lode. Una medaglia.
Oscar Luigi Scalfaro ne fa una
grossa. Per non comparire di persona, incarica il fedele Tanino Scelta di
informare la direzione del Corriere che Breda non è gradito perché ha avuto la
colpa di «coprire» il settennato di Cossiga. E il direttore, onore al merito, fa
spallucce. Scalfaro, da uomo del Parlamento si trasforma in un presidenzialista
senza se e senza ma, al punto di sciogliere le Camere nel 1994 motu proprio.
Cose da far rizzare i capelli.
Carlo Azeglio Ciampi è sì un
«pacificatore nazionale» ma è percepito anche come «presidente di opposizione».
Di Napolitano, è Breda a sottolinearlo, ce ne sono ben due. L'uno dice e l'altro
si contraddice. Su tutto: sull'invasione dell'Ungheria, sulle foibe, sulla
contestazione giovanile, perfino sulla Resistenza. Della quale non nasconde le
zone d'ombra. Nella nomina dei senatori a vita non ha la mano felice. Implorato
per il bis, nel suo messaggio d'insediamento del 2013 più fustiga i suoi
elettori e più costoro si spellano le mani per gli applausi. Una seduta
sadomasochistica. Una presidenza in chiaroscuro.
Dulcis in fundo, Mattarella.
Del dodicesimo presidente Breda scrive: «Ha tenuto a battesimo governi fondati
su maggioranze fragilissime e di opposto segno, gialloverdi e giallorosse, pur
di assicurare la tenuta di un paese entrato anche in una crisi di
rappresentanza». Né manca qualche pennellata sui predecessori. Per esempio su
Giovanni Gronchi, al quale il Quirinale sta stretto e si sente un leone in
gabbia. Quella gabbia della presidenza di Montecitorio nella quale Alcide De
Gasperi lo aveva rinchiuso nel 1948 perché lo considerava una fastidiosa mosca
tze-tze. Ma lui la utilizzò come pedana di lancio per il Colle. Paolo Armaroli
Come è diventato presidente
della Repubblica Giuseppe Saragat, sgattaiolato tra i big nel furioso 1964.
David
Romoli su Il Riformista il 5 Gennaio 2022. Con questo articolo iniziamo un breve
racconto di alcune delle elezioni presidenziali più complesse o combattute della
storia della Repubblica.
Quando il 16 dicembre 1964,
appena due anni e mezzo dopo l’elezione del precedente capo dello Stato, le
Camere si riunirono per eleggere il quinto presidente della Repubblica, tutti
sapevano che, chiunque fosse stato, l’eletto avrebbe avuto il compito di
agevolare con vera convinzione la marcia della neonata formula del
centrosinistra: l’alleanza appena pochi anni prima neppure immaginabile tra
il Psi e la Dc. L’alchimia bizzarra tentata due anni prima dalla stessa Dc,
eleggendo al Quirinale un rappresentante della sua ala di destra ostile a
quell’esperimento politico per “controbilanciarlo”, si era dimostrata un
pericoloso disastro, anche se gli italiani ne erano ancora all’oscuro. Come
erano all’oscuro della drammaticità degli eventi che si erano conclusi, il 7
agosto , con la trombosi cerebrale che aveva colpito il presidente in
carica, Antonio Segni.
Solo anni dopo gli italiani
avrebbero saputo che nel luglio 1964 il capo dello Stato appoggiato da altissimi
esponenti dell’arma dei carabinieri avevano minacciato un colpo di Stato, non è
mai stato chiarito se con l’intenzione di tentarlo davvero o, come è più
probabile, solo con quella di condizionare pesantemente le scelte del governo di
centrosinistra. Non è e non sarà invece mai noto nei dettagli cosa avvenne nel
corso del tempestoso colloquio al Quirinale del 7 agosto tra Segni, il
presidente del consiglio Moro e il ministro degli Esteri e segretario del Psdi,
Partito Socialdemocratico Italiano, Giuseppe Saragat. Di certo avevano parlato
di quella manovra golpista, il Piano Solo. Di certo i toni si erano alzati di
parecchi decibel. I due esponenti di governo, secondo la sola ricostruzione del
colloquio esistente, quella a propria volta de relato del direttore generale
della Rai di allora Ettore Bernabei, avevano minacciato di denunciare il
presidente per aver attentato alla Costituzione.
Di fatto, nel corso del
concitato colloquio, Segni stramazzò colpito da trombosi. Fu subito chiaro che
non si sarebbe ripreso ma le forze politiche decisero di nascondere l’
“impedimento permanente” che avrebbe reso obbligatoria l’immediata nomina di un
nuovo presidente. Per darsi tempo di trattare sulla successione scelsero la
formula dell’“impedimento temporaneo”. Le funzioni presidenziali furono assunte
dal presidente del Senato Cesare Merzagora fino a che, il 6 dicembre, non
arrivarono le “dimissioni volontarie” di Segni. Nel dicembre 1964 era chiaro che
il nuovo presidente avrebbe dovuto essere politicamente collocato all’opposto di
Segni: un garante del centrosinistra e dunque, quasi certamente, un socialista
come il segretario del Psi Nenni o un socialdemocratico come Saragat. Torinese,
66 anni, socialista negli anni ‘20, antifascista ed esule in Francia dal 1926 al
1943, dirigente della Resistenza, Saragat era andato a un passo dal Colle già
nel 1962. Partito come “candidato di bandiera” aveva ottenuto i voti
del Psi dalla seconda votazione e quelli del Pci dalla terza. Per spuntarla
Segni aveva dovuto chiedere e ottenere i voti dell’estrema destra monarchica e
neofascista.
Il sostegno del Psi e
del Pci chiudeva la ferita apertasi nel 1948, quando Saragat, atlantista e
anticomunista convinto, aveva capeggiato la scissione del Psi di palazzo
Barberini e poi aveva schierato la sua neonata formazione, che all’inizio si
chiamava Psli, Partito socialista dei lavoratori italiani, contro il Fronte
popolare nelle storiche elezioni del 1948. Nell’aula della Camera il
comunista Giancarlo Pajetta non aveva usato mezzi termini, lo aveva apostrofato
direttamente nel suo intervento dopo l’attentato a Togliatti (luglio 1948): “Tu,
traditore del socialismo, tu, traditore”. Saragat però non aveva mai perso di
vista l’obiettivo della riunificazione socialista, che si realizzò
effettivamente nel corso della sua presidenza della Repubblica, con la nascita
del Psu, Partito socialista unificato, nel 1966. Successo effimero: appena 3
anni dopo i due partiti si divisero di nuovo.
I socialisti, in quel dicembre
del 64, aprirono la corsa al Colle candidando proprio Saragat, mentre
la Dc puntava nella fase iniziale su Leone e il Pci su Terracini. Saragat,
sapendo di non avere in quel momento possibilità reali, restò però defilato in
attesa che si consumasse lo scontro interno nella Dc. Fanfani, che nel ‘63 aveva
guidato un governo “anticamera” del centrosinistra, scese infatti in campo, i
suoi consensi aumentarono progressivamente di votazione in votazione erodendo
quelli di Leone. Era anche lui uno dei principali registi del centrosinistra,
aveva guidato nel ‘63 il governo che doveva aprire la strada a quella formula e
che si rivelò a conti fatti molto più ardito e riformatore dei successivi
esecutivi appoggiati dal Psi. Ma la sua linea, in politica estera, si collocava
all’estremo opposto di quella del leader socialdemocratico. Saragat era il
rappresentate dell’ala più atlantista del centro italiano. Fanfani era un
autonomista che sosteneva la politica energetica e filo araba indirizzata sino
alla sua morte, due anni prima, da Enrico Mattei.
I partiti della sinistra,
però, non volevano che la presidenza andasse di nuovo a un Dc, diffidavano della
tendenza a centralizzare e del carattere autoritario di Fanfani. Al decimo
scrutinio, quando era ormai chiaro che la battaglia sarebbe stata di inaudita
(fino a quel momento) lunghezza, il Psi candidò Nenni. Alla tredicesima
votazione Pci e Psdi fecero convergere i loro voti sul leader socialista.
Arrivati al quindicesimo scrutinio la Dc, estenuata, ritirò Leone e dopo altre
tre votazioni a vuoto accettò di votare per Saragat. Pci e Psi puntarono i
piedi. Insistettero su Nenni. Persino il Pci, in quella circostanza si divise,
per la prima volta dopo la morte di Togliatti, avvenuta in agosto, pochi giorni
dopo la trombosi di Segni. L’ala sinistra del Pci, cioè Ingrao, preferiva
Fanfani. L’ala riformista (ma all’epoca certo non poteva chiamarsi così),
cioè Amendola e Napolitano stava con Saragat.
La battaglia del Colle più
dura nella storia repubblicana sino a quel momento lacerava così sia il nascente
centrosinistra che l’area socialista. Nenni sbloccò la situazione dopo la
ventesima prova fallita, ritirandosi e invitando il Psi a votare Saragat che fu
eletto il 28 dicembre, con 646 voti su 963, alla ventunesima votazione. Il
record fu superato sette anni dopo, con l’elezione del successore di Saragat, ma
quella del 1964 resta a tutt’oggi la seconda elezione più combattuta nella
storia della Repubblica. L’esito della presidenza Saragat però non fu affatto
all’altezza della tensione con cui era cominciata. Il centrosinistra
di Moro navigò sotto costa facendo pochissimo. Il dualismo in politica estera
proseguì, con Fanfani ministro degli Esteri. Negli anni delle bombe e del
maggior conflitto sociale nell’occidente post-bellico, il presidente
socialdemocratico fu scialbo e poco consistente. Molto rumore per (quasi) nulla.
David Romoli
Storia delle presidenziali.
Come fu eletto presidente Giovanni Leone, che sconfisse Moro coi voti fascisti.
David
Romoli su Il Riformista il 9 Gennaio 2022.
Furono le elezioni della
grande guerra interna alla Dc, la sagra dei franchi tiratori scudocrociati.
Toccarono il record a tutt’oggi insuperato di 23 votazioni necessarie per
eleggere il sesto presidente della Repubblica italiana. Elezione di strettissima
misura, arrivata il 24 dicembre quando le tavole erano quasi già apparecchiate
per il cenone. Sulla carta doveva trattarsi di una partita facile. Dopo i 7 anni
passati sul Colle dal socialdemocratico Saragat il posto spettava di diritto,
sia pur diritto informale, alla Dc e tutte le correnti sostenevano ufficialmente
la candidatura del presidente del Senato Amintore Fanfani, il “cavallo di razza”
della balena bianca alla pari di Aldo Moro.
Accentratore come pochi,
dinamico come nessuno, l’ex presidente del Consiglio, ex segretario della Dc, ex
ministro degli Esteri (tutto insieme, mica una carica per volta come usa e
usava…) al Quirinale teneva moltissimo. L’handicap era l’ostilità ferrea
del Pci e del Psi e a segnalargli il problemino fu il leader Dc che meno lo
amava, Giulio Andreotti. Era implicitamente l’ “amichevole” consiglio di
ritirarsi per evitare la mazzata. Va da sé che nei decenni successivi Andreotti
avrebbe poi sempre negato di aver organizzato la fronda democristiana destinata
a rendere la sua fosca profezia realtà. Fanfani, battagliero, al passo indietro
non ci pensò per niente. Le danze si aprirono il 9 dicembre 1971. Gli
scricchiolii, nelle truppe dello scudo crociato, era tanto forti che il
segretario Forlani commentò subito: “Se passa è un miracolo”. Non ci furono
miracoli. Alla prima votazione il candidato della sinistra, il socialista De
Martino, superò il cavallo di razza con 397 voti contro 384. Alla seconda
votazione andò anche peggio. De Martino migliorò di un voto la posizione di
testa, Fanfani perse altri 18 voti.
A voler fucilare
l’ingombrante Amintore sono i franchi tiratori democristiani. Forlani lo sa e
con il suo vicesegretario Gullotti si inventa un escamotage ai confini del
dettato costituzionale. I rappresentanti delle varie correnti si scambieranno le
schede, dopo aver votato ma prima di deporle nell’urna, con i colleghi delle
altri correnti. Minuetto codificato: ai rumoriani tocca il valzer con gli
andreottiani, i colombiani fanno a cambio con i piccoliani, morotei e
rappresentanti della destra si passano le schede. Come se non bastasse, parecchi
democristiani depongono nell’urna la scheda aperta, sventolandola platealmente,
finché il presidente di turno, Sandro Pertini, sbotta ricordando a tutti che il
voto è segreto. La girandola di trovate non basta. Fanfani resta impietosamente
sotto De Martino fino alla sesta votazione. Tra le schede che al suo
fianco Pertini proclama nulle non sfugge agli occhi del diretto interessato la
più esplicita di tutte: “Nano maledetto non sarai mai eletto”, con poco garbata
allusione alla statura fisica del candidato, gigante politico ma alto poco più
di un metro e mezzo.
Dopo il sesto buco
nell’acqua Forlani tenta di congelare la situazione spostando il partito di
maggioranza relativa sulla scheda bianca, nella speranza di raccogliere nella
pausa i consensi necessari a eleggere Fanfani. La prova arriva all’XI votazione
e ancora una volta il candidato della Dc viene impallinato dal suo stesso
partito. Tocca il vertice di 393 voti e resta sotto De Martino che ne vanta 407.
“Era oltre il 90% del partito. Più di così non si poteva fare”, dirà anni
dopo Andreotti, intervistato da Bruno Vespa, rivendicando il merito di aver
spinto verso Fanfani quanti più democristiani possibile. Pochi. Neppure
sufficienti a proseguire la battaglia. Nella notte, una delle tante passate poi
alla storia come “dei lunghi coltelli”, Forlani riunì la direzione per quella
che non poteva che essere una rissa violenta. Sul tavolo c’era la resa di
Fanfani, i cui fedelissimi, al grido di “Fanfani o morte”, non intendevano
mollare la presa anche a costo di imporre votazioni all’infinito. Il segretario,
a sua volta un fanfaniano, si schierò con il partito della resa. Dopo una notte
allucinante, la candidatura Fanfani fu ritirata e la Dc si trincerò dietro la
scheda bianca mandando a vuoto le dieci votazioni successive.
Dopo la XXI votazione, Forlani
riunì l’assemblea dei grandi elettori Dc e affidò a loro la scelta tra Aldo
Moro e Giovanni Leone, principe del foro napoletano con all’attivo l’assoluzione
dei responsabili della strage del Vajont, docente universitario, due volte
presidente del consiglio ma in entrambi i casi alla guida di governi balneari,
rimasti tutti e due in carica, nel 1963 e nel 1968, da giugno a dicembre,
senatore a vita. Di misura prevalse Leone. Pci e Psi, in extremis, tentarono di
innescare un nuovo agguato dei franchi tiratori dc, stavolta allettando i
morotei, già imbufaliti per la sconfitta del loro leader, con la candidatura
di Nenni al posto di De Martino. Era una mossa disperata e tuttavia alla XXII
votazione, a record della maratona più lunga per il Colle già superato, anche
Leone mancò il colpo per un solo voto, nonostante l’appoggio anche dei partiti
tradizionalmente alleati della Dc: i repubblicani, i liberali, i
socialdemocratici. Si fermò a 503 voti.
Per consentire ai Grandi
Elettori di correre a casa giusto in tempo per festeggiare la vigilia fu
necessario ciò che sin dalla VI votazione Forlani aveva cercato di evitare: il
voto determinante di alcuni parlamentari del Msi. Arrivarono, portarono i
consensi di Leone a quota 518, comunque la percentuale più bassa mai
raggranellata da un capo dello Stato. Nata sotto una cattiva stella, la
presidenza Leone finì peggio. Accusato ingiustamente di corruzione, massacrato
da una campagna stampa ingiusta per la quale avrebbe ricevuto le scuse solo in
occasione del novantesimo compleanno, nel 1998, fu costretto a dimettersi alla
vigilia del semestre bianco, il 15 giugno 1978. Poco più di un mese dopo
l’uccisione di Aldo Moro, nei giorni più terribili e pericolosi della storia
della repubblica. Gli successe, dopo un’altra grande battaglia in Parlamento, il
Presidente più popolare di tutti: Sandro Pertini. David Romoli
L’Italia si sveglia col
nuovo presidente. Svolta dopo una lunga trattativa tra i partiti.
Annabella De Robertis su
La Gazzetta del Mezzogiorno il 09 Luglio 2022
È il 9 luglio 1978: l’Italia
si sveglia con un nuovo presidente della Repubblica. «La Gazzetta del
Mezzogiorno» titola «Una unità nuova sul nome di Pertini». Al sedicesimo
scrutinio, Sandro Pertini è stato finalmente eletto capo dello Stato, il settimo
della storia del nostro Paese. Nato in provincia di Savona nel 1896, combatté
nella Grande Guerra e fu tra gli animatori dell’antifascismo ligure.
Perseguitato dal regime, condannato a 11 anni di carcere (trascorse anche alcuni
mesi a Turi), fu confinato a Ponza e Ventotene. Con la caduta del fascismo
ricostituì il Partito socialista e fu protagonista della lotta di liberazione
nazionale. Segretario del Psi, direttore dell’Avanti, per diverse legislature
senatore e deputato (a partire dalla Costituente), nel 1968 fu eletto Presidente
della Camera.
Nel giugno 1978 il capo dello
Stato Giovanni Leone, travolto dallo scandalo Lockheed e dalla tragedia del
rapimento e della morte di Aldo Moro, si dimette. Si apre, così, la corsa al
Quirinale, ma non c’è accordo tra i partiti. Finalmente, l’8 luglio 1978, la
svolta: l’inviato della Gazzetta Antonio Rossano racconta: «Quota 506 era stata
raggiunta dal nome di Sandro Pertini. È stato un applauso lungo, intenso, senza
isterismi: un applauso che ha accomunato democristiani, socialisti, comunisti,
socialdemocratici, repubblicani, liberali, radicale e demoproletari. Gli
elettori si sono levati in piedi: seduti soltanto missini e parlamentari di
Democrazia nazionale».
Rossano non può risparmiare ai
lettori un tocco di colore sull’umanità del nuovo Presidente: «La giornata di
Pertini era cominciata alle 8.40 quando è uscito dal palazzo di piazza Trevi,
davanti alla famosa e fotografatissima fontana. Una scorta discreta ma per lui
inconsueta: si è fermato guardandosi alle spalle ed ha chiesto al giovane agente
“Lei ce l’ha la fidanzata?” “Sì” ha risposto l’agente “E allora ascolti me, vada
a fare una passeggiata con lei. Io dirò che è stato tutto il tempo con me”!».
Pertini è eletto con l’83,6%
dei consensi: ancora oggi, è il presidente più votato della storia della
Repubblica. «L’eccezionale linea dritta della sua vita morale, politica ed
umana, la sua ineguagliabile fiera ed eroica coerenza, sono alla stesso tempo il
suo straordinario biglietto da visita e un patrimonio acquisito per la storia
della nuova Italia, un patrimonio che gratifica anche tutti noi, un punto di
orientamento e di garanzia del nostro riscatto», scrive Oronzo Valentini.
Pertini rimarrà in carica fino al 1985: alla guida del Paese, affronterà una
delle fasi più complesse della seconda metà del Novecento, riuscendo ugualmente
a riavvicinare gli Italiani alle istituzioni.
Come fu eletto Sandro
Petrini, nell’anno della lotta armata un partigiano al Quirinale.
David Romoli su Il
Riformista il 12 Gennaio 2022.
Il 15 giugno 1978 Giovanni
Leone, presidente della Repubblica massacrato da mesi da una campagna di stampa
che lo accusava ingiustamente di essere il misterioso leader politico che aveva
intascato una cospicua tangente dall’americana Lockheed, decise di difendersi
con un’intervista all’agenzia Ansa. Ne inviò copia al presidente del
consiglio Giulio Andreotti, al segretario della Dc, il suo stesso
partito, Benigno Zaccagnini e, per conoscenza, al segretario del Pci, in quel
momento parte della maggioranza di unità nazionale, Enrico Berlinguer. Il
verdetto di tutti fu unanime: quell’intervista non doveva uscire. Infatti non
vide mai la luce. Non bastava. Era ora che Leone traesse i partiti della
maggioranza fuori dall’imbarazzo andandosene. Lo fece. Si dimise con un
messaggio in tv nel quale ribadiva la propria innocenza la sera stessa. Il
semestre bianco sarebbe iniziato 15 giorni dopo. Il 29 giugno, invece, i Grandi
Elettori si ritrovarono in una Montecitorio assediata e in assetto da guerra per
eleggere il settimo presidente della Repubblica.
Con le dimissioni di Leone, il
terremoto che squassava l’intera Italia era arrivato a travolgere la massima
istituzione della Repubblica. Poche settimane prima, il 9 maggio, il cadavere
di Aldo Moro era stato fatto ritrovare dalle Brigate rosse in via Caetani, nel
centro di Roma, vicino alle sedi della Dc e del pci, dopo i 55 giorni più lunghi
e tragici della storia dell’Italia del dopoguerra. L’inflazione martellava,
l’economia crollava, la stabilità politica, basata sul fragile accordo
fra Dc e Pci, era appesa a un filo sottile. Sino a due mesi prima il candidato
naturale per la presidenza era stato proprio Moro, il regista dell’unità
nazionale. Le Br avevano sgombrato il campo crivellando la sua scorta e poi il
presidente della Dc sequestrato. Il candidato numero uno socialista, l’ex
segretario Francesco De Martino, era stato anche lui azzoppato da un sequestro,
quello del figlio, nel 1977. Il riscatto fu pagato e quel pagamento mise De
Martino fuori gioco. In campo c’era un nuovo giocatore, il giovane segretario
del Psi Bettino Craxi, 43 anni, che aveva tutte le intenzioni di farsi valere e
dimostrare con le cattive che la musica nei rapporti col Psi era cambiata.
La partita iniziò, senza
esclusione di colpi, già nei 10 giorni precedenti lo sparo d’inizio. La Dc e
il Pci puntavano su Zaccagnini, già vicinissimo a Moro. L’ “onesto Zac”, come
comunemente veniva definito all’epoca, era pronto. Craxi lo abbattè subito,
spalleggiato dall’area moderata e più anticomunista della Dc, guidata
da Flaminio Piccoli. Il socialista Giacomo Mancini, bruciando i tempi,
candidò Sandro Pertini, ex presidente della Camera. Craxi fece finta di
appoggiare la candidatura, in realtà mirando a bruciarla. L’handicap di Pertini,
ufficialmente, era l’età, 82 anni, meno di quanti ne contano oggi candidati
eccellenti come Silvio Berlusconi e Giuliano Amato. “Va bene, il presidente deve
avere un grande passato ma è bene che abbia anche un po’ di futuro”, ironizzò il
deputato Dc Zucconi. L’anagrafe, in realtà, era il problema minore. Sandro
Pertini, ligure sanguigno e fumantino, ex detenuto ed ex confinato durante il
fascismo, tra i massimi dirigenti della Resistenza, non presentava nessuna delle
doti diplomatiche che si richiedevano allora a un presidente. Aveva innescato di
persona la più violenta rissa nella storia del Parlamento, nel 1953, il giorno
dell’approvazione della legge elettorale detta “legge truffa”.
Si era piazzato di fronte
all’appena nominato presidente del Senato Meuccio Ruini, destinato a restare in
carica solo per quel giorno fatale, e aveva scandito a pieni polmoni: “Lei è un
porco”. Nelle ore seguenti parecchi senatori si sarebbero ritrovati con la testa
spaccata, incluso il presunto suino. Sette anni dopo era stato di nuovo
l’incendiario comizio di Pertini a scatenare la rivolta di Genova contro
il governo Tambroni, sostenuto dal Msi. Inoltre era un socialista poco
favorevole al nuovo corso craxiano: e durante i 55 giorni del sequestro Moro si
era schierato decisamente contro la trattativa e dunque contro il nuovo
segretario. Finì nel bussolotto tritacarne anche il repubblicano Ugo La Malfa,
padre della patria e gradito al Pci. Craxi lo fulminò prima ancora che si
aprissero i battenti: “Non può essere il punto di equilibrio”. La Malfa, uomo
dell’unità nazionale, non poteva andare, ma su un punto Craxi era tassativo: il
nuovo presidente non doveva avere in tasca la tessera della Dc.
Cominciò con i candidati di
bandiera, essendo chiaro che nessuno avrebbe potuto farcela nella prime tre
votazioni, quindi la Dc si barricò dietro l’astensione. Poi, il 2
luglio, Craxi candidò ufficialmente Pertini. L’anziano socialista poteva avere
una certa età ma non era uno sciocco né un ingenuo. Colse al volo la manovra per
sacrificarlo e rispose con una lettera rovente, nella quale si diceva pronto ad
accettare la candidatura ma solo se appoggiata da tutta la maggioranza e non
solo dalla sinistra. Una mossa che sembrava averlo messo definitivamente fuori
gioco. Craxi, a quel punto, giocò la carta di Antonio Giolitti, l’ex comunista
che aveva abbandonato il Pci dopo l’invasione dell’Ungheria, nel 1956. Era una
mossa calcolata.
Il leader del Psi sapeva che
il Pci avrebbe affossato Giolitti e intendeva tirare fuori solo a quel punto il
vero candidato, Giuliano Vassalli, principe del foro come era stato, prima di
lui, Leone, ma, a differenza di Leone e come Pertini, dirigente importante della
Resistenza, torturato in via Tasso. Il Pci bocciò anche lui: troppo critico con
Berlinguer nei giorni del sequestro Moro. Lo stallo precipitava così verso il
vicolo cieco. Le votazioni si susseguivano a vuoto e non era certo la prima
volta. Ma con il cadavere di Moro ancora fresco e il Paese travolto dal
terrorismo e dall’inflazione le cose erano cambiate. I partiti capivano che la
delegittimazione li avrebbe travolti. La notte tra il 6 e il 7 luglio si svolse
un del tutto inusuale vertice tra i segretari di maggioranza che si ridusse a
una sagra dei veti incrociati. Così riemerse il nome del candidato già
trombato, Sandro Pertini. Aveva dato lui stesso la partita per persa. Il 7
luglio aveva già in tasca il biglietto per raggiungere, dopo tre giorni, la
moglie in un Paese vicino Mentone, per le vacanze.
La Malfa accettò di sostenerlo
ma solo con garanzia che nella postazione chiave di segretario generale, al
Quirinale, sarebbe andato un uomo di sua completa fiducia, Antonio Maccanico. La
Dc si rassegnò. Craxi fece buon viso a cattivo gioco: stava per essere eletto un
socialista, ma il più anticraxiano di tutti. Giampaolo Pansa, scarcastico, lo
ribattezzò dopo la battaglia “Pirrino Craxi”. Sandro Pertini fu eletto l’8
luglio con una maggioranza schiacciante, 832 voti su 995. Lo bocciarono
solo Msi e monarchici ma il leader del Msi Giorgio Almirante ci tenne a
manifestare comunque il suo rispetto. Pertini fu il primo presidente a non
traslocare al Quirinale: la moglie, Carla Voltolina, non volle neppure sentirne
parlare. Rimase nel suo appartamento a Fontana di Trevi, spostandosi la mattina
in ufficio, sul Colle. La scelta si dimostrò azzeccata. Proprio in virtù delle
sue caratteristiche più sospette Pertini, che non la mandava a dire, si esponeva
senza peli sulla lingua, adorava i media e si prestava volentieri al loro gioco,
restituì lustro all’istituzione ormai opaca. David Romoli
Storia delle presidenziali.
Storia dell’elezione di Oscar Luigi Scalfaro al Quirinale: un garante che remava
per affossare i partiti.
David Romoli su Il Riformista il 20 Gennaio 2022.
Votavano sul ponte del Titanic
ma non lo sapevano. I segnali dell’imminente naufragio della Prima Repubblica si
moltiplicavano ma i partiti, ingessati e inamovibili, non riuscirono a
coglierli: l’ascesa che pareva inarrestabile della Lega, le picconate sempre più
micidiali del presidente Cossiga e le sue dimissioni anticipate, sia pur
lievemente, la vittoria a sorpresa di Mario Segni nel referendum sulla
preferenza unica, la batosta elettorale subìta dai partiti di governo nelle
elezioni politiche, il referendum contro il proporzionale che era dietro
l’angolo, l’iceberg-killer di tangentopoli che era già entrato in attrito anche
se nessuno credeva ancora che avrebbe non solo danneggiato ma affondato la nave
della Prima Repubblica.
Cominciò con una sagra delle
cineserie democristiane. Invitati a cena dall’ancora presidente Cossiga i due
papabili della Dc, il premier Andreotti e il segretario del partito Forlani, si
lanciarono in un minuetto senza precedenti: “Tocca a te”, “Ma figurati, l’uomo
adatto sei tu”. Spazientito Cossiga li lasciò soli a scambiarsi sdolcinate e
ipocrite cortesie. Il Picconatore, che voleva Forlani come suo successore,
insistette con le cenette sul Colle, mettendo intorno al tavolo il segretario
della Dc e quello del Psi Bettino Craxi, anche lui forlaniano perché convinto
che con Forlani al Colle a palazzo Chigi sarebbe rientrato lui. Con le due teste
di serie impegnate nel giochino del “Passi prima Lei”, “Ma si figuri” la Dc se
la cavò nella prima votazione, il 13 maggio 1992 e poi nelle due successive con
il classico candidato di bandiera, il capo dei senatori Giorgio Di Giuseppe.
Il futuro presidente, Oscar
Luigi Scalfaro, “lanciato” da Marco Pannella in virtù delle sue fermissime prese
di posizione contro il piccone di Cossiga, prese 6 voti. Nessuno lo considerava
in corsa. Per i socialisti poteva essere una seconda scelta dopo Forlani.
Il Pds proprio non lo voleva. Cattolico sì, ma con misura. Scalfaro se lo
ricordavano tutti per la piazzata fatta in pubblico a una signora troppo
scollata, entrata poi nella leggenda come schiaffone in realtà mai affibbiato.
“In Italia un’importante autorità religiosa c’è già. Non ne serve un’altra”,
ironizzava il giovane Fabio Mussi solo al sentirlo nominare. Su Scalfaro, poi,
pesava la Fatwah di Botteghe Oscure per aver scippato, poche settimane prima,
a Giorgio Napolitano il seggio di presidente della Camera. Un gioco quirinalizio
anche quello: per insediare Napolitano, Craxi chiedeva l’impegno del Pds a
votare Forlani nelle imminenti presidenziali. Occhetto rifiutò lo scambio. Craxi
e la Dc elessero Scalfaro, che a Bettino del resto piaceva essendo stato il suo
ministro degli Interni.
Dopo la quarta votazione,
andata anch’essa a vuoto con l’astensione della Dc, Forlani si recò di persona
nello studio di Andreotti per offrirgli di nuovo la candidatura e stavolta
l’astutissimo cedette alle insistenze, si presume di buon anzi ottimo grado. La
sua candidatura fu meteorica. Poche ore dopo arrivò la notizia che i dorotei di
Gava non la accettavano e i socialisti neppure. Volevano Forlani e Forlani fu.
Candidato ufficiale della Dc. Trombato con 39 voti mancanti alla quinta
votazione, 29 alla sesta. A fucilarlo fu un eterogeneo plotone di franchi
tiratori: socialisti anticraxiani, un po’ di sinistra Dc, molti andreottiani.
Restava in campo, in via rigorosamente ufficiosa, Andreotti. I suoi colonnelli
erano attivissimi, Cirino Pomicino macinava incontri. Ma il blocco composto dai
dorotei e da Craxi era inamovibile. Per una settimana fu il caos. Candidature in
libertà affossate una dopo l’altra, come quella del socialista Vassalli proposto
da Craxi, accettato da Forlani, affondato dai cecchini democristiani o di Leo
Valiani. Scalfaro, il futuro presidente, aveva raggiunto il picco di 25 voti ma
svettava come presidente della Camera fornendo prove di carattere una via
l’altra. S’inventò il “catafalco”, l’urna chiusa al centro dell’aula che rendeva
impossibile sbirciare chi andava in bianco. Bastonò parlamentari riottosi con la
dovuta dose d’ironia.
Alcuni parlamentari che
strillavano “Imbecille” rivolti a un onorevole collega si sentirono invitare a
non pronunciare il proprio cognome a voce tanto alto. Un ribelle che rifiutava
di sedersi sbandierando il regolamento che non citava detto obbligo fu abbattuto
con una battuta fulminante: “In effetti non c’è neppure una norma che obblighi a
ragionare. È facoltativo”. Andreotti puntava proprio sul vicolo cieco. Sarebbe
uscito allo scoperto solo quando fosse stato certo dei numeri. Bossi gli aveva
promesso l’appoggio della Lega ma il divo Giulio, che non era un pollastro,
subodorava il trappolone. Il 23 maggio il numero 2 del Psi era nello studio del
premier, invitato dal divo per discutere la richiesta rivolta a Craxi di
votarlo. La notizia della strage di Capaci, della bomba, dell’uccisione
di Giovanni Falcone, della moglie e della scorta, rimbombò nel bel mezzo del
colloquio. Chiuse i giochi. Impossibile tergiversare oltre: il Paese non lo
avrebbe accettato. Impossibile anche uscire dalla palude con Andreotti
presidente: neppure quello sarebbe stato accettabile.
Restava solo una soluzione,
quella istituzionale. Dovevano essere eletti o il presidente del Senato Giovanni
Spadolini o quello della Camera Oscar Scalfaro. Spadolini era convinto di
farcela. Ai funerali di Falcone arrivò con il discorso da presidente già
scritto. Nel corso delle esequie gli fu data la poco lieta novella: presidente
della Repubblica sarebbe stato Oscar Scalfaro. I dubbi del Pds, dovuti
soprattutto all’aura di integralismo che circondava il papabile, furono dissolti
in un colloquio diretto tra Occhetto e lo stesso Scalfaro, che anticipò ogni
eventuale appunto: “Io sono degasperiano. La Chiesa è la Chiesa, lo Stato è lo
Stato”. Il 25 maggio fu eletto con 672 voti. Lo bocciarono solo Lega,
Msi e Rifondazione comunista. Doveva essere il ritorno alla normalità dopo il
pirotecnico mandato di Cossiga, almeno nella sua ultima e dinamitarda fase: un
presidente discreto, poco invadente, opaco. Le circostanze e il carattere
dell’uomo lo resero, con Giorgio Napolitano, il presidente più interventista
nella storia della Repubblica.
È un luogo comune dire che
Scalfaro “fu eletto dalla mafia”. Non è solo una boutade. Senza la bomba
di Capaci probabilmente quel democristiano di seconda fila non sarebbe mai
asceso al Colle. Ma ancora prima della strage l’elezione di Scalfaro fu il
prodotto dello stallo nel quale si erano infilati partiti lontanissimi dall’aver
capito la gravità della situazione nella quale si trovavano. Avessero saputo
cogliere i segnali evidenti che arrivavano ormai da ogni parte avrebbero eletto
subito un loro garante, quale era Arnaldo Forlani e quale invece non era e non
fu Oscar Luigi Scalfaro. David Romoli
L’addio sei anni fa al presidente Ciampi.
Fu il 10º presidente della Repubblica. Annabella De
Robertis su La Gazzetta del Mezzogiorno il 17 Settembre 2022.
«Addio a Ciampi, l’uomo delle due Repubbliche
vicino al Sud e alla Puglia»: così su «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 17
settembre 2016 si rende omaggio al decimo Presidente della Repubblica Italiana.
Nato a Livorno nel 1920, umanista di formazione – si laurea in Lettere classiche
alla Normale di Pisa –, diventerà uno dei più prestigiosi economisti della
storia del nostro Paese. Ha ricoperto, infatti, la carica di Governatore della
Banca d’Italia per quattordici anni, dal 1979 al 1993. Subito dopo, in una
delicata fase di transizione istituzionale ed economica, è stato nominato
presidente del Consiglio.
Dal 1996 al 1999 ha ricoperto diversi incarichi
politici: ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica nei
governi Prodi e D’Alema, con il risanamento dei conti pubblici ha contribuito
fortemente all’adesione dell’Italia all’euro sin dalla sua creazione. Al primo
scrutinio, con 707 voti su 990, il 13 maggio 1999 Carlo Azeglio Ciampi è stato
eletto capo dello Stato: durante il suo settennato ha ribadito più volte
l’importanza di salvaguardare i principi fondamentali della Costituzione e la
necessità di consolidare le fondamenta dell’Unione Europea, non solo in senso
economico, ma soprattutto politico. «La scelta europeista e la grande partita
per far entrare l’Italia nel gruppo di testa tra i paesi che hanno adottato
l’Euro, fu una costante, un punto fermo, un radicamento della sua vita politica
prima e durante il suo settennato. Era il “padre della moneta unica” e lo
ricordava costantemente insieme alla sua vocazione europea».», si legge sulla
«Gazzetta».
C’è anche un elemento biografico che lega Ciampi
alla nostra terra. All’indomani dell’armistizio, da giovane sottotenente
dell’esercito italiano di stanza in Albania, rifiuta di aderire alla Repubblica
di Salò e si rifugia in Abruzzo. Da qui, nel marzo 1944, arriva a Bari, che in
quel momento è uno dei maggiori centri dell’Italia liberata. In tasca ha un
dattiloscritto sul liberalsocialismo che il suo maestro dell’Università di Pisa,
Guido Calogero, gli ha affidato: il suo compito è consegnarlo al meridionalista
Tommaso Fiore. In quei mesi trascorsi a Bari, Ciampi entra in contatto con gli
antifascisti e giovani intellettuali che ruotano attorno alla casa editrice
Laterza, all’ambiente del neonato Partito d’Azione, alla redazione di Radio
Bari. Con alcuni di loro, tra cui Vittore Fiore e Paolo Laterza, instaura legami
che dureranno tutta la vita; spesso ha ricordato, nelle sue non poche visite
istituzionali in Puglia, quanto importanti siano stati, per la sua formazione
politica e personale, quei mesi trascorsi a Bari nel 1944.
Storia delle presidenziali.
Elezione del presidente della Repubblica: i 101 traditori che favorirono il bis
di Giorgio Napolitano.
David Romoli su Il Riformista il 21 Gennaio 2022.
Lo chiamavano re Giorgio.
Nessuno più di lui, Giorgio Napolitano, primo e unico presidente della
Repubblica ex comunista, aveva inteso il mandato presidenziale come una sorta di
monarchia costituzionale. Eletto nel 2006 alla quarta votazione, dunque la prima
a maggioranza semplice, con i voti dell’Unione, la vasta coalizione di
centrosinistra, e la scheda bianca del centrodestra, Napolitano aveva dichiarato
una guerra, sostituito imperiosamente un governo, orientato l’intera vita
politica del Paese. Nessuno aveva saputo dirgli di no. I Ds trasformatisi nel
corso de mandato di re Giorgio in Pd obbedivano puntualmente.
Persino Fini, mentre si
giocava l’intero futuro politico con una mozione di sfiducia contro l’alleato di
sempre Berlusconi, accettò di posporre di un mese il voto di fiducia su
richiesta del presidente-monarca. Una scelta suicida che diede a Berlusconi, che
sul momento sarebbe stato in minoranza, il tempo necessario per acquistare
consensi e capovolger l’esito della conta. Napolitano, tuttavia, non mirava a
una conferma del mandato. Dopo aver condizionato e quasi orchestrato le alleanze
del Pd in vista delle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013 era pronto a
passare la mano alla scadenza del suo settennato, in aprile. L’esito delle
elezioni politiche complicò tutto. La buona affermazione del M5S aveva rotto il
bipolarismo. Nessuno dei tre poli in campo aveva i numeri per governare, né
Italia bene comune, la coalizione di centrosinistra che aveva candidato alla
premiership il segretario del Pd Bersani e conquistato la maggioranza relativa,
né il centrodestra ancora guidato da Berlusconi, né la folta pattuglia dei nuovi
arrivati di Beppe Grillo.
Bersani rifiutava l’ipotesi di
una maggioranza di unità nazionale con la destra, sponsorizzata invece dal
presidente uscente della Repubblica. Mirava a un’alleanza con i 5S, che però non
erano disponibili e anzi, nell’incontro tra Grillo e Bersani in diretta
streaming lo umiliarono pubblicamente. Lo stallo era destinato inevitabilmente a
riflettersi sulla corsa al Colle. La guerra nel Pd era un ulteriore elemento che
rendeva a massimo rischio l’elezione del nuovo presidente. Nelle primarie per
indicare il candidato premier della coalizione svoltesi in due turni, il 25
novembre 2012 con ballottaggio il 2 dicembre, il rampante sindaco di
Firenze Matteo Renzi aveva sfidato Bersani. Era stato sconfitto con il 39,1% dei
voti contro il 60,9% del segretario ma la mancata vittoria alle politiche aveva
di fatto riaperto la sfida e reso più che traballante la posizione
di Bersani. Anche la battaglia nel Pd si sarebbe dunque combattuta nell’arena
delle elezioni presidenziali. Bersani preparò una rosa di cinque nomi da
sottoporre alla destra. Spiccava la mancanza di Romano Prodi. Per Berlusconi
sarebbe stato inaccettabile e il leader del Pd mirava a una soluzione unitaria.
Si mise in moto l’eterno ciambellano Gianni Letta. Organizzò una faccia a faccia
tra il signore d’Arcore e Marini. Berlusconi gli diede il via libera: “Di te mi
fido”.
Marini, ex segretario storico
della Cisl, ex ministro, ex segretario del Ppi, nell’ultima legislatura
presidente del Senato, era uno dei principali padri del Pd. Era stato lui, nel
1995, dalla postazione di responsabile dell’Organizzazione, a determinare la
sconfitta di Rocco Buttiglione che proponeva l’alleanza con Berlusconi: un
passaggio determinante, senza il quale l’intera vicenda italiana alla fine del
secolo scorso avrebbe preso tutt’altro percorso. Eppure la scelta di candidarlo
a capo dello Stato provocò una rivolta tanto tra i parlamentari quanto nella
base. L’accusa era quella di “essere stato scelto da Berlusconi”. Il sospetto,
probabilmente infondato, era che l’accordo con la destra sul Colle preludesse a
quello sul governo. Renzi soffiava sul fuoco con l’intento di far saltare gli
equilibri nel partito. I prodiani pure, per rimettere in gioco il Professore.
L’assemblea dei Grandi Elettori approvò comunque la candidatura ma i segnali
erano minacciosi. La componente Sel abbandonò l’assemblea. I renziani
annunciarono il voto per Sergio Chiamparino, sindaco di Torino. Marini non
raggiunse il quorum alla prima votazione. Si fermò a quota 521. Una parte dei
voti del Pd era confluita sul candidato del M5S e di Sel, Stefano Rodotà,
un’altra quota era andata a Chiamparino.
Alla quarta votazione, con la
maggioranza semplice, i voti presi da Marini sarebbero stati più che
sufficienti. Erano poco meno di quelli che aveva ottenuto 7 anni prima
Napolitano, più di quelli con i quali erano stati eletti in passato Einaudi,
Segni e Leone. Sembrava dunque naturale insistere sino a quella votazione e
questo intendeva fare Marini. Nella speranza di salvare l’unità del
Pd Bersani decise invece di mollarlo. La sera stessa, 18 aprile, Marini fu
costretto a ritirarsi. La mattina dopo l’assembla degli grandi elettori accettò
per acclamazione la candidatura di Prodi, che in quel momento si trovava nel
Mali. Prodi fu messo in campo alla quarta votazione, nel pomeriggio del 19
aprile, dopo aver fatto passare la terza con l’astensione. Non andò oltre i 395
voti, molti meno di quanti ne aveva raccolti Marini. Mancavano ufficialmente
all’appello 101 elettori del Pd: non sarebbero bastati comunque. In realtà erano
probabilmente di più, intorno ai 120 perché molti nel piccolo partito di Mario
Monti, Scelta civica, avevano votato per il professore. Il terremoto travolse
non solo Prodi. La presidente del Pd Rosi Bindi e il segretario Bersani si
dimisero. La sola alternativa al caos era convincere il re a mantenere ancora
per un po’ la corona. Ci provò per primo Gianni Letta, con il pieno consenso del
dimissionario Bersani.
Bussò alle porte
del Quirinale tre volte in quel 19 aprile di caos e per tre volte re Giorgio
rifiutò il secondo mandato. Il giorno dopo fu un corteo. Lo implorò Bersani,
scortato da Enrico Letta. Lo pregò Berlusconi, con zio Gianni al fianco.
Insistette Mario Monti, ancora premier. Si presentò Vasco Errani, presidente
della Conferenza Stato-Regioni, a nome di tutti i governatori. Napolitano non
poté negare “l’assunzione di responsabilità verso la nazione”. Con una
condizione però: chi lo pregava di salvare la situazione s’impegnava anche a
seguire le sue sovrane direttive. Subito un governo “del dialogo” con Berlusconi
e a guidarlo, invece di Giuliano Amato come da indicazione del Pd, Enrico Letta.
Nessuno osò opporre la pur minima resistenza. David Romoli
INTERVISTA A GIOVANNI
MATTEOLI, PORTAVOCE DEL PRESIDENTE EMERITO.
«Il bis Napolitano durò due
anni perché era stanco e provato». DANIELA PREZIOSI ROMA su Il Domani il 05
febbraio 2022.
«La situazione del 2013 non
era meno complessa di quella odierna, che almeno vede una nuova, positiva
iniziativa europea per la crescita e il sostegno alle situazioni di difficoltà e
disagio sociale».
«La decadenza di Berlusconi
dal mandato parlamentare avvenne per una legge approvata a larga maggioranza dal
Parlamento precedente, non per effetto di uno dei fantomatici complotti dei
quali Napolitano avrebbe tenuto le fila».
«Nel 2010 la legge di
stabilità ebbe la precedenza sulla discussione di una mozione di sfiducia al
governo Berlusconi,. Ma per una necessità oggettiva, di fronte alla difficile
situazione finanziaria internazionale, e si muoveva nel solco di una decisione
simile presa alla fine del 1994 da Scalfaro».
DANIELA PREZIOSI ROMA.
Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni
Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice
radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una
tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma,
ha un figlio.
Quirinale, per Berlusconi
Mattarella fu eletto a tradimento dal Pd.
Riccardo Mazzoni su Il Tempo
il 22 gennaio 2022.
L’elezione di Mattarella è
passata alla storia come la causa della rottura del Patto del Nazareno fra Renzi
e Berlusconi, ma in realtà ne è stata più precisamente l’effetto, perché gli
scricchiolii si erano manifestati da mesi, con una parte della classe dirigente
di Forza Italia che contestava in modo sempre più netto quello che
spregiativamente veniva definito un “inciucio a perdere”, al quale veniva
peraltro attribuita la perdita di consensi del partito.
Dopo una luna di miele quasi
stupefacente, che aveva portato per la prima volta Berlusconi a entrare con
tutti gli onori nella sede del Pd, insomma, il rapporto fiduciario tra i due
leader era entrato in crisi, tra incomprensioni, colpi bassi e sospetti
crescenti, e nelle settimane che precedettero il voto per il Quirinale – gennaio
2015 – si era preferito parlare più di metodo che di nomi, in linea con la
tradizione per cui le trattative per il Colle devono essere sempre ammantate da
una sorta di mistero. Dal punto di vista politico, la situazione era per certi
versi simile a quella di oggi: senza un accordo sul Presidente, infatti, il
Patto del Nazareno saltò, così come sarebbe impensabile che l’unità nazionale
ora reggesse se dall’urna presidenziale uscisse un nome non concordato da tutta
la maggioranza.
C’era però, allora, una
sottintesa base di partenza che avrebbe potuto indirizzare il percorso verso una
figura condivisa: Berlusconi infatti in più occasioni, nei numerosi incontri
intercorsi, non aveva fatto mistero di preferire Giuliano Amato, politico ma
anche giurista, nominato nel 2013 giudice della Consulta da Napolitano, un
personaggio autorevole in grado di ottenere consensi anche nel Pd, partito
peraltro a cui aveva a suo tempo aderito. Un nome quindi su cui Renzi non
avrebbe potuto porre veti, mentre Berlusconi il suo no a Mattarella nei colloqui
riservati lo aveva lasciato trapelare, eccome.
Ma il segretario-premier, con
la consueta abilità manovriera tenne coperte fino all’ultimo le sue carte, pur
dando prova di grande attivismo incontrando le delegazioni di tutte le forze
politiche: un’ammuina, perché in realtà il suo vero candidato lo aveva in testa
da tempo. La data cruciale segnata sul calendario quirinalizio, comunque, fu
quella del 28 gennaio, all’immediata vigilia del primo voto a Camere riunite,
quando era in agenda il vertice decisivo tra Rottamatore e Cavaliere. Un
incontro finito malissimo, e per comprendere la fumata nera di quel duro faccia
a faccia bisogna fare un passo indietro di qualche giorno, rileggendo i
retroscena raccolti e pubblicati nei loro libri da Luigi Bisignani e Massimo
Parisi.
Renzi non aveva preso affatto
bene i contatti intercorsi tra Berlusconi e Alfano – di cui era stato tenuto
all’oscuro - per vagliare l’ipotesi di appoggiare la candidatura di
Pierferdinando Casini. Ma conseguenze ancora peggiori ebbe poi la conferma,
datagli candidamente dallo stesso Cavaliere, degli abboccamenti da lui avuti con
la minoranza del Pd, nella persona - sgraditissima all’interlocutore - di
Massimo D’Alema, l’arcinemico per eccellenza che covava da anni propositi di
vendetta contro il leader che lo aveva messo al primo posto nella lista dei
rottamandi. Un’ammissione dunque che, agli occhi di Renzi, faceva rima con
provocazione. Per cui se Berlusconi e D’Alema avevano convenuto che Amato era il
miglior candidato bipartisan, per lui quello diventava un nome irricevibile, da
depennare senza se e senza ma: “Non metto la faccia su un accordo fatto contro
di me” - sibilò.
In realtà, come si evince
dalla ricostruzione dei fatti, la scelta su Mattarella l’aveva già fatta, e
l’incidente D’Alema non fu altro che un ghiotto pretesto per buttare all’aria il
tavolo e stravincere la partita. Renzi rinfacciò al centrodestra di saper dire
solo no: quello a Prodi era comprensibile, ma perché no a Cantone, e soprattutto
no a Mattarella? Un lontano ma concreto motivo, in effetti, il Cavaliere ce
l’aveva eccome: nel luglio del’90 Mattarella si era infatti dimesso dal governo
Andreotti insieme agli altri quattro ministri della sinistra dc per contestare
il varo della legge Mammì sull’emittenza televisiva, ritenuta troppo sbilanciata
a favore delle tv di Berlusconi. Uno sgarbo che Sua Emittenza non aveva per
nulla dimenticato.
A quel punto era chiaro che si
sarebbe andati al voto senza alcun accordo: alla riunione dei grandi elettori di
Forza Italia, il 28 pomeriggio, Berlusconi ammise che il nome ancora non c’era,
mentre la mattina dopo Renzi avrebbe proposto ufficialmente Mattarella ai suoi
gruppi parlamentari. Il tentativo di contromossa per ricompattare il
centrodestra e sabotare così una candidatura sgradita, sperando in una rivolta a
scrutinio segreto dei grandi elettori del Pd come era accaduto due anni prima
per Prodi, si risolse in una pantomima che durò solo poche ore. Se non avesse
votato Mattarella, infatti, l’Ncd sarebbe dovuto uscire dal governo, un’ipotesi
che, grazie anche alla immediata controffensiva di Renzi, avrebbe messo in
gravissima difficoltà Alfano. Il contrordine arrivò quindi quasi in tempo reale,
e il giorno successivo, al quarto scrutinio, Mattarella fu eletto con 665 voti,
raccogliendo non solo il consenso dei centristi, ma anche qualche decina di voti
forzisti, nonostante l’indicazione di votare scheda bianca dimostrandolo con un
rapido passaggio dal catafalco elettorale.
“È stato il Pd - avrebbe poi
commentato amaramente Berlusconi - a cambiare le carte in tavola. Avevamo
avviato una collaborazione per cambiare lo Stato, garantire al Paese una legge
elettorale efficace, scegliere insieme gli elementi di garanzia del sistema,
come il Presidente della Repubblica. Non tutto in questo percorso ci convinceva,
ma il progetto era di tale importanza, da farci accettare anche alcune forzature
e alcuni sacrifici, anche dolorosi. Purtroppo il Pd ha mostrato il suo vero
volto, confermando di considerare le istituzioni un patrimonio da usare a
proprio esclusivo vantaggio”.
"Vi racconto
l'operazione Pertini. Fu amato perché rimase se stesso".
Federico Bini il 23 Gennaio
2022 su Il Giornale.
La liturgia della Prima
Repubblica, l'elezione di Pertini, il ricordo di Lombardi e la presidenza che
verrà.
Claudio Signorile,
vicesegretario e ministro del Psi, è stato una delle figure più influenti e
importanti della Prima Repubblica. Assieme a Bettino Craxi è stato protagonista
della creazione di una sinistra socialista di governo e soprattutto
dell'elezione di Sandro Pertini al Quirinale che segnò l'ascesa del primo
socialista al vertice della presidenza della Repubblica.
Come avveniva ai tempi della
Prima Repubblica la scelta del candidato presidente?
“C’erano sostanzialmente due
livelli. Quello partitico, il livello classico, cioè gli incontri avvenivano
nelle segreterie mentre il secondo quello degli incontri trasversali avveniva in
altri luoghi. Ad esempio per l’elezione di Pertini fu lo studio di Andreotti.
Però il momento cruciale era Montecitorio ovvero il “Corridoio dei passi
perduti” e il Transatlantico. Quelli erano luoghi dove le passeggiate
diventavano poi incontri, scambio d’informazioni ecc…
E l’operazione Pertini dove
nacque?
“Nel Transatlantico, perché
era il mondo in cui tutti i grandi elettori erano compresenti nello stesso
ambito fisico. E i miei interlocutori, ero vicesegretario del partito socialista
- facevo l’attività di “funivia” come si diceva allora - in quel passaggio
delicatissimo erano Antonio Bisaglia (leader della corrente di maggioranza della
Dc) e Alessandro Natta (capogruppo alla Camera del Pci). Fu in quel momento in
cui ci parlavamo che venne fuori la necessità di dare un nome comune”.
I socialisti non avevano una
rosa di nomi?
“Il candidato dei socialisti
era Antonio Giolitti, ma Pertini dopo aver ricevuto un buon numero di voti,
scrisse una lettera, che tutti noi concordavamo nella quale si dichiarava
disponibile solo per soluzioni di unità nazionale. Questa fu l’occasione per
dire che “Pertini era il candidato di tutti”. E Pertini venne votato. Tanto che
lui stava ritornando a Nizza. Io lo fermai a Montecitorio preannunciandogli un
esito favorevole della sua candidatura”.
De Martino nelle elezioni del
’78 era un nome forte per la presidenza della Repubblica. Su di lui pesò molto
il rapimento del figlio?
“Non c’è dubbio che lo
indebolì molto. Lui poteva essere un candidato forte, aveva solo un elemento che
poteva danneggiarlo, il fatto di essere un leader, ma non lo era più, nel ’78
ormai lui era una grande figura socialista, aveva perso anche la maggioranza del
partito. Il rapimento del figlio lo danneggiò perché lo rese una figura con
delle ombre”.
Come era il clima con cui
andaste a votare?
“Difficile. Era la prima
elezione dopo che Moro era stato assassinato due mesi prima, eravamo ancora con
il governo di 'unità nazionale', il paese era in emergenza e la risposta doveva
essere di convergenza, di solidarietà nazionale. E questo venne fatto”.
Pertini nel partito non
apparteneva a correnti e non aveva poteri forti alle spalle. Questa fu la sua
forza?
“Sicuramente anche questo fu
un elemento importante. Nei momenti di grande convergenza non è il leader
politico che diventa punto di unificazione è la figura la cui debolezza
organizzativa si accompagna al prestigio personale e alla credibilità politica.
Faccio un esempio: Moro che era il naturale candidato alla presidenza della
Repubblica se non fosse stato ammazzato, era un uomo debolissimo dal punto di
vista organizzativo nella Dc, la sua corrente era minoritaria, però
rappresentava il punto di convergenza di tutta una serie di equilibri. Questa
cosa vale anche per Pertini. Pertini si è sempre considerato l’erede di Moro,
noi ne parlammo, lui conveniva che doveva adempiere la strategia politica di
Moro e così venne eletto con la convergenza di tutti”.
Montanelli di Pertini scrisse:
“Un brav’uomo, pittoresco e un po’ folcloristico”.
“Montanelli come al solito
aveva il gusto toscano della battuta! Pertini era una persona dalla finezza
politica non comune. Non è stata una figura folcloristica era una persona
estroversa questo si può dire, questo è corretto, che si affidava alla
comunicazione”.
Ebbe modo di rivederlo al
Quirinale?
“Certamente. Io tra l’altro
sono la prima persona che vide il giorno dopo l’elezione, come vicesegretario
del partito e come portatore da parte sua di tutto quell’insieme di notizie,
informazioni di cui aveva bisogno. Io con Pertini avevo un rapporto personale
buono”.
È vero l’aneddoto che una
volta Lei e Craxi vi siete presentati al Quirinale in jeans e Pertini vi ha
“cacciato”?
“Ci fece notare che non era
corretto il modo in cui eravamo vestiti. C’è molto di folclore in questo
episodio, però una piccola parte di verità esiste”.
“Dall’83 all’87 è ministro dei
Trasporti con Craxi. Quali erano i vostri rapporti?
“I miei rapporti personali con
lui sono sempre stati molto buoni. Noi avevamo avuto occasione di scontri
politici aspri ma abbiamo avuto sempre un rapporto molto intenso anche perché
siamo cresciuti insieme nonostante lui avesse qualche anno in più di me. Tra
l’altro noi eravamo due esponenti di minoranze. Craxi era autonomista e numero
due di Nenni, mentre io ero lombardiano e numero due di Lombardi. Eravamo
minoranza che poi divenne maggioranza al Midas nel ‘76”.
Che ricordo ha di Riccardo
Lombardi?
“Persona affascinante. Una
figura il cui senso della politica aveva caratteristiche di alta nobiltà.
Lombardi veniva dal Partito d’Azione, non dimentichiamo mai che la sinistra
socialista aveva il suo cuore azionista. Perché c’era un altro pezzo di sinistra
che poi fece la scissione, che diede vita al PSIUP che era invece massimalista,
incompatibile con ciò che il PSI era diventato ovvero una grande sinistra di
governo”.
In che modo Pertini riuscì a
farsi così amare dal popolo italiano?
“Essendo se stesso. Dando
l’impressione vera di essere autentico in tutte le cose che faceva”.
Qual è il segreto della
longevità al potere di Giuliano Amato?
“Giuliano non è mai stato uno
della vecchia guardia socialista. È sempre stato una figura di grande spessore
culturale, un grande tecnico, ma nel partito non è mai stato avvertito come un
leader di riferimento. Lui è uno che sarebbe un naturale presidente della
Repubblica in altre condizioni, non in questa”.
Previsioni per l’apertura
delle votazioni da lunedì?
“La vicenda di Pertini è
quella più simile. Anche questa volta l’elezione del presidente della Repubblica
deve essere il risultato di un progetto politico importante. Una volta che
questo sia chiaro il passo successivo deve essere l’indicazione del nome”.
Federico Bini. (Bagni di Lucca
1992) maturità classica e laurea in legge. Lavoro nell’azienda di famiglia, Bini
srl materie prime dal 1960, come membro del commerciale e delle pubbliche
relazioni. Liberale e un po’ conservatore. Lettera 22 sulla scrivania,
Straborghese, cultore dell’Italia di provincia. Svolgo da quando avevo quindici
anni un’intesa attività pubblicistica e di studio in ambito
politico, giornalistico e storico. Collaboro con diverse riviste d’informazione
e approfondimento culturale. Tra le mie pubblicazioni si ricorda: Montanelli e
il suo Giornale (Albatros editore), Roberto Gervaso. L’ultimo dandy
(L’Universale) assieme a Giancarlo Mazzuca, Un passo dietro Craxi (Edizioni We)
e Una democrazia difficile. Partiti, leader e governi dell’Italia repubblicana
(Albatros editore). Sono stato condirettore del settimanale Il Caffè.
De Nicola, il presidente
provvisorio. Fu lui a promulgare la Costituzione.
Orlando Sacchelli il 22
Gennaio 2022 su Il Giornale.
Avvocato penalista con il
pallino per il giornalismo, non volle mai essere chiamato “presidente”, ma a
tutti ricordò sempre il suo essere “provvisorio”. Dopo il Colle fu presidente
del Senato e poi presidente della neonata Corte costituzionale.
Contrariamente a tutti gli
altri il primo Presidente della Repubblica italiana, Enrico De Nicola, ebbe
nuovi importanti incarichi dopo l'esperienza al Colle. In seguito, infatti, fu
presidente del Senato (1951-1952) e poi presidente della Corte costituzionale
appena istituita (1956-1957).
Nato a Napoli nel 1877, De
Nicola fu eletto presidente provvisorio della Repubblica dall’Assemblea
Costituente il 28 giugno 1946 e ricoprì la carica di capo provvisorio dello
Stato dal 1° luglio 1946 fino al 31 dicembre 1947. Successivamente, dal 1°
gennaio 1948 (data che segna l’entrata in vigore della Costituzione italiana)
fino al 12 maggio dello stesso anno, fu il primo presidente della Repubblica,
cui succedette Luigi Einaudi.
Studente brillante, entrato
all’università a 16 anni, due anni dopo iniziò a scrivere
come cronista giudiziario per il giornale “Don Marzio”, considerato vicino a
Crispi. Diviso tra due grandi passioni, il giornalismo e la Legge, alla fine
dopo la laurea in Giurisprudenza aveva scelto la toga avvocato, divenendo ben
presto un penalista di fama nazionale, noto per aver abbandonato la pomposità
tipicamente napoletana preferendo uno stile più concreto e asciutto. Si avvicinò
alla politica dopo aver superato i trent’anni ed essersi appassionato, fin da
giovane, ascoltando i discorsi dello storico meridionalista Giustino Fortunato e
del giovane promettente politico Francesco Saverio Nitti.
Vicino alle posizioni liberali
di Antonio Giolitti, nel 1909 Orlando fu eletto alla Camera e confermato nel
1913. Sottosegretario (alle Colonie e al Tesoro) nei governi Giolitti IV e
Orlando, De Nicola proseguì la propria ascesa presentandosi come capolista nel
Partito democratico costituzionale alle elezioni politiche del 1919. Nel 1920,
dopo le dimissioni di Vittorio Emanuele Orlando, fu eletto presidente della
Camera. Rieletto nel 1921, confermato alla guida di Montecitorio, fu vicino alle
trattative più importanti per la formazione di un nuovo governo, nel pieno della
crisi dell’Italia liberale.
Presiedeva la Camera quando
Mussolini si insediò alla guida del Governo, fino a quando fu sciolta la
legislatura (25 gennaio 1924). Molti lo rimproverarono per non aver saputo (o
voluto) tenere testa a Mussolini, quando il capo del fascismo pronunciò il suo
discorso sprezzante contro il parlamento. Alle elezioni del 1924 si candidò
nel listone fascista e fu eletto, nella sua Napoli. Ma non prestò giuramento e
si allontanò dalla politica. Nel 1929, però, il Re lo nominò senatore. Mai
vicino al fascismo, con la caduta del regime seppe muoversi abilmente per
disegnare il futuro politico e istituzionale del Paese.
Il 28 giugno 1946 l’Assemblea
Costituente lo elesse capo provvisorio dello Stato con 396 voti su 501, dopo
diversi scrutini andati a vuoto. De Gasperi avrebbe voluto Vittorio Emanuele
Orlando, Nenni vedeva bene Croce, il Pci era favorevole a un accordo ma di certo
non stravedeva per De Nicola. La sua elezione ebbe luogo come frutto di un
compromesso tra le varie forze politiche e alla luce di due dati di fatto
incontrovertibili: era un fiero monarchico (e ciò serviva a non spaccare il
Paese in una fase di trapasso estremamente delicata), era un esponente politico
del Sud Italia, particolare non secondario visto che diversi leader politici
erano del Nord. Rifiutò di risiedere al Quirinale con la motivazione che la sua
era solo una carica provvisoria: rimase in un appartamento all’interno di
Palazzo Giustiniani, dove già aveva sede la presidenza del Senato.
Non volle mai essere chiamato
“presidente”, ma a tutti ricordò sempre il suo essere “provvisorio”. Ma pochi
giorni dopo la promulgazione della Costituzione, avvenuta nella Biblioteca del
Quirinale il 27 dicembre gennaio 1947, per ovvi motivi di forma (e di sostanza)
De Nicola divenne, a tutti gli effetti, Presidente della Repubblica. Il primo
presidente.
Nei suoi due anni al vertice
dello Stato ebbe alcuni screzi con il capo del governo, Alcide De Gasperi, che
in un caso fecero pensare a un vero e proprio conflitto tra poteri con la
possibile nascita di un esecutivo del presidente. Alla fine a vincere il braccio
di ferro di De Gasperi, che quando si trattò di discutere sulla possibile
conferma di De Nicola si guardò bene dal farlo. De Gasperi, infatti, mai gli
perdonò di aver tentato di scavalcare i partiti cercando di formare un governo
(presieduto dall’amico Francesco Saverio Nitti) aperto ai comunisti. Fallito il
tentativo il presidente ci provò ancora affidando un incarico esplorativo a
Vittorio Emanuele Orlando, ma il “colpo di mano” non ebbe fortuna. E il pallino
tornò nelle mani, ben salde, di De Gasperi.
Il primo discorso da capo
provvisorio dello Stato
"Per l'Italia si inizia un
nuovo periodo storico di decisiva importanza. All'opera immane di ricostruzione
politica e sociale dovranno concorrere, con spirito di disciplina e di
abnegazione, tutte le energie vive della nazione, non esclusi coloro i quali si
siano purificati da fatali errori e da antiche colpe. Dobbiamo avere la
coscienza dell'unica forza di cui disponiamo: della nostra infrangibile unione.
Con essa potremo superare le gigantesche difficoltà che s'ergono dinanzi a noi;
senza di essa precipiteremo nell'abisso per non risollevarci mai più" (Enrico De
Nicola, 15 luglio 1946).
Parsimonioso e austero
Molto parsimonioso e umile, il
giorno dell'insediamento De Nicola arrivò a Roma con la propria auto, da Torre
del Greco (Napoli), dove abitava. Non volle mai abitare al Quirinale, ripetendo
di continuo che gli pareva il caso essendo, lui, un presidente provvisorio.
Preferì la sistemazione di Palazzo Giustiniani. Fedele alla propria linea di
austerità rifiutò l'appannaggio previsto e pagò moltissime spese di tasca sua.
Orlando Sacchelli. Toscano, ho
scritto per La Nazione e altri quotidiani. Dal dicembre 2006 lavoro al sito
internet de il Giornale. Ho fondato L'Arno.it, per i toscani e chi ama la
Toscana
Giovanni Gronchi,
equidistante tra i due blocchi in cui era diviso il mondo.
Orlando Sacchelli il 22
Gennaio 2022 su Il Giornale.
Sottosegretario del primo
governo Mussolini, fondatore della Dc nonché leader della corrente di sinistra,
fu tra i primi e più convinti sostenitori dell'apertura al Partito socialista
italiano di Nenni, superando la politica centrista.
Quando fu eletto alla massima
carica dello Stato Giovanni Gronchi, 68enne, aveva ricoperto già importanti
incarichi politici: sottosegretario all’Industria nel governo Mussolini, e
successivamente ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio,
rispettivamente nei governi Bonomi (II e III) e De Gasperi. Insomma, aveva un
curriculum politico di tutto rispetto e fu il primo esponente della Democrazia
cristiana a diventare Presidente della Repubblica.
Nato a Pontedera (Pisa) nel
1887, figlio del contabile di un panificio, fin da ragazzo fu attivo e impegnato
nelle organizzazioni giovanili cattoliche. Dopo il liceo classico si iscrisse
all’università e, allievo di Giovanni Pascoli, si laureò in lettere alla Scuola
Normale di Pisa. Insegnante di filosofia nei licei, andò a combattere da
volontario nella Prima guerra mondiale, come ufficiale di fanteria, conquistando
una medaglia di argento e una di bronzo al valor militare.
Il ritorno alla vita civile,
dopo la Grande guerra, lo vide molto impegnato in politica. Nel gennaio 1919
partecipò alla fondazione del Partito Popolare Italiano, entrando a far parte,
dopo alcuni mesi, della direzione e venendo eletto deputato. L’anno successivo
fu chiamato a guidare la Confederazione italiana dei lavoratori (progenitrice
della Cisl), venendo rieletto alla Camera nel 1921.
Entrato a far parte del
governo Mussolini, come sottosegretario all’Industria, si dimise quando il Ppi
uscì dalla maggioranza (1923). Dopo le dimissioni di Luigi Sturzo, nel 1924, con
altri due esponenti fece parte del triumvirato che guidò il partito, e nel ’24
fu rieletto deputato. Contro il fascismo aderì alla protesta dell’Aventino e,
dopo le leggi fascistissime, fu dichiarato decaduto dal parlamento. Ritiratosi a
vita privata, svolse il lavoro di agente di commercio e industriale, rientrando
in politica nel 1942, quando con alcuni altri esponenti cattolici, tra i quali
De Gasperi, pose le basi per la nascita della Democrazia cristiana. Nel 1946 fu
eletto all’Assemblea costituente. Eletto alla Camera nel 1948 e nel 1953, fu uno
dei più autorevoli esponenti della sinistra Dc, insieme a Dossetti, La Pira e
Fanfani.
L’elezione al Quirinale, nel
1955, arrivò nonostante gli sforzi del segretario del suo partito, Fanfani, di
far eleggere Cesare Merzagora. Lo “scherzetto” che Fanfani aveva fatto qualche
anno prima a De Gasperi questa volta gli si ritorse contro. Gronchi fu eletto
grazie ai voti della sinistra Dc e delle forze della sinistra (più alcuni
settori della destra), nonostante gli sforzi contrari portati avanti dal capo
del governo, il democristiano di destra Mario Scelba. Fin dall’inizio, con il
suo discorso di insediamento, si capì subito che Gronchi sarebbe stato un
presidente scomodo, sicuramente autonomo e non legato agli interessi di un
partito. La sua elezione fece storcere la bocca agli Stati Uniti, che lo
consideravano troppo poco atlantico, ma paradossalmente anche l’Unione sovietica
non lo avrebbe amato. Tra i suoi sostenitori, inoltre, Gronchi ebbe Enrico
Mattei, potentissimo presidente della neonata Eni, che giocherà un ruolo sempre
più importante nella politica italiana, con forti influenze nelle questioni
estere.
Fortemente critico della
partitocrazia (in alcuni discorsi parlava apertamente di dittatura dei partiti),
Gronchi era stato eletto al Colle proprio in virtù di un gesto di ribellione
che, in occasione del voto a camere riunite, aveva fatto saltare le discipline
di partito. E sfidò il suo stesso partito, la Dc, nell’affidare alcuni incarichi
per formare il governo (ad Antonio Segni), sia volendo dettare la linea in
politica estera, ma anche in quella interna, spingendo verso un’effettiva
apertura alle masse (di fatto il via libera all’asse Dc-Psi). Senza ombra di
dubbio la presidenza Gronchi fu, ideologicamente, agli antipodi rispetto a
quella di Einaudi, con ampie aperture al mondo sindacale e persino al Pci.
Nel suo settennato Gronchi
scatenò due crisi diplomatiche. La prima quando, poco prima di una visita di
Stato a Washington, rilasciò un’intervista in cui propose la riunificazione
delle due Germanie e la loro neutralità per 20 anni. Comunicò poi questa sua
proposta all’ambasciatore dell’Urss, che a nome di Mosca mostrò interesse.
Peccato che quella sua idea non fosse stata minimamente concordata con il
governo italiano, mandando su tutte le furie il presidente del consiglio Antonio
Segni, il suo vice Giuseppe Saragat e il ministro degli Esteri Gaetano Martino.
Gronchi fu costretto dall’esecutivo, proprio prima di partire per gli Usa, a
correggere le sue posizioni.
Un’altra crisi derivò da una
lettera che Gronchi scrisse, nel 1957, al presidente Usa Dwight Eisenhower: il
presidente della Repubblica vi espresse diversi obiettivi di politica estera,
senza però aver minimamente consultato il ministro degli Esteri. Questa mossa
indusse il capo della Farnesina, Martino, dopo essersi consultato con il
presidente del Consiglio Segni, a bloccare la missiva non inviandola negli Stati
Uniti. In punta di diritto ciò avvenne per non aprire la strada a una repubblica
di tipo presidenziale, cosa non prevista dalla Costituzione.
Nonostante questi inciampi
Gronchi non rinunciò mai alle proprie iniziative personali, molte delle quali in
politica estera, ponendosi come “mediatore” tra l’Occidente europeo e i paesi
arabi, dopo la grave crisi del canale di Suez. Linea politica, ancora una volta,
personale, in perfetta sintonia con l’Eni di Mattei.
Orlando Sacchelli. Toscano, ho
scritto per La Nazione e altri quotidiani. Dal dicembre 2006 lavoro al sito
internet de il Giornale. Ho fondato L'Arno.it, per i toscani e chi ama la
Toscana
Luigi Einaudi, l'economista
liberale con il pallino per il giornalismo.
Orlando Sacchelli il 22
Gennaio 2022 su Il Giornale.
Nel 1948 per il Quirinale De
Gasperi aveva puntato su Carlo Sforza, ministro degli Esteri, ma l'azione dei
"franchi tiratori" vicini a Fanfani, esponente della corrente di sinistra della
Dc, fece sfumare il piano. La scelta ricadde sul liberale Einaudi, uno dei padri
della Repubblica.
Intellettuale ed economista di
fama internazionale, Luigi Einaudi è considerato uno dei padri della Repubblica.
Secondo presidente, fu il primo eletto dal Parlamento riunito in seduta comune,
come previsto dalla Costituzione. Carta che, come membro dell’Assemblea
Costituente, contribuì a scrivere.
Fu eletto l’11 maggio 1948
alla quarta votazione, ottenendo 518 voti, contro i 320 di Vittorio Emanuele
Orlando che aveva il sostegno dei partiti di sinistra. De Gasperi, capo del
governo, avrebbe voluto Carlo Sforza, ministro degli Esteri, ma non riuscì a
trovare i numeri necessari, dovendo poi convergere su Einaudi. Cosa che gli pesò
non poco, visto che il capo del governo sapeva bene che non avrebbe più potuto
contare sulla collaborazione del professore piemontese nella delicatissima
gestione dei conti pubblici della neonata Repubblica, dopo la sua salita sul
Colle.
L’elezione di Einaudi avvenne
in un clima politico infiammato dalla rottura della vecchia coesione figlia
dell’unità antifascista: ormai i tempi erano cambiati, con Pci e Psi estromessi
dal governo e la guerra fredda che divideva il mondo in due blocchi
contrapposti. Le elezioni Politiche del 18 aprile 1948 erano avvenute in un
clima infuocato dallo scontro ideologico, con i due fronti contrapposti (blocco
sovietico e Stati Uniti) pronti a darsi battaglia senza esclusione di colpi. Se
Einaudi tutto sommato era stato scelto in un clima politico abbastanza sereno,
con qualche divisione ma senza che vi fossero aspre battaglie ideologiche in
corso, l’elezione del 1948 avvenne, per usare una metafora, su un vero e proprio
campo di battaglia. Basti pensare che, poco prima, il segretario di Stato
americano George Marshall aveva detto a chiare lettere che gli aiuti per
l’Italia sarebbero stati congelati se le elezioni le avesse vinte il Fronte
Popolare formato dall’alleanza Pci-Psi.
I candidati in lizza, nel
1948, erano diversi: oltre al presidente provvisorio e uscente, De Nicola, vi
erano Benedetto Croce, Vittorio Emanuele Orlando (sostenuto dalle sinistre),
Francesco Saverio Nitti e, come dicevamo prima, il nome forte voluto da De
Gasperi, il ministro degli Esteri Sforza, sostenuto anche dai repubblicani. A
far fallire il progetto del leader della Dc fu l’azione, per la prima volta
nella storia della neonata Repubblica, dei “franchi tiratori”, organizzati da un
giovane emergente leader della sinistra Dc, Amintore Fanfani. Fu lui, infatti, a
rompere la disciplina di partita e ad organizzare una fronda che, di fatto, fece
saltare l’elezione di Sforza. Più tardi, per i corsi e ricorsi della storia, da
segretario della Dc Fanfani subì la stessa sorte, vedendosi stoppare l’elezione
al Colle del presidente del Senato Cesare Merzagora.
Nato a Carrù (Cuneo) nel 1874,
rimase orfano di padre a quattordici anni e si trasferì a Dogliani, paese della
madre. Studiò dai padri Scopoli di Savona e poi si trasferì a Torino, dove si
diplomò al Liceo classico. Si iscrisse a Giurisprudenza, iniziando a
interessarsi con vivo interesse ai temi economici, politici e sociali. Iniziò a
scrivere per Critica Sociale, la rivista fondata da Filippo Turati, andando
avanti per circa dieci anni. Spostato su posizioni più vicine al liberismo
economico, continuò poi a scrivere su La Stampa. Nel 1895 si laureò in
Giurisprudenza, iniziò a insegnare alla scuola media e poi all’istituto tecnico,
coltivando parallelamente la sua grande passione per il giornalismo. A solo 27
anni ottenne una cattedra di Scienza delle finanze all’università di Torino. Da
La Stampa passò al Corriere della sera, dove continuò a collaborare finché
rimase alla guida il direttore Albertini, allontanato dal fascismo. Tornò a
scrivervi dopo la caduta del regime.
Nominato senatore del Regno,
nel 1919, con Giovanni Gentile e Gioacchino Volpe e altri intellettuali aderì al
Gruppo Nazionale Liberale, che propugnava uno stato forte, con ampie autonomie
regionali e comunali, in grado di combattere mali atavici quali la burocrazia e
i protezionismi, oltre che a contrastare il “radicalismo democratico”. In quegli
anni, inoltre, scrisse diversi articoli (poi raccolti in un volume) in cui
propose una federazione europea.
Pur apprezzando le iniziali
aperture del fascismo al mercato e ai privati (rispetto al dirigismo economico
giolittiano), Einaudi si distaccò progressivamente dal governo mussoliniano,
soprattutto per la deriva autoritaria. Firmò, nel 1925, il manifesto
degli intellettuali antifascisti, scritto da Benedetto Croce, e pose fine alla
sua collaborazione con il Corriere della sera, dopo l’allontanamento del
direttore Albertini. In rotta con il regime, ascoltò il consiglio di Croce e,
giurando fedeltà al regime, conservò la cattedra all’università di Torino, “per
continuare il filo dell'insegnamento secondo l'idea di libertà”. Rimase tuttavia
sempre contrario al fascismo, come dimostrato dai suoi voti al Senato: contro la
lista unica elettorale (1928), contro l’ordine del giorno favorevole alla guerra
in Etiopia e contro le leggi razziali (1938).
Negli anni immediatamente
successivi alla seconda guerra mondiale Einaudi era stato vicepresidente del
Consiglio, ministro del Tesoro e del Bilancio nel governo De Gasperi. Mentre tra
il 1945 e il 1948 il Paese aveva affidato a lui l’onore e l’onere di guidare la
Banca d’Italia.
Così come De Nicola anche
Einaudi era un monarchico. Nel referendum del 1946 si schierò apertamente per la
corona, anche se ripetè sempre, con insistenza, che qualunque fosse stato il
risultato gli italiani avrebbero dovuto accettarlo, in nome della democrazia.
Orlando Sacchelli. Toscano, ho
scritto per La Nazione e altri quotidiani. Dal dicembre 2006 lavoro al sito
internet de il Giornale. Ho fondato L'Arno.it, per i toscani e chi ama la
Toscana
Che ne è dei presidenti una
volta ex? Vanno a palazzo Giustiniani, dotato di uffici tanto bui da essere
soprannominato “la tomba”. Ma, a seconda dei casi, fanno anche molto, molto
altro. Carrellata.
La Repubblica il 20 gennaio 2022.
Sempre che vada nel modo in
cui si è detto e ridetto, è comunque difficile immaginare la vita pubblica e
privata di Sergio Mattarella fuori dal Quirinale. La nuova casa, d'accordo, i
nipoti, qualche lieta lettura a lungo rinviata, una sospirata libertà da
incombenze e cerimoniali, anche se quella carica lascia un bel vuoto. Lo aspetta
un vasto ufficio a Palazzo Giustiniani, tanto rinomato per essere il più buio di
Roma che già Enrico De Nicola l'aveva soprannominato "la Tomba".
·
La Legge.
Per questo un popolo di
coglioni sarà sempre governato ed amministrato, giudicato ed informato, educato
ed istruito da coglioni. E se un
Parlamento è composto da coglioni, si sforneranno Leggi del cazzo.
Filosofia giuridica. Il
pensiero di Antonin Scalia e la forza del testualismo.
Giuseppe Portonera su
L'Inkiesta il 25 Luglio 2022.
Come spiega Giuseppe Portonera
nella monografia pubblicata dall’Istituto Bruno Leoni, lo scomparso giudice
della Corte Suprema degli Stati Uniti per 30 anni ha corroborato l’idea che le
leggi devono essere interpretate secondo il significato che un cittadino avrebbe
assegnato al loro tenore letterale quando sono state promulgate
Per quasi trent’anni giudice
della Corte suprema statunitense, Antonin Scalia (1936-2016) è stato tra i
giuristi più noti e influenti al mondo. Così influente che secondo molti
commentatori la sua impostazione e il suo pensiero sarebbero maggioritari
all’interno dell’attuale Corte. Alla figura di Scalia è dedicato il nuovo libro
dell’Istituto Bruno Leoni, scritto da Giuseppe Portonera e uscito nella collana
dei Classici Contemporanei, agili monografie sui pensatori più significativi dei
nostri giorni.
Antonin Scalia è stato uno dei
giuristi più importanti della storia recente statunitense. Egli è noto al nostro
pubblico nazionale, o quantomeno alla sezione di esso che sta all’incrocio fra
giuristi interessati alla comparazione o alla teoria generale e cittadini
appassionati di cose americane. Tuttavia, mentre in lingua italiana possono
leggersi pregevoli studi sui metodi interpretativi che egli ha difeso per tutta
la sua vita (originalismo e testualismo), sono state finora assenti biografie
intellettuali del giudice statunitense presentate in forma monografica.
Probabilmente anche per tale ragione, è diffuso l’equivoco che vuole Scalia come
una sorta di difensore del conservatorismo politico: è indubbio che Scalia fosse
politicamente un conservatore, ma da ciò non segue che l’originalismo e il
testualismo siano metodi «politicamente» conservatori, come confermato dal fatto
che diversi intellettuali americani, sia libertari che progressisti, si
considerano originalisti e testualisti.
Scalia ha legato il proprio
nome all’idea che le leggi, compresa la Costituzione, devono essere interpretate
secondo il significato che un cittadino, al tempo della promulgazione, avrebbe
assegnato al loro tenore letterale. Questa idea ha, come suo corollario, non la
«mitizzazione» della legge, bensì il suo rovescio. Scalia non è come il Volonté
protagonista del capolavoro di Elio Petri, Indagine su un cittadino al di sopra
di ogni sospetto (1970), il quale vuole la legge «immutabile, scolpita nel
tempo»; di contro, egli è perfettamente conscio del fatto che leggi, prodotto
umano e storicamente condizionato, possono risultare, con il passare degli anni,
non più in linea con il sentire sociale: tuttavia, ed è questo il nocciolo del
suo pensiero, spetta al popolo – la cui volontà «originaria» è stata fissata
nell’enunciato legislativo – farsi carico della responsabilità della riforma
normativa. Come ha scritto in uno dei suoi ultimi e più appassionati dissents,
«Permettere che [una] questione politica […] sia considerata e risolta da un
gruppo ristretto, aristocratico, del tutto non rappresentativo, di nove
individui significa violare un principio ancor più fondamentale del no taxation
without representation: no social transformation without representation».
L’importanza di Scalia non è
dovuta, però, soltanto all’elaborazione di una teoria. Egli non è stato solo, o
principalmente, un uomo di pensiero, bensì uno di azione, come si conviene al
giurista che opera non nelle aule universitarie, bensì in quelle giudiziarie.
Proprio i trent’anni trascorsi alla Corte suprema gli hanno consentito di
rendere «popolare» la sua judicial philosophy. Eppure, se è vero che essere
stato primariamente giudice ha consentito a Scalia di difendere nel modo più
efficace possibile la propria teoria, è altrettanto vero che ciò lo ha costretto
alle volte a vivere al di sotto delle proprie aspettative, commettendo –
consapevolmente o meno – «errori», ossia mancando in alcune occasioni di
impiegare correttamente la propria metodologia «originalista» e «testualista». E
Scalia è stato il primo a riconoscere la propria umana fallibilità, nonché le
limitazioni della stessa judicial philosophy che ha difeso per tutta la sua
vita.
Ciò appare, nel modo più
chiaro possibile, in una certa ambivalenza che egli ha mostrato nei confronti
di Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954), la celebre
sentenza con cui la Corte suprema ha dichiarato incostituzionale la segregazione
razziale. La giustificabilità del decisum di quella sentenza alla stregua del
significato originario del XIV emendamento è dibattuta, eppure Scalia si è
spinto ad affermare che, anche nel caso in cui si fosse dimostrato che il
significato storico del XIV emendamento non avrebbe escluso l’illegittimità
della segregazione, ciò non sarebbe stato sufficiente per fargli cambiare idea
sulla necessità di essere un originalista. Questo non faceva di lui né un
segregazionista, né un apologeta della Costituzione come originariamente
redatta: per Scalia, al netto di certi principi «eterni» (su tutti, la
separazione dei poteri), il resto della Costituzione si sarebbe potuto e dovuto
cambiare nel caso in cui fosse entrato in tale rotta di collisione con gli
orientamenti maggioritari da risultare intollerabile.
È indubbio che, a seconda dei
punti di vista, la posizione di Scalia verrà intesa o come una filosofia
dell’umiltà o come un
atteggiamento pilatesco. Senza avere l’ingenuità (o l’ipocrisia) di rimuovere
completamente dal quadro il peso morale che grava sul giudice chiamato a
compiere «scelte tragiche», il tratto di realismo che connota questa
impostazione ha il pregio di renderla, ai nostri occhi, preferibile
all’alternativa, ossia alla pretesa di un giudice «erculeo», non solo sempre in
grado di compiere la scelta giusta, ma quasi unico soggetto, nel contesto
istituzionale, in grado di farlo.
Per dirla con Alexander
Bickel, se dovessimo avere a che fare «non con problemi di disuguaglianza e di
ingiustizia sociale, ma con un colpo di stato, con un tentativo da parte di una
maggioranza esaltata o di una potente élite, sciolta da altri vincoli, di
proscrivere e mettere fuori legge uno o un altro gruppo, o di montare un assalto
fondamentale contro un governo democratico», la speranza è che «i giudici
possano richiamare alla ragione [questa] società lacerata». Ma questa speranza –
questa estrema e tenue speranza – può valere in tempi eccezionali solo se, in
tempi ordinari, l’ordine giudiziario rifiuti il «complesso del salvatore»,
agendo con cautela, umiltà e rispetto del progredire, libero e disordinato,
delle forze sociali.
·
Il Potere Assoluto della Casta dei Magistrati.
La Magistocrazia. Così il
potere giudiziario è diventato potere di governo.
Il magistrato: «Le parole del Senatore Scarpinato ma anche passaggi non
secondari dell'intervento del presidente Meloni sulla mafia, si muovono
nell'alveo di stereotipi culturali consolidati, ma non riqualificati». Alberto
Cisterna su Il Dubbio il 3 novembre 2022.
La torsione del processo
penale verso obiettivi securitari rappresenta, probabilmente, uno dei più
vistosi disallineamenti dello ordinamento dello Stato rispetto ai principi
enunciati dalla Costituzione. In verità, tutto il modo con cui si sono
concretamente costruite le relazioni tra giudice e pubblico ministero, si sono
intrecciati i rapporti tra procure della Repubblica e polizia giudiziaria, si
sono alterate le correlazioni tra la pena e la sua espiazione, si sono allineati
le interlocuzioni tra stampa e magistratura si colloca ai margini, se non fuori
dal perimetro della Carta fondamentale e di tutti gli statuti internazionali di
garanzia. Si è costruito una sorta di regime franco, di condizione anomica che
nessuna legge riesce davvero a riportare all’ordine, di ginepraio che nessun
intervento riesce a dipanare.
E’ stata una silente
eversione, o almeno un’elusione, che ha lasciato sempre ( o quasi) intatta la
forma – sia chiaro, quella è sempre stata apparentemente rispettata – ma che ha
favorito il proliferare di un sottobosco nelle prassi, nella costruzione delle
carriere, nelle interlocuzioni del deep state tra magistratura inquirente ed
enti governativi della sicurezza che contraddice qualsivoglia separazione dei
poteri e rappresenta, a ogni effetto, la più potente minaccia all’autonomia
della politica e alla sua indipendenza dagli altri poteri della Repubblica. Una
provocazione? Sicuro, ma necessaria visti i decenni in cui si è sempre recitato
il mantra di una cittadella delle toghe assediata dalla politica e minacciata
nelle sue guarentigie. Ma o la riflessione collettiva ribalta i piani d’analisi
e tenta almeno di percorrere sentieri perigliosi e inesplorati, o altrimenti ci
si arrende alla constatazione che la spada di Brenno è sulla bilancia e, quindi,
“vae victis”. Guarda caso: una spada e una bilancia, la metafora millenaria
della giustizia, scolpita in ogni anfratto giudiziario dell’occidente.
Nei giorni scorsi,
prima, Giorgio Spangher e, poi, Giovanni Fiandaca e Alessandro Barbano hanno da
par loro analizzato sulle pagine del Dubbio i contorcimenti del processo e del
diritto penale che da circa quaranta anni affliggono la giustizia italiana, in
nome di perenni stati d’eccezione, rendendola un Moloch aggressivo e, talvolta,
pericoloso. Luciano Violante, in un’intervista di un paio d’anni or sono, ha
ricapitolato efficacemente i termini politici e istituzionali di questa
condizione accusando il potere giudiziario di essere divenuto un «potere di
governo» .
Una frase che pesa come un
macigno e che, quindi, merita ancora oggi alcune ulteriori considerazioni: ogni
riflessione sul processo penale, e in generale sugli statuti di irrogazione
delle sanzioni (misure di prevenzione e misure interdittive antimafia incluse)
non dovrebbe prescindere dalla considerazione che proprio la giurisdizione – e
non certo da sola – ha elaborato negli anni una propria Weltanschauung, una
propria precisa visione e rappresentazione del mondo, che vive e si nutre di
interviste, di libri, di convegni, di relazioni ufficiali, di un’immane
pubblicistica, di serie televisive di successo; tutto questo plesso culturale e
ideologico – nelle declinazioni ben evidenziate da Spangher e Fiandaca) – vive e
si espande in modo del tutto autosufficiente, ossia senza la necessità che la
politica abbia saputo far altro che assecondarne la traiettoria e
assoggettarvisi; sino a idolatrare i medesimi totem e ad ammiccare ai sommi
sacerdoti officianti i riti di quella ideologia.
Questo sedime ha generato una
precisa antropologia criminale, ha agevolato la lettura della stessa storia
repubblicana, ha spalancato la strada a una interpretazione delle relazioni
politiche, sociali, finanziarie sostanzialmente totalitaria, ossia poco o per
nulla incline a tollerare obiezioni o eccezioni e a marchiare il dissenso come
una sorta di eresia o di strisciante collaborazionismo con il nemico. Tutto
questo è stato ricapitolato dal compianto Filippo Sgubbi in un pamphlet di
ineguagliabile nitore: Il diritto penale totale (Il Mulino, 2019); un caposaldo
esegetico alla cui lettura occorre necessariamente rinviare.
Una cultura egemone, quindi,
esattamente nel senso gramsciano del termine, provvista di una straordinaria
capacità espansiva e in grado di aggredire e metabolizzare qualunque
declinazione della vita pubblica dall’economia alla scuola, dal lavoro allo
sport, dalla sanità all’arte, dalla politica alla agricoltura, indicati tutti
come potenziali o reali luoghi del contagio mafioso da sottoporre a controllo;
per giungere a stigmatizzare finanche i capisaldi della cultura nazionale con le
polemiche durissime che ancora lambiscono la figura di Leonardo Sciascia dopo il
profetico articolo sui professionisti dell’antimafia.
Partita dagli angusti anfratti
della mafia e da una lettura regionalistica, se non localistica, di quella
drammatica realtà, la decodifica del mondo è divenuta la Stele di Rosetta con
cui poter decifrare le oscure trame delle organizzazioni criminali e della
politica, interpretare il reticolo dei poteri occulti, rileggere la stessa
storia del paese nei suoi paurosi e, spesso, colpevoli vuoti di verità.
Non esiste settore della vita
della nazione che possa e, quindi, non debba nel ministero sacerdotale che
discende dal “controllo di legalità” – sottrarsi al crivello dell’indagine
penale; l’inquisitio generalis è prima che un modello d’indagine onnivoro, un
paradigma culturale, una vocazione intellettuale che muove e sollecita settori
cospicui della giustizia penale e, si badi bene, il più delle volte in assoluta
buona fede; ovvero nell’assoluta convinzione che occorra bonificare, se non
purificare, la società dai mali che l’affliggono e che, per attendere a questo
compito immane, sia necessario «sorvegliare e punire», prendendo a prestito la
famosa endiadi di Foucault.
Né è estranea al consolidarsi
– anzi alla stessa originaria, rapida legittimazione di questa impostazione – la
mera trasposizione dal versante della denuncia politica a quello giudiziario
della “questione morale” additata da Enrico Berlinguer nella celebre intervista
rilasciata ad Alfredo Reichlin, sull’Unità, il 7 dicembre 1980; se è vero, come
era vero, che i «partiti hanno degenerato e questa è l’origine dei malanni
d’Italia», la condivisione dell’analisi imponeva una coerente chiamata alle armi
della magistratura, già impegnata contro terrorismo e mafia in quegli anni, per
dare risposta al grido di dolore della parte migliore del paese.
Questa cultura interventista è
divenuta la precondizione, lo strumento della precomprensione delle prove e
degli indizi e del loro peso dimostrativo, la forza trainante che giustifica
finanche le opzioni più discutibili e controverse, come quella sull’ergastolo
ostativo che ha a proprio fondamento non la realtà concreta del trattamento
penitenziario, ma l’affermazione totalitaria di un modello antropologico
sottratto a qualunque discussione e imposto come indefettibile; nessuno è
davvero in grado di poter affermare che solo il pentimento attesti l’abbandono
di un’organizzazione criminale, almeno che questa prova non sia sostituita da un
sintagma inespugnabile, dalla presunzione invincibile che non esista la mafia,
ma esista la mafiosità come stimmate incancellabili dell’anima.
E così, dopo le sanguinose
battaglie per abbandonare la visione ottocentesca e del primo novecento della
mafia come mero atteggiamento interiore, per sconfiggere la visione
antropologica di Giuseppe Pitrè («Usi, costumi, usanze e pregiudizi del popolo
siciliano», 1889), il pendolo della storia è tornato indietro e non mancano
provvedimenti di irrogazione del regime speciale di 41-bis o di applicazione
della sorveglianza speciale o di applicazione di un’interdittiva antimafia in
cui non spiri, nell’ideologia e nell’impostazione sociologica che li giustifica,
la convinzione, condivisa con Pitrè, che «anche senza conoscere la persona di
cui si serve ed a cui si affida, il solo muover degli occhi e delle labbra,
mezza parola basta perché egli si faccia intendere, e possa andar sicuro della
riparazione dell’offesa o, per lo meno, della rivincita».
Suggestioni, deduzioni,
stereotipi, massime d’esperienza, decodifiche unilaterali sono il sostrato
profondo, il collante ideologico delle torsioni che Spangher e Fiandaca hanno,
non da ora, sempre denunciato e stigmatizzato, con l’aggiunta che una cultura
giudiziaria così sedimentata corre il rischio della sclerosi o dell’ischemia,
ossia il pericolo di perdere di vista le attuali e moderne connotazioni
dell’avversario e di smarrirne la prossemica criminale; in fondo le
celebrazioni, gli anniversari, le commemorazioni si atteggiano quasi sempre a
rievocazioni prive di un aggiornamento di quei capoversi interpretativi della
realtà che pur sono stati indispensabili prima del 1982 per dare ingresso al
reato di associazione mafiosa nel codice penale.
Le parole del senatore
Scarpinato nel dibattito sulla fiducia, ma anche passaggi non secondari
dell’intervento del presidente Meloni sulla mafia, si muovono nell’alveo di
stereotipi culturali consolidati, ma non riqualificati; e, quindi, privi di
concreti e riscontrabili elementi di verifica che sono indispensabili al fine
essenziale di stabilire quale sia l’opzione strategica migliore per rintracciare
un nemico scomparso da almeno un decennio dagli orizzonti delle indagini penali.
L’ortodossia e il conformismo
culturale sono, al momento, la minaccia più grave nel contrasto ai fenomeni
criminali organizzati; la dilatazione del doppio binario ( pena/ misure di
prevenzione) verso fattispecie sideralmente lontane dalla mafia ( persino lo
stalking), non rappresenta la dimostrazione dell’espansione inevitabile di uno
strumentario ritenuto efficiente, quanto la prova della preoccupante incapacità
di procedere a elaborazioni alternative, alla costruzione di modelli di
investigazione che sappiano davvero leggere il moderno poliformismo della
minaccia criminale per poterlo intercettare in modo non velleitario.
In fondo la debacle
giudiziaria di “Mafia Capitale” dovrebbe pararsi a monito; rapidamente riposta
nello scantinato della storia giudiziaria per la sua ingombrante e imbarazzante
miscellanea di modelli sociologici inadeguati, presupposizioni sfocate e
scoppiettanti campagne mediatiche, si dovrebbe – invece – ergere a riprova
dell’insufficienza dei canoni interpretativi applicati e dell’inadeguatezza di
approcci meramente e meccanicamente trasposti in un punto di caduta lontano dal
loro perimetro di elaborazione.
E, giunti a questo punto, la
parabola espositiva volge necessariamente al termine, ma si non può chiudere
senza evocare gli scenari melmosi e mefitici, i miasmi del potere raccontati
da Il Sistema; in quelle pagine (e nelle molte, molte altre non scritte e che
mai si scriveranno) v’è il riflesso che quell’egemonia ha esercitato sulla
costruzione delle carriere in magistratura, v’è la prova del triangolo d’oro tra
pubblici ministeri disinvolti/ polizia giudiziaria compiacente/
giornalisti embedded nel carrozzone giudiziario; v’è la dimostrazione che un
approccio al contrasto alla criminalità, concepito in modo geniale e profetico e
a costo della vita, si sia trasformato in uno strumento di potere anzi, come
diceva Violante, di governo della società, in una clava da far roteare sulle
teste più o meno coronate dell’establishment e non solo.
Quando l’indagine sui politici scatta per
pura “coincidenza” a ridosso del voto. Da De Luca a
Fontana, da Comi a Morisi: storie di campagne elettorali giudiziarie. Simona
Musco su Il Dubbio il 06 settembre 2022
Qualcuno la chiama “campagna elettorale a mezzo
procura”. Si tratta degli avvisi di garanzia piombati sulla testa di candidati
più o meno quotati a ridosso degli appuntamenti con le urne. Qualunque sia il
livello della contesa – dalle Comunali alle Regionali, fino alle Politiche e
alle Europee – nessuna competizione, in Italia, è stata risparmiata dalle
entrate a gamba tesa delle procure. Che in alcuni casi, chiuse le urne con
l’indagato di turno magari rimasto a casa perché ritenuto “impresentabile”,
hanno poi fatto clamorosi passi indietro.
Anche l’attuale campagna elettorale, che
vede Giorgia Meloni lanciatissima verso Palazzo Chigi, si è aperta con
un’inchiesta, da subito definita dai membri di Fratelli d’Italia «giustizia ad
orologeria» . È il caso dello tsunami giudiziario che a luglio ha decapitato la
giunta di Terracina, facendo finire ai domiciliari la sindaca di FdI Roberta
Tintari, accusata di reati di turbata libertà degli incanti e falso nella
gestione dell’arenile comunale, poi tornata in libertà ad agosto in quanto la
misura sarebbe stata «illegittima». Si tratterebbe di un piccolo assaggio,
secondo chi si rifiuta di vedere nelle iniziative delle procure delle semplici
coincidenze, di quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Anche
perché la richiesta dei pm al gip era stata presentata il 23 febbraio del 2021,
con la preghiera di applicare in via «urgente» le «misure cautelari coercitive»
per «interrompere le condotte criminose».
Ma gli arresti sono arrivati due anni dopo, due
giorni prima della caduta del governo Draghi. «Il modello Terracina evocato più
volte da Giorgia Meloni come esempio di riscatto ed efficienza è stato infangato
mentre il partito è in testa ai sondaggi, l’obiettivo era quello di sporcare un
simbolo e di sporcare anche me, che in passato sono stato portavoce della leader
di Fratelli d’Italia. È un’inchiesta ad orologeria? Le prove non le avremo mai,
ma i fatti parlano chiaro», aveva commentato Nicola Procaccini, eurodeputato di
Fratelli d’Italia coinvolto nella stessa inchiesta.
I casi sono tanti e molti anche eclatanti. E poco
importa se il nome del personaggio destinatario di un avviso di garanzia – a
volte a mezzo stampa, prima che per mano di un ufficiale giudiziario – sia o
meno presente nelle liste dei candidati. Basta anche un fedelissimo, come Luca
Morisi, creatore della “bestia” social che ha fatto la fortuna del leader della
Lega Matteo Salvini, all’epoca affaccendatissimo con le Amministrative. Il guru
della comunicazione del Carroccio era infatti finito nel mirino della Procura di
Verona a settembre dello scorso anno, a pochi giorni dall’appuntamento alle
urne, con l’accusa di cessione di stupefacenti. L’indagine finì con
un’archiviazione «per particolare tenuità del fatto», ma quella tornata
elettorale fu una stangata per la Lega, secondo cui il caso Morisi, reso
pubblico dalla stampa, fu un modo per affondare Salvini. «È una vicenda
meschina, attaccano lui per attaccare me», tuonò il leader del Carroccio.
Fu più fortunato Vincenzo De Luca, governatore
della Campania riconfermato alla guida della Regione a febbraio 2021. La grana,
casualmente, era scoppiata a due settimane dal voto, in programma a settembre
2020, un’elezione che i sondaggisti davano già in mano allo stesso De Luca,
superfavorito con più di 10 punti di vantaggio sullo sfidante di
centrodestra, Stefano Caldoro. La procura di Napoli gli contestava l’ipotesi di
abuso d’ufficio, falsità ideologica e truffa, ipotesi che, a pochi mesi dalla
rivelazione di Repubblica – nonostante la notizia fosse ancora coperta da
segreto -, venne archiviata. L’indagine era in corso da tre anni ma «lo
straordinario scoop giornalistico», ironizzò il governatore su Facebook, venne
reso pubblico solo a pochi giorni dal voto. «Nel frattempo si comunica che
l’organizzazione dell’Ufficio di segreteria della Presidenza attuale, rispetto a
quella precedente, ha comportato un risparmio di 84.000 euro l’anno – aveva
evidenziato il governatore col solito piglio -. Buon lavoro a tutti. E per il
resto, non perdere tempo e non farsi distrarre» .
A giugno scorso a finire nei guai era stato un
altro candidato di centrodestra, in lizza come consigliere comunale a Palermo:
si tratta di Francesco Lombardo, accusato di scambio elettorale politico-
mafioso, arrestato a pochi giorni dalle elezioni per aver chiesto appoggio
a Vincenzo Vella, boss di Brancaccio, già condannato tre volte per associazione
mafiosa. L’arresto fu annullato pochi giorni dopo e l’accusa derubricata a
corruzione elettorale, ma Meloni non perse tempo a scaricarlo: «Ha fatto una
cosa che per me è intollerabile in campagna elettorale – aveva commentato – per
cui è giusto intanto che sia stata arrestato e poi ovviamente è giusto che noi
lo sappiamo. Ci stiamo già costituendo come parte lesa perché chiaramente
impatta molto su di noi l’ultimo giorno di campagna elettorale».
A maggio 2019 era toccato invece a Lara Comi,
candidata di Forza Italia alle Europee e accusata di finanziamento illecito,
accusa poi archiviata. «Su di lei un grande equivoco», la difese Silvio
Berlusconi. Ma l’inchiesta aveva colpito anche altri esponenti del partito
dell’ex presidente del Consiglio, come Pietro Tatarella, vicecoordinatore
regionale lombardo di Forza Italia e candidato alle elezioni europee. A venti
giorni dal voto, toccò anche il governatore leghista Attilio Fontana, accusato
di abuso d’ufficio per un incarico al socio di studio Luca Marsico, rimasto
senza posto in consiglio regionale. «Vergognosi attacchi all’uomo, all’avvocato,
a un sindaco e a un governatore la cui onestà e trasparenza non sono mai state
messe in discussione in tanti anni, né mai potranno esserlo oggi o in futuro»,
aveva tuonato Salvini. E anche nel caso del governatore l’inchiesta si chiuse
con un’archiviazione, arrivata a marzo del 2020.
L’elenco è lunghissimo. E a volte la magistratura
è intervenuta anche in momenti delicati per le compagini governative: è quanto
accaduto nel 2021 con l’indagine su Lorenzo Cesa, all’epoca dei fatti segretario
nazionale dell’Udc, accusa dalla procura di Catanzaro di aver favorito le cosche
di ‘ndrangheta. L’inchiesta si abbatté sulle trattative allora in corso per
salvare il governo guidato da Giuseppe Conte. Il M5S, all’epoca, era a caccia
dei cosiddetti “responsabili”, tentando di fare entrare in maggioranza anche i
colleghi dell’Udc per non far naufragare l’esecutivo del capo politico grillino.
L’allora presidente del Consiglio, per sopperire
all’uscita dalla maggioranza dei renziani di Italia viva, aveva trovato un
accordo con i tre senatori democristiani Antonio De Poli, Antonio Saccone e
Paola Binetti, con il benestare del segretario Cesa. Che una volta ricevuto
l’avviso di garanzia si ritirò da qualsiasi trattativa, facendo naufragare quel
tentativo e spianando la strada al governo Draghi. «Ho ricevuto un avviso di
garanzia su fatti risalenti al 2017 – disse Cesa –. Data la particolare fase in
cui vive il nostro Paese rassegno le mie dimissioni da segretario nazionale con
effetto immediato». Mesi dopo, l’accusa finì nel cestino, su richiesta della
stessa procura, e Cesa fu scagionato. Ma ormai tutto era cambiato.
Con Panorama la voce delle
eminenze grigie, gli aiutanti del potere.
Lorenzo Castellani su Panorama
il 27 Febbraio 2022.
C’è sempre una via che conduce
al potere, ma questa via non è sempre illuminata. Di fronte o dietro ogni trono,
c’è un corridoio da percorrere, una porta da aprire, un’anticamera in cui
sostare. E’ in questi cunicoli che spesso i più vitali gangli del potere
politico si snodano e connettono. Nella storia c’è ciò che si vede - re,
dittatori, condottieri, leader politici - e ciò che non si vede - consiglieri,
burocrati, banchieri, diplomatici, scienziati, santoni e spin doctor. E’ di
questo potere invisibile che nel podcast ci occuperemo, con un lungo viaggio
nella storia. Lontani dai riflettori, misteriosi, riservati questi personaggi si
muovono con disinvoltura nei corridoi semi bui dei palazzi, delle corti, delle
istituzioni. Se i loro capi sono potenti, questi uomini sono influenti. E spesso
le loro decisioni, i loro consigli, i loro calcoli sono stati più importanti per
la storia di quelli dei grandi protagonisti che tutti conoscono. All’ombra del
potere si muovono figure che spesso sono l’emblema dell’enigma che circonda il
potere stesso e che si nutrono di mistero, inaccessibilità, cinismo,
spregiudicatezza. A volte sono personaggi eccentrici ed eccessivi; altre uomini
frugali ed invisibili; tra di essi ci sono degli intellettuali e dei tecnici, ma
anche uomini pragmatici e brutali; in alcuni casi sono amati dal popolo e in
molti altri detestati; a volte sono parte ufficiale della macchina statale
mentre altre agiscono come confidenti o confessori del potente. Come in un’opera
teatrale, il potere può assumere mille volti e sfumature. Si può materializzare
e smaterializzare. La complessità estrema del carattere di questi personaggi -
spesso difficili da analizzare psicologicamente e ancor più da giudicare sul
piano morale - sono forse l’oggetto di studio più interessante per chi si
appassiona con la storia e la politica. Perché ciò che c’è dietro, che non si
vede affatto o si vede sfocato, è sempre più interessante di ciò che c’è
davanti. Si tratti di antichi regni, democrazie nascenti, stati liberali, vecchi
totalitarismi, nuovi regimi autoritari c’è sempre una eminenza grigia pronta a
consigliare e indirizzare i vertici del potere. Ma chi sia davvero il capo e chi
sia lo strumento del potere è spesso una distinzione sfumata e complessa quando
si affronta il caso delle eminenze grigie.
Molto si è riflettuto sulla
leadership e sulla comunicazione negli ultimi anni, ma molto meno si è guardato
agli “aiutanti” del potere politico. Una mancanza grave in un tempo come quello
che viviamo, caratterizzato da istituzioni multilivello che intrecciano
rappresentanza, economia e amministrazione. Le carriere di questi grandi
suggeritori sono state molto diverse tra loro, a volte fatte di ascese rapide e
fulminee, altre di costanza e di gradualità; alcune sono finite in gloria, altre
in tragedia, altre ancora nell’anonimato. Ci sono stati uomini che hanno
lavorato per una sola patria, altri per più d’una e infine ci sono quelli che si
sono mossi sul piano globale. Più in generale, questo podcast vuole mostrare
come il potere politico sia tutt’altro che verticale, sistema in cui decide uno
soltanto oppure l’autorità ufficiale. Esso è piuttosto concepibile come una
grande rete al cui centro stanno dei punti nodali che contano più di altri e che
si connettono con vaste ramificazioni. È in questa posizione che vivono,
prosperano e decidono le eminenze grigie.
Luca Telese per “TPI - The
Post Internazionale” il 25 febbraio 2022.
Sergio Rizzo, l’autore del “La
Casta”, scrive un libro su un’altra Casta.
«Quella parola e troppo spesso
pronunciata a sproposito. Ma forse non in questo caso. Questa e la Casta somma:
quella che oggi comanda l’Italia».
Un potere che tuttavia quasi
nessuno conosce. Quello dei consiglieri di Stato. «Sono 130 in tutto: un
centinaio di loro sono magistrati, gli altri consiglieri a tutti gli effetti,
nominati dal governo».
Perchè sono così importanti?
«Semplice: hanno in mano le
leve strategiche della giustizia e dell’economia».
Come?
«Sono al governo del Paese, si
giudicano da soli con il proprio organismo di autogoverno, sono attraversati da
decine di conflitti di interessi. Capita perfino che giudichino ricorsi su leggi
e decreti che magari hanno scritto loro stessi.
Cose di importanza decisiva
per tutti noi e, caso unico, senza possibilità di ricorrere al grado di giudizio
successivo. Tuttavia nessuno ne parla, pochi ne scrivono, nessuno li controlla.
Ti basta questa sintesi?».
E come può accadere?
«I politici hanno tanti
difetti, ma non è mai mancata in questi anni la vigilanza pubblica sui loro
errori».
Sicuro.
«Sono sotto i nostri occhi.
Abbiamo potuto vedere e raccontare i loro pregi, i loro peccati, e soprattutto i
loro misfatti».
Tutti conoscono la faccia di
chi si vota, ma pochi conoscono i volti degli uomini di cui parli nel tuo libro.
«Questo e un primo problema.
Sono funzionari dello Stato, invisibili, discreti, molto spesso anonimi. Eppure
scrivono le leggi che regolano le nostre vite, e, come ti dimostrerò, spesso
decidono loro anche come applicarle. Questo conflitto di interessi e un secondo
problema».
Il tuo e un libro contro la
magistratura?
«Al contrario, io credo che a
fine intervista i lettori si renderanno conto che è un libro a sua tutela».
Addirittura.
«I consiglieri di Stato fra
l’altro, come abbiamo visto, non sono solo magistrati, e per giunta non devono
seguire le regole di incompatibilità che invece valgono per tutti gli altri
togati».
Fammi un esempio.
«Il governo Draghi».
Perche?
«Oggi, collocati in diversi
ruoli, ci sono ben 11 consiglieri di Stato. Piu Luciana Lamorgese, che guida uno
dei ministeri più importanti, l’Interno. Un record».
Molti di loro sono “solo” capi
di gabinetto o consiglieri. Ma tu scrivi che sono potenti come i ministri.
«Sono molto più potenti dei
ministri, anche se scelti e nominati da loro. Piu influenti, anche se
apparentemente li servono».
Perchè?
«Occupano i posti chiave, del
potere e del sottopotere: guidano i processi».
Fammi un altro esempio.
«Partiamo dal vertice dello
Stato, ovvero da Palazzo Chigi, con il sottosegretario alla presidenza del
Consiglio?».
Ruolo rivestito oggi da
Roberto Garofoli.
«E la figura politica più
importante, in un governo: il vero braccio operativo del presidente del
Consiglio. Anche lui e, ovviamente, un consigliere di Stato».
Un altro esempio.
«Il segretario generale di
Palazzo Chigi, cioè il capo dell’amministrazione più potente del Paese? E
Roberto Chieppa, figlio dell’ex presidente della Corte costituzionale Riccardo
Chieppa. Anche lui e un consigliere di Stato».
E seguendo la scala
gerarchica, chi c’è?
«Il capo del dipartimento
degli Affari giuridici di Palazzo Chigi, Carlo Deodato. Anche lui un consigliere
di Stato: svolgeva la stessa funzione nel governo Letta».
Un ruolo delicatissimo.
«Fai tu: da quell’ufficio
della presidenza escono tutti i disegni di legge e tutti i decreti del governo.
E c’è quasi sempre stato un consigliere di Stato».
Continuiamo.
«C’e un consigliere di Stato
anche nel ministero più importante, quello che ha i cordoni della borsa dello
Stato: e il capo di gabinetto del ministero dell’Economia, si chiama Giuseppe
Chine».
E poi?
«Gli uffici legislativi di
quel ministero sono affidati ad Alfredo Storto e Glauco Zaccardi».
Che non e consigliere di
Stato!
«E magistrato ordinario, ma
figlio di Goffredo Zaccardi, già consigliere di Stato, capo di gabinetto del
ministero della Salute fino al settembre 2021».
E negli altri ministeri?
«Raffaello Sestini e vicecapo
di gabinetto di Roberto Cingolani, alla Transizione ecologica. Nello stesso
ministero il responsabile legislativo fino a novembre era il presidente di
sezione del Consiglio di Stato Claudio Contessa».
E poi?
«Il ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi ha come capo di gabinetto Luigi Fiorentino. Anche lui
consigliere di Stato».
Altri?
«Certo. Al ministero della
Salute, alla stesura dei testi di legge c’è Luca Monteferrante. Anche lui
consigliere di Stato».
E infine?
«Il capo dell’ufficio
legislativo del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e Roberto Proietti.
Anche lui e un consigliere di Stato».
E ancora?
«Antonella Manzione e
consigliere giuridico della ministra della Famiglia Elena Bonetti. Prima della
sua nomina a consigliere di Stato era a capo dell’ufficio legislativo di Palazzo
Chigi con Matteo Renzi».
Prima che Renzi la portasse a
Palazzo era capa dei vigili urbani di Firenze e prima ancora di Marina di
Pietrasanta: ne ha fatta di strada. Ma perchè dici che loro contano più di un
ministro?
«Basta indagare i loro
curriculum, come faccio nel mio libro, per capirlo».
Ovvero?
«I ministri passano, loro
restano. I ministri hanno diversi colori politici, loro invece transitano
indifferentemente da amministrazioni di destra e di sinistra senza rendere conto
a nessuno delle loro scelte».
Fammi un altro esempio.
«Uno clamoroso, di questi
giorni: le concessioni balneari. Su questo tema – giusto o sbagliato – il
Governo gialloverde aveva deciso, allungandole fino al 2032».
E il Consiglio di Stato ha
annullato quella scelta.
«Imponendo le gare, e
avvisando il Governo che non può più intervenire con un decreto».
Il Consiglio sostiene di aver
interpretato una direttiva europea.
«Si, e in questo caso ha
ragione da vendere. Ma a me interessa un altro aspetto: un consigliere può
partecipare alla stesura di un decreto o di una legge, e poi, nella sua
attività, abrogarla?».
Per questo dici, per
paradosso, che contano più dei ministri.
«Non e un paradosso. I
ministri spesso si limitano a dare gli indirizzi politici, loro scrivono le
norme e poi determinano i processi reali».
Anche i consiglieri, come i
politici, cambiano ruolo.
«La maggior parte di loro,
pero, come si vede, non resta mai a terra. Il 10% dell’attuale Consiglio di
Stato e al governo. Sono i veri padroni della macchina amministrativa, conoscono
informazioni a cui talvolta nemmeno i ministri accedono».
Pure certi politici hanno
carriere lunghe.
«Se ci fai caso, soprattutto
nella seconda Repubblica, la “mortalità” negli incarichi di governo e altissima.
Ora ti racconto delle storie che stupiranno i lettori di TPI».
Prima di scrivere il suo libro
Sergio Rizzo ha lavorato due anni. Ha consultato dossier, organigrammi, carte
processuali, visure catastali e camerali. Poi ha dato alle stampe “Potere
assoluto”, un libro che – appena uscito – e andato esaurito (e stato ristampato
nella prima settimana) e che racconta vita morte e miracoli su «cento magistrati
che comandano in Italia».
Rizzo e stato giornalista sia
al Corriere della Sera che di Repubblica, scrive da anni di norme e leggi. Il
tuo ragionamento e affascinante, ma si potrebbe dire: non e normale che un
consigliere dello Stato serva lo Stato?
«In linea teorica sì. Ma vuoi
un esempio illuminante? Il monumentale curriculum di Garofoli, uno dei migliori
e più influenti consiglieri di Stato. Espertissimo».
Da quando ricopre incarichi di
governo?
«Ecco qui: capo dell’ufficio
legislativo agli Esteri con D’Alema, per due anni».
Ottimo esordio.
«Poi capo di gabinetto di
Patroni Griffi – altro consigliere di Stato, fra l’altro – quando questi era
ministro. Un anno e mezzo. Poi segretario generale della presidenza con Enrico
Letta. Un altro anno».
Quindi?
«Capo di gabinetto al Tesoro
con Padoan nei governi Renzi, Gentiloni e un pezzo del Conte uno. E fanno quasi
cinque anni. Ora – come abbiamo visto – e sottosegretario alla presidenza, con
Draghi, e devi aggiungere un altro anno».
Vuoi dire che ha ricoperto
incarichi in governi di sinistra di destra, istituzionali e tecnici per un
decennio almeno?
«Esatto, ed e un paradosso del
nostro sistema. Garofoli e stato al governo più tempo di Berlusconi. E molto più
di Letta, Renzi, Monti e Draghi messi insieme. Per me il potere reale in Italia
e questo. I politici passano, i grand commis restano».
Quando inizia quella che
chiami l’ultracasta del potere?
«L’ultracasta non è un termine
mio: era del bravo Stefano Livadiotti, autore nel 2009 di un magnifico libro
sulla magistratura. Ma per rispondere alla tua domanda: il Consiglio di Stato
nasce prima del Regno d’Italia».
Addirittura?
«Sono i Savoia a crearlo, su
suggerimento diretto di Metternich a Carlo Alberto».
Parliamo dello Stato sabaudo.
«Esatto: quello pre-unitario,
non c’è stato neppure il 1848».
E poi?
«Importiamo il modello
francese, accrescendo le funzioni di questo organismo. Poi, nel tempo, i
consiglieri si separano da- gli altri magistrati, diventando un mondo a se
stante. I problemi iniziano qui».
Si potrebbe obiettare che il
Consiglio e un organismo costituzionale.
«Ma la Costituzione specifica
che la magistratura deve essere indipendente».
E i consiglieri di Stato non
sono uguali agli altri magistrati, in questo?
«Per nulla. Un magistrato non
può avere altri incarichi, un consigliere di Stato si. E talvolta grazie a
questi incrementa un bel po’ lo stipendio».
Possibile?
«Nel piccolo, visto che tanti
di loro ad esempio insegnano, basta sommare al limite di 220mila euro i
50-60mila di una cattedra in una scuola di formazione».
E in grande?
«Immagina quanto si guadagnava
un tempo con gli arbitrati. Li avevano praticamente aboliti, oggi sono riapparsi
in altre forme».
Fino a quanto possono
guadagnare?
«Ecco il punto. Un tetto non
c’è. I guadagni privati, per esempio quelli dalle scuole private dove insegnano,
non si calcolano nel limite dei 240mila euro lordi annui».
Non ci credo.
«Ma quando gli arbitrati
andavano alla grande era una pacchia. Fino a una quindicina d’anni fa c’era chi
portava a casa anche un milione e mezzo di euro».
Incredibile.
«Ma e cosi. E c’è un altro
capitolo importante di quello che io chiamo il potenziale conflitto d’interessi
permanente».
Quale?
«La giustizia sportiva.
Milioni di italiani appassionati di calcio sono rimasti appesi alla diatriba tra
Juve e Napoli in piena pandemia, su una delicatissima gara da disputare o meno».
E c’entra il Consiglio di
Stato?
«A decidere tutto sono stati
gli organi della giustizia sportiva, che pero non sono parte di una categoria
autonoma. E che sono tutti costituiti da una particolare categoria di
magistrati. Indovina quali?».
I consiglieri di Stato?
«Inizi a capire. Ora ti faccio
un altro esempio, quello che ritengo un conflitto di interessi politico. Che il
protagonista ovviamente negherà».
Ovvero?
«Goffredo Zaccardi, bravissimo
consigliere di Stato: per una vita lavora nei gabinetti dei governi della
sinistra. E poi diventa presidente del Tar del Molise».
Cosa vuoi dire?
«In quel ruolo si ritrova ad
annullare l’elezione di un governatore di centrodestra, Michele Iorio».
Era in conflitto di interessi?
«Un ex funzionario vicino al
centrosinistra che azzera l’elezione di un esponente di centrodestra: magari in
punto di diritto ha ragione. Ma se fossi in lui un po’ d’imbarazzo lo
proverei».
Esistono anche casi opposti?
«Il caso dei casi: Franco
Frattini».
Ex ministro con Berlusconi.
«Esatto: ministro degli Esteri
di Forza Italia, promosso presidente di sezione del Consiglio di Stato mentre
era ministro e parlamentare, in aspettativa».
Ma era legale.
«Diranno cosi. Ma per me e
incredibile. La politica diventa la prosecuzione della carriera con altri
mezzi».
Ma poi accade altro?
«Certo. Frattini, anche in
virtù di quell’avanzamento, diventa presidente del Consiglio di Stato, superando
un concorrente che lamenta di avere più anzianità di lui».
Si parlava di lui per il
Quirinale.
«Sarebbe diventato capo della
magistratura, cioè di se stesso. Ma sai chi sarà a giudicare il ricorso del suo
rivale?».
Non me lo dire.
«Si arriverà al Consiglio di
Stato».
Quindi Frattini giudicherà sul
ricorso contro Frattini?
«La ministra Dadone aveva
meritoriamente proposto una legge per fermare gli avanzamenti di carriera
durante gli incarichi politici».
E che fine ha fatto?
«Scomparsa in qualche
cassetto».
Sui ricorsi in primo grado
decide il Tar.
«Ma in appello rispetto al Tar
c’è il Consiglio di Stato. Tecnicamente inappellabile, perchè non esiste un
terzo grado. Ora immagina che il Tar, e dunque il Consiglio di Stato, hanno
giurisdizione su tutti i contenziosi economico-legislativi del Paese. Potere
vero».
E un conflitto d’interessi?
«Io credo che chi ha scritto
le leggi non dovrebbe mai decidere sui contenziosi che le riguardano».
Mi dicevi dello sport. «I
magistrati ordinari non possono fare i giudici sportivi».
Mentre i consiglieri di Stato?
(Sorriso).
«Loro sì».
Un esempio?
«Gerardo Mastrandrea, giudice
sportivo, ma anche coordinatore legislativo del Tesoro. Io mi chiedo: ma come
fa?».
Parliamo di quel famoso
Juve-Napoli?
«Il Napoli non si presenta
alla partita: 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione decisivo per la corsa
allo scudetto».
De Laurentis ricorre alla
Corte federale.
«E chi decide? Mario Torsello.
Consigliere di Stato».
E poi?
«Vanno alla Cassazione
sportiva: e il presidente chi e? Sempre Franco Frattini».
Improprio, ma non grave.
«Dipende. In questi organismi
di giustizia ci sono anche gli avvocati amministrativi. Tu ti trovi al fianco di
uno in una Corte sportiva, e poi come controparte in un procedimento ordinario.
Capisci? Poi succedono pasticci come quello di Chine».
Sempre lui?
«Si è trovato a giudicare
sulla Lazio. Ed e successo un macello: c’è stata anche una interrogazione
parlamentare, perchè il figlio giocava nella Lazio!».
Un altro caso?
«Pasquale De Lise. Da
presidente del Tar Lazio, si trova a giudicare un ricorso di Lotito contro la
Consob. E giudica a favore di Lotito. Ma poi magari gli sarebbe capitato di
avere a che fare come presidente della Cassazione sportiva con la squadra di
Lotito. Una commistione di ruoli che non va».
Siamo alla fine, chiudi con
una perla.
«Le scuole per diventare
magistrati o avvocati, come puoi immaginare, sono molto ambite».
E ti credo.
«Bene, tra le tante società
che si occupano di formazione, che fanno soldi, ci sono alcune società, che
hanno sede a Bari».
Non ci vedo nulla di strano.
«Nemmeno io. Se alcune di loro
non facessero capo alle consorti di consiglieri di Stato».
Curioso. Piccole società
didattiche? «Insomma. I bilanci che ho controllato dicono che dal 2008 la prima
ha fatturato 30 di milioni di euro, e la seconda 14».
Incredibile.
«Fidati. Relazioni, intrecci,
incarichi, porte girevoli. Nel vuoto degli altri poteri, nella crisi della
politica, questa e la casta delle caste».
Quei cento giudici che
fanno casta: agli amministrativi è permesso tutto.
Luca Fazzo il 7 Febbraio 2022
su Il Giornale.
Il saggio punta i riflettori
su un gruppo ristretto di magistrati, dai Tar al Consiglio di Stato. Rizzo:
"Sono legati alla politica, spesso sono nei posti chiave dei ministeri e
ricevono incarichi extra".
Un potere dentro il potere,
una Casta con la toga impelagata in profondità col mondo della politica e degli
affari in un viluppo di clamorosi conflitti di interesse: è il sistema della
giustizia amministrativa, poche centinaia di magistrati che - dai Tar regionali
fino al Consiglio di Stato - dettano legge fuori da ogni controllo. È questo il
quadro desolante che ne traccia Sergio Rizzo in Potere assoluto, il saggio in
uscita in questi giorni per Solferino. E che dal marcio nella giustizia penale,
dal degrado nelle correnti e nelle Procure raccontato dal caso Palamara, sposta
l'attenzione verso un mondo di cui invece si è sempre parlato poco.
«L'idea del libro - racconta
Rizzo - nasce proprio dalle percezioni che di questo mondo si sappia pochissimo.
Eppure è un crocevia decisivo. Da una parte i giudici amministrativi si muovono
al di fuori di ogni controllo, rendendo conto solo a se stessi; dall'altra sono
però legati da un cordone ombelicale al mondo della politica». A fare di questi
magistrati poco noti dei personaggi decisivi c'è anche il fatto che sono spesso
loro a costituire l'ossatura del potere esecutivo. «Forse non tutti lo sanno -
dice ancora Rizzo - ma in buona parte dei posti chiave dei ministeri e del
governo ci sono giudici amministrativi: persino l'attuale sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, una delle figure chiave dell'esecutivo, è un giudice
del Consiglio di Stato. Sono dentro gli uffici legislativi dei ministeri,
scrivono le norme che loro stessi poi sono chiamati ad applicare. Le loro
carriere incrociano quelle della politica e ovviamente ne vengono condizionate.
La cosa incredibile è che mentre lavorano nei ministeri continuano a maturare
anzianità come magistrati e ad avere avanzamenti di carriera».
Tra i privilegi dei magistrati
amministrativi c'è la possibilità di svolgere incarichi stragiudiziari: possono
insegnare nelle scuole, possono fare arbitrati. Quasi grottesco è il quadro che
in Potere assoluto viene tracciato del funzionamento della giustizia sportiva,
anch'essa affidata in buona parte a giudici amministrativi. Sono incarichi quasi
sempre non retribuiti, si dirà. Ma nei tribunali del Coni e delle federazioni i
giudici siedono insieme agli avvocati, si crea una contiguità, una colleganza
tra figure che il giorno dopo, in una udienza davanti al Tar o al Consiglio di
Stato, dovrebbero essere ben distanti. «Si tenga presente - chiosa Rizzo - che
il mondo della giustizia amministrativa è un microcosmo dove tutti conoscono
tutti e tenere i ruoli separati sarebbe decisivo. Quanti sanno che il presidente
del comitato di sorveglianza di Alitalia è anche segretario del Consiglio di
Stato?».
Consigliere di Stato era il
giudice Francesco Bellomo, diventato famoso per come gestiva le scuole per
aspiranti magistrati. «Ma non è un caso isolato, a Bari mogli di giudici
amministrativi hanno partecipazioni in case editrici che stampano i libri...
Avere frequentato i corsi di un giudice importante è un titolo che i regoli non
prevedono ma che pesa comunque».
Il libro punta il dito contro
il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il
Csm dei giudici amministrativi, che sembra condividere - nella sostanza se non
nella forma - le storture del Csm ordinario. E ad accomunare le due categorie di
giudici è anche il sistema delle «porte girevoli», con giudici che vanno in
politica, poi rimettono la toga e danno torto alla parte avversa. Rizzo racconta
il caso di Goffredo Zaccardi, che dopo aver lavorato per i governi Prodi e
D'Alema tornò in servizio e annullò le elezioni in Molise vinte dal
centrodestra. Caso non dissimile, ricorda, da quello del giudice Giancarlo
Sinisi che dopo tre legislature in Parlamento per la sinistra tornò in
magistratura. E condannò Augusto Minzolini, allora senatore di Forza Italia.
Luca Fazzo (Milano, 1959) si occupa di cronaca giudiziaria dalla fine degli anni
Ottanta. È al Giornale dal 2007. Su Twitter è Fazzus.
Goffredo Buccini per
il "Corriere della Sera" il 3 febbraio 2022.
Il fantasma di Attilio
Brunialti non ha mai smesso, in fondo, di turbare i sonni dei suoi successori.
Con la sua aura di astuzia e competenza, certo, qualità principali anche delle
generazioni di consiglieri dopo di lui: le stesse doti che lo portarono a
dirimere magistralmente, nel lontano 1907 (ancora in tempi di Non expedit e
mangiapreti), una questione esplosiva sui crocefissi, da rimuovere o meno nelle
scuole, grazie a un memorabile «escamotage evasivo» (il crocefisso, come la
lavagna, «è suppellettile essenziale» in aula); ma anche col suo fardello di
spregiudicatezza, che lo trascinò nel 1913 sotto accusa davanti ai suoi
colleghi, per arbitrati opachi.
La medesima spregiudicatezza
che, nella sua ultima fatica saggistica, Sergio Rizzo pare attribuire a una
parte non proprio minore di chi riempie oggi (e ha riempito in tempi recenti) le
stanze ovattate di Palazzo Spada, nella Roma antica del rione Regola. Un
edificio cinquecentesco ignoto a tanti, eppure sede di un vero gnommero di
poteri e sottopoteri incrociati in modo quasi mai illegale ma spesso e
volentieri incestuoso, tra coincidenze di controllori e controllati, generose
prebende e dorate remunerazioni: il Consiglio di Stato, organo decisivo nella
risoluzione dei rapporti, talora assai conflittuali, tra Stato, amministrazioni
pubbliche e privati.
Potere Assoluto, in uscita per
Solferino in questi giorni, mette così a fuoco (e sul fuoco, nel senso di...
graticola) « i cento magistrati che comandano in Italia »: e, comandando
davvero, lontano dai riflettori della pubblica vanità, sono dunque spesso
sconosciuti, tranne che agli addetti ai lavori. Rizzo ce li svela nella loro
umanissima natura.
A quindici anni da La Casta
che, scritto con Gian Antonio Stella, gli valse la notorietà (denunciando come
certa politica caricaturale fosse diventata oligarchia insaziabile) e, forse non
casualmente, nel trentennale di Mani pulite, ci racconta come chi decide sul
serio nel Belpaese non siano né i politici né i pubblici ministeri, tanto spesso
in conflitto tra loro, ma quei dotti mandarini che alla politica sono assai
prossimi e rappresentano «la scheggia più autoreferenziale della magistratura».
Quelli che scrivono leggi e
decretano come applicarle. Hanno «in mano i ministeri», «che i ministri gli
danno volentieri in gestione chiamandoli a fare i capi di gabinetto» grazie agli
«incarichi fuori ruolo». Quelli che possono cambiare con una sentenza il destino
di interi settori dell'economia nazionale, far decadere un presidente di
Regione, annullare la nomina di un procuratore. Che arbitrano lucrosi arbitrati.
E governano persino l'insopprimibile passione italica del calcio, tramite
incarichi nelle corti federali. «Il Consiglio di Stato», sostiene Rizzo, «è il
nocciolo duro del potere».
Intendiamoci: in sé non c'è
nulla di esecrabile nell'essere un fuoriclasse della dottrina e nello scalare,
perciò, più in fretta i gradini che conducono a uno status di grand commis e
perfino di riserva della Repubblica. E sarebbe puerile descrivere un ganglio
essenziale dello Stato come una compatta consorteria di colendissimi
furbacchioni.
Dunque, si tratta di capire e
distinguere. Più ancora che in altri saggi di denuncia, Rizzo pare affrontare
qui la questione soprattutto in termini di inopportunità e cortocircuito del
potere: «La giustizia italiana ha un problema grande come una casa e fa finta di
non vederlo... L'autoreferenzialità, è questo il problema, ha infettato in
profondità tutte le magistrature mortificando l'efficienza e il merito. Con il
paradosso che è la degenerazione di un principio sano, quello della separazione
dei poteri e dell'autonomia dei magistrati».
E i più autoreferenziali di
tutti (anche grazie al loro «Csm» ad hoc, il Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa) ci appaiono qui gli illustri inquilini di Palazzo
Spada. Nel sostenerlo, Rizzo concede come di consueto pochissimo alla seduzione
narrativa e offre invece al lettore tanta sostanza di cifre, sentenze e
circostanze che, se pazientemente seguite, disegnano un ordito di grande
efficacia. Senza rinunciare a qualche target maggiore, s' intende.
Come nel caso di Franco
Frattini, già enfant prodige di lunghissimo corso della politica nazionale,
fresco presidente del Consiglio di Stato e soprattutto fresco «quirinabile»
caduto nella settimana rovente della rielezione di Mattarella soprattutto a
causa di qualche vecchia dichiarazione russofila (piuttosto improvvida se
riletta in costanza di crisi dell'Ucraina).
Rizzo ne viviseziona carriera,
promozioni e arbitrati, ponendo in questione il criterio stesso di anzianità
alla base della progressione di ruolo: «Dei trentatré anni e mezzo trascorsi dal
giuramento come consigliere di Stato () ne ha passati decisamente più della metà
in aspettativa, a fare politica».
E che politica: già celebrato
ispiratore di quella «pistola caricata a salve» che fu nel 2004 la legge sul
conflitto d'interessi così sensibile per Berlusconi, il nostro ottiene «la
promozione in magistratura» (nel 2009, a presidente di sezione del Consiglio di
Stato), mentre ne è fuori, essendo deputato del Popolo della Libertà e ministro
degli Esteri nell'ultimo governo del Cavaliere. Con buona pace «per la
separazione dei poteri».
Non si pensi tuttavia che
tanta attenzione sul dottor Sottile del berlusconismo sia dettata da malanimo.
Sarà opportuno rammentare che Frattini sconta a Palazzo Spada il successo (che,
come sempre predica Berlusconi, attira «invidia sociale», spesso tra colleghi e
ricorrenti) e la notorietà, in una confraternita di potenti quasi sempre senza
volto. Ma Rizzo è bipartisan, ne ha per tutti e per tante tristi vicende della
nostra Italia.
Dallo scandalo della P2, coi
suoi diciotto magistrati irretiti da Gelli (di cui uno del Consiglio di Stato),
alle più recenti imprese dell'avvocato Amara (pietra dello scandalo di
innumerevoli fascicoli giudiziari); dalle cene di qualche giureconsulto rampante
con l'immancabile Luca Palamara e col lobbista Fabrizio Centofanti, alle
relazioni pericolose tra il penale e l'inopportuno che s' infilano nella carne
viva di Palazzo Spada, fino (poteva mancare?) alla gara Consip che è una specie
di sacro Graal dei trafficanti d'influenze italici.
Poiché non tutto può essere
indignazione, non manca un sorriso triste, infine, di fronte all'impresa da
maratoneta di quel consigliere che corre la Roma-Ostia in un'ora e quaranta poco
dopo aver proposto causa di servizio per un'ernia del disco provocata, a suo
dire, «dall'aver sollevato pesanti fascicoli processuali». Fra tanti scranni
occupati da terga autorevoli, uno strapuntino per Totò non poteva mancare.
“I magistrati sono la vera
casta”. Parola di Sergio Rizzo. L'autore che con la "Casta" contribuì a
cambiare le sorti del paese, ora in un altro libro ammette: "L'autonomia della
magistratura così com’era stata concepita ha mostrato tutti i suoi limiti, fino
ad assumere pian piano connotati diversi". Valentina Stella Il Dubbio il 4
febbraio 2022.
“Potere assoluto – I cento
magistrati che comandano in Italia”, è il titolo del nuovo saggio del
giornalista Sergio Rizzo (Solferino Editore, pagine 256, euro 17), in cui svela
storie, protagonisti, conflitti d’interesse e retroscena inediti della casta più
nascosta e potente del Paese: «i consiglieri di Stato. Ovvero, il nocciolo duro
del potere in Italia».
Il libro, di cui discuteremo
con l’autore venerdì 4 febbraio alle 19 sulla pagina Facebook del Dubbio, cade
a fagiolo, considerato che solo poche settimane fa il Consiglio di Stato è stato
al centro della cronaca giudiziaria per aver decapitato i vertici della
Cassazione. Quest’ultimo aspetto è ritenuto talmente problematico che si torna a
parlare seriamente di un’Alta Corte: Rizzo riprende l’idea di Luciano Violante
preoccupato del «rischio che “la magistratura amministrativa diventi il soggetto
che, al di là della Costituzione, decide delle promozioni e delle sanzioni dei
magistrati“. Al di là della Costituzione. Vero. Ma questo può accadere –
prosegue Rizzo – perché, “al di là della Costituzione”, l’autonomia della
magistratura così com’era stata concepita ha mostrato tutti i suoi limiti, fino
ad assumere pian piano connotati diversi».
Fra tutti i 10 mila e passa
magistrati italiani i Consiglieri di Stato sono quelli più vicini alla politica.
«Al punto da indirizzarne talvolta le scelte importanti. Gli spetta per legge –
scrive Rizzo – il compito di esprimere pareri e suggerimenti sulle iniziative
del governo. Pareri e suggerimenti, si badi bene, talvolta vincolanti». Ma il
vero asso nella manica di questi magistrati è la possibilità di assumere
incarichi diversi da quelli strettamente giudiziari, andando «fuori ruolo».
Hanno in mano i ministeri,
come capi di gabinetto, e «perfino il processo legislativo della nostra
democrazia, visto che, come esperti giuridici dei ministri, scrivono le leggi e
ne gestiscono il funzionamento attraverso decreti attuativi predisposti da loro
stessi», trasformandosi così negli uomini più potenti del Paese. «Nel governo di
Mario Draghi ce ne sono undici: il 10 per cento dell’intero Consiglio di Stato».
Rizzo fa i nomi, individua i
strani giri che fanno non uscendo mai da quelli che contano, e anche le preziose
parentele: chi sono, lo scoprirete leggendo il libro. Il testo è ricco di storie
realmente accadute, come si suol dire: a cominciare dalla partita non giocata
tra Juventus e Napoli durante la pandemia e che divise l’Italia a metà. Il
giudice sportivo e «consigliere di Stato Gerardo Mastrandrea infligge alla
squadra di De Laurentiis non soltanto la sconfitta a tavolino per 3-0, ma la
condisce per sovrapprezzo con la penalizzazione di un punto in classifica. […]
Si può sempre fare ricorso alla Corte federale d’appello. E chi è lì il
presidente? Manco a dirlo, un altro consigliere di Stato. Resta tuttavia ancora
una chance estrema. Il Collegio di garanzia dello sport del Coni».
E chi è il presidente? «Un
terzo consigliere di Stato che spunta in questa assurda vicenda: Franco
Frattini», ora divenuto Presidente del CdS. Ma nel saggio si fanno anche i conti
in tasca alla magistratura amministrativa, con esiti sconcertanti: le spese per
l’informatica sono passate dagli 8,3 milioni del 2013 per schizzare a 23 milioni
nel 2020, per poi leggere, nel bilancio di previsione, che la spesa sarebbe
salita in soli tre anni a 52 milioni e mezzo. «La botta è così pesante che uno
dei quattro membri laici, Salvatore Sica, chiede lumi. Fa mettere a verbale che
vuole vederci chiaro lamentando “l’assenza di un’adeguata e dettagliata
indicazione dei costi e della ratio sottesa alla spesa”. Ma poi la sua uscita
non sortisce effetti. Gli spiegano che a fare le gare è la Consip e che
l’aumento deriva anche da questo (!)».
Ma non finiscono qui le
bizzarrie per Rizzo. Nel mirino del suo racconto entra pure Frattini e la sua
nomina nell’aprile 2021 a Presidente aggiunto del CdS, contro la quale fa
ricorso il consigliere di Stato Giuseppe Severini: «dei trentatré anni e mezzo
trascorsi dal giuramento come consigliere di Stato alla nomina come numero due
di Palazzo Spada, Frattini ne ha passati decisamente più della metà a fare
politica, in aspettativa. Esattamente, precisa il ricorso di Severini, diciotto
anni e mezzo». Ma non c’è nulla da fare, tutto regolare perché con una
motivazione che «assomiglia a un triplo salto mortale con doppio carpiato del
maestro di sci Frattini» si dice che «l’aspettativa presa per ragioni “extra
istituzionali”, come quelle politiche, si può equiparare al cosiddetto “fuori
ruolo”. Che cosa significa? In sostanza, un consigliere di Stato che va in
aspettativa perché viene eletto alla Camera con un partito, e perciò non prende
lo stipendio, è come se andasse a fare il capo di gabinetto di un ministero
conservando la busta paga». La vicenda di cui parliamo per Rizzo «sta a
dimostrare quanto sia robusto il cordone ombelicale di certa magistratura con la
politica. E quanto l’indipendenza del potere giudiziario possa rivelarsi in
determinate circostanze un concetto abbastanza vacuo».
Da "la Verità" il 4 febbraio
2022.
Per gentile concessione
dell’autore e dell’editore, pubblichiamo stralci da Potere assoluto, ultimo
libro di Sergio Rizzo in vendita da oggi (Solferino libri, 256 pagine, 17 euro).
Il popolare giornalista si concentra su influenza e soldi attorno ai magistrati
più potenti d’Italia: Csm, consiglieri di Stato, procuratori. Il brano proposto
tocca il tema dei corsi di formazione dei magistrati, assurto alle cronache per
il «caso Bellomo».
Ma, al di là delle vicende
pecorecce, Rizzo dà conto dell’intreccio di società decise a difendere fatturati
pazzeschi: sono quelle che organizzano appunto le docenze per preparare le
future toghe agli esami. Tra i protagonisti di queste società occupa un posto di
primo piano Maria Elena Mancini, moglie di Roberto Garofoli, potente uomo di
Stato che, a seguito di un lunghissimo cursus honorum, è oggi sottosegretario di
Mario Draghi a Palazzo Chigi.
L'epicentro delle scuole di
formazione è in Puglia, fra Bari e il circondario. Prendiamo la storia della
Dike Giuridica Editrice. Tutto comincia l'11 dicembre 2006, quando una giovane e
intraprendente signora barese, Sandra Della Valle, va dal notaio per costituire
una società, la Dea immobiliare. Quel nome però sopravvive pochi mesi. Il 24
maggio 2007, infatti, Sandra Della Valle ci ripensa. Si reca da un altro notaio,
questa volta a Palombara Sabina, nei pressi di Roma, e cambia tutto. La sua
società non si chiama più Dea immobiliare bensì Ildirittopericoncorsi.it.
E non si occupa di case e
terreni ma di corsi di formazione per i concorsi pubblici che deve sostenere chi
vuole fare, per esempio, il magistrato. Una metamorfosi assolutamente singolare,
dettata da chissà che cosa. Ma contestualmente alla modifica della denominazione
sociale e dello statuto arriva anche un secondo azionista, che rileva l'1%. Si
tratta di Nicola Campione. [...] Ancora pochi mesi e l'irrequieta imprenditrice
Sandra Della Valle torna dal medesimo notaio di Palombara Sabina per cambiare di
nuovo il nome della società. Che il 4 febbraio 2008 viene così battezzata con il
nome, si spera definitivo, di Dike Giuridica Editrice.
Scopo sociale: «Pubblicazione
e commercializzazione di opere prevalentemente in materia economico-giuridica» e
«l'organizzazione di corsi per la preparazione a esami universitari e concorsi
statali». Il rapporto d'affari fra la signora Della Valle e Nicola Campione
prosegue per anni evidentemente in modo prolifico, se il 4 dicembre 2017 i due
costituiscono un'altra società, stavolta in accomandita. Si chiama Training &
Law di Nicola Campione sas.
Oggetto, la «formazione
professionale, nonché la preparazione a esami universitari e concorsi pubblici»
e «la pubblicazione di opere editoriali prevalentemente in materie
economico-giuridiche». Praticamente la fotocopia dello statuto Dike. E stavolta
compare anche un terzo socio, appena diciottenne: Antonio Caringella, il figlio
di Sandra Della Valle e di suo marito Francesco Caringella. Proprio lui. Perché
la proprietaria della società Dike nonché socia dell'attivissimo Campione è la
consorte di uno dei consiglieri di Stato più noti e stimati nel circuito della
magistratura amministrativa. Francesco Caringella, nato, come la moglie, a Bari,
è dal 1998 al Consiglio di Stato, dove ha scalato i gradini più impervi
raggiungendo l'invidiabile posizione di presidente di sezione. [...]
Caringella è diventato fra i
consiglieri di Stato una specie di recordman degli incarichi «extragiudiziali»
di insegnamento. A dire la verità ha fatto anche una puntatina nel mondo degli
arbitrati, come presidente del collegio che doveva decidere la controversia da
15 milioni fra la Fiat e la Tav. Ma niente al confronto dell'attività didattica,
regolarmente autorizzata dal Csm del Consiglio di Stato: in una decina d'anni ha
superato agevolmente 300.000 euro di compensi per le sue lezioni.
Pagate anche 800 euro l'una.
Dal 2008 ha collezionato quasi una ventina di incarichi, tutti in società
private di corsi di formazione e preparazione per concorsi da magistrato o
esperto giuridico. Legate, all'apparenza, da uno stesso filo rosso barese. Nella
lista non poteva mancare la Dike di sua moglie, presso cui il Consiglio di
giustizia amministrativa lo ha autorizzato nel 2019 a tenere un corso che gli ha
fruttato 60.000 euro lordi. Poi c'è l'Accademia Juris Diritto Per Concorsi, una
srl di Bari di proprietà del barese Carlo Giampaolo.
Ha un indirizzo di posta
elettronica certificata curiosamente identico alla penultima denominazione
sociale assunta dalla Dike: ildirittopericoncorsi@pec.it. Talmente identico che
assai difficilmente ci può essere un caso di omonimia. Soprattutto ci sono la
Lexfor e la Corsolexfor, da cui Caringella ha avuto una dozzina di incarichi di
docenza. Si tratta di società che fanno capo al socio della consorte, Nicola
Campione, barese, classe 1964: il quale risulta in entrambe azionista di
minoranza con altri due soci baresi, ma è amministratore unico. [...]
Per la serie poi «le
coincidenze non esistono», la Corsolexfor di Campione, socio della moglie di
Caringella, ha sede a Molfetta, trenta chilometri da Bari. E in via San
Francesco d'Assisi al numero 51. Dove si trova una sorpresa. Lo stesso indirizzo
ospita anche tre società operative nello stesso campo dei corsi di formazione
per esami e concorsi pubblici e dell'editoria giuridica. Neldiritto Editore srl,
Nld Concorsi e Omniaforma sas, queste le tre sigle, hanno anche la medesima
proprietaria originaria di Bisceglie, altra città sempre vicino a Bari: Maria
Elena Mancini.
Un'altra moglie. Maria Elena
Mancini è infatti la consorte di Roberto Garofoli. Consigliere di Stato fra i
più conosciuti e influenti, già capo di gabinetto del ministro della Pubblica
amministrazione e poi presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi,
nonché dei ministri dell'Economia Pier Carlo Padoan e Giovanni Tria. Fino
all'incarico più prestigioso e politico: sottosegretario alla presidenza del
Consiglio, braccio destro del capo del governo Mario Draghi. Garofoli, pugliese
di Taranto, mostra una tale passione per l'insegnamento al punto da tallonare da
vicino per numero di incarichi «extragiudiziali» didattici autorizzati il suo
collega e amico Caringella.
Un paio li ha svolti presso la
società Neldiritto di sua moglie Maria Elena Mancini. Ma la stragrande
maggioranza commissionati sempre da Lexfor e Corsolexfor di Nicola Campione:
talvolta in parallelo con Caringella. [...] Le società di formazione dal
pedigree barese (una decina), ruotano intorno alle figure di alcuni magistrati.
Tutte o quasi sono diventate operative a cavallo del 2007-2008, quando è
iniziato il boom delle scuole private per i concorsi di giustizia. Da allora e
fino alla fine del 2019, secondo quanto è stato possibile calcolare, hanno
incassato 66,1 milioni.
Con utili netti per 7,8. Il
tutto ampiamente per difetto perché i bilanci delle società in accomandita
semplice non sono reperibili nelle banche dati delle imprese di capitali. Il
solo fatturato delle due srl di Maria Elena Mancini, la moglie di Garofoli, ha
quasi raggiunto 30 milioni: 29 milioni 937.000 euro. E gli utili netti sono
ammontati a 2 milioni 248.000 euro. La Dike di Sandra Della Valle, moglie di
Caringella, ha registrato un giro d'affari di 14 milioni 251.000 euro, per
410.444 euro di utili netti.
Nel 2019 Sandra Della Valle ha
poi venduto la propria quota, allora del 94%, all'avvocato di Bari Marco
Giustiniani per 115.000 euro. Nei soli anni successivi al 2015, quando
Corsolexfor e Lexfor hanno abbandonato lo status di accomandite per trasformarsi
in srl, le attività di Nicola Campione e degli altri azionisti hanno sommato
ricavi pari a 7 milioni 513.000 euro, e profitti netti per 1 milione 684.000
euro. Ancora. Alla Accademia Juris, società di Carlo Giampaolo, i corsi hanno
fruttato 622.000 euro di utili netti, su un fatturato di 6 milioni e mezzo. E
poi dicono che in Italia la giustizia non funziona.
Caiazza: «Che assurdità le
toghe che scrivono leggi per riformare se stesse».
Il presidente dei penalisti
italiani, Gian Domenico Caiazza: «Una riforma che deve intervenire sulla più
grave crisi della magistratura nella storia repubblicana non può essere scritta
a quattro mani con l'Anm». Simona Musco Il Dubbio il 3 febbraio 2022.
Altro che svolta: la nuova
riforma del Csm «sarà scritta dai magistrati, con un metodo parasindacale». A
dirlo è Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione delle Camere penali,
secondo cui per affrontare la crisi della magistratura sarebbe stato necessario
affrontare il problema delle valutazioni di professionalità – positive quasi nel
100% dei casi – e dei fuori ruolo. Temi sui quali è proprio l’Ucpi a lavorare
per una riforma di iniziativa popolare. «In questo progetto di riforma – spiega
Caiazza al Dubbio – si parla solo di sistema elettorale. E francamente non è
questa la soluzione alla crisi».
La nuova riforma del Csm è
attesa come una svolta. Ma a conti fatti saranno gli stessi magistrati a
decidere quale sarà il loro futuro, col rischio che tutto cambi affinché nulla
cambi.
Questa riforma, diversamente
da quella sul processo penale, che ha coinvolto molti più soggetti, tra cui noi,
è in corso di definizione tra il governo e l’Associazione nazionale magistrati,
secondo una logica parasindacale. Ma una riforma che deve intervenire sulla più
grave crisi della magistratura nella storia repubblicana non può essere scritta
a quattro mani con l’Anm. Mentre noi penalisti siamo stati, credo proficuamente,
coinvolti nella riforma del processo penale, qui siamo stati tenuti fuori, come
chiunque altro. Ed è significativo. Questa è la prima osservazione di metodo.
Il dibattito si sta
concentrando essenzialmente sul sistema elettorale, come se fosse l’antidoto
ultimo alla crisi. Basta?
No. È un aspetto che
consideriamo marginale rispetto alle ragioni della crisi della magistratura.
Immaginare che si possa riformare l’ordinamento giudiziario modificando il
sistema elettorale del Csm è una sorprendente illusione, che ha colpito anche la
politica, negli anni. Non crediamo che ci saranno grandi differenze, qualunque
modifica si riuscirà a fare.
Sorteggio compreso?
Il sorteggio avrebbe
certamente un impatto molto forte. Anche se comprendiamo che si arrivi a questa
idea per disperazione, da parte di chi vuole riformare, a noi penalisti l’idea
del sorteggio non piace. È e rimane una sgrammaticatura democratica, una
soluzione disperante e disperata. Se siamo a un livello di crisi così
ingovernabile da avere il bisogno sorteggiare i componenti di un organismo
costituzionale di quell’importanza siamo veramente alla frutta. Se poi dobbiamo
prendere atto che siamo alla frutta va bene.
Quali sono i problemi da
affrontare con priorità?
In primo luogo il problema
della progressione delle carriere. Il motivo per il quale il sistema delle
nomine non funziona, con le sue derive correntizie, è che le carriere procedono
automaticamente, come è noto, con valutazioni positive oltre il 99%. Così,
quando si deve scegliere un procuratore capo o il presidente di una Corte
d’Appello, si troveranno sempre cinque o sei magistrati che avranno lo stesso
curriculum e saranno considerati equivalenti. È naturale, con questo
appiattimento.
La grande riforma della
magistratura passa dunque, prima di tutto, dalla riforma dei meccanismi di
progressione di carriera e quindi della valutazione di professionalità, che
avrebbe anche il pregio di responsabilizzare il magistrato per ciò che fa. Se il
magistrato non risponderà mai a nessuno della qualità del proprio lavoro, come
succede adesso, sarà totalmente deresponsabilizzato, perché tanto andrà avanti
ugualmente. Di tutto questo, nel progetto di riforma, non c’è nulla, se non
l’introduzione di un ulteriore livello di giudizio. Ma è una cosa assurda.
La vicenda dei vertici della
Cassazione ne è un esempio?
I ricorsi al Tar riguardano
un’enorme quantità di nomine di magistrati, in tutta Italia. Dovrebbe essere la
magistratura a capire, per amor proprio, che deve recuperare dei meccanismi di
merito nell’avanzamento delle carriere, in modo da non dover vedere sindacare
ogni cinque minuti le proprie scelte e le proprie stesse regole. Sa, le
circolari sulle valutazioni quadriennali sono severissime e presuppongono
un’analisi veramente approfondita per far andare avanti chi merita e lasciare
indietro chi non merita. Ma è carta straccia.
Questa valutazione è stata
annientata, in nome di principi di autonomia e indipendenza, con la conseguenza
che non si sa più chi sia capace e chi no. E lo decide il Consiglio di Stato, il
che crea un problema di tensione istituzionale molto forte tra magistratura
ordinaria e amministrativa. Quest’ultima vicenda è clamorosa perché colpisce i
vertici della magistratura, e grave perché queste decisioni non possono
intervenire dopo due anni che si esercitano le funzioni. Ma non è una cosa
nuova: è la conseguenza di quella gravissima disfunzione. È proprio per questo
che noi stiamo lavorando a due grandi leggi di iniziativa popolare su distacchi
dei magistrati e valutazioni professionali. Lavorandoci posso dire che non è
facile costruire un’alternativa. Quindi non banalizzo, ma bisogna farlo.
L’altro tema è, appunto,
quello dei fuori ruolo, sul quale più volte l’Unione delle Camere penali ha
posto l’accento.
Abbiamo appreso con
soddisfazione dell’inserimento di una delega che prevede, molto genericamente,
una riduzione del numero dei magistrati fuori ruolo presso l’esecutivo. È un
piccolo segnale di attenzione nei riguardi di una tematica cruciale, perché
questa è una cosa unica al mondo. Ma dovrebbe essere una riduzione prossima
all’azzeramento: non si capisce per quale ragione un magistrato che vince un
concorso dovrebbe andare a fare una cosa diversa dal concorso che ha vinto,
laddove poi c’è una carenza di giudici e di magistrati. E non è solo un problema
di percentuale, ma anche di ruoli apicali, cioè politici, che dovrebbero essere
preclusi al magistrato, per evitare la commistione tra potere giudiziario e
potere esecutivo. Ci vadano i funzionari di carriera, i professori universitari:
perché ci deve andare un magistrato? Noi pensiamo che le leggi le facciano il
Parlamento e il governo e che la magistratura le applichi. Questa cosa che la
magistratura debba scrivere le leggi e soprattutto su se stessa e sulla riforma
di se stessa a noi pare un’assurdità.
Altro punto è la presenza
degli avvocati nei consigli giudiziari.
E si torna al grande tema
della valutazione professionale. Nel momento in cui diciamo che bisogna far
saltare in aria questo sistema ipocrita delle valutazioni quadriennali, un ruolo
importantissimo sarebbe proprio quello degli avvocati. La loro è la voce del
foro. Guardi, capisco la delicatezza, perché il diritto di voto dell’avvocatura
nei consigli giudiziari diventa un’assunzione di responsabilità enorme ed esige
una indipendenza di giudizio veramente straordinaria, perché l’avvocato dovrà
esprimere un giudizio sui magistrati con i quali deve lavorare tutti i giorni.
Siamo consapevoli che si tratti di qualcosa che richiede un impegno formidabile,
anche eticamente. Ma come si può immaginare che la voce dell’avvocatura non
debba avere peso nel giudizio dell’operato di un magistrato?
·
I Top Manager.
Giovanni Bazoli:
«La P2 non finì con Calvi e cercò di ostacolarmi. Convinsi Berlusconi a comprare
il Milan».
Aldo Cazzullo su Il Corriere della Sera l’11 dicembre 2022.
I 90 anni
dell’avvocato e banchiere: «Da bimbo fui nascosto in una casa di Paolo VI. Vidi
Moro, ebbi un presagio»
Giovanni Bazoli,
qual è il suo primo ricordo?
«Una passeggiata con
mio padre Stefano e mio fratello Luigi, sui monti sopra il Tonale. Una fatica
improba; ma non potevo arrendermi. A dire il vero, mi sembra di ricordare pure
mia madre; anche se è impossibile».
Perché?
«Morì che avevo tre
mesi».
Per le conseguenze
del parto?
«No. Si ferì alla
guancia con una rosa, nel giardino di casa, a Brescia. Con gli antibiotici o
almeno i sulfamidici sarebbe guarita in sette giorni. Invece in sette giorni
morì. Papà ci ha lasciato un diario dell’agonia, per raccontarci chi fosse
nostra madre, Beatrice Folonari. Ancora adesso non riesco ad aprirlo senza
emozione».
Suo padre si
risposò?
«No. Era un uomo
esuberante e aveva solo 32 anni. Ci andò vicino alcune volte, ma rinunciò: non
voleva darci una “matrigna”, come si diceva allora. “Tutto è morto con Bice”
scrisse. Da allora visse ogni cosa con un distacco di fondo: un suo amico
osservò che gli eventi gli giungevano come un “ronzio di api”. L’unica ragione
di vita eravamo noi figli. Papa Paolo VI mi disse una volta di aver conosciuto
mia mamma, descrivendola come una donna “bella, intelligente, buona”. In
quest’ordine».
Paolo VI per lei era
una figura di famiglia.
«Suo fratello
Ludovico Montini era socio nello studio legale di papà; poi si aggiunse Gianni
Martinazzoli, il fratello di Mino. Durante l’occupazione nazista eravamo
nascosti a casa di Vittorio Montini, il cugino del futuro Papa».
Come andò?
«Mio padre era
legato agli ambienti antifascisti di Brescia. Quando doveva vestirci da balilla,
recitavamo una giaculatoria da lui coniata contro il Duce. Durante la guerra fu
arrestato e scarcerato. Quando stavano per tornare a prenderlo e deportarlo in
Germania, fuggì con me e Luigi in Val Trompia, sopra Concesio, in un rifugio
quasi inaccessibile, dove si arrivava solo a piedi».
Concesio è il paese
natale di Paolo VI.
«Infatti il rifugio
apparteneva alla sua famiglia. Quando non ce la faceva più a stare chiuso, papà
saliva la montagna con la gerla da contadino sulle spalle. La domenica, mentre
lui restava nascosto, mio fratello e io scendevamo in paese per la messa e il
pranzo a casa Montini, dove il Papa era nato e che ora è sede dell’istituto
Paolo VI. Un giorno vidi un rastrellamento: i militi fascisti e le SS gettavano
gli uomini a forza sui camion, le donne piangevano disperate, una scena
terribile... Andavo in bici a lezione dal parroco di un paese vicino, una volta
mi buttai in un fosso per sfuggire a un mitragliamento. Arrivavano notizie
terribili: conoscenti impiccati o morti nei lager. Ma Radio Londra assicurava
che la fine della guerra era vicina».
Com’era il vostro
rifugio?
«Una casupola
abbandonata, con una stanza al pianterreno, un’altra di sopra, e il bagno fuori.
La notte bisognava stare al buio per non attirare le bombe di Pippo, l’aereo
inglese. Sotto le coperte, alla luce di una lampadina senza pila che tenevo
accesa muovendo di continuo la mano, lessi un intero libro d’avventure, “La
tragedia di Mountheron”. Ogni sera nostro padre ci leggeva un capitolo del Don
Chisciotte. Spesso, in risposta a una mia domanda ingenua — a cosa serve la
poesia? —, recitava Dante e Manzoni».
Come ricorda la
liberazione?
«Ricordo una fila di
autocarri che scendono dalla valle verso la città, pieni di partigiani che
sventolano bandiere, e la gente ai lati della strada, felice, festante. Recitai
a mio padre: dagli atri muscosi dai fori cadenti... Lui rispose: lo vedi a cosa
serve la poesia?».
E la battaglia
elettorale del 1948?
«Andai ad ascoltare
il comizio di De Gasperi a Brescia. Non era un grande oratore, oggi forse
avrebbe difficoltà a imporsi come leader; ma all’epoca conquistava la folla con
le buone ragioni. Andai anche al comizio di Togliatti, ma con sospetto: era il
nostro avversario».
Suo padre, già
eletto nel ’46 alla Costituente, divenne deputato.
«Però nel ’53 la Dc
bresciana non lo ricandidò. Anche mio nonno Luigi, tra i fondatori del partito
popolare, nel 1919 era rimasto fuori dal Parlamento, ma per sua scelta. “Roma è
pericolosa” ammoniva».
Non c’erano donne
nella sua vita?
«A parte la balia,
mi fece da mamma zia Anita: una ragazza figlia di un setaiolo della Val Trompia,
fallito dopo la stretta monetaria di Mussolini, che aveva messo fuori mercato la
filiera della seta. Anita si era adeguata a fare lavori umili per mantenere il
papà, che viveva una vita poverissima. Una santa. È morta in casa nostra a 93
anni».
Aldo Moro l’ha mai
conosciuto?
«L’ho visto. Una
volta accompagnai mio padre a salutarlo, a messa, a Ortisei. Un’altra volta
andai a sentire una sua conferenza in un teatro di Brescia, all’uscita lo
attendevano alcuni contestatori. Quando Moro passò, ebbi netta la sensazione di
una tragedia incombente sul suo capo: come se fosse una vittima designata. Ho
sempre avuto presentimenti».
Questi presentimenti
l’hanno mai guidata nelle decisioni cruciali della sua vita?
«No. Non vengono a
comando. Spesso sono futili. E divertenti».
Ad esempio?
«Amo il bel calcio,
e quest’anno ho seguito il Napoli, che finora ha perso una sola partita, a
Liverpool. Su una punizione ho sentito chiaramente che il Napoli avrebbe
segnato, ma poi avrebbe subito due gol. È finita così, anzi peggio perché poi il
gol del Napoli l’hanno annullato per un fuorigioco millimetrico».
Dopo la laurea lei
andò a vivere a Milano con Nino Andreatta.
«Mi ospitò in un
piccolo appartamento in via Durini. Un giorno ci trovammo chiusi in casa, perché
la porta aveva una serratura particolare: anche per uscire ci voleva la chiave,
e Nino, genio distratto, ovviamente l’aveva persa. Allora lui si mise a
cavalcioni sul davanzale della finestra, per richiamare l’attenzione dei
passanti che venissero a liberarci...».
Nel 1982 fu
Andreatta, con Ciampi, ad affidarle l’Ambrosiano dopo il drammatico fallimento.
«Era una sera di
fine luglio. Nel salone delle assemblee della Banca d’Italia, con il governatore
e il direttorio, c’erano i rappresentanti delle sette banche che avevano
accettato la proposta respinta dalle grandi banche milanesi: farsi carico
dell’Ambrosiano dopo il crac e la morte di Calvi. Quando fu annunciato che il
nuovo presidente era Bazoli, tutti si guardarono attorno: non mi conosceva
nessuno».
E lei?
«Mi alzai in piedi e
dissi: Bazoli sono io. Ma non ho ancora accettato, anzi ho molte riserve».
Chi la convinse?
«Ciampi e Andreatta
mi presero sottobraccio e mi portarono in giro nei corridoi della Banca
d’Italia. “Non posso accettare, sono un giurista non un economista” dicevo. “Se
è per questo io sono laureato in lettere” rispose Ciampi. “E poi per il lavoro
che l’attende la sua preparazione giuridica tornerà utilissima”. Ma la frase che
mi convinse fu un’altra».
Quale?
«Andreatta disse,
con aria delusa: “Pensavo che fosse venuto anche per te il momento di uscire
dalla tua vita riservata e tranquilla, di fare qualcosa per il tuo Paese. Ma se
non ti senti di assumere questa responsabilità, non insisto”. Ci rimuginai per
ore. E accettai».
Per Ciampi e
Andreatta.
«Non solo. Allora si
parlava di Sindona e di Calvi come di “banchieri cattolici”. Mi proponevo di
dimostrare che un cattolico si può occupare di finanza in modo corretto.
All’epoca ero più ingenuo di oggi, più convinto che gli esempi servissero. E
volevo dare un esempio non solo di legalità, ma anche di non avidità».
Qualcosa avrà pur
guadagnato.
«Certo, quanto mi
permette di vivere bene. Ma ho rinunciato all’avvocatura, e in alcuni decenni ai
vertici del sistema non mi sono arricchito. Le disuguaglianze eccessive stanno
distruggendo la democrazia».
Nella costruzione di
quella che sarebbe diventata la più grande banca d’Italia, lei si scontrò con
Cuccia. La Comit voleva comprare la sua Ambroveneto; alla lunga ha comprato lei
la Comit. Come andò?
«Dopo l’aggressione
fallita della Comit nel 1994, tra me e Cuccia erano iniziati colloqui riservati.
Venne anche a casa mia a Brescia. Due anni dopo, nell’ottobre del ‘96, fu messa
in vendita la Cariplo. L’acquisto si presentava molto interessante sia per noi
sia per la Comit. Ma erano passate poche settimane dalla morte improvvisa di mio
fratello, e non me la sentivo di affrontare un’altra battaglia con Comit e
Mediobanca. Così pensai di chiedere a Cuccia se sarebbe rimasto neutrale».
E lui?
«Gli confidai subito
il mio stato d’animo, così angosciato da farmi pensare di ritirarmi dalla banca.
Cuccia mi interruppe: “La posso comprendere, Bazoli. Due giorni fa, dopo
sessant’anni di vita insieme, ho perso mia moglie”. La notizia era stata tenuta
riservata; e lui non aveva disdetto l’appuntamento. Profondamente commosso, mi
alzai. Ci abbracciammo».
Con Berlusconi che
rapporto ha avuto?
«Non ci siamo mai
scontrati, nonostante le mie idee politiche, che notoriamente non coincidono con
le sue, e l’amicizia con Prodi. Conosco Berlusconi da quando era soltanto un
imprenditore di successo. Lo incoraggiai a comprare il Milan».
Berlusconi non
voleva?
«Temeva, comprando
una squadra, di perdere la simpatia dei tifosi delle altre; e lui voleva piacere
a tutti. Gli feci notare che, come dimostrava Agnelli, possedere una squadra non
impediva di essere ammirato, anzi».
È vero che Agnelli
le affidò il Corriere in punto di morte?
«Lo vidi per
l’ultima volta quando era molto grave e sofferente. Era il giorno in cui si
presero a Torino decisioni drammatiche per la Fiat: fu respinta l’idea di
Mediobanca, che voleva affidarla a Bondi e ridimensionarla. Parlammo per più di
mezz’ora. Agnelli mi disse: “In Rizzoli abbiamo fatto un buon lavoro. Ho detto
al mio avvocato di non prendere nessuna decisione senza parlare con lei”».
L’avvocato
dell’Avvocato era Franzo Grande Stevens.
«E Grande Stevens mi
riferì di aver capito che la raccomandazione fosse più vasta: parlare con me non
solo di Rizzoli, ma di tutto».
Perché, secondo lei?
«Perché Agnelli mi
trovava diverso dagli uomini che frequentava. Curiosissimo com’era, voleva
sapere cosa fosse mai questo mondo che non conosceva, le banche cattoliche...».
Con Berlusconi lei
rischiò di incrociare le armi nella campagna elettorale del 2001. Andreatta la
indicò in un’assemblea dei parlamentari del centrosinistra come candidato
premier ideale. E tentò di convincerla.
«Era il 7 dicembre
1999. Andammo alla prima della Scala, Muti diresse magistralmente il Fidelio,
ricordo Nino in piedi che non smetteva di applaudire. Il mattino dopo le mogli
uscirono a passeggio, e lui mi parlò per due ore, nel tentativo di persuadermi.
Poi andammo insieme a messa in Duomo. Io non gli dissi di sì, anzi, obiettai che
dovevo occuparmi della fusione tra Comit e Cariplo. Ma lui tenne lo stesso quel
discorso ai parlamentari; anche se non fece il mio nome, parlò genericamente di
un federatore...».
Pochi giorni dopo,
il 15 dicembre, Andreatta entrò in coma. Sarebbe riuscito a convincerla a
sfidare Berlusconi?
«Non lo so. Certo
quel discorso di Nino sulla responsabilità aveva avuto su di me una certa presa…
Comunque alla fine dissi no a Prodi, a Bruxelles, dove presiedeva la Commissione
europea».
Andreatta morì oltre
sette anni dopo, senza aver mai ripreso conoscenza.
«Sua moglie Giana e
i figli furono straordinari. Io andavo regolarmente a trovarlo. Non saprò mai se
mi riconoscesse. Mi piace pensarlo felice, come quando andavamo insieme in
vacanza al mare, in Grecia o in Turchia. Nino non sapeva nuotare, ma volle
imparare: legato alla barca, con il salvagente, si compiaceva dei suoi
progressi, come un gigantesco bambino. Dopo la morte di Luigi, era diventato per
me come un fratello».
Luigi Bazoli morì in
un incidente stradale.
«Dopo aver perso la
moglie Giulietta nella strage fascista di piazza della Loggia. Lasciarono tre
figli. Confesso che per molto tempo non sono riuscito ad accettare la sua
morte».
Eppure lei una volta
ha detto: «Senza la Provvidenza, non avrei fatto nulla». Quindi crede alla
Provvidenza.
«Sì. La Provvidenza
è la risposta di Dio alle preghiere degli uomini. Ed è meraviglioso pensare che
ciò possa avvenire attraverso i santi, le persone morte che ci hanno amato.
L’intero Vangelo non è che un invito a pregare: “Chiedete e vi sarà dato”. La
liturgia è preghiera: la Chiesa non fa altro che pregare. Ma la fede del
credente incontra sempre momenti di prova: perché resta da spiegare la preghiera
non esaudita. Il male, la sofferenza, l’ingiustizia. E oggi, per la prima volta
nella storia, la scienza offre risposte alternative, sino a mettere in crisi
l’idea stessa di creazione. Anche per questo il mondo ha sempre meno fede».
Com’era il suo
rapporto con il cardinal Martini?
«All’inizio mi
accolse con freddezza. Calvi finanziava la Biblioteca Ambrosiana, e
l’arcivescovo temeva che il rapporto si interrompesse. Dovevamo vederci per un
primo incontro di cortesia; restai con lui un’ora e mezza. Nacque una
consuetudine. Una volta gli dissi che alla Chiesa occorreva un nuovo Tommaso,
una nuova Summa. La volta successiva mi mise ko. Si era presentato con un tomo
gigantesco di un gesuita sul metodo: “Cominci da qui!”».
Poi però non deve
offendersi se Dagospia la chiama Abramo Bazoli.
«Infatti non mi
offendo. Non sono particolarmente suscettibile».
Com’è morto Calvi?
«Ormai è provato che
sia stato ucciso. Sulla banca la sua figura è rimasta a lungo come un’ombra.
Molti anni dopo la sua morte, al ritorno da una riunione del Fondo monetario a
Washington vennero a prendermi all’aeroporto e mi portarono di corsa da Passera,
allora amministratore delegato, che mi informò con grande allarme e cautela,
temendo di essere spiato, che era stata rinvenuta una cassetta di sicurezza
intestata a Calvi...».
E cosa c’era in
quella cassetta?
«Niente. Dei
giornali. E un mattone. Non si è mai saputo che cosa significassero. Certo,
quando fu ucciso, aveva dei mattoni al collo».
Che idea si è fatto
della P2?
«Era strettamente
intrecciata al mondo di Sindona e Calvi. Sopravvissuta a loro, ha cercato in
tanti modi e in diversi tempi di ostacolare il cammino del Nuovo Banco,
l’operazione di pulizia affidatami da Ciampi e Andreatta».
Pensa che ci fosse
lo zampino della P2 pure nel processo di Bergamo, quello per la Banca Ubi, da
cui lei è stato assolto in primo grado?
«Sarò ingenuo, ma
non lo credo. A mio parere, il processo è originato da gravi contrasti nel mondo
bergamasco. Non ne posso parlare perché il pm ha fatto ricorso, non è ancora
finita. Certo, si è trattato di un’esperienza terribile: sono stato
intercettato, mi hanno pedinato come un malfattore. E ancora oggi mi pare
paradossale, incredibile, essere stato imputato di ostacolo alla vigilanza».
Perché?
«Perché tutto quello
che ho fatto è stato appoggiato dalla Banca d’Italia. Legga cosa mi scrisse
Ciampi alla fine della mia presidenza: “Il Paese, caro Bazoli, deve esserti
grato per il servizio reso in trent’anni di attività, prestato con spirito
disinteressato e con grade signorilità...”».
Come giudica il
governo Meloni?
«Mi sono imposto di
mettere da parte ogni pregiudizio ideologico. Riconosco l’alto significato
democratico dell’ascesa al potere di una giovane donna, senza nulla alle spalle
che l’abbia favorita, guidata soltanto dalla sua intelligenza e volontà. Concita
De Gregorio l’ha definita una fuoriclasse. Lo sarebbe se alzasse il livello
della politica riportando l’Italia a un ruolo di primo piano in Europa, come era
riuscito a Draghi. Altrimenti, il suo successo sarà effimero e di breve durata,
come è accaduto ai suoi predecessori».
C’è un leader che
può salvare il centrosinistra?
«Il problema non è
il leader; è l’anima del partito. A Enrico Letta, più che la colpa di non aver
realizzato una missione impossibile, dovrebbe essere riconosciuto il merito di
aver schierato il Pd sulla linea atlantica».
E il suo
quasi-genero Beppe Sala?
«Ha fatto bene a
resistere alle tante sollecitazioni che ha ricevuto. E a ribadire che si sente
impegnato a fare il sindaco, dopo appena un anno dalla fiducia che i milanesi
gli hanno confermato».
In Lombardia il Pd
avrebbe dovuto sostenere la Moratti?
«Come molti elettori
del Pd, non mi sono per nulla ritrovato nella posizione presa dagli organi
regionali. Un partito di minoranza che, per dirla con Carlo De Benedetti, fa lo
schizzinoso con chi proviene dalla maggioranza, sceglie di restare minoranza».
Alla soglia dei
novant’anni, la morte le fa paura?
«Mi fa paura l’idea
del tempo che scompare. Vorrei avere ancora una stagione da vivere per le tante
cose incompiute. Nonostante la speranza, il passaggio è traumatico».
Come immagina
l’Aldilà?
«Va ripensato il
concetto di anima, che fa parte della nostra educazione tradizionale, ma è di
derivazione platonica. Il Vangelo promette molto più dell’immortalità
dell’anima; promette la resurrezione della carne. L’Aldilà sarà la ripresa di
questa nostra vita umana, ma del tutto rinnovata: senza più affanni, perché
liberata dal male. Sarà il ristoro dell’ingiustizia. Sarà illuminato il grande
mistero in cui siamo immersi».
Emma Marcegaglia: «Quando
papà fu rapito andai da un santone. So essere aggressiva».
Michela Proietti su Il
Corriere della Sera il 2 settembre 2022.
«Le donne in azienda fanno
casino». Alla battuta di Steno Marcegaglia, la figlia Emma ribatteva: «Anche io
papà sono una donna». «No, tu Emma non sei una donna». C’era già tutto il
percorso futuro di Emma Marcegaglia in quello scambio di battute tra un padre
capitano d’industria, fondatore della Marcegaglia Spa, e una figlia promettente
che avrebbe conquistato un incarico dietro l’altro, alcuni ricoperti per la
prima volta proprio da una donna.
Presidente di Confindustria
dal 2008 al 2012, presidente della Luiss dal 2010 al 2019, presidente di Eni dal
2014 al 2020. In qualche modo ha smentito suo padre? «Mio padre ha avuto sempre
molta fiducia in me, dandomi le pari opportunità di mio fratello Antonio: era un
sostenitore delle donne e ha sempre lavorato a fianco di mia madre».
Era orgoglioso del percorso
fuori dall’azienda? «Molto, ma mi riportava sempre con i piedi a terra. Ricevevo
i complimenti di Angela Merkel e il giorno dopo lui mi ricordava “sì, va bene,
ma ora risolviamo quella questione con la banca”. Una volta gli dissero: “Ah,
lei è il papà di Emma”. E lui: “No, Emma è mia figlia».
Altre battute che oggi
parrebbero strane? «Per mio padre un uomo in gamba era un “ragazzo da
marciapiede”. Un giorno per elogiarmi pubblicamente disse: “Emma è una ragazza
da marciapiede”...»
La sua infanzia. «Sono
cresciuta a Gazoldo degli Ippoliti, 1500 abitanti in provincia di Mantova. Le
compagne di classe erano le figlie degli operai di mio padre. Un’infanzia
serena, dove l’uomo nero era il comunismo: io e mio fratello orecchiando in casa
i discorsi tra i miei genitori quando giocavamo proteggevamo le mie bambole
dall’arrivo dei comunisti».
Dove si sono conosciuti i suoi
genitori? «In paese. Il parroco disse a mio padre: “Sposala, questa è una brava
ragazza”. Lui che era un mezzo genio scapestrato, nato poverissimo, ha ascoltato
il consiglio».
Un ricordo di suo
padre. «Avendo sofferto la fame quando ti vedeva lasciare qualcosa nel piatto ti
invitava a finirlo. Gli piaceva il diritto, ha cominciato a difendere i
contadini dai latifondisti: da ragazzo diceva che avrebbe voluto fare il Papa.
Lavorava 20 ore al giorno e fumava 4 pacchetti di sigarette».
Un ricordo di sua
madre. «Un’alleata di ferro per mio padre: quando papà venne rapito, neppure
cinque minuti dopo aver appreso la notizia, chiamò il direttore della banca per
andare a prelevare i soldi. All’epoca c’era il blocco dei beni. L’unica cosa che
papà non ha mai davvero superato è stata la malattia di mia mamma».
Che ricordi ha del
sequestro? «Avevamo un’azienda ad Arzano, in provincia di Napoli: venne rapito
di sera. In famiglia c’era una autentica disperazione: io e mia madre, due
persone parecchio razionali, andammo persino da un santone».
Avete mai pensato di non
rivederlo? «Il rischio fu concreto. I sequestratori erano dei ragazzotti, papà
diceva loro: “Se mi fate uscire di qui vi insegno a diventare ricchi in Borsa”.
Avevano abbassato la guardia e lui riuscì a fuggire. Venne però ripreso e
sarebbe stato ucciso se quel giorno un elicottero fosse stato in volo sopra
l’Aspromonte. In quel preciso posto c’era mio padre, che venne salvato».
Il momento del ritorno in
famiglia? «Prima di venire a casa è andato in azienda per vedere che tutto fosse
a posto e per rassicurare gli operai. Diceva che grazie al rapimento aveva
scoperto la fede».
L’imprenditore Steno
Marcegaglia (1930-2013) con il figlio Antonio (a sinistra) e la secondogenita
Emma
Lei è nata il 24 dicembre. In
famiglia si festeggiava più il Natale o il suo compleanno? «A Mantova in realtà
il Natale coincide con Santa Lucia, il 13 dicembre. La sfortuna è che il regalo
era uno solo: ma ho sempre puntato sulla qualità. Mio padre aveva l’abitudine di
viaggiare durante quei giorni: partivamo per la Malesia, la Persia e Bali con la
nonna materna e gli zii. Nove persone in viaggio, dei Natali non tradizionali».
Una donna internazionale ma
con Mantova nel cuore. «Ho fatto le scuole a Mantova, poi mi sono trasferita a
Milano per frequentare la Bocconi e in seguito a New York, dove ho trascorso gli
anni più formativi. Ma tra una tappa e l’altra tornare in una città piccola mi
rassicurava».
Gli Stati Uniti. «Otto mesi
intensi, bellissimi, con la tentazione forte, ogni tanto, di non tornare più.
Studiavo alla New York University a Wall Street ma abitavo ad Harlem alla
International House. Andavamo a ballare al Limelight o al Club 54. Mio padre mi
chiamava di sera e mi chiedeva: “Emma, ma tu torni, vero?”».
Il rientro in Italia. «Mia
mamma mi venne a prendere a Malpensa. Per me tornare in pianta stabile nel
paesino fu uno shock. Ho trascorso una settimana a letto, mi hanno fatta vedere
persino dai dottori, pensavano che in America mi avessero dato chi sa che cosa».
È sempre stato chiaro che lei
avrebbe lavorato nella azienda di famiglia? «Per tanti anni ho studiato danza
classica. Però ho sempre respirato l’aria della fabbrica».
Una giovane Emma Marcegaglia
mentre si esercita alla sbarra
Il suo ingresso alla
Marcegaglia Spa. «Non facile. Arrivavo per terza, dopo papà e mio fratello, ed
ero donna. Mio padre ebbe una intuizione felice: mi mandò a lavorare ad
Albarella, l’isola turistica nel Delta del Po dove il gruppo aveva concentrato
investimenti turistici e immobiliari. Un bel banco di prova».
Confindustria. «Dopo il
Consiglio direttivo dei giovani imprenditori di Mantova, mi venne proposto di
ricoprire l’incarico di vicepresidente nazionale. A 42 anni sono diventata
presidente. Mi piaceva mettermi alla prova su cose diverse».
È stata la prima donna a
ricoprire quell’incarico. «Anche in Luiss sono stata la prima donna».
Continui primati. «Sono stata
anche la prima presidente di Business Europe, la prima italiana dopo Guido
Carli. Sono stati i tedeschi i miei grandi sostenitori: mi dicevano che avevo un
carattere tedesco dentro a un corpo italiano».
Essere donna destava
perplessità? «Sedevo nei direttivi con Gianni Agnelli, Carlo De Benedetti,
Cesare Romiti: ero l’unica donna e avevo l’età dei loro nipoti. All’inizio mi
guardavano con l’aria “come è gentile e carina Emma”. Per un periodo ho
ascoltato senza intervenire troppo, poi a un certo punto ho alzato la mano e
hanno apprezzare anche le idee».
Un commento sul genere che
l’ha offesa? «Atteggiamenti. Del tipo: “Siamo sicuri che sei in grado di fare
questa cosa? “. Ho imparato ad essere umile, ma anche aggressiva: se qualcuno ti
sta per fare del male devi sbranare».
In cosa vengono più attaccate
le donne? «Nel loro essere donne: se una si fa sentire è subito un’isterica o
con gli ormoni sottosopra. Oggi va meglio, ma c’è ancora tanto da fare. Per
questo mi piace aiutare le donne più giovani a non fare i miei errori. Sono una
tutor».
Le quote rosa. «Se servono per
avere più donne al comando vanno bene: c’è il rischio che qualcuna non sia così
brava, ma pensiamo a quanti uomini poco competenti hanno avuto ruoli di potere».
Ha mai pianto sul posto di
lavoro? «Sì, ma più per emozione che per rabbia. Quando mi arrabbio mi
concentro, è più facile che pianga per gioia».
Il dress code di una donna al
comando? «Non mi sono maschilizzata, ho deciso che dovevo essere me stessa. La
divisa da lavoro mi ha sempre intristita, mi sento più a mio agio con un
bell’abito. Ma certamente un look “conforme” ti mette più al riparo».
Emma Marcegaglia ricevuta da
Papa Benedetto XVI nel 2009, quando ricopriva la carica di presidentessa di
Confindustria
Da ex Presidente dell’Eni come
vede la situazione energetica che si sta profilando in seguito al conflitto in
Ucraina? «Insostenibile. Il rischio che parecchie imprese decidano di fermare la
produzione o di chiudere è reale. E se un’azienda si ferma, si fermano anche i
lavoratori: il che vuol dire cassa integrazione e un inasprimento del clima
sociale, povertà per le famiglie e per il Paese. Non possiamo permettercelo.
L’Europa deve intervenire, ogni giorno che passa è tardi».
Lei conosce bene i
protagonisti della vita politica italiana: cosa si aspetta che facciano per il
Paese in un momento così delicato? «Che continuino ad agire e a reagire con la
stessa tempra di responsabilità, resilienza e dinamismo con cui nel corso della
nostra storia, abbiamo superato altre prove difficili, sovvertendo tutti i
pronostici e dimostrando al mondo che siamo un grande Paese».
Gli imprenditori che le piace
ricordare? «Primo tra tutti Vittorio Merloni: straordinario. Poi Giorgio
Squinzi, mio successore in Confindustria: una persona speciale».
I suoi predecessori in
Confindustria: Luca Cordero di Montezemolo «Un grande team maker. Ha
un’incredibile abilità nel saper scegliere le persone giuste per creare la
squadra vincente.
. «Il padre nobile di
Confindustria».
Eni. «Un anno dopo che è morto
mio padre, Matteo Renzi mi ha cercata. Ho chiesto a mio fratello e a mio marito.
Entrambi mi hanno detto di poter contare su di loro. È il luogo dove ho imparato
di più».
Sposata da 20 anni con
l’ingegnere Roberto Vancini e mamma di Gaia, 19 anni. «Con mia figlia ho un
rapporto meraviglioso. Da piccola ha sofferto la mia esposizione: la imbarazzava
una mamma con la guardia del corpo e spesso al tg. Quando la andavo a prendere
alle gite faceva finta di non conoscermi».
Un segreto del
successo? «Essere tranquilli anche a casa, con qualcuno su cui poter contare
sempre».
Montezemolo: «Io
figlio di Agnelli? Con mia mamma ci ridevamo su. Ma fu come un padre».
Aldo Cazzullo su Il Corriere
della Sera il 28 agosto 2022.
L’ex presidente della Ferrari e fondatore di
Ntv: «Marchionne voleva diventare primo azionista dell’azienda e mi ferì per il
modo in cui mi mandò via»
Luca di Montezemolo, qual è il suo primo
ricordo?
«Il vestito della domenica. E le gite fuori
porta in Vespa, attraversando una Bologna ancora semidistrutta dalla guerra:
papà alla guida, mamma dietro, io in mezzo, ovviamente tutti senza casco».
Com’era la sua famiglia?
«Vengo da due famiglie molte diverse. I
Montezemolo sono piemontesi, aristocratici, militari. Mio nonno era il
comandante di Bologna. Suo fratello, mio prozio Giuseppe, fu un eroe della
Resistenza, ucciso alle Ardeatine».
Tacque sotto le torture.
«Gli strapparono le unghie. Ma non tradì i
suoi uomini. Sono sempre stato molto vicino a sua moglie Iuccia e a suo figlio
Andrea, che divenne cardinale e fece gli accordi tra la Santa Sede e Israele».
E la famiglia di sua madre?
«Sono legatissimo a Bologna, dai nonni ho
preso i valori degli emiliani: gente di passione, con facilità di rapporti
umani, e capacità di inventarsi mestieri nuovi. Ho sempre avuto molti amici
veri, e diffidato delle persone senza amici. La mia formazione è stata diversa
da quella, che trovo un po’ provinciale, dei giovani della borghesia romana:
sempre insieme, all’Argentario e a Cortina... A me interessava conoscere il
mondo e frequentare tutti gli ambienti, il figlio di Susanna Agnelli e il figlio
del portiere; e mi è stato utile».
Preferibilmente il figlio di Susanna Agnelli.
«Innanzitutto Susanna Agnelli è stata una
donna di grande impegno sociale, che ha fatto moltissimo per i bisognosi e i
malati. Una delle cose di cui sono più orgoglioso nella vita è aver ereditato da
lei l’impegno di Telethon. E poi, sì, il mio primo amico è stato suo figlio,
Cristiano Rattazzi. Siamo anche stati insieme al collegio navale Morosini di
Venezia».
Lei però rimase solo un anno. Perché?
«Perché la carriera militare non faceva per
me. Tornai a Roma e studiai al Massimo, dai gesuiti».
Dove trovò Mario Draghi. Com’era?
«Ero in classe con Gianni De Gennaro, il
futuro capo della polizia. Draghi era in un’altra sezione. Un ragazzo molto
serio, con la passione della pallacanestro. I gesuiti furono un’ottima scuola.
Anche di fede».
Lei ha fede?
«Molta. Quando mi sento sfiduciato, mi chiudo
tre giorni nel santuario della Verna, dove san Francesco ricevette le stimmate;
e quando ne esco sono un altro uomo».
Lei è considerato un uomo di comunicazione, di
pubbliche relazioni.
«La verità è che io nella vita mi sono fatto
veramente il culo. Ho lavorato tantissimo. Di sabato, di domenica. Alla Ferrari
ho rivoluzionato la gamma dei modelli, rifatto la fabbrica, decuplicato il
fatturato, vinto 19 mondiali tra costruttori e piloti...».
Come conobbe Enzo Ferrari?
«Quando nel ’68 le università erano occupate,
Cristiano e io ne approfittammo per correre i rally. Eravamo bravini, fui preso
dalla Lancia. Un giorno ero ospite in radio: “Chiamate Roma 3131”, condotta da
Boncompagni. Chiamò un ragazzo per dire che l’automobilismo era uno sport per
ricchi; io risposi che non era vero, che Bandini era figlio di un meccanico...
Il caso volle che Ferrari stesse ascoltando. Telefonò: “Lei ragazzo ha gli
attributi, venga a trovarmi».
E lei?
«Io mi ero laureato in giurisprudenza e volevo
fare l’avvocato penalista. Ero entrato nel carcere di Porto Azzurro per
intervistare Fenaroli, quello del delitto. Poi avevo vinto una borsa di studio
alla Columbia. Ma nei primi giorni del gennaio 1973 andai a trovare Enzo
Ferrari; e lui mi chiese di fargli da assistente. I miei ci rimasero malissimo:
“Ti metti a giocare con le macchinine?”».
Di Ferrari raccontano fosse un uomo molto
duro.
«Aveva le sue manie: non è mai venuto a Roma
in vita sua, non ha mai preso un aereo o un ascensore, quando cedette la Ferrari
all’Avvocato la firma si fece al pianterreno di corso Marconi. Ma era un uomo
straordinario. Mi ha insegnato due cose: non arrendersi quando le cose vanno
male; chiedere sempre di più, a se stessi e ai collaboratori, quando le cose
vanno bene. Aveva un talento naturale per il marketing: il cavallino di Baracca,
le auto tutte rosse, l’accortezza di far aspettare anche se la macchina era
pronta. Ogni tanto arrivava in treno da Roma il decano dei concessionari, e
ripartiva con l’auto per il cliente. Era Vincenzo Malagò, il papà di Giovanni;
una volta andò via con una Rossa per Mastroianni. La Ferrari per Enzo era come
una donna bellissima, che si fa desiderare».
Luca Cordero di Montezemolo con Gianni Agnelli
(Fotogramma)
Ma non vinceva da tempo.
«Luglio 1973, Brands Hatch, il mio primo Gran
Premio. Qualifiche: Jacky Ickx sedicesimo, Arturo Merzario diciottesimo.
Telefona Ferrari: “Ci ritiriamo. Caricate le macchine sui camion e tornate a
casa”».
E lei?
«Lo convinsi a correre. Ma poi ci fermammo
davvero, per due gare. Cominciò la ricostruzione. Ci consigliarono Jean-Pierre
Jarier, ma io volevo prendere Niki Lauda, che aveva fatto bene con la Brm. Mi
sparò una cifra in scellini austriaci, dovetti andare in edicola a comprare il
giornale per sapere quanto chiedesse...».
Nei quattro anni successivi, Niki Lauda vinse
due Mondiali, ne perse altri due all’ultima corsa, e rischiò di morire bruciato.
«Dopo il rogo del Nurburgring andai in clinica
a parlare con il medico. Mi disse che la notte sarebbe stata decisiva: bisognava
tenerlo sveglio, perché aveva respirato gas velenosi, e doveva muovere i
polmoni. Niki sentì tutto. E restò sveglio. Quaranta giorni dopo era già in
pista a Monza. Quando indossò il casco si riaprirono le ferite, grondava
sangue».
Ma al Fuji, in Giappone, sotto la pioggia, si
ritirò.
«Forghieri gli propose: diciamo che hai un
problema alla macchina. Replicò: no, diciamo la verità; correre in queste
condizioni è una follia».
L’anno prima Lauda aveva vinto il Mondiale
proprio a Monza.
«Era il 7 settembre 1975: uno dei due giorni
più belli della mia vita, a parte quando sono nati i miei cinque figli. Clay
Regazzoni vince il Gran Premio d’Italia, e Lauda è campione del mondo. Telefono
a Enzo Ferrari, e intuisco che è commosso. Non l’avevo mai sentito piangere».
E l’altro giorno più bello?
«8 ottobre 2000. Michael Schumacher sta per
conquistare il titolo dopo 21 anni. L’Avvocato mi telefona quando mancano due
giri alla fine: “È fatta, grazie, grazie...”. Io sono superstizioso, e gli dico:
“Avvocato, aspettiamo...”. Ma sento che lui, come Ferrari, è commosso».
I festeggiamenti per la vittoria della Ferrari
al Mondiale in Malesia del 2000
Anche l’Avvocato non l’aveva mai sentito
piangere?
«Una volta, a Roma, all’ultimo concerto di
Frank Sinatra, ebbi l’impressione che si fosse emozionato, ascoltando My way».
Com’era l’Avvocato?
«Diverso da come lo raccontano. Ad esempio era
molto italiano».
Cosa intende?
«Amava il calcio, le auto. Non era affatto
disinteressato al cibo: la prima volta che da ragazzo andai a trovarlo
all’Argentario parlammo dell’olio toscano, quando veniva a Roma andavamo a
Fregene a mangiare il pesce. Era anche lui un po’ superstizioso. Soprattutto,
era legatissimo a Torino, al Piemonte. E voleva essere il primo promoter
dell’Italia in America, nel mondo».
Nacque la leggenda che lei fosse suo figlio.
«In famiglia ne sorridevamo: “Mamma, cos’hai
combinato?”. È vero però che per me è stato come un padre. Mi ha trasmesso la
curiosità per gli uomini, per il mondo, per l’arte contemporanea: la pop art e
l’arte povera, Lichtenstein e Alighiero Boetti, Warhol e Pistoletto... A Torino
abitavo sulla sua stessa collina, qualche tornante sotto. Ogni tanto mi
chiamava: “Vieni a vedere il secondo tempo di un film?”. Avvocato, ma perché il
secondo tempo? “Va bene, vediamo il primo, poi andiamo a dormire”».
Dopo la Ferrari la chiamò in Fiat.
«A riorganizzare le relazioni esterne. Poi a
dirigere la Cinzano. E a lanciare l’operazione Azzurra: un caso incredibile di
marketing nazionale».
Ma lei entrò in urto con Romiti, che non era
certo un suo estimatore.
«Abbiamo avuto alti e bassi. Romiti non era
una persona facile, come hanno sperimentato anche uomini del calibro di Ghidella
e De Benedetti. Io poi ho dovuto pagare il rapporto stretto che avevo con
l’Avvocato. Però fu Romiti, su suo input, a telefonarmi nel 1991 per propormi di
tornare in Ferrari. Temevo mi volesse come direttore sportivo, e mentre parlava
pensavo a una scusa per dire no».
Invece la fecero presidente e amministratore
delegato.
«I dipendenti erano in cassa integrazione.
Venne a trovarmi uno dei tre grandi che mi hanno sempre ispirato, Ralph Lauren,
un genio del marketing...».
Chi sono gli altri due?
«Michele Ferrero. Un genio del prodotto. Un
inventore: due giorni dopo che ero diventato presidente della Fiat, venne a
propormi una sua invenzione per coprire la 500 per quelli che non avevano il
garage... L’altro è Achille Maramotti, il fondatore di Max Mara».
Cosa le disse Ralph Lauren in Ferrari?
«Che si aspettava una fabbrica più high-tech.
Cambiammo tutto. Renzo Piano fece la galleria del vento. Chiamai Fuksas e Jean
Nouvel. Inventammo la Formula Uomo, mettendo al centro la qualità della vita
degli operai. Fummo i primi ad autoprodurre l’energia. Vincemmo il premio “The
best place to work in Europe”. Andammo in Cina. E rifacemmo la gamma dei
prodotti. Compresa la prima auto ibrida italiana».
Alla presidenza della Juventus non era andata
altrettanto bene.
«Fu un errore dire di sì. Dopo l’avventura
bellissima di Italia ‘90, non ne potevo più del calcio, di stadi, partite,
arbitri... Ma non potevo rifiutare. E poi l’Avvocato si era infatuato di
Maifredi. Era il tempo del Milan di Sacchi, e lui in fondo aveva sempre amato il
bel gioco: Sivori, Platini, Maradona, Baggio».
Nel 2000 l’Avvocato fu il testimone delle sue
seconde nozze.
«Arrivò un bellissimo piatto d’argento, lo
chiamai per ringraziarlo. Rise: “Quello sarà il regalo di Marella. Il mio lo
trovi dal concessionario Ferrari di Bologna”. Era una 360 barchetta, senza tetto
e senza vetro, disegnata apposta da Pininfarina. Lascerò scritto che non si
potrà mai vendere».
Lei a Torino ritornò da presidente della Fiat,
in circostanze drammatiche.
«In sedici mesi erano morti i due leader,
prima l’Avvocato, poi Umberto Agnelli. John Elkann era un bambino. La Fiat era
nelle mani delle banche. Ero stato eletto presidente di Confindustria il giovedì
mattina; Umberto morì la sera stessa. Due giorni dopo mi chiamò Susanna Agnelli,
con lei c’era tutta la famiglia. Passai una notte insonne. Poi capii che non
potevo dire di no».
Perché?
«Perché ho il senso della riconoscenza. E lo
pretendo. Tanti l’hanno avuto. Qualcuno no».
Calenda l’ha avuto?
«Sì. E ora in politica può fare bene. Non è
vero che gli manchi il senso del sociale, è per il salario minimo. Rappresenta
un’Italia repubblicana, perbene, seria».
Elkann l’ha avuto?
«Suo nonno era un uomo generoso d’animo, pieno
di interessi, con un grande senso dell’amicizia, che mi è sempre stato vicino
nei momenti difficili. Non mi faccia dire altro».
Anche con Marchionne lei ha avuto un rapporto
difficile.
«Eravamo seduti vicini in consiglio
d’amministrazione, e ci stavamo simpatici. Insieme bloccammo Morchio quando
voleva cancellare il marchio Panda, una follia. Dopo Morchio, la scelta
dell’amministratore delegato era tra Marchionne e Bondi, grande ristrutturatore.
Scegliemmo Marchionne».
Sergio Marchionne, John Elkann e Luca di
Montezemolo (Ansa)
Prima di morire, disse a Bianca Carretto che
«si vergognava come un ladro» per come l’aveva mandato via dalla Ferrari.
«Marchionne era un assoluto dittatore, ma a me
stava bene, avevo altre cose da seguire. Era naturale che nel tempo dovessi
lasciare, anche perché non avrei mai portato la Ferrari in Borsa; la Borsa vive
di annunci, e la Ferrari va gestita diversamente. Inoltre credo che della
Ferrari Marchionne volesse diventare il numero 1: non solo gestore, ma
azionista. Ci rimasi molto male per il modo. Ma non dimenticherò mai l’addio a
sorpresa di Maranello».
Come andò?
«Mi invitarono per un piccolo brindisi con i
dirigenti; in realtà c’erano tutti gli operai in tuta. Applaudivano e
piangevano, sulle note di Una lunga storia d’amore di Gino Paoli».
Cos’è oggi la Fiat?
«Una proprietà francese. E anche la Magneti
Marelli è stata una grave perdita per l’industria italiana».
Berlusconi nel 2001 la voleva ministro.
«Lo disse a Porta a Porta, ovviamente senza
avvertirmi. L’Avvocato mi consigliò di accettare; ma quella volta non gli diedi
retta. Agli Esteri andò Renato Ruggiero; resistette sei mesi».
Nel 2006 in Confindustria ci fu la
contestazione di Vicenza.
«Berlusconi era invitato, ma disse che non
sarebbe venuto. Poi si presentò a sorpresa, con il sostegno delle truppe
cammellate di Galan, allora presidente del Veneto. Diego Della Valle lo
affrontò, gli diede del buffone... Per fortuna Andrea Pininfarina fece cenno a
de Bortoli di chiudere il convegno».
Il 2006 è anche l’anno di Italo.
«Da un foglio bianco è nata un’azienda da 25
milioni di passeggeri e 1500 dipendenti, quasi tutti giovani. Dopo le tv, la più
grande privatizzazione nella storia italiana. Ma a differenza di Berlusconi noi
non abbiamo avuto aiuti, anzi ci hanno ostacolato in tutti i modi possibili».
Addirittura?
«Trenitalia controllava pure la rete
ferroviaria. Moretti ci faceva partire i treni alle 4 del mattino. Ci negarono
la stazione Termini, e andammo a Ostiense; il giorno del primo viaggio la fecero
trovare chiusa da una grata...».
La sua presidenza di Alitalia non andò
altrettanto bene, anzi.
«Accettarla fu un errore, commesso per
generosità. Prima Letta, poi Renzi mi chiesero di far di tutto per convincere
Etihad a prendere Alitalia. Gli sceicchi dissero sì, ma poi vollero che facessi
il presidente. Sbagliai, proprio perché non sono un uomo di rappresentanza, ma
uno abituato a fare, a decidere».
E nell’editoria, non pensa di aver commesso
errori?
«L’editoria è una delle mie grandi passioni,
sono stato anche presidente della Federazione editori. Nelle varie epoche ho
puntato sugli uomini giusti. Marco Benedetto, amministratore della Stampa, dove
portai Bernardo Valli e Forattini. Giulio Anselmi: un grande direttore, un uomo
dalla schiena dritta. Con lo stesso criterio, quando c’era da scegliere il
direttore del Sole24Ore chiamai Ferruccio de Bortoli, che con Berlusconi, allora
premier, non aveva un gran rapporto. Sono orgoglioso di aver contribuito a
portare due volte Paolo Mieli alla guida del Corriere. E ho un ricordo
meraviglioso di Montanelli».
Era amico pure di Montanelli?
«Gli facevo scherzi crudeli. Lui era schivo, a
volte burbero, non amava essere importunato per strada, e quando andavamo a
passeggio a Cortina giocavo a precederlo di qualche metro sussurrando ai
passanti: c’è Montanelli, c’è Montanelli... Così tutti lo fermavano, e lui si
infuriava: “Colpa tua!”».
Amici tra gli artisti?
«Soprattutto Lucio Dalla, che mi manca, e Gino
Paoli, cui voglio molto bene. Con Lucio cenavamo spesso insieme a Bologna. Una
sera venne anche un altro amico, Paolo Borgomanero: aveva lo stesso profumo che
sentivo a mio nonno. Gli chiesi: cos’è? Rispose: una cosa che non si usa più, si
chiama Acqua di Parma. Gli dissi: perché non lo compriamo? La sera stessa
chiamai Diego Della Valle. Pagammo Acqua di Parma 50 milioni di lire, e fu un
successo clamoroso».
E Gino Paoli?
«Veniva a trovarmi a Torino. Una sera aveva un
concerto al festival dell’Unità, era in ritardo e gli diedi un passaggio. Gli
uomini della sicurezza del Pci si stupirono: “Gino, ma lo sai che il tuo autista
è identico a quella testa di cazzo di Montezemolo?”».
Pare la scena di un film dei Vanzina.
«Siamo amici fraterni da quando avevo dieci
anni. La prima volta che andai allo stadio ero con loro: sapevano che tifavo
Bologna, e il loro papà, Steno, ci portò a vedere Lazio-Bologna. Espugnammo
l’Olimpico con gol dell’uruguagio Di Marco. Con Enrico e Carlo Vanzina abbiamo
pure fondato una società di produzione cinematografica...».
Il suo primo matrimonio fu annullato dalla
Sacra Rota. Come mai?
«Perché avevo sposato una signora in parte di
origini americane, con una mentalità divorzista: vediamo come va, al limite ci
separiamo. Ci separammo. Ma non mi faccia parlare di cose familiari».
Tra meno di un mese si vota, e vincerà la
destra. È un pericolo per l’Italia?
«Sono molto più preoccupato per il dopo
elezioni, con una politica che non perde occasioni per aumentare il distacco con
famiglie, giovani, imprese anche in questa campagna elettorale fatta di parole,
promesse irrealizzabili, politici nominati dai partiti, pochissimo spazio alla
società civile».
È così pessimista?
«Spero con tutto il cuore di non esserlo
troppo. Purtroppo non vedo le condizioni per ricostruire una politica decente.
Sentiremo molto la mancanza dell’autorevolezza di Draghi, non solo in Europa».
Franco Tatò.
Giulia Cerasoli per “Chi” il 24 agosto 2022.
Un
giorno, quando selezionavo il personale in Olivetti, mi si presentò una ragazza
di una bellezza conturbante per un posto di segretaria. Appena entrata nel mio
ufficio si sedette accavallando le gambe. Severo, le chiesi: “Bene, mi dica che
cosa sa fare”. E lei: “ Perché, non si vede?”. Un’altra volta invece si presentò
un super laureato in Fisica. Ottimi voti, grandi capacità, interessi... Pensai
di aver selezionato un vero genio. Beh, finito il colloquio, il genio si alzò
infilandosi direttamente nell’armadio, invece di uscire dalla porta
dell’ufficio...».
Kaiser
Franz (al secolo Franco Tatò) - uno dei top manager più famosi, filosofo,
scrittore, germanista, celebre per aver risanato decine di aziende tra cui
Olivetti, Mondadori, Enel, Enciclopedia Treccani e per aver licenziato, pur
stimandolo, uno come Urbano Cairo - ha compiuto 90 anni (il 12 agosto) e si
racconta. Al suo compleanno, con gli amici più cari e la sua famiglia, tutti
raccolti nella masseria che possiede vicino a Fasano (Brindisi), in Puglia, ha
voluto solo noi di “Chi”. E ha deciso di raccontarci particolari della sua vita
da romanzo che non ha mai svelato a nessuno.
Domanda.
Partiamo dall’inizio: l’infanzia.
Risposta.
«Poverissima. Papà era un militare, mamma faceva la sarta. A casa non avevamo il
telefono né il bagno. Papà era di Barletta e mamma di Lodi. Abitavamo a Torino,
fare la spesa a volte per mia madre era un problema. Al posto della carne ci
rifilava il sanguinaccio chiamandolo fegato sterilizzato. Ma da questa famiglia
ho imparato che nella vita bisogna darsi da fare. Educazione sabauda».
D. E lei
ha cominciato subito. È riuscito a laurearsi nelle migliori università con una
sola borsa di studio e lavava i piatti per mantenersi.
R. «Al
Collegio Ghislieri di Pavia si entrava solo per concorso. Un orgoglio farne
parte. Anche lo scrittore ed editore Gian Arturo Ferrari è fra gli ex alunni che
incontro spesso. Negli Stati Uniti per mantenermi ho fatto il lavapiatti, ho
pulito le scale e servito a tavola. Cose da cui ho imparato tanto, come quando
sono entrato in Olivetti come operaio, nonostante la laurea in Filosofia e le
borse di studio ad Harvard».
D. Poi ha
fatto carriera. Ed è diventato anche un po’ cattivo. Talmente temuto come
tagliatore di teste che è rimasta celebre la frase di Silvio Berlusconi, che in
Mondadori confessò di camminare rasente i muri nel timore di incontrarla e che
considerasse anche lui “un costo da abbattere”.
R. «Non
sono mai stato cattivo. Ho sempre applicato la regola del cancelliere Bismarck
del “rigore compassionevole”. Non si risanano le aziende licenziando, ma
adeguando le risorse e aumentando la produttività. A volte ho dovuto ridurre il
personale, come all’Enel, ma non ho avuto un’ora di sciopero. Berlusconi però
aveva ragione! In Mondadori il risanamento più veloce della mia vita».
D. A
proposito di Mondadori: perché ha licenziato Urbano Cairo?
R. «Ho
dovuto farlo anche se lo stimo. Berlusconi me lo ha chiesto perché Cairo
lavorava per se stesso invece che per la Mondadori, infatti con la buonuscita
s’è fatto la sua azienda. Non me l’ha mai perdonato però».
D. Chi
licenzierebbe oggi?
R. «Un
bel po’ di persone. Ma terrei di certo Mario Draghi. Ho sentito il dibattito al
Senato dopo il suo discorso e mi sono vergognato».
D.
Cambiamo argomento: Tatò e le donne.
R. «Da
ragazzo ero sfortunatissimo. Non mi sono mai sentito attraente. Non mi filava
nessuno e non avevo nemmeno la disponibilità per far colpo. Poi la mia prima
moglie si innamorò di me e lasciò il lavoro per seguirmi in giro per il mondo.
Ancora adesso ci sentiamo spesso e ci vogliamo bene».
D. Da lei
ha avuto due figli. Poi il matrimonio è finito.
R. «Mia
moglie era giustamente stanca di seguirmi ovunque e superati i 60 anni mi
prospettò una sorta di pensionamento anticipato. Per vivere in maniera più
tranquilla. Di fronte alla prospettiva dei giardinetti o della crociera per
pensionati benestanti ho reagito. Volevo continuare a lavorare, avevo altre
sfide davanti e ancora molta energia da spendere per le aziende, mi sono
ribellato al suo progetto, lo confesso».
D. Poi ha
conosciuto la sua seconda moglie, Sonia.
R. «Avevo
64 anni e Sonia 30 di meno. Ho dovuto superare barriere morali ed etiche molto
impegnative, cambiare la mia vita. Ho capito che però non avrei potuto condurre
una doppia vita (e lei non avrebbe mai accettato). Percepivo che era una cosa
seria, un amore profondo. Quindi ho fatto la mia scelta. Sofferta, ma con una
spinta travolgente».
D. Lei è
un eterno primo della classe?
R.
«Macché. Per un periodo della mia vita sono stato insicuro, con un’autostima
traballante. Sono una persona modesta, senza esplosioni di autoritarismo. Ho
scoperto solo lavorando di avere un talento da manager. A scuola studiavo tanto
perché non ero mai sicuro di essere promosso».
D. Qual è
la persona che l’ha influenzata maggiormente?
R. «Il
mio allenatore di rugby, l’ingegner Ardizzone. Ci educava con il credo del
rugbista: “Andare avanti, placcare l’avversario e sostenere il compagno”».
D.
Carolina, la sua figlia ventenne, studia a Londra, ha una ciocca viola tra i
capelli e lancerà una linea di pasti vegani. Che rapporto ha con lei?
R. «È la
mia fotocopia. Serissima. Ha carattere e dedizione. Ha lavorato sodo a Londra e
si è pure divertita. Parliamo molto. Una ragazza matura».
D. È vero
che a 90 anni si è scoperto poeta?
R. «Su
consiglio dell’analista, entusiasta dei miei versi, ho cominciato a scrivere
poesie. Ho scritto quattro saggi tra Economia e Filosofia, ma ho scoperto che la
poesia letta ad alta voce nel cielo della Puglia aiuta a vivere».
·
I
Politologi.
Gianfranco
Pasquino, il politologo con la spider: «L’Ulivo di Prodi? Benemerito ho lottato
contro Renzi».
Ferruccio de
Bortoli su Il Corriere della Sera il 5 marzo 2022.
Docente di
Scienze Politiche ed ex parlamentare, ha girato il mondo studiando e insegnando.
Quella volta che chiese a Bob Kennedy cosa pensasse del rapporto Warren
sull’omicidio del fratello John (e lui non rispose)
Gianfranco
Pasquino, 79 anni, ex parlamentare, è docente emerito di Scienze Politiche a
Bologna (foto Imagoeconomica)
Ho incontrato
Gianfranco Pasquino, qualche settimana fa, su un Frecciarossa diretto a Roma.
Lui era salito a Bologna, la sua città d’adozione. Ci siamo salutati con grande
cordialità. Pasquino è simpatico, alla mano. Era seduto, nella mia stessa fila,
dall’altra parte della carrozza. Aveva di fronte una giovane ragazza,
puntualmente rapita dal proprio smartphone. Assente. Il professore la guardava
incuriosito e cominciò a rivolgerle qualche domanda. Non è educato ascoltare i
discorsi degli altri, ma la tentazione è sempre irresistibile. Non se ne può
fare a meno. A un certo punto, la ragazza, non più distratta dal suo cellulare
ma certamente affascinata dalla conversazione con l’anziano e sconosciuto
viaggiatore, gli chiese: «Ma lei come fa a sapere tutte queste cose?».
«Semplice, sono colto», rispose Pasquino con un mezzo sorriso, divertito,
guardandomi. L’intromissione fu spontanea. «Confermo», dissi io.
Maestri e
avversari L’ ultimo libro di Pasquino «Tra scienza e politica» (Utet)
Ecco, l’episodio
è illuminante per descrivere il carattere gioviale e disincantato, non privo di
un compiaciuto egocentrismo, del professore. Il buon umore, autoironico,
dell’intelligenza, potremmo definirlo. Un sottotitolo consigliabile alla sua
autobiografia ( Tra scienza e politica, Utet) che esce in libreria in questi
giorni. E leggendola - proprio perché ricca di episodi curiosi - avremmo voluto
assistere, allo stesso modo, a un altro incontro. Tanti anni fa. Quando Pasquino
era agli esordi come scienziato della politica e docente universitario. Un
colloquio con il dottor Giovanni Evangelisti, austero intellettuale e
imprenditore della cultura, che doveva esaminarlo, candidato redattore
del Dizionario di Politica , all’Istituto Cattaneo, su suggerimento di Nicola
Matteucci che lo dirigeva. Il condirettore della pubblicazione era nientemeno
che Norberto Bobbio. L’incontro avvenne a Ferragosto del 1969 a Firenze al
celebre caffé Paszkowski in piazza della Repubblica.
Gianfranco
Pasquino da giovane quando praticava il salto in alto
Con la Giulietta
azzurra decapottabile
Pasquino era in
vacanza a Castiglione della Pescaia e si presentò a un appuntamento fondamentale
per la sua carriera a bordo di una Giulietta «spider azzurra decapottabile in
mocassini senza calze, pantaloni bianchi, camicia a righine bianco-azzurre,
abbronzato». Per sua stessa definizione un beach boy . «Non avevo proprio
l’aspetto di un intellettuale del Mulino», confessa divertito nel libro. E
chissà come avrebbe reagito la sua casuale compagna di viaggio se avesse potuto
godere di questo frammento della vita di uno dei più affermati, anche a livello
internazionale, scienziati italiani della politica. Nel ripercorrere la propria
vita e i propri studi, Pasquino è generoso di riconoscimenti ai suoi maestri, in
particolare Bobbio che fu relatore della sua tesi («deludente e mediocre»
confessa ora con civetteria) e Giovanni Sartori. E si ritiene fortunato per i
tanti incroci, le numerose occasioni, che lo hanno portato a contatto con
colleghi e personaggi straordinari, da Nicola Abbagnano a Luigi Firpo, da Siro
Lombardini a Francesco Forte, a Leopoldo Elia.
DURANTE I 5 MESI
A CAMBRIDGE FACEVA QUALCHE PARTITA DI PALLONE CON ALTRI ITALIANI: «C’ERA UN
GIOCATORE LENTO E POCO GRINTOSO». ERA MARIO DRAGHI
Il tucano della
saggezza
Torinese e
granata (forse l’unica vera fede di un laico impenitente), Pasquino ama la vita
in tutti i suoi aspetti ed è forse questo il talismano della sua perdurante
giovinezza di spirito. O meglio il tucano, come quello che domina la sua
scrivania. Il tucano della saggezza. Partecipò anche lui, come alcuni politici
dei quali oggi non condivide assolutamente nulla (Matteo Salvini e Matteo Renzi)
ad un quiz televisivo, vincendo una discreta somma (700 mila lire). Frequenta,
grazie a una delle più ambite borse di studio, un corso universitario negli
Stati Uniti e incontra addirittura Bob Kennedy al quale chiede con grande
candore che cosa pensi del rapporto Warren sull’uccisione del fratello, non
ricevendo ovviamente alcuna risposta. Tornerà poi negli Stati Uniti, negli anni
seguenti, quando è già da tempo in cattedra, per ricoprire, ad Harvard, la De
Bosio chair di Gaetano Salvemini. Prima di lui un giovane e ugualmente
sconosciuto Romano Prodi. Ha il privilegio di essere ospite, nelle domeniche del
thé, del futuro premio Nobel dell’Economia Franco Modigliani. E in quei cinque
memorabili mesi che trascorre a Cambridge gioca di tanto in tanto a pallone con
i suoi connazionali. Tra questi c’è «un giocatore piuttosto lento e poco
grintoso». Nome: Mario Draghi.
I peggiori
bestiari parlamentari
Uno dei nostri
maggiori politologi mai avrebbe pensato che il timido economista, un po’ schivo,
si sarebbe trovato alle prese con uno dei peggiori bestiari parlamentari della
storia repubblicana. La politica non è una scienza esatta, tantomeno nel
tracciare i profili dei suoi protagonisti. Ma i politologi, spesso, come «cacciatori
di teste» non ci prendono. Nell’estate calda e umida del New England, gli dicono
che è esplosa una bomba a Bologna. È il due agosto del 1980. Giovanni Sartori,
grande firma del Corriere, è celebrato in questo libro come un maestro,
inarrivabile anche per il suo carattere, autenticamente toscano. Gli scontri non
mancano, per esempio sulla linea e sulle scelte della Rivista italiana di
scienza politica. Non c’è solo affetto ma anche molta riconoscenza. Soprattutto
per aver trasmesso a Pasquino la passione, e insieme la bellezza,
dell’insegnamento. La consapevolezza di poter allargare l’orizzonte della
conoscenza insieme ai propri studenti, vedendo accendersi, nei loro occhi, la
scintilla critica della curiosità. Come quella scattata nella giovane,
studentessa per caso, incontrata sul Frecciarossa.
Gianfranco
Pasquino con Achille Occhetto (Imagoeconomica)
Bologna, Scienze
politiche e i prof in parlamento
Alla sua prima
lezione all’Università di Bologna, il professore ha quattro studenti. Uno di
questi è Angelo Panebianco, un’altra grande firma del Corriere. Sarà relatore
della sua tesi. E Panebianco parteciperà anche all’ultima lezione del professore,
una volta «messo a riposo», anche se ormai tra i due le idee divergeranno e non
poco. Tra i suoi colleghi c’è Giuliano Urbani, bravissimo nell’imitare il leader
liberale Giovanni Malagodi. Dice a uno scettico Pasquino che farà politica. Sarà
l’architetto di Forza Italia, formazione che al professore non è mai piaciuta,
ma nella quale confluirono molti ex socialisti come lui. Prima di votare Pci,
nel ‘79, il professore era convintamente socialista. Ma non amò Craxi, né il
Berlinguer del compromesso storico. Il partito comunista lo propose alle
elezioni del 1983 come indipendente di sinistra. Un vero trionfo per la facoltà
di Scienze politiche dell’università di Bologna che si trovò (ogni raffronto con
l’attualità è sconsigliabile) ad avere in Parlamento quasi tutti i suoi
professori: Beniamino Andreatta e Roberto Ruffilli (poi ucciso dalle Brigate
Rosse) per la Dc; Franco Piro per il Psi; Filippo Cavazzuti e lo stesso Pasquino
per la Sinistra indipendente. Poi, dal 1996 al 2001, Ettore Rotelli di Forza
Italia. «Competenza e pluralismo politico», sintetizza orgoglioso il nostro
autore. Quando lo eleggono, sta insegnando alla Summer school di Harvard. Tra i
messaggi di congratulazione quello di un altro allievo di Sartori, Domenico
Fisichella, di Alleanza Nazionale, che giudica «riprovevole» la scelta del
partito comunista.
«SONO GIUNTO ALLA
CONCLUSIONE CHE LA LEGGE ELETTORALE PREFERIBILE PER L’ITALIA È IL SISTEMA A
DOPPIO TURNO FRANCESE APPLICATO IN COLLEGI UNINOMINALI»
Marco Pannella a
Bologna nel maggio 2009 per sostenere la candidatura a sindaco di Gianfranco
Pasquino (foto Tecnavia)
Protagonista
della stagione referendaria
Leggendo il libro
di Pasquino sorge spontanea una domanda sul perché un Paese con così tanti
maestri della politica, distribuiti lungo un arco ben più vasto di quello
costituzionale, abbia avuto allievi così scarsi. Mistero. Pasquino è tra i
protagonisti della stagione referendaria, in particolare del dibattito sulla
preferenza unica. Stigmatizza le troppe leggi elettorali, ma salva il
Mattarellum, il meno peggio. «Giunsi, però, alla conclusione, che non ho più
abbandonato, che la legge elettorale preferibile per l’Italia sia il sistema a
doppio turno francese applicato in collegi uninominali. Nel 1995 scrissi un
disegno di legge apposito sul quale raccolsi quasi cinquanta firme dei senatori
del gruppo progressista, molto più di un terzo che consente la richiesta di
inserire il disegno di legge all’ordine del giorno. Non pochi di quei firmatari
furono poi convinti (costretti?) a ritirare la loro adesione dal capogruppo
Cesare Salvi». L’Ulivo è un esperimento appassionante. «Fu il benemerito
tentativo di rinnovare il ceto politico aprendosi alla società (sì, civile).
Riuscì solo parzialmente». Non così il partito democratico, una delusione. Un
amalgama mal riuscito, per citare una frase sfuggita a Massimo D’Alema.
«Mettere fine
all’obbrobrio delle pluricandidature»
«Continuo ad
augurarmi di sentire alte e forti le voci di Prodi, di Veltroni e, naturalmente,
di Parisi, che chiedono si metta fine all’obbrobrio delle pluricandidature e
delle liste bloccate. O la qualità del ceto parlamentare è una variabile
irrilevante?». Pasquino però è stato nelle diverse esperienze paracadutato anche
lui in collegi sicuri (quando c’era il Pci) o meno certi, in luoghi nei quali
non era nemmeno mai stato. «Da Harvard a Rivabella» (una delle spiagge di
Rimini) era scritto in un manifesto elettorale per la sua candidatura. «Quei
luoghi di vacanze, da Rimini a Riccione a Cattolica fino alla discoteca Baia
Imperiale di Gabicce che Wikipedia colloca tra le dieci discoteche più belle al
mondo, furono lo sfondo di una (mia) vittoria mai in discussione».
Contro Matteo
Renzi: salutare fallimento
Un capitolo
estremamente interessante del libro è dedicato alle riforme costituzionali di
Renzi e al loro salutare fallimento. Le ragioni di quel no sono ancora più forti
oggi nel marasma di proposte senza senso. Pasquino guidò quel fronte,
individuando pericoli, torsioni e pasticci, nonostante non sia mai stato
affascinato dalla retorica della «Costituzione più bella del mondo». Non è
tenero con gli avversari, specie se colleghi, trova intollerante l’abuso della
qualifica di politologo in un Paese in declino anche morale. Detesta, con poche
eccezioni, i giornalisti. Si ritiene un Wanderredner , un predicatore errante. E
siamo convinti che se la sconosciuta viaggiatrice incontrata in treno,
studentessa per caso, avesse saputo (ma forse sì) lo spagnolo si sarebbe
indirizzata a lui come una sua allieva dopo una delle molte conferenze tenute in
America Latina: Profesor, Usted es un lujo , lei è un vero e proprio lusso. «Troppo?»
si schermisce, neanche tanto, Pasquino «ma non fatelo dire a me».



 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996

 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS: