 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
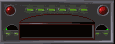
 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA -
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
ANNO 2021
FEMMINE E
LGBTI
PRIMA
PARTE
DI ANTONIO
GIANGRANDE

L’ITALIA
ALLO SPECCHIO
IL DNA
DEGLI ITALIANI
L’APOTEOSI
DI UN POPOLO DIFETTATO
Questo saggio è un aggiornamento temporale, pluritematico e
pluriterritoriale, riferito al 2021, consequenziale a quello del 2020. Gli
argomenti ed i territori trattati nei saggi periodici sono completati ed
approfonditi in centinaia di saggi analitici specificatamente dedicati e già
pubblicati negli stessi canali in forma Book o E-book, con raccolta di materiale
riferito al periodo antecedente. Opere oggetto di studio e fonti propedeutiche a
tesi di laurea ed inchieste giornalistiche.
Si troveranno delle recensioni deliranti e degradanti di
queste opere. Il mio intento non è soggiogare l'assenso parlando del nulla, ma
dimostrare che siamo un popolo difettato. In questo modo è ovvio che l'offeso si
ribelli con la denigrazione del palesato.
IL GOVERNO
UNA BALLATA
PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
L’ITALIA CHE SIAMO.
UNA BALLATA PER AVETRANA
(di Antonio Giangrande). L’AVETRANA CHE SIAMO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
LA SOLITA INVASIONE
BARBARICA SABAUDA.
LA SOLITA ITALIOPOLI.
SOLITA LADRONIA.
SOLITO GOVERNOPOLI.
MALGOVERNO ESEMPIO DI MORALITA’.
SOLITA APPALTOPOLI.
SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED
ESAMI DI STATO TRUCCATI.
ESAME DI AVVOCATO. LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE
TRUCCATA.
SOLITO SPRECOPOLI.
SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE
SPECULAZIONI.
L’AMMINISTRAZIONE
SOLITO DISSERVIZIOPOLI. LA DITTATURA DEI
BUROCRATI.
SOLITA UGUAGLIANZIOPOLI.
IL COGLIONAVIRUS.
L’ACCOGLIENZA
SOLITA ITALIA RAZZISTA.
SOLITI PROFUGHI E FOIBE.
SOLITO PROFUGOPOLI. VITTIME E CARNEFICI.
GLI STATISTI
IL SOLITO AFFAIRE ALDO
MORO.
IL SOLITO GIULIO ANDREOTTI. IL DIVO RE.
SOLITA TANGENTOPOLI. DA CRAXI A BERLUSCONI. LE
MANI SPORCHE DI MANI PULITE.
SOLITO BERLUSCONI. L'ITALIANO PER ANTONOMASIA.
IL SOLITO COMUNISTA BENITO
MUSSOLINI.
I PARTITI
SOLITI 5 STELLE… CADENTI.
SOLITA LEGOPOLI. LA LEGA DA LEGARE.
SOLITI COMUNISTI. CHI LI
CONOSCE LI EVITA.
IL SOLITO AMICO TERRORISTA.
1968 TRAGICA ILLUSIONE
IDEOLOGICA.
LA GIUSTIZIA
SOLITO STEFANO CUCCHI &
COMPANY.
LA SOLITA SARAH SCAZZI. IL DELITTO DI AVETRANA.
LA SOLITA YARA GAMBIRASIO. IL DELITTO DI
BREMBATE.
SOLITO DELITTO DI PERUGIA.
SOLITA ABUSOPOLI.
SOLITA MALAGIUSTIZIOPOLI.
SOLITA GIUSTIZIOPOLI.
SOLITA MANETTOPOLI.
SOLITA IMPUNITOPOLI.
L’ITALIA DELL’IMPUNITA’.
I SOLITI MISTERI ITALIANI.
BOLOGNA: UNA STRAGE
PARTIGIANA.
LA MAFIOSITA’
SOLITA MAFIOPOLI.
SOLITE MAFIE IN ITALIA.
SOLITA MAFIA
DELL’ANTIMAFIA.
SOLITO RIINA. LA COLPA DEI PADRI RICADE SUI
FIGLI.
SOLITO CAPORALATO. IPOCRISIA E SPECULAZIONE.
LA SOLITA USUROPOLI E
FALLIMENTOPOLI.
SOLITA CASTOPOLI.
LA SOLITA MASSONERIOPOLI.
CONTRO TUTTE LE MAFIE.
LA CULTURA ED
I MEDIA
LA SCIENZA E’ UN’OPINIONE.
SOLITO CONTROLLO E MANIPOLAZIONE MENTALE.
SOLITA SCUOLOPOLI ED IGNORANTOPOLI.
SOLITA CULTUROPOLI. DISCULTURA ED OSCURANTISMO.
SOLITO MEDIOPOLI. CENSURA, DISINFORMAZIONE,
OMERTA'.
LO SPETTACOLO E LO SPORT
SOLITO SPETTACOLOPOLI.
SOLITO SANREMO.
SOLITO SPORTOPOLI. LO SPORT COL TRUCCO.
LA SOCIETA’
AUSPICI, RICORDI ED ANNIVERSARI.
I MORTI FAMOSI.
ELISABETTA E LA CORTE DEGLI SCANDALI.
MEGLIO UN GIORNO DA LEONI O CENTO DA AGNELLI?
L’AMBIENTE
LA SOLITA AGROFRODOPOLI.
SOLITO ANIMALOPOLI.
IL SOLITO TERREMOTO E…
IL SOLITO AMBIENTOPOLI.
IL TERRITORIO
SOLITO TRENTINO ALTO ADIGE.
SOLITO FRIULI VENEZIA GIULIA.
SOLITA VENEZIA ED IL VENETO.
SOLITA MILANO E LA LOMBARDIA.
SOLITO TORINO ED IL PIEMONTE E LA VAL D’AOSTA.
SOLITA GENOVA E LA LIGURIA.
SOLITA BOLOGNA, PARMA ED EMILIA ROMAGNA.
SOLITA FIRENZE E LA TOSCANA.
SOLITA SIENA.
SOLITA SARDEGNA.
SOLITE MARCHE.
SOLITA PERUGIA E L’UMBRIA.
SOLITA ROMA ED IL LAZIO.
SOLITO ABRUZZO.
SOLITO MOLISE.
SOLITA NAPOLI E LA CAMPANIA.
SOLITA BARI.
SOLITA FOGGIA.
SOLITA TARANTO.
SOLITA BRINDISI.
SOLITA LECCE.
SOLITA POTENZA E LA BASILICATA.
SOLITA REGGIO E LA CALABRIA.
SOLITA PALERMO, MESSINA E LA SICILIA.
LE RELIGIONI
SOLITO GESU’ CONTRO MAOMETTO.
FEMMINE E LGBTI
SOLITO CHI COMANDA IL MONDO: FEMMINE E LGBTI.
FEMMINE E
LGBTI.
INDICE PRIMA
PARTE
SOLITO CHI COMANDA IL MONDO: FEMMINE E LGBTI.
(Ho scritto un saggio dedicato)
Discriminazione di Genere.
La cura
maschilista.
Comandano Loro.
Donne e
Sport.
Le Dominatrici.
La Rivoluzione
Sessuale.
La Verginità.
Il Gang Bang.
Il Cinema Femmina.
San Valentino.
Il Femminismo.
Le Quote rosa.
Le
donne di sinistra che odiano le donne.
I Transessuali.
Gli Omosessuali.
Le
Lesbiche.
Gli Agender - “Non
Binari”.
Il DDL Zan:
la storia di una Ipocrisia. Cioè: “una presa per il culo”.
A morte i Maschi.
A morte i Padri.
Revenge Porn.
Dagli al Maschio.
L’Odore.
Il Sudore.
Il Pelo.
I Capelli.
L’occhio vuole la
sua parte.
Il trucco.
Il
Reggiseno.
Il Bikini.
Le Strafatte.
Parliamo del Culo.
Mai dire...Porno.
Mai
dire...prostituzione.
Cornuti/e e
mazziati/e.
Essere Single.
INDICE
SECONDA PARTE
SOLITO CHI COMANDA IL MONDO: FEMMINE E LGBTI.
(Ho scritto un saggio dedicato)
La
Molestia.
Il
Catcalling: la presunta molestia sulle donne.
Il Metoo.
Le Violenze di
Genere: Maschicidi e femminicidi.
Il Delitto
d'onore.
Lo Stupro.
Lo Stupro
Emozionale.
Mai
dire…Matrimonio.
Mai dire …Mamma.
Mai dire…Figli.
L’Aborto.
Il Figlicidio.
Le Feste: chi non
lavora, non fa l’amore.
La
cura chiamata Amore.
La Dieta del
Sesso.
Il Sesso.
Dildo &
Company: gli accessori del sesso.
La
Virilità.
La Masturbazione.
Il Corteggiamento.
Durante il sesso.
Il
Tradimento.
Il Priapismo:
l’erezione involontaria.
Il Bacio.
Il Cunnilingus.
I Feticisti.
Durante la
Menopausa.
L'Andropausa.
Il Sesso
maturo.
Le Truffe Amorose.
FEMMINE E LGBTI
PRIMA PARTE
·
Discriminazione di Genere.
L'errore di chi confonde le differenze
con la "diversità". Luca Doninelli il 9 Dicembre 2021
su Il Giornale. Parlare di Alain Finkielkraut in Francia significa schierarsi.
Se sei d'accordo con Finkielkraut, sia pure su un singolo argomento, ti trovi a
far parte di un gruppo che pensa e dice tutta una serie di cose che un altro
gruppo depreca e condanna, e questo ti segnerà, ti infetterà. Non succede solo
in Francia. Esiste un tipo di infettività che oltrepassa le emergenze sanitarie
quanto le esplosioni mediatiche: una specie di sordità selettiva e degenerativa
che comincia con ciò che non ci interessa per estendersi - è cronaca - a tutto
il resto. Insomma, leggi Finkielkraut? Allora sei di destra, sei con la Le Pen,
sei con Zemmour.
Ciò nonostante, io sono convinto che leggere
Finkielkraut, accettandone anche le intemperanze, sia una buona cosa (per tutti,
anche per i suoi nemici) per la ragione opposta: la lucidità tutta illuminista
con la quale questo grande allievo di Roland Barthes ci aiuta a riconoscere le
trappole culturali: anche quelle di chi si vorrebbe suo compagno di strada.
Il suo ultimo libro, uscito in Francia e di
prossima pubblicazione in Italia, ha per titolo L'après littérature, ossia «La
post-letteratura» (Stock, pagg. 230, euro 19,50). Il libro è come sempre molto
«francese», si riferisce a fatti di cronaca a noi spesso ignoti e va letto tra
le righe.
Tema centrale è, secondo me, lo smarrimento del
senso delle parole. La prima di queste parole è «differenza». Parola difficile,
pericolosa, impossibile da maneggiare fuori da un serio esercizio del pensiero.
La società è fatta di differenze: io non sono te, e il «noi» è un equilibrio
difficile, del quale il nostro tempo sembra del tutto ignaro, nel nome di
sentimenti indiscutibili. La differenza discrimina, eccome.
«Il nostro tempo, sganciato dalla saggezza degli
Antichi, non conosce altra legge del proprio stesso slancio compassionevole».
Alla difficile «differenza» subentra la facile «diversità», debole di pensiero e
generatrice di diktat morali. La cultura che la nostra civiltà ha generato non
viene più interrogata, celebriamo Dante e Shakespeare, Eschilo o Rembrandt senza
chiedere loro nessun lume.
La ragione è semplice e terribile: «Essi non hanno
bisogno di compiere un lungo percorso per accedere alla verità, perché sono
convinti di possederla già». In America la chiamano cancel culture. Una sottile
linea nazista, alimentata dall'ignoranza, attraversa gli opposti schieramenti.
La Storia non ha nulla da insegnarci, siamo noi i suoi giudici. In nome del
tutto è cultura si cancella la cultura, si aboliscono le gerarchie, si eliminano
i maestri.
Diverse pagine del libro sono dedicate alla
battaglia per l'emancipazione femminile. Dove sta il nemico? Non tanto nei
contenuti di una battaglia sacrosanta, ma nel presunto unanimismo, che produce
un discorso povero (anche sul piano linguistico) e urlante.
La ragione si presenta come economica: tutto deve
essere ridotto a qualcosa che si possa comprare e vendere. Il me too (fatti
salvi gli aspetti penali) appartiene, come molte altre cose - io ci metto anche
il sovranismo - a questa legge mercantile. Il problema è però ideologico, non
economico. La riduzione del mondo (e delle sue infinite differenze, che secondo
Aristotele costituiscono la fonte stessa dell'umana conoscenza) a qualcosa che
si possa acquistare o vendere (compreso l'utero di una donna) non riguarda in
primis i soldi, ma il pensiero.
La ricchezza degli Antichi era melanconica: si
poteva acquistare la bellezza di un fiore, il suo profumo, il sorriso di un
bambino? Ma il principio ideologico ha azzerato la poesia e la bellezza, anche
se celebriamo Dante dalla mattina alla sera. La poesia del mondo è cosa da
boomer, le parole d'ordine sono: tutela del pianeta, biodiversità, green
eccetera. Tutte parole negoziabili, inseribili in un'agenda internazionale: a
differenza dei gelsomini.
Ciò che resta fuori da ogni agenda? Che so, la
crescita della fame nel mondo, il destino di popoli interi rimasti senza patria,
la situazione dei vaccini nei Paesi poveri, e così via.
La nostra civiltà - dice Finkielkraut - ha eretto,
contro la barbarie, due grandi baluardi: il Diritto e la Letteratura. L'uno e
l'altra celebrano la Differenza - che comprende l'assoluta unicità di ogni
singolo essere umano, la sua difficile giudicabilità, e la complessità dei corpi
sociali. E l'uno e l'altra sono oggi in pericolo di estinzione sotto i colpi di
un egualitarismo cieco.
Torna in mente Le urla del silenzio (1984) il film
di R. Joffé, dove la furia ideologica dei khmer rossi giunge ad affidare ai
bambini il ruolo di sorveglianti per catturare negli occhi delle persone anche
il più piccolo bagliore di ribellione. Perché ai bambini? Perché non hanno
memoria, non hanno passato, e quindi non hanno pietà.
Eppure, anche il nuovo mondo che sta sorgendo
conosce le sue débâcles. Nonostante tutto, esso non procede compatto verso un
futuro ecologico, paritario, green. E non per colpa di tutti i no-qualcosa che
popolano il mondo, non per il rancore di chi non ha ricevuto dalla società un
senso per cui vivere, e nemmeno per l'egoismo dei ricchi, ma per una
contraddizione insita nel modello stesso.
Ne parla Finkielkraut a proposito delle pale
eoliche. Le pale eoliche, deturpando l'ambiente che dovrebbero proteggere, sono
il simbolo di una specie di nemesi del mito del Progresso, il sogno nato con
«Cartesio e Bacon di renderci padroni e dominatori della natura per sconfiggere
la fatalità e le miserie del genere umano».
Il brusio profondo del lavoro umano è sublime «nel
suo sforzo concertato affinché la Terra non sia più una valle di lacrime (...)
Ma ai nostri giorni, osserva il filosofo francese, la terra implora pietà mentre
il cielo fa quello che gli pare. Più la tecnologia è performante e più
l'avvenire è buio. Ieri vittorioso, il Progresso si è fatto compulsivo e
incontrollabile. Tutto funziona e, a un tempo, tutto deraglia. Tutto dipende
dall'uomo, perfino il meteo, e niente va come lui vorrebbe. La natura entra
nella Storia, e non è una buona notizia, perché la locomotiva della Storia non
ha più qualcuno che la guidi».
Chi sia questo «qualcuno» non sappiamo. Certo non
è un leader politico, o un guru informatico. Forse, più modestamente, è quel
riferimento ad Altro (il totalmente-altro, come lo chiamava Horkheimer) che la
creazione di una città totalmente terrena, senza riferimenti oltre sé stessa (a
dispetto di tutte le chiese, le moschee e le pagode) ha sempre cercato di
cancellare, e che la poesia e l'arte non fanno che ripetere ad orecchie sempre
più sorde.
Nel suo ultimo romanzo, citato da Finkielkraut,
Nemesis, Philip Roth racconta di un uomo colpito da un dolore inaccettabile. Ma
la delusione verso un Dio che non risponde all'assurdità dell'esistenza si
trasforma in una delusione ancora più profonda: verso se stesso.
Abbiamo abbattuto Dio per innalzare l'Uomo, con la
sua pretesa di chiarire tutto, di prevedere tutto, di spiegare tutto. Ne siamo
usciti presuntuosi, violenti e soprattutto vuoti. Ci resta quello che Musil
chiamava «il principio di ragione insufficiente»: ossia «la restituzione agli
eventi del loro carattere fragile, fortuito, intempestivo, aleatorio». Luca
Doninelli
Dagotraduzione dal Sun il 13
novembre 2021. Perché il mio partner non porta fuori la spazzatura? O critica il
programma tv che scelgo di vedere? Chi vive in coppia lo sa: i motivi per
litigare sono tanti. L’esperta di sesso e relazione Kate Taylor esamina le
lamentele comuni delle coppie, spiega cosa nascondono, e indica come
risolverle.
LA TEMPERATURA DI CASA
Pensi che riguardi: il
comfort
Si tratta davvero di: ormoni
Secondo gli studi, a causa dei
livelli più alti di estrogeni, le donne preferiscono una temperatura di 24-25° C
a casa, mentre gli uomini stanno bene con 21,5°C. Le donne inoltre avvertono di
più il freddo quando sono intorno alla metà del loro ciclo mestruale.
Risolvere il
problema: accettate un compromesso (diciamo intorno ai 22°C) e, signore,
avvolgetevi in mutande e coperte termiche a metà mese.
LASCIARE LE LUCI ACCESE
Pensi che riguardi: i soldi
Si tratta davvero di: non
essere quello “divertente”
Sei risentito di dover essere
l’adulto della relazione. Il tuo partner può essere spensierato perché ti assumi
tutte le preoccupazioni da solo. Questo probabilmente accade anche in altre aree
della relazione.
Risolvere il problema: Dividi
le faccende in modo uniforme. Lascia che il tuo partner si occupi delle
bollette, in modo che si renda conto dei soldi che spendete per la luce invece
che per fare cose divertenti.
CARICARE LA LAVASTOVIGLIE
Pensi che riguardi: pentole
sporche
Si tratta davvero
di: inettitudine tattica
Caricano male la
lavastoviglie? Potrebbe essere “inettitudine tattica”: fare un pasticcio in modo
che non venga chiesto loro di occuparsene di nuovo. Vedi anche: bruciare la
cena, ignorare la lista della spesa del supermercato,…
Risolvere il problema: ogni
volta che sbagliano, faglielo rifare. E di nuovo. Ne uscirà veloce ed
efficiente.
PORTARE FUORI LA SPAZZATURA
Pensi che
riguardi: l’immondizia
Si tratta davvero
di: motivazione
Più ricordi al tuo partner che
è il giorno della spazzatura, più se ne dimentica. Per sentirsi motivati a
svolgere un compito noioso, gli umani devono credere di decidere come e quando
lo fanno. L’autonomia dà motivazione.
Risolvere il problema: smetti
di occuparti della microgestione. Lascia che il tuo partner assuma la piena
responsabilità delle sue faccende.
STARE SEMPRE AL TELEFONO
Pensi che riguardi: dipendenza
dal telefono
Si tratta davvero di: gelosia
Secondo YouGov, un terzo di
coloro che hanno una relazione è stato snobbato dal proprio partner a favore di
un telefono. Normale sentirsi soli e insicuri.
Risolvere il problema: rendete
le serate libere dai telefoni. Lasciate i telefoni fuori dalla camera da letto
in modo da coccolarvi l’uno con l’altro. In casi estremi, meglio passare a un
telefono non smart.
PANTALONI SUL PAVIMENTO
Pensi che riguardi: disordine
Si tratta davvero di: essere
dati per scontati
La camera da letto fa da
scenario alla tua vita sessuale. Se è disseminata di boxer e calzini sporchi,
come aspettarsi che uno di voi venga travolto dalla passione?
Risolvere il problema: investi
in un elegante cesto della biancheria per nascondere i reciproci difetti.
NON ESSERE PRONTI IN TEMPO
Pensi che riguardi: essere in
ritardo
Si tratta davvero di: sentirsi
messi da parte
Le persone danno la priorità a
ciò che è importante per loro. Quindi quando un partner ritarda l’uscita per
fare qualcos’altro, dice a tutti quelli che lo stanno aspettando: «Non sei
importante quanto me».
Risolvere il problema: se ci
vogliono due ore per prepararti, trova quelle ore da qualche altra parte nella
tua giornata. Le persone preferiscono vederti puntuale piuttosto che con la
frangia perfetta.
NON ASCOLTARE
Pensi che
riguardi: maleducazione
Si tratta davvero di: sentirsi
poco importanti
Meno il tuo partner ti
ascolta, meno ti sentirai connesso. Alcuni presumo di sapere costai per dire,
altri ignorano la conversazione per evitare l’intimità.
Risolvere il problema: tocca
la mano del tuo partner mentre parli per focalizzare la sua attenzione. Metti le
informazioni importanti all'inizio e chiedi loro di ripetere, così sai che hanno
sentito.
Valentina Santarpia per
il “Corriere della Sera” il 13 novembre 2021. Quattro anni fa fu la dirigente
dell'istituto Vinci Belluzzi di Rimini, Sabina Fortunati, a sollevare la
questione, imponendo un regolamento scolastico che vietava pantaloni corti,
jeans con i buchi, canotte, magliette stracciate, cappellini, ciabatte. L'anno
scorso nel polverone ci finì il liceo romano Socrate: la vicepreside suggerì a
una studentessa di non indossare la minigonna, altrimenti «a qualche prof poteva
cadere l'occhio». Apriti cielo: le ragazze arrivarono a scuola in minigonna,
affiggendo cartelli: «Non è colpa nostra se cade l'occhio». Dopo giorni di
commenti e approfondimenti su come fosse appropriato vestirsi a scuola, su
quanto il decoro contasse in classe e su quali capi di abbigliamento fossero
consentiti o no, la faccenda fu dimenticata. Ma il tema ritorna,
prepotentemente. Una professoressa del liceo artistico Marco Polo di Venezia
qualche giorno fa ha detto alle sue studentesse di non presentarsi in top a
lezione di ginnastica. Anche in questo caso è arrivata la protesta delle ragazze
(appoggiate dai ragazzi) con immagini postate su Instagram : tutte indossavano
un top sportivo sfidando il freddo e srotolando su un ponte lo striscione
«Cambiate mentalità, non i vestiti». Per mostrare solidarietà alle compagne si
sono mossi anche gli studenti del liceo Zucchi di Monza, dove studenti e
studentesse almeno per un giorno hanno abbandonato i jeans e si sono presentati
indossando le gonne. In questo caso c'era l'avallo della dirigente Rosalia
Natalizi Baldi, che ha approvato l'iniziativa degli studenti dell'ultimo anno
contro «la sessualizzazione del corpo». La verità è che «il problema lo hanno
tutte le scuole», come sintetizza Maria Teresa Corea, preside dell'istituto
Amerigo Vespucci di Roma. «Capita che vengano richiamati i ragazzi per il loro
abbigliamento poco adeguato - ammette -. Il mio è un istituto alberghiero,
quindi studentesse e studenti sanno che devono essere sobri, abituarsi a
vestirsi in modo consono. Tacchi adeguati, scollature non eccessive: insomma,
dare di sé un'immagine non volgare». Anche Ludovico Arte, preside del Marco Polo
di Venezia, concorda: «In tutte le scuole del regno ci sono ragazzi che si
vestono in modo più o meno improbabile». Ma lui trova «sbagliato metterci a
censurare il dress code dei ragazzi, perché bisognerebbe anche porsi il problema
di quello degli adulti. Tanto per dirne una, qualcuno viene in ciabatte d'estate
per la maturità. Questo non significa che sia tutto lecito: dovremmo fare un
lavoro di educazione con i ragazzi, per far capire loro che ognuno è libero di
esprimersi ma bisogna capire come si sta nei vari contesti». «Esiste un modo di
vestire adeguato rispetto al contesto, indifferentemente dall'essere ragazzo o
ragazza: ad esempio i calzoncini corti a scuola non sono opportuni - spiega
Cristina Costarelli, dirigente del liceo scientifico Newton di Roma -. Ma quando
si introduce il tema della disparità di genere (ad esempio dicendo di "non
vestire in quel modo perché si diventa provocanti") il discorso cambia, è
assolutamente non condivisibile ed è proprio un tema su cui si sta lavorando in
senso contrario a livello educativo e formativo. Altrimenti finiremmo per
avallare il ragazzo che si sente autorizzato a fare certi atti o a esprimere
certi commenti perché la ragazza era vestita in tal modo». Allora, come
comportarsi? Daniela Crimi, preside del liceo Ninni Cassarà di Palermo, sul
dress code ha una posizione chiara: «I ragazzi possono esprimersi come vogliono,
nel rispetto di se stessi e degli altri. Questo significa che se non sono in
costume da bagno, e questo assolutamente non è consentito a scuola, ma sono in
un abbigliamento dignitoso, possono indossare ciò che vogliono». Ma non è solo
una questione di regole. Ragiona Matteo Lancini, psicologo esperto di
adolescenti e autore di numerosi libri di riferimento: «In passato la scuola
rappresentava prevalentemente il luogo del sapere e degli apprendimenti. Negli
ultimi anni, invece, i ragazzi e le ragazze vivono la scuola come un luogo dove
poter esprimere se stessi in modo più ampio, dove si è adolescenti e non solo
studenti. In questo senso la scuola è diventata un palcoscenico dove comunicare
in modo esplicito chi si è, a volte anche la propria sofferenza e il proprio
disagio. Per i ragazzi e le ragazze di oggi la questione centrale in adolescenza
non è più la sessualità né la trasgressione ma la questione della visibilità,
dell'essere visti. Il corpo è estetico e non sessuale, per questo è diventato
del tutto normale esibirlo, così come, purtroppo accade in altre occasioni».
Che dramma il menù per le
"signore".
Davide Bartoccini il 2 Novembre 2021 su Il Giornale. A ridosso del week end, nel
centro di Milano si è consumato un dramma: all'ospite di un calciatore di serie
A è stato consegnato un menù senza "prezzi", e l'occasione si è fatta ghiotta
per rispolverare il tema sessismo e far correre alle barricate gli chef
stellati. "Scegli quello che ti pare!", il dito passa in rassegna la colonna dei
prezzi che stabiliscono, da che mondo è mondo, il valore d'ogni prelibata
pietanza al ristorante. Scorre, scorre, giù per il menù, fino in fondo; e
l'unghia acuminata si ferma. Ha scelto. "Questo, è buono, 55mila lire". Forse
ricorderete questa magnifica sequenza cinematografica, dove il barbone Barabba
ordina alla cieca "Pommesaux amandes scandinaves" (mele alle mandorle
scandinave, ndr), in un lussuoso ristorante dalle classiche quattro forchette
sulla guida Michelin. Mi è tornata alla mente ieri mentre leggevo il giornale,
quando mi sono imbattuto nell'invettiva contro il "blind menù" lanciata da una
di quelle che, per onorare il più apprezzato dei cliché italiani dopo la pizza,
il mandolino e il Rinascimento forse, se ne stava a cena con il suo compagno:
stranamente un calciatore di Serie A e non un ricercatore del Cern. Secondo
quanto riporta la stampa - ne scrive anche il The Times, non soltanto
il Vernacoliere - la signorina, Agustina Landolfo, avrebbe tacciato l'Italia
di sessismo perché in un esclusivo locale del centro di Milano, qualche
antiquato, testardo, medievale patriarca le avrebbe porto quel tipo di menù che
"oscura" il prezzo delle pietanze all'ospite in virtù di antiquate e ormai
aggiungerei anche vituperate consuetudini dettate dal galateo. Un piccolo dramma
consumatosi tra flûte di champagne e piatti quadri con cascate di cardamomo, o
sale rosa dell'Himalaya o riduzione di pistacchio di Bronte al profumo di foca e
bisque di coccia di ostriche; insomma le classiche diavolerie che quando stai
leggendo il menù di uno stellato o wannabe stellato ti fanno sentire più Angela
Lansbury in "Pomi d'ottone e manici di scopa", di uno che è uscito per mangiarsi
un boccone con la fidanzata. Si è dichiarata estremamente indignata, lady
Lautaro, recriminando il suo diritto, sacrosanto, anche forse di tanto in tanto
auspicato, di voler conoscere il prezzo delle pietanze che si apprestava ad
ordinare nella cena romantica. Conoscere il prezzo fissato all'etto o al grammo,
si fosse trattato di carne di kobe - ossia quella proveniente dai pregiati
bovini massaggiati in Giappone che aveva mandato nel pallone quel macellaio
intervistato nel Chianti -, o di astice azzurro o di tartufo bianco di Alba.
Anche se non è annata, dicono gli esperti. "La cosa peggiore è che molti
italiani giustificano questo fatto dicendo che succede solo nei ristoranti di un
certo livello. E quindi le donne non possono pagare se si tratta di una cena più
costosa?", ha poi chiosato la moglie dell'attaccante dell'Inter in una storia
caricata su Instagram, un buon megafono sempre a portata di mano nell'era del
piagnisteo così ben raccontata da Robert Hughes nel suo saggio. Proseguendo
implacabile: "E se avessi voluto pagare io? Sono indignata". Appellandosi al
diritto di una donna, nella spessa remota evenienza ch'ella volesse, di poter
pagare il conto al suo cavaliere, in questo caso ospite. Ecco una persona
pragmatica - insomma noi gente semplice - si sarebbe limitata a sorridere al
personale del blasonato ristorante e, proprio avesse voluto fare un po' di
teatro, avrebbe sottolineato che era lei l'ospite e lui, l'altro, l'ospitato; e
che dunque prima dell'atroce lettura da parte dei di lui occhi degli importi di
iettature e grammatura da inforcare assieme alle linguine, i menù andavano
"sostituiti". Oppure avrebbe potuto dire teneramente al suo lui, o alla sua lei,
o chi che fosse, "Car* stasera pago io". Ma quel che diverte è la presenza
puntuale e solenne di quel "Se", nelle invettive e nelle denunzie feroci
lanciate da certi personaggi del jet set. "Se avessi voluto dire", "Se avessi
voluto fare", "Se io avessi voluto "pagare", "Se mia nonna avesse avuto le ruote
sai che carrozza", direbbe l'uomo della strada che questi problemi non se li
pone. E forse su Instagram, se s'indigna, gli tocca farlo per altro. Ma troppa
morale poi. Troppa. Fermiamoci quindi al punto in cui la cavalleria, la
galanteria, sono tra le poche cose che restano a noi uomini di una volta. Che
rispettiamo le donne e l'ospitalità di ogni genere e che, per questo, non
vogliamo essere neanche rispettati, ma almeno consolati. Che leggere queste
notizie ci duole. Tanto. E non perché non divideremmo il conto "alla romana". E
non perché pensiamo di essere in dovere di pagarlo intero, alla cieca, perché
magari portiamo noi i soldi a casa. Nient'affatto. Vorremmo essere consolati per
tutte quelle signore che abbiamo invitato a cena per fare i galanti, che non si
sono mai ribellate al sistema come l'audace intrepida Agustina. Noi soli,
pochi, noi banda di fratelli. Ricordo per esempio di un anno, frequentavo la
nipote di un grande industriale, e in una stagione che per il tartufo invece era
stata buona, ella non sborsò mai il becco di un quattrino. Nemmeno un importo
sufficiente ad acquistare una mela e tre mandorle...al mercato. Per questo, e
per altri milioni di casi nel mondo, così atroci, porrei ad Augustina il grande
quesito aristotelico: secondo lei, è nato prima l'uovo o la gallina?
Davide Bartoccini. Romano,
classe '87, sono appassionato di storia fin dalla tenera età. Ma sebbene io viva
nel passato, scrivo tutti giorni per ilGiornale.it e InsideOver, dove mi occupo
di analisi militari, notizie dall’estero e pensieri politicamente scorretti. Ho
collaborato con il Foglio e sto lavorando a un romanzo che
Genere adolescente. La
differenza tra maschi e femmine esiste (ma sia chiaro che io non l’ho mai
detto).
Guia Soncini su L'Inkiesta il 20 Ottobre 2021. Da bambina, Shiloh Jolie-Pitt
somigliava a Brad e amava vestirsi da maschiaccio. Undici anni fa nessuno faceva
ipotesi sul suo vero genere sessuale e oggi può tornare a mostrarsi come una
ragazza. Nell’epoca degli identitarismi, invece, non è più così. Nel 2006,
quando Shiloh Jolie-Pitt aveva pochi mesi, mi trovai – assieme ad altri
disgraziati i cui giornali vogliono poter mettere in copertina una foto d’una
bella attrice e dire «ha parlato con noi, proprio con noi» – attorno a un tavolo
al quale, per venti ambìti minuti, si sarebbe seduta Angelina Jolie – a parlare
con noi, proprio con noi. L’ufficio stampa aveva fatto quel che gli uffici
stampa fanno in questi casi – dirci che le domande personali erano bandite,
intendendo con «domande personali» tutto ciò che attiene a cose più interessanti
e che fanno vendere più i giornali di «ci parli del film che è qui per
promuovere» – ma Angelina Jolie non era mica una starlette che ha paura di
quattro cavalli e quattro segugi che vogliono sapere i fatti suoi. Shiloh era
l’argomento di cui tutti volevamo parlare, per molte ragioni. Era l’unica
neonata bella della storia del mondo, al netto della scarrafonite, la sindrome
ormonale per cui alle madri i neonati sembrano comunque bellissimi. I neonati
sono in genere cosine grinzose che guardi sperando che poi migliorino. Shiloh
era sulla copertina di “People” un minuto e mezzo dopo il parto, ed era
bellissima, liscia come chi è fuori dall’utero da mesi, evidentemente bionica
come la madre. Ed era la prima figlia biologica, Angelina (e poi Brad) avevano
adottato un maschio e una femmina in precedenza (e avrebbero adottato un maschio
già quattrenne l’anno dopo, e successivamente avuto altri due figli biologici,
gemelli). E all’epoca Brad e Angelina sembravano una coppia perfetta:
bellissimi; multietnicissimi: il primo adottato era cambogiano, la seconda
etiope; attentissimi alle buone cause molto prima che diventasse un dovere, per
la gente di spettacolo; disattenti alle puttanate cui badano gli americani e
l’Italia meridionale (questa frase verrà presa benissimo sui social), ovvero il
matrimonio. Non si sarebbero sposati per altri otto anni (per poi separarsi dopo
due; sono ancora coinvolti, a cinque anni dalla separazione, in un perpetuo
litigio tra un tribunale e l’altro, per un po’ tutto, dall’affido dei minori ai
soldi). Brad e Angelina erano la sacra famiglia, e qualcuno doveva chiedere
l’inchiedibile: cosa c’è di diverso nella figlia che è carne della vostra carne,
rispetto a quelli adottati? Toccò a me, che feci tutt’un giro di parole.
Angelina mi sorrise con la condiscendenza d’una sovrana benevola. È la stessa
cosa, disse, «tranne che Shiloh è uguale a Brad». A Brad, mica a lei. Se fossero
stati anni in cui si portava già il discorso sull’identità di genere degli
esseri umani di qualunque età, se fossero stati anni in cui un discorso del
genere fosse parso sano di mente, a quel punto avrei dovuto capire. Ma era
un’epoca in cui si sapeva che il genere sessuale era quello con cui nascevi, in
cui non si cadaverizzavano le parole dividendo tra «sesso» e «genere», e quindi
registrai la risposta e la trascrissi con soddisfazione. Shiloh somiglia al
papà, che cosa carina. Due anni dopo, il papà dice a Oprah Winfrey che Shiloh
vuol essere chiamata John. «Oppure Peter, perché le piace Peter Pan». A
riascoltarlo adesso, si prova il brivido con cui visiti un museo di storia
antica: ve lo ricordate, c’è stata un’epoca in cui sapevamo che se un bambino
dice che è Superman (o Peter Pan, o Cenerentola, o Dumbo) non dobbiamo
preoccuparci della sua identità di genere, è solo un bambino che gioca a essere
un superoe, o una femmina, o un elefante. Ve la ricordate, quell’epoca remota?
Altri due anni dopo, Shiloh ne aveva quattro, la mamma disse che alla piccina
piaceva vestirsi da maschio, si era fatta tagliare i capelli corti, «pensa
d’essere uno dei suoi fratelli». Era un’ovvietà, undici anni fa, quando eravamo
una società sana di mente: una bambina che fa il maschiaccio non ha un disturbo
psichiatrico, non ha bisogno d’essere curata dal sesso che la natura le ha
fornito, non ha bisogno che la società le assegni una nuova identità da
registrare nei documenti: vuole somigliare ai fratelli più grandi, poi passa. (A
volte non passa, e allora una diventa un’adulta con gusti da maschiaccio,
succede; a Katharine Hepburn stavano meglio i pantaloni, e per sua fortuna visse
in un’epoca in cui un dettaglio del genere faceva di te un feticcio modaiolo
invece che una malata di mente che si percepisce d’un altro sesso e che la
società decide di curare illudendola che il sesso si possa cambiare con la
facilità con cui cambi i pantaloni). L’altro giorno Bari Weiss è stata
intervistata sulla Cnn. Le hanno chiesto perché abbia scritto nella sua
newsletter che il mondo è uscito di senno. Con una formula di quelle che
piacciono a Aaron Sorkin, il quale una volta fece dire a un personaggio che
scriveva i discorsi del presidente degli Stati Uniti che quella formula lì era
«a little thing called cadence», Bari ha fatto l’elenco d’indicibilità che
l’avevano convinta della deriva folle, elencando episodi accaduti quand’era
nella redazione degli editoriali del New York Times e anche dopo; tra di esse,
«quando non si può dire in pubblico che esistono differenze tra maschi e
femmine, vuol dire che il mondo è uscito di senno». La stessa sera Shiloh era
alla prima d’un film assieme alla mamma e a fratelli e sorelle. Indossava un
vestito che più da femmina non si può, e ballerine forse dovute al fatto che
l’anno scorso è stata operata all’anca, ma che evocano un effetto bullismo sulla
sorella che ha un anno più di lei ma è alta decine di centimetri in meno.
Un’amica mi ha girato la foto della prole Jolie con un messaggio che rievocava
il fatto che all’asilo Shiloh si sentiva maschio, e che il fatto che ora sia
evidentemente femmina forse dovrebbe farci riconsiderare questo delirio
collettivo del non aspettare che diventino adulti prima di prendere sul serio le
loro istanze. Ho rilanciato ricordandole che ora ha, Shiloh, quindici
piccolissimi anni: fa in tempo a cambiare idea sulla propria identità – sessuale
e di qualunque altro sottinsieme – altre venticinque volte (stima per difetto).
Ma sia chiaro che io tutto questo non l’ho scritto, perché sto sui social da
abbastanza tempo da sapere che dire come la pensi è un diritto inalienabile, ma
assai più inalienabile è il diritto a non farsi rompere i coglioni dai
giustizieri social e dall’ideologia totalitarista che va di moda nel periodo in
corso. In questo caso, quella secondo la quale la mutevolezza dell’identità
sessuale non è affatto segno di malattia mentale, e anzi dirlo mette in pericolo
i malati di mente. Se do delle goccine a quello che si sente Napoleone non lo
sto tutelando, macché: sto dicendo che va picchiato e discriminato e ucciso; è
annuendo di fronte alla follia e dicendo che è davvero Napoleone, che dimostro
di averlo a cuore. Come ha detto Bari Weiss sulla Cnn, parlando della viltà del
New York Times ma anche della nostra di carneadi con uso di social: ma io perché
dovrei passare settimane a smistare insulti se dico una cosa indicibile, quando
posso commissionare un editoriale in cui ci sia scritto che Donald Trump è un
mostro immorale? Vuoi mettere quant’è comodo.
Lavoro e discriminazioni. Svantaggiate ma
non solo: le donne sono un capitale. Azzurra
Rinaldi su Il Riformista il 28 Settembre 2021. La teoria economica ha sempre
avuto un problema con il lavoro femminile. Non a caso, l’Homo Oeconomicus è, di
fatto, davvero un maschio. Su di lui sono modellate tutte le caratteristiche del
successo, così come configurato sin da Adam Smith: non solo è un uomo, ma è
egoista, orientato alla massimizzazione, isolato. Un sociopatico, praticamente
(e, devo dire, fortunatamente lontanissimo dalla realtà della maggior parte
degli uomini reali che mi vengono in mente). Ad ogni modo, le donne, nel
pensiero economico, fino ad una certa fase storica proprio non esistono. A
tentare di colmare questa assenza sono gli economisti della Scuola di
Chicago (meglio noti per il loro sfrenato liberismo, oltre che per aver
sperimentato i propri modelli sul Cile di Pinochet). È Gary Becker ad occuparsi
del lavoro delle donne e, in particolar modo, di quella che potrebbe apparire
come una loro discriminazione in termini salariali. E la spiegazione suona più o
meno così: quando una donna in carriera finisce la sua giornata di lavoro, si
occupa della casa e dei figli. Cosa fa, invece, un uomo ogni giorno al ritorno
dal lavoro? Torna a casa, si mette sul divano, legge un quotidiano o guarda la
TV. È naturale quindi che la donna sia più stanca. E, di conseguenza, meno
produttiva sul mercato del lavoro. Quindi, non deve sorprenderci che venga
retribuita di meno, anche perchè il mercato è perfetto in ogni sua declinazione
e quindi non ammette falle. (Era facile, no??). Sembrano riflessioni lontane nel
tempo, ma la realtà dei fatti è che, ancora nel 2021, il tasso di occupazione
femminile è considerevolmente più basso rispetto a quello maschile. Secondo i
dati europei, nel 2020 il tasso di occupazione delle donne in età lavorativa
(ovvero, compresa tra i 15 ed i 64 anni) è pari al 62,4%. Ma in Italia scendiamo
al 49% e nel Sud Italia arriviamo perfino al 33,2%. Quanto alla disparità
retributiva, possiamo citare il premier Mario Draghi, che, nel suo discorso
programmatico al Senato, ha affermato che «L’Italia presenta oggi uno dei
peggiori gap salariali tra generi in Europa». Stando alle stime
di Eurostat infatti, in Italia la componente discriminatoria del gender pay
gap ammonta al 12%. Sulla scorta di questi dati e con l’obiettivo di avviare una
controtendenza, nell’ultima Legge di Bilancio sono state introdotte alcune nuove
agevolazioni che dovrebbero favorire l’assunzione delle donne. A partire dalla
decontribuzione sul lavoro femminile. La Legge di Bilancio prevede un esonero
contributivo del 100% a favore dei datori di lavoro che assumono nel
periodo 2021-2022 donne che siano disoccupate da 6, 12 o 24 mesi, fino ad un
importo massimo di 6.000 Euro all’anno. In realtà, l’esonero contributivo
determinato con il nuovo bonus non è rivolto a tutte le donne, ma unicamente ad
alcune categorie di donne, identificate come donne svantaggiate, come ad esempio
le donne dai 50 anni di età in su che siano disoccupate da più di 12 mesi o le
donne di qualsiasi età ma che siano disoccupate da almeno 24 mesi. Ma è rivolto,
tra le altre, anche alle donne che risiedono nelle regioni ammissibili ai
finanziamenti sui fondi strutturali europei, o a quelle che lavorano in settori
ad elevata disparità occupazionale di genere. Anche nella Strategia nazionale
per la parità di genere 2021-2026, la riforma del Family Act prevede alcuni
strumenti di fiscalità che dovrebbero contribuire a rimuovere gli ostacoli che
le donne incontrano nel mondo del lavoro. Misure tra le quali si trova, ad
esempio, la decontribuzione per assunzioni e sostituzioni di maternità, che
dovrebbe mitigare la disparità nell’accesso di donne ed uomini al mercato del
lavoro, rendendo meno oneroso per le aziende assumere una donna anziché un uomo.
Stiamo quindi cercando di andare nella direzione giusta, a partire dalla
fiscalità. Ma forse occorre soffermarsi su alcune riflessioni. Nel quadro
dell’Unione europea, la strategia per la parità di genere 2020-2025 contiene
un’affermazione potente: per eliminare il gender pay gap, occorre per prima cosa
risolvere le sue cause profonde e radicate. Bisogna non solo intervenire sul
divario salariale e sul differenziale del tasso di occupazione, ma bisogna anche
aggredire il tema del lavoro di cura non retribuito, da cui deriva l’adozione
massiccia del part-time, nonché sradicare gli stereotipi che sono alla base
delle discriminazioni. L’Unione europea suggerisce anche una roadmap, che
prevede non solo una pianificazione degli interventi specifici rivolti ad
eliminare le disuguaglianze di genere, ma anche (e qui troviamo l’innovazione)
una vera e propria integrazione della questione di genere su tutti i livelli
dell’azione politica, dalla programmazione all’attuazione concreta. E forse su
questo piano siamo ancora in difetto. Bene, infatti, la decontribuzione, che
rappresenta senza dubbio un punto di partenza per sanare le disparità di genere
sul mercato del lavoro, riconoscendo le donne come una categoria svantaggiata.
Ma forse è arrivato per il nostro paese il momento di fare un salto culturale ed
assumere davvero un principio di base (che ahinoi non è stato assunto neppure
nel Pnrr): le donne non sono solo svantaggiate. Le donne del nostro paese
rappresentano un capitale, sono più numerose degli uomini e più istruite,
potrebbero contribuire alla creazione di ricchezza e di valore aggiunto. Ed il
ruolo delle istituzioni dovrebbe essere anche quello di agevolare una
transizione culturale che parta da questa presa di consapevolezza. Azzurra
Rinaldi
Carlo Nicolato per “Libero Quotidiano” il 27
settembre 2021. Certo, da una pubblicazione scientifica non è che potessimo
aspettarci una citazione di Dante per descrivere con parole appropriate il
genere femminile, ma definire la donna "corpo con vagina" è davvero troppo.
Indignante e perfino sorprendente per una rivista di indiscutibile prestigio
come la britannica "The Lancet", considerata insieme a poche altre come una
sorta di Vangelo nel campo medico-scientifico. Per la verità, alla redattrice
senior Sophia Davis non avevano affidato un compito facile, visto che era stata
spedita al Vagina Museum nel Camden Market di Londra per recensire una mostra
sul "menstrual shame" dal titolo "Periods on Display"; ma è evidente si sia, per
così dire, fatta prendere la mano dagli schemi mentali e comunicativi
attualmente in voga. Travolta dagli eccessi del politically correct, ammaliata
dalle sirene della cancel culture e dall'ideologia woke - quella che appunto
afferma la necessità di stare sempre all'erta di fronte a razzismo e alle
discriminazioni sessuali -, per la copertina del suo articolo ha scelto un
titolo che in realtà è una citazione del pezzo stesso, in cui si asserisce che
«storicamente, l'anatomia e la fisiologia dei corpi con le vagine sono state
trascurate». Una battuta consona al tema della mostra in un museo peraltro già
di suo non esattamente aulico? Può darsi, ma di gran pessimo gusto visto che tra
l'altro l'articolo appare su una pubblicazione che dovrebbe interessarsi di
scienza senza far discutere di altro. La definizione, come ovvio, ha scatenato
una diffusa indignazione sui social media, specie su Twitter, dove la pagina in
questione è stata riportata provocando una serie di contraddittorie proteste,
una specie di cortocircuito tra le vestali del pensiero unico. Tra chi si è
ritenuto offeso ci sono politici, scienziati, medici. Ad esempio lo psichiatra
in pensione e professore dell'University College di Londra Dave Curtis che
comunica, indignato, di aver scritto a Lancet «per dire loro di togliermi dalla
loro lista di revisori statistici e cancellare il mio abbonamento e non
contattarmi mai più per nulla». Ci sono ovviamente e giustamente anche le
femministe, come il gruppo "Women Make Glasgow", che dicono di voler presentare
un reclamo formale su quella copertina «disumanizzante e sessista». Ma tra gli
indignati ci sono anche gli attivisti dei diritti gay, lesbian, bisexual,
trangender, e poi queer, intersexual e perfino asexual, secondo la versione
attualizzata d'oltreoceano. «Il linguaggio disumanizzante ha ora infettato il
Lancet», ha ad esempio twittato Dennis Kavanagh di Lesbian & Gay News. «Dove
andremo a finire?» ha scritto invece Martina Navratilova, grande tennista del
passato e celebrata atleta del mondo Lgbt. Ovviamente nessuno toglie a questi
maître à penser della vulgata pseudo progressista il diritto e le libertà di
indignarsi, se non fosse che sono proprio loro che hanno innescato la deriva che
ha trascinato al largo anche il Lancet, promuovendo la cancellazione dei "gender
binari" e di fatto la disumanizzazione dei sessi (si badi, non del sesso),
ridotti così in definitiva a pura scelta individuale, se non addirittura a
capriccio. In quest'ottica la vagina diventa una semplice caratteristica fisica,
perfino trascurabile e in alcuni casi indesiderata, mentre l'utero viene
relegato a mero organo utile solo allo scopo riproduttivo. D'altronde cos'è se
non un "corpo con vagina" una donna che a pagamento riproduce un bambino per una
coppia gay? Ma questa non è la sola contraddizione. L'altra, più politica, è che
contro la definizione di Lancet si è scatenato tutto l'armamentario politically
correct progressista e di sinistra, sotto il cui ombrello convivono appunto
femminismo alla Boldrini ed estremismo Lgbt, anche se sono l'uno la negazione
dell'altro. In questa supponente cozzaglia ideologica, convive chi vorrebbe
declinare al femminile parole che non lo richiedono per onorare la parità dei
sessi, e chi al contrario vorrebbe introdurre l'asterisco per annullare i sessi,
neutralizzando e trascendendo i generi. Trasformando cioè l'umanità in corpi con
vagine e corpi con peni.
Selvaggia
Lucarelli per tpi.it il 9 settembre 2021. Ho provato a immaginare una realtà
parallela in cui la coppia Concita De Gregorio/David Parenzo alla conduzione di
In Onda sia la stessa, ma a sessi invertiti. David è una donna, Concita un uomo.
Ecco, non saremmo arrivati alla terza puntata senza le barricate delle
femministe (me compresa) fuori dagli studi, visto non tanto l’evidente
disequilibrio negli spazi concessi ai due nel programma (Parenzo parla meno
della Lagerback da Fazio) ma per i modi con cui lei si rivolge a lui.
Sbrigativi, sprezzanti, conditi da sorrisini nervosi attraverso i quali mostra
forzatamente i denti (che nel linguaggio non verbale significano una cosa ben
precisa: ti vorrei addentare la giugulare) e con una frequente espressione che
copre tutte le scale di colori comprese tra il disprezzo e il compatimento.
Davvero, se Concita De Gregorio fosse un uomo, non staremmo neppure più qui a
parlarne. Avrebbe preso un unico, gigantesco cazziatone agli esordi e si sarebbe
ravveduta. E invece ne parliamo perché ieri sera si è raggiunta la vetta più
alta della sua arroganza. Ospite il ministro Luigi Di Maio, lo stesso Di Maio ha
respirato quell’imbarazzo che si respira a cena, di fronte a una coppia di amici
con lui che tratta di merda la moglie o viceversa e tu balbetti qualcosa per
sdrammatizzare, ma vorresti infilare la testa nell’insalatiera per l’imbarazzo.
Tra l’altro, duole dirlo, ma modi a parte, sul tema virus e Green Pass la De
Gregorio era di un’impreparazione tale che Parenzo e Di Maio al confronto
parevano Fauci e Burioni. A partire dalla sua sconcertante premessa, ovvero: “Il
Green Pass da solo non serve a niente, è solo una certificazione che significa
che sei tamponato o vaccinato per entrare nei posti”. Che voglio dire, certo che
da solo non serve a niente, infatti non è l’unica misura di contenimento del
paese. E no, non è “solo una certificazione”, ma, appunto, una misura di
contenimento del virus e di protezione per i cittadini. A quel punto il ministro
Di Maio spiega con chiarezza che “il Green Pass serve a entrare nei locali,
luoghi insomma in cui c’è la più alta probabilità di trasmettere il virus. Non
sarà certo meglio tornare al coprifuoco…”. La De Gregorio scatta come se Di Maio
avesse urlato “sieg heil!” in piedi sulla scrivania. E lo interrompe con una
supercazzola devastante, avvitandosi su se stessa come spesso le succede: “Il
Green Pass è uno strumento di controllo, non di cura! Il vaccino cura o comunque
previene cioè “cura” è inesatto, diciamo che PREVIENE DALLA malattia, mentre il
Green Pass controlla se ti sei vaccinato. Quindi il governo si deve prendere la
responsabilità eventuale”. In pratica, a un anno e mezzo dalla pandemia, la De
Gregorio non ha ancora capito le basi dell’epidemiologia, e questo sarebbe pure
un peccato grave ma accettabile, ma su quelle dell’educazione ero convinta
andasse più forte. E invece riesce pure a rimproverare gli altri interlocutori
del problema che la affligge in quel momento: la confusione. “Introducendo il
Green Pass abbassiamo la curva dei contagi!”, dice Di Maio, provando a
semplificare il concetto. E lei, nervosa: “No, non è che abbassiamo la curva,
col Green Pass non facciamo entrare le persone non vaccinate e tamponate, è
questa la questione sennò facciamo confusione!”. In pratica, secondo la
conduttrice, il Green Pass è una specie di tessera magnetica dell’hotel, serve
solo a entrare in camera. Probabilmente lei accede ai tavolini al chiuso nei bar
con la scheda della camera 107 dell’Hilton. Non ha capito quello che hanno
capito anche i lampioni: se nei luoghi al chiuso entrano solo persone o
vaccinate (quindi protette e meno contagiose se infette) o tamponate (quindi
probabilmente non infette e in contatto con persone che se infette contagiano
meno gli altri, perché vaccinate) il virus si contiene di più. E i primi ad
essere protetti dal Green Pass sono proprio i non vaccinati. Che non sono
discriminati, ma tutelati. Parenzo, che ha capito, aggiunge incauto: “Non voglio
dar ragione a Di Maio, ma il Green Pass è incentivante!”. Ha dato ragione a un
grillino. A UN GRILLINO. Lei mostra le gengive fingendo di sorridere e lì si
capisce che butta male, tipo il gatto quando muove la coda. Sono segnali della
natura che non si possono ignorare. E insiste, improvvisandosi portavoce “delle
persone” che non si sa chi siano, se quelle che incontra lei al bar o quelle che
al casello autostradale pagano contanti, boh: “Le persone non vogliono il Green
Pass perché il Green Pass stabilisce che ci sia una differenza tra vaccinati e
non vaccinati!”. Parenzo prova a proferire parola e lei: “Non sto parlando con
te, sto parlando con LUI!”. Cioè, Parenzo non è un suo interlocutore titolato ad
intervenire e il ministro è un “Lui generico”. Una specie di schwa, ma un po’
meno. L’invasione della Polonia è stato un momento di maggiore modestia, nella
storia. Mentre Di Maio assiste allibito alla tensione tra i due conduttori, lei
va avanti: “Molta gente dice ‘se ci dobbiamo vaccinare vi dovete prendere voi la
responsabilità, perché io devo firmare? Dovete imporre voi l’obbligo’, oggi una
signora mi ha scritto questo!”. Persone, gente, una signora. Deve essere la
nuova sinistra che vuole dimostrare di ascoltare la gente. Ma soprattutto la
nuova sinistra che non ha mai sentito parlare di “consenso informato” in tema di
sanità. Un concetto nuovo, inedito, per la conduttrice. Di Maio dice un altro
paio di cose insolitamente lucide e Parenzo, che ormai ha deciso di morire come
quei delfini che si spiaggiano da soli e non sai perché, sussurra: “Io non sono
d’accordo con Concita!”. I denti. Le gengive. “IO faccio un mestiere che è
quello del giornalista e il giornalista fa domande!”, sibila lei. IO. Come a
dire “tu invece sei un metalmeccanico” e “tu invece annuisci e basta”. Il
problema è che le sue non erano quasi mai domande, ma affermazioni. Dovrebbe
rivedersi la puntata, la De Gregorio, e scoprirebbe che oltre all’assenza di
educazione, di equilibrio, di preparazione, ieri c’era anche quella dei punti
interrogativi. I grandi latitanti, nella sua vita televisiva. E non solo.
DISCRIMINAZIONI DI GENERE.
E se Einstein si fosse chiamato Alberta? Una favola insegna a dare alle
scienzate il valore che meritano.
Artefici di scoperte chiave, eppure oppresse dal “tetto di cristallo”. Un
movimento prova ora a ribaltare il maschilismo scientifico. Stefania Di Pietro
su L'Espresso il 31 agosto 2021. Proviamo ad immaginare cosa sarebbe potuto
accadere se Albert Einstein, Alexander Fleming ed Erwin Schrödinger fossero nati
donne. È ciò che ha pensato Amit, l’ong spagnola, nata nel 2001, che riunisce le
ricercatrici e tecnologhe di tutto il mondo attraverso la nuova campagna di
sensibilizzazione #NomoreMatildas della GettingBetter Creative Studio. Immagini,
video e tre racconti illustrati, scaricabili gratuitamente dal sito
ufficiale sono tra le proposte nate con l’obiettivo di incoraggiare le ragazze
ad intraprendere una carriera scientifica. L’icona posta a manifesto della
campagna è Matilda Joslyn Gage, un’attivista americana che si occupò di
abolizionismo, difesa dei popoli nativi ed emancipazione femminile. I creatori
del progetto hanno deciso di ricordarla dopo la ricerca della storica della
scienza Margaret W. Rossiter, la prima a denunciare nel 1993 l’invisibilità
delle donne sotto il nome di «effetto Matilda». Con l’appoggio del Parlamento
europeo, le tre favole spagnole sono diventate in breve tempo un fenomeno
sociale. Le ipotetiche vite di tre donne geniali dotate di cognomi di un certo
spessore, sono divenute spunto di riflessione per un pubblico senza età tanto da
far registrare il sold out per la prima edizione di questi storybook.
L’illustratore Rodrigo García Llorca ha alleggerito il tema con simpatiche
illustrazioni in bianco e nero, mentre a raccontare con semplicità, empatia e
senza troppa polemica le tre brevi favole sono stati gli scrittori Nöel Lang e
Ángeles Caso, in collaborazione con la giornalista Carme Chaparro. In un’epoca
in cui imperava un maschilismo di Stato, le carriere delle tre Matilde avrebbero
avuto degli intoppi lungo il percorso a causa di una scarsa considerazione di
fondo. Per la società le tre donne geniali sarebbero state «cristallizzate»,
relegate in una posizione periferica poiché non assimilabili alla normalità di
genere, etichettate piuttosto come tre creature aliene, fondamentalmente fatte
male perché dotate di un cervello troppo maschile. Le loro valide scoperte
sarebbero state nascoste per rendere invisibile il contributo di un’intelligenza
femminile al mondo della scienza. Ma i pregiudizi sulle attitudini rosa per
fisica, matematica e chimica sembrano non tramontare mai. In generale, quando
oggi si domanda a qualcuno di ricordare un grande scienziato, più della metà
delle persone dice subito un nome maschile, con Albert Einstein che batte tutti.
Nella storia compaiono pochi nomi di scienziate nonostante siano state artefici
di scoperte chiave. Attualmente i riferimenti femminili sono appena un centesimo
nei libri di testo delle scuole primarie e secondarie e poco più nei lavori
accademici. Alcuni esempi sono riportati in un documento di otto pagine
illustrate, che l’Amit propone di allegare ai libri di testo delle scuole
elementari a partire dalla quinta classe, in quanto è il primo anno in cui si
iniziano a studiare i personaggi che hanno fatto storia. Tra le donne mai citate
c’è la biochimica ceca Gerty Cori, premio Nobel per la medicina nel 1947,
riconoscimento che dovette obbligatoriamente condividere con il marito e un
collega per le scoperte sul glicogeno. Poco si sa sul talento di Irene
Joliot-Curie, figlia della famosa Maria che nel 1935 fu orgogliosa di vedere
riconosciuto il premio Nobel per la chimica proprio alla ragazza, costretta a
dividerlo con il marito collega. In tempi più recenti, l’immunologa francese
Francoise Barré-Sinoussi ricevette nel 2008 il premio Nobel per la medicina
insieme al più noto e citato Luc Montagnier per lo studio sull’Hiv. E la lista è
lunga. L’idea di allegare ai libri scolastici ordinari degli opuscoli con le
storie di scienziate poco raccontate è un valido tentativo per superare
definitivamente il gender gap, partendo proprio dall’infanzia e dalla scuola.
«Il divario di genere è ancora troppo largo e si riflette sulle condizioni
economiche, sociali, sull’accesso all’istruzione e al mondo del lavoro, in
particolare per le discipline Stem (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) in cui la presenza femminile è di certo troppo bassa. Oggi una
ragazza su otto decide di iscriversi alla facoltà di Ingegneria informatica e se
prima in Matematica si vedeva qualche spiraglio di speranza femminile, adesso le
donne rappresentano soltanto i due quinti e i numeri sono sempre più in
discesa», spiega Carmen Fenoll, Presidente dell’Amit e professoressa di
Fisiologia vegetale presso la Facoltà di scienze ambientali e biochimica
dell’Università di Castilla-La Mancha a Toledo. Nel manifesto dell’ong spagnola
è espresso il punto cruciale della questione: quanto la mancanza di referenze
femminili abbia avuto un forte impatto sulle aspirazioni delle ragazze nel
momento della scelta professionale e come per loro sia ancora troppo complicato,
rispetto ai colleghi maschi, decidere di intraprendere facoltà matematiche o
ingegneristiche, non certo per assenza di capacità, ma solamente per la certezza
di non essere successivamente prese in considerazione in ambito lavorativo. «La
voragine di genere inizia purtroppo durante l’adolescenza, già nella scelta
della scuola secondaria: soltanto tre ragazze su dieci si sentono incoraggiate a
intraprendere studi scientifici e all’università il solco tra maschi e femmine
diventa profondissimo. Se l’interesse femminile per le materie
tecnico-scientifiche si sviluppa intorno agli undici anni, già cala verso i
sedici, quando inizia la consapevolezza di ciò che si vorrebbe fare nella vita.
Il motivo è da ricercare nella percezione di assenza di pari opportunità nel
mondo del lavoro che determina un ripensamento e di conseguenza la spinta a
scelte differenti, per così dire più sicure», spiega Carmen Fenoll.
#NomoreMatildas non rappresenta soltanto una campagna puramente descrittiva, ma
un modo per limitare i danni causati dall’invisibilità femminile in ambito
scientifico. «Il problema non è da sottovalutare, poiché una delle
disuguaglianze di genere più citate nel campo della scienza è il cosiddetto
“soffitto di cristallo”. Le donne arriverebbero soltanto fino ad un certo
livello di carriera, ma poi difficilmente raggiungerebbero il vertice e in
ambito scientifico ancora oggi solo una scienziata su dieci assume alti
incarichi accademici». In pratica le adolescenti percepiscono che la scienza sia
una cosa da uomini e cambiano velocemente idea sul percorso da intraprendere.
Inoltre la società, la famiglia e la scuola dubitano dell’idoneità delle ragazze
a perseguire un cammino scientifico, quindi ciò crea forti dubbi anche nelle
stesse adolescenti. «Chi riesce a superare questi ostacoli si ritrova in
ambienti accademici ostili, ancora afflitti da stereotipi inconsci. Molte
ragazze abbandonano e altre non riescono a realizzare il proprio potenziale.
Questo circolo dell’invisibilità è molto difficile da spezzare, nonostante i
progressi legislativi», afferma il presidente dell’Amit. L’hashtag nasce proprio
con lo scopo di aiutare le donne a trovare il proprio ruolo nella scienza e a
spingere le adolescenti a considerare questo campo come opzione di carriera
senza farsi scoraggiare dai muri di cristallo, ma le azioni vanno attuate
attraverso le istituzioni per assicurare il totale abbattimento delle
discriminazioni, combattendo attivamente contro gli stereotipi di genere e
garantendo un ambiente di lavoro equo per tutti. Occorre sostenere l’interesse
delle bambine verso la scienza garantendo un pari accesso a percorsi formativi
in ambito tecnico-scientifico, rendendole protagoniste attive delle proprie
scelte. Margherita Hack e Rita Levi-Montalcini sono per fortuna tra le eccezioni
alla regola. Le nostre signore della scienza erano dotate di qualità
perennemente giovani: curiosità, sete d’avventura, ironia e spirito ribelle.
Rita è stata la seconda donna italiana ad aver ricevuto un premio Nobel nel 1986
scoprendo il fattore di accrescimento della fibra nervosa, fu nominata senatrice
a vita nel 2001, ma ammessa abbastanza tardi per i tempi storici come prima
donna alla Pontificia Accademia delle Scienze. Margherita ha svelato al mondo un
amore che nasceva dalla sete di conoscenza e per lei il coraggio di sapere non
doveva avere età né tantomeno appartenenza ad un genere. «Oggi i geni solitari
nel mondo della scienza sono un’eccezione, quasi sempre il lavoro è di squadra,
ma l’effetto Matilda c’è ancora, alimentato da meccanismi inconsci che fanno
pensare come i risultati raggiunti siano ad opera di uomini e che le donne
rappresentino solo una piccola parte di quella squadra. È l’ora di sbarazzarci
di questi stereotipi cosicché tutte le scienziate, di cui nessuno parla ai
bambini, possano riprendere il posto che spetta loro nella storia». Le tre
Matilde vogliono essere uno stimolo per risvegliare nelle bambine una vocazione
scientifica, soffocando quelle voci che fin dalla più tenera età dicono loro che
sono meno intelligenti e dotate per la scienza rispetto ai maschietti. In tal
senso, la campagna Amit ha già avuto un forte riscontro: sono molti i professori
che a titolo personale hanno pensato di utilizzare le tre favole come allegati
ai libri di testo, mostrando anche ai propri alunni il video presente nel sito
ufficiale della campagna. Ed è per tutto il mondo un esito che fa ben sperare.
·
La cura maschilista.
Curami.
Report Rai PUNTATA DEL
01/11/2021 di Antonella Cignarale. Nello studiare la salute della donna, per
anni, si è posta l’attenzione soprattutto sui suoi organi sessuali e
riproduttivi. Le malattie, i sintomi, le cure sono state studiate
prevalentemente sull’organismo maschile, traslando i risultati delle ricerche
sulla donna, come se non ci fossero differenze. Per esempio, i sintomi di alcune
malattie nella donna sono diversi da quelli nell’uomo e per questo non sempre
riconosciuti: può accadere così che ad alcune donne colpite da Alzheimer sia
diagnosticata la depressione o che altre colpite da infarto al miocardio
finiscano ricoverate nei reparti di psichiatria. Simili errori si trascinano
anche nello sviluppo di nuove terapie, quando i dati delle sperimentazioni
farmacologiche effettuate su uomini e donne non sono analizzati separatamente.
Nell'era della medicina di precisione è accettabile dal punto di vista etico,
scientifico ed economico non considerare l’influenza delle differenze di
genere?
“CURAMI”
Di Antonella Cignarale immagini di Alfredo Farina, Davide Fonda e Fabio
Martinelli ricerca immagini di Paola Gottardi grafica di Michele Ventrone Report
Rai
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO
Per anni le malattie, i sintomi e le cure sono state studiate prevalentemente
sull’organismo maschile: il suo cuore, i suoi polmoni, il suo cervello. Non
sulle donne. Un errore.
GIOVANNELLA BAGGIO –
CARDIOLOGA – CENTRO STUDI NAZ. SALUTE E MEDICINA DI GENERE Tutti gli organi sono
differenti tra uomini e donne.
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO
Si crede che l’infarto riguardi soprattutto gli uomini, invece le malattie
cardiovascolari sono la prima causa di morte nelle donne. E i sintomi
dell’infarto nella donna sono diversi da quelli nell'uomo.
GIOVANNELLA BAGGIO –
CARDIOLOGA – CENTRO STUDI NAZ. SALUTE E MEDICINA DI GENERE Il famoso dolore al
petto irradiato al braccio sinistro la donna, soprattutto più giovane è, meno ce
l’ha. Qualche dolore lo può avere tipo alla base del collo, all'addome, può
anche avere solo un po' di nervosismo.
ANTONELLA CIGNARALE Per questo
ci possono essere anche rischi di ritardo nel diagnosticare, ad esempio, una
patologia in una donna?
GIOVANNELLA BAGGIO –
CARDIOLOGA – CENTRO STUDI NAZ. SALUTE E MEDICINA DI GENERE Sì. Io ho una signora
che è andata a finire in gastroenterologia, ho un'altra signora che è finita in
psichiatria. Però tutte e due avevano un infarto al miocardio.
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO
E la cardio aspirina ha una particolare efficacia sulla donna?
GIOVANNELLA BAGGIO –
CARDIOLOGA – CENTRO STUDI NAZ. SALUTE E MEDICINA DI GENERE Solamente nel 2006
siamo arrivati a capire che nella donna previene l’ictus, ma perché questo?
Perché fino a questo momento erano stati fatti esperimenti con l’aspirina
solamente nell’uomo.
FLAVIA FRANCONI – FARMACOLOGA
- OSSERVATORIO MEDICINA DI GENERE ISS Dobbiamo pretendere che sia fatta la
scienza rigorosa, che non sia traslato nelle donne ciò che è stato coperto negli
uomini.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Curami. Sembra facile. Buonasera. Le pari opportunità sono saltate anche nel
campo della medicina. Se un farmaco viene ingerito invece che da un uomo, da una
donna, potrebbe aumentare l’effetto e anche la reazione avversa potrebbe essere
più cruenta. Ma questa è una spiegazione, perché quando viene fatta una ricerca,
uno studio, viene fatta prevalentemente sugli uomini. Questo vale anche sullo
studio delle patologie che vengono fatte più sul sesso maschile. Insomma. Ma
qual è il prezzo nascosto che facciamo pagare - neppure tanto nascosto che
facciamo pagare alle donne? Un alto prezzo. La nostra Antonella Cignarale.
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO
Sono passati vent’anni dall’allarmante rapporto del Government Accountability
Office statunitense in cui veniva riportato che su dieci medicine ritirate dal
mercato, otto presentavano maggiori rischi per la salute nelle donne che negli
uomini. Tuttavia, poco è cambiato: sebbene le donne siano le maggiori
consumatrici di medicinali, molti dei farmaci che assumono sono stati testati
prevalentemente su un campione maschile di 70 chili.
ANTONELLA CIGNARALE Che
differenza c’è quando questo farmaco lo assume un uomo di 70 chili e una donna
come me?
FLAVIA FRANCONI – FARMACOLOGA
- OSSERVATORIO MEDICINA DI GENERE ISS Può succedere che mi va in iperdosaggio,
quindi, può avere più reazioni avverse ai farmaci.
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO
E solo quando si sono verificati eventi gravi questa diversità è stata
riconosciuta con una dose più appropriata per la donna. È successo negli Stati
Uniti, dove è stata osservata da studi clinici una correlazione tra incidenti
stradali e l’assunzione da parte delle donne di un farmaco per curare
l’insonnia, a base di zolpidem. Rispetto agli uomini, la stessa dose di farmaco
assunta la sera veniva eliminata più lentamente nelle donne aumentando il
rischio di compromettere la guida la mattina dopo. Così negli Stati Uniti la
FDA, l’agenzia regolatoria del farmaco, ha raccomandato di dimezzare la dose per
la donna rispetto a quella per l’uomo.
FLAVIA FRANCONI – FARMACOLOGA
- OSSERVATORIO MEDICINA DI GENERE ISS Le diversità sono nell’assorbimento, nella
distribuzione, nel metabolismo.
ANTONELLA VIOLA – IMMUNOLOGA –
PROF. PATOLOGIA GENERALE UNIVERSITÀ DI PADOVA Le reazioni avverse che sono più
frequenti, appunto, nel sesso femminile dipendono dal fatto che le donne hanno
una biologia diversa. Ma dipende anche dal fatto che le donne, molto spesso, non
sono incluse e studiate in maniera adeguata durante la sperimentazione
preclinica e clinica.
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO
Il controllo degli effetti di un medicinale avviene durante la sperimentazione
farmacologica ma è proprio qui che il sesso femminile è sottorappresentato. La
fase preclinica viene condotta prevalentemente su animali maschi e anche nelle
fasi successive il numero delle donne testate è spesso inferiore al numero degli
uomini. I principali motivi di questa esclusione sono la variabilità ormonale,
le fasi del ciclo e il rischio gravidanza.
FLAVIA FRANCONI – FARMACOLOGA
- OSSERVATORIO MEDICINA DI GENERE ISS Se tu fai una ricerca di genere rispetto a
una ricerca non di genere spendi sicuramente il doppio, ma non solo: la ricerca
di genere è più lunga. Quindi questo non incentiva né l’industria farmaceutica,
né l’industria dei device, né i ricercatori.
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO
Basterebbe bilanciare nei test il numero di donne e uomini e separare i
risultati degli studi per ciascuno dei due sessi. L’associazione Women’s Brain
Project ha condotto un’analisi sugli studi di farmaci sperimentati per
l’Alzheimer, e ne emerge che solo 7 studi su 56 hanno riportato i dati della
risposta ai farmaci separando quelli delle donne da quelli degli uomini.
ANTONELLA CIGNARALE Nello
studio di patologie e nello sviluppo di nuove cure, quando non dividiamo i dati
per uomo e per donna poi che cosa ci perdiamo?
ANTONELLA SANTUCCI CHADHA – AD
PRO BONO ASSOCIAZIONE WOMEN’S BRAIN PROJECT Perdiamo delle informazioni
importantissime a capire come la malattia si differenzia tra maschio e femmina
in termini di sintomo, di decorso e quindi, successivamente, di risposta
terapeutica ad un determinato agente.
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO
La struttura di farmacologia sperimentale del Centro di Aviano ad aprile ha
pubblicato un’analisi sull’efficacia dei vaccini per il COVID-19 nei due sessi.
I dati su cui si è basato lo studio sono quelli valutati dagli enti regolatori
per darne l’approvazione. All’epoca i dati pubblici divisi per sesso erano
quelli di Pfizer, Moderna, Johnson e Sputnik e ne emerge come a poche settimane
dalla prima e dalla seconda dose la percentuale di efficacia nel prevenire il
COVID-19 sia leggermente diversa nei due sessi.
GIUSEPPE TOFFOLI – DIRETTORE
FARMACOLOGIA SPERIMENTALE CRO DI AVIANO (PN) Una volta fatto il vaccino è
efficace nell’uomo e nella donna, però c’è un trend di tendenza di efficacia
maggiore nell’uomo.
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO
E con il passare del tempo il trend sembra cambiare. Confrontando questi primi
dati con quelli pubblicati a settembre relativi all’efficacia di Pfizer e di
Moderna dopo 5/6 mesi dalla seconda dose si nota come la percentuale di
efficacia diventi maggiore nella donna.
GIUSEPPE TOFFOLI – DIRETTORE
FARMACOLOGIA SPERIMENTALE CRO DI AVIANO (PN) Probabilmente la capacità del
sistema immune di una donna diventa più, diciamo, prono a difendersi dal virus
con l’andar del tempo rispetto all’uomo.
ANTONELLA CIGNARALE Siete
riusciti a fare anche un paragone della sicurezza del vaccino nell’uomo e nella
donna?
GIUSEPPE TOFFOLI – DIRETTORE
FARMACOLOGIA SPERIMENTALE CRO DI AVIANO (PN) Sì. Noi abbiamo dati disaggregati
per sesso dopo cinque mesi relativi al vaccino Moderna. Se dobbiamo fare il
confronto, è un po’ più sicuro nell’uomo rispetto alla donna, questo è il dato
che emerge.
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO
Ma per l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, questi dati sull’efficacia dei
vaccini non evidenziano differenze significative tra i due sessi. E neanche i
dati sulla sicurezza di Moderna sono un chiaro segnale di aumento di reazioni
avverse nelle donne rispetto agli uomini.
ANTONELLA CIGNARALE Com’è
possibile che dai dati della sperimentazione dei vaccini le differenze tra
uomini e donne nella sicurezza non sono considerate significative, poi però, dal
rapporto di farmacovigilanza vediamo che il 72 percento delle reazioni avverse
sono state registrate nelle donne.
ANTONELLA VIOLA – IMMUNOLOGA –
PROF. PATOLOGIA GENERALE UNIVERSITÀ DI PADOVA Questo succede perché passando da
una vaccinazione a poche migliaia di persone a centinaia di milioni di persone,
ecco che le reazioni anche più rare possono emergere. Se poi lei guarda bene i
dati disaggregati non solo per genere ma anche per età, vedrà che la differenza
tra uomini e donne è più ampia nell’età fertile, no? Quindi dai 20 anni ai 50
più o meno proprio perché questa è la fascia in cui il sistema immunitario delle
donne è molto più reattivo rispetto a quello degli uomini.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO Non
c’erano dubbi che fossero le più reattive. È la fotografia che emerge anche dal
Centro di Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità che ha appurato
che i vaccini a MrnA, sono più efficaci per contrastare la forma sintomatica del
virus, nelle donne rispetto agli uomini. 96% contro 88%. Ma questo noi lo
possiamo sapere perché sono stati divisi i dati in questo per età e sesso. Ma
non sempre funziona così, anzi, le aziende farmaceutiche e i ricercatori, quando
devono sperimentare nei test preclinici o quelli clinici o quando vengono
sperimentati i dispositivi medici, non studiano in materia approfondita le
reazioni sulle donne. Questo perché hanno un organismo più complicato e diverso
e perdono più tempo che si traduce in più costi. Allora viene semplice traslare
quello che hanno scoperto sull’uomo. È una visione miope perché non calcolano
che quello che risparmi oggi, domani lo dovrai investire a spese del Sistema
Sanitario Nazionale, per curare le reazioni avverse non previste o le diagnosi
errate. La soluzione c’è: investire sulla medicina di genere. Anche perché poi,
a pensarci bene non è che è così etico far pagare alle donne anche quest’altro
prezzo.
·
Comandano Loro.
Mario Bernardi Guardi per "Libero quotidiano" il
12 dicembre 2021. «Io sono io» amava dire Virginia Verasis, contessa di
Castiglione. Bella, anzi bellissima. Ma tutt' altro che impossibile, visto che
ebbe una cinquantina di amanti. Tra cui un re, Vittorio Emanuele II di Savoia,
un imperatore, Napoleone III Bonaparte, il bel diplomatico Costantino Nigra,
ministri, banchieri, giornalisti. Tutti affascinati da quella "seduttrice
seriale" (così la definisce Benedetta Craveri nella bella biografia La contessa.
Virginia Verasis di Castiglione, Adelphi, pp. 452, euro 24). Disposta a tutto
per raggiungere i suoi scopi, infrangeva i cuori e incendiava i sensi. Altera ed
algida, per decenni signoreggiò di corte in corte, spesso ostentando un sovrano
disdegno per quelli che spasimavano per lei. Fino a un vero e proprio delirio di
onnipotenza che diventò cupa depressione quando la sua immagine cominciò a
incrinarsi e prese il via una inarrestabile decadenza.
ANTESIGNANA Ma prima di allora la buona stella
aveva sfolgorato alla grande e più che mai brillò quando il cugino Camillo Benso
di Cavour la convinse, senza far troppa fatica, a portarsi a letto l'Imperatore
Napoleone III. Per una buona causa, è ovvio: quella col contrassegno sabaudo,
che prevedeva la lotta all'Austria e l'indipendenza della Lombardia e del
Veneto. Anche l'Unità d'Italia? Bè, il Porco Re (così Virginia chiamava il
Savoia, visti i suoi irrefrenabili appetiti sessuali) e il conte di Cavour non
ci pensavano ancora: ma forse lei, sì, perché era una buona patriota e ci teneva
ad essere ammirata anche per la sua intelligenza politica. Del resto, ne darà
prova anche in seguito, nel 1870, quando, dopo la "breccia di Porta Pia",
attiverà amicizie e arti diplomatiche per evitare che il Papa Pio IX, sdegnato
dell'affronto sabaudo, abbandonasse Roma. Difficile, di fronte a una personalità
del genere, bilanciare luci ed ombre. Meglio, come ha fatto Benedetta Craveri,
disegnare il profilo di una donna che, a metà Ottocento, «prefigurò le celebrità
da rotocalco ..., interpretando tutti i ruoli del repertorio teatrale (...) e
dosando con sapienza le sue performance». Una Diva, in anticipo sui tempi, che,
tra l'altro, intuì la potenza espressiva della fotografia, affidando la propria
bellezza a un gran numero di ritratti. Mentre, come segnala la Craveri, svariati
documenti inediti conservati in archivi italiani e francesi, consentono di
ricostruire la sua personalità e la sua vita. Insieme alla ricca corrispondenza,
che, all'insegna della più spregiudicata schiettezza, ebbe con un vecchio amico
di famiglia, il principe Giuseppe Poniatovski, uomo politico del Secondo Impero.
E anche a lui - pur chiamandolo "il Vecio"non avrebbe negato i suoi favori. Ma,
come si è detto, li concesse a tanti, da sapiente ammaliatrice che irretiva con
la sua sensualità ma restava sempre padrona di sé.
I GENITORI Nata nella Firenze granducale, "la
città più gaia d'Italia", il 22 marzo 1837, Virginia era figlia di Filippo
Oldoini, spezzino, diplomatico sabaudo, e di Isabella Lamporecchi, di agiata e
onorata famiglia. Dunque, educazione e frequentazioni di ottimo livello. Ma
mentre al babbo Virginia vuole un gran bene (in seguito, quando stringerà legami
con politici e governanti, cercherà in ogni modo di favorire la sua carriera),
lo stesso non può dirsi per mamma. Isabella ha "voglia di tenerezza", ma la
figlia con lei non si confida punto, o molto poco. E sarà così anche in seguito
quando il matrimonio di Virginia, andata sposa a diciassette anni, naufragherà
miseramente. E sì che suo marito, il conte torinese Francesco Verasis di
Castiglione, diplomatico sabaudo, aveva e avrà sempre per lei una vera e propria
devozione, e si ingegnerà in ogni modo per salvare il decoro familiare. Niente
da fare. Virginia che, già nel 1855, tre mesi dopo avergli dato un figlio,
Giorgio, gli ha messo le corna, lo umilia con la sua indifferenza e quando la
coppia si trasferisce a Torino lei fa quel che le pare. Non ha nessuna voglia di
essere una sposa e una madre "esemplare". Del resto, il povero conte, non si
avvede delle corna o finge di non vederle. E i genitori non hanno voce in
capitolo di fronte a quella figlia che sfugge a ogni controllo. E che dunque
accetterà di buon grado il ruolo di seduttrice dell'Imperatore Napoleone III,
l'unico che può favorire le ambizioni "italiane" del "Porco Re" e di Camillo di
Cavour. Una volta in Francia, su "mandato" istituzionale, Virginia, un ballo a
corte dopo l'altro, sfolgora per la sua bellezza. Così, lo sciupafemmine
Napoleone, ammaliato, e ovviamente facendo il calcolo dei propri interessi
"europei", un passo dopo l'altro si consacra alla causa risorgimentale. Per la
scostumata Virginia ci saranno alti e bassi, tonfi e trionfi. In ogni caso, avrà
il suo bel posto nella Storia e nell'"immaginario" tricolore.
Storia. Le donne guerriere più famose
della Storia. Giuliana Rotondi l'1 aprile 2020 su
Focus (Facebook).
I reparti regolari femminili al fronte apparvero
solo nel ‘900. Ma nei secoli precedenti non sono mancati esempi di guerriere e
condottiere molto valorose. Ecco le più famose. I primi reparti militari
formati da sole donne, in Europa, sono nati nel Novecento. Uno dei primi fu
istituito in Russia durante la prima guerra mondiale (1917): erano i battaglioni
femminili della morte - nella foto - ed erano composti da donne che si offrivano
volontarie per combattere in prima linea. Però nei secoli precedenti non sono
mancati casi di condottiere scese sui campi di battaglia per difendere il loro
popolo. E se quello delle donne amazzoni è un mito, alimentato probabilmente da
alcune guerriere scite che combattevano a cavallo, sono tutt’altro che
leggendarie le storie di donne e regine che hanno davvero impugnato le armi in
nome di un’ideale o per difendere i confini del proprio territorio. Ecco alcune
delle guerriere più famose della Storia.
L’amica dei Persiani. Artemisia (VI-V secolo a.C.)
fu sovrana di Alicarnasso, un piccolo centro in Asia Minore. Durante la seconda
guerra persiana si schierò contro i Greci al fianco dell'Impero persiano.
Secondo Erodoto (484-430 a.C.), anche lui di Alicarnasso, la regina partecipò
alla battaglia di Salamina (480 a.C.) e, quando la situazione volse a sfavore
dei Persiani, capendo che non c’era più margine di vittoria, si mise in salvo
grazie a un originale stratagemma: ordinò ai marinai di sostituire le insegne
con altri contrassegni che riproducevano i colori e i simboli della flotta
greca. A battaglia conclusa, continuò a interessarsi alle sorti della guerra. Il
re dei re Serse la consultò più volte e la ricompensò anche con una armatura
greca.
La vendicatrice. Tomiri (VI secolo a.C.), regina
dei Massageti, è diventata famosa per aver sconfitto e ucciso l'imperatore
persiano Ciro il Grande (530 a.C.) quando questi invase il suo paese per
conquistarlo. Il suo spirito truce è diventato leggendario: per vendicare la
morte del figlio ucciso da Ciro in un combattimento, prima assassinò
l’imperatore persiano, poi gli immerse la testa in un otre di sangue. Infine lo
decapitò e lo oltraggiò. Secondo alcuni resoconti tenne la testa del sovrano con
sé tutta la vita, usandola come coppa per bere il vino.
La più feroce anti romana. Budicca (33-60 ca.d.C.)
era la regina della tribù degli Iceni (Inghilterra orientale). Negli anni in cui
i Romani erano impegnati nella conquista della Britannia (43-84 d.C.) guidò la
più grande rivolta delle tribù dell'isola contro di loro. Dione Cassio (II
secolo) la descrive come una donna con “gli occhi feroci e la voce aspra”. In
realtà sembra fosse molto alta e molto bella. Di origine nobile, a 7 anni andò a
vivere in un’altra famiglia dove apprese le tradizioni celtiche, sposando poi il
re della potente tribù degli Iceni. Alla morte del marito, i Romani occuparono
il loro regno, umiliandola pubblicamente. Nel 60 d.C. guidò una rivolta
antiromana che culminò nella battaglia di Watling Street. Costretta ad
arrendersi si tolse la vita.
La regina di Palmira. Zenobia (III secolo d.C.)
regina del regno di Palmira (sì, proprio la città distrutta dall'ISIS) fu una
sovrana fieramente anti romana. Il suo regno al momento della massima espansione
andava dalla Siria ai confini dell’Egitto. La regina puntava però ad espandersi
in tutta l’Asia minore. Nel 270 cercò un accordo con l'imperatore romano
Aureliano per consolidare i confini dei suoi territori. Ma di tutta risposta lui
fece una controffensiva sconfiggendola a Emesa (272). Dopo l’assedio di Palmira,
mentre cercava di fuggire in Persia, fu arrestata, ma Aureliano le salvò la
vita: fu condotta a Roma e fatta sfilare in città. Passò gli ultimi anni a
Tivoli.
La Pulzella d’Orléans. Giovanna d’Arco (1412-31)
visse durante la guerra dei Cent’anni (1337-1453) quando a confrontarsi erano
due nazioni nascenti, Francia e Inghilterra. Di umile origine, a 17 anni si
convinse di essere stata scelta da Dio per salvare la Francia, così percorse
oltre 2000 km e raggiunse la corte di Carlo VII per chiedere di poter cavalcare
- senza nessun comando - alla testa dell'esercito che andava a soccorrere
Orléans, assediata dall'esercito di Enrico VI. Avuto il consenso, la Pulzella e
il suo esercito riuscirono a liberare Orléans. Ma la sua carriera si interruppe
in fretta: catturata l’anno successivo in un'imboscata fu consegnata a Giovanni
di Lussemburgo, che la diede come bottino di guerra agli Inglesi. Nel 1431, a
soli 19 anni, fu accusata di eresia e bruciata viva. Oggi è santa e patrona di
Francia.
La regina di Forlì. Caterina Sforza (1463-1509),
figlia di Galeazzo Maria Sforza e madre di Giovanni dalle Bande Nere, governò su
Imola e Forlì. Soprannominata tygre per il suo coraggio e la sua determinazione,
si occupò personalmente della difesa dei suoi Stati: pianificò le manovre
militari, si curò dell'approvvigionamento dei soldati, delle armi e dei cavalli
e anche dell’addestramento delle milizie. Tanto zelo non bastò però a difendere
il suoi territori dalle conquiste del famigerato Cesare Borgia, detto il
Valentino. Imprigionata a Roma, dopo aver riacquistato la libertà, visse i suoi
ultimi anni a Firenze.
Donna samurai. Nakano Takeko (1847-68) fu
un'onna-bugeisha, ovvero una donna guerriera appartenente alla nobiltà
giapponese. Queste donne potevano partecipare alle battaglie, insieme
ai samurai ed erano addestrate all'uso delle armi per proteggere la loro casa,
la famiglia e l'onore in tempo di guerra. Nakano Takeko si mise a capo di un
corpo speciale di donne guerriere, una sorta di esercito femminile e combatté
servendosi del naginata (una spada giapponese con una lunga lama ricurva). Morì
sul campo durante la battaglia di Aizu (1868) nel pieno della guerra civile
giapponese.
Guerriera e scrittrice. Nadežda Andreevna Durova
(1783-1866), figlia di un comandante Ussaro, crebbe tra i cavalieri. Forse anche
per questo pensò che la sua strada non potesse essere la vita domestica, ma la
carriera militare. Così si fece arruolare con un nome maschile nel corpo degli
Ulani, soldati a cavallo armati di lancia, e durante le guerre napoleoniche
vinse molte medaglie tanto da essere promossa addirittura ufficiale.
Appassionata anche di letteratura pubblicò poi le sue memorie nella
rivista Sovremennik (1836) con una presentazione del poeta russo Puškin.
Guerriera e scrittrice. Chiudiamo questa gallery
con una "guerriera" dei giorni nostri: Asia Ramazan (1996-2016), una combattente
curda che ha cercato di fermare l’avanzata dell’Isis nei territori del Kurdistan
siriano. Nel 2014, a 18 anni, era entrata come volontaria nelle fila dell’Ypj la
milizia femminile curda interna alla milizia del Kurdistan siriano. Diventata
famosa sui media occidentali come simbolo di eroina resistente, è morta nel 2016
nella Siria del Nord.
Storia. Le 15 donne più potenti di
sempre. Elisabetta Intini il 22 giugno 2016 su Focus
(Facebook). 15 antesignane del potere politico che hanno fatto la storia,
regnando (nel bene e nel male) in un universo al maschile. Per la maggior parte
della storia scritta, e in un gran numero di culture, la politica è stata una
prerogativa maschile. Ma fortunatamente ci sono state alcune rare eccezioni:
donne che hanno conquistato e gestito il potere in modo illuminato e per lunghi
periodi, tessuto relazioni, ricucito strappi, sposato un ideale (anche in modi
non sempre pacifici), garantito prosperità economica e tenuto alla larga le
ingerenze. Vi raccontiamo alcuni celebri esempi di sovrane, imperatrici, donne
faraone e primi ministri che hanno inciso il loro nome a chiare lettere nella
Storia.
Hatshepsut (XV secolo a.C.)
Divenne la prima donna sovrano d'Egitto in
un'epoca in cui non esistevano neppure i vocaboli per riferirsi a un faraone
donna. Potente sacerdotessa, incoraggiò le arti e i commerci, dando slancio
all'economia; fece fiorire l'edilizia e garantì un'istruzione al futuro faraone,
che pure avrebbe dovuto aspettare 30 anni per divenire l'unico re d'Egitto. Per
mantenere il potere era solita vestirsi e farsi ritrarre con abiti maschili (e
con la barba). Voleva dimostrare di essere simile ai faraoni uomini anche
nell'aspetto, e rassicurare sul fatto che non avrebbe, con eventuali figli,
scalzato il legittimo faraone, ovvero il figliastro Thutmose III, ancora troppo
giovane per salire al trono.
Cleopatra (69-30 a.C.)
L'ultima regina del Regno tolemaico d'Egitto,
celebrata dal cinema per l'indiscusso fascino di fronte al quale caddero
personalità del calibro di Giulio Cesare e Marco Antonio, era anche un'abile
statista e una fine conoscitrice delle relazioni internazionali, e riuscì a
influenzare la politica dell'Impero romano in diverse circostanze. Grazie al
supporto di Cesare riconquistò il trono dopo la guerra civile con il fratello
Tolomeo, e ottenne una posizione di favore per il suo regno presso l'impero.
Divenendo amante di Marco Antonio, dopo l'assassinio di Cesare riuscì a
consolidare il dominio sull'Oriente, fino alla sua morte: nel 30 a.C. la regina
si fece mordere da un aspide (o ingoiò veleno) per non cadere nelle mani di
Ottaviano, che ridusse l'Egitto a provincia dell'Impero Romano.
Budicca (33-60/61 d.C.)
La giovane regina della tribù degli Iceni,
nell'Inghilterra orientale, è ricordata per aver guidato la più feroce rivolta
anti-Romana dell'isola.
Dopo aver protestato per l'esproprio delle terre
del defunto marito Prasutago da parte dei Romani, fu denudata e umiliata in
pubblico dai conquistatori, che stuprarono le sue figlie. Budicca, esperta di
arte militare, organizzò allora una vendetta, chiamando a raccolta tutti i
nobili Iceni scontenti, infliggendo al proconsole romano Paolino una prima, dura
sconfitta. Vinta una battaglia, perse però la guerra e pur di non cadere nelle
mani dei Romani Budicca si suicidò, avvelenandosi.
Ulpia Severina (in carica dal 274 al 275 d.C.)
Moglie dell'Imperatore Aureliano, potrebbe aver
regnato da sola per un anno tra la morte del marito e l'elezione del successore
Marco Claudio Tacito. Lo si evince dalla sua effigie raffigurata molto spesso
sulle monete in questo periodo di transizione. Se così fosse, si tratterebbe
dell'unica imperatrice romana che abbia governato in modo ufficiale.
Teodora di Bisanzio (497-548)
Moglie dell'imperatore d'Oriente Giustiniano I,
regnò al fianco del marito, con pari dignità e potere decisionale. Si dice che
in molte occasioni fosse ella stessa la "mente" di importanti decisioni
politiche: come quando, in occasione della rivolta di Nika, scoppiata nel 532 a
Costantinopoli per rovesciare l'imperatore, convinse il marito a non fuggire, ma
a rimanere e sedare la ribellione.
Promotrice di molte leggi a tutela delle donne,
morì forse per una forma di cancro, tra i primi casi storici documentati di
questa malattia. Nella foto, l'imperatrice raffigurata in un mosaico nella
Basilica di San Vitale, a Ravenna.
Imperatrice Suiko (554-628)
Prima imperatrice di cui si abbia attestazione
scritta in Giappone, salì al trono prima dei propri figli (che pure erano eredi
legittimi) per sanare un periodo di forti instabilità politiche. Consolidò il
buddismo, introdusse il calendario e la burocrazia cinesi in Giappone, e permise
l'ingresso nel paese di artigiani cinesi e coreani. Introdusse una costituzione
di 17 articoli che ribadiva i principi morali del buddismo e la supremazia della
figura imperiale.
Wu Zetian (624-705)
Anche chiamata Wu Zhao, o Wu-hou, è considerata
una delle donne più potenti della storia della Cina, l'unica ad aver fondato una
propria dinastia, la dinastia Zhou. Originariamente concubina di ultimo livello
per gli imperatori della dinastia Tang, riuscì a compiere una rapida ascesa
sociale, divenendo la favorita dell'imperatore Gao Zong, e scalzando le rivali
(tra cui la moglie legittima del sovrano). Fece abbassare le tasse e promosse lo
sviluppo agricolo, consolidando il buddismo come religione di stato. Eleonora di
Aquitania (1122-1204)
Fu tra le più ricche e potenti donne dell'Alto
Medioevo, e moglie non di uno, ma di due re. Figlia primogenita del duca di
Aquitania, tra i più importanti domini di Francia, sposò dapprima il sovrano di
Francia Luigi VII, con il quale partecipò alla seconda crociata. Ma i due non
andavano d'accordo e "divorziarono"(ottenendo l'annullamento delle nozze) nel
1152. Eleonora sposò allora Enrico II, futuro re di Inghilterra, da cui ebbe 8
figli (due dei quali, Riccardo e Giovanni, sarebbero divenuti sovrani). Fu più
volte coreggente del potere e fu una figura chiave nel trasformare l'Aquitania
in una delle terre più culturalmente interessanti dell'Europa dell'epoca. Qui la
vediamo rappresentata nel ruolo di paciere con i figli Giovanni e Riccardo.
Isabella di Castiglia e Aragona (1451-1504)
Moglie di Ferdinando di Aragona, fu con il marito
sovrana congiunta dell'intera Spagna. Per contratto matrimoniale poteva
governare la Castiglia in modo indipendente, e lo fece con decisione.
Fervente cattolica, introdusse in Castiglia
l'Inquisizione, e fece espellere dalla Spagna oltre 170 mila ebrei. Aiutò il
consorte nella conquista di Granada, territorio dei Mori, e fu la prima
sostenitrice, con il marito, dei piani di esplorazione di Cristoforo Colombo,
con il quale la vediamo raffigurata (il navigatore è sulla sinistra, sulla
destra il marito Ferdinando).
Elisabetta I di Inghilterra (1533-1603)
Figlia di Enrico VIII e Anna Bolena, governò in un
contesto ricco di congiure familiari e rivalità internazionali (prima tra tutte,
quella con la Spagna). Per il rifiuto di sposarsi per convenienza politica, si
guadagnò il soprannome di "Regina Vergine". Fu fervida sostenitrice della Chiesa
di Inghilterra e si oppose per questo motivo a Maria Stuarda, sua cugina e
regina di Scozia, simbolo del Cattolicesimo inglese (Elisabetta la fece
giustiziare). Tra i suoi maggiori successi politici, ci fu la sconfitta
dell'Armada Spagnola in acque inglesi, nel 1588. Il suo regno vide anche una
fioritura culturale senza precedenti: William Shakespeare e Francis Bacon sono
solo alcuni degli intellettuali che vissero nella sua epoca.
Caterina II di Russia (1729-1796)
È considerata uno dei massimi esempi di dispotismo
illuminato: estremamente colta, non esitò a esercitare il potere in modo
assolutista e dispotico. Sposò il granduca ed erede al trono Pietro Fëdorovič
con il quale entrò presto in disaccordo, fino a ordinare una cospirazione per
imprigionarlo (il sovrano morì in carcere). Salita al potere, governò secondo
ideali illuministici, supportando riforme giuridiche, nell'istruzione e
nell'amministrazione. In politica estera è famosa per aver annesso al suo impero
buona parte della Polonia, sopprimendo senza pietà i nazionalismi di quella
terra.
Cixi, imperatrice della Cina (1835-1908)
Come per altre imperatrici orientali, la sua
ascesa al potere iniziò dal grado di concubina. Ma la sorte giocò a suo favore e
fu l'unica a dare un figlio maschio all'imperatore Xianfeng: quando questo morì,
assunse la reggenza del potere prima per il figlio, poi per il nipote,
rifiutandosi di farsi da parte quando i legittimi eredi al trono ebbero
raggiunto la maggiore età. Prima del record della Regina Elisabetta, fu suo il
regno più lungo della storia d'Inghilterra. E il suo potere fu esercitato
nell'epoca coloniale, il che fece della regina il simbolo della potenza
espansionistica britannica nel mondo. Madre di nove figli, guidò il paese in un
periodo di intensi cambiamenti sociali ed economici, sotto lo sguardo attento
del marito, il Principe Alberto, del quale era sinceramente e profondamente
innamorata.
Golda Meir (1898-1978)
Fu primo ministro di Israele in un periodo
particolarmente complesso della storia del Paese, dopo il massacro di 11 atleti
e allenatori israeliani ai Giochi olimpici di Monaco del 1972, e durante il
conflitto arabo israeliano del 1973. Fu anche tra gli esponenti di spicco del
movimento sionista, per la creazione di uno stato israeliano in Palestina. In
molti la paragonano, per il piglio e la longevità al potere, alla "Lady di
Ferro" Margaret Thatcher (vedi foto seguente). Qui la vediamo in una conferenza
stampa con alcuni senatori americani, a Washington, nel 1970.
Margaret Thatcher (1925-2013)
Unica donna primo ministro del Regno Unito, eletta
per 3 mandati consecutivi. Per la sua gestione inflessibile degli scioperi
interni e di alcune crisi internazionali (tra le quali l'assedio all'ambasciata
iraniana a Londra da parte di 6 terroristi arabi nel 1980) si è guadagnata il
soprannome di "Iron Lady" (la Lady di ferro). Il suo operato non è esente da
critiche storiografiche, come quella di razzismo e di non aver favorito l'ascesa
al potere di altre donne. Nella foto, la Thatcher in un discorso a un congresso
di giovani conservatori, nel 1975.
Francesco Semprini per "la Stampa" il 3 dicembre
2021. È considerata una delle donne più potenti al mondo, non solo per i ruoli
svolti in alcune tra le più grandi multinazionali del Pianeta, ma per il suo
impegno a favore dei diritti Lgbtq. Susan E. Arnold è la prima presidente donna
(chairwoman) di Disney, appena nominata dal Cda, prenderà il posto del veterano
Bob Iger numero uno del colosso dell'animazione dal 2000, e dal 2005 al 2020
anche amministratore delegato del gruppo. Il guru artefice dell'acquisto dei
marchi Pixar, Marvel, Lucasfilm e 21st Century Fox nel 2019, e con velleità
politiche mai concretizzatesi. «Nel mio nuovo incarico continuerò a servire gli
interessi a lungo termine degli azionisti di Disney e a lavorare a stretto
contatto con l'a.d. Bob Chapek (nominato nel 2020) per onorare l'eredità
secolare dell'azienda in termini di eccellenza creativa e innovazione», afferma
Arnold in una nota. La successione sarà effettiva alla fine dell'anno assieme a
una serie di sostituzioni ai vertici del gruppo tese a cementare la nuova
leadership di Disney. Arnold porta in dote 14 anni nel ruolo di consigliera del
Cda ed è considerata a tutti gli effetti parte della famiglia che ha dato i
natali a Topolino e Minni. A sottolinearne il valore è lo stesso Iger: «Susan è
una dirigente stimata, la cui ricchezza di esperienza, integrità incrollabile e
giudizio esperto sono stati pregi importanti per l'azienda da quando è entrata a
far parte del Cda nel 2007». Del resto, Arnold ha una vasta esperienza nei
Consigli di amministrazione così come nelle strategie relative ai beni di largo
consumo. Prima di sbarcare in California è stata dirigente nella società di
investimento Carlyle e, precedentemente, di Procter & Gamble, ed è stata
consigliera nel Cda di McDonald's per otto anni. Guiderà un colosso che ha
dovuto superare un periodo di turbolenze senza precedenti, con la chiusura dei
parchi e delle sale cinematografiche a causa della pandemia di Covid. La società
da allora ha accelerato i suoi piani per concentrarsi sui servizi di streaming
come Disney+, che ha visto una rapida crescita ma anche un più recente
rallentamento. Nessun dubbio quindi sulla bontà della scelta che peraltro ha la
portata storica di consacrare alla guida del gigante dell'animazione la prima
donna presidente nei 98 anni di vita della società. Una donna considerata più
volte dalle riviste Fortune e Forbes tra le più potenti al mondo anche
l'attivismo dal punto di vista sociale di cui può fare vanto. Apertamente
omosessuale, si adopera a sostegno dei diritti Lgbtq nel mondo del business. Lei
stessa ha ricordato come in P&G, nonostante le dichiarazioni di facciata, la
leadership fosse fortemente conservatrice e i colleghi omofobi. «Vogliamo dirla
tutta? C'erano uomini che erano molto potenti alla Procter che si rifiutavano di
riconoscere gli stessi diritti alla comunità Lgbqt. Non ce lo meritavamo -
racconta Arnold -. Non c'era nessun programma o iniziativa in azienda volta a
contrastare questo orientamento». La sua testimonianza ha contribuito la stessa
P&G ad avviare una campagna per l'uguaglianza dei diritti Lgbtq anche attraverso
un cortometraggio «Out of the Shadows» (fuori dall'ombra), che racconta il
tormento a cui erano sottoposti i dipendenti con orientamenti sessuali non etero
nei primi anni 'Novanta, gli stessi che hanno unito le forze combattendo per
l'uguaglianza dei diritti sul posto di lavoro.
Doppio record. Prima ad essere eletta; prima a
dimettersi.
Svezia, per la prima volta una premier
donna: ma si dimette dopo poche ore. Andrea Tarquini
su La Repubblica il 24 novembre 2021. Con la nomina di Magdalena Andersson le
donne governavano in metà dei Paesi europei, ma dopo il "no" del Parlamento alla
sua finanziaria il suo esecutivo è entrato subito in crisi. Come
previsto, Magdalena Andersson è la prima donna-premier svedese. Ma si è già
dimessa. Col no del Parlamento alla sua finanziaria, la sua missione è durata
poche ore. Eletta giorni fa dal partito di governo (la storica socialdemocrazia,
Sap) nuova leader al posto del dimissionario da leader politico e da
premier Stefan Löfvén, oggi Andersson, ministro delle Finanze uscente, era
appena stata di fatto automaticamente confermata, sebbene a fatica, capo
dell'esecutivo dal Riksdag, il parlamento unicamerale della prima potenza
nordica. Hanno votato a favore 117 deputati, 57 si sono astenuti e 174 hanno
votato contro. Cioè appena uno in meno della maggioranza di 175 sui 349
legislatori del Riksdag, il cui eventuale voto contrario boccia qualsiasi
premier. Senza maggioranza contraria infatti in Svezia un governo entra in
carica. Ma non è tutto: il Parlamento ha appunto respinto il suo progetto di
legge finanziaria, aprendo la porta all´ipotesi di sue dimissioni, che ella
stessa aveva minacciato in caso di no alla sua legge di bilancio moderata,
aperta al centro e pro-economia. Magdalena Andersson non ha resistito
all´elezione sofferta, alla tempesta del no alla finanziaria, alla crescente
insofferenza contro di lei mostrata da centristi, conservatori e dai
sovranisti Sverige Demokraterna del giovane Jimmie Andersson, in volo in ogni
sondaggio in vista delle elezioni parlamentari regolari dell'autunno prossimo.
Secondo fonti di Stoccolma Andersson avrebbe potuto accettare, sottoponendolo al
voto di fiducia, di sottoscrivere il progetto di finanziaria alternativa
proposto da liberali centro e conservatori. La sorte della governabilità svedese
era dunque appesa all'incertezza, poche ore dopo le elezioni della prima premier
donna nel paese ai vertici europei quanto a gender equality. Andersson si diceva
decisa a governare con decisione, come sempre da quando lei, sorridente e
gentile laureata all'accademia di Uppsala (la Oxford svedese) e campionessa di
nuoto, si è guadagnata il soprannome di "bulldozer". È figlia unica del docente
di Uppsala Goran Andersson e dell'insegnante Brigitta Andersson. Si è guadagnata
un dottorato in scienze sociali a Uppsala, poi ha debuttato in politica nella
gioventù socialdemocratica: 54 anni, bionda coi capelli all'altezza delle
spalle, si impone anche quando contestata dice "la Svezia può fare di meglio e
di piú in ogni campo, anche nell'ambiente", sfidando i colossi industriali e
forestali. Il soprannome di Bulldozer le viene dalla pratica di imporre la sua
linea con mano di ferro in guanto di velluto, da anni e soprattutto da quando è
stata titolare delle Finanze, allineando la Svezia (che non fa parte
dell´eurozona) alla posizione dura dei Frugali (Austria Olanda Finlandia) in
politica monetaria, sfidando così la stessa tradizionale politica
di quantitative easing e tassi negativi della Riksbank, la banca centrale, che
finora ha salvato i primati di crescita ed export di tecnologie avanzate svedese
nel mezzo della tragedia del covid. Poi ha studiato con successo a Harvard e nel
partito e nel governo ha fatto carriera come massimo consulente economico di
qualsiasi governo socialdemocratico. "Sa intimorire persino i migliori
economisti e accademici e questo da noi è singolare", dicono i direttori di
molti grandi media svedesi. La sua partenza è stata tutta in salita, col no del
centrodestra "pulito" alla sua finanziaria e la sfida della crescente ascesa del
partito populista. Che molti partiti moderati e conservatori sono pronti a
"sdoganare" prima o dopo le prossime elezioni, segnando una cesura storica e la
fine del modello nordico. La sua nomina aveva rafforzato ulteriormente il peso
delle donne al potere in Europa portando il numero di donne numero uno in
politica al 50 per cento nel vecchio continente. Molte premier e presidenti,
dalla islandese Katrín Jakobsdóttir alla finlandese Sanna Marin, dalla
danese Mette Frederiksen alle presidenti kosovara e greca, alle premier
estone Kallas e moldava Maia Sandu, fino a madame Lagarde alla Bce e Ursula von
der Leyen presidente della Commissione europea, mostrano che il "tetto di
cristallo" denuncia crepe crescenti sopra i cieli dell´Unione europea.
La rivoluzione è donna. Zapatiste in
lotta per i diritti delle escluse. Dal Chiapas un
modello di sviluppo alternativo alle regole discriminatorie del liberismo
economico. “Siamo noi le prime vittime di un sistema che causa distruzione e
morte”. Chiara Sgreccia su L'Espresso il 4 novembre 2021. All’alba dell’8 marzo
si vedevano solo gli occhi delle Mujeres que Luchan. Migliaia di donne che
lottano con il volto coperto da un cappello di lana o da un lembo di stoffa,
perché ciò che importa non è chi, ma la rivoluzione. L’intenzione di cambiare un
sistema, il capitalismo, che dello scontro tra sfruttati e sfruttatori fa il
motore del progresso. Tra le montagne del Chiapas, a El Caracol de Morelia, nel
2018, c’è stato il Primo incontro internazionale delle donne, organizzato dalle
zapatiste. Erano più di 8 mila e provenivano da ogni parte del mondo.
Scienziate, maestre, studentesse, artiste, dirigenti, contadine, indigene,
compañeras, unite nella ribellione contro un ideale di sviluppo che vuole le
donne vittime, come se il genere potesse essere un crimine per cui dare
condanna. «Ho vissuto il disprezzo, l’umiliazione, le derisioni, le violenze, i
colpi, le morti perché sono donna, indigena, povera e zapatista», ha detto dal
palco l’insurgente Erika, una voce che le rappresenta tutte nella loro
diversità, di età, storie e lingue. Donne che quel giorno hanno esteso
l’accordo, già presente nel pensiero zapatista, per condurre insieme la
battaglia contro chi persegue solo il profitto anche a scapito del pianeta,
ognuna secondo i suoi modi, mezzi e possibilità. Un accordo di cui María de
Jesús Patricio Martínez, conosciuta come Marichuy, si era già fatta portavoce
nazionale, prima donna indigena candidata alle presidenziali in Messico del
2018. La “vocera” del Consiglio indigeno di governo che con le sue parole ha
mostrato che non è tardi per ripensare l’organizzazione sociale. «Se la
distruzione e la morte sono il progresso, allora noi siamo contro», dice la voce
fuori campo di Marichuy nei primi minuti del documentario visibile su Netflix,
diretto da Luciana Kaplan. La proposta zapatista non è la riproposizione di una
società comunista in chiave contemporanea e neppure la rivendicazione di
indipendenza degli emarginati, è una modalità diversa attraverso cui intendere
la collettività e gli individui, modellata sull’affermazione d’identità dei
popoli indigeni che non chiedono distacco ma inclusione, e che rappresentano gli
ultimi del Chiapas, come del resto del mondo. Le donne sono vittime, ancora più
degli uomini, dell’oppressione capitalista che, per la sua impostazione
patriarcale «come un giudice decreta che siamo colpevoli di essere donne e
pertanto la nostra punizione deve essere violenza, morte o sparizione». Anche
per contrastare le discriminazioni quotidiane e per dimostrare che esiste un
altro modo di essere donna, le zapatiste hanno lasciato le loro case e preso il
coraggio, e quando necessario le armi, per assumere ruoli di primo piano
nell’esercito e nella lotta. Come spiega Raffaele Crocco, direttore di “Atlante
delle guerre”, che era a San Cristóbal de Las Casas il primo gennaio 1994,
quando l’Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln) occupò la città, «la
loro visione era già ampia, libertaria, attenta ai diritti civili, all’ambiente,
aperta a forme di economia differente. Il pensiero zapatista ha avuto il merito
di rivelare che esiste un’alternativa all’egemonia del libero mercato. E lo ha
fatto negli anni in cui il neoliberismo sembrava l’unico modello vincente,
l’Unione Sovietica era crollata, gli Stati Uniti apparivano come i padroni».
L’Ezln ha invitato alla riflessione, ha riacceso la miccia del fronte
d’opposizione al pensiero dominante e ha stimolato la rinascita dei movimenti
antagonisti in Europa e Nord America, come i no global e i pacifisti. Crocco
incontrò il subcomandante Marcos proprio la notte del primo gennaio. Aveva il
passamontagna e la pipa tra i denti, era il portavoce dell’Ezln. Poco dopo,
dalla piazza principale della città, avrebbe dichiarato guerra al governo del
Messico. Una data non casuale che coincideva con l’entrata in vigore del Nafta,
il trattato di libero scambio commerciale tra Usa, Canada e Messico, che avrebbe
costretto gli indigeni a vendere le terre, concretizzazione del neoliberismo a
cui gli zapatisti si oppongono. Lo scontro tra l’Ezln e governo messicano
sarebbe potuto finire anni fa, con gli accordi di San Andrès, un’intesa di pace
per cui l’autonomia e il rispetto dei diritti politici, giurisdizionali e
culturali degli indigeni sarebbero dovuti entrare nella Costituzione. Ma non è
accaduto. Zedillo, l’allora presidente messicano, e tutti i successivi leader
infransero gli accordi firmati. Così il conflitto è diventato una guerra a bassa
intensità tra il governo, i gruppi paramilitari supportati dal governo che
alimenta le divisioni e le disparità tra le fasce più basse della popolazione, e
gli zapatisti, sottile e silente con picchi acuti di violenza come la strage di
Acteal del 1997. Morirono 45 persone per l’incursione di una milizia
paramilitare e tante furono quelle che per paura abbandonarono il comune di
Chenalhó (dove si trova il villaggio di Acteal), risultato della strategia
governativa che isola e terrorizza le comunità che, però, non si sono arrese.
«Ci leviamo in armi per essere ascoltate, perché la nostra vita era il silenzio,
l’oblio». Così dissero le donne del Chiapas quella notte del primo gennaio 1994,
quando l’Ezln irruppe sulla scena internazionale. Quando la Mayor insurgente Ana
Maria guidava la presa di San Cristóbal de Las Casas. Scese tra la nebbia dalle
montagne a capo di una milizia di circa mille persone, circondò il municipio,
strappò la bandiera che sventolava sopra il palazzo e la consegnò alla
comandante Ramona, volto (coperto) dell’Ezln insieme a quello di Marcos, oggi
subcomandante Galeano. Ramona, sebbene malata e minuta, è stata protagonista
delle più importanti battaglie dell’esercito zapatista. Grazie al suo lavoro e a
quello di tante altre che si sono fatte portavoce della volontà di cambiamento
delle popolazioni indigene, è stata redatta la legge rivoluzionaria delle donne.
Dieci punti che sottolineano la libertà, l’indipendenza e la centralità della
donna per il pensiero e nella lotta dell’Ezln, fin dal 1993. «La legge è stata
un investimento sul futuro che oggi è realtà in tutte le comunità», spiega
Andrea Cegna autore di “20 zln” e “Por la vida y la libertad”. «All’interno
delle giunte di buon governo, l’autorità politica e sociale che governa le zone
d’influenza zapatista, c’è parità tra i sessi e le donne svolgono ruoli di primo
piano e responsabilità». Dal 2003 gli zapatisti hanno istituzionalizzato la loro
presenza sul campo, lasciato le armi se non come difesa, e inaugurato un nuovo
modo di costruire la società: hanno dato vita ai caracoles, nuove forme di
autogoverno, reti di solidarietà tra municipi che propongono un modello
alternativo di partecipazione alla vita politica. A cui il governo del Chiapas
ha risposto «non solo sostenendo le bande di narcotrafficanti, ma incoraggiando
e finanziando gruppi paramilitari come quelli che attaccano continuamente le
comunità», si legge nel comunicato dell’Ezln dello scorso settembre. Ma senza
ottenere i risultati sperati. «Fino al 2019 i caracoles erano 5, ora sono 12 per
rispondere all’esigenza di includere nuovi territori nello spazio di resistenza
zapatista. I caracoles sono le sedi della giunta di buon governo che accoglie i
rappresentati dei municipi che a loro volta raccolgono i diversi villaggi. Un
po’ come da noi che ci organizziamo in province e regioni ma dove chi ha ruoli
rappresentativi esegue ciò che viene deciso dalle assemblee comunitarie»,
chiarisce Cegna. Zone con scuole, ospedali, amministrazioni autonome rispetto al
governo messicano, che hanno consentito alle donne l’accesso all’istruzione,
alla sanità, all’indipendenza economica. Perché, proprio come disse la
comandante Esther, a Città del Messico, l’undici marzo del 2001, davanti a
migliaia di persone arrivate a piedi dopo 16 giorni e più di tremila chilometri,
dalle montagne del Chiapas fino alla capitale, per rivendicare i propri diritti,
il malgoverno messicano non fa caso al dolore delle donne, «ci hanno trattato
come oggetti e non ci hanno considerato esseri umani […] ma ora noi, le donne
zapatiste, siamo organizzate, nella nostra organizzazione occupiamo incarichi
con un alto grado di responsabilità e autorità. Per cui non veniamo in ginocchio
né ad implorare né ad essere biasimate, non vogliamo negozietti, auto né
televisione, vogliamo che venga riconosciuto il nostro diritto come indigene e
come donne». Le zapatiste si sono ribellate all’ordine esistente e così hanno
costruito nuove relazioni nella comunità e con il potere dominante. Parlano al
mondo con il volto coperto per aprire un altro orizzonte di visibilità: affinché
sia la loro parola collettiva a rivendicare un mondo in cui i diritti e
l’identità vengano riconosciuti a ogni persona, senza creare conflitto, e in cui
la terra è il mezzo per l’affermazione e il sostentamento. L’esempio delle
zapatiste ha fatto sì che le indigene (e non solo) di tutto il mondo prendessero
coscienza delle loro condizioni e cominciassero a uscire dalle case e dalle vite
a cui erano abituate. Una delegazione zapatista composta principalmente da donne
«non solo perché intendono ricambiare l’abbraccio ricevuto nei precedenti
incontri internazionali, ma anche e soprattutto perché noi uomini zapatisti
sappiamo bene che siamo quello che siamo, e non siamo, grazie a loro, per loro e
con loro» da qualche mese sta facendo il giro d’Europa. Sarà in Italia fino
all’8 novembre.
Marinella Meroni per “Libero
quotidiano” l'1 novembre 2021. I polpi sono così intelligenti da essere
considerati dagli studiosi gli animali più ingegnosi del mare: sanno usare la
memoria come l'uomo, hanno il senso dell'umorismo, riescono a svitare coperchi
di barattoli (anche quelli con chiusure di sicurezza), sono curiosi e simpatici
tanto da giocare con i sub e perfino farsi accarezzare. Ora i ricercatori hanno
fatto una nuova rivoluzionaria scoperta: le femmine dei polpi "sparano" oggetti
contro i maschi quando si sentono molestate. In pratica, si difendono dalle
molestie insistenti dei corteggiatori lanciando intenzionalmente contro di loro
degli oggetti, come conchiglie e fango. E la loro tattica è vincente, poiché i
maschi poi si allontano frustrati. Una strategia difensiva nei confronti dei
"molestatori" piuttosto rara nel regno animale, individuata finora solo in
pochissime specie animali, come scimpanzè ed elefanti. A confermarlo i
ricercatori australiani dell'Università di Sidney con lo studio "In the line of
fire: debris throwing by wild octopuses" (Sulla linea di fuoco: detriti lanciati
da polpi selvatici), pubblicato su New Scientist. Sono arrivati a queste
conclusioni dopo aver visionato centinaia di video registrazioni che hanno
fornito informazioni dettagliate. In pratica, si è visto che le femmine di polpo
quando sono importunate con eccessivi e non graditi corteggiamenti, raccolgono
con i loro otto tentacoli dal fondale marino fango, conchiglie o altri sedimenti
per poi prendere bene la mira inclinando il corpo e lanciare gli oggetti con un
agile movimento contro i maschi. Un comportamento che gli scienziati chiamano
"lancio" e con il quale questi intelligenti cefalopodi di solito posizionano un
oggetto nei loro tentacoli e lo "sparano" con un getto d'acqua.
POTENZA E PRECISIONE In
proposito, dichiara Godfrey-Smith dell'Università di Sidney: «Sono le femmine a
lanciare oggetti spesso ai maschi che tentano l'accoppiamento. Abbiamo osservato
che quando una polpa lancia per colpire tende a farlo con più potenza e
precisione prendendo la mira, e il maschio in nessun caso ha mai risposto al
fuoco. Ad esempio, in un video si vede una femmina lanciare fango dieci volte al
maschio che tentava di accoppiarsi con lei, colpendolo per ben cinque volte, e
il maschio ha cercato di schivare il fango, tentando anche di anticipare le
mosse della femmina, il che conduce a pensare che si trattasse di una qualche
forma di combattimento. Al maschio rifiutato, poi, non è rimasto che lanciare
una conchiglia nel vuoto, in quello che è sembrato un altrettanto evoluto
segnale di frustrazione. In un altro video, invece, una femmina ha lanciato una
conchiglia in "stile frisbee" con i tentacoli. Oggi è chiaro che il lancio di
oggetti da parte dei polpi non soltanto è intenzionale, ma è anche chiaramente
offensivo». I ricercatori hanno anche osservato e svelato il comportamento
particolarmente curioso e la reazione dei maschi che cercavano di evitare di
essere colpiti, schivando i vari lanci: alcuni si abbassavano poco prima che
partisse il tiro, altri subito dopo il lancio, e in altri ancora li hanno visti
alzare i tentacoli in direzione del lanciatore senza abbassarsi, proprio come fa
un portiere di calcio quando si prepara a pare un tiro. Ma non è tutto: in
alcuni casi questi comportamenti delle femmine si sono riscontrate anche quando
devono difendere la loro tana o territorio da altri polpi intrusi. Una femmina
"tosta", dunque, che sa tutelarsi da avances non gradite e proteggere il suo
territorio, quasi avvertendo gli incauti: "Stai alla larga e non avvicinarti
senza il mio permesso perché potresti prenderle di santa ragione".
Roberto D’Agostino
per Vanityfair.it il 23 ottobre 2021. La politica non vuole amplessi
clandestini. Il sesso sciolto è un handicap. Vale sempre il vecchio motto:
meglio comandare che fottere. L'orgasmo è sostituito dal potere. In Italia il
primato della virtù (o dell’ipocrisia) fu una delle ragioni dei 4O anni di
potere della classe politica democristiana, che, a parte autorevoli eccezioni, è
stata prevalentemente casta. I pettegolezzi erano competenza dei servizi segreti
che poi li trasformavano in ricatti (vedi la carriera stroncata di Fiorentino
Sullo, gigante della DC irpina e nazionale, ma omosessuale). Con Craxi, la
svolta del socialismo notte, la trombata decisionista, l'harem del garofano alla
De Michelis: si passò da "L'orgia del potere" al "Potere con l'orgia". Eppure
mai fu scritto un rigo. Per anni, solo peccati di omissione a mezzo stampa.
Anche se Moana Pozzi dà i voti alle perfomance di Craxi, silenzio. Poi, quando
Bettino era più morto che vivo, ecco apparire Anja Pieroni sulle copertine dei
settimanali mezza nuda. E giù piccanti allusioni alla relazione con il
Cinghialone. Infine, Sandra Milo introduce in Italia il genere letterario delle
confessioni d'alcova a sfondo politico, la politica delle mutande, sia pure alla
memoria. I tempi cambiano: dal sesso proporzionale (il politico gode e tace) al
sesso maggioritario (il politico gode e racconta). Alla faccia del
bacchettonismo democristiano, alle spalle della "glande-stinità" socialista,
irrompe la volontà di esternare - politicamente - una scelta di campo erotica.
Così, nel 1991 lo spirito infedele di Bossi pensò bene di proporre come slogan
politico lo stato di erezione. "La Lega ce l'ha duro", durissimo, chilometrico;
armato di "manico" è lui, Bossi, Membro Kid. Da una parte. Dall’altra, la
signorina Rosy Bindi ammetteva la sua verginità, fatto privatissimo che diventa
un pubblico messaggio di virtù. Lo spirito del tempo cambia, di nuovo. Oggi,
quello che è certo è che le marachelle sessuali sono sempre di più diventate il
lato debole dell'uomo di potere, l’arma politica preferita per far fuori il
nemico. Bill Clinton, appena accennò alla riforma della sanità americana (che
penalizzava le potentissime società assicurative), tirarono fuori dal cassetto i
suoi rapporti “orali” con Monica Lewinski, e la riforma morì. Le “cene eleganti”
con Bunga Bunga di olgettine hanno bruciato il berlusconismo senza limitismo.
Oggi è tutto un parlare della doppia morale di Luca Morisi, la ‘’Bestia’’ social
che ha decretato il successo della Lega di Salvini. Con la sua frangetta da
chierichetto, s’avanza uno di quei leghisti che, secondo il libro del senatore
Zan, sono “machi” omofobi a Roma ma baciano uomini a Mykonos. Fa scalpore le due
facce della “Bestia”: quella pubblica (insulti e calunnie sessisti sui social,
gogne e demonizzazioni in Rete per immigrati e spacciatori, campagne di
ineguagliabile violenza: "Se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno") e
quella privata (festini nel cascinale veneto con immigrati rumeni da scopare con
cocaina e Ghb, la “droga dello stupro”). Da notare infine la differenza: quando
a delinquere è un poveraccio è solo un “tossico”, quando sbuca Luca Morisi,
insaziabile killer da tastiera, gli orchi si fanno pecore: si scrive di
“fragilità esistenziali” e lo spaccio diventa ‘’cessione’’. Amorale della doppia
morale: a volte basta un'erezione (sbagliata) per distruggere un partito.
Da "ansa.it" l'11 ottobre
2021. In attesa di finire sulle banconote, alcuni volti di importanti figure
storiche femminili dal 2022 appariranno sui quarti di dollaro. La Zecca
americana ha infatti presentato il primo lotto di monete da 25 centesimi che
onorano icone come la poetessa Maya Angelou, l'astronauta Sally Ride, l'attrice
Anna May Wong, la suffragista e politica Nina Otero-Warren, Wilma Mankiller, la
prima donna al comando della nazione Cherokee. "La grafica particolarmente
ispirante delle monete - ha detto Alison L. Doone, direttrice facente funzione
della United States Mint - racconta la storia di cinque donne straordinarie il
cui contributo è impresso nella cultura americana. Le generazioni future
guarderanno i volti sulle monete tenendo presente gli obiettivi che possono
essere raggiunti con una visione, la determinazione e il desiderio di migliorare
le opportunità per tutti". Su uno dei lati delle monete resta il volto di George
Washington.
Lidia Poët, la storia della
prima avvocata italiana arriva su Netflix.
La fiction su Lidia Poët si
propone di rileggere in chiave "light procedural", la lunga battaglia della
prima avvocata italiana, interpretata da Matilda De Angelis. Francesca Spasiano
Il Dubbio l'11 ottobre 2021. «L’avvocheria è un ufficio esercibile soltanto da
maschi e nel quale non devono punto immischiarsi le femmine». Novembre 1883, i
giudici della Corte d’Appello di Torino sono chiari: Lidia Poët, prima avvocata
del Regno d’Italia iscritta all’Albo in quello stesso anno, deve lasciare
l’Ordine. Perché, spiega la Corte, «sarebbe disdicevole e brutto veder le donne
discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici
giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali
anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso più
gentile si conviene di osservare: costrette talvolta a trattare ex professo
argomenti dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi
uomini di fare motto alla presenza di donne oneste». Un “rischio” paventato da
uomini, con parole scritte da uomini, quali erano i componenti della Corte. Poco
male. La tenace Lidia Poët non si lascia scalfire. Privata del “titolo”,
continua a svolgere la professione nello studio legale del fratello per i 37
anni successivi alla sua cancellazione dall’Albo degli avvocati di Torino. Per
esservi infine riammessa nel 1920 dopo una lunga battaglia. Quella di Poët è una
storia di straordinaria determinazione, un esempio di dedizione per chiunque
indossi la toga. Che ora balza anche all’occhio del grande pubblico con una
serie tv firmata Netflix. Scritta da Guido Iuculano e Davide Orsini, diretta da
Matteo Rovere e Letizia Lamartire (produzione Groenlandia), la fiction si
propone di rileggere in chiave “light procedural” la vicenda reale di Poët, nei
cui panni vedremo l’attrice Matilda De Angelis. Le riprese sono iniziate a
Torino il 20 settembre e per ora le indiscrezioni sono poche: si parte dalla
sentenza della Corte d’Appello per raccontare gli anni in cui Poët, decisa a
ribaltare quel pronunciamento, si dedica alla professione sfidando pregiudizi ed
ostacoli di ogni sorta. Al suo fianco leggiamo nella sinossi – c’è Jacopo, «un
misterioso giornalista e cognato di Lidia, che le passa informazioni e la guida
nei mondi nascosti di una Torino magniloquente». Spulciando tra archivi e
quotidiani dell’epoca, scopriamo che in quegli anni Poët si dedica in
particolare alla tutela dei diritti dei minori, degli emarginati e delle donne.
Il divieto di patrocinare non le impedisce di rimanere a lavorare nello studio
legale del fratello Enrico, che le aveva trasmesso l’amore per la professione.
Dopo la sua rimozione dall’Albo, Poët partecipa al primo Congresso Penitenziario
Internazionale a Roma e nel 1890 venne invitata come delegata a San Pietroburgo,
alla quarta edizione del Congresso. Il suo impegno non si arresta neanche allo
scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando lascia lo studio e diventa
volontaria della Croce Rossa. Di questa attività senza sosta ci parla anche
l’avvocata Simona Grabbi, presidente dell’Ordine di Torino che a Poët ha
intitolato l’area giochi nei giardini del Palazzo di Giustizia con un cippo
commemorativo scoperto lo scorso luglio. Il cippo, spiega Grabbi, è un «simbolo
per le battaglie di genere» posto a «beneficio dei tanti cittadini che non
conoscono questa storia». Una storia che inizia nel 1881, quando Poët si laurea
in giurisprudenza all’Università di Torino con una tesi sulla condizione
femminile in Italia e sul diritto di voto per le donne – «una tesi profetica»,
fa notare Grabbi. Per due anni svolge la pratica forense per abilitarsi alla
professione, quindi supera brillantemente l’esame di procuratore legale. La sua
richiesta di iscrizione all’Ordine, a quel punto, non avrebbe dovuto stupire
nessuno: è conforme alla legge. Che non prevede nessun divieto esplicito per le
donne di presentare domanda né di esercitare la professione. Ma la cultura,
quella con cui Poët deve fare i conti, è un altro affare. Le donne nel Regno
d’Italia non hanno diritto di voto, avvicinarsi alla professione è
inimmaginabile. Così il chiacchiericcio si rincorre nei corridoi dei tribunali
sabaudi. Soprattutto quando, nel 1883, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati
accetta la sua iscrizione con otto voti a favore e quattro contrari. Un vero
successo, se si considera il dibattito che la vicenda aveva suscitato. A
mettersi di traverso, a quel punto, è l’allora Procuratore Generale del Re che
decide di denunciare questa “anomalia” alla Corte d’Appello. Che quindi provvede
a cancellarla dall’Ordine, prestando l’orecchio allo “scandalo”. «Non occorre
nemmeno di accennare – scrivono i giudici – al rischio cui andrebbe incontro la
serietà dei giudizi se, per non dir d’altro, si vedessero talvolta la toga o il
tocco dell’avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri, che non di
rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre; come non
occorre neppure far cenno del pericolo gravissimo a cui rimarrebbe esposta la
magistratura di essere fatta più che mai segno agli strali del sospetto e della
calunnia ogni qualvolta la bilancia della giustizia piegasse in favore della
parte per la quale ha perorata un’avvocatessa leggiadra». E ancora: «Di ciò
potranno occuparsi i legislatori, di ciò potranno occuparsi le donne, le quali
avranno pure a riflettere se sarebbe veramente un progresso e una conquista per
loro quello di poter mettersi in concorrenza con gli uomini, di andarsene
confuse fra essi, di divenirne le uguali anziché le compagne, siccome la
provvidenza le ha destinate». Ebbene, “i legislatori” se ne occupano, ma
soltanto nel 1919 con l’approvazione della legge Sacchi che autorizza
ufficialmente le donne ad entrare nei pubblici uffici. Così arriviamo al 1920,
quando Poët – ormai 65enne – può ripresentare la richiesta di iscrizione
all’Ordine degli Avvocati e indossare finalmente la toga.
Femministe delle caverne.
Nicla Panciera per La Repubblica il 25 settembre 2021. "Wilma,
dammi la clava!". Macché. Una paleontologa parigina fa il punto sui torti che
ricercatori e divulgatori del recente passato hanno fatto alle progenitrici. Sì,
l'uomo preistorico era (anche) donna. Innovativa, e pure robusta e muscolosa.
Tirate per i capelli, sedute intorno al fuoco, le dita esili impegnate in
qualche attività meticolosa. Queste le donne preistoriche nell'immaginario
comune, raffigurate nei film e nei fumetti. Ma siete davvero convinti che
passassero le loro giornate a spazzare la grotta, dove uomini pelosi e nerboruti
facevano ritorno dopo la caccia o la pesca, giusto il tempo di un boccone, prima
di uscire per dedicarsi alla pittura rupestre o alle opere dell'ingegno? Se
nutrite la convinzione che i resti archeologici non forniscano prove per
assegnare alle donne un ruolo centrale nei cambiamenti che hanno permesso
l'evoluzione delle nostre civiltà, sappiate che le cose stanno diversamente.
Dagospia il 29
settembre 2021. Estratto del commento di Gianfranco Ravasi al IX Comandamento,
da “Dieci Comandamenti per Dieci Cardinali” (Edizioni Ares, Milano), pubblicato
da “Libero quotidiano”. Karl Kraus, nei suoi Detti e contraddetti, giustamente
osservava che «il vizio e la virtù sono parenti, come il carbone e i diamanti»
(che hanno entrambi come base il carbonio). Il desiderio, quindi, da virtù può
diventare quel vizio che è condannato dal IX Comandamento. Vorremmo, allora,
svolgere qualche considerazione essenziale attorno al vizio o desiderio
degenerato che si connette a questo Comandamento. Esso ha alle spalle una sua
«naturalezza»: la pulsione sessuale e la relazione d'amore sono nella natura
stessa dell'uomo e della donna. Tuttavia, questo desiderio legittimo può
imboccare strade devianti e precipitare nell'ossessione, nella frenesia,
nell'esasperazione viziosa. È curioso notare che in uno dei testi fondamentali
dell'induismo, la Bhagavadgita, si legge che «l'inferno ha tre porte:
l'avarizia, la lussuria e l'ira». C'è, dunque, la porta della cupidigia (X
Comandamento), ma anche quella della concupiscenza, che si apre su coloro che
hanno violato il sesto e il nono Comandamento del Decalogo. A ragione sant'
Agostino, nella Città di Dio, affermava che «la lussuria non è il vizio dei
corpi belli e attraenti, ma dell'anima perversa» (XII 8). Siamo, dunque, ancora
nell'orizzonte del desiderio smodato, dell'anima che si illude di raggiungere
l'amore moltiplicando gli amori. Il vocabolo stesso, «lussuria», derivando dal
latino «luxus», rimanda nella sua prima accezione a un eccesso, a un'esuberanza
che travalica e prevarica, supponendo un'eccedenza, un'esagerazione,
un'intemperanza, appunto un'incontinenza. È un po' questa la via che è stata
imboccata nella società contemporanea, quasi si obbedisse a quel Manifesto
futurista della lussuria che era stato elaborato da Valentine de Saint-Point
(1875-1953), nipote del poeta francese Lamartine e amante di Filippo Tommaso
Marinetti: «L'amore è un valore obsoleto e deve essere sostituito dal desiderio
che, lungi dal ridursi al piacere carnale, è la condizione di pienezza
dell'essere. La lussuria è una forza». Il desiderio così concepito infrange
l'armonia unitaria del paradigma sessualità-eros-amore e riduce la relazione
amorosa a mera attrazione fisica, a bramosia e piacere nei confronti di ciò che
è sexy (senza ulteriore connotazione), al puro e semplice congiungimento
carnale, regolato dall'estro e dall'istintività. La relazione amorosa, segnata
invece da tante caratteristiche personali e interpersonali, si riduce così a
mero possesso e «consumo». La logica dominante diventa, allora, quella della
liberazione del desiderio da ogni prescrizione morale. Il nuovo codice del
desiderio è quello di non avere codici normativi, lasciato libero di essere
governato solo dalla pulsione e dalla sua «irregolarità». È un po' quello che
già sottolineava Dante a proposito di «peccator carnali, / che la ragion
sommettono al talento» (Inferno V 38-39); è la scelta di vita della dantesca
Semiramide che «libito fe' licito in sua legge» (V 56). La qualità, anche in
questo caso come nel parallelo della brama per le cose, è assurdamente ricercata
attraverso la quantità, la sessualità si misura sull'esercizio, si trasforma in
sfida che conduce al ricorso a stimolanti sempre più eccitanti, a una
pornografia sempre più bieca. È paradossale, ma non troppo, che questo sentiero
in discesa porti al suo antipodo, l'impotenza. La dismisura del desiderio
incontinente ha, infatti, spesso come esito la caduta della potenza sessuale e
della stessa attrazione e persino, oltre alla saturazione nauseata, ha come
sbocco la paura. La donna, sempre più aggressiva ed eccessiva nella seduzione
(non solo pubblicitaria), riesce non di rado più ad allontanare che ad attirare.
Il grande mercato del sesso imbandito dalla pornografia virtuale, o cartacea,
esaltata da un'offerta esasperata ed estenuante, genera alla fine un'anoressia
della comunicazione interpersonale, un crollo della passione, dell'intimità
vera, una vuota solitudine. La logica della spudoratezza immiserisce il
desiderio, lo rende incapace di gustare la delicatezza dello svelamento,
dell'ammiccamento, della finezza dell'eros autentico. Potremmo proporre un
parallelo, forse inatteso: contrariamente all'opinione comune che considera
l'ascesi solo come rinuncia e, quindi, il «Non desiderare» solo come ablazione o
negazione di sentimenti, la genuina pratica ascetica corrisponde, invece, al
significato originario del greco áskesis, ossia «esercizio». È, perciò,
creatività, padronanza di sé, abilità: il corpo dell'acrobata o della ballerina
classica sfida la gravità e si fa lieve con una semplicità assoluta che è, però,
frutto di lungo e ininterrotto esercizio. Costoro sono dominatori perché si sono
dominati, si librano nello spazio in libertà totale in quanto si sono duramente
controllati. Ebbene, questa dovrebbe essere anche la vera grammatica del
desiderio: la sua energia vitale e creatrice nasce non dalla corrività sfrenata,
ma dall'esercizio severo e dall'autocontrollo, la bellezza è generata dal
rigore, la rinuncia a un piacere immediato è finalizzata a un godimento più
emozionante e alto. Naturalmente alla base di tutto ci dev' essere una
concezione della natura umana unitaria, fisica e spirituale, per cui il
desiderio sessuale è inquadrato nella persona con le sue radicali capacità di
relazione, comunione e trascendenza. Esso esprime l'individuo nella sua
identità, ma anche nel suo essere «ad extra», orientato verso l'esterno, in
rapporto con l'altro umano e l'Altro divino. Significativa è, al riguardo, la
polemica di san Paolo contro il riduzionismo libertino di alcuni cristiani di
Corinto che proclamavano: «Tutto mi è lecito! I cibi sono per il ventre e il
ventre per i cibi!», riducendo, quindi, la sessualità solo a un mero atto
fisiologico. La replica paolina punta, invece, su una diversa concezione del
corpo «non per l'impudicizia ma per il Signore», non per la fornicazione ma per
essere «membra di Cristo» e «tempio dello Spirito Santo» (1 Cor 6, 12-20). Siamo
appunto di fronte a una visione unitaria per cui il desiderio sessuale non può
essere alimentato solo carnalmente, ma è in sé epifania di domande trascendenti,
è anelito a un amore superiore, è stimolo a un itinerario che tutta la persona
compie in progressione verso una meta di pienezza. Altrimenti il desiderio
meramente soddisfatto sotto l'azione della pulsione merita l'acuta analisi che
ci ha lasciato Shakespeare nel suo Sonetto 129: «Nel desiderio, beatitudine;
sciagura a prova fatta. / Un sorridente sogno, prima; una chimera dopo. / È cosa
che chiunque sa bene. / Ma nessuno sa sottrarsi al cielo / che conduce gli
uomini in tale inferno». La condanna del peccato presente nel nono Imperativo
decalogico diventa, quindi, innanzitutto un appello alla «purificazione del
cuore», secondo quanto suggerisce, commentandolo, il Catechismo della Chiesa
Cattolica (nn. 2517 ss.), perché, come ricordava Cristo, «è dal cuore che
provengono desideri malvagi, omicidi, adulteri, impurità, furti, false
testimonianze, calunnie» (Mt 15, 19). Ma il Comandamento decalogico è, in
positivo, un appello ad avere un cuore nuovo, capace di desideri autentici,
creativi, generosi, assoluti. È ciò che si augurava il profeta Ezechiele
attraverso questo celebre oracolo divino: «Vi darò un cuore nuovo, metterò
dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un
cuore di carne» (Ez 36, 26). Solo così il desiderio ritroverà la sua radicale
tensione verso l'infinito, espressa proprio dalla sua etimologia lessicale,
ossia la sua apertura versoi «sidera», le stelle. È, quindi, il suo «in-finito»
protendersi verso la pienezza a cui la persona umana è votata, pur col suo
limite creaturale, secondo la visione cristiana che assegna agli uomini e alle
donne la possibilità di diventare «figli di Dio» (Gal 4, 4-7; Rm 8, 14-17).
Trenta donne forti.
a cura di Chiara
Severgnini e Irene Soave, illustrato da Mabel Sorrentino su Il Corriere della
Sera il 13 settembre 2021. Le protagoniste di questo lavoro collettivo sono
donne reali o immaginarie, vive o morte, celeberrime o quasi ignote, scelte dai
giornalisti e dalle giornaliste del Corriere in virtù della loro forza,
qualunque essa sia. Modelli di riferimento potenziali a disposizione di tutti e
tutte, per mostrare che aspetto può avere «un altro genere di forza».
Margaret Mead Antropologa
statunitense (1901-1978)
Virginia Nesi Aveva 23 anni
Margaret Mead, quando viaggiò fino a Samoa per studiare un’umanità incontaminata
dalla civilizzazione. Nata nel 1901, è stata pioniera dell’antropologia
culturale. Al centro dei suoi studi c’erano donne, adolescenti, bambine e
bambini. Sostenitrice dei diritti e della libertà sessuale, si opponeva
all’oppressione culturale. Fu soprannominata «la nonna del mondo»: credeva nella
capacità umana di apprendimento e promuoveva il cambiamento sociale. Ebbe tre
mariti e una figlia. A quasi un secolo dal quel viaggio nel Pacifico, i suoi
studi continuano a influenzare le generazioni che l'hanno seguita.
Carmen Protagonista dell'opera
«Carmen» (1875), di George Bizet
Greta Sclaunich «Libera è nata
e libera morirà». In questo poche parole, pronunciate da Carmen stessa quasi
alla fine del quarto e ultimo atto dell’opera omonima di Georges Bizet, è
condensata tutta la sua forza. Nel 1875, anno in cui l’opera (tratta dalla
novella di Prosper Mérimée) fu rappresentata per la prima volta, non si parlava
certo di femminicidio. Ma la sua storia, di fatto, è questa: una donna libera,
forte, indipendente e sicura delle sue scelte che viene uccisa da un ex amante
geloso, che preferisce vederla morta e finire in prigione che accettarne
l'indipendenza. Lei non scappa, anzi gli va incontro e quando lui la minaccia
ripete che è una donna libera e libera resterà, a qualsiasi costo.
Janina Duszejko Protagonista
di «Guida il tuo carro sulle ossa dei morti» (2009), di Olga Tokarczuk
Irene Soave La protagonista di
«Guida il tuo carro sulle ossa dei morti», romanzo della polacca Olga Tokarczuk
che ha meritato il Nobel per la letteratura, patisce la società. Non più
giovane, spinta ai margini del mondo del lavoro dalla concorrenza di giovani
hi-tech, si rifugia come una strega moderna nelle foreste della Slesia, dove
contempla e ama la natura: cerve, scarabei, e una volpe «così elegante che la
chiamavo il Console». «Salvatico», scriveva Leonardo, «è colui che si salva».
Quando una serie di misteriosi omicidi colpisce cacciatori e amministratori
nemici dell'ambiente, è la prima a capire cosa succede. Incarna le nostre paure
(la vecchiaia, il finire ai margini, la natura inospitale) ma ci riconcilia con
loro perché se la cava benissimo.
Meghan Rapinoe Calciatrice
statunitense (1985 -)
Andrea Marinelli Il 2021 è
stato l’anno in cui Megan Rapinoe ha dimostrato di essere imbattibile anche
quando perde. La nazionale di calcio americana è arrivata solo terza alle
Olimpiadi di Tokyo, offrendo a Donald Trump l’opportunità di definire la squadra
e la sua capitana «woke»: un gruppo di radicali di sinistra troppo attente alla
politica e poco concentrate sul calcio. «Davvero tifi perché qualcuno perda?»,
ha risposto Rapinoe definendo «tristi» le parole dell’ormai ex presidente. Poi è
corsa ad assistere la finalissima della promessa sposa Sue Bird, cestista della
nazionale americana, a cui ha dato un bacio sulle labbra dopo la vittoria
dell’oro. È stata l’immagine di chiusura dell’Olimpiade più inclusiva di sempre:
un bacio personale, e politico.
Margaret Thatcher Politica
britannica, già Primo Ministro (1925-2013)
Elisabetta Rosaspina Si dimise
da primo ministro del Regno Unito, prima donna a occupare quella carica in
Occidente, il 28 novembre 1990, con gli occhi rossi di lacrime. Le rare lacrime
apparse tra le sue ciglia: Margaret Hilda Thatcher, figlia di un droghiere di
Grantham (Midlands Orientali), sfoggiava già da 15 anni il soprannome di Iron
Lady, cioè dama di ferro. Le era stato affibbiato dai sovietici, suoi avversari
dichiarati fino al debutto di Gorbaciov: «Con lui posso fare affari». E divenne
il suo distintivo in tutte le battaglie (spesso impopolari) che, da
conservatrice, condusse in 11 anni di mandato: contro i sindacati dei minatori,
contro l’Ira, contro l’Argentina nella guerra per le Falkland, contro l’Euro. Ma
sotto le sue cure severe l’economia britannica si rigenerò.
Saranda Bogujevci Deputata
kosovara (1985 -)
Mara Gergolet Dicono che
Saranda Bogujevci sia fatta di ferro, anzi che non ci sia uomo più duro di lei
in tutto il Kosovo. Aveva 13 anni quando i serbi fucilarono lei e 14 membri
della sua famiglia; lei però sopravvisse, unica, e fu curata in Regno Unito. A
18 anni testimoniò a Belgrado contro gli Skorpioni, i paramilitari che avevano
cercato di ucciderla, e come una Kill Bill senza spada si vendicò guardando
negli occhi il suo aguzzino. Ora ha 35 anni, è diventata deputata del suo Paese
ed è uno dei volti del nuovo Kosovo, dove la presidente, Vjosa Osmani, è una
donna come il 40% dei parlamentari. Qualcosa sta cambiando.
Elisabetta II Regina del Regno
Unito (1926-)
Luigi Ippolito Elisabetta è la
roccia su cui poggia la nazione britannica, la pietra angolare della società e
la chiave di volta delle istituzioni. Con la sua forza ha traghettato l’impero
verso la decolonizzazione, ha retto alle sfide del tempo e ha aggiornato la
monarchia al mutare degli eventi. Una sovrana che ha saputo anteporre le ragioni
della Corona a quelle del cuore, anche a costo del sacrificio personale: e che
non ha vacillato neppure alla prova più dura, la scomparsa dell’amato Filippo.
Angela Merkel Politica
tedesca, Cancelliera dal 2005 (1954)
Paolo Valentino Quella di
Angela Merkel è stata l’incredibile parabola di una donna, protestante,
divorziata, venuta dall’Est, capace di conquistare un partito fin lì dominato da
maschi, cattolici, sposati, tutti dell’Ovest, portandolo a vincere quattro
elezioni consecutive. Nei suoi 16 anni al potere, segnati da crisi drammatiche,
la cancelliera tedesca ha cambiato la Storia della Germania e del mondo. Per
questo, quando gli storici futuri guarderanno indietro, molto probabilmente
parleranno dell’«Età di Merkel».
Carrie Mathison Protagonista
di «Homeland»
Beppe Severgnini Caroline Anne
Mathison è bionda, intensa, fragile, appassionata e non molla mai. Tutti la
chiamano Carrie. Nata nel 1979 in Maryland, mentre insegnava arabo a Princeton è
stata reclutata nella CIA dal barbuto Saul Berenson, un po' capo e un po' papà.
Soffre di un disturbo bipolare che, unito alla vocazione a cacciarsi nei guai,
produce televisione avvincente. Per l'esattezza otto stagioni di «Homeland» (dal
2011 al 2020), per un totale di 96 episodi. «Homeland» è una serie femminile.
Carrie, intepretata da Claire Danes, non è solo la protagonista che entra nelle
ferite del mondo (da Beirut a Kabul, da Teheran a Mosca). È una meravigliosa
piantagrane. Una donna sorprendente, intuitiva e fortissima perché consapevole
della propria fragilità. In un mondo opaco, pieno di maschi che si nascondono e
fingono d'essere ciò che non sono, Carrie è una luce bionda. La prova che molti
sbatteranno il muso, ma tutti ce la possono fare.
Angiolina Casella Madre di
Cesare Casella, rapito nel 1988 (1946-2011)
Alessandro Cannavò Minuta,
scarna, provata da un’interminabile angoscia, Angela Casella da Pavia fu nel
1989 una madre coraggio contro la ‘ndrangheta. Suo figlio Cesare restava in mano
dei rapitori da oltre 500 giorni nonostante il pagamento di un miliardo. Davanti
al silenzio degli aguzzini, dell’ambiente circostante, dello Stato, decise di
incatenarsi nelle piazze di Platì e San Luca, inscenando le condizioni disumane
della prigionia di Cesare. La cui liberazione sarebbe arrivata dopo 743 giorni,
senza ulteriori riscatti. Il gesto plateale (e rischioso) di Angela aiutò a
cambiare il destino dei sequestri di persona. Poi lei non speculò su quella fama
che piuttosto voleva rimuovere. Si dedicò al volontariato. Fino alla morte,
dieci anni fa.
Amy March Protagonista di
«Piccole Donne» (1869), di Louisa May Alcott
Roberta Scorranese Se
l’università del Missouri (si fa per dire) facesse uno studio ad hoc sono certa
che due donne su tre dichiarerebbero di voler assomigliare a Jo, dovendo
scegliere una delle sorelle March di «Piccole donne». Jo è indipendente, forte,
assennata, concreta, sobria. Quella più snobbata? Amy, perché vezzosa,
belloccia, poco credibile. E se, invece, un certo tipo di forza risiedesse
proprio in quello sguardo pacificato di chi sa di piacere a tutti? Non è forse
ora di difendere (paritariamente) anche le vanitose? Viva Amy.
Golda Meir Politica
israeliana, già Primo Ministro (1898-1978)
Micol Sarfatti Forza d’animo,
forza politica, forza intellettuale, forza fisica. Golda Meir, nata Mabovitch a
Kiev, Ucraina, nel 1898, è stata questo e molto altro. Prima - e ad oggi unica -
donna a guidare lo stato d’Israele, terza leader femminile a livello
internazionale. La vita di Meir merita di essere conosciuta, lei stessa l’ha
raccontata nell’autobiografia «My Life». Ha gestito da ministro degli Esteri la
crisi del canale di Suez, nel 1956, e da Primo Ministro l’attentato alle
Olimpiadi di Monaco del 1972 e la guerra dello Yom Kippur nel 1973. Oriana
Fallaci l’ha descritta così: «Ha una modestia irritante, una saggezza che viene
dall’aver sgobbato tutta la vita». La vera «modestia irritante» può essere
appannaggio solo delle grandissime. Morì nel 1978 dopo aver affrontato, per anni
e senza mai parlarne pubblicamente, la leucemia.
Hermione Granger
Coprotagonista di «Harry Potter» (1997-2007), di J. K. Rowling
Francesco Giambertone Alla
prima manifestazione di donne contro Trump nel gennaio 2017, una bambina
mostrava fiera un cartello: «Quando il presidente è Voldemort, abbiamo bisogno
di una nazione di Hermione». La maga più intelligente della classe di Harry
Potter, senza la quale lui sarebbe durato vivo giusto un libro, in questi
vent’anni è diventata un’icona femminista di inevitabile fascino anche per il
genere maschile: è giusta ma non moralista, coraggiosa ma non matta, e ha
successo perché - oltre al talento - lavora più di tutti. È bello conoscere
tante Hermione vere.
Modesta Protagonista del
romanzo «L'arte della gioia» (1976, pubblicato nel 1998), di Goliarda Sapienza
Chiara Severgnini Modesta
nasce povera, ultima tra gli ultimi, e diventa una principessa. Se fosse la
protagonista di una fiaba, questo testo potrebbe finire qui e lei non sarebbe un
modello di forza. Ma Modesta è la figlia d’inchiostro di una scrittrice
rivoluzionaria, Goliarda Sapienza. E, come il romanzo di cui è protagonista,
Modesta è spregiudicata, talvolta spaventosa. Dispensa vita e morte, come una
divinità, eppure è tremendamente umana. Combatte tutto, dalle convenzioni
sociali al fascismo. Sopravvive al confino, cresce una piccola tribù di figli
(suoi e altrui), impara ad arringare le folle. La sua forza: ama molto, in
primis se stessa.
Margrethe Vestager Politica
danese, commissaria Ue per la Concorrenza (1968-)
Irene Soave Danese, la
Commissaria Europea per la Concorrenza (dal 2014), ha ispirato il personaggio
principale di «Borgen», una serie tv sulla politica di Copenhagen. Non è strano:
è tra le figure più carismatiche di questi anni nelle istituzioni europee. Ad
alcuni vertici internazionali si è presentata coi documenti in una borsa della
spesa, e indossa abiti fiorati e fantasiosi che contrastano con i suoi capelli a
spazzola. Ma al grande pubblico sembra una supereroina soprattutto per le
battaglie che conduce: una su tutte, far pagare più tasse in Europa alle
multinazionali che sfuggono al fisco, o abusano della loro posizione di leader
di mercato. Una «Davide dell'antitrust» che lotta (e vince) contro Golia come
Gazprom, Facebook, Amazon.
Samantha Cristoforetti
Astronauta italiana (1977-)
Martina Pennisi Per sua
precisa scelta, siamo abituati a vedere Samantha Cristoforetti sempre più o meno
nello stesso modo, dal 2014, quando è diventata la prima astronauta italiana a
volare nello spazio, dopo essere stata selezionata dall'Esa: la vediamo in abiti
da lavoro o con i loghi delle missioni appuntati sulle t-shirt. Impegnata in
interviste, conferenze o conversazioni sulla sua professione, quella - ai nostri
occhi straordinaria - degli studi e delle missioni fuori dai confini terrestri.
Sta funzionando: l'ingegnera e pilota Cristoforetti ha contribuito in questi
anni a portare la percentuale di donne candidate alla selezione dell'Agenzia
spaziale europea dal 15 al 24%. Rigorosa e sempre concentrata, rappresenta il
volto (femminile) di un'Italia che funziona e osa, senza compromessi o
sbavature. E la prossima primavera riparte, questa volta col grado di
comandante.
Clarissa Ward Giornalista
statunitense (1980-)
Federica Seneghini Fredda,
coraggiosa, imperturbabile tra gli spari in diretta. Ha passato il microfono
agli afghani incontrati per strada restituendo loro la voce che in quelle ore
stavano perdendo. Ha slalomato tra la folla che davanti all'aeroporto di Kabul
tentava di lasciare il Paese, affrontando i talebani armati di Ak7 e manganelli.
«Copriti il volto». «Non vogliamo parlare con te, sei una donna». Clarissa Ward,
classe 1980, inviata della Cnn, è andata avanti. Rinchiusa nell'abaya nera, i
capelli sotto un velo nero. «La testa l'ho sempre coperta, ma ora ho dovuto
nascondere anche i capelli». Un cambio d'abito necessario, un velo che per le
donne afghane, e per lei, è tornato ad essere la migliore armatura contro i
talebani. Grazie alla Cnn, che ha distribuito i suoi servizi sui social, abbiamo
conosciuto il suo talento. Cronaca sul campo, riflessioni da studio: «Se si
comportano in modo brutale con noi che siamo giornalisti stranieri, riuscite a
immaginare come possono essere violenti con gli afghani?». Un esempio.
Amal Clooney Avvocata libanese
(1978-)
Marta Serafini Amal Alamuddin,
sposata Clooney, è l’avvocata che più di tutti, in questi anni, si è spesa per
le donne yazide, vittime dell’Isis. Dal 2016 sta combattendo e ha combattuto per
portare i loro casi davanti alle corti internazionali e nazionali (ultimo il
caso di due ragazze che hanno accusato i loro carnefici in Germania) e le sta
sostenendo affinché il mondo riconosca il genocidio perpetrato dai jihadisti
contro questa minoranza religiosa. E se la Storia cambierà sarà anche merito suo
e del suo lavoro. Dunque non chiamatela moglie di George: casomai il «marito di»
è lui.
Erika Siffredi Alpinista e
moglie di Cala Cimenti, sportivo estremo scomparso nel 2021 (1984-)
Giusi Fasano Erika ha
conosciuto la felicità, l'ha tenuta per mano per sei anni e in quei sei anni ha
vissuto una vita a colori. Poi - l'8 febbraio del 2021 - una valanga si è
portato via il suo Cala, l'uomo dei suoi sogni e dei suoi colori. E
all'improvviso tutto è diventato scuro. «Avrei tanto voluto morire con lui» ha
ripetuto lei per mesi. Finché un giorno un suo amico le ha chiesto: «Davvero
vuoi che finisca tutto così?» ed Erika ha risposto a se stessa che no, non
voleva. Carlalberto Cimenti, il suo marito adorato, l'alpinista romantico dalle
mille imprese pericolose in giro per il mondo, se n'era andato sotto un cumulo
di neve nel suo piccolo Piemonte. E per lei era tempo di ricominciare - di
provarci almeno - nel nome e nella memoria di Cala. Così, con l'aiuto di due
amici, Erika ha ripreso fra le mani la sua vita, ha avviato una raccolta fondi
per ricostruire aule scolastiche terremotate nel Nepal che lui tanto amava, ha
in mente un progetto per scalare i 5000 africani e legare le imprese a missioni
umanitarie in Africa, racconta di lui in serate-evento a sfondo sociale, pensa a
una mostra fotografica...in ricordo di Cala. Che è accanto a lei più che mai.
Sarah Connor Eroina della saga
di «Terminator» (iniziata nel 1984)
Chiara Severgnini All’inizio
di «Terminator 2», Sarah Connor è rinchiusa in un manicomio criminale. Moderna
Cassandra, profetizza la fine del mondo (per mano dell’A.I. sfuggita al
controllo degli umani): nessuno le crede. Lei, però, non molla. Coltiva la sua
forza, si allena, si prepara. A cosa? A evadere, e a salvare sè stessa, suo
figlio e il mondo. Di nuovo. Nel primo film della saga con Arnold
Schwarzenegger, aveva passato 90 minuti su 107 a fare la damsel in distress, poi
aveva scoperto di sapersi salvare anche da sola. Una lezione che Connor non ha
dimenticato. Non a caso, nel secondo film è un'eroina fatta e finita.
Fortissima. Non tanto per i muscoli (sebbene abbia anche quelli), ma per la
fibra d'animo: Connor combatte fino all'ultimo, nel nome del futuro.
Simone Biles Ginnasta
statunitense (1997-)
Viviana Mazza Da piccola
Simone Biles aveva un sesto senso per l’aria. Non perdeva mai l’equilibrio.
Sapeva esattamente dov’era il suo corpo, dove stava andando e quando appoggiare
i piedi al suolo per non farsi male. Vent’anni dopo era diventata la più forte e
premiata ginnasta americana, forse la più grande di tutti i tempi. Ma intanto
per anni subiva abusi sessuali da parte del medico della nazionale. Arrivata
alle Olimpiadi di Tokyo Biles ha scoperto di aver perso il senso dell’aria.
Sentiva il peso del mondo sulle sue spalle. Allora, l’ha sollevato con tutta la
sua forza e l’ha posato a terra.
Garima Arora Chef indiana
(1981-)
Alessandra Dal Monte La prima
chef donna indiana a prendere una stella Michelin è un’ex giornalista di 34
anni, Garima Arora. Abbandonati i panni della reporter in favore della cucina,
nel suo ristorante Baa, a Bangkok, Arora mette la millenaria sapienza culinaria
del suo Paese soprattutto al servizio delle verdure. «Preparate in modo
delizioso», dicono i critici. Che nel 2018 le riconoscono l’ambito
riconoscimento nella guida Rossa. Ma il suo principale impegno è Food forward,
il sito che mappa e promuove centinaia di prodotti nativi dell’India e i
contadini che li coltivano. Grazie a questa piattaforma piccole e sperdute
comunità locali hanno trovato un posto nell’Atlante globale del cibo. Il
prossimo step? «Scrivere il codice della cucina indiana, che in termini di
tecniche e ricette non ha nulla da invidiare a quella italiana o francese».
Assaggiare le verdure del Baa per credere.
Mrs. Maisel Stand-up comedian,
protagonista di «La fantastica signora Maisel» (iniziata nel 2017)
Andrea Federica de Cesco Se
non avete ancora guardato «La fantastica signora Maisel» fatevi un regalo e
recuperate il prima possibile (lo trovate su Amazon Prime Video). Anche voi vi
innamorerete della protagonista, Mrs. Maisel, interpretata dalla meravigliosa
Rachel Brosnahan. All'inizio della serie è una casalinga ebrea nella New York
della fine degli anni '50. Nel giro di qualche episodio diventa la comica più
spassosa della città (e non solo), fregandosene dell'invidia del marito. Mrs.
Maisel ci mostra che le donne possono essere e fare tutto quello che vogliono,
incluso far ridere. Ma ridere sul serio.
Antigone Eroina di «Antigone»,
tragedia greca (442 a. C.), di Sofocle
Alice Scaglioni Moderna pur
appartenendo alla tragedia greca, Antigone è simbolo di disobbedienza civile: il
nuovo re di Tebe Creonte ha vietato di dare una sepoltura al fratello di lei,
Polinice, ma lei si oppone. Al divieto; ma anche alle convenzioni sociali che
volevano una donna sottomessa alla volontà di un uomo. Si intromette nella
politica della città, prerogativa degli uomini. Antigone – che ispirò tra gli
altri Bertolt Brecht e Jean Anouilh – ha più anime. La più attuale: si sacrifica
per ciò in cui crede, dimostrando che nulla può impedirti di avere un tuo
pensiero. Una storia che continua a ripetersi, in Afghanistan e non solo.
Marie Curie Scienziata polacca
(1867-1934)
Venanzio Postiglione Una foto.
Che dice tutto. Ottobre 1927, Bruxelles, conferenza di Solvay. Ci sono 29
scienziati da ogni parte del pianeta, anche Einstein, e una sola donna: Marie
Curie. Lei, soltanto lei, tra ventotto uomini. Due premi Nobel, per la fisica e
per la chimica, una vita controcorrente, sospesa fra la testa e il cuore, e una
curiosità senza fine, che ancora ci affascina. Quanto è bello sapere che per le
ragazze, nel 2021, appare come un simbolo: di indipendenza e di emancipazione. È
anche grazie a lei se il mondo è diventato un posto migliore. Per la scienza e
per le donne.
Naomi Osaka Tennista
giapponese (1987-)
Marco Imarisio Con Naomi Osaka
non è più questione di diritti o di rovesci in senso tennistico. Fino a pochi
mesi fa la ragazza di madre giapponese, padre americano, social con seguito da
rockstar e fatturato personale da 55 milioni di dollari, era una semplice
benedizione per il tennis femminile. Dal maggio scorso, è diventata altro.
Perché ha rivendicato il proprio diritto a stare male, parlando di depressione.
Chiamando il male oscuro con il suo nome, esponendo la propria fragilità in
pubblico, Naomi ha dato voce a tanti che non trovano le parole o il modo per
affrontare i rovesci della vita.
Giulia Re Staffetta partigiana
(1926-2020)
Greta Privitera «Re Giulia»,
diceva quando si presentava. Ma tutti la chiamavano Giulietta, anche i
partigiani. Nata a Milano, Giulia Re è morta nel 2020, a 94 anni. «Mio padre era
molto antifascista, e io ho preso molto da mio padre», raccontava. Un giorno,
una certa Emma Gessati, attivista per la difesa delle donne, le disse: «Te fai
finta di niente e porta in giro qualche manifestino». Aveva 12 anni e iniziò a
portare messaggi ai partigiani. Da più grande, durante la guerra, «portavo anche
le armi, ma c’era d’aver paura». Staffetta partigiana, coraggiosa, Giulia è
stata regina di libertà.
Francesca Spada Giornalista,
musicista e scrittrice italiana (1916-1961)
Alessandro Trocino Era di una
bellezza aspra, selvaggia e raffinata quando a trent'anni, negli anni Cinquanta,
entrò nella redazione napoletana dell’Unità. Diplomata al Conservatorio, due
lauree, Francesca Spada era una donna divorziata, con due figli avuti da un uomo
ignoto, un compagno dirigente. Per il Pci dell’epoca era solo «una puttana, una
marcia borghese che pretende di fare la rivoluzionaria di professione». Donna
«scandalosamente libera, decadente, romantica, borghese», fu travolta dallo
stalinismo e si uccise nel 1961. Ermanno Rea ne ha raccontato la storia in uno
dei romanzi italiani più belli del Dopoguerra, «Mistero Napoletano».
Chimamanda Ngozi Adichie
Scrittrice nigeriana (1977-)
Silvia Morosi «Femminista
felice africana». Le parole che ha scelto per definirsi, tutte nella stessa
frase, hanno fatto storcere il naso a molti. Ma è proprio in quelle parole che
la scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie ha trovato la forza per sfidare
il pensiero oggi dominante e mettere in guardia dal rischio di raccontare la
Storia da un’unica prospettiva. Un invito a ribellarsi a ogni forma di
imposizione e a battersi per l’affermazione della donna e dei suoi diritti come
la più alta forma di difesa della democrazia alla quale siamo chiamati. Tutte e
tutti.
Margherita Vicario Cantautrice
italiana (1988-)
Stefania Chiale Cantautrice
con carriera da attrice (tra i registi che l'hanno diretta c'è Woody Allen), due
album all'attivo, a otto anni l'uno dall'altro. In mezzo c'è tanta vita,
esperienza, storie, studio. Le canzoni di Margherita Vicario hanno il sapore del
racconto, della cronaca. La sua voce, coltivata dalla recitazione e dallo studio
del canto, fa di ogni testo una traiettoria teatrale. La sua estensione vocale
non è mera erudizione canora, ma ricerca artistica. Poi la versatilità. Vicario
è capace di cambiare genere musicale ad ogni brano. Lo ha fatto nel suo ultimo
album, Bingo. Forse proprio l'esperienza di attrice le rende possibile sondare
con facilità le tante possibilità anche nel campo della musica, dal pop al
cantautorato, dalle sonorità latine al rap. Le sue canzoni, infine, sono in
apparenza leggere; ma sotto sono poesia, sguardo ironico sulla realtà e sui
ruoli (pre)assegnati, critica sociale. Una sola regola: sfuggire all'ovvio. Se
la forza è capacità di sfidarsi, cambiare, arricchire la propria arte,
Margherita Vicario è una delle più forti musiciste italiane.
Antonello Caporale per "il
Fatto Quotidiano" il 13 settembre 2021. "Siamo nella condizione di dire basta
alle quote rosa, a questa formula che invece di liberare le donne statuisce,
oltre ogni intenzione, una condizione di statica indispensabilità. Essere
indispensabili per forza di legge è la negazione della forza e del potere della
condizione femminile oggi in Italia". Eva Cantarella è la donna che ha studiato
e illustrato meglio di tutti la storia anche drammatica delle donne, il cammino
verso l'emancipazione, le lotte e le conquiste femminili.
Professoressa, lei vorrebbe
le quote rosa al macero. Grideranno allo scandalo.
Sono divenute, per paradosso,
una minorazione delle capacità femminili. Siamo così forti che non abbiamo
bisogno di tutor e magari pure maschi. Esiste questa punta di ossessione verso
l'esatta parità aritmetica tra l'uomo e la donna. Un fenomeno soprattutto
mediatico, con fiumi d'inchiostro a commentare ogni temuta discriminazione.
Le diranno che nega la
storia recente.
Chi le parla ha vinto il
concorso da professore ordinario al tempo in cui l'università era un coperchio
totalmente maschile. Figurarsi se non conosco quale e quanta discriminazione
abbia patito la donna. Ma conosco la nostra forza, conosco le conquiste
ottenute. Io voto una donna se è più brava di un uomo, voto due donne se ambedue
sono brave così come scelgo un maschio se ritengo che sappia difendere meglio di
altri i miei diritti.
Il volto femminile colora
quotidianamente la cronaca nera.
E qui le donne sono ancora
vittime indifese. Voglio augurarmi che sia la coda finale del patriarcato
morente. La forza dell'identità femminile è tale che all'uomo non resta, per
affermare il proprio potere, che ricorrere a quella biologica. Con la sua forza
fisica intende regolare i conti.
La guerra è raccontata dal
volto delle donne.
La tragedia dell'Afghanistan è
segnata quasi esclusivamente dall'imposizione del burqa. Converrà che è una
violenza orribile. Non è in discussione la natura violenta di questa imposizione
e la retrocessione della donna a oggetto, quanto il sospetto che la tragedia
femminile afgana ci sollevi dalla domanda: perché il regime talebano è ancora
vincente, e l'Occidente laggiù chi ha aiutato, chi ha arricchito, chi magari ha
ucciso? C'è, ed è vero, una ipocrisia di fondo. Il burqa, segno della
retrocessione femminile, come utile paratia per covare lo sdegno senza avanzare
autocritica, senza indagare sui nostri errori. Biden se l'è cavata dicendo che
gli Usa hanno smesso di esportare la democrazia. Ma la faccenda è più complessa.
Molto tempo prima degli Usa sono stati i Sumeri a esportare la democrazia.
Questo per la precisione. La storia insegna ma ha cattivi scolari, diceva
Gramsci. Alle donne la storia di discriminazione ha insegnato tanto e ha
contribuito a sostenere le lotte di liberazione. In sessant'anni abbiamo
conquistato più di quel che si è visto nei duemilacinquecento anni precedenti.
Questo è un fatto.
Lei ha scritto un libro
sulla emancipazione femminile attraverso lo sport.
Le scorse Olimpiadi si sono
colorate di rosa. E sarà una meravigliosa turbina che darà ancora più forza al
motore femminile. Perciò dico che non abbiamo bisogno di forme di solidarietà
pelose, e nemmeno del circuito scandalistico (al quale anche noi partecipiamo)
di maniera, che a volte pare densamente intriso di ipocrisia.
Professoressa, facciamo
conto che lei sia grande elettrice e debba scegliere il nuovo presidente della
Repubblica. Uomo o donna?
Io sceglierei il più bravo. Se
potesse proporre un nome? Se potesse rivivere Zenobia di Palmira senza alcun
dubbio voterei lei. Zenobia. Sotto l'imperatore Aureliano, quando Roma amplia i
suoi confini fino all'odierna Siria, Zenobia si fa nominare regina di Palmira.
Sotto il suo comando la città rinasce e si espande. Aureliano ritiene che
Zenobia sia una semplice portatrice d'acqua ma, quando s'accorge che la regina
batte moneta, cambia idea.
Quindi Zenobia presidente.
Assolutamente sì.
Erika
Antonelli per espresso.repubblica.it il 12 settembre 2021. «Mi sottovalutano
spesso. Perché sono donna, per la mia età, per il mio aspetto fisico. Sono una
guerriera e lo so, ma a volte mi manca la forza. Ho bisogno di avere più donne
al mio fianco, che mi sostengano quando da sola non ce la faccio. Unite, è più
facile». Parla così Josephine Teske, 35 anni, a cui anche il settimanale tedesco
Der Spiegel ha dedicato un lungo ritratto. È pastora di due comunità: quella
evangelica di Büdelsdorf – cittadina nel nord della Germania – e una virtuale,
su Instagram, da oltre 29 mila follower. Rappresenta tante cose Josephine, a
partire dal nome. Frau Teske in chiesa, con la tunica nera e i capelli raccolti
sulla nuca, e “Phine” su Instagram, immortalata con un vestito bianco e verde il
giorno del suo compleanno. Si definisce con tre sostantivi: amante della vita,
femminista, mamma single. Quando le chiedi se femminismo e fede siano in
contraddizione, risponde con tono placido che no, non è così, perché tutti gli
esseri umani hanno pari dignità e in quanto tali meritano lo stesso rispetto.
Uno dei temi a lei più cari è l'empowerment femminile, la capacità di rafforzare
la consapevolezza di sé e delle proprie capacità. Creando comunità e
apprezzamento reciproco: «Dovremmo sostenerci a vicenda e non invidiarci o
sminuirci. Diciamocelo se ci piace qualcosa l'una dell'altra. Una cosa tipo,
“hey, come sei bella oggi, hai davvero un bel vestito”». Per Teske, che ha due
figli piccoli, femminismo e maternità sono intrecciate: «Mi ritengo una buona
madre, anche quando ho dei dubbi. Anche se sgrido i miei bambini, o se gli
lascio bere la Coca Cola. Amo i miei figli e mi butterei nel fuoco per loro,
sono grata di averli avuti. Eppure, sono altrettanto grata quando si
addormentano». Nessun senso di colpa dovrebbe impedire di ritagliarsi del tempo
prezioso. L'attività di Josephine Teske, di persona e sui social, ruota attorno
all'importanza di creare connessioni con le altre donne: «Se sgrido i miei
bambini – a volte bisogna farlo – mi piacerebbe ricevere sguardi dei
comprensione e non occhiate severe». I temi di cui parla Teske sono vari, spesso
difficili o laterali per la religione. Sesso prima del matrimonio, masturbazione
o mestruazioni, secondo lei, non sono tabù ma «argomenti che interessano alla
società di oggi, e in quanto tali imprescindibili per la Chiesa». Proprio questo
le permette di rivolgersi a un pubblico vario - capita la seguano anche atei o
appartenenti ad altre confessioni - con cui mantiene un dialogo aperto. Nel suo
profilo una sezione è dedicata alle domande dei follower – «Quando sei rimasta
incinta?», «Com'è stato il tuo primo funerale?», «Hai mai dubbi sulla fede?» – e
lei risponde a tutti. Oggi, di dubbi non ne ha più. Ma in passato il cammino per
diventare pastora non è stato facile. Già a 14 anni sapeva di voler fare quello,
perché nessuna professione l'affascinava più del vicariato. Eppure, le
incertezze hanno coinciso con l'inizio degli studi di Teologia, a Rostock. «Mi
intimidiva l'approccio “scientifico” alla fede – racconta – all'università non
avevo trovato una comunità e lo studio mi metteva davanti a questioni cui non
sapevo dare risposte». La perdita di un figlio, il primo, a pochi giorni dal
parto, acuisce il dolore e porta con sé una nuova consapevolezza: «Ero così
arrabbiata con Dio. Allo stesso tempo, però, sapevo che era sempre là per me».
Continua a studiare nonostante la difficoltà di apprendere lingue nuove,
soprattutto il greco antico, mentre latino ed ebraico le vengono più facili. Si
trasferisce a Büdelsdorf, la cittadina in cui risiede tuttora. Qui scopre il
lato femminista della fede, che cambia anche il suo rapporto con Dio. Spesso a
lui si rivolge usando il genere femminile, una particolarità che non disturba i
fedeli. Il Signore ha tanti volti, spiega, «puoi chiamarlo padre nostro o madre
amorevole, dio è un concetto e in quanto tale non ascrivibile a una categoria».
Secondo il portale web Statista, nel 2020 sono stati oltre 440 mila i credenti
che in Germania hanno lasciato la chiesa cattolica ed evangelica. Molti l'hanno
fatto per sfuggire alla “Kirchensteuer”, la tassa sulla
religione. L'appartenenza religiosa – cattolica, protestante o ebraica – va
infatti segnalata nella dichiarazione dei redditi e comporta il pagamento di una
cifra. Teske crede però che sulla scelta dei cattolici abbiano influito anche
gli scandali legati agli abusi sessuali e la poca apertura verso le coppie
omosessuali. «La Chiesa, temo, non parla più la lingua delle persone». Josephine
Teske ha ricevuto critiche, «alcune costruttive, altre meno», perché affronta la
religione in modo poco convenzionale. Discute di temi su cui la fede preferisce
non interrogarsi, dà spazio ai dubbi dei giovani. E sfrutta ogni mezzo possa
agevolarla nel dialogo: «Instagram è più di un social dove postare foto, è uno
strumento per creare rete e parlare». Come le piace ripetere, in fin de conti,
«non mi va di combattere da sola, è troppo faticoso».
Michela Murgia: «Donne, gli uomini ricchi
siamo noi». Michela Murgia su La Repubblica il 6
settembre 2021. Ci hanno insegnato che parlare di soldi non fosse educato. Per
tenerci all’angolo. Per ribaltare i luoghi comuni, dieci storie di successi
professionali di chi ha costruito una fortuna puntando solo su se stessa. Da
Oprah Winfrey a Beyoncé. Il racconto dell’autrice del libro “Morgana – L’uomo
ricco sono io”, scritto con Chiara Tagliaferri. Di denaro, di Dio, di politica e
di sesso non si parla tra persone ben educate. Quest’opinione, eredità
familiare, ha accompagnato gran parte del mio percorso adolescenziale, cercando
di trasmettermi l’idea che trattare argomenti delicati guastasse i rapporti col
mondo. Alle cene e alle feste meglio parlare del tempo, come gli inglesi, o al
massimo di cibo, che dà luogo a discussioni sì, ma mai fatali. Il tentativo di
convincermi che parlare di denaro fosse vile, di Dio troppo personale, di sesso
volgare e di politica pericolosamente divisivo ottenne però l’effetto contrario,
confermandomi che in realtà erano gli unici argomenti di cui valesse la pena
occuparsi. A distanza di anni mi sono invece resa conto che mentre di Dio, di
sesso e di politica ho ragionato anche pubblicamente in modo esplicito, la
questione del denaro rimaneva legata a un certo pudore, come se avesse prevalso
anche in me l’idea che parlare di soldi fosse una cosa vile. Il tabù del denaro,
al netto del retaggio cattolico che ci impone di mostrarci tuttǝ sempre
disinteressatǝ allo sterco del demonio, viaggia abbracciato anche a un
pregiudizio di genere: se proprio qualcuno deve parlare di quella cosa volgare
che sono i soldi, è meglio che a farlo non sia una femmina. Donne e soldi non
stanno insieme per molte ragioni storiche, a partire dalla contrapposizione tra
matrimonio e patrimonio che Jane Austen aveva già così ben investigato. Le donne
non hanno avuto diritto alla proprietà perché per troppo tempo sono state esse
stesse una proprietà che passava dal marito al padre, accompagnate nei casi più
fortunati anche da quel risarcimento chiamato dote. L’unico modo per avere
accesso al denaro è stato per secoli quello di sposare un uomo che ne avesse.
L’autonomia economica era esclusa: le donne non hanno potuto lavorare per secoli
se non in ambiti familiari e quando hanno cominciato a farlo non hanno mai visto
riconosciuto il valore della loro fatica. Quel dislivello storico ha strascichi
così lunghi che nel settore privato ne paghiamo ancora le conseguenze: il gender
pay gap in Italia viaggia tutt’ora su percentuali a cavallo tra le due cifre e
gli uomini, siano operai, liberi professionisti o dirigenti, godono di stipendi
più alti delle loro colleghe sin dall’inizio delle rispettive carriere. A
compromettere la parità è proprio la mancata dimestichezza con l’idea di gestire
dei soldi. L’Unicredit qualche anno fa lanciò un prodotto bancario telematico
dedicato alle nuove generazioni, quelle che a diciotto anni cominciano ad avere
bisogno di un conto dove mettere il denaro dei primi lavoretti estivi, di un
part time universitario o del regalo di diploma. Dopo un anno dalla promozione
del conto on line, le statistiche aziendali rivelarono che l’80% dei fruitori
erano maschi. Le ragazze, già in partenza meno incoraggiate a cercarsi piccole
fonti di reddito autonomo, avevano meno entrate e tendevano a metterle nel conto
familiare, lasciandole gestire ai genitori. I dati di Unioncamere rivelano che
purtroppo la tendenza a scoraggiare le donne nella gestione del proprio reddito
non cambia nemmeno quando si esce dagli studi e si entra nel mercato del lavoro:
l’accesso al credito bancario è molto più faticoso per le imprenditrici, che
sono considerate dalle banche meno affidabili nella gestione dei soldi e si
vedono dunque chiedere garanzie in solido a fronte di progetti d’impresa per
finanziare i quali agli uomini basta semplicemente presentare un business plan.
Le donne che aprono un’impresa preferiscono chiedere un prestito interfamiliare,
laddove è possibile, perché è più semplice che domandare ai genitori di firmare
una fidejussione, mettendo magari a garanzia la casa di famiglia. Il consiglio
che in troppe case ancora viene dato alle donne non è quello assai saggio di
Virginia Woolf, avere una stanza per sé e 500 sterline di rendita all’anno, ma
quello di “sistemarsi” sposando un uomo ricco e dipendendo per sempre
dall’agiatezza di qualcun altro. È stata la presa di coscienza di questa
situazione di ingiustizia economica, e dunque foriera di violenza, a convincermi
che fosse importante e politicamente urgente cercare, insieme a Chiara
Tagliaferri, dieci storie di donne che nell’ultimo secolo avessero provato a
realizzare se stesse e i propri sogni attraverso l’indipendenza economica. Da
Helena Rubinstein, che crea un impero commerciale partendo dalla cosa più
effimera che esista, fino a Oprah Winfrey, nata povera e discriminata, ma
divenuta padrona del salotto televisivo più importante degli Stati Uniti, non è
stato facile trovare figure di donne che rientrassero nei canoni di libertà che
per gli uomini sono sempre stati scontati. Nessuna delle donne che abbiamo
trovato ha una storia semplice. Nadia Comaneci si è vista rubare tutto quello
che ha guadagnato con gli ori olimpici e c’è voluta una vita intera perché
tornasse padrona di sé in tutti i sensi possibili. Chiara Lubich, carismatica
leader cattolica e osservatrice dei meccanismi capitalistici, inventò un modello
economico umanamente non distruttivo che viene tutt’ora applicato a Loppiano, la
città da lei fondata. Madame Clicquot, nome leggendario nel mondo dello
champagne, per centuplicare il valore dell’azienda vinicola a Reims dovette
attendere di diventare vedova di un marito imprenditorialmente inetto. Beyoncé,
JK Rowling e Angela Merkel si sono affermate nei rispettivi ambiti con un
talento e un impegno certamente fuori dal comune, ma il loro esempio è scalabile
anche nelle comunissime vite di molte donne. In questa sequenza di Morgane
indipendenti, che prima è stata podcast per StorieLibere e oggi esce come libro
per Mondadori, abbiamo voluto inserire ineditamente anche Asia Argento, che a
nove anni era già economicamente indipendente nel modo poco invidiabile in cui
lo sono le persone costrette a contare solo su se stesse. La speranza,
raccontando queste storie, è che qualunque donna possa un giorno rispondere,
davanti al consiglio di trovarsi un uomo ricco, con la famosa frase che Cher
disse a sua madre: non serve, mamma. L’uomo ricco sono io.
Vittorio Feltri, la
stoccata alle femministe italiane: "Si facciano un bel giro in Afghanistan..."
Vittorio Feltri su Libero Quotidiano il 03 settembre 2021. Nonostante anche io
sia stato giornalista e conosca i difetti della categoria, mi ostino a credere
in quello che essa scrive. Apprendo pertanto dalle mie letture fiduciose che
quei brutti ceffi di talebani si apprestano a varare a Kabul un governo
interamente formato da uomini. Le donne sono escluse dalle istituzioni e forse
pure dal consorzio civile. Niente scuola, niente università, vietatele
professioni. Gli orrendi maschi ultrafedeli di Allah hanno lunghi capelli e
lunghissime nonché foltissime barbe: quando ne vedo uno penso che abbia troppi
peli, troppi per un co***e solo. Non credo di sbagliarmi. Mentre sono certo che
si sbagliano le femmine (femministe) italiane e in genere quelle occidentali ad
accusare noi poveri tapini che le corteggiamo, e spesso purtroppo le sposiamo,
di trascurarle e di impedire loro di salire ai vertici delle gerarchie
professionali. Il maschilismo è l'insulto più ricorrente che ci colpisce, segue
il sessismo come se le pratiche erotiche interessassero noi, mentre è ovvio che
semmai le esercitiamo in coppia, normalmente costituita da un lui e da una lei.
Sorvolo sugli omosessuali perché voglio vivere in pace cioè senza passare per
omofobo, dato che in questo senso ho già pagato il fio. Consiglierei alle nostre
mogli di fare un salto in Afghanistan: sarebbe per loro un appassionante
viaggio studio finalizzato ad apprendere che l'Italia è un immenso gineceo dove
le signore sono considerate l'élite della società. In famiglia comandano loro,
ai mariti è consentito soltanto leggere la Gazzetta dello Sport. Sui posti di
lavoro si impongono poiché di norma sono più brave dei maschi, allorché una di
esse entra nel mio ufficio provvedo a spalancare la porta per rendere pubblico
l'incontro, si sa mai; se solo le stringi la mano è capace di denunciarti per
molestie. A me le donne ispirano solamente timore, una volta mi piacevano,
adesso che sono diventate aggressive preferisco i gatti che al massimo ti
graffiano ma non ti trascinano in tribunale. Ribadisco di detestare i talebani,
però un po' li invidio, non certo per l'abbigliamento bensì per il loro rapporto
con le fidanzate e generi affini.
La democrazia è delle
donne.
Donatella Di Cesare su L'Espresso il 25 agosto 2021. Fallita l’idea di esportare
un sistema neoliberale, resta la consapevolezza dei diritti. Quei punti nel
cielo, che compaiono sulla scia di un Boeing tracotante mentre precipitano
impietosamente nel vuoto, resteranno nella storia un’immagine tremenda e
indelebile. Non solo il simbolo di una fuga cinica e sconsiderata, ma anche il
sigillo di una rappresaglia ignominiosa, di una rivalsa caparbia che la grande
potenza ha cercato insistentemente per un ventennio. «America is back», aveva
dichiarato Joe Biden dopo l’inquietante periodo del trumpismo. Oggi si può dire
che quel «back» non sia altro che un «back home». L’America torna a casa
portando con sé un trofeo macabro a pochi giorni dall’anniversario dell’11
settembre, quando nel vuoto cadevano i corpi di coloro che erano rimasti
imprigionati nelle torri gemelle. Quel trauma profondo, che avrebbe dovuto
essere adeguatamente elaborato, provocò invece la overreaction, la risposta
militare americana. La caduta di Kabul getta un’inquietante luce retrospettiva
sulla «guerra al terrore», una singolare sfida a una tecnica di attentato,
spesso ridotta a una caccia a fantasmi, e una guerra che non era più tale, senza
nemici definiti, né fronti precisi, né tempi certi. Come una guerra al Male. Il
7 ottobre 2001, al momento dell’invasione dell’Afghanistan, Bush promise
un’interminabile azione riparatrice, secondo il motto della “guerra giusta”
teorizzata da Michael Walzer, che ebbe perciò l’altisonante nome in codice di
Infinite Justice, giustizia infinita, sostituito dal più mite Enduring Freedom,
libertà duratura, rimpiazzato in seguito da un paio di sigle burocratiche. Con
il pretesto del terrore fu allora dichiarato lo stato d’emergenza e venne
sospesa in modo eclatante la democrazia. Sarebbe una miope ingenuità credere che
la fuga da Kabul rappresenti l’ultimo fallimentare capitolo delle guerre
occidentali nel XXI secolo. Non è possibile prevederne ora le conseguenze. Ma
già la guerra in Iraq del 2003, che ha minato la credibilità degli Usa e
alimentato potentemente il complottismo per via di quelle «armi di distruzioni
di massa» mai trovate, mostra quali possono essere gli effetti. Contraddistinta
da menzogne e atrocità peggiori, la guerra in Afghanistan rischia di far
deflagrare l’Occidente stesso non solo sullo scacchiere geopolitico, ma anche e
soprattutto nei propri valori. Tutto si è disgregato in un soffio. D’un tratto
sembra vanificato il grande sogno della civilizzazione e della
democratizzazione. C’è chi parla di disfatta dell’Occidente. A parlare chiaro è
il bilancio delle cifre. Canta vittoria l’industria bellica. Ma il fallimento è
tutto di una politica che pochi, inascoltati, avevano già denunciato vent’anni
fa. Perché l’ipocrisia non ripaga e non si può contrabbandare a lungo di portare
agli altri la libertà quando non si vuole in effetti che proteggersi,
difendersi, cautelarsi da questi altri. Quel che, più nel male che nel bene, è
stato compiuto in Afghanistan, dai militari ma perfino dalle Ong, è inficiato da
quest’ambiguità di fondo. Dove finisce l’intervento umanitario e dove comincia
il controllo bellico-poliziesco? Se quei programmi, che apparivano così
promettenti e magnanimi, hanno avuto scarsa presa, come adesso sembra evidente,
è perché sotto sotto erano guidati dal criterio della nostra sicurezza e non
della loro democrazia. Quel che oggi emerge è la fragilità delle istituzioni
edificate, l’inconsistenza dello stato di diritto esportato a
forza. L’operazione «libertà duratura» avrebbe dovuto tradursi in una democrazia
costituzionale. Il castello di carta è crollato. A riprova che non si può
imporre la libertà e non si può esportare la democrazia. L’ossimoro non potrebbe
essere più palese. Fin qui ormai quasi tutti concordano. Ma l’esportazione della
democrazia è una questione ben più profonda e mette allo scoperto un dissidio
contemporaneo sul modo stesso di intendere la parola democrazia. Esce piegata da
questa sconfitta la concezione neoliberale che, mentre riduce la democrazia a un
sistema di governo, più ampio e tollerante di altri, la imbriglia alle redini
istituzionali e a una serie di regole e procedure. Si tratterebbe allora di
esportare semplicemente questa teoria politica insieme alle istituzioni
confacenti e a una competente capacità di amministrare. Se il trapianto non
riesce (come non è riuscito), si potrà sempre dire che è colpa degli altri:
della loro subcultura, degli usi retrivi, del loro medioevo. Senonché la
democrazia non è una manciata di istituzioni, non è un insieme di regole. A
uscire incrinata dalla sconfitta è questa concezione normativo-procedurale della
democrazia, buona per essere più o meno maldestramente esportata perché buona
già per la governance neoliberale che si limita ad amministrare l’economia. Ben
più che una costituzione, un sistema politico-giuridico, la democrazia è una
forma di vita. Non ne va solo della partecipazione dei cittadini, ma della loro
esistenza e coesistenza. Non può essere irrigidita e disciplinata perché ha un
fondo anarchico, come ricordano i teorici della democrazia radicale. Sarebbe
inconcepibile senza il paradigma dell’esodo, di una liberazione che si ripete
incessantemente. Una società democratica è il teatro di un’avventura non
dominabile. Perciò la democrazia è sempre stata guardata con sospetto, già da
Platone che denuncia lo scandalo di una politica dove gli schiavi sono
affrancati, gli stranieri diventano cittadini, le donne hanno la parità nel
rapporto con gli uomini. Si può intuire che il fondamentalismo veda nella
democrazia (e nel suo fondo anarchico) il suo più acerrimo nemico. Ma proprio
mentre su Kabul cala il velo dei talebani, c’è motivo per essere, malgrado
tutto, ancora ottimisti. Perché quelle donne afghane, che andavano a viso
scoperto, che frequentavano la scuola e all’università, che erano sempre più
sicure e orgogliose di sé, sono allo stesso tempo le vittime predestinate, ma
anche le possibili protagoniste di una resistenza. La democrazia non si è
dissolta in poche regole, è rimasta introiettata in loro, nel loro modo di
vivere, di pensare, di rapportarsi ad altri. Così come è rimasta in
quell’avanguardia di afghani che, anche per ciò, sono in questo momento più a
rischio. Al tradimento e all’abbandono che avvertono comprensibilmente si può
rispondere solo restando al loro fianco. Sarebbe questo il primo compito di
coloro a cui sta a cuore la democrazia. Il che si traduce in molti modi: nel
sostegno a chi deciderà di non lasciare il proprio paese e nell’accoglienza per
chi non ha altro scampo che andar via. La democrazia non ha frontiere. Nulla
apparirebbe oggi un crimine efferato come chiudere le porte ai rifugiati
afghani. Da tempo l’Occidente è diviso e questa è l’ora dell’Europa, che non è
una potenza come quelle emergenti, che non ha la forza economico-militare
americana. Ma è la patria dei diritti umani, un privilegio che altri non hanno e
un dovere in più. Perché i diritti umani sono il vessillo della democrazia.
Questo ulteriore tradimento sarebbe imperdonabile e sancirebbe davvero il nostro
tracollo.
Riccardo De Palo per "Il Messaggero" il 10 agosto
2021. «Sono molto onorata di essere la prima donna a ricevere questo
riconoscimento, e anche molto sorpresa», dice Alessandra Buonanno raggiunta
sulla strada per Cape Cod, Massachusetts, dalla notizia: la ricercatrice
italiana, direttrice del Max Planck Institute for Gravitational Physics di
Potsdam, ha ricevuto la medaglia Dirac, uno dei principali premi scientifici
internazionali. Da Cassino agli Stati Uniti, passando per la Germania e la
Francia: un grande successo per la scienziata nata nella città in provincia di
Frosinone nel 1968, dove ha frequentato il liceo prima di partire per
l'Università. E mentre la raggiungiamo al telefono negli Stati Uniti, piovono le
congratulazioni. «Un importante riconoscimento - ha affermato il premier, Mario
Draghi - che dà lustro al nostro Paese, nell'ambito della ricerca scientifica».
Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, twitta che «l'Italia si conferma un
punto di riferimento». La stessa Buonanno aveva ricevuto lo scorso febbraio
anche la Galileo Galilei Medal. E la responsabile dell'Università e della
Ricerca, Maria Cristina Messa, ha auspicato che la medaglia conferita
dall'International Centre for Theoretical Physics di Trieste sia «di sicura
ispirazione anche per le giovani ragazze che decideranno di intraprendere
percorsi di studio scientifici e tecnologici».
Cosa direbbe alle ragazze che sognano di seguire
le sue orme?
«Siate determinate, cercate di seguire i vostri
istinti, le vostre passioni. Questa è la cosa più importante. Sono contenta che
questo premio possa mandare un messaggio molto positivo ai giovani in generale e
ovviamente alle ragazze che vogliano intraprendere una carriera nella ricerca
scientifica. Spero di ispirare molte di loro».
Come donna ha incontrato difficoltà nella sua
carriera?
«Io non ho avuto esperienze in cui ho avuto
l'impressione di essere trattata in modo diverso. Bisogna eliminare barriere
sociali e culturali che impediscono alle donne di intraprendere la ricerca
scientifica».
Questo è anche un riconoscimento all'Italia?
«Sicuramente. Sono nata in Italia, e sono molto
grata a questo Paese: il corso di laurea e il dottorato li ho conseguiti
all'Università di Pisa. Poi all'inizio di gennaio del 1997 sono andata via, e
sono molto riconoscente nei confronti dei vari Paesi in cui ho lavorato: la
Francia, la Svizzera, la Germania, gli Stati Uniti. Tra l'altro io sono anche
cittadina americana».
È felice delle sue scelte?
«Sono molto contenta di avere fatto ricerca in
Paesi diversi: ci si arricchisce, si impara tanto. Sono un po' una cittadina del
mondo, ma ovviamente resto italiana».
Ci spiega per quale studio è stata premiata?
«Il premio è stato dato per varie ricerche
teoriche che hanno reso possibile la rilevazione delle onde gravitazionali (la
scoperta che ha permesso di confermare la teoria di Einstein, ndr) con i
progetti Ligo e Virgo».
Quando ha iniziato?
«Il mio lavoro è cominciato vent'anni fa, quando
ero ancora nel gruppo di lavoro di Thibault Damour, in Francia. Avevo tentato
una teoria che permette di semplificare il problema dei due corpi, ovvero un
sistema binario di buchi neri, come se fosse un corpo solo. Questo per poter
predire le forme d'onda in maniera più semplice».
Fu solo il primo passo, è così?
«Poi c'è stato il lavoro con Frans Pretorius e le
persone che lavorano in relatività numerica, per migliorare queste forme d'onda
e poterle usare per osservare le onde negli interferometri (ovvero macchinari
complessi che misurano le differenze d'onda, ndr) di Ligo e Virgo, ed estrarre
informazioni».
Questa ricerca ora continua?
«Sì, nel 2015 abbiamo scoperto le prima onda
gravitazionale generata dalla collisione di due buchi neri e adesso ne abbiamo
osservate altre cinquanta...».
Quindi la scoperta viene confermata continuamente?
«Certo, e gli strumenti sono migliorati nel tempo,
diventano più precisi, più sensibili. C'è tutto un programma per costruire nuovi
interferometri nel prossimo decennio».
Dove?
«Sulla Terra, in Europa, ci sarà l'Einstein
Telescope e negli Stati Uniti il Cosmic Explorer. Poi nello Spazio dal 2036
arriverà Lisa, il progetto dell'Esa, l'agenzia spaziale europea. E siamo solo
all'inizio».
E qual è il ruolo della ricerca italiana?
«Il ruolo italiano è stato importante, con
l'interferometro Virgo (che si trova vicino a Cascina, in provincia di Pisa,
ndr), anzitutto, che ha permesso di osservare la prima onda gravitazionale
proveniente da un buco nero e una stella di neutroni. C'è collaborazione tra i
due interferometri americani, di cui faccio parte, e Virgo».
Quale sarà il prossimo obiettivo della ricerca?
«Ovviamente le scoperte più interessanti sono
quelle che giungono inaspettate. Però nel campo delle onde gravitazionali, un
mese fa abbiamo pubblicato con Ligo e Virgo la scoperta di sistemi binari misti.
La cosa importante è capire come questi sistemi si formano, perché i buchi neri
hanno questa massa, perché si trovano in certe galassie...»
Riusciremo a capire cosa sia la cosiddetta materia
oscura?
«Le onde gravitazionali possono anche essere utili
per capire qualcosa della materia oscura e dell'energia oscura».
E cos'altro vorrebbe scoprire?
«In futuro forse la cosa più straordinaria sarà
vedere le onde gravitazionali emesse pochi istanti dopo il Big Bang. È una
scoperta che potrà avvenire soltanto nei prossimi decenni, perché ci vorranno
strumenti più sensibili di quelli che abbiamo adesso».
E come sarà possibile?
«Le onde gravitazionali permettono di poter
tornare indietro a quando l'Universo si è formato. E sono gli unici messaggeri
astronomici, come li chiamiamo noi, che possono fare questo. Le informazioni che
possiamo avere per esempio dai fotoni, con la radiazione cosmica primordiale,
sono informazioni che arrivano trecentomila anni dopo il Big Bang. Le onde
gravitazionali, invece, vengono emesse dopo una frazione piccolissima di
secondo. Sarebbe bellissimo rivelare, un giorno, il rumore proveniente
dall'Universo primordiale».
Sarebbe il primo suono emesso dall'Universo?
«Esatto, proprio così».
QUANTE MATA HARI?
Il vero volto di Mata Hari:
il ventre della spia.
Davide Bartoccini il 26 Luglio 2021 su Il Giornale. La leggenda
dell'enigmatica danzatrice olandese rivelò agli imperi quanto possa essere
pericolosa una donna in grado di tessere trame fantasiose e ben giocare gli
uomini in guerra. A un secolo dalla morte di una delle agenti segrete più famose
della storia, l’idealizzazione di Mata Hari, all'anagrafe Margaretha Geertruida
Zelle poi nota alle cronache come Lady Mac Leod, sembra essere riportata a
un'assai meno intrigante verità. Quella che pone ai nostri occhi affascinati una
donna avvenente, furba e affabulatrice, ma non abbastanza intelligente da
rassegnarsi ai propri limiti. Una cortigiana travolta dagli eventi e assetata di
avventura, che senza una reale capacità nel campo dello spionaggio, finì per
essere fucilata come spia doppiogiochista. Questo, senza aver servito veramente,
con convinzione o merito, nessuna delle due fazioni che richiesero i suoi
sinuosi e libertini servigi. Al termine della Guerra Fredda, gli operativi del
Kgb che albergavano a Berlino Est rivelarono paciosi che uno dei metodi più
collaudati ed efficaci per acquisire segreti dalla Nato era quello di infilare
nei letti di ufficiali e personalità con ruoli chiave "oltre cortina" delle
bellissime donne di facili costumi, sapientemente reclutate, alle quali, dopo
essersi abbandonati alle più sfrenate passioni, essi avrebbero potuto rivelare
informazioni importanti per l'avversario. Non era una tattica nuova, anzi, è la
più antica del mondo. E vide tra le più celebri dame coinvolte in questo gioco
pericoloso proprio l’esotica danzatrice Mata Hari. Nei dossier e rapporti
redatti dalla Direzione Generale della Polizia Giudiziaria, trasmessi
nell'aprile del 1917 al Governo militare di Parigi che avrebbe firmato di lì a
pochi mesi l’ordine d’arresto della stessa, ella veniva indicata come ballerina
di origine olandese - sebbene lei raccontasse d’essere nata a Giava e avere
“sangue indù nelle vene” - ; che prima di raggiungere il successo si era
dedicata con disinvoltura alle così dette “galanterie”, ossia alla prostituzione
d’alto bordo all’inizio del secolo scorso. Le demi-mondaines, parafrasando
Alexandre Dumas figlio, a causa della loro provenienza dal mondo di mezzo e dei
loro costumi equivoci, sono sempre state considerata le "spie" prediletta per
eccellenza. E Mata Hari era decisamente una demi-mondaine. Destinata a diventare
per un talento innato, cortigiana fatale e desiderio proibito di uomini ricchi e
potenti.
L'Occhio dell'Alba. Nata in
Frisia, nel nord dei Paesi Bassi, e omaggiata dal destino di una bellezza
conturbante e non comune fatta di colori che la distinguevano da tutte le altre
donne del cantone - un incarnato scuro, occhi scuri e profondi e lunghi capelli
neri -, Margaretha era stava svezzata nell'agio, ma si trovò presto a dover fare
i conti con l'indigenza dopo il tracollo finanziario della sua famiglia. Una
vita complicata, fatta di separazioni, lutti, parenti come tutori e continui
spostamenti da una città a un'altra, la portarono a rispondere a un annuncio
matrimoniale pubblicato sul giornale - come era costume al tempo - da un
ufficiale del Regio Esercito olandese: il capitano Rudolph Mac Leod. L'uomo si
era ritirato per convalescenza dai possedimenti olandesi nelle Indie Orientali.
Solo al termine della convalescenza di suo marito la giovane olandese avrebbe
scoperto le esotiche terre oltre mare. Dirà di averle viaggiate in lungo e in
largo, di essere entrata di nascosto "a rischio della vita", nei templi segreti
dell'India dove avrebbe assistito alle esibizioni mistiche di danzatrici sacre
davanti ai simulacri di Shiva, Viṣṇu, della dea Kālī; di aver frequentato e
amato maharaja e di aver cacciato tigri delle quali portava la rara e preziosa
pelliccia indosso negli alberghi di lusso delle maggiori capitali europee. Ma la
realtà è che prima della rottura con suo marito, accentuata dalla perdita di un
figlio morto avvelenato a pochi anni di vita, Magaretha aveva vissuto come
moglie di un ufficiale subalterno in villaggi piccoli e mal collegati
dell'Indonesia, a quel tempo dominio coloniale olandese.
Il primo tentativo di rifarsi
una vita a Parigi, posando come modella di pittori poco noti, fallisce
miseramente. Torna in Olanda dallo zio che l'aveva accolta, me già 1904, fa
ritorno nella ville lumiere dove il suo nuovo amante, il barone Henri de
Marguérie, la mantiene al Grand Hotel. È in questo periodo che la danza
giavanese nella quale è solita esibirsi, fa colpo su monsieur Guimet,
industriale e collezionista di oggetti d'arte orientali che ne resta
profondamente affascinato. Entusiasta di quelle danze che lei racconta di aver
appreso dalle sacerdotesse del dio Shiva, la fa esibire nel museo. E poi la farà
esibire nei salotti dei potenti che vogliono essere a-la-page , mostrando questa
sinuosa ballerina che mimando un approccio amoroso verso la divinità occulta,
finisce per spogliarsi, un velo dopo l'altro, per rimanere in un audace nudità
coperta da pochi gioielli appositamente disegnati per lei. Diviene nota alle
cronache come lady Mac Leod, ma la sua fama di "danzatrice venuta dall’Oriente"
che dovrà esibirsi dei maggiori teatri d'Europa necessita di un nome più
esotico, che richiami davvero le origini ancestrali che la danzatrice millanta
di possedere. Giimet decide che il suo nome sarà Mata Hari, che significa
"Occhio dell'Alba" in malese. E resterà quello, anche quando lei cercherà di
reinventarsi dopo essersi recata in Spagna, narrando di un'infanzia andalusa e
di un torero con per un suo rifiuto si era lasciato uccidere da un toro restando
immobbile di fronte alla feroce carica. Il success, ottenuto grazie
all'esibizione progrettata da Guimet, e grazie all'interessamento
di monsieur Molier, diverrà presto internazionale. Sul Times si riferiscono a
lei come "..un'avvenenza che sconfina nell'incredibile, con una figura dal
fascino strano e dalle movenze di una belva divina che si conduca in una foresta
incantata”. Nel frattempo lei continua a esibirsi nei salotti di finanzieri e
aristocratici, cambiando numerosi amanti. Dopo aver frequentato il banchiere
parigino Félix Rousseau, si trasferisce per un lasso di tempo a Berlino, dove si
lega ad Hans Kiepert, un facoltoso junker prussiano. Ma gli animi revanscisti,
che trovano nell'assassinio dell'arciduca una ragione in più per far scoppiare
una guerra, vedranno la cortigiana danzatrice che null'altro voleva se non
vivere un'eternità scandita dagli agi e dai fasti che fatto la Belle Epoque,
travolta da un conflitto che la sorprende in Svizzera. Mata Hari vuole tornare a
Parigi, e dopo una breve tappa in Olanda, finanziata dall'ennesimo petit ami,
riesce a farvi ritorno. Ma non prima d'essere stata avvicinata da una vecchia
conoscenza: il console tedesco Alfred von Kremer.
Agente H21, al servizio del
Kaeiser. Durante un incontro avvenuto all'Aja, il console propone a Mata Hari
di diventare una spia al servizio del Kaiser. In cambio le offre un'ingente
quantità di denaro, che lei accetta con la stessa disinvoltura di una bambina
che sembra entusiasta di partecipare a un nuovo gioco. Quella bambina però, sta
per compiere 39 anni. Dopo aver ricevuto un breve addestramento alle pratiche
dello spionaggio presso il Centro di Anversa, gestito dalla nota Fraulein
Doktor, Elsbeth Schragmueller, viene inviata in Spagna e poi a Parigi. Il suo
identificativo in codice, che inizialmente è H21, viene cambiato in AF44. Il
primo incarico sarà quello di trovare il modo di fornire informazioni
sull'aeroporto di Contrexeville, situato nei pressi di Vittel in Francia.
L'escamotage sarà quello di far visita a uno dei suoi giovani amanti - forse il
suo unico vero amore tra le decine di ufficiali ai quali ha concesso le sue
grazie - il capitano russo Vadim Masslov. Nel frattempo Mata Hari, alloggerà al
Grand Hotel e, come da consuetudine, farà conoscenza con ufficiali dei diversi
eserciti alleati dell'Intesa. Ignorando di essere già sorvegliata dallo
spionaggio inglese e dal controspionaggio francese. Che già sospettavano di lei
in quanto demi-mondaine che si era sempre professata amica dei potenti di mezza
Europa. E ora che tutta l'Europa era in guerra, il rischio o il vantaggio di
rivelare un segreto giusto o sbagliato a l'una o l'altra fazione era dietro
l'angolo. Con se portava due boccette di inchiostro simpatico fornitegli dai
servizi segreti tedeschi: nessuna arma al di fuori della sua fama di seduttrice
mangiauomini.
Ingenua, tradita e colpevole.
Benché estremamente furba, intraprendente, poliglotta, e affascinante, Mata Hari
non si rivela essere una spia all’altezza delle aspettative. Non ha la stoffa,
la perspicacia, e l'arguzia di un agente segreto. È solo una donna fragile,
quasi apolide, che ama la bella vita più della vita stessa, e che pur di
continuare a godere dei piaceri che essa può darle, finisce col promettere a un
politico straniero di fornirgli le informazioni che desidera, sfruttando le
confidenze dei suoi amanti. La stessa cosa che promette - sempre in cambio di
denaro, non certo per amor di patria - agli ufficiali del Deuxième Bureau, il
servizio segreto militare francese. Le informazioni che fornisce al console von
Kalle e al colonnello Joseph Denvignes si rivelano ininfluenti, e soprattutto
ben distanti dalle generose somme di denaro che la danzatrice chiede in cambio
del suo pericoloso gioco. Quando il console tedesco capisce che Mata Hari è
una doppiogiochista, forse su ordine del centro informativo tedesco di Colonia,
decide di bruciare la sua copertura inviando un messaggio cifrato ma adoperando
un codice vecchio, che sa essere stato decifrato dai servizi segreti francesi.
Nel messaggio ne rivela l'identità. E questo viene prontamente intercettato
dalla centrale del controspionaggio sistemata sulla Tour Eiffel per captare le
frequenze su onde lunghe, dove nel 1917 transitano anche i messaggi cifrati. Per
essersi resa colpevole dei crimini di "espionnage, tentative, complicité,
intelligences avec l'ennemi", Mata Hari, già da tempo sorvegliata a vista,
viene arrestata dalla polizia francese nella sua camera d'albergo, la 131 del
Palace Hotel, al numero 103 degli Champs Elisées, il 12 febbraio del 1917.
Benché le prove non siano abbastanza consistenti, e non sia trovato alcun
documento o messaggio scritto con l'inchiostro simpatico che lei non sapeva
usare, confesserà di essere stata reclutata anche dai tedeschi come spia. Forse
non immaginando nemmeno che, dopo numerosi fallimenti nella campagna militare
condotta dall'esercito francese e con un governo in difficoltà di fronte a un
popolo affamato e stremato, il crimine di spionaggio l'avrebbe vista senza
dubbio come condannata a morte. L'esecuzione di una spia come lei, inoltre,
avrebbe senza dubbio riscosso il piacere della vendetta che sovente viene
invocato dalla vorace opinione pubblica. Negatale la grazia, Mata Hari, al
secolo scorso Margaretha Geertruida Zelle, sconterà parte della sua prigionia
nel carcere di Saint-Lazare, prima di essere condannata a morte per fucilazione
il 15 ottobre del 1917. Per comparire di fronte al plotone d'esecuzione
schierato presso il campo di tiro di Vincennes, Margaretha sceglie un abito
grigio perla. Rifiuterà la benda, per guardare la morte in faccia.
Coraggiosamente. Degli 11 colpi sparati all'ordine del fuoco, solo tre la
colpiscono. Uno dritto al cuore. Il suo corpo, rimasto irreclamato, viene
sepolto in una fossa comune. Delle tre lettere scritte prima della condanna, una
indirizzata alla figlia Jeanne Louise, una al suo unico amore, il capitano
Masslov, che l'aveva archiviata pubblicamente come "una semplice avventura",
l'ultima all'ambasciatore d'Olanda, Cambon, nessuna verrà recapitata. Chi
leggerà quegli addii, come le altre memorie custodite nei dossier che sono
rimasti secretati fino al 2017, descriverà una donna ingenua e tradita, che
forse si era lasciata trascinare in un gioco molto più grande di lei. Ma Mata
Hari in fondo era solo un'attraente e misteriosa ballerina di una danza
fantasiosa, che temeva di perdere il suo fascino come tante dive quando
invecchiano. Una donna con un passato difficile, alla ricerca della
sofisticatezza che appartiene alle regine. Che adorava inventare storie
appassionanti solo per rendersi ancora più desiderabile agli occhi di chiunque
l'avesse accompagnata fino alla nuova alba. Forse un complesso diffuso
dell'esistenza. Di certo nel suo caso, un lasciapassare per restare nella
storia.
Davide Bartoccini. Romano,
classe '87, sono appassionato di storia fin dalla tenera età. Ma sebbene io viva
nel passato, scrivo tutti giorni per ilGiornale.it e InsideOver, dove mi occupo
di analisi militari, notizie dall’estero e pensieri politicamente scorretti. Ho
collaborato con il Foglio e sto lavorando a un romanzo che credo sentirete
nominare.
Mata Hari.
Da Wikipedia. Mata Hari, pseudonimo di Margaretha Geertruida
Zelle (Leeuwarden, 7 agosto 1876 – Vincennes, 15 ottobre 1917), è stata
una danzatrice e agente segreto olandese, condannata alla pena capitale per la
sua attività di spionaggio durante la prima guerra mondiale. Era figlia di Adam
Zelle (1840-1910) e di Antje van der Meulen (1842-1891), ed ebbe tre fratelli,
il maggiore, Johannes (1878), e due fratelli gemelli, Arie Anne e Cornelius
(1881-1956). Il padre aveva un negozio di cappelli, era proprietario di un
mulino e di una fattoria. La sua famiglia poteva permettersi di vivere molto
agiatamente in un antico e bel palazzo sulla Grote Kerkstraat, nel centro della
città. Margaretha, che in gioventù frequentò una scuola prestigiosa, aveva una
carnagione scura e i capelli e gli occhi neri, caratteristiche fisiche che la
differenziavano notevolmente dai suoi connazionali olandesi. Nel 1889 gli affari
del padre incominciarono ad andar male tanto da costringerlo a cedere la sua
attività commerciale. Il dissesto economico provocò dissapori nella famiglia che
portarono, il 4 settembre 1890, alla separazione dei coniugi e al trasferimento
del padre ad Amsterdam. La madre morì l'anno dopo e Margaretha venne allevata
nella cittadina di Sneek dal padrino, il quale scelse di farla studiare da
maestra d'asilo in una scuola di Leida. Sembra che le eccessive attenzioni, se
non proprio molestie, del direttore della scuola, avessero spinto il suo padrino
a toglierla dalla scuola, mandandola da uno zio che viveva a L'Aia.
Nel 1895 Margaretha rispose all'inserzione matrimoniale di un ufficiale, il
capitano Rudolph Mac Leod (1856-1928), che viveva ad Amsterdam, in licenza di
convalescenza dalle colonie d'Indonesia poiché soffriva di diabete e
di reumatismi. L'11 luglio 1896, ottenuto anche il consenso paterno, Margaretha
sposò il capitano Mac Leod: il padre, divenuto nel frattempo viaggiatore di
commercio, partecipò alla cerimonia nuziale in municipio, ma non fu invitato al
pranzo di nozze. Dopo il viaggio di nozze a Wiesbaden, la coppia si stabilì ad
Amsterdam, nella casa di Louise, la sorella di Rudolph.
Il 30 gennaio 1897 nacque a
Margaretha un figlio, cui fu dato il nome del nonno paterno, Norman John. In
maggio la famiglia s'imbarcò per Giava, dove il capitano riprese servizio nel
villaggio di Ambarawa, nel centro della grande isola. L'anno dopo si
trasferirono a Teompoeng, vicino a Malang, dove il 2 maggio 1898 nacque Jeanne
Louise († 1919), chiamata col vezzeggiativo Non, dal malese nonah (piccola). La
vita familiare non fu serena: vi furono litigi tra i coniugi, sia per la durezza
della vita in villaggi che non conoscevano gli agi delle moderne città europee
dell'epoca, sia per la gelosia del marito e la sua tendenza ad abusare
dell'alcol. L'anno seguente il marito fu promosso maggiore e comandante della
piazza di Medan, sulla costa orientale di Sumatra. Come moglie del comandante,
Margaretha ebbe il compito di fare gli onori di casa agli altri ufficiali che,
con le loro famiglie, frequentavano il loro alloggio, e conobbe i notabili del
luogo. Uno di questi la fece assistere per la prima volta a una danza locale,
all'interno di un tempio, che l'affascinò per la novità esotica delle musiche e
delle movenze, che ella provò anche a imitare. La famiglia venne sconvolta dalla
tragedia della morte del piccolo Norman, che il 27 giugno 1899 morì avvelenato.
La causa della morte fu una medicina somministrata dalla domestica indigena ai
figli della coppia, ma non si hanno prove che costei avesse voluto uccidere i
bambini; si sospetta però che ella, moglie di un subalterno del maggiore Mac
Leod, fosse stata spinta dal marito a vendicarsi del superiore, che gli aveva
inflitto una punizione. Rudolph, Margaretha e la piccola Non, per sottrarsi a un
luogo di tristi ricordi, ottennero di trasferirsi a Banjoe Biroe, nell'isola di
Giava, dove Margaretha si ammalò di tifo. Il maggiore Mac Leod, raggiunta la
maturazione della pensione, il 2 ottobre 1900 diede le dimissioni dall'esercito:
dopo poco più di un anno passato ancora a Giava, nel villaggio di Sindanglaja,
cedendo forse alle richieste della moglie, riportò, agli inizi del 1902, la
famiglia in Olanda.
Sbarcati il 2 marzo 1902, i
due coniugi tornarono per breve tempo a vivere nella casa di Louise Mac Leod,
poi per loro conto in un appartamento di van Breestraat 188: lasciata dal
marito, che portò con sé la figlia, Margaretha chiese la separazione, che le
venne accordata il 30 agosto, insieme con l'affidamento della piccola Non e il
diritto agli alimenti. Dopo una successiva, breve riconciliazione, Margaretha e
il marito si separarono definitivamente; questa volta fu il padre a ottenere la
custodia della bambina, mentre Margaretha si stabilì dallo zio a L'Aja. Decisa a
tentare l'avventura della grande città, nel marzo del 1903 Margaretha andò
a Parigi, dove pure non conosceva nessuno: cercò di mantenersi facendo la
modella presso un pittore e cercando scritture nei teatri ma con risultati
alquanto deludenti. Forse giunse anche a prostituirsi per sopravvivere, nella
vana attesa del successo. Il fallimento dei suoi tentativi la convinse a
riparare in Olanda ma l'anno seguente, il 24 marzo 1904, tornò nuovamente a
Parigi e prese alloggio al Grand Hotel, divenendo l'amante del barone Henri de
Marguérie. Presentatasi dal signor Molier, proprietario di un'importante scuola
di equitazione e di un circo, Margaretha, che in effetti aveva imparato a
cavalcare a Giava, si offrì di lavorare e poiché un'amazzone può essere
un'attrazione, fu accettata. Ebbe successo e una sera si esibì durante una festa
in casa del Molier in una danza giavanese, o qualcosa che sembrava somigliarle:
Molier rimase entusiasta di lei. La sua danza era, a suo dire, quella delle
sacerdotesse del dio orientale Shiva, che mimavano un approccio amoroso verso la
divinità, fino spogliarsi, un velo dopo l'altro, del tutto, o
quasi. Trasferitasi in un più modesto alloggio, una pensione presso
gli Champs-Élysées, sempre a spese del Marguérite, il suo vero esordio avvenne
nel febbraio 1905, in casa della cantante Kiréevsky, che usava invitare i suoi
ricchi amici e conoscenti a spettacoli di beneficenza. Il successo fu tale che i
giornali arrivano a parlarne: lady Mac Leod, come ora si faceva chiamare,
replicò il successo in altre esibizioni, ancora tenute in case private, dove più
facilmente poteva togliersi i veli del suo costume, e la sua fama di «danzatrice
venuta dall'Oriente» incominciò a estendersi per tutta Parigi. Notata da
monsieur Guimet, industriale e collezionista di oggetti d'arte orientale,
ricevette da questi la proposta di esibirsi in place de Jéna, nel museo, dove
egli custodiva i suoi preziosi reperti, come un animato gioiello orientale. Fu
però necessario cambiare il suo nome, troppo borghese ed europeo: così Guimet
scelse il nome, d'origine malese, di Mata Hari, letteralmente «Occhio dell'Alba»
e quindi "Sole". L'esibizione di Mata Hari nel museo Guimet ebbe luogo il 13
marzo. Mata Hari alternò le esibizioni, tenute nelle case esclusive di
aristocratici e finanzieri, agli spettacoli nei locali prestigiosi di Parigi:
il Moulin Rouge, il Trocadéro, il Café des Nations. Il successo provocò
naturalmente una curiosità cui ella non poté sottrarsi e dovette far collimare
l'immagine privata con quella pubblica: «Sono nata a Giava e vi ho vissuto per
anni» - raccontò ai giornalisti, mescolando poche verità e molte menzogne -
«sono entrata, a rischio della vita, nei templi segreti dell'India [ ... ] ho
assistito alle esibizioni delle danzatrici sacre davanti ai simulacri più
esclusivi di Shiva, Visnù e della dea Kalì [ ... ] persino i sacerdoti fanatici
che sorvegliano l'ara d'oro, sacra al più terribile degli dei, mi hanno creduto
una bajadera del tempio [ ... ] la vendetta dei sacerdoti buddisti per chi
profana i riti [ ... ] è terribile [ ... ] conosco bene il Gange, Benares, ho
sangue indù nelle vene».
Consacrata, il 18 agosto 1905,
dopo l'esibizione al teatro dell'Olympia, come la «donna che è lei stessa
danza», «artista sublime», e come colei che «riesce a dare il senso più profondo
e struggente dell'anima indiana», Mata Hari si trovò a essere desiderata tanto
dai maggiori teatri europei quanto, come moglie, da ricchi e nobili pretendenti.
La sua tournée in Spagna, nel gennaio 1906, fu un trionfo: venendo incontro alla
fantasia, ingenua e torbida, costruita su realtà di paesi del tutto sconosciuti,
Mata Hari offriva agli spettatori quanto essi si attendevano dalla sua danza: il
fascino proibito dell'erotismo e la purezza dell'ascesi, in un
assurdo sincretismo in cui la mite saggezza di un Buddha veniva parificata ai
riti sanguinari - per quanto inesistenti - di terribili dee indù.
D'altra parte, pare che ella
avesse un certo talento se è vero che la sua esibizione nel balletto musicato
da Jules Massenet, Le roi de Lahore, all'Opéra di Monaco ottenne, il 17
febbraio, un grande successo e lei venne salutata come «danzatrice unica e
sublime» mentre il musicista francese, e anche Giacomo Puccini, si dichiararono
suoi ammiratori. Il 26 aprile 1906 fu sancito ufficialmente il divorzio di
Margaretha Zelle dal McLeod. Da Monaco si recò a Berlino, dove si legò a un
ricco ufficiale, Hans Kiepert, che l'accompagnò a Vienna e poi a Londra e
in Egitto. Furono intanto pubblicate due sue biografie, una scritta dal padre,
che esalta la figlia più che altro per esaltare sé stesso, inventandosi
parentele con re e principi, e quella, di opposte intenzioni, di George Priem,
avvocato del suo ex-marito. Mata-Hari, naturalmente, confermò la versione del
padre: l'ex-cappellaio era un nobile ufficiale, mentre sua nonna era una
principessa giavanese; quanto a lei, aveva viaggiato in tutti i continenti e
aveva vissuto a lungo a Nuova Delhi, dove aveva frequentato maharaja e
abbattuto tigri, come dimostra la pelliccia che indossava - in realtà acquistata
in un negozio di Alessandria d'Egitto. Il successo provocò anche imitazioni ma
nessuna delle sue epigoni raggiunse mai la sua fama. Il suo nome fu accostato a
quello delle maggiori vedettes del passato, come Lola Montez, e del tempo,
come la Bella Otero, Cléo de Mérode e Isadora Duncan. Il 7 gennaio 1910 riscosse
a Montecarlo nuove acclamazioni con la sua Danse du feu che non replicò
all'Olympia di Parigi solo perché le sue pretese economiche furono eccessive. Il
successo fece crescere enormemente le spese necessarie a sostenere una
incessante vita mondana che conobbe solo una breve tregua quando, nell'estate,
si trasferì in un castello a Esvres, non lontano da Tours, che il suo nuovo
amante, il banchiere Félix Rousseau, affittò e le mise a disposizione e dove
rimase circa un anno, quando, a causa dei problemi finanziari della banca
Rousseau, il suo Félix affittò per lei un appartamento carino, ma meno costoso,
a Neuilly, uno dei sobborghi di Parigi. Alla fine del 1911 raggiunse il vertice
del riconoscimento artistico partecipando, al Teatro alla Scala di Milano, prima
alla rappresentazione dell'Armida di Gluck, tratta dalla Gerusalemme
liberata del Tasso, recitando la parte del Piacere e poi, dal 4 gennaio 1912,
dando cinque rappresentazioni del Bacco e Gambrinus, un balletto di Giovanni
Pratesi musicato da Romualdo Marenco, dove interpretò il ruolo di Venere. Il
direttore dell'orchestra, Tullio Serafin, dichiarò che Mata Hari « [...] è una
donna eccezionale, dall'eleganza perfetta e con un senso poetico innato;
inoltre, sa ciò che vuole e sa come ottenerlo. Ella così fa della propria danza
una sicura opera d'arte». In realtà, il Teatro milanese stava attraversando un
periodo di decadenza e i tentativi, fatti in quell'occasione da Mata Hari, di
ottenere collaborazione da musicisti come Umberto Giordano e Pietro Mascagni,
andarono a vuoto, come inutile fu anche il tentativo di esibirsi con i ballerini
russi della compagnia di Djagilev. Mata Hari si consolò allora con le Folies
Bergères dove, mettendo per un momento da parte la danza orientale, si trasformò
in gitana e, nell'estate del 1913, andò in tournée in Italia, esibendosi a Roma,
a Napoli e a Palermo. C'è un motivo, raccontava, per cui ella conosceva così
bene i balli spagnoli: giovanissima, aveva sposato un nobile scozzese, con il
quale aveva vissuto in un antico castello; dopo il fallimento del suo
matrimonio, aveva viaggiato molto e a lungo in Spagna, dove un torero,
innamorato di lei, si era fatto uccidere nell'arena, disperato per non essere
stato corrisposto. Nel 1914 si spostò a Berlino, per preparare un nuovo
spettacolo nel quale intendeva interpretare una danza egiziana: nella sua stanza
dell'albergo Cumberland, scrisse lei stessa il libretto del balletto, che
intitolò La chimera; nel frattempo prevedeva di esordire in settembre al Teatro
Metropole in un altro spettacolo. Ma quello spettacolo non ebbe mai luogo: con
l'assassinio del principe ereditario austriaco finì la Belle Epoque ed ebbe
inizio la prima guerra mondiale.
Mentre l'esercito tedesco
invadeva il Belgio per svolgere quell'operazione a tenaglia che, con
l'accerchiamento delle forze armate francesi, avrebbe dovuto concludere
rapidamente la guerra, Mata Hari era già partita per la Svizzera, da dove
contava di rientrare in Francia; tuttavia, mentre i suoi bagagli proseguirono il
viaggio verso la terra francese, lei venne trattenuta alla frontiera e rimandata
a Berlino. Nell'albergo ove fece ritorno, senza bagaglio e denaro, un
industriale olandese, tale Jon Kellermann, le offrì il denaro per il viaggio,
consigliandole di andare a Francoforte e di qui, tramite il consolato, passare
la frontiera olandese. Così, il 14 agosto 1914, il funzionario del consolato
olandese rilasciò a Margaretha Geertuida Zelle, «alta un metro e
settantacinque», di capelli, in quell'occasione, biondi, il visto per
raggiungere Amsterdam. Qui divenne l'amante del banchiere van der Schalk e poi,
dopo il trasferimento a L'Aja, del barone Eduard Willem van der Capellen,
colonnello degli ussari, che la soccorse generosamente nelle sue non poche
necessità finanziarie. Il 24 dicembre 1915 Mata Hari tornò a Parigi, per
recuperare il suo bagaglio e tentare, nuovamente invano, di ottenere una
scrittura da Djagilev. Ebbe appena il tempo di divenire amante del maggiore
belga Fernand Beaufort che, alla scadenza del permesso di soggiorno, il 4
gennaio 1916, dovette fare ritorno in Olanda. Furono frequenti le visite nella
sua casa de L'Aja del console tedesco Alfred von Kremer, che proprio in questo
periodo l'avrebbe assoldata come spia al servizio della Germania, incaricandola
di fornire informazioni sull'aeroporto di Contrexéville, presso Vittel, in
Francia, dove ella poteva recarsi col pretesto di far visita al suo ennesimo
amante, il capitano russo Vadim Masslov, ricoverato nell'ospedale di quella
città. Mata Hari, divenuta agente H21, fu istruita in Germania dalla famosa
spia Fräulein Doktor, che la immatricolò con il nuovo codice AF44. La ballerina
era già sorvegliata dal controspionaggio inglese e francese quando, il 24
maggio 1916, partì per la Spagna e di qui, il 14 giugno, per Parigi dove,
tramite un ex-amante, il tenente di cavalleria Jean Hallaure, che era anche,
senza che lei lo sapesse, un agente francese, il 10 agosto si mise in contatto
con il capitano Georges Ladoux, capo di una sezione del Deuxième Bureau, il
controspionaggio francese, per ottenere il permesso di recarsi a Vittel. Ladoux
le concesse il visto e le propose di entrare al servizio della Francia, proposta
che Mata Hari accettò, chiedendo l'enorme cifra di un milione di franchi,
giustificata dalle conoscenze importanti che ella vantava e che sarebbero potute
tornare utili alla causa francese.
A Vittel incontrò il capitano
russo, fece vita mondana con i tanti ufficiali francesi che frequentavano la
stazione termale e dopo due settimane tornò a Parigi. Qui, oltre a inviare
informazioni sulla sua missione agli agenti tedeschi in Olanda e in Germania,
ricevette anche istruzioni dal capitano Ladoux di tornare in Olanda via Spagna.
Dopo essersi trattenuta alcuni giorni a Madrid, sempre sorvegliata dai francesi
e dagli inglesi, a novembre s'imbarcò da Vigo per L'Aia. Durante la sosta della
nave a Falmouth, nel Regno Unito, fu arrestata perché scambiata con una
ballerina di flamenco, Clara Benedix, sospetta spia tedesca. Interrogata
a Londra e chiarito l'equivoco, dopo accordi presi con Ladoux, Scotland Yard la
respinse in Spagna, dove sbarcò l'11 dicembre 1916. A Madrid continuò il doppio
gioco, mantenendosi in contatto sia con l'addetto militare all'ambasciata
tedesca, Arnold von Kalle, sia con quello dell'ambasciata francese, il
colonnello Joseph Denvignes, al quale riferì di manovre dei sottomarini tedeschi
al largo delle coste del Marocco. Il von Kalle comprese che Mata Hari stava
facendo il doppio gioco e telegrafò a Berlino che «l'agente H21» chiedeva denaro
ed era in attesa di istruzioni: la risposta fu che l'agente H21 doveva rientrare
in Francia per continuare le sue missioni e ricevervi 15.000 franchi. L'ipotesi
che i tedeschi avessero deciso di disfarsi di Mata Hari - rivelandola al
controspionaggio francese come spia tedesca - poggia sull'utilizzo, da loro
fatto in quell'occasione, di un vecchio codice di trasmissione, già abbandonato
perché decifrato dai francesi, nel quale Mata Hari veniva ancora identificata
con la sigla H21. In tal modo, i messaggi tedeschi furono facilmente decifrati
dalla centrale parigina di ascolto radio della Tour Eiffel. Il 2
gennaio 1917 Mata Hari rientrò a Parigi e la mattina del 13 febbraio venne
arrestata nella sua camera dell'albergo Elysée Palace e rinchiusa nel carcere di
Saint-Lazare.
Di fronte al titolare
dell'inchiesta, il capitano Pierre Bouchardon, Mata Hari adottò inizialmente la
tattica di negare ogni cosa, dichiarandosi totalmente estranea a ogni vicenda di
spionaggio. Fu assistita, nel primo interrogatorio, dall'avvocato Édouard
Clunet, suo vecchio amante, che aveva mantenuto con lei un affettuoso rapporto e
che poté essere presente, secondo regolamento, ancora solo nell'ultima
deposizione. Poi, con il passare dei giorni, Mata Hari non poté evitare di
giustificare le somme - considerate dall'accusa il prezzo del suo spionaggio
-che il van der Capelen, suo amante, le inviava dall'Olanda, di ammettere le
somme ricevute a Madrid dal von Kalle, giustificandole come semplici regali, e
di rivelare anche un particolare inedito: l'offerta ricevuta in Spagna di
ingaggiarsi come agente dello spionaggio russo in Austria. Riferì anche della
proposta fattale dal capitano Ladoux di lavorare per la Francia, una proposta
che cercò di sfruttare a suo vantaggio, come dimostrazione della propria lealtà
nei confronti della Francia. L'accusa non aveva, fino a questo momento, alcuna
prova concreta contro Mata Hari, la quale poteva anzi vantare di essersi messa a
disposizione dello spionaggio francese. Il fatto è che il controspionaggio non
aveva ancora messo a disposizione del capitano Bouchardon le trascrizioni dei
messaggi tedeschi intercettati che la indicavano come l'agente tedesco H21.
Quando lo fece, due mesi dopo, Mata Hari dovette ammettere di essere stata
ingaggiata dai tedeschi, di aver ricevuto inchiostro simpatico per comunicare le
sue informazioni, ma di non averlo mai usato - avrebbe gettato tutto in mare - e
di non avere trasmesso nulla ai tedeschi, malgrado 20.000 franchi ricevuti dal
console von Kramer, che ella, sostenne, considerò solo un risarcimento per i
disagi patiti durante la sua permanenza in Germania nei primi giorni di guerra.
Quanto al messaggio di von Kalle a Berlino, che la rivelava come spia, Mata Hari
lo considerò la vendetta di un uomo respinto. I tanti ufficiali francesi dei
quali fu amante, interrogati, la difesero, dichiarando di non averla mai
considerata una spia. Al contrario, il capitano Georges Ladoux negò di averle
mai proposto di lavorare per il servizi francesi, avendola sempre considerata
una spia tedesca, mentre l'addetto militare a Madrid, l'anziano Denvignes,
sostenne di essere stato corteggiato da lei allo scopo di carpirgli segreti
militari; quanto alle informazioni sulle attività tedesche in Marocco, egli negò
che fosse stata Mata Hari a fornirle. Entrambi gli ufficiali non seppero citare
alcuna circostanza sostanziale contro Mata Hari, ma le loro testimonianze, nel
processo, ebbero un peso determinante. L'inchiesta si chiuse con un colpo a
effetto: l'ufficiale russo Masslov, del quale Mata Hari sarebbe stata
innamorata, scrisse di aver sempre considerato la relazione con la donna
soltanto un'avventura. La rivelazione non aveva nulla a che fare con la
posizione giudiziaria di Mata Hari, ma certo acuì in lei la sensazione di
trovarsi in un drammatico isolamento. L'inchiesta venne chiusa il 21 giugno con
il rinvio a giudizio di Mata Hari. Il processo, tenuto a porte chiuse, ebbe
inizio il 24 luglio: a presiedere la Corte di sei giudici militari fu il tenente
colonnello Albert Ernest Somprou; a sostenere l'accusa il tenente Mornet. Nulla
di nuovo emerse nei due giorni di dibattimento: dopo l'appassionata perorazione
del difensore Clunet, vecchio combattente e decorato, nel 1870, nella Guerra
Franco-Prussiana, i giudici si ritirarono per rispondere a 8 domande:
se nel dicembre 1915
Margaretha Zelle avesse cercato di ottenere informazioni riservate nella zona
militare di Parigi a favore di una potenza nemica;
se si fosse procurata
informazioni riservate al console tedesco in Olanda von Kramer;
se nel maggio 1916 avesse
avuto rapporti in Olanda con il console von Kramer;
se nel giugno 1916 avesse
cercato di ottenere informazioni nella zona militare di Parigi;
se avesse cercato di favorire
le operazioni militari della Germania;
se nel dicembre 1916 avesse
avuto contatti a Madrid con l'addetto militare tedesco von Kalle allo scopo di
fornirgli informazioni riservate;
se avesse rivelato al von
Kalle il nome di un agente segreto inglese e la scoperta, da parte francese, di
un tipo di inchiostro simpatico tedesco;
se nel gennaio 1917 avesse
avuto rapporti con il nemico nella zona militare di Parigi.
Dopo meno di un'ora venne
emessa la sentenza secondo la quale l'imputata era colpevole di tutte le otto
accuse mossele: «In nome del popolo francese, il Consiglio condanna
all'unanimità la suddetta Zelle Marguerite Gertrude alla pena di morte [...] e
la condanna inoltre al pagamento delle spese processuali» Quanto all'unanimità
dei giudici, questa valeva per la sentenza ma non per ogni capo d'imputazione,
per alcuni dei quali il verdetto di colpevolezza non trovò l'unanimità.
L'istanza di riesame del
processo venne respinta dal Consiglio di revisione il 17 agosto e il 27
settembre anche la Corte d'Appello confermò la sentenza di condanna. L'ultima
speranza era rappresentata dalla domanda di grazia che l'avvocato Clunet
presentò personalmente al Presidente della Repubblica Poincaré. Il 15 ottobre,
un lunedì, Mata Hari, che dopo il processo occupava una cella in comune con due
altre detenute, venne svegliata all'alba dal capitano Thibaud, il quale la
informò che la domanda di grazia era stata respinta e la invitò a prepararsi per
l'esecuzione. Si vestì con la consueta eleganza, assistita da due suore. Poi, su
sua richiesta, il pastore Arboux la battezzò; indossato
un cappello di paglia di Firenze e infilati i guanti, fu accompagnata da suor
Léonide e suor Marie, dal pastore, dall'avvocato Clunet, dai dottori Bizard,
Socquet, Bralet, dal capitano Pierre Bouchardon e dai gendarmi nell'ufficio del
direttore, dove scrisse tre lettere - che tuttavia la direzione del carcere non
spedì mai - indirizzate alla figlia Jeanne Louise, al capitano Masslov e
all'ambasciatore d'Olanda Cambon. Poi tre furgoni portarono il corteo
al castello di Vincennes dove, scortati da dragoni a cavallo, giunsero verso le
sei e trenta di una fredda e nebbiosa mattina. Al braccio di suor Marie, si
avviò con molta fermezza al luogo fissato per l'esecuzione, dove venne salutata,
come è previsto, da un plotone che le presentò le armi. Ricambiato più volte il
saluto con cortesi cenni del capo, fu blandamente legata al palo; rifiutata la
benda, poté fissare di fronte a sé i dodici fanti, reduci dal fronte, ai quali
era stato assegnato il compito di giustiziarla: uno di essi, secondo regola,
aveva il fucile caricato a salve. Degli undici colpi, otto andarono a vuoto -
ultima galanteria dei militari di Francia - uno la colpì al ginocchio, uno al
fianco e il terzo la fulminò al cuore: il maresciallo Pétey diede alla nuca un
inutile colpo di grazia. Nessuno reclamò il corpo: trasportato all'Istituto
di medicina legale di Parigi, sezionato, fu presto sepolto in una fossa comune.
Venne conservata la testa che fu trafugata negli anni cinquanta, in circostanze
mai chiarite, per servire forse come estrema e macabra reliquia.
I protagonisti della vita di
Mata Hari, padre, figlia, amanti, diplomatici e agenti segreti, proseguirono
così la loro vita:
Rudolph (John) Mac Leod, l'ex
marito di Mata Hari, si risposò nel 1907 con Elizabeth van der Maast, dalla
quale ebbe una figlia, Norma, nel 1909. La coppia si separò, la figlia venne
portata via dalla madre e Mac Leod, con il quale era rimasta la figlia avuta da
Margaretha, ottenuto il divorzio da Elizabeth, nel 1917 si sposò per la terza
volta con la governante di Non, la venticinquenne Gietje Meijer. Ebbe dalla
terza moglie una figlia nel 1921 e morì settantatreenne nel 1928.
Non Mc Leod, figlia di
Margaretha e di Rudolph (John) Mac Leod, alta e slanciata e di carnagione scura,
molto somigliante alla madre anche nel carattere, rimasta a vivere con il padre,
morì improvvisamente alla vigilia della partenza per l'Indonesia (10
agosto 1919): aveva ventuno anni.
Il capitano francese Georges
Ladoux, del Deuxième Bureau, venne arrestato quattro giorni dopo l'esecuzione di
Mata Hari con la medesima accusa: spionaggio a favore della Germania. Prosciolto
in un primo momento, venne nuovamente incarcerato e ci vollero quasi due anni
prima che fosse prosciolto definitivamente e reintegrato nel grado, andando poi
in pensione con quello di maggiore.
Il capitano francese Pierre
Bouchardon, che condusse l'inchiesta per il processo, entrò nella magistratura
civile e fece carriera come pubblico accusatore, morendo poi nel 1950. Fu lui a
essere di nuovo in carica nel 1944 per tutti i grandi processi della
"Libération" su richiesta speciale del generale Charles de Gaulle.
Il maggiore tedesco Arnold
Kalle, addetto militare all'ambasciata tedesca di Madrid, rientrato in patria,
rimase nell'esercito e si ritirò in pensione nel 1932.
Il barone francese Henri de
Marguérie continuò la sua attività diplomatica presso il Quai d'Orsay; entrato
in politica venne eletto senatore nel 1920 e morì ultranovantenne nel 1963.
Il barone olandese Eduard
Willem van der Capellen lasciò l'esercito dei Paesi Bassi nel 1923 dopo essere
diventato generale di divisione.
Il capitano russo Vadim
Masslov sposò Olga Tardieu, figlia di un francese e di una russa; rientrato in
Russia allo scoppio della rivoluzione, se ne persero le tracce.
Il tenente di cavalleria
francese Jean Halaure ricevette dal facoltoso padre una cospicua somma, si
trasferì a New York, ove sposò un'americana con la quale rientrò in Francia,
precisamente in Bretagna, vivendoci il resto della vita con la moglie e
morendovi nel 1960.
Jules Martin Cambon,
ambasciatore francese in Olanda, fu delegato francese alle trattative di pace di
Versailles nel 1919; morì novantenne a Vevey nel 1935.
Il console tedesco all'Aja,
Alfred von Kramer, rientrato in Germania alla fine della guerra, morì nel 1938.
Cent’anni dalla fucilazione
di Mata Hari.
Una mostra al Fries Museum ne ricostruisce la storia, tra documenti e
fotografie, scrive Fiorella Minervino il 21/10/2017 su "La Stampa". Bella, forse
fin troppo per i canoni del tempo, seducente e avvolta nei veli, danzava e
ammaliava le folle del mondo, collezionando amanti facoltosi, di preferenza
militari e banchieri. E anche fatale, con una vita di successi e dolori; era una
giovane di provincia, avida di uscire dall’anonimato e conquistare fama e
ricchezza. Si era inventata tutto, esotismo, origine, professione, nome.
Cent’anni fa, il 15 ottobre, veniva giustiziata per tradimento a Parigi, nel
Castello di Vincennes, Margaretha Gertruids Zelle, in arte Mata Hari (in malese
significa Occhio dell’Aurora cioè sole), 41 anni, accusata di essere un’agente
segreta dei tedeschi. Lei, dignitosa, incoraggiò i 12 fanti che, reduci dalla
guerra, erano riluttanti a spararle. La sua città, Leeuwarden, capitale della
Frisia (il prossimo anno sarà capitale europea della cultura), ora la ricorda
con una mostra di foto, documenti rari, 100 oggetti e scritti che compaiono per
la prima volta. Accanto, documenti militari francesi recentemente desecretati e
resi pubblici, documenti legali, rapporti sulla sua attività, trascrizioni delle
udienze e prove chiave, come i telegrammi intercettati di un diplomatico tedesco
a Madrid, che forniscono una panoramica completa del processo. “Mata Hari: Il
mito e la donna” è il titolo della maggiore personale mai dedicata a Margaretha,
appena inaugurata al Fries Museum (fino al 2 aprile 2018) di Leeuewarden, a cura
di Hans Groeneweg e di Yves Rocourt. Chi era in realtà “la spia del secolo” che
ha poi animato straordinarie interpretazioni al cinema di Greta Garbo, Marlene
Dietrich, Jeanne Moreau e Sylvia Kristel o ispirato grandi ballerine come Carla
Fracci? È entrata in pagine di libri come La spia di Paulo Coelho che la vede
fra le prime femministe, e di Giuseppe Scarafia che ne indaga i giorni ultimi.
Morta e risorta tante volte, come ora al Fries Museum. Era una bimba felice
nella graziosa casa al centro di Leeuewarden, la si vede nelle foto esposte. Ci
sono le sue poesie, il libro di preghiere e le pagelle. Il padre possedeva un
negozio di cappelli, ma fallì, la famiglia si sfasciò, la madre morì quando lei
aveva 15 anni; era alta 1,75 cm, ben fatta, scura di capelli, aria vagamente
esotica. Senza soldi, a 18 anni risponde a un’inserzione sul giornale locale di
cuori solitari di un militare di 40 anni, il capitano Rudolph John Mac Leod. Si
sposano dopo 6 giorni: eccoli, sorridenti, in una foto delle nozze. Vanno a
vivere a Giava, nelle Indie Orientali Olandesi: è subito vita di colonia, balli,
intrattenimenti, ma pure esistenza assai meno comoda che in Europa; lui è
ubriaco, geloso, violento, malato di sifilide. Hanno due figli, ma solo la bimba
Non (piccola in malese) sopravvive. Lei vuol separarsi e lui è contrario, scrive
lettere ai parenti e al rientro in Olanda divorzia dal marito che le rifiuta gli
alimenti e le impedisce di vedere la bimba. Le lettere presentate nella mostra
la raccontano mamma e donna, nell’incertezza e dolore di lasciare la figlia e la
voglia di fuggire dalla provincia. Sceglie Parigi, fa di tutto per mantenersi,
anche la modella a Montmartre per gli artisti con poca fortuna, poi rientra in
Olanda. Qui comincia a ballare dapprima in teatri modesti e si inventa la danza
sacra che aveva ammirato a Giava, come la scelta del nome; anche se non si sa
esattamente come ballasse, dice di essere una principessa di Giava. Così
cominciano gli amanti danarosi. Un impresario la stimola a continuare e il 13
marzo 1905 Mata Hari fa il suo grande debutto come danzatrice nella biblioteca
del Musée Guimet: è il successo. Partendo da Parigi, Folies Bergère, Trocadero,
conquista i teatri di tutta Europa, è ormai la diva: da Roma a Berlino, da
Vienna a Madrid, alla Scala a Milano, presto famosa per le sue storie con amanti
famosi. Il Musée Guimet presta una statua di Shiva e 14 marionette wayang, i
gioielli e il reggiseno di scena (che ha sempre indossato), tutto parte di
scenografie nelle prime rappresentazioni di Mata Hari nella biblioteca del ricco
industriale Emile Guimet. Foto rare, poster, recensioni, articoli (uscì in
copertina di Vogue) compaiono in mostra al Fries Museum, e pure il grande
ritratto a figura intera che le fece il pittore Isaac Israëls nel 1916. Troppo
famosa, troppo chiacchierata, troppi innamorati di nazioni diverse, in lotta fra
loro nella Belle Époque smaniosa di esotismo ed evasioni. La Grande Guerra
spegne ogni cosa, anche la vorticosa carriera ormai al declino a 40 anni.
Conduce una vita costosa da star, sempre in cerca di denaro. L’amico console
tedesco all’Aia, Alfred von Kremer, le offre l’equivalente di 15.000 per fare la
spia e procurare notizie dei francesi. Lei accetta e sarà l’agente H21, ma
altrettanto fa la Francia e ora pure l’Inghilterra pare, e perfino la Russia; in
realtà non offre mai rivelazioni determinanti o utili ma il triplo o quadruplo
gioco in momenti tanto drammatici la rendono una mina vagante. In realtà è una
pluri-agente che tutti controllano, è pedinata per mesi, ora per ora, anche
quando va dal parrucchiere, si legge nel rapporto del sedicente amico capitano
Georges Ladoux del controspionaggio francese. Si è innamorata follemente del
giovane ufficiale russo Vadim Masslov, 20 anni meno di lei, stessa età del
figlio Norman. Sogna di sposarlo e cerca più soldi. Il 13 febbraio 1917 i
servizi segreti francesi la arrestano, 8 mesi di prigione fra topi e lacrime di
una diva. Scrive anche 5 lettere al giorno, è certa di cavarsela, il processo la
vede incerta: dapprima nega, poi ammette qualcosa, mai di aver tradito, con
testimonianze contraddittorie, forse troppo abituata a mentire o a mezze verità.
Il tribunale per crimini di guerra, non unanime (c’è chi la ritiene innocente),
la dichiara colpevole con condanna a morte. Viene chiesta la grazia al
Presidente Poincaré, che la nega. Su un foglio giallognolo in francese si legge
in grande, al centro: Mort. All’esecuzione vuole che le tolgano la benda agli
occhi. Nessuno reclamerà la salma che, dopo l’autopsia, viene gettata nella
fossa comune. Non la vuole la figlia Non, e neppure Vadim che ha assicurato che
per lui era stata solo un’avventura e sposa una coetanea. Lei lascia le lettere
che nessuno vuole, neppure il suo giovane ufficiale russo. Ora i nuovi documenti
presentati (ci sarà un’app apposita per sfogliarli) portano qualche luce sulla
donna e la vicenda e inducono a credere che non fosse una vera spia, bensì una
celebrità o un’avventuriera in cerca di denaro, ma anche dell’amore che forse
non ricevette mai. Forse un’incallita bugiarda, forse troppo famosa, troppo
amata, odiata, invidiata. Tuttavia una donna coraggiosa, fuori dagli schemi
nella società allo scatto del secolo XIX. Esce dalla vita, entra nella
leggenda.
Mata Hari, cent’anni fa
veniva fucilata la «spia che danzava»,
scrive "Il Corriere della Sera". Chi era Mata Hari? Una spia, una cortigiana,
una donna che si è trovata in un gioco più alto delle suo saper giocare?
Accusata di spionaggio e fucilata a 41 anni in Francia, questa è la biografia di
un personaggio entrato nel mito. Margaretha Geertruida Zelle - questo il nome
all’anagrafe della donna nota con il nome d’arte di Mata Hari - nasce a
Leeuwarden, in Olanda, il 7 agosto 1876. Di famiglia borghese, conduce una vita
agiata sino alla crisi delle attività commerciali della famiglia che provocano
la separazione dei genitori. Qualche anno dopo, nel 1896, Margaretha sposa il
capitano Rudolph Mac Leod, ufficiale di stanza in Indonesia provvisoriamente di
ritorno in Europa per una convalescenza. Nel 1897 si trasferisce a Giava dove il
marito è stato promosso al grado di maggiore. Qui Margaretha si avvicina per la
prima volta alle danze rituali locali e e ne rimane affascinata. Lasciata dal
marito, si trasferisce a Parigi, dove, tra molte difficoltà, inizia ad
affermarsi nel mondo dello spettacolo. Dopo gli inizi come amazzone in un circo,
ottiene in seguito un grande successo grazie a una danza ispirata proprio alla
ritualità giavanese, durante la quale Margaretha, qui in un’immagine del 1905,
si libera dei veli che la avvolgono uno dopo l’altro. Nel 1905, anno della
consacrazione all'Olympia di Parigi, assume il nome d'arte di Mata Hari,
riscuotendo da quel momento in poi una crescente ammirazione in tutta Europa,
cosa che la porta a esibirsi nei principali teatri europei, ricercata dai
maggiori musicisti dell'epoca. Con lo scoppio della Prima guerra mondiale e la
fine della Belle Epoque Mata Hari continua a spostarsi attraverso l’Europa
intrattenendo rapporti e liaisons sentimentali con diplomatici e ufficiali
francesi e tedeschi. Mata Hari viene arrestata a Parigi il 13 gennaio 1917 con
l’accusa di «spionaggio, connivenza e complicità con il nemico». Durante
l’interrogatorio ammette di essere l’agente H21 ingaggiata nella primavera
precedente dal console tedesco di Amsterdam con 20 mila franchi ma giura di non
aver mai tradito. Il 25 luglio 1916 viene condannata dalla corte militare alla
pena capitale e fucilata all’alba del 15 ottobre nel Poligono di Vincennes. La
figura e la vita di Mata Hari sono state oggetto di numerose trasposizioni
cinematografiche: la più famosa quella diretta da George Fitzmaurice del 19 con
Greta Garbo nel ruolo di Mata Hari.
È passato un secolo, ancora
nessuno sa chi era Mata Hari,
scrive Lanfranco Caminiti il 13 Ottobre 2017 su "Il Dubbio". Il 15 ottobre 1917
fu fucilata per tradimento. Castello di Vincennes – 15 ottobre 1917 – dove un
tempo sorgeva un forte quasi distrutto dai prussiani durante l’assedio di Parigi
del 1870. Alle sei e trenta di una fredda e nebbiosa mattina, un plotone di
dodici soldati zuavi reduci dal fronte di guerra aspetta il comando
dell’ufficiale per scaricare la sua fucileria. Di quei dodici fucili, uno è
caricato a salve, come vuole il regolamento, perché ogni soldato possa pensare
di non essere stato lui a tirare il colpo mortale. L’ufficiale si avvicina alla
persona condannata a morte per coprire i suoi occhi con una benda. Lei, con un
elegante gesto della mano, rifiuta. Guarda negli occhi i soldati, guarda negli
occhi i suoi carnefici. Non ha paura. È stata svegliata poco dopo le cinque al
secondo piano di Saint- Lazare, il penitenziario femminile di Parigi, cella
numero 12. Le monache le hanno già comunicato, qualche giorno prima, che la
domanda di grazia presentata al presidente francese è stata respinta. Si aspetta
perciò questa sveglia improvvisa all’alba. È il suo nome, d’altronde, occhio
dell’alba, in lingua giavanese: Mata Hari. Almeno, era il suo nome d’arte,
quando calcava le scene dei palcoscenici di tutta Europa, perché all’anagrafe è
registrata come Margaretha Geertruida Zelle, nata a Leeuwarden, Olanda, il 7
agosto 1876. L’altro “nome d’arte”, quello che le è stato dato dai tedeschi per
i quali ha lavorato come spia è: agente segreto H21. È l’agente segreto H21, la
donna che i soldati zuavi stanno per fucilare. Anche se tutti sanno che lei è la
famosa Mata Hari. Mata Hari si è vestita con calma nel carcere femminile di
Saint-Lazare, indossando un lungo cappotto dai risvolti di pelliccia sul suo
kimono, mettendo i guanti di pelle nera, e rassettando i capelli che ha tenuto
insieme con un fermaglio, e sui quali ha poi poggiato un cappello di paglia di
Firenze, legandolo al mento con un nastro perché non voli. Ha quarantun anni.
Della intrigante bellezza che ha fatto impazzire ufficiali e nobili, trafficanti
e coreografi, artisti e faccendieri della Belle Époque dev’essere rimasta ancora
qualche traccia – e poi, arrestata a gennaio, ha vissuto con dolore e
disperazione i lunghi mesi del processo iniziato a giugno, pieno di voltafaccia
e colpi di scena: sa da tempo d’essere giunta al capolinea della sua lunga
corsa. Ma il fascino è rimasto intatto: è una donna alta, dai capelli scuri, gli
occhi di giada e la carnagione olivastra – e benché abbia avuto due gravidanze,
il corpo è ancora sensuale, flessuoso e agile. Dopo il breve tragitto dal
carcere fino a Vincennes, i furgoni scortati dai dragoni a cavallo, Mata Hari è
stata legata blandamente al palo dell’esecuzione – di certo lei non fuggirà, di
certo lei non tremerà. La leggenda dice che proprio per mostrare quanto non
abbia paura, Mata Hari d’improvviso faccia scivolare il suo lungo cappotto fino
ai piedi e offra ai fucili il suo petto nudo. Vero o no, l’ufficiale, il
maresciallo Petey, alza la sciabola, l’abbassa: fuoco. Degli undici colpi, otto
vanno fuori bersaglio – forse un’estrema galanteria dei soldati francesi. Dei
tre al corpo, uno colpisce una rotula, uno un fianco, il terzo va dritto al
cuore. Il maresciallo Petey si avvicina per dare il colpo di grazia, anche se
del tutto inutile. Poi annuncia: Mata Hari è morta. Un soldato zuavo, uno dei
fucilatori, sviene. Colpevole o meno di tradimento, il processo a Mata Hari, in
piena guerra e con uno stato maggiore che non sta proprio dando gran prova di sé
sul piano militare contro un nemico tedesco straordinariamente capace, serve per
rinsaldare il fronte interno. E salda i conti aperti nello spionaggio francese
fin dal tempo del caso Dreyfus. Come ha scritto Julie Wheelwright, autrice
di The Fatal Lover: Mata Hari and the Myth of Women in Espionage, dal momento
della sua esecuzione l’esotica danzatrice Margaretha “Gretha” Zelle sposata
MacLeod – universalmente nota come Mata Hari – è diventata sinonimo del
tradimento sessuale femminile. Giudicata da un tribunale militare francese per
passare segreti al nemico durante la Prima guerra mondiale, fu condannata come
la “più grande spia del secolo”, responsabile di aver mandato alla morte più di
ventimila soldati alleati. Ma il suo status di straniera – era, appunto,
olandese – e di donna divorziata, assolutamente non pentita di avere dormito con
ufficiali di tutte le nazionalità, ne fecero un perfetto capro espiatorio nel
1917. Era nata in una famiglia più che benestante, nella capitale della
Frisonia, Olanda. Il padre era proprietario di un mulino, ma le sue speculazioni
in affari di petrolio lo portarono sul lastrico e, senza un soldo, partì per
l’Aia. La madre morì quando Greta aveva solo quindici anni, e fu data in
custodia presso degli zii. A diciott’anni rispose a un annuncio di cuori
solitari su un giornale quattro mesi dopo, era sposata a Rudolph “John” MacLeod,
un uomo che aveva il doppio dei suoi anni, era un forte bevitore e era militare
di stanza nell’esercito in India. Da un padre volgare finì nelle mani di un
marito volgare. Il matrimonio fu rovinoso fin dall’inizio. Dopo la nascita del
primo figlio, Norman, nel 1897, Greta e il marito navigarono verso le Indie
orientali, dove la loro vita si spese per quattro anni in guarnigioni militari.
La tragedia arrivò dopo la nascita della figlia, Non, quando entrambi i bimbi
furono avvelenati: la piccola sopravvisse, il piccolo morì. Quando John poté
andare in pensione, la coppia tornò in Olanda e si separò. È il 1902. Eppure
questa “mangiauomini”, che ballò a La Scala di Milano e all’Opera di Parigi e
nei salotti privati di mezzo mondo, era disgustata dal sesso. Nuovi documenti –
finora i biografi avevano avuto accesso solo alla trascrizione del processo
francese e alle sue lettere in prigione – gettano un’altra luce sulla sua vita:
«Mio marito mi ha dato un tale disgusto per le cose sessuali che non posso
dimenticarlo mai». Dal marito aveva contratto la sifilide, nelle Indie
occidentali, e per precauzione la figlia Non era stata sottoposta alle cure di
mercurio. Dopo la separazione lei ebbe la custodia della figlia, ma si rifiutò
di pagare una intermediazione finanziaria, e la mancanza di sostegni familiari e
l’assenza di una qualche attività professionale finirono per dare la bimba al
marito. Decide così di andare a Parigi. Più tardi scrisse: «Pensavo che tutte le
donne che si separavano dal marito andavano a Parigi». A Parigi, cercò in ogni
modo di guadagnarsi rispettabilmente da vivere, sempre con l’obiettivo di
riprendersi la bambina, dando lezioni di piano, insegnando il tedesco, facendo
la dama di compagnia, e come commessa in un negozio di abbigliamento. Meno
rispettabile, ma più remunerativo era lavorare come modella per pittori di
Montmartre. Ritorna brevemente in Olanda, come comparsa in una compagnia di
teatro, ma confessa in una lettera di “dormire con uomini” per denaro. Fa la
ballerina al Perroquet bleu, esibendosi in una «danza delle bayadere». E qui
s’incontra la sua genialità con quella di un impresario che vede in lei
l’incarnazione di un desiderio d’Oriente: Gretha s’inventa ascendenze indiane,
di avere partecipato a segreti riti e d’avere imparato le movenze di danze sacre
– ci sono i gesti, c’è la caduta dei veli e la nudità finale. L’occidente non
vede l’ora di perdere la testa per l’oriente. Gumet mette intorno ai gesti
lascivi di Gretha vasi, décor, musiche, tende, gioielli, crea una mistica. È
così che nasce il mito di Mata Hari. Qualcosa che era nell’aria e che
d’improvviso prende corpo in una donna, in un corpo, in una danza. Tra il 1904 e
il 1906, Mata Hari calca i palcoscenici più importanti, viene contesa dagli
impresari più grandi, desiderata da tutti gli uomini. E lei passa dalle braccia
di un barone tedesco a quelle di un imprenditore francese, da un nobile spagnolo
a un ufficiale inglese o russo. È all’apice del successo. Poi, vive di rendita.
Quando i colpi di pistola di Sarajevo pongono fine alla Belle Époque e danno
inizio alla Grande guerra, viene reclutata dai tedeschi. Vogliono sapere di
impianti industriali, lei che è dentro quel mondo, di segreti militari – gli
uomini a letto parlano, si vantano, sono tronfi. I sospetti cominciano a
aleggiare su di lei: i francesi provano a tenderle una trappola, lei si offre
per un doppio gioco. Spera di tornare in Olanda, e così salvarsi. L’attirano in
un tranello, e forse sono gli stessi tedeschi a disfarsene perché è ormai
“bruciata”, oppure commettono una grave imprudenza utilizzando un codice di
trasmissione che era stato già decifrato. Insomma l’arrestano. È la fine.
Eppure, inventandosi quel passato orientale, quella conoscenza di riti e di
culti, fu proprio Gretha la vera creatrice di se stessa e di un proprio doppio,
Mata Hari. È questa forza d’animo, questa capacità di reinventarsi ogni volta,
di risollevarsi dalla disperazione, non importa quel che costi, che fa di Gretha
Zelle un personaggio così straordinario, così moderno. Mata Hari era una donna
forte, e questo è un giudizio che va oltre le sue azioni, reali o presunte.
Paola De Carolis per il Corriere della Sera il 18
luglio 2021. Di fronte alla battaglia tra l'oligarca russo Farkhad Akhmedov e
l'ex moglie Tatiana, la giudice dell'Alta Corte Gwynneth Knowles ha ripensato
all'incipit di Anna Karenina: «Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo». Il
clan Akhmedov, ha sottolineato, è tra i più infelici che le siano mai capitati
davanti. La signora Tatiana ha ora di che consolarsi: dall'ex marito ha ottenuto
il patrimonio che le era stato assegnato dal tribunale nel 2016, qualcosa come
454 milioni di sterline, circa 531 milioni di euro, un totale che rende il suo
il divorzio più salato nella storia legale britannica. Se privatamente Farkhad,
sulla lista nera dei collaboratori di Vladimir Putin stilata dagli Usa, aveva
confidato che avrebbe preferito bruciare i soldi piuttosto che consegnarli
all'ex consorte e «per anni», a sentire la moglie, non le ha dato «neanche un
penny», alla fine è stata trovata una formula che ha messo d'accordo le due
parti: un misto di contanti, immobili e opere d'arte che ha raggiunto
l'ammontare indicato dall'Alta Corte. L'annuncio è stato dato da un portavoce
dell'oligarca nonché dal Burford Capital, il gruppo di litigation funding,
ovvero di finanziamento delle liti legali cui si era rivolta Tatiana per
costringere l'ex ad aprire il portafoglio. Lei, Tatiana, per ora non ha
commentato, forse le basta la vittoria finanziaria e morale nonché l'opportunità
di entrare in possesso di una collezione privata che fa gola a tanti esperti.
Agli Akhmedov, infatti, appartengono quadri di Andy Warhol, Mark Rothko e Damien
Hirst, apparentemente custoditi nel Lichtenstein. A differenza dell'ex marito,
che è tornato in Russia, la signora Akhmedova è cittadina britannica da più di
20 anni. Nel Surrey ha cresciuto, «praticamente da sola», due figli ora adulti.
Aver raggiunto con l'ex un accordo sul trasferimento dei fondi le permetterà di
costruirsi una nuova vita, anche se il divorzio ha lasciato segni profondi sugli
equilibri e gli affetti familiari. Il primogenito Temur, ad esempio, è stato
accusato dall'Alta Corte di essere diventato il braccio destro del padre e di
averlo aiutato a nascondere il patrimonio «con una serie di operazioni» il cui
obiettivo era quello di impedire alla madre di ottenere ciò cui aveva diritto.
Lo scorso aprile, la giudice Knowles lo aveva definito «un individuo disonesto»
e gli aveva ordinato di pagare alla madre 75 milioni di sterline. Sarebbe grazie
a lui e alle sue peripezie finanziarie che Akhmedov padre, che a 65 anni si è
risposato con una donna di trent' anni più giovane di lui, è riuscito a negare
all'ex moglie lo yacht Luna, un'imbarcazione da 300 milioni di sterline con
dieci cabine vip e una piscina da 20 metri costruita per un altro
supermiliardario russo, Roman Abramovich. I suoi rappresentanti legali hanno
sostenuto che Temur - un trader della City che dal padre è stato abituato a un
certo tenore di vita con tanto di appartamento da 35 milioni di sterline con
vista su Hyde Park, una Rolls Royce e una Tesla - «non ha mai desiderato
prendere la parte di uno e dell'altra ma che inevitabilmente è stato risucchiato
nel vortice di un'amara disputa familiare». Difficile immaginare che potrà ora
riallacciare i rapporti con la madre Tatiana, che tra l'altro era riuscita ad
ottenere un'ingiunzione per arginare le sue spese a 3.000 sterline al mese.
Da Bill e Melinda Gates a
Bezos e MacKenzie: i divorzi più cari della storia.
Tg24.Sky.it il 4 maggio 2021.
Con un patrimonio immenso, la separazione del fondatore di Microsoft potrebbe
diventare il più costoso, superando anche quello del proprietario di Amazon. Da
Rupert e Anna Murdoch fino a Silvio Berlusconi e Veronica Lario: tutte le
separazioni dal valore di miliardi o milioni di dollari e euro
Bill e Melinda Gates hanno
annunciato il divorzio nel 2021 dopo 27 anni e tre figli insieme. Non sono noti
i termini dell'accordo, ma il patrimonio della famiglia Gates è immenso. La
ricchezza di lui ammonta a 133 miliardi di dollari al gennaio 2021, quella della
moglie a 70 miliardi di dollari. L'1% di azioni della coppia in Microsoft, vale
oltre 7 miliardi di dollari, la fondazione Bill e Melinda Gates detiene asset
per un valore di oltre 50 miliardi di dollari. Ecco le altre coppie la cui
separazione è costata milioni o miliardi di dollari
Nel 2019 un'altra delle coppie
più ricche degli Usa ha posto fine alla propria unione. Jeff Bezos e l'ex moglie
MacKenzie hanno trovato un accordo del valore di 38 miliardi di dollari. Il
proprietario di Amazon ha trasferito alla donna il 4% delle azioni del colosso
dell'e-commerce, valutate in 38,3 miliardi di dollari. Bezos manterrà una quota
del 12%, del valore di 114,8 miliardi di dollari, e rimane la persona più ricca
del pianeta
Da Mountain View, a metà del
2015, è arrivato un altro divorzio tra i più cari della storia: Sergey Brin,
fondatore insieme a Larry Page di Google, e Anne Wojcicki, imprenditrice e
filantropa statunitense co-founder e ceo della società di genomica 23andMe, si
sono detti addio dopo 8 anni. I termini dell'accordo, in realtà, non sono stati
rivelati ma solo due anni fa il patrimonio netto stimato di lui ammontava a 48,8
miliardi mentre la partecipazione di Anne in 23andMe valeva 440 milioni
Il divorzio tra Rupert
Murdoch, imprenditore e produttore televisivo australiano naturalizzato
statunitense, e la sua seconda ex moglie Anna Maria Torv Mann è costato un
miliardo e 700 milioni di dollari. La coppia è stata unita per 32 anni dal 1967
al 1999
Nel 2009, dopo 25 anni di
matrimonio, hanno posto fine all'unione Bernie Ecclestone e Slavica. La donna
aveva avanzato una richiesta di 4 miliardi di dollari, ma il miliardario inglese
è riuscito a sborsarne "solo" un miliardo
Storia di Bill e Melinda
Gates, dalla fondazione al divorzio.
Il divorzio tra il miliardario
saudita Adnan Khashoggi e l'ex moglie Soraya è stato per 20 anni il più caro
della storia. I due si sposarono nel 1960 e divorziarono nel 1982 dopo otto anni
di battaglie legali. La richiesta iniziale sarebbe stata di 2,54 miliardi di
dollari, quella finale è stata di 874 milioni di dollari
Il divorzio tra Silvio
Berlusconi e Veronica Lario è probabilmente stato il più costoso d'Italia. Nel
2015 la penultima sentenza aveva stabilito un assegno mensile all'ex moglie
di un milione e 400mila euro al mese lordi (circa 800mila netti). Poi la
Cassazione aveva revocato l’assegno divorzile chiedendo indietro a lario 46
milioni. Nel 2020 l'accordo: l'ex premier ha rinunciato ai 46 milioni di credito
nei confronti della ex moglie e Veronica al suo credito da 18 milioni
Tra i divorzi più cari della
storia c'è anche quello tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic. La coppia è stata
sposata dal 1983 al 2000. L'addio è costato all'imprenditore un assegno di 4
miliardi e mezzo di lire
Anche in casa Disney si conta
un divorzio milionario, è quello tra Roy, nipote di Walt Disney, e la
moglie Patricia avvenuto nel 2007. All’epoca, il patrimonio dell'uomo ammontava
a circa 1,3 miliardi di dollari e la separazione dopo 52 anni di matrimonio
avrebbe avuto il valore di 600 milioni di dollari
Tra i costosi addi degli
imprenditori miliardari si inserisce anche un oneroso accordo di separazione di
una star di Hollywood. Il divorzio tra Mel Gibson e Robyn Moore, nel 2011 dopo
26 anni di matrimonio e 7 figli, ha il valore di 425 milioni di dollari tra i
più cari delle stelle del cinema
L'imprenditore e pioniere
della telefonia cellulare Craig McCaw, fondatore di McCaw Cellular e Clearwire
Corporation, è stato sposato con Wendy McCaw. La coppia ha divorziato un paio
d’anni dopo che il marito aveva venduto la sua società ricavandone 11 miliardi
di dollari. L'ex moglie ha ottenuto circa 460 milioni di dollari
Il magnate e primo miliardario
afroamericano, fondatore della rete televisiva Black Entertainment
Television, Robert L. Johnson nel 2000 ha divorziato da Sheila, dopo 33 anni di
matrimonio e un accordo da 400 milioni di dollari
Roman e Irina Abramovich si
sono sposati nel 1991 e hanno divorziato nel 2007 con un accordo di 300 milioni
di dollari
Per anni coppia d'oro di
Hollywood, anche il divorzio tra Tom Cruise e Nicole Kidman ha il valore di
svariati milioni di dollari: nello specifico circa 200 milioni
Tra gli sportivi ha segnato un
record anche per quanto riguarda il valore dell'accordo di divorzio la stella
Nba Michael Jordan che, dopo 17 anni di matrimonio, nel 2006 ha lasciato la
moglie Juanita. Alla donna sarebbero andati 168 milioni di dollari (145 milioni
di euro)
Così Euripide assolse Elena, la
seduttrice più innocente. Giuseppe Conte il 15 Luglio
2021 su Il Giornale. La nuova traduzione della tragedia ci mette di fronte
all'incarnazione della passione amorosa. Elena figlia di Leda e del Cigno nelle
cui 9forme si nascondeva Zeus, fu la donna più bella al mondo, suscitatrice dei
più infuocati desideri: per lei, dopo che Paride la portò via al marito Menelao,
scoppiò la guerra di Troia e trovarono la morte tanti eroi. Pari a lei, per fama
e per incidenza sull'immaginario dei posteri, c'è soltanto Ulisse. Che quando a
Sparta furono convocati tutti i principi pretendenti alla mano di Elena, era tra
loro. Ma ancora una volta fu il più scaltro, e si ritirò senza portare alcun
dono appena seppe che a chiederla in sposa per il fratello sarebbe stato il più
potente e ricco degli Achei, Agamennone. La bellezza, di cui Elena è emblema
supremo, si accoppia con la potenza. Ma sacrifica a Eros. Elena non è statica
nella gloria delle sue forme perfette, è in continuo divenire, contraddittoria,
dolcissima e feroce. È vittima ma è anche carnefice, è colpevole ma anche
innocente, è splendore ma anche rovina. Nella sua ottima introduzione alla Elena
di Euripide (Mondadori, pagg. 383, euro 50) Barbara Castiglioni, che ne è anche
traduttrice, mostra in quante opere Elena di Troia sia stata protagonista e su
quanti autori abbia esercitato in diversi modi il suo fascino. In un raggio che
copre tutta la letteratura e la civiltà occidentale. Elena è intanto un
personaggio omerico, e nelle vicende dell'Iliade mostra, lei traditrice e ormai
principessa troiana, tratti di sconcertante ambiguità filogreca. E se in Omero
resta una colpevole, ci pensa Gorgia il sofista, fedele ai suoi metodi, a
tesserne un Encomio e a mostrarne con un esercizio di alta retorica la
sostanziale innocenza. Personalmente, sono affascinato da una celebre poesia
lirica di Saffo dove Elena ricorre in quanto esempio: c'è chi sostiene che la
cosa più bella al mondo sia una torma di cavalieri, chi di fanti, chi una flotta
di navi. Saffo invece sostiene che la cosa più bella al mondo è «ciò che si
ama». Capovolge l'ordine dei valori: in cima non ci sono guerra e potere. C'è
l'amore. E per mostrare la potenza di Eros, ecco che «la donna più bella del
mondo,/ Elena, abbandonò/ il marito (era un prode) e fuggì /verso Troia, per
mare./ E non ebbe un pensiero per sua figlia,/ per i cari parenti: la travolse/
Cipride nella brama». Elena è qui il modello di ogni trasgressione amorosa, di
ogni passione terribile, inevitabile: gioia e disastro nello stesso tempo.
Troveremo Elena negli autori latini, con la versione mondana che ne dà Ovidio
nelle Heroides, negli autori medievali devoti all'amore cortese, come Benoit de
Sainte Maure col suo Roman de Troie, in Dante, nei drammaturghi elisabettiani,
in Goethe, dove diventa, nell'immenso affresco simbolico del Faust,
«l'incarnazione vera e propria dell'eterno Elemento femminile». E, più vicino a
noi, c'è la Elena di William Butler Yeats reincarnata nella rivoluzionaria
irlandese Maud Gonne, di cui il poeta fu sempre e vanamente innamorato. In Maia,
il suo vero capolavoro, D'Annunzio preferì dipingerci una Elena mendicante,
superstite nella vecchiezza e nella vergogna: i secoli le hanno incanutito i
capelli, sfatto la bocca vorace, smunto il seno infecondo, curvato il dorso di
belva, e le hanno lasciato un solo occhio socchiuso e senza ciglia. È una
epifania potente e misteriosa. «Aedo hai dato la dramma/ a Elena, figlia del
Cigno/ che fatta è serva millenne/ d'una meretrice di Pirgo». Più tardi, anche a
Ghiannis Ritsos, superbo poeta erotico neogreco, Elena apparve in un simile
degrado e sfacelo. Scrive Barbara Castiglioni che «tra tutti gli oltraggi
mitologici compiuti da Euripide, il più clamoroso è senza dubbio il
rovesciamento del mito di Elena». Ed è vero. Euripide fa sua la versione di una
Elena del tutto innocente e vittima. E sposta l'azione lontano sia da Sparta sia
da Troia, nell'Egitto che per i Greci ha la voce straordinaria di Erodoto. Che
cosa è accaduto perché il mito potesse così capovolgersi? Per capirlo, bisogna
introdurre il tema del doppio e del fantasma. Già ricorre nelle vicende di Era e
di Zeus. Quando Issione, figlio del re dei Lapiti, invitato al banchetto degli
Dei osò mettere gli occhi su Era e tentare di sedurla, Zeus, prima di punirlo,
lo beffò, costruì con la sostanza eterea delle nubi un doppio della moglie, gli
diede le sue fattezze del volto e le sue forme, e Issione ingannato possedette
quello. Da quel coito, nacque la stirpe dei Centauri. Per sottrarre Elena al
tradimento e alla vergogna, gli dei ne mandarono a Sparta un fantasma: costruito
anch'esso di aria e di nuvole, ma talmente somigliante da indurre Paride a
crederla la vera Elena: così fece innamorare e portò con sé a Troia un'ombra. E
la Elena in carne ed ossa, con tutta la sua irresistibile bellezza, fu portata
in Egitto presso la corte del più casto dei Re, Proteo, l'unico che poteva
vedersela vicino senza cominciare a smaniare di desiderio. Quando il dramma di
Euripide inizia, il re è morto ed è succeduto a lui Teoclimeno, che invece
comincia a desiderare follemente e a insidiare Elena. E Menelao, reduce da
Troia, arriverà naufrago proprio su quelle sponde. La tragedia prende toni più
da commedia, che il lieto fine potenzia: e si legge bene in questa nuova
freschissima traduzione tra dialoghi serrati e alati spunti lirici. Elena ne
esce completamente redenta: donna eccellente, virtuosa, dal nobile animo.
Perché, come sentenzia il coro: «Molte sono le forme del divino, / e
incomprensibili le decisioni degli Dei». Giuseppe Conte
Padova, la prima rettrice
dopo 799 anni. Mapelli: “Porterò inclusione e sostenibilità sociale".
Corrado Zunino su
La Repubblica il 5 luglio 2021. Neuropsicologa, la nuova guida dello storico
ateneo ha le idee chiare: "Non scimmiotterò una leadership maschile. A ottobre
tutti in presenza. Per i giovani abbiamo allestito 800 concorsi e calamitato
1.400 matricole straniere”. Daniela Mapelli, 56 anni, ultimo rettore italiano in
ordine di elezione, alla guida dell’Università di Padova fondata nel 1222, ha un
curriculum costruito in sede e su un percorso lungo e naturalmente complicato:
umanista, si è laureata a Padova nel 1991 in Psicologia sperimentale, si è
quindi dottorata a Trieste e per due anni si è formata all’estero, alla Carnegie
Mellon di Pittsburgh. Impegnerà dodici anni per diventare ricercatrice a tempo
indeterminato, e uscire dalla palude del precariato post-doc e assegnista,
diciannove anni per approdare alla cattedra: professore di seconda fascia. Oggi,
ordinario di prima fascia da cinque stagioni, insegna Neuropsicologia e
Riabilitazione neuropsicologica ed è diventata prima rettrice della storia
padovana. E’ l’eletta numero 98 da quando è stato istituito il referente unico,
nel 1806.
Professoressa, sarà in carica
dall’uno ottobre. La prima donna rettrice dopo 799 anni.
“In otto secoli questo ateneo
non solo non aveva mai avuto una guida femminile, ma non aveva visto neppure una
candidata al rettorato. Questa volta eravamo in tre su quattro partecipanti.
Abbiamo capito, noi donne, che vale la pena mettersi in gioco, che essere donna
è un valore aggiunto. Esistono uomini molto capaci e così è tra noi.
Precludersi, come genere femminile, la competizione a una leadership significa
rinunciare a un 50 per cento di possibilità di scegliere la persona giusta. Sono
stata travolta da una campagna elettorale davvero impegnativa e adesso, certo,
non scimmiotterò una leadership maschile”.
Cosa farà, da rettrice,
all’Università di Padova? Abbiamo detto università storica, e poi?
“Ateneo d’eccellenza, con una
valutazione sulla didattica da lettera A. Ateneo inserito dall’Anvur, a
proposito della Valutazione della qualità della ricerca, per due volte
consecutive tra i primi. Quel che vorrei portare, e che forse ancora manca, è
quello che si fa fatica a trovare nella nostra società: inclusione e pari
opportunità, sostenibilità ambientale e sociale. Temi che ci impegneranno per i
prossimi anni”.
Con il suo insediamento, ci
sarà il ritorno in presenza di tutta la vita accademica? O l’esperienza a
distanza vi farà mantenere alcuni corsi in Dad?
“Da ottobre avremo il rientro
in aula di tutti, gli orari sono già pronti. Esami e lauree sono già in
presenza. Abbiamo imparato molto in questi mesi e ci sono tre piani di azione
pronti per affrontare le tre opzioni possibili: cento per cento in aula, metà
presenti e metà a distanza, tutti in Dad. Con l’emergenza, abbiamo girato online
tremila insegnamenti. Siamo pronti a rifarlo. Devo dire che in queste due
stagioni i nostri studenti non hanno fermato le carriere, abbiamo verificato che
non ci sono differenze sostanziali su crediti e esami. Non vediamo l’ora di
aprire per tutti, l’università è un’esperienza da fare in presa diretta. Certo,
la Dad è una vera e propria nuova tecnologia: un’alfabetizzazione semiologica.
Dobbiamo decidere come guidarla per organizzare le lezioni, i consigli interni”.
Anche all’Università di
Padova, nella stagione 2020-2021, c’è stato un aumento delle immatricolazioni
degli studenti?
“Sì e credo dipenda dai molti
aiuti offerti agli studenti, a livello nazionale e di ateneo. Abbiamo chiuso
l’anno accademico con 22.000 matricole, tremila in più del precedente. Abbiamo
investito sull’internazionalizzazione e calamitato a Padova 1.400 neoiscritti da
tutto il mondo”.
Sta seguendo il dibattito
parlamentare sulla riforma del percorso post-laurea? E’ una proposta di riforma
per alleggerire il precariato.
“Sì, l’abolizione della
differenza tra ricercatore di Tipo A e di Tipo B, l’introduzione di un’unica
figura con una tenure track, un percorso di avvicinamento alla docenza, non più
lungo di sette anni. Dobbiamo garantire meno precariato possibile, questo è lo
spirito di fondo. Sui dettagli, si può discutere”.
A Padova come siete
intervenuti, in autonomia, sulla questione?
“Nel precedente sessennio
abbiamo organizzato 800 concorsi per ricercatori e ricercatrici. Due terzi dei
vincitori hanno trovato una collocazione nella nostra università, il restante
terzo in altri atenei ed enti di ricerca”.
Su Repubblica c’è stato un
lungo dibattito, alimentato dall’inchiesta “Agnese nel Paese dei baroni”, sulla
bontà dei concorsi universitari italiani. La ministra Maria Cristina Messa, ex
rettrice alla Bicocca di Milano, ha chiesto commissioni esterne, dipartimenti
che si assumano responsabilità per le scelte fatte e la possibilità di avere
candidati con competenze vicine alle richieste degli atenei. Che ne pensa?
“La penso come la ministra. In
Italia si possono già fare chiamate dirette e si possono allestire concorsi non
certo ad personam, ma su linee di ricerca: sarebbe bello e utile poter avere
quella persona su quell’argomento scientifico. I concorsi pubblici, d’altra
parte, devono garantire trasparenza e onore al merito. Devono tenere insieme le
due cose: competenze specifiche e curriculum generale. Da ricercatrice ho
partecipato a due bandi, e ho vinto il secondo. Da professore associato ho fatto
cinque concorsi, e ho vinto il quinto. Dobbiamo metterci in gioco. Certo, a
volte, se esclusa, ho pensato “l’avrei meritato io”, ma non ho mai pensato che
quei concorsi fossero predeterminati”.
Perché le università italiane
che, chiaramente, formano buoni ricercatori, riconosciuti nel mondo, non
riescono mai a entrare nelle prime cento nei ranking internazionali?
“Perché su alcune voci non
potremo mai competere, per esempio, con gli Stati Uniti. Uno dei parametri più
frequenti delle diverse classifiche è il rapporto docenti-studenti, e qui
giochiamo un altro campionato. Negli Stati Uniti si ha un professore ogni
sette-quindici studenti, noi abbiamo classi di 150-300 discenti. Quasi tutta la
nostra università è pubblica, quella americana d’eccellenza è privata. Un altro
parametro è: quanti Premi Nobel ha in organico tra i docenti una singola
accademia? I Nobel sono professori molto costosi: gli atenei americani dell’Ivy
League e quelli mediorientali possono pagare questi grandi nomi, da noi non è
possibile”.
Nei trent’anni che separano la
Daniela Mapelli neolaureata dalla Daniela Mapelli rettrice, l’università
italiana è cambiata? E come?
“E’ cambiata in meglio,
l’accademia italiana gode di buona salute. I nostri studenti e assegnisti e
dottorati all’estero li cercano, eccome. Siamo molto forti e questo nonostante
restiamo uno dei Paesi che investe meno in ricerca e alta formazione”.
Deve cambiare l’atteggiamento
del sistema Italia nei confronti della sua università?
“Sono fiduciosa che nei
prossimi sei anni questo avverrà. Ho letto il Piano nazionale di ripresa e
resilienza e gli investimenti negli atenei e nelle amministrazioni pubbliche
sono notevoli. Dobbiamo imprimere velocità alle riforme, ce la faremo”.
Vittorio Feltri, le donne
si preparano a prendere il potere? Era ora.
Vittorio Feltri su Libero
Quotidiano l'11 luglio 2021. È noto che gli Stati Uniti sul piano del costume e
dei fenomeni sociali sono sempre in anticipo rispetto all'Italia. E abbiamo
sperimentato da tempo: ciò che succede Oltreoceano prima o poi accadrà dalle
nostre parti. L'ultima notizia in proposito è stupefacente: le donne laureate in
America sono il 37 per cento, gli uomini invece si fermano al 30 per cento,
cosicché le femmine che occupano posti di lavoro di alto livello stanno
quantitativamente diventando superiori ai maschi. Le ripercussioni di questo
stato di fatto si avvertono in ogni settore dell'economia e sulla composizione
delle famiglie. Le nubili respingono i corteggiamenti dei celibi che non abbiano
titoli accademici, inoltre puntano a sposare ragazzi fisicamente prestanti,
alti, di buona borghesia. Parecchie di esse cominciano a coltivare il desiderio
di avere un figlio, tuttavia se ne guardano di accoppiarsi con uno sfigato:
preferiscono ricorrere alla fecondazione artificiale in modo da poter partorire
lo stesso, senza il contributo di un partner. Avanti di questo passo gli
aspiranti mariti non conteranno un accidente, nel senso che rimarranno scapoli
in quanto superflui, inservibili. Ciò non si verificherà domani, ma dopodomani
sì, di sicuro. Insomma, il futuro sarà ricco di sorprese. Ormai non esiste più
alcuna distinzione sostanziale tra i due generi, entrambi godranno di pari
reputazione, saranno persone e basta. Le avvisaglie del radicale cambiamento si
avvertono pure in Italia, dove già le laureande sono più numerose dei laureandi,
il che significa che tra qualche anno presumibilmente succederà che il caso
statunitense sarà in procinto di sfondare prima a Milano, poi in tutto il Paese.
Il mondo sarà molto diverso da ora, per esempio la questione delle quote rosa
non avrà più senso. In ogni professione impegnativa il successo arriderà a chi
merita di più, il sesso di appartenenza non avrà alcun peso. Prepariamoci a tale
mutamento epocale, che inciderà nella formazione e nella conduzione delle
famiglie. I difensori della tradizione in questo campo sono destinati a perdere
le loro battaglie. Le donne si sono evolute da quando hanno scoperto che
l'Università spalanca le porte senza fare distinzioni di timbro antiquato. Una
volta le ragazze studiavano poco, al massimo diventavano maestre, adesso i
medici e gli avvocati di grido sono signore. Chiaro che si impadroniranno delle
leve del potere. Io ne sono contento, perché almeno le femministe non romperanno
più le balle, essendo uguali e migliori di noi che abbiamo inventato i pantaloni
senza metterli più.
La prima donna laureata al
mondo, a Padova, ci ricorda quanto è antica la questione femminile.
Riccardo Luna su La
Repubblica il 25 giugno 2021. Il 25 giugno 1678 (si avete letto bene:
1678) Elena Cornaro Piscopia si laurea. E' la prima donna a laurearsi a Padova,
in Italia e nel mondo intero. Che stesse accadendo qualcosa di speciale lo
sapevano tutti visto che la discussione della tesi di laurea in Filosofia era
stata spostata dall'università alla cattedrale per accogliere il folto pubblico
di curiosi provenienti, pare, da diverse università italiane. Elena Cornaro
Piscopia discusse la tesi dottorale in latino commentando brani scelti dalla
commissione di esame che al termine, invece di riunirsi per deliberare i voti,
scelse di approvare la nuova dottoressa seduta stante. Aveva appena compiuto 32
anni e non le fu mai concesso di insegnare, in quanto donna: mori pochi anni
molto giovane, terminando una vita, per quel che si è appreso, piuttosto
infelice. Era nata a Venezia, quinta di sette figli, da un papà nobile e una
mamma popolana, Già a 6 anni il padre di era accorto dell'intelligenza della
figlia e ne aveva favorito l'educazione assoldando insegnanti di fama. A 19
anni, quando era in età da marito, Elena decise di farsi oblata benedettina, di
dedicarsi alla vita religiosa, per poter continuare a studiare. Parlava greco,
latino, spagnolo, francese e inglese, suonava quattro strumenti ma la sua
passione era la teologia. Ma quando il padre chiese all'università di Padova di
assegnare alla figlia la laurea in Teologia il vescovo (e cancellerie
dell'ateneo) disse che "dottorar una donna" era uno "sproposito" che avrebbe
reso i decisori "ridicoli a tutto il mondo". Non il primo e neanche l'ultimo
come sappiamo, intervento "a sproposito" della Chiesa. Ma Elena non si arrese,
cambiò materia e qualche anno dopo riuscì a laurearsi. La sua impresa resta
un esempio mondiale di emancipazione femminile, ancora più grande se si pensa
che per avere la seconda donna laureata al mondo, sempre in Italia, toccherà
attendere 54 anni. E che solo da qualche giorno Padova ha la sua prima donna
rettore. La statua di Elena Cornaro Piscopia è nel cortile dell'Ateneo.
Simona Siri per "la Stampa" il 17 giugno 2021. Non
si fa chiamare con il cognome dell' ex marito, Jeff Bezos, e neanche con quello
del nuovo, Dan Jewett, un insegnante di Seattle sposato a marzo. Lei è
semplicemente MacKenzie Scott, ammesso che ci sia qualcosa di semplice nell'
essere una delle donne più facoltose e generose del mondo. Nel 2019 il divorzio
dopo 25 anni di matrimonio dal fondatore di Amazon nonché uomo più ricco del
mondo (193,5 miliardi di valutazione secondo Forbes) le aveva lasciato in dote
59 miliardi. Oggi, sta mantenendo quello che aveva già promesso alla vigilia
della separazione, ovvero dare gran parte della sua fortuna in beneficenza. È di
ieri la notizia che la signora Scott ha deciso di donare altri 2.74 miliardi di
dollari a 286 organizzazioni. Non è la prima volta. Nel luglio 2020 aveva già
donato 1,7 miliardi a 116 organizzazioni, a dicembre altri 4,2 miliardi erano
andati a 384 organizzazioni. Un totale di otto miliardi negli ultimi undici mesi
per lei non sono un problema visto che le azioni di Amazon - ne possiede un
quarto - sono schizzate ulteriormente in alto grazie alla pandemia, tanto da
fare scrivere al New York Times che «Mrs Scott sta accumulando ricchezza più
velocemente di quanto possa spenderla». Eppure è una cifra che fa impressione,
anche per il modo in cui è elargita. A differenza di Melinda Gates, Scott non ha
creato una sua fondazione, cosa che richiederebbe documenti pubblici sulle spese
e la presenza di uno staff. Quando decide di donare, scrive un post sul blog che
ha sulla piattaforma Medium in cui si lascia andare ad alcune riflessioni
(«sarebbe meglio se la ricchezza non fosse concentrata in un piccolo numero di
mani», ha scritto nell' ultimo) e lo annuncia al mondo. Chiamarlo un metodo
anticonvenzionale di filantropia è un eufemismo. Tra i riceventi di questo nuovo
ciclo di donazioni ci sono l'Apollo Theatre, il Balletto Hispánico e il Dance
Theatre di Harlem a cui sono andati 10 milioni. Simili quantità sono andate all'
Università della California e all' Università del Texas, a organizzazioni
focalizzate sulla giustizia razziale come la Race Forward e Borealis
Philanthropy, a gruppi incentrati sull' equità di genere e sulla lotta alla
violenza domestica e ad altre organizzazioni non profit tra cui l'Authors League
Fund, che aiuta gli scrittori in difficoltà finanziarie, e Afrika Tikkun, che
lavora per porre fine alla povertà infantile in Sud Africa. Istituzioni scelte
personalmente da lei, dal marito Dan e da un gruppo di consulenti e ricercatori.
«Vorrei che l'attenzione fosse su di loro», ha scritto nel blog. «Anche se so
che gli articoli saranno sulla mia ricchezza». E poi: «Questi 286 gruppi sono
stati selezionati attraverso un rigoroso processo di ricerca e analisi. Queste
sono persone che hanno passato anni a portare avanti con successo obiettivi
umanitari, spesso senza sapere se ci sarebbero stati fondi nei loro conti in
banca. Cosa pensiamo che potrebbero fare con più soldi a disposizione di quanto
si aspettassero? Acquistare i rifornimenti necessari. Trovare nuovi modi per
aiutare. Assumere personale extra sapendo di poter pagare loro lo stipendio per
i prossimi cinque anni. Comprare delle sedie. Smettere di lavorare durante il
fine settimana. Dormire un po'».
Francesco Semprini per "la Stampa" il 17 giugno
2021. Melinda French Gates inaugura la sua campagna per il rafforzamento della
previdenza sociale partendo dalla Casa Bianca. L' obiettivo è di incassare
l'appoggio delle istituzioni su alcuni temi portanti come i congedi retribuiti,
in particolare a scopo parentale, e l'assistenza all' infanzia.
E non a caso l'ex moglie di Bill Gates è partita
dal 1600 di Pennsylvania Avenue, visto che nel piano infrastrutturale presentato
da Joe Biden, il cui valore complessivo si aggira attorno ai 4 mila miliardi di
dollari, è riservata una rilevanza particolare a questi aspetti. La signora
French Gates si è così recata due giorni fa alla Casa Bianca dove ha avuto
colloqui col capo di gabinetto del presidente Ron Klain, e la consigliera per la
politica interna Susan Rice, assieme ad altri alti funzionari
dell'amministrazione. «Melinda ha incontrato i leader a Washington per ragionare
su strategie volte a far fronte alla pandemia (in particolare nel Sud del Mondo)
ringraziando al contempo i politici per gli sforzi compiuti a sostegno della
campagna di vaccinazione globale - ha reso noto una portavoce -. Si è anche
sottolineata la necessità di una politica federale di congedo retribuito per
sostenere la ripresa economica e occupazionale». Nell' agenda dei lavori
dell'attivista filantropica ci sono stati anche una serie di incontri con membri
di Capitol Hill, tra cui la senatrice Patty Murray di Washington, lo Stato di
origine dell'ex marito e la sede del quartier generale di Microsoft, il gigante
del software co-fondato da Bill assieme a Paul Allen nel 1975 che ha sede,
appunto, a Redmond. La scorsa settimana, French Gates si è unita invece al
Democratic Women' s Caucus per dare il via a un incontro virtuale con esperti e
addetti ai lavori dove si sono formulate proposte incentrate su assistenza ed
emancipazione economica delle donne. French Gates e la sua organizzazione,
Pivotal Ventures, si battono da tempo per agevolare politiche volte a favorire
il rafforzamento del ruolo delle donne nella società anche attraverso una
maggiore assistenza all' infanzia. Oltre a perorare campagne di ampio respiro
rivolte al sostegno delle realtà meno fortunate del Pianeta. In questo senso
l'ex moglie di Bill (i due hanno annunciato la separazione a maggio con un Tweet
e dopo aver raggiunto un corposo e articolato accordo) ha trovato una sponda in
Biden che ha posto alcuni di questi temi al centro della propria politica di
rilancio del Paese nel post pandemia. La prima gamba dell'American Jobs Plan (2
miliardi di dollari) prevede stanziamenti in grandi opere come strade, ponti,
completamento della banda larga, ammodernamento della rete elettrica e di quella
idrica. La seconda fase (per altri 2 mila miliardi) è stata modulata per agire
su altri settori economico-sociali affetti talvolta da obsolescenza, come
sanità, assistenza e istruzione. Una sintonia perfetta si profila tra Joe e
Melinda che si innesta perfettamente nel solco delle attività portate avanti
dalla Fondazione Bill & Melinda Gates sopravvissuta indenne alla separazione fra
i due, come ha tenuto a sottolineare lo stesso Bill. «Continuiamo a condividere
la nostra convinzione in questa missione e ci lavoreremo insieme ma non crediamo
di poter crescere come coppia». Fine dell'amore, quindi, ma non
dell'organizzazione filantropica con un patrimonio di circa 50 miliardi di
dollari, frutto di un progetto nato nel 1993, su una spiaggia di Zanzibar che ha
cambiato la vita di Melinda, in questo caso per sempre.
Un seggio, una matita, una
scheda: la prima volta delle donne in politica.
Emilio Gardini su Il
Quotidiano del Sud il 13 giugno 2021. Ne "Il racconto dell’ancella", romanzo
distopico della scrittrice Margareth Atwood che esce nel 1985, i moderni Stati
Uniti d’America, in piena crisi ambientale che causa infertilità portando quasi
a zero le nascite, diventano una teocrazia totalitaria nella quale le donne sono
ridotte a oggetto di proprietà degli uomini. In seguito al colpo di Stato, le
poche donne fertili perdono lo status di “donne libere” e diventano “funzionali”
solo alla riproduzione biologica. Addirittura le donne di coloro che sono al
potere, le mogli dei comandanti, non possono ricoprire cariche politiche né
essere autonome e indipendenti. Si tratta di letteratura distopica, certo, che
fa pensare a tempi lontani, quando “essere liberi” significava “essere maschi e
borghesi”. Un mondo patriarcale e autoritario, nel quale la sfera dei diritti
politici e civili non è accessibile a tutti, soprattutto alle donne. Ma, va
detto, la concezione di individuo dell’età moderna, non tiene conto
completamente della condizione femminile. Autonomia e proprietà (della propria
persona e di beni) sono le condizioni che definiscono gli individui nelle
società libere, e “proprietari e indipendenti” sono soprattutto gli uomini. Gli
Stati moderni faticano a includere le donne nel processo di modernizzazione
della società, anzi spesso esse rappresentano “l’ancoraggio” ai valori
tradizionali contro la paura del mutamento sociale. E infatti, la questione del
“riconoscimento politico” delle donne in Italia non si chiude affatto con il
diritto di voto che solo 75 anni fa viene riconosciuto, tra l’altro con ritardo
rispetto alla gran parte dei paesi europei. Quel 2 giugno del 1946 in Italia le
donne votano per la prima volta con gli uomini, che non votavano anch’essi da
tempo perché durante la dittatura fascista non ci furono elezioni. Per circa 2
milioni di voti, non tantissimo, la scelta della repubblica sulla monarchia. Si
votò anche per l’Assemblea Costituente, 21 donne vennero elette e di queste
alcune fecero carriera politica. Fu senza dubbio un traguardo importante. Si
veniva fuori dal dramma della seconda guerra mondiale e dal disastro del
fascismo che aveva rafforzato l’immaginario patriarcale che relegava la donna a
custode della casa e della famiglia con il ruolo unico di procreare, occuparsi
dei figli e servire l’uomo. Poche possibilità di lavoro, se non nei lavori “di
cura” che più si confacevano alla “naturale” propensione femminile. Anche ai
tempi dell’Italia liberale la donna si trovava in condizione di subalternità
rispetto all’uomo ma il fascismo riuscì ad annichilire totalmente il desiderio
di emancipazione. Dunque, con il diritto di voto nel dopoguerra non si trattò
tanto di riconquistare qualcosa quanto piuttosto di affermare ciò che in passato
non c’era stato. Tuttavia l’ottenimento del diritto di voto non fu vero e
proprio riconoscimento politico, non rappresentò in tutto “l’ingresso” delle
donne nel mondo democratico e moderno.
L’ottenimento della
cittadinanza politica – intesa come piena realizzazione dei diritti civili,
politici, sociali che non si esaurisce con la sola partecipazione al voto – è un
processo lungo, conflittuale, che va compreso nel quadro articolato delle
trasformazioni sociali che investono l’Italia per certi versi ancora legata a
strutture familiari tradizionali anche in piena modernizzazione e crescita
economica. Ancora dopo l’ottenimento del diritto di voto le donne sono in
condizioni di “minorità”; non sempre ricevono lo stesso trattamento degli uomini
sul lavoro (quando hanno accesso a posizioni lavorative almeno equiparabili a
quelle degli uomini) e sono in posizione subalterna in famiglia nei confronti di
padri e fratelli. Inoltre, questione di non poco conto, non entrano appieno
nella sfera della politica che, in quanto spazio di potere, non può che essere
soprattutto maschile. Anche se i primi movimenti femminili che hanno rivendicato
il suffragio sono stati importanti, e anche se le donne hanno avuto un ruolo
rilevante nella liberazione dal nazifascismo, fino agli anni sessanta non cambia
molto nell’immaginario collettivo, dove la divisione tra i sessi riproduce la
divisone sociale dei ruoli basata sulla disuguaglianza. Il ’68 stesso, che fu un
momento di grande coinvolgimento dei giovani, ragazzi e ragazze, fu segnato
dalla cifra del “maschile” di cui la società italiana era pregna. I movimenti
studenteschi però furono uno spazio importante di ripensamento delle categorie
tradizionali e soprattutto di rottura verso quelle prescrizioni autoritarie
connaturate nelle istituzioni della società, nella scuola, in famiglia, nelle
università. La contestazione e la questione della liberazione dall’autorità
assunsero un significato particolare per le donne in termini di legittimazione
della propria presenza nella società. È importante ribadire che il vero
cambiamento non può che avvenire con la partecipazione attiva, politica, con le
rivendicazioni nello spazio pubblico della città, nelle piazze, nei movimenti
sociali. È in questo modo, negli anni settanta, che i diritti vengono realmente
guadagnati dalle donne e il “riconoscimento politico” perde il carattere della
semplice elargizione. L’emancipazione politica può rappresentare talvolta una
mera concessione di diritti e di libertà ai cittadini e non essere vera
liberazione, lo scriveva Karl Marx nella fase giovanile, se le sopravvivenze
culturali continuano ad alimentare le disuguaglianze di status. Il suffragio
universale femminile ha rappresentato senza dubbio una tappa importante ma
l’emancipazione si traduce in riconoscimento politico quando scuote con forza o
addirittura scardina l’apparato ideologico. Così il riconoscimento diventa
riconoscimento della dignità della persona nella sua integrità politica (e
quindi collettiva) che si afferma nello spazio pubblico. Nel descrivere una
passeggiata immaginaria in un college inglese, luogo maschile per eccellenza,
scriveva Virginia Wolf nel saggio Una stanza tutta per sé: “Qui c’era il prato,
più in là il vialetto. Soltanto ai membri del College e agli Studiosi è
consentito poggiare i piedi qui; il mio posto è la ghiaia”. Ecco,
l’emancipazione femminile ha aperto la via per l’occupazione del “prato”.
A Pillon non rispondiamo soltanto con
Samantha Cristoforetti. Se per il senatore Pillon le
donne hanno una naturale propensione «alle materie legate all'accudimento»,
facciamo bene ad indignarci. Magari senza scomodare "l'eccezione" di
AstroSamantha, ma discutendo di qualche dato. Francesca Spasiano su Il Dubbio il
29 maggio 2021. Ci siamo cascati di nuovo. Ieri l’altro il senatore Simone
Pillon ha dichiarato a mezzo social che le ragazze sì, magari vanno anche
all’Università, ma è noto che abbiano una naturale «propensione per materie
legate all’accudimento, come per esempio ostetricia». L’occasione per farci
saltare dalla sedia gli è servita su un piatto d’argento. Al leghista Pillon,
infatti, maestro della provocazione, non è sfuggita la decisione dell’Ateneo di
Bari di ridurre le tasse per le studentesse, in modo da incentivarle a
frequentare corsi di laurea “tipicamente maschili”. Ecco «l’ideologia gender»,
accusa Pillon, tanto per farcire di nuovi argomenti la sua crociata Facebook
contro il ddl Zan. Fatto sta che il popolo del web è subito insorto e non si è
fatto trovare impreparato. Anzi, ha prontamente affilato le armi della «prima
donna che…». E anche in questo caso la cronaca ha offerto l’appiglio per
argomentare: è proprio di ieri la notizia che Samantha Cristoforetti sarà la
prima donna europea a comandare la Stazione Spaziale Internazionale in occasione
dell’Expedition 68a che sarà lanciata nel 2022. Un «orgoglio italiano» che fa
piacere a tutti. Ma davvero per rispondere al Pillon sessista c’è bisogno di
scomodare il pur illustre esempio di AstroSamantha? O di Marie Curie, Margherita
Hack e via dicendo. Impugnare “l’eccezione” e mettersi a fare la lista della
spesa non è forse un modo per dargli ragione? Forse potremmo ragionare sul fatto
che non tutti siamo destinati allo Spazio. A qualcuna può persino piacere
ostetricia, e qualcun’altra può persino non gradire le materie scientifiche. Ma
qualunque sia la nostra “naturale propensione”, di certo questa non è
determinata dal genere. Ammesso che si debba parlare di “propensione”, e non si
debba invece discutere di possibilità. Perché a ben vedere è quel “tipicamente
maschile” che fa storcere il naso. Secondo l’ultimo rapporto sul “gender gap”
pubblicato lo scorso marzo dal consorzio interuniversitario Almalaurea,
statisticamente le donne «studiano di più, hanno più interessi e voti più alti,
ma nel lavoro hanno retribuzioni inferiori e sono penalizzate se hanno figli».
Nel rapporto, fondato “sulle performance formative e professionali delle donne,
dalla scuola superiore all’università, fino al mercato del lavoro” si legge che,
in base ai dati 2020, tra i «laureati di secondo livello, a cinque anni dal
conseguimento del titolo, le differenze di genere si confermano significative e
pari a 5,0 punti percentuali in termini occupazionali: il tasso di occupazione è
pari all’84,8% per le donne e all’89,8% per gli uomini». «Le differenze di
genere si confermano anche dal punto di vista retributivo», prosegue il
rapporto, secondo il quale «tra i laureati di secondo livello che hanno iniziato
l’attuale attività dopo la laurea e lavorano a tempo pieno emerge che il
differenziale, a cinque anni, è pari al 16,9% a favore degli uomini: 1.715 euro
netti mensili rispetto ai 1.467 euro delle donne». Si obietterà che tale divario
è determinato anche dalle diverse scelte di studio e professionali maturate da
uomini e donne. Ma se guardiamo alla composizione per genere tra i laureati
dell’Area Stem (science, technology, engineering and mathematics), scopriamo che
a fronte di una più elevata componente maschile (il 59,8 % rispetto al 40, 2%,
dati Almalaurea), le donne si distinguono per una migliore riuscita in termini
di voti e regolarità negli studi (tra le donne il 51,3% ha concluso gli studi
nei tempi previsti rispetto al 47,7% degli uomini) e ciononostante restano
penalizzate nel mondo del lavoro con una percentuale di occupazione pari
all’86,9% per le donne contro il 92,9% per gli uomini. Un dato confermato anche
dal Consiglio Universitario Nazionale, che nell’ultimo rapporto pubblicato a
dicembre 2020 mette in evidenza le disparità di genere nei gradi più alti della
carriera accademica all’interno delle Università italiane. Un divario
particolarmente accentuato nelle discipline dell’Area Stem, ma radicato anche
nelle facoltà di medicina, giurisprudenza ed economia. Insomma, abbiamo guardato
allo Spazio e ci siamo dimenticati della terra: ci siamo cascati di nuovo.
Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera” il 23
maggio 2021. A 29 anni Elle Parker ha già declinato la sua passione per i
cavalli in molti mestieri che nell' immaginario collettivo appartengono ai
cowboy del West: ha lavorato da «cowgirl» in ranch dell' Idaho e dell' Oregon
per poi tornare nel suo Montana dove, a Miles City, è stata assunta come
ispettore per il controllo di razze e stato di salute del bestiame. Poi la
passione per i cavalli l' ha riportata verso la vita di ranch e, soprattutto, l'
organizzazione dei rodeo. Un po' più a Est, a Kremmling, sulle Montagne Rocciose
del Colorado, Caitlyn Taussig è l' anima di Indigo, un ranch gestito da donne.
Crescendo ha visto sua madre impegnata soprattutto in cucina, mentre lei veniva
chiamata spesso a dare una mano col bestiame. Si è appassionata e, poco
interessata ai fornelli, ha capito che con le nuove tecnologie la forza fisica
dell' uomo non era più indispensabile per mandare avanti un allevamento e curare
i cavalli. Elle e Caitlyn sono solo due delle tante donne del West che stanno
interpretando il mestiere del cowboy al femminile. La stampa racconta storie
simili in molti Stati mentre i «ranch delle donne» si moltiplicano dal South
Dakota allo Stato di Washington all' Oregon, all' Oklahoma. Può sembrare una
stranezza, visto che da John Wayne in poi siamo abituati a considerare il West
terra di cowboy: uomini, appunto. Ma queste donne a cavallo la vedono
diversamente: nelle tribù indiane che hanno vissuto per secoli in queste terre,
con gli uomini impegnati nella caccia o guerrieri, erano le donne a occuparsi
del bestiame e della terra. E anche nei territori controllati dai messicani il
ruolo delle donne negli allevamenti era tutt' altro che marginale. Le cose sono
cambiate dopo il Seicento, con l' arrivo dei coloni dall' Europa che avevano
altre idee sulle divisioni di ruoli tra sessi. Al resto ha pensato Hollywood.
Ora che i rapporti sociali sono cambiati, il genere western non trionfa più nei
cinema e la meccanizzazione dell' agricoltura e dell' allevamento ha reso la
forza fisica meno importante rispetto alle capacità di business e di marketing,
le donne si stanno conquistando un loro spazio nell' economia rurale dell' Ovest
americano. Anche perché i maschi che un tempo avrebbero ereditato stalle e
praterie oggi spesso preferiscono cercare lavori più comodi in città. Già dalle
indagini fatte qualche anno fa dal ministero dell' Agricoltura Usa (dati del
2012) era emerso che il 14% dei 2 milioni di business agricoli Usa aveva un
proprietario donna. Intanto è nata una letteratura sulle cowgirl e la sola
associazione Women in Ranching raccoglie 200 imprenditrici che gestiscono 140
ranch al femminile. Da allora il fenomeno sembra essere ulteriormente cresciuto.
Ranch che producono e allevano, ma spesso ospitano anche gente delle aree urbane
a caccia di esperienze outdoor. Come il Ranch 320 di Gallatin Gateway, in
Montana con l' allevamento dei cavalli e l' accoglienza degli ospiti gestita
insieme da uomini e donne. Ma stanno diventando numerosi i ranch women only come
Indigo o Wild West Women: a volte veri camp di addestramento per donne «toste»
che cercano nell' Ovest l' ispirazione per emergere in finanza o nei team di
computer scientist di aziende tecnologiche dominati da uomini. Le donne sono in
genere più abili nel trasformare la vita di un ranch in un business redditizio,
ma non si tratta solo di fiuto per gli affari. Elle Parker, che si trascina
dietro in tutti i rodeo il figlioletto, Gabe, di 6 anni, ha una passione
infinita per la vita all' aria aperta: «Dopo il liceo ho fatto sei mesi alla
Montana State University ma non sapevo che lavoro volevo fare. Sapevo che volevo
girare il mondo a cavallo: ho cominciato a vagare per ranch, dal Montana all'
Idaho, all' Oregon. Nessuno si è meravigliato, tutti mi hanno dato lavoro».
Massimo Falcioni per "tvblog.it" il 17 maggio
2021. La tv è davvero maschilista? Il discorso rispunta ciclicamente e l’ultima
ad aver riacceso la miccia è stata Rula Jebreal. La giornalista, che ha
rifiutato l’invito di Propaganda Live in quanto unica donna tra gli invitati, si
è soffermata sugli ospiti. Ma si sa, l’ospite lo si convoca in base al contesto,
alle esigenze del momento e alle storie che si intendono raccontare. Il discorso
al contrario cambia, e di molto, se l’occhio di bue si accende sui conduttori.
Questi offrono una fotografia stabile e molto più nitida della reale situazione.
Ecco allora che si torna al quesito di partenza: la tv è davvero maschilista? La
risposta è no. Basta darle una sbirciata in lungo e largo, dalla mattina alla
sera, sette giorni su sette. Prendiamo il sabato sera, giorno in cui si
concentrano le principali sfide del piccolo schermo: da anni il duello
riguarda Milly Carlucci e Maria De Filippi. Mutano i programmi – Ballando con le
stelle e Cantante Mascherato da una parte, Amici e C’è posta per te dall’altra –
eppure il risultato non cambia. Sì, c’è Tu si que vales, show a guida corale, ma
anche qui l’impronta di Maria sembra predominante, al pari di quella di Gerry
Scotti. La musica non cambia la domenica: scavallato il pranzo, parte
l’invasione femminile: Mara Venier a Domenica In, Barbara D’Urso a Domenica
Live, Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, Camila
Raznovich a Kilimangiaro e Francesca Fialdini a A ruota libera. Tinte rosa pure
al mattino, nei feriali: è il caso di Luisella Costamagna ad Agorà, di Gaia
Tortora e Alessandra Sardoni a Omnibus, di Eleonora Daniele a Storie Italiane,
di Barbara Palombelli a Forum, di Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno,
di Myrta Merlino a L’Aria che tira e di Adriana Volpe a Ogni Mattina. E quando
l’uomo appare lo fa quasi sempre in coabitazione con una collega, vedi Uno
Mattina, Mattino Cinque e Mi manda Rai 3. Si prosegue al pomeriggio: a Oggi è un
altro giorno e Detto Fatto ci sono Serena Bortone e Bianca Guaccero (entrambe
subentrate a Caterina Balivo), a Geo c’è Sveva Sagramola, a Tagadà c’è Tiziana
Panella, mentre su Canale 5 è staffetta tra la De Filippi (Uomini e Donne) e la
D’Urso (Pomeriggio Cinque). L’eccezione è rappresentata da Alberto Matano a La
vita in diretta, dove però la doppia guida uomo-donna è stata portata avanti per
ben due lustri fino al giugno scorso. Un’altra fascia dove per il maschio
l’ingresso è off-limits è il talk di access prime time. A Otto e mezzo, Stasera
Italia e Tg2 Post regnano infatti quattro donne: Lilli Gruber, Barbara
Palombelli, Veronica Gentili (nei weekend) e Manuela Moreno. Stesso discorso, o
quasi, per i reality. Da Ilary Blasi ad Alessia Marcuzzi, passando per Simona
Ventura, Daria Bignardi, Paola Perego e la stessa D’Urso, il genere è stato poco
battuto dagli uomini (riciclati semmai come ‘valletti’ e inviati), con Alfonso
Signorini che ha infranto una sorta di tabù con le ultime due edizioni
del Grande Fratello Vip. Prima di lui, si ricordavano a malapena Nicola Savino
all’Isola (l’ultima targata Rai) e Carlo Conti al timone del dimenticato – e
dimenticabile – Ritorno al presente. Da notare, inoltre, come su La7 la figura
maschile sia ripetutamente accostata a quella del "supplente", con Francesco
Magnani e Alessio Orsingher fanno spesso le veci della Merlino e della Panella.
A sorpresa, le donne hanno saputo gradualmente imporsi in un settore
storicamente ‘maschilista’ come quello del calcio. Pertanto, non fanno più
notizia le conduzioni di Ilaria D’Amico, Anna Billò, Giorgia Rossi, Diletta
Leotta, Simona Rolandi e Paola Ferrari. Giusto per citarne alcune. Se c’è invece
un campo in cui il gentil sesso non riesce a sfondare è quello dei giochi e dei
quiz. Motivo per cui non troviamo donne nel preserale delle ammiraglie
(L’Eredità, Avanti un altro, Caduta Libera, Reazione a catena) e nemmeno nei
vari game piazzati altrove (Soliti Ignoti, Affari tuoi). A memoria, oltre alle
fugaci esperienze di Clerici e Ventura ad Affari Tuoi e Le tre scimmiette, non
si registrano altri esperimenti. Ci siamo concentrati sulla quantità,
volutamente. Perché su quello si è soffermata la Jebreal con la sua protesta. Il
discorso, tuttavia, non ci entusiasma. Le donne ci sono e non per rispettare
delle quote, o una sorta di immaginaria par-condicio. Ci sono dove è giusto che
ci siano, dove c’è domanda. In televisione vanno analizzati i contenuti, a
prescindere da chi li veicola. Nessuno dovrebbe ispirarsi al manuale Cencelli,
almeno per il sesso. E anche un palinsesto riempito al 99 per cento da soli
uomini – o sole donne – sarebbe ampiamente giustificato, qualora la scelta fosse
basata sulla professionalità e la preparazione.
ELISABETTA BELLONI, LA PRIMA DONNA A CAPO
DELLA SICUREZZA ITALIANA. Il Corriere del Giorno il 12
Maggio 2021. La nomina della Belloni è stata disposta sentito il Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica, a garanzia della sicurezza
dello Stato e delle istituzioni. È la prima volta che in Italia una donna arriva
alla guida dell’intelligence. In suo favore è stata importante la grande
esperienza di ambasciatrice da sempre in prima linea nelle emergenze
internazionali. Il prefetto Vecchione termina in anticipo il suo mandato:
nominato nel novembre del 2018 dall’allora premier Conte,si era visto rinnovare
l’incarico per 2 anni nell’estate scorsa. Il premier Draghi ha scelto e nominato
Elisabetta Belloni a capo del Dis, il Dipartimento delle Informazioni per la
Sicurezza al posto dell’attuale Direttore generale, il prefetto Gennaro
Vecchione, dopo aver preventivamente informato della propria decisione Raffaele
Volpi, presidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica. La nomina è stata disposta sentito il Comitato interministeriale per
la sicurezza della Repubblica, ringraziando Vecchione per il lavoro svolto a
garanzia della sicurezza dello Stato e delle istituzioni. Confermato per un anno
il prefetto Mario Parente attualmente alla guida dell’ AISI, il servizio segreto
interno dello Stato. Elisabetta Belloni, romana, 61 anni, laureata in scienze
politiche alla Luiss nel 1982, è entrata in carriera diplomatica nel 1985,
ricoprendo incarichi, tra gli altri, a Vienna e Bratislava.Era segretario
generale alla Farnesina, ruolo che ha ricoperto per cinque anni, dal 2016 a
oggi, sostituendo Michele Valensise, per la Farnesina la sua nomina era stata
una novità assoluta: infatti fino a quel momento, quell’incarico era stato
ricoperto soltanto da uomini. Al posto della Belloni è stato nominato
l’ambasciatore Ettore Sequi, sinora capo di gabinetto del ministro degli
Esteri Luigi Di Maio. L’ambasciatrice Belloni, fin da ragazza è stata
un’apripista . Infatti, fu la prima studente di sesso femminile a essere
ammessa, insieme a un’altra ragazza, all’Istituto “Massimiliano Massimo” dei
Gesuiti, scuola fino a quel momento esclusivamente maschile. Lo ha fatto anche
successivamente, durante la sua carriera al ministero degli Esteri: dall’Unità
di crisi (Udc) alla direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo (Dgcs)
fino all’ultimo incarico ricoperto prima della nomina a segretario generale:
quello di capo di gabinetto del ministro Paolo Gentiloni. Tutte queste
posizioni, infatti, con l’ambasciatore Belloni sono state coperte per la prima
volta da una donna. Ma non tutti sanno di cosa si occupa il Dis. Principalmente,
coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, compresa quella
relativa alla sicurezza cibernetica e ne verifica i risultati, oltre a essere
informato costantemente delle operazioni di Aise e Aisi e trasmette al
Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal
Sistema; raccoglie informazioni, analisi e rapporti prodotti da Aise e Aisi, da
altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca. Inoltre, il Dis elabora
analisi strategiche o relative a particolari situazioni da sottoporre al Cisr o
ai singoli ministri che lo compongono e promuove e garantisce lo scambio
informativo tra i servizi di informazione e le Forze di polizia. “Rivolgo i miei
sentiti e sinceri complimenti all’ambasciatore Elisabetta Belloni per il nuovo
incarico alla direzione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(Dis). La vasta esperienza professionale ed il profilo umano sono doti che
consentiranno un contributo saldo e costante alla sicurezza nazionale. Al
prefetto Mario Parente confermato alla guida dell’Aisi ribadisco la mia stima
certo che possa dare continuità all’ottimo lavoro che sta svolgendo. A tutti e
due i migliori auguri di buon lavoro nel comune supremo interesse della nostra
Italia” ha dichiarato il presidente del Copasir Raffaele Volpi. La nomina di
Elisabetta Belloni ha messo d’accordo tutti, anche due avversari politici
come Matteo Salvini e Matteo Renzi. “Buon lavoro a Elisabetta Belloni, donna di
valore nominata ai vertici del Dis, e buona prosecuzione al generale Mario
Parente” ha commentato su Twitter il leader della Lega, mentre Renzi leader
di Italia Viva sottolinea: “La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del Dis è
un’ottima scelta per le Istituzioni italiane” a cui si è aggiunto l’ex
presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini: “La nomina di Elisabetta
Belloni a capo del Dis premia una donna di grande valore, di profonda conoscenza
delle relazioni internazionali e di sicura affidabilità. Sono certo che
interpreterà al meglio un ruolo così delicato per le istituzioni democratiche
del nostro Paese”. È la prima volta che in Italia una donna arriva alla guida
dell’intelligence. In suo favore è stata importante la grande esperienza
dell’ambasciatrice Belloni, da sempre in prima linea nelle emergenze
internazionali. A capo per anni dell’unità di crisi della Farnesina, ha gestito
i sequestri degli italiani in Iraq lavorando fianco a fianco con gli 007 e
diventando punto di raccordo per l’azione del governo per la liberazione degli
ostaggi, ma anche punto di riferimento per le famiglie. Da segretario del
ministero degli Esteri si è occupata dell’organizzazione della Farnesina. La
nomina dell’ambasciatrice Belloni alla guida e coordinamento dei servizi segreti
italiani (AISI ed AISE) conferma la volontà del presidente del Consiglio di dare
una svolta agli assetti dell’Intelligence italiana con una nomina di peso. Dopo
la scelta del prefetto Franco Gabrielli, ex capo della Polizia di Stato, come
autorità delegata per l’Intelligence e la Sicurezza, il premier Draghi ha scelto
un altro vertice di alto livello dell’amministrazione dello Stato. Una decisione
che conferma la volontà di rafforzare il comparto sicurezza per essere pronti
alle sfide economiche e geopolitiche affrontate dal Paese. Il cambio ai vertici
non sarà certo l’ultimo intervento del governo sulle nomine, in quanto sarebbe
imminente anche un cambio dei vicedirettori del Dis.
Francesca Sforza per "la Stampa" il 13 maggio
2021. Se è la prima volta che i servizi avranno una donna come capo, non è la
prima volta, per quella donna, arrivare prima. Elisabetta Belloni, classe 1958,
nominata ieri alla direzione generale del Dipartimento delle Informazioni per la
Sicurezza, ha alle spalle una storia di comando all'interno della Farnesina, che
nell'ultima puntata l'ha vista nel ruolo di Segretario Generale, ma che è stata
costruita con pazienza anche nelle puntate precedenti, da quando fu la prima
donna a essere ammessa all'Istituto Massimo di Roma, lo stesso frequentato da
Mario Draghi. Segretario o Segretaria? Direttore o direttrice? Alla Farnesina il
dibattito sugli asterischi non è mai entrato, perché alla fine, per farsi
capire, si parlava sempre di "Lei": «Lo ha detto Lei», «A Lei non piace», «Lei è
d'accordo», «Bisogna chiederlo a Lei». Inizia la sua carriera all'estero alla
rappresentanza di Vienna, ma è il ritorno a Roma, nella Direzione nevralgica
degli Affari Politici, a farle capire che la sua storia sarebbe stata lì, dove
le cose si decidevano, dove il potere si mostrava nelle sue molte e differenti
sfaccettature. «Ha fatto poco estero», dicono i suoi critici. Ma molta Roma: ha
attraversato indenne il governo Berlusconi, quello Monti, quello di Letta e
Renzi, quello Conte e ora Draghi, a cui la lega un'amicizia di scuola, di
appartenenza, di conoscenze comuni, dai gesuiti alla Luiss, dove si è laureata,
ha tenuto corsi, ha fatto parte insieme a Paola Severino del Consiglio direttivo
e non manca, ancora oggi, a una riunione degli ex alunni. Il suo ingresso nella
rosa dei nomi che non si possono ignorare è datato 2004, quando diventa capo
dell'Unità di Crisi - prima donna, ancora - e si trova a gestire due situazioni
complesse come il rapimento dell'inviato di Repubblica Daniele Mastrogiacomo e
la tragedia dello tsunami, con italiani intrappolati nei paradisi thailandesi e
bisognosi di ogni tipo di assistenza. Le dirette televisive mostrano al Paese il
volto di questa donna ferma e minuta, sempre piuttosto elegante, che dava la
sensazione di avere la situazione in mano, non una parola di meno, non una di
troppo. Misura, strategia, capacità di calcolo e profonda conoscenza dei
meccanismi istituzionali: Elisabetta Belloni è il ritratto del grand commis
d'etat, senza cedimenti "all'in quanto donna". Si è convertita alle quote rosa
con il tempo: inizialmente era convinta - come spesso accade alle donne brave e
sostenute dalle circostanze - che fosse solo una questione di merito. Col tempo
si è resa conto dell'importanza di "fare rete", e sotto la sua reggenza - è
stata segretario generale alla Farnesina per cinque anni, un tempo lungo
rispetto al passato - gli incarichi di rilievo alle diplomatiche si sono
moltiplicati. Sposata con un uomo di oltre vent' anni più grande di lei - anche
lui diplomatico - e rimasta vedova da qualche anno, una casa nella campagna
toscana dove trascorre il (poco) tempo libero dagli impegni di lavoro,
Elisabetta Belloni ha costruito nel tempo una rete di contatti - dentro e fuori
la Farnesina - che costituisce il suo asset fondamentale. Non è un caso che il
suo nome, negli ultimi giri di nomine, sia stato in più occasioni evocato per
posti di rilievo, da ministro degli Esteri fino a presidente del Consiglio. Poi
la mano è sempre passata ad altri, ma Elisabetta Belloni non ha mai coltivato il
culto della sconfitta. Casomai il contrario: a ogni giro di nomine riprendeva il
suo lavoro a testa bassa, senza dichiarazioni improvvide, senza pencolamenti. I
suoi critici le rimproverano da sempre un eccesso di tatticismo, una tendenza al
compromesso mirante più a non scontentare che a promuovere, più a mantenere che
a innovare. Ma difficile - anche per chi la critica - non riconoscerle una
profonda sapienza nel gestire equilibri, e di fronte alle difficoltà, una salda
capacità di gestione. Amata da molti, tollerata da altri, Belloni esce dalla
Farnesina col passo sicuro di chi sa di aver fatto molto: «Con la sua nomina al
Dis - ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio - arriva un importante
riconoscimento per tutto il corpo diplomatico».
Elisabetta Belloni
nuovo capo dei servizi segreti: salta Vecchione, l’uomo di Conte “licenziato”.
Redazione su Il Riformista
il 12 Maggio 2021. L’ambasciatrice Elisabetta Belloni, 61 anni, è il nuovo capo
dei servizi segreti. La nomina del direttore generale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza (DIS) è arrivata dal presidente del Consiglio
Mario Draghi in sostituzione del prefetto Gennaro Vecchione. Il Presidente Mario
Draghi ha preventivamente informato della propria intenzione il Presidente del
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), Raffaele
Volpi, e ha ringraziato il prefetto Vecchione per il lavoro svolto a garanzia
della sicurezza dello Stato e delle istituzioni. La nomina è disposta sentito il
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Dopo la nomina di
Belloni, secondo quanto apprende l’Ansa da fonti informate,
l’ambasciatore Ettore Sequi, attualmente capo di gabinetto del ministro degli
Esteri Luigi Di Maio, è il nuovo segretario generale della Farnesina. IL PROFILO
– Nata a Roma, l’ambasciatrice Belloni, 63 anni, è stata la prima donna
segretario generale della Farnesina (dal 2016 ad oggi). Laureata in scienze
politiche alla Luiss, Belloni ha iniziato la carriera diplomatica nel 1985,
ricomprendo incarichi nelle ambasciate italiane e nelle rappresentanze
permanenti a Vienna e a Bratislava, oltre che presso le direzioni generali del
Ministero degli Affari Esteri. Dal novembre 2004 al giugno 2008 ha diretto
l’Unità di Crisi della Farnesina, passando poi a rivestire il ruolo di
direttrice generale della cooperazione allo sviluppo fino al 2013 e
successivamente direttrice generale per le risorse e l’innovazione. Nel febbraio
2014 è stata promossa ambasciatrice di grado e, dal giugno 2015, è stata capo di
gabinetto dell’allora ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. Nell’aprile 2016
viene nominata Segretaria Generale del Ministero degli Affari Esteri, ruolo che
ha mantenuto finora. Belloni era stata tra i nomi ipotizzati per il ruolo di
ministro nel governo Draghi, qualora non vi fosse stata la riconferma di Di
Maio. LA SCONFITTA DI CONTE – La scelta di sostituire Vecchione a sei mesi dalla
naturale scadenza del suo mandato è di fatto uno “schiaffo” del presidente del
Consiglio Mario Draghi al suo predecessore Giuseppe Conte, che aveva voluto con
forza Vecchione, suo amico, al Dis. L’irritazione di Conte, spiegano i
retroscena, sarebbe emersa anche durante le telefonate di rito durante le quali
il premier informa i leader di maggioranza e opposizione della nomina. Vecchione
però paga la volontà da parte di Draghi di un deciso cambio di rotta nella
gestione dei principali dossier. Quello più spinoso per Vecchione risale ormai
all’estate 2019, quando l’allora premier Conte incaricò il numero uno del Dis di
incontrare l’allora ministro della Giustizia americano William Barr per
condividere le informazioni che l’Italia aveva su Joseph Mifsud. Mifsud,
professore dell’università romana Link Campus, aveva fatto sapere
all’amministrazione Trump di avere mail segrete russe in grado di mettere in
difficoltà Hillary Clinton, candidata democratica alle Presidenziali del 2016.
Quell’incontro tra Vecchione e Barr, avvenuto fuori dalle regole, crearono un
caso con l’avvio di una istruttoria del Comitato parlamentare di controllo.
Chi è Elisabetta
Belloni, prima donna a capo dei servizi segreti: l’amicizia con l’ambasciatore
Luca Attanasio. Antonio
Lamorte su Il Riformista il 12 Maggio 2021. Elisabetta Belloni è la nuova
direttore generale del Dis, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza.
Si tratta della prima donna ai vertici dei servizi segreti italiani. Il suo nome
era circolato nei mesi scorsi anche per il ministero degli Esteri, confermato a
Luigi Di Maio nell’avvicendamento tra il governo Conte 2 e il governo Draghi, e
per il sottosegretariato con nomina ai servizi segreti, carica poi andata a
Piero Benassi. Belloni prende il posto del prefetto Gennaro Vecchione.
L’ambasciatore Ettore Sequi, capo di gabinetto del ministro degli Esteri Di
Maio, succede a Belloni come nuovo segretario generale della Farnesina. LA
CARRIERA – Belloni ha 62 anni. Romana. Era alla guida della macchina della
Farnesina dal 2016, prima donna segretario generale degli Esteri. Ha studiato al
liceo Massimo di Roma, lo stesso frequentato dal Presidente del Consiglio Mario
Draghi. Si è laureata in Scienze Politiche all’Università Luiss nel 1982. LA
DIPLOMAZIA – La sua carriera diplomatica è partita nel 1985. Ha ricoperto
incarichi a Vienna e a Bratislava. Belloni è stata nominata nel 2004 capo
dell’Unità di crisi del ministero degli Esteri. Anche in questo caso la prima
donna a ricoprire tale incarico. Durante quel mandato si occupò di dossier
delicati come i rapimenti di italiani in Iraq e Afghanistan e lo tsunami nel
sudest asiatico. Dal 2008 al 2012 è direttore generale per la Cooperazione allo
sviluppo e poi dal 2013 al 2015 ha assunto le funzioni di direttore generale per
le Risorse e l’innovazione. Promossa ambasciatore di grado nel 2014, nel 2015 è
stata capo di gabinetto dell’allora ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. Da
oggi coordinerà le due agenzie dei servizi segreti e si coordinerà con
l’autorità delegata Franco Gabrielli. L’AMBASCIATORE ATTANASIO – “L’Ambasciatore
d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e il
Carabiniere Vittorio Iacovacci sono rimasti vittime di una violenza che non
riusciamo a capire e ad accettare”. Questo il cordoglio dell’allora segretario
generale del ministero Belloni, in un intervento del 23 febbraio su Il Corriere
della Sera, dopo l’attacco in Congo che aveva colpito il collega e amico Luca
Attanasio. Con quelle parole aveva voluto salutare un “collega, amico e
Ambasciatore d’Italia” di cui “siamo orgogliosi”. “Ieri non sono riuscita a
esprimere ai familiari il dolore profondo di tutta la Farnesina e la vicinanza
sincera perché è prevalso il silenzio e la commozione”, aggiungeva, scrivendo di
ricorrere “quindi alla penna per lasciare traccia dell’esempio di Luca che spero
non svanisca negli anni a venire e che possa, invece, ispirare i più giovani che
hanno fatto la stessa scelta professionale”. Il suo ricordo di Attanasio, dal
2017 Ambasciatore a Kinshasa, corrispondeva a quello di “una persona buona,
affettuosa con la stupenda famiglia che amava sopra ogni cosa e che lo ha
accompagnato anche in Africa, nonostante la giovane età delle tre bambine” e al
tempo stesso “anche un vero diplomatico che ha affrontato la ‘Carriera’ con
l’entusiasmo di chi è consapevole della necessità di imparare e farsi le ossa
affrontando senza scorciatoie le sfide che la Diplomazia mette dinanzi a ogni
passaggio della vita professionale e personale”.
Antonio Lamorte. Giornalista
professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha
frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha
collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura,
spettacoli.
Matteo Persivale per il
"Corriere della Sera" il 5 maggio 2021. Se Nicole Kidman si disse felice, dopo
il divorzio dall'aitante ma non altissimo Tom Cruise, di poter tornare a
indossare i tacchi, Melinda Gates adesso potrà comprare tutti gli iPhone e i
computer Apple che vuole. I soldi, nel cammino della separazione non solo dal
marito ma dalla Microsoft, non le mancheranno: oggi la donna più potente del
mondo non è Angela Merkel, né Ursula von der Leyen, né Christine Lagarde, ma
Melinda Ann French Gates, nata il 15 agosto 1964 a Dallas, Texas, liceo dalle
Orsoline e laurea (con master) all'ottima Duke, sempre col massimo dei voti
tanto da scherzare sul suo essere una secchiona sposata con il secchione più
famoso del mondo. Melinda French Gates è la più potente non solo perché gestisce
(e continuerà a gestire) con Bill una Fondazione benefica da 50 miliardi di
dollari che porta il nome di entrambi, ma perché il patrimonio dell'ex marito è
di circa 150 miliardi di dollari e non è mai stato siglato, tra i due, un
accordo prematrimoniale. Non c'era un contratto per determinare, in anticipo,
quanti soldi sarebbero spettati alla moglie in caso di divorzio, neanche tra
Jeff Bezos e Mackenzie Scott e sappiamo come è finita - il patrimonio del
fondatore di Amazon, circa 129 miliardi di dollari, venne quindi diviso a metà.
Difficile prevedere cosa succederà, in termini di accordi finanziari, tra i non
ancora ex-coniugi Gates, ma è evidente che alcune legioni di avvocati stanno in
queste ore lavorando agli aspetti più pratici della separazione (Melinda si è
affidata allo studio del divorzista Robert Cohen che in precedenza ha lavorato
per Ivana Trump, Michael Bloomberg e il comico Chris Rock). Bill & Melinda hanno
passato trentaquattro anni insieme, ventisette dei quali come marito e moglie:
si sono conosciuti nel 1987 a New York, e si sono sposati il 1° gennaio 1994.
Tre figli - Jennifer, Rory e Phoebe - e una casa da 150 milioni di dollari
soprannominata Xanadu 2.0, versione aggiornata (al mondo digitale) della
megavilla del magnate protagonista di «Quarto Potere», il film di Orson Welles.
La questione dei figli, sotto il profilo finanziario, è stata risolta da anni:
Gates è convinto che «ereditare miliardi non aiuta a formare il carattere» e
d'accordo con Melinda ha stipulato che ciascuno dei tre figli erediterà
«soltanto» 10 milioni di dollari. Il resto finirà alla Fondazione. D'accordo, ma
cosa sarà della Fondazione stessa: continueranno Bill e Melinda a lavorare
fianco a fianco come nei decenni precedenti? L'intesa, tra i due, è sempre stata
civile: Gates, uomo magari non straordinariamente carismatico ma di ammirevole
pragmatismo, fece presente all'allora fidanzata Melinda che gli sarebbe piaciuto
continuare con una tradizione alla quale era affezionato, un weekend all'anno
passato in vacanza con un'amica (e ex fidanzata), l'ex programmatrice Microsoft
e ora venture capitalist Ann Winblad. Melinda disse sì, e Bill anche da sposato
continuò la tradizione. D'altronde c'è un aneddoto che fa capire bene l'indole
precisina del personaggio: quando ancora erano fidanzati Melinda lo scoprì
intento a annotare in un grafico, su una lavagna, i pro e i contro di un
eventuale matrimonio con lei.
Giuseppe Sarcina per il
"Corriere della Sera" il 5 maggio 2021. Nel 2020, anno primo della pandemia, due
figure tenevano testa alla linea minimalista di Donald Trump. Uno era il
virologo Anthony Fauci. L'altro Bill Gates, fiancheggiato dalla moglie Melinda.
Il New York Times scrive che per tutta la giornata di ieri, molti dei 1.600
collaboratori della Bill e Melinda Gates Foundation si sono scambiati messaggi
preoccupati. «E adesso?». Il direttore esecutivo, Mark Suzman, ha provato a
rassicurare tutti: «È chiaramente un momento difficile sul piano personale, ma
entrambi mi hanno assicurato che continueranno a impegnarsi nella Fondazione».
L'organizzazione, costituita nel 2000 dal fondatore di Microsoft insieme con la
moglie, è considerata la più importante non profit del mondo. Naturalmente
contano le risorse: il capitale ammonta a 50 miliardi di dollari. Ma ciò che
spicca è l'approccio innovativo. Poca assistenza, poca filantropia consolatoria;
tante iniziative di grande impatto politico. Bill e Melinda hanno chiamato a
raccolta scienziati e manager di alto livello. Hanno intuito fin dal 2000 la
pericolosità delle pandemie; hanno elaborato progetti concreti per contrastare
il «climate change». Un modello da studiare, cui si sono ispirati, tra gli
altri, Michael Bloomberg e l'attore Sean Penn con la sua Core. Non è esagerato
sostenere che oggi la Fondazione dei Gates possa essere paragonata a uno Stato
sovrano. L'anno scorso Donald Trump decise di bloccare i finanziamenti
all'Organizzazione mondiale della Sanità, pari a 889 milioni di dollari, il 20%
del capitale a disposizione dell'agenzia Onu, fondata nel 1948. L'ex presidente
americano accusò il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom, di essere «un pupazzo
manovrato dai cinesi». Ci fu una grande polemica. Ma negli Stati Uniti solo i
Gates fecero un passo concreto. Bill difese apertamente Adhanom e la Fondazione
confermò la posizione di secondo finanziatore dell'Oms, con una quota di 531
milioni di dollari. La Fondazione ha ormai una funzione di guida mondiale nella
lotta alla pandemia: ha investito 1,75 miliardi di dollari nella produzione e
nella distribuzione dei vaccini, entrando in forze nel Covax, il consorzio
costituito per aiutare i Paesi più poveri. Negli ultimi mesi c'è stato anche
qualche contrasto tra i Gates e il neo presidente Joe Biden. La Casa Bianca ha
teorizzato e attuato l'America First in materia di immunizzazione: prima gli
americani, poi gli altri. Bill, invece, si è fatto intervistare regolarmente
dalle tv statunitensi per chiedere «più generosità» e anche «più lungimiranza» a
Biden. Senza una vaccinazione, rapida e universale, il contagio non sarà
sconfitto. Adesso bisogna capire se e come il divorzio potrà cambiare qualcosa.
Forse non sarà un problema di patrimonio. La ricchezza di Bill ammonta a 133
miliardi, quella di Melinda a 70 miliardi. I due hanno anche investimenti
finanziari separati con cui alimentare la Fondazione. Il tema, invece, sarà
quello della gestione. Bill, 65 anni, e Melinda, 56, hanno condiviso il lavoro
per venti anni. Hanno studiato, esplorato; sono cresciuti politicamente, sono
diventati protagonisti del dibattito pubblico. Sempre insieme: anche questa è
stata la loro forza.
Il doodle di Google. Laura Bassi, la
storia della prima donna al mondo a ottenere una cattedra universitaria.
Antonio Lamorte su Il Riformista il 17 Aprile 2021. È stata
la prima donna al mondo ad ottenere una cattedra universitaria. Laura Bassi,
nata a Bologna il 29 ottobre 1711, era fisica e accademica. È protagonista
del doodle di oggi di Google. Viene considerata la seconda donna laureata in
Europa; ricordata per la sua ricerca sulla dinamica dei fluidi,
nell’elettricità, nell’ottica e nella fisica newtoniana. Bassi il 17 aprile del
1732 sostenne la disputa De universa re philosophica davanti a un pubblico di
letterati, professori e religiosi presso il Palazzo Pubblico di Bologna. La sua
argomentazione colpì i presenti e il 12 maggio, neanche un mese dopo il suo
intervento, le venne conferita la laurea in filosofia. La cattedra onoraria le
valeva 500 lire annue ma poteva insegnare soltanto in alcune occasioni. Sposò ed
ebbe otto figli da Giuseppe Veratti, medico. I due intrapresero insieme studi di
fisica sperimentale e matematica. Si sposarono nel 1738. In casa avevano un
laboratorio di fisica sperimentale newtoniana. Dal 1749 cominciò a insegnare a
universitari aggirando il divieto di insegnamento per le donne. Quella casa era
un salotto culturale ricco e aperto a incontri e scambi scientifici e
filosofici. Le venne assegnato nel 1776 il posto di professore di fisica
sperimentale nell’Istituto delle scienze dell’Università di Bologna. Bassi era
particolarmente dotata in diverse materie: biologia matematica, logica,
filosofia, latino, greco e francese. Molte delle quali studiate e approfondite
in autonomia a casa. Tra i suoi primi allievi Lazzaro Spallanzani, lontano
parente, che grazie alla sua influenza lasciò gli studi in giurisprudenza per
dedicarsi alle scienze naturali. Bassi è morta, improvvisamente, la mattina del
20 febbraio 1778. Fu onorata con solenni esequie e seppellita, rivestita con le
insegne dottorali.
Antonio Lamorte. Giornalista professionista. Ha
frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di
Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di
stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.
Chi è Laura Bassi, prima donna docente
universitaria, cui Google dedica il doodle. Il
Quotidiano del Sud il 17 aprile 2021. Oggi, sabato 17 aprile, Google dedica il
suo doodle nella pagina di ricerca a Laura Maria Caterina Bassi, una delle prime
donne laureate in Italia e in Europa, e certamente la prima in assoluto al mondo
ad insegnare all’università: nel 1732 a Bologna, sua città natale (nel 1711) e
dove morì nel 1778. Laura Bassi fu avviata agli studi dai genitori, benestanti
ed entrambi istruiti, che dopo aver riconosciuto in lei delle doti non comuni le
presero un insegnante privato, Gaetano Tacconi, docente di biologia
all’Università di Bologna, con il quale studiò tutto quello che altrimenti le
sarebbe stato vietato nei collegi e all’università, in quanto donna. Nel 1732,
con il sostegno del cardinale Prospero Lambertini (dal 1940 divenne papa
Benedetto XIV) Laura Bassi riuscì a laurearsi in filosofia a soli vent’anni, in
seguito entrò a far parte del collegio dei dottori di filosofia e grazie a
questo ingresso ottenne una cattedra onoraria di filosofia. All’inizio della sua
attività accademica poteva tenere lezione solo in occasioni speciali, ma la
volta arrivò nel 1749 divenne titolare di regolari corsi di fisica sperimentale,
gli unici di questo tipo in città, nel laboratorio allestito in casa con il
marito, Giuseppe Veratti, medico e lettore di fisica particolare all’università.
Il suo corso venne successivamente riconosciuto a tutti gli effetti
dall’Università di Bologna, che le assegnò uno degli stipendi più alti
dell’ateneo. Nel 1766 divenne insegnante di fisica sperimentale al Collegio
Montalto di Bologna, mentre nel 1776 le fu assegnata la cattedra di fisica
sperimentale all’Istituto delle Scienze. Tra i suoi alunni ci fu anche quel
Lazzaro Spallanzani, suo cugino e futuro biologo famoso soprattutto per gli
studi sulla fecondazione artificiale, cui è dedicato l’ospedale forse tra i più
noti oggi a causa dell’emergenza coronavirus covid 19. Si sposò con Giuseppe
Veratti nel 1738 ed ebbe otto figli. Morì nel 1778 a 67 anni. A Bologna le sono
stati dedicati un liceo linguistico, un liceo musicale e una via nei pressi dei
Giardini Margherita.
Così l’ateneo bolognese ricorda la studiosa sul
suo sito, a questa pagina: “Laura Maria Caterina Bassi Verati – o Veratti
(1711-1778) è la più illustre tra le donne salite in cattedra, nata a Bologna il
29 ottobre 1711. Nel 1732, il Senato e l’Università di Bologna, dopo averle
conferito una laurea in Filosofia, le assegnarono una cattedra universitaria per
l’insegnamento della Fisica (allora denominata filosofia naturale), in tempi in
cui le donne erano ovunque escluse dagli studi e dalle professioni
intellettuali. Nello stesso anno fu cooptata come socia nell’Accademia delle
Scienze dell’Istituto di Bologna, un consesso fino ad allora solo maschile.
Laura Bassi condusse un’instancabile lotta per ottenere pari condizioni
nell’insegnamento e percorse una carriera intellettuale e professionale
nell’ambito di istituzioni pubbliche di ricerca e insegnamento in un periodo in
cui, in Italia e nel mondo, le università e le accademie erano mondi senza
donne. I numerosi studi, che negli ultimi anni le sono stati dedicati, hanno
messo in risalto l’importante ruolo da lei svolto nella diffusione in Italia
della filosofia naturale newtoniana e delle ricerche, allora pionieristiche,
sull’elettricità. Brillante lettore di filosofia, nonostante avesse numerosi
figli, continuò l’attività accademica e nel 1776 ebbe la cattedra di fisica
sperimentale nell’Istituto delle Scienze fondato da Marsili. Fu considerata dai
contemporanei donna di eccezionale ingegno, egualmente versata in latino,
logica, metafisica, filosofia naturale, algebra, geometria, greco, francese. Fu
in contatto con i più importanti studiosi del suo tempo, da Volta a Voltaire, e
illustri personaggi dell’epoca -di passaggio per Bologna – vollero conoscerla.
Le dissertazioni di Laura Bassi, conservate all’Accademia delle Scienze di
Bologna (una di chimica, tredici di fisica, undici di idraulica, due di
matematica, una di meccanica e una di tecnologia) rimangono a testimoniare il
ruolo di questa studiosa nella discussione scientifica del suo tempo“.
La nomina. Chi è Alessandra Galloni, la
prima giornalista donna alla direzione dell’agenzia Reuters.
Antonio Lamorte su Il Riformista il 13 Aprile 2021. Alessandra
Galloni sarà la prima donna a guidare l’agenzia di stampa Reuters. Un’agenzia
tra le più antiche, fondata nel 1851, e autorevoli al mondo. A farlo sapere la
stessa società attraverso il suo sito. Galloni è una giornalista italiana,
a Reuters dal 2013, dopo una precedente esperienza nella sezione delle news
italiane. “Onorata di guidare la migliore redazione al mondo”, ha twittato la
giornalista. Galloni ha 47 anni, è nata a Roma, parla quattro lingue e ha alle
spalle una lunga esperienza. Prenderà il posto di Stephen J. Adler, alla guida
negli ultimi dieci anni e prossimo alla pensione. Con la sua direzione la
testata ha vinto sette premi Pulitzer. Prima di tornare alla Reuters Galloni era
stata al Wall Street Journal. Si è laureata alla Harvard University nel 1995 e
alla London School of Economics con un master nel 2002. “Per 170 anni, Reuters
ha stabilito lo standard per l’informazione indipendente, affidabile e globale –
ha detto la giornalista dopo l’annuncio della sua nomina – È un onore guidare
una redazione di livello mondiale piena di giornalisti di talento, dedicati e
stimolanti”. Al Wsj aveva lavorato da corrispondente da Londra, Parigi e Roma.
Galloni entrerà in carica a partire dal 19 aprile. La Reuters conta uno staff di
circa 2.450 giornalisti in tutto il mondo. “Galloni – si legge sul sito
della Reuters – con base a Londra, è conosciuta internamente come una presenza
carismatica con un appassionato interesse nelle business news. Ha detto ai
colleghi che le sue priorità includeranno spingere la componente digitale di
Reuters e quella economica. Prende il timone dopo aver servito come editor
globale di Reuters, supervisionando giornalisti in 200 location in tutto il
mondo. all’inizio della sua carriera, ha lavorato al servizio di news in
italiano. Si è laureata alla Harvard University e alla London School of
Economic. È tornata alla Reuters nel 2013 dopo circa 13 anni al The Wall Street
Journal, dove si è specializzata in economia e finanza come reporter ed editor a
Londra, Parigi e Roma”.
Margherita Incisa di Camerana: il primo
ufficiale donna marciava a Fiume con d'Annunzio.
Tenente degli Arditi e moglie dell'eroe Elia Rossi Passavanti. Andrea Cionci su
Libero Quotidiano il 24 marzo 2021.
Andrea Cionci. Storico dell'arte, giornalista e
scrittore, si occupa di storia, archeologia e religione. Cultore di opera
lirica, ideatore del metodo “Mimerito” sperimentato dal Miur e promotore del
progetto di risonanza internazionale “Plinio”, è stato reporter dall'Afghanistan
e dall'Himalaya. Ha appena pubblicato il romanzo "Eugénie" (Bibliotheka).
Ricercatore del bello, del sano e del vero – per quanto scomodi - vive una
relazione complicata con l'Italia che ama alla follia sebbene, non di rado, gli
spezzi il cuore.
Dopo il primo pilota militare nero del mondo -
italiano e orgogliosamente fascista, tanto da diventare generale delle Camicie
Nere QUI - un altro personaggio manderà dallo psicanalista gli aedi della
storiografia ideologizzata. Parliamo della marchesa Margherita Incisa di
Camerana, il primo ufficiale-donna del mondo in età contemporanea:
interventista, dannunziana, fiumana, monarchica e moglie di un podestà. Prima di
lei, nel ‘7-‘800, già l’italiana Francesca Scanagatta, la russa Nadežda Durova,
la prussiana Eleonore Prochaska, la francese Marie-Thérèse Figueur avevano
indossato l’uniforme, ma tranne l’ultima, (che restò sottufficiale), tutte
dovettero dissimulare il loro sesso. All’epoca, infatti, gli eserciti non
badavano molto alle autoconvinzioni degli arruolandi sul proprio genere. Nata a
Torino nel 1879 dal marchese Alberto e dalla baronessa Amalia Weil Weiss,
Margherita Incisa, dopo il collegio, si arruolò nelle Infermiere volontarie il
20 aprile 1909. “Interventista convinta - scrive Elisabetta David - prese parte
attiva alla propaganda per la guerra a Torino contro il disfattismo giolittiano,
avendo ereditato da suo padre il più profondo disprezzo per quell’uomo di
governo”. Durante tutta la Grande Guerra, oltre ad essere dama di compagnia
della principessa Laetitia di Savoia, prestò servizio attivo al fronte in vari
ospedali da campo e come addetta ai doni e alla propaganda per le truppe i prima
linea. Ricorderà questa esperienza in un libro, “Nella tormenta”, pubblicato nel
1929. “La futura madrina degli arditi di Fiume – spiega lo storico della Grande
Guerra Paolo Cavassini - entra in contatto con le temibili “fiamme nere” già
nel maggio del ’18. Incaricata di consegnare da parte delle donne di Torino un
gagliardetto all’8° reparto d’assalto, gode da subito della stima e della
simpatia dei vari comandanti degli arditi, dal generale Zoppi, al maggiori
Freguglia, Nunziante e Vagliasindi. Ritroverà questi ultimi fra i fedelissimi
di d'Annunzio a Fiume. Nella travagliata atmosfera della “Vittoria mutilata”,
l’ex crocerossina interventista s’infiamma di passione fiumana. “Ho parlato di
Fiume – registra il 12 giugno 1919 -; mi si assicura che si stanno preparando
bande di volontari per difendere la frontiera. Se potessi essere utile
m’iscriverei anch’io”. L’occasione arriva esattamente te mesi dopo, quando il
Vate, sollecitato dagli irredentisti fiumani, rompe gli indugi e occupa Fiume
avvalendosi soprattutto di arditi. Margherita, naturalmente, è fra di loro".
Iniziava un sogno rivoluzionario che sarebbe culminato nella Carta del Carnaro,
un’epopea - come scriveva il legionario Eugenio Coselschi - composta da una
variegata schiera di “uomini vivi, armati di armi vere e di sentimenti
umanissimi”. Ma non solo uomini, come dimostra la Incisa, che fu nominata
Tenente degli Arditi, vale a dire il corpo precursore delle nostre Forze
Speciali. Dal 4 ottobre 1919 fino all’11 giugno 1920, la marchesa fu all’ufficio
propaganda del Comando, poi in forza alla compagnia della Guardia “La Disperata”
con varie funzioni di “commissariato”. Scriveva di lei il poeta Leone
Kochnitzky: “Fra gli Arditi c’è una donna che, sopra una succinta gonna
grigio-verde, porta la giacca coi risvolti neri. Prende parte alla marce, alle
esercitazioni; con una virile grazia, quest’anima ben temprata si piega alle
necessità rudi del blocco vigilando alla salute morale e alla disciplina delle
sue truppe”…Era, dunque, l’unica “ufficiala”, come qualcuno direbbe oggi, ma non
unica donna. Spiega il presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri: “Le
donne a Fiume venivano considerate legionarie alla pari degli uomini. Erano
spesso mogli di legionari, o crocerossine, o signore che volevano partecipare
all’impresa. Giravano con il pugnale e la pistola alla cintura e molte di loro
combatterono anche durante il Natale di Sangue, quando l’occupazione dannunziana
fu sgomberata dal Regio esercito italiano. La Carta del Carnaro anticipò di 26
anni il diritto per le donne di votare - ed essere votate - e di 70 anni quello
di indossare le stellette. A Fiume potevano condurre una vita disinvolta e “da
maschiacci”». Ancor più godibile, il fatto che uno dei moralisti-maschilisti più
critici con la Incisa e le sue “commilitone” fosse un socialista, Filippo
Turati, che, in una lettera alla compagna Anna Kuliscioff, scriveva: “Fiume è
diventato un postribolo, ricetto di malavita e di prostitute più o meno high
life. Nitti mi parlò di una marchesa Incisa che vi sta vestita con tanto di
pugnale”. E proprio in quel crogiolo di animi ardenti Margherita conobbe il
futuro conte Elia Rossi Passavanti. Era uno degli eroi più decorati (e
mutilati) della Grande Guerra, più giovane di lei di 17 anni, con il quale ebbe
una splendida storia d’amore che, ad onta del bigotto Turati, regolarizzò un
anno dopo con un matrimonio lungo e felice. “Dopo l’esperienza fiumana – spiega
lo storico militare Leonardo Malatesta – la Incisa rientrò nelle Infermiere
volontarie e fu ispettrice per la provincia di Terni; partì per l’Africa
orientale insieme al marito e, al ritorno, lo aiutò a diventare deputato.
Durante la Seconda guerra mondiale prestò servizio nella Campagna greco-albanese
presso l’ospedale di Tirana e sulla nave ospedale “Trapani”. Dal dopoguerra fu
attiva con associazioni monarchiche, civiche e benefiche. Morì a Roma il 5
febbraio 1964”. I cimeli di quest’eroina, come la divisa fiumana da tenente
degli Arditi, sono conservati a Terni nella casa del marito che, amatissimo
podestà della città umbra, alla sua morte, nel 1985, lasciò una Fondazione,
la Ternana Opera Educatrice, col preciso scopo di premiare i concittadini
meritevoli e di aprire al pubblico la casa-museo. La sua volontà non fu mai
esaudita: la fondazione, oggi legata alla Cassa di Risparmio di Terni,
nonostante il bilancio da un milione di euro, sostiene che “mancano i
fondi”. Ma i ternani vanno all’attacco con una sottoscrizione popolare QUI e,
probabilmente, con la benedizione dal cielo di una coppia di soldati non da
poco: Elia e Margherita.
Miriam Romano per “Libero Quotidiano” il 22 marzo
2021. Le orecchie sventolano lente e pesanti. La proboscide si arriccia e
spruzza l'acqua che sgorga come da un'antica fontana. L'età non la scalfisce. Il
peso degli anni è il vessillo del suo comando, indiscusso e ponderato.
L'elefante femmina più anziana è la matriarca: la regina del branco, guida
eletta per dirimere le controversie, assennata avventuriera della savana. I
maschi non ci provano nemmeno a soffiarle lo scettro. Il sesso dominante è
quello femminile. Ogni pronuncia della matriarca, che con zampe possenti marcia
lungo la terra e segna il tragitto per tutti, è perentoria. Nessuna gara di
forza. Nessuno che provi a mostrare i muscoli. Ci si affida al più saggio, come
suggerisce l'istinto, infallibile timone degli animali. E la saggezza è femmina.
In alto, elefanti e scimmie bonobo: specie animali in cui il dominio della
femmina è indiscusso. Anche nei branchi di lupi le "donne" dominano, foto sotto
Il predominio femminile non vale soltanto per gli elefanti. È una costante nel
mondo animale che seleziona gli esemplari di quello che noi definiamo "gentil
sesso" per affidargli le redini del branco. «Le femmine sono più vigorose, più
in salute, vivono più a lungo dei maschi, in virtù dell'apparato riproduttore
che le rende possenti», spiega l'etologo Roberto Marchesini. «Nel mondo animale
essere la fonte riproduttiva del branco ha una valenza molto significativa: il
potere di far andare avanti la specie si traduce automaticamente nel potere di
prendere qualsiasi tipo di decisione sociale», spiega ancora l'esperto. Agli
animali, in altre parole, non servono quote rosa. Semmai quote azzurre, come
dimostrano diversi casi di sottomissione maschile. «Il fatto in sé di generare
figli conferisce alle femmine il comando. Come non seguire le decisioni di chi
detiene un potere così grande?». La natura sovverte le logiche umane. Per le
donne mettere al mondo un figlio spesso significa abbandonare il lavoro o
ridurlo o non tentare nemmeno la scalata verso ruoli apicali. Fare figli relega,
ancora oggi, le donne a una dimensione domestica, unico cantuccio in cui possono
esercitare il potere. Tutto il contrario di quello che accade tra quattro zampe,
insetti e pesci: qui le femmine sono a capo di intere società, gestiscono le
lotte, decidono tempi e luoghi della caccia. L'esempio più immediato e più
vicino a noi è quello dei Bonobo, scimmie che si definiscono sagge, se non altro
perché dirimano i conflitti con il sesso anziché tuffarsi in guerre di sangue.
Tra questi primati non vige la legge del più forte, ma le leader dei Bonobo,
sempre femmine, spiccano per le grandi capacità di mediazione. Secondo gli
studi, le femmine hanno una così alta capacità di coalizione da riuscire a
sottomettere gli uomini: la più pertinace battaglia femminista nel mondo animale
è stata vinta. Anche le strutture familiari delle orche ruotano attorno alle
femmine del gruppo. Le più anziane, come per gli elefanti, detengono il potere.
Sono molto più longeve dei maschi, per questo non ci sarebbe partita tra i due
sessi. La matriarca vede crescere figli e nipoti e i suoi anni avanzati le
conferiscono lo scettro. Per non parlare dei lemuri, altri primati molto meno
docili dei Bonobo. Tra questa specie le femmine dominano con la forza. Tolgono
il cibo da bocca ai maschi, gli riempiono di morsi o schiaffi quando ne
disapprovano i comportamenti. Tra le iene invece le femmine sono più forti e più
grandi, così sottomettono i maschi. La caccia spetta al sesso maschile, ma non
per una questione di virilità: loro procurano il cibo e lo danno in pasto alle
femmine. Nessun maschio provi a fiondarsi per primo sullo spuntino: i primi
morsi spettano alle regine. Il mito del maschio dominante è da sfatare anche per
quanto riguarda i lupi. Ci vogliono arguzia e molte abilità per governare la
società dei lupi e sono le "lupe" a primeggiare. Le femmine prendono tutte le
decisioni più importanti: dove andare, quando cacciare, dove fare la tana. Una
maggiore parità tra i sessi, invece, regnerebbe tra gli uccelli. «In diversi
casi sia il maschio che la femmina covano insieme le uova e poi alimentano i
pulcini», spiega Marchesini. Ma anche nel mondo dei volatili capita che ci possa
essere un sovvertimento dei ruoli rispetto al nostro mondo. «Le femmine di
Jacana, grandi uccelli che camminano sull'acqua con zampe affusolate e artigli
incredibilmente lunghi, hanno veri e propri harem di maschi per cui depongono le
uova», aggiunge l'etologo. Queste femmine difendono persino i maschi attaccati
da altre femmine mentre covano. Sono i maschi, ancora, a occuparsi dei pulcini,
li portano sotto le ali, gli insegnano a procurarsi il cibo. Mentre le femmine,
immemori degli affari domestici, continuano la loro vita tra paludi e laghi. Non
dimentichiamo le api. La società matriarcale per eccellenza, dove domina su
tutti, fuchi e operaie, l'ape regina, padrona dei destini degli insetti e
custode dell'alveare. Senza l'ape regina al comando nessuna colonia di api
resisterebbe. Madre di tutti, viene nutrita con la pappa reale dai sudditi. La
mantide religiosa, invece, è lo spettacolare insetto che divora il maschio dopo
averlo sedotto. La femme fatale del mondo animale. Durante l'amplesso il povero
maschio viene decapitato e poi fagocitato. Non è un atto di crudeltà femminile.
È l'istinto materno che guida la femmina: si ciba del maschio per trarre le
energie per far crescere le uova. Dura è anche la vita del maschio che si
accoppia con la vedova nera, vere accalappiatrici che possono attirare fino a
quaranta partner in una sola notte. Dopo aver fatto fuori la concorrenza e
ottenuta la sua femmina, il destino dello sventurato non è molto diverso dal
maschio della mantide: anche lui viene divorato in un sol boccone.
Da liberoquotidiano.it il 15
febbraio 2021. Il botta e risposta tra Concita De Gregorio e Nicola Zingaretti
non si ferma. La prima “discussione” a distanza tra i due è nata qualche giorno
fa, quando la giornalista di Repubblica ha criticato la performance del
segretario del Pd al Quirinale, definendolo “un ectoplasma, tutto fuorché un
leader”. Per il suo giudizio, la De Gregorio si era beccata della radical chic
dallo stesso leader del Partito. Adesso invece la firma di Repubblica mette nel
mirino il Pd per la mancanza di una donna tra i ministri espressi dal partito.
“Si osserva che la più a sinistra in questo governo è Mara Carfagna (e che le
donne le porta Silvio)”, ha scritto la De Gregorio su Instagram. Un vero e
proprio attacco alle recenti scelte del Pd. Come scrive il Tempo, probabilmente
adesso si cercherà in ogni modo di impedire a Zingaretti di rispondere ancora
una volta, evitando così di dare inizio a un botta e risposta infinito.
All’interno del Pd, però, ci sarebbero – rivela il Tempo - molte parlamentari
dem schierate contro Zingaretti per la risposta data alla giornalista dopo le
prime critiche: “Il tono della replica di Nicola, che non avrebbe mai fatto una
cosa simile se a scrivere quel fondo fosse stato un uomo. Vergognosa prova di
machismo, e proprio contro una donna di sinistra", questa una delle frasi
sussurrate al Nazareno.
Giovanna Cavalli per il
“Corriere della Sera” il 15 febbraio 2021. Nemmeno la promessa di «rimediare»
allo sgarbo con i posti da sottosegretario placa la rivolta delle donne del Pd,
escluse dai tre ministeri che Draghi ha assegnato ai democratici. E la proposta
di Nicola Zingaretti accontenta forse solo chi è in odore di nomina. «Nel
partito esiste un problema di leadership, non di riconoscimento di ruoli,
incarichi o di competenze specifiche non valorizzate, lettura questa che sconta
un principio di subalternità», arringa l' onorevole dem Marianna Madia. «Il
problema del partito è un correntismo esasperato che condiziona le scelte e
riduce ogni passaggio alla ricerca di un equilibrio burocratico».
Concorda la collega Lia
Quartapelle: «Ha ragione, il problema che emerge è la leadership. E anche la
politica, aggiungo».
Realista Lucia Bongarzone,
responsabile Pari opportunità del Pd: «Le aspettative stavolta erano alte, per
questo il tonfo è ancora più pesante. La domanda è una: nel partito c' è una
cultura di genere o no? Perché altrimenti le belle proposte restano carta
straccia».
Indignata Simona Bonafè,
eurodeputata e segretaria regionale Pd Toscana: «La scelta del gruppo dirigente
del Pd di indicare solo figure maschili è una ferita aperta, uno sfregio alla
storia della sinistra».
Sostiene Cecilia D' Elia,
coordinatrice nazionale Donne democratiche, che «il tema non è un risarcimento
per la scelta di aver nominato ministri uomini, ma è a monte: bisogna chiedersi
perché le figure apicali del Partito democratico sono tutte maschili». E
rilancia: «Se Andrea Orlando lascerà la vicesegreteria, spero possa esserci una
donna al suo posto».
La senatrice Francesca Puglisi
sposta la prospettiva: «Tra noi donne del Pd c' è poca capacità di promuovere
una leadership femminile e molta timidezza a mettersi in gioco per cariche di
primo piano, anche perché è difficile raccogliere il sostegno delle altre
intorno ad una candidatura». Con inevitabili conseguenze: «Spesso il
rinnovamento è stato fatto sulla pelle delle donne, tant' è che è difficile
trovare in Parlamento politiche di lungo corso». Per lei, che nel Conte 2 era
sottosegretario al Lavoro - ministero dove adesso è approdato Orlando, esaurendo
la quota dem - sarebbe pronta la nomina a sottosegretario con delega allo Sport.
«Il problema bisognava porselo
prima», ragiona l' onorevole Alessia Morani, sottosegretaria uscente allo
Sviluppo economico. «Ci sono tre ministri per il Pd? E allora discutiamone,
pretendiamo che uno sia donna, non che stiamo zitte e poi ci stupiamo se gli
uomini si sistemano tra loro».
La ferita nei dem. Niente
ministre e il Pd si spacca, la protesta: “Nessuna sottosegretaria”.
Antonio Lamorte su
Il Riformista il 15 Febbraio 2021. Non era – a quanto pare – un capriccio, una
nuvola passeggera, un malumore temporaneo: le donne del Partito
Democratico stanno agitando il Partito Democratico. Una ferita partita venerdì
sera, quando il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato la squadra
di governo. Otto ministri su 23 donne, due di Forza Italia, una della Lega, una
di Italia Viva, una del Movimento 5 Stelle, tre tecniche (le uniche con
portafoglio). E nessuna del Pd. Una “ferita” l’hanno definita in tante. Ormai si
parla di rivolta. E quindi è partito l’hashtag #graziemaNOgrazie, a indicare il
probabile rifiuto, una specie di scintilla rivoluzionaria, a ricoprire incarichi
da sottosegretarie o viceministre, un rimedio che a quanto trapelato il
segretario dem Nicola Zingaretti aveva pensato di adoperare per placare la
rivolta. “E se tutte le donne di centrosinistra cui verrà chiesto di fare da
sottosegretarie, o viceministre, dicessero: ‘No, grazie, come se avessi
accettato’, e cominciassero a costruire qualcosa per uscire dall’angolo
davvero?”, aveva scritto sui social la giornalista Annalisa Cuzzocrea. Una
proposta che non è passata inosservata. Dei problemi della leadership femminile
nella politica ne aveva parlato in un’intervista a questo giornale la
scrittrice Giulia Blasi. Il tema è scottante, e anima il Partito in queste ore.
La portavoce della conferenza delle donne democratiche si riunisce oggi. La
portavoce Cecilia D’Elia parla di “ferita”, l’ex Presidente della Camera Laura
Boldrini sposa la campagna: “Non può bastare qualche posto da sottosegretaria”;
l’ex ministro Livia Turco definisce la mancanza di donne dem “frutto di una
logica maschilista e correntizia”; Debora Serracchiani fa notare come si tratti
della prima volta “in cui nella delegazione di governo del Pd non c’è una
rappresentanza femminile”; l’ex ministra Roberta Pinotti parla di una “sconfitta
per tutti”; “un’assenza che stride molto” per Rosy Bindi; un “problema di
coerenza per la presidente della commissione femminicidio Valeria Valente, Lia
Quartapelle parla di occasione mancata per dare un “esempio sulla parità”,
caustica Giuditta Pini: “Per il women new deal c’è tempo compagne, oggi no,
domani neanche, dopodomani sicuramente, lo metteremo in un odg”. La sollevazione
insomma è quasi unanime. Dal Nazareno si sforzano a far sapere che le scelte sui
ministri dem – Dario Franceschini alla Cultura, Andra Orlando al Lavoro, Lorenzo
Guerini alla Difesa – sono state di Palazzo Chigi e Quirinale. Zingaretti “si è
speso moltissimo per le donne”, ha detto Valentina Cuppi, presidente del Partito
dal febbraio 2020. Niente da fare: la crepa è partita. La protesta potrebbe
esaudirsi nel rifiuto ai sottosegretariati – nel dibattito non manca chi fa
notare che si tratti comunque di ruoli rilevanti. La questione centrale della
polemica è il ruolo di leadership delle donne nel partito, non quote rosa ma
argomento di subalternità complicato dal correntismo esasperato, come ha scritto
l’ex ministra Marianna Madia su Huffington Post. Tutto un paradosso per chi
promuove e si erge a paladino di diritti e parità mentre il centrodestra porta
nell’esecutivo tre donne e sempre nella destra, in Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni siede sullo scranno più alto ed è la politica più influente in
Italia. Matteo Renzi, l’ex segretario e fuoriuscito dal partito, che ha fondato
Italia Viva, nel governo rappresentato alle Pari Opportunità da Elena Bonetti,
gira il coltello nella piaga del Pd che “non riesce a proferire una parola
credibile sul tema femminile”.
Concita De Gregorio umilia il Pd e
Zingaretti: "La più a sinistra in questo governo è Mara Carfagna, le donne le
porta Silvio". Libero Quotidiano il 13 febbraio 2021.
Il botta e risposta tra Concita De Gregorio e Nicola Zingaretti non si ferma. La
prima “discussione” a distanza tra i due è nata qualche giorno fa, quando la
giornalista di Repubblica ha criticato la performance del segretario del Pd al
Quirinale, definendolo “un ectoplasma, tutto fuorché un leader”. Per il suo
giudizio, la De Gregorio si era beccata della radical chic dallo stesso leader
del Partito. Adesso invece la firma di Repubblica mette nel mirino il Pd per la
mancanza di una donna tra i ministri espressi dal partito. “Si osserva che la
più a sinistra in questo governo è Mara Carfagna (e che le donne le
porta Silvio)”, ha scritto la De Gregorio su Instagram. Un vero e proprio
attacco alle recenti scelte del Pd. Come scrive il Tempo, probabilmente adesso
si cercherà in ogni modo di impedire a Zingaretti di rispondere ancora una
volta, evitando così di dare inizio a un botta e risposta infinito. All’interno
del Pd, però, ci sarebbero – rivela il Tempo - molte parlamentari dem schierate
contro Zingaretti per la risposta data alla giornalista dopo le prime critiche:
“Il tono della replica di Nicola, che non avrebbe mai fatto una cosa simile se a
scrivere quel fondo fosse stato un uomo. Vergognosa prova di machismo, e proprio
contro una donna di sinistra", questa una delle frasi sussurrate al Nazareno.
Giovanna Vitale per “la Repubblica” il 14 febbraio
2021. Una ferita che brucia, e non solo alle donne del Pd. Ascoltando la lista
dei ministri, è stato Zingaretti per primo a rendersi conto che a sinistra erano
tutti maschi. Lasciato al buio da Draghi, il segretario dem sperava che - al
netto delle manovre dei capicorrente - la sua richiesta di rispettare «il valore
della differenza di genere» avanzata in Direzione, avrebbe trovato orecchie più
attente. E invece lo spettacolo offerto al Paese di una destra che premia le
donne (due su tre Fi, una su tre la Lega) e di un centrosinistra che le
mortifica (quattro uomini su quattro, Leu inclusa) è stato devastante. Una
valanga rosa s' è staccata dal Nazareno, obbligando Zingaretti alla contromossa:
se sui sottosegretari il premier darà libertà ai partiti, lui indicherà solo
donne. E pazienza per i delusi: citofonassero ai capibastone, nel frattempo
diventati ministri. «Non credo accadrà, ci sono troppi aspiranti. Se però lo
facesse, sarebbe un bel segnale: la prova che Nicola vuol finalmente far saltare
gli equilibri di corrente», reagisce Lia Quartapelle, una delle deputate più
infuriate. «Il nostro statuto prevede metà delle cariche per le donne », spiega.
«Se ci fossimo comportati come Forza Italia oggi avremmo un governo con dieci
ministre e tredici ministri, in linea con la rappresentanza di genere a livello
europeo ». Perciò «Berlusconi è stato più bravo di Zingaretti». Concorda Laura
Boldrini: «Occorre scardinare l' assetto delle correnti che schiaccia il
protagonismo femminile e impedisce il rinnovamento». Ma per Marianna Madia la
questione è un' altra: «Le donne del Pd hanno un problema di leadership, che non
si ottiene per concessione, ma si esercita con battaglie sulla linea politica.
Se la risposta sarà la spartizione di qualche posto da sottosegretario resteremo
al punto di partenza. Forse peggio », taglia corto l' ex ministra, criticando la
gestione "machista" della crisi. È questo il nodo da sciogliere: le donne dem
che vanno avanti solo per cooptazione, sperando di arrivare prima e meglio. «Si
sono illuse che funzionasse essere "in quota" a capicorrente o inserite per
prossimità, anziché per competenza o consenso », annuisce Debora Serracchiani. E
guarda adesso: «Per la prima volta il Pd al governo non ha una rappresentanza
femminile». E la colpa «non è semplicemente degli uomini, anzi», spiega Anna
Ascani: «Spesso ci siamo relegate in correnti a guida maschile per comodità.
Abbiamo lasciato che fossero gli uomini a "indicarci" in ruoli di responsabilità
secondari. Abbiamo schernito chi di noi provava ad emanciparsi. Forse quanto è
successo ci permetterà di cambiare passo». Brutalizza Monica Nardi, ex portavoce
di Enrico Letta, segnalando «la corsa al tweet sdegnato delle donne pd, tutte
inquadrate in correnti rette da uomini, cooptate senza un voto che è uno. Fatela
la politica, scalateli i partiti, prendeteli i voti». Eccolo il punto: è
arrivato il momento di esporsi, di lanciare la sfida alla segreteria, quando
sarà. Prendendosi nel frattempo il posto di vice-leader che Andrea Orlando dovrà
lasciare e poi uno dei due capigruppo in Parlamento. La controffensiva verrà
lanciata già domani, alla Conferenza delle democratiche convocata «per decidere
come agire». Perché «la misura è colma», sbotta la presidente Valentina Cuppi,
scagionando però Zingaretti: «Il più scontento è lui, la scelta dei ministri l'
ha fatta Draghi». Che ha pure suscitato «la profonda delusione » della rete
"Donne per la salvezza". Mentre nel Pd resta l' amarezza per un' esclusione che,
segnala Orfini, «non è un problema solo delle donne, ma di tutto il partito».
Zingaretti, su "Repubblica" sinistra
elitaria e radical chic. (ANSA il 30 gennaio 2021) "Ho
letto su Repubblica una pagina di Concita De Gregorio, purtroppo ho visto solo
l'eterno ritorno di una sinistra elitaria e radical chic, che vuole sempre dare
lezioni a tutti, ma a noi ha lasciato macerie sulle quali stiamo ricostruendo".
Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti su Facebook critica duramente
l'articolo dal titolo "La sinistra timida pilotata dagli eredi della Dc". "Chi
fa un comizio in diretta dopo le consultazione al Quirinale - prosegue
Zingaretti riferendosi ai giudizi su Matteo Renzi - è un esempio, chi rispetta
quel luogo una nullità. La prossima volta mi porto una chitarra. Che degrado. Ma
ce la faremo anche questa volta".
Fulvio Abbate per Dagospia il 4 febbraio 2021.
Alla fine, è stato un “uomo senza qualità”, Nicola Zingaretti, segretario del
Pd, a spezzare le brame di un piccino mondo di sinistra convinto d’essere
intoccabile. In possesso dell’occorrente completo di ciò che altrove, dove
esserlo è invece possibile, consente una dimensione da veri “radical chic”. Il
medesimo mondo che nel corso dell’ultimo ventennio, svanito il Pci, ha ritenuto
necessario dare a se stesso un proprio seguito professionale invidiabile e
benefit ulteriori, forte dell’applauso perfino di signore acefale, ma in ogni
caso di buone letture, sicure che Veronica Lario fosse “una compagna” e, più
recentemente, che Melania nutra in cuor suo politico disprezzo per Trump.
Dunque, anche lei una femminista quasi come, un tempo, Carla Lonzi. Che
imbarazzante candore, supportato, s’intende, dall’Invece di Concita De
Gregorio. Invece, con un semplice tweet, Zingaretti, amorfo ex quadro cittadino
della Fgci di via dei Frentani, così ai loro occhi, ha abbattuto un castello di
carta profumata d’Eritrea che nel tempo, anche grazie all'amico Walter, era
convinto della propria esistenza, meglio, della propria invidiabile persistenza.
Un’enclave forte dei propri riti: serate a sgranocchiare cipster davanti al
Festival di Sanremo in case di edificanti narratori, ad applaudire recital
letterari alla Basilica di Massenzio, a mostrarsi ai vernissage del MaXXI, anche
questo affidato a una signora del medesimo contesto, Giovanna Melandri, a
pronunciare frasi da anime belle, davvero ispirate, dagli studi di Radiotre di
Marino Sinibaldi, un altro cooptato ancora nel circoletto. Con la sua reazione a
calco, nel cupio dissolvi della sinistra romana (dunque, italiana) il negletto
(sempre ai loro occhi) segretario Pd ha preso di fatto a calci un mondo che,
sempre nel tempo, era convinto della proprio inscalfibile invincibilità. E dei
propri benefit. Che pena e imbarazzo per l'autore stesso, la difesa d’ufficio di
Michele Serra corso a supporto morale della collega di “Repubblica”. Chissà
quante persone dovrà consolare in questi giorni Veltroni, che di quel mondo è
stato garante e principe dispensatore di opportunità. La verità? Magari, si
potesse vivere nei lussi da radical chic nel desolante mondo della sinistra
italiana, dove, nel migliore dei casi, è concessa una dimensione da condomini.
Resta però che grazie a Zingaretti da oggi siamo tutti finalmente liberi!
Boldrini attacca: "Nel Pd
potere a uomini".
L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, fa autocritica:
"Nel Pd la gestione del potere viene considerata una questione per soli uomini".
Rosa Scognamiglio, Lunedì 15/02/2021 su Il Giornale. "Girl power", direbbero
agli inglesi. Uno slogan che ben si addice alla ex presidente della Camera dei
Deputati, Laura Boldrini, che in questi anni ha condotto fior fior battaglie
femministe - o presunte tali - nell'aula parlamentare di Palazzo Chigi. Ma
stavolta lo fa, con un pizzico di inaspettata autocritica, nei confronti
del partito democratico dove è approdata appena 2 anni fa, nel 2019, dopo esser
passata da SI (2017) e Futura (2018) nel giro di un biennio. "Nel Pd la gestione
del potere viene considerata una questione per soli uomini", dichiara in
un'intervista all'agenzia stampa Adnkronos. Tira già aria di burrasca? Chissà.
Le "rappresaglie di genere" della Boldrini, di certo, non sono una novità.
Tuttavia, stupisce che "si armi" proprio contro il PD, di cui ha sempre tessuto
le lodi. "Nel Pd la gestione del potere viene considerata una questione per soli
uomini e in questa occasione il partito si è dimostrato per quello che è: un
partito che non mette l'uguaglianza di genere tra le sue priorità. - dice ai
microfoni di Adnkronos - Non fa parte della cultura di questo partito. Basta
vedere i candidati alle regionali. Ora vedremo come andrà con le
amministrative...". Che non abbia mai digerito l'assenza di una "quota rosa"
consistente ai piani alti di Palazzo Chigi, era noto già da tempo. Lo conferma
l'idea di adibire una "sala delle donne" in quel di Montecitorio dove ci sono
"specchi appesi al posto dei ritratti mancanti di donne nei ruoli di presidenti
della Repubblica, del Senato e del Consiglio". Ma adesso sembra avere tutta
l'intenzione di dare seguito concreto ai suoi nobili propositi. La ex-presidente
della Camera ha seguito oggi la riunione via remoto delle donne dem - dopo la
rivolta per la delegazione dem di governo tutta al maschile - che è stata
riaggiornata a domani. "specchi appesi al posto dei ritratti mancanti di donne
nei ruoli di presidenti della Repubblica, del Senato e del Consiglio - ha
spiegato - Qui noi siamo di fronte a uno scollamento dalla realtà: da una parte
i documenti, gli odg, le iniziative, i materiali e poi niente di tutto questo si
concretizza. E questo stride se messo a confronto con i partiti progressisti
degli altri Paesi europei. Prendiamo la Spagna, paese latino come il nostro: al
governo ci sono 6 ministri uomini e 11 donne. In Francia sono pari. Ma in Italia
ancora il Pd non ha capito che questo è un tema imprescindibile anche in termini
di consenso". E quindi, che cosa si propone? "Intanto occorre la compattezza
delle donne, innanzitutto. I posti si devono ottenere combattendo e non per
cooptazione. Ma serve anche uno sforzo culturale di questo partito:
l'uguaglianza di genere deve essere una priorità. A partire dal vicesegretario.
Ma sarebbe bene che" una dualità di genere "ci fosse per ogni incarico: un uomo
e una donna per ogni incarico sul modello dei Verdi europei. Le proposte ci
sono. Il punto è che così non si può andare avanti e quello che è accaduto non
può essere derubricato come una cosa marginale".
Annalisa Cuzzocrea per "la Repubblica" il 16
febbraio 2021. Neanche lo shock di ritrovarsi tutti maschi al governo riesce a
suscitare nelle donne Pd un moto d'orgoglio, la voglia di far pagare a caro
prezzo l'onta subita. Dal partito tutto, non solo da loro: ostaggio di
capicorrente che hanno azzerato la rappresentanza femminile, restituendo
l'immagine di una forza retrograda e antistorica. «Un gravissimo problema a cui
troveremo una soluzione», ha promesso ieri Zingaretti. Aggiornata a oggi per le
conclusioni, il primo round della Conferenza delle democratiche finisce con un
nulla di fatto. Consolidando la spaccatura tra chi, per fare un favore al
segretario, preferisce annacquare il dibattito, buttandola sui posti di
sottogoverno che vanno presi per attutire il colpo; e chi invece spinge per
allargarlo, convocando subito la Direzione: il danno prodotto è troppo grave,
non si può far finta di niente. Appartiene alla prima scuola la portavoce
Cecilia D'Elia, zingarettiana di ferro. Dopo aver spiegato che «il pluralismo
delle correnti ha prevalso, mettendo tra parentesi la questione di genere: una
terribile sottovalutazione, una ferita, una battuta d'arresto», D'Elia ha
incalzato sulle compensazioni. «Bisogna che qualcosa succeda subito. Non per
risanare la ferita, o compensare l'assenza. Il tema della sottosegretarie o
viceministre non è questione di risarcimento, non ci accontentiamo delle
retrovie. È un dato di fatto, ci sono donne competenti, il Pd dia un segnale
subito e netto su questo». Senza dimenticare gli incarichi di partito, dove
però, attenzione, i maschi non devono fare un passo indietro, sono le donne che
devono affiancarsi. «Non ho chiesto le dimissioni di Orlando, a cui rinnovo la
mia stima», precisa infatti D'Elia, reduce da una ramanzina dei vertici. «Però
penso che ci possa essere una vice donna, come aveva fatto Zingaretti all'inizio
con la vicesegreteria duale di Orlando e De Micheli». E comunque se ne potrà
parlare, propone, alla prossima assemblea. Parole che però fanno indignare Titti
Di Salvo, numero 2 della Consulta che - come pure Marta Leonori e tante altre lì
dentro - pensa che «quanto è accaduto è una sconfitta e un errore», altro che
battuta d'arresto. «In un partito che ha tre luoghi per le donne - Conferenza,
Dipartimento pari opportunità, Women new Deal - e zero ministre qualcosa non
torna. Si dimostra l'inefficacia di questo assetto». Specchietti per le
allodole, mentre i maschi si prendono tutto. «Noi abbiamo bisogno di ingaggiare
una battaglia politica negli organismi di vertice per riaffermare l'idea di un
Pd contemporaneo fatto di donne e uomini», che devono vedersi entrambi. Perciò
va convocata la Direzione. Per parlarne tutti, guardandosi in faccia. Come ha
fatto ieri, sfogandosi, l'ex ministra De Micheli. «Io al Mit ho sempre lavorato
a testa bassa, senza preoccuparmi di intessere rapporti che potessero
proteggermi», ha raccontato. «E forse è stato uno sbaglio. Quando mi hanno
attaccato, anche nel mio partito, nessuna di voi mi ha difesa. Mi sono sentita
sola». Perché nel Pd non è solo la leadership femminile che manca, come denuncia
Anna Ascani. A mancare, fra le donne dem, è innanzitutto la sorellanza.
Annalisa Cuzzocrea per "la Repubblica" il 16
febbraio 2021. Marisa Rodano ha compiuto 100 anni e crede ancora nella lotta.
Nei simboli, anche, lei che è nata nello stesso giorno del Partito comunista
italiano, il 21 gennaio del 1921. Lei che - l'8 marzo 1946 - scelse la mimosa
per festeggiare la festa internazionale della donna, un fiore povero, ma una
pianta robusta, tenace. Risponde al telefono a ora di cena, l'ex dirigente del
Pci, del Pds, dell'Unione donne italiane. Antifascista, partigiana,
parlamentare, prima donna a ricoprire l'incarico di vicepresidente della Camera,
Rodano ha 5 figli, 11 nipoti e un'idea precisa del perché il Pd non abbia
nominato neanche una ministra: «Io penso che ci sia, anche a sinistra, per lo
meno in una parte della sinistra, l'idea che in realtà più donne ci sono, meno
posti ci sono per gli uomini».
Ancora? E soprattutto, perché?
«Perché malgrado tutto resiste quella vecchia
convinzione per cui le donne debbano occuparsi della famiglia, dei bambini, di
un'area solo parapolitica».
Siamo rimasti agli anni '50?
«Stupisce anche me, ma devo dire che l'impressione
di chi vede le cose da fuori - attraverso i giornali, la televisione, stando
chiusa in casa come devo fare io ora - è questa».
Ma non crede ci sia stata una regressione? Lei ha
rivestito ruoli importanti, in Parlamento, nel partito ...
«Non tanto importanti, mi sono sempre occupata
delle donne». ( Dalla cornetta arriva un sorriso, un cenno di ironia).
Ci sono state per anni troppe riserve indiane, a
sinistra, luoghi specifici dove confinare il pensiero femminile?
«Per parecchio tempo gli uomini hanno pensato che
le donne potessero occuparsi solo di materie particolari, relative ai bambini,
alla famiglia, alla cura, non delle stesse cose di cui si occupavano loro».
Hanno paura?
«Non è che hanno paura, hanno la convinzione che
spetti a loro».
Cosa bisogna fare, quindi?
«Continuare a battersi per una equilibrata
presenza delle donne in tutti i luoghi in cui si decide. Una presenza
paritaria».
Per anni si è affidata questa missione alle quote
rosa.
«È una parola che non mi è mai piaciuta. Non
vorrei si continuasse a parlare di quote, bisognerebbe concentrarsi sul fatto
che le donne devono avere gli stessi diritti, le stesse opportunità. In tutti
questi anni mi sono battuta per questo. E penso anch' io che le donne del Pd
dovrebbero rinunciare a tutti i posti di sottogoverno che saranno loro offerti,
fare un gesto simbolico forte che rimetta tutto in gioco».
Non pensa che questa situazione sia anche generata
da una sorta di timidezza delle donne in politica. Dalla certezza di poter
ottenere qualcosa solo mettendosi dietro al capo - uomo - di turno?
«Non credo questo. Penso che le donne siano state
negli anni troppo occupate, impegnate a sostenere la loro attività sia dentro
che fuori dalla famiglia. Una vita faticosa, difficile».
I tempi in cui si riteneva che il loro unico
dovere fosse fare figli sono finiti, o no?
«C'è stato un avanzamento dal punto di vista
intellettuale, ma da quello pratico, se guardiamo alle misure concrete per la
vita quotidiana, che consentano di conciliare lavoro e famiglia, non è stato
fatto quasi niente».
È una sconfitta della sinistra?
«Oggettivamente lo è. E non credo dipenda dalle
debolezze delle donne, ma dal tipo di politica che i dirigenti del Pd hanno
condotto negli ultimi anni e nelle ultime settimane».
Che consiglio darebbe alle donne che fanno
politica nel Pd?
«Di continuare a battersi per avere il ruolo che
spetta loro e per ottenere quelle misure che rendono possibile la conciliazione
lavoro-famiglia. Perché se non vanno avanti le politiche che servono a tutte le
donne, non vanno avanti neanche le donne in politica».
Michela Tamburrino per “la
Stampa” il 15 febbraio 2021. Donne si, donne no. Poche, troppo poche in questo
governo. E la pezza dei vertici del Pd che ora, giurano, le indicheranno in
massa per il ruolo di numeri due non copre il buco, anzi. C' è sconcerto a
sinistra, gode la destra di Giorgia Meloni. Un loop da cui non si esce, ammette
la scrittrice Lidia Ravera, nume tutelare di una sinistra femminista rispetto a
cui, pure, ha preso posizioni scomode, scandalizzando i perbenisti e anticipando
i tempi. E chi ricorda solo il romanzo di formazione «Porci con le ali» si è
perso una vita di battaglie in prima linea, compresa l' ultima, quella, fino al
2018, di assessore alla Cultura e alla Politiche giovanili nella Regione Lazio
guidata dal segretario del Pd Nicola Zingaretti.
Signora Ravera, cosa pensa
della componente femminile nel nuovo governo Draghi?
«In questo sono radicale. Ho
postato su Facebook il mio pensiero in proposito: le donne in politica
dovrebbero imporre la loro diversità, le loro differenze. Invece vengono assunte
per cooptazione e per somiglianza agli uomini. "Le uome" , le chiamo io».
Sarebbero, esattamente?
«Parlano la lingua maschile e
non impongono mai la visione femminile del potere e della politica».
Vuol dire che anche stavolta
dovevamo aspettarcelo un governo con poche donne?
«Personalmente vado oltre il
contingente, mi pongo al di là delle scelte di questo Governo. Le donne del Pd
sono state usate e poi emarginate. Non è neppure una interpretazione politica
del famoso tetto di cristallo. E non si illudano di rappresentano le altre
donne, non è così. Sono invece omogenee, fanno gli stessi giochi maschili che
peraltro sono giochi che le vedono perdenti. Dovrebbero imporre un modello
capace di aprire uno spazio diverso sul mondo. Non è che io voglia estirpare il
maschile ma non credo in un nostro ruolo subalterno, non credo che ci dovremmo
accontentare. Dovremmo essere equipollenti. Vado oltre le logiche della destra e
della sinistra».
L' attualità è un luogo
angusto?
«L'attualità è figlia di una
mancata rivoluzione che ci poteva far raggranellare qualche briciola di dignità
politica ma non è riuscita, perché queste geometrie seguono regole di una
professione che non è delle donne. Non esiste una storia che possa raccontare le
donne in politica».
Come siamo arrivate a questo
punto?
«Le donne non hanno fatto
irruzione nel Palazzo imponendo la loro diversità. Sono entrate e basta».
Un quadro senza speranze?
«No credo invece che la
speranza ci sia, prima o poi l' irruzione ci sarà, rispettando altri tempi,
altre lingue, altri riguardi. Imparare il gioco maschile è impossibile e
masochistico».
Forse, se all' epoca del
femminismo si fosse osato di più?
«Sull' onda del femminismo
montante, forse sbagliando, non ci siamo mai misurate con la politica
parlamentare del Palazzo, tranne sparuti casi. Negli anni Settanta la politica
si combatteva fuori, mai affrontata come impegno professionale della
rappresentanza. Esistevano altre parole d' ordine. Ora siamo in stallo».
E la speranza?
«La rivoluzione femminista è
un fiume carsico, s' interrompe, s' inabissa, torna. Le donne che non hanno più
coscienza di loro stesse devono passare il testimone ai movimenti che non
tornano indietro, movimenti lontani da giochi lobbistici e narcisisti».
In che cosa sbagliano le donne
in questo gioco?
«Gli uomini fanno rete e le
donne no. Ogni posto dato a un uomo è una vittoria della specie perché si tratta
di un posto tolto a una donna. Dunque non cedono nulla con cavalleria».
Questo in politica ma in altri
ambiti la situazione è differente?
«La percentuale di peso è la
stessa anche in mondi diversi. Prendiamo i premi letterari. Lo Strega, contiamo
quante donne l' hanno preso rispetto agli uomini...»
Eppure era un premio inventato
da una donna, condotto da una donna e per decenni tenuto in mano da un' altra
donna.
«Appunto, le donne non fanno
rete e non si proteggono a vicenda. A parte questo, esistono due soggetti non
uno solo e non uno inferiore all' altro. Un principio che nella sua semplicità
viene coniugato con emancipazione».
E si torna così alla
rivoluzione di cui sopra?
«Se le donne si arrabbiassero
e decidessero veramente forse la politica italiana potrebbe cambiare,
addirittura si riuscirebbe a colmare la distanza che separa la politica dai
cittadini comuni. La lingua delle donne, i loro tempi, la loro complessità
potrebbe veramente travolgere le regole del gioco. Come vede è tutto molto più
complesso di questo governo e della situazione interna al Pd».
Concetto Vecchio per “la
Repubblica” il 15 febbraio 2021.
Luciana Castellina, perché la
sinistra non ha portato nessuna donna al governo?
«La deluderò, ma non sono mai
stata una grande appassionata delle quote femminili: non è che cambia la società
se una donna s' infila nei ruoli maschili».
Cosa intende dire?
«Potremmo anche occupare più
posti in un governo, e ovviamente sono favorevole, ma se non modificheremo
leggi, codici e orari, abbattendo il modello maschile che ci viene spacciato
come neutro, non ne verremo a capo».
La politica non è fatta anche
di simboli?
«Il 70 per cento delle donne
manager non fa figli. Il problema quindi è fare in modo che tutte le donne che
assumono responsabilità possano anche fare i figli e gestire una famiglia».
Come definirebbe la sua
posizione?
«Semplicemente non m'
interessa essere uguale all' uomo, l' ho capito tardi».
Non la pensava così da
giovane?
«All' epoca tendevo a
nascondermi le tette pur di non fare capire che ero una donna».
Come lo spiegherebbe oggi a
una giovane?
«Con il fatto che una bella
era spesso considerata anche stupida».
Quando ha cambiato idea?
«Grazie alla generazione di
mia figlia, che ha fatto una battaglia per il femminismo della differenza. Loro
hanno capito che serviva portare la nostra diversità al potere».
Il fatto che ci siano solo 8
donne su 23 come lo valuta?
«Non è bello, perché non ci
hanno pensato, nemmeno Draghi. Ma non lo ritengo decisivo. Vantiamo un credito
storico. E quindi allora bisognerebbe stabilire il 75 per cento della presenza
femminile per risarcire la discriminazione millenaria, come affermava il codice
della Repubblica popolare cinese, anche se poi se lo sono dimenticati».
È un' Italia più maschilista
di un tempo?
«Al contrario. Gli uomini sono
molto in crisi, anche perché le donne hanno imparato a pretendere che la
comunità porti il segno della loro presenza».
Non ci sono troppi
femminicidi?
«Non c' è dubbio, ma sono la
prova della crisi di cui le parlavo, e infatti muoiono le donne che hanno osato
fare una scelta di autonomia».
L' uomo ha perso potere?
«Ha perso autorità, non
potere. Pensi al Me too, un tempo nessuno avrebbe creduto alla donna. I manager
di Hollywood invece sono stati tutti condannati per molestie».
Lei è la prova che una donna
di valore può arrivare in alto.
«In tante ce l' hanno fatta,
anche meglio di me. A tutte è costata fatica, dolore, lotta, e infatti ne
portiamo le cicatrici. Guardi la von der Leyen, fa un lavoro pesantissimo e ha
sette figli, perciò l' ammiro».
La destra le donne però le ha
nominate ministre.
«È una cosa che mi lascia
freddina».
Le piace il governo Draghi?
« Sono molto scontenta. Alla
transizione ecologica c' è uno che approva la politica dell' Eni, siamo al
greenwashing, alla vanteria ambientale. Un fisico che si occupa di
nanotecnologie, poi, non un ecologo».
Non va giudicato con i fatti?
«Mi fa impressione che ci sia
Giorgetti allo sviluppo economico, un uomo vicino alla Confindustria, che vuole
lo sblocca-cantieri: costruzioni e produzioni anche se nocive».
Draghi voleva pure sua figlia
Lucrezia Reichlin nel governo.
«È candidata ogni volta e poi
non accade mai».
Perché?
«Forse perché vive a Londra».
Insomma, boccia Draghi?
«È un uomo intelligente, e in
Europa conduce le mie stesse battaglie. Ma mi sarei aspettata di più».
Su Dagospia il 15 febbraio
2021. Luciano Capone 14 feb: Molte donne di centrodestra si fanno strada e si
affermano perché sono abituate a dover lottare per vincere stereotipi e
pregiudizi, spesso alimentati anche da donne di sinistra. Un esempio è questo
confronto dialettico tra Mara Carfagna e la Costamagna.
Selvaggia Lucarelli
per "Libero" il 15 febbraio 2021. I momenti tv Eva contro Eva sono sempre
imperdibili. E memorabile è stato anche lo scontro tra la conduttrice disperata
Eva Longoria Costamagna e la sexy maliarda ex ministra Eva Mendes Carfagna. Ne è
uscita, a pezzi, la Costamagna. Che ha sbagliato tutto. E più precisamente,
punto per punto:
a) Le argomentazioni tipo
"perchè dopo che lei è diventato ministro ha cambiato immagine?" non sono
materiale con cui incalzare l'avversario Carfagna. Ovvio che ‘sta donna non
poteva fare il ministro conciata come quando regalava il vaso cinese ai
telespettatori. Era argomento da battuta, che andava detto per prenderla
amorevolmente per i fondelli, non per costruirci un'accusa.
b) Io fossi stata la
Costamagna, avrei applicato il metodo Carfagna. Un po' di trucco in meno, il
boccolo più floscio, la gonna più lunga. Se sei lì a mettere i puntini sulle i
in stile maestrina e l'argomento principe è che Mara è una showgirl promossa a
ministro, l'abito fa il monaco. E alla prima occhiata, non devi sembrare tu, la
showgirl che parlava col comitato e cantava "O sole mio" con Magalli.
c) La mimica facciale non è
un'opinione. E la comunicazione non verbale neppure. La Costamagna faceva più
smorfie di Jim Carrey in Ace Ventura-l'acchiappanimali tradendo un certo
nervosismo, mentre la sfinge Carfagna incassava impassibile, sorrideva,
deglutiva e poi lanciava il missile.
d) Di fronte a una che dice
con piglio sicuro: "Non ho mai rinnegato il mio passato", c'è poco da stare a
inzigare ulteriormente. L'avesse detto la Melandri, quando Briatore giurava di
averla avuta ospite a casa sua a Capodanno a Malindi, l'avesse ammesso che
faceva i trenini con Fede e la Zardo a suon di Brigitte Bardot Bardot, sarebbe
stata più simpatica a tutti, la sora Giovanna.
e) Perchè dire calendario sexy
se non era calendario sexy? Perchè andare a cercare lo stereotipo da camionista
per svilire l'avversario? Cioè, aveva scheletri nell'armadio ben peggiori ‘sta
Carfagna. Poteva dirle "Lei ha condotto un programma con Davide Mengacci!" e
l'annichiliva. Altro che calendario sexy.
f) Che razza di domanda è "È
più simpatico Berlusconi o è più simpatico Santoro?". Che minchia di domanda è
"Berlusconi è brutto e vecchio?"? E perché non "preferisci mamma o papà" allora?
"Meglio Branko o Paolo Fox"? o "Come nascono i bambini? o "Meglio al latte o
fondente"? Ma chi gliele ha scritte le domande? Moccia?
g) Diciamocelo. La battuta sui
pettegolezzi riguardanti la Costamagna e Santoro è stata un piccolo capolavoro
di strategia bellica. Qui l'abilità della Carfagna è stata memorabile. La
sensazione è questa: il modo in cui Mara l'ha appoggiata, buttata lì, quasi
sussurrata ad occhi bassi, lascia intendere che era il suo asso nella manica.
Che tutto sommato se la sarebbe anche risparmiata, se l'altra non fosse ricorsa
ai colpi bassi. Della serie: io non la uso, ma se mi costringe, so' cazzi della
bionda.
h) Che razza di difesa è :
"Quando sono andata a lavorare con Santoro io ero già giornalista"?. Allora
l'altra quando è stata nominata ministro era già consigliere regionale, se la
vogliamo mettere su questo piano. Anzi, se la vogliamo mettere su questo piano,
la Toffanin è giornalista, Iva Zanicchi ha scritto un romanzo e Sara Tommasi è
laureata alla Bocconi.
i) Sempre a proposito di
espressioni facciali. La vera notizia è che la Carfagna non ha più l'occhio
sgranato di chi ha appena visto Boateng senza mutande. S'è ammorbidita. La
Costamagna, invece, ha la faccia di quella che ha visto Telese, senza mutande.
Della serie: meglio zitella.
E comunque, io una spiegazione
sull'accaduto ce l'ho. Il programma su Rai 3 è una copertura. Luisella
Costamagna è in realtà il nuovo ufficio stampa di Mara Carfagna. Neanche
Lucherini, dopo tutto quello che s'è detto di lei, sarebbe riuscito a
trasformarla, dopo sei minuti di intervista su Rai 3, in una gradevole, pacata,
ragazza normale. Manco se l'avesse intervistata Mollica, ne sarebbe uscito un
ritratto migliore. E come ha scritto qualcuno sul mio twitter: la Costamagna è
alla deriva, come tutte le Costa, di questi tempi.
Francesco Borgonovo per "la
Verità" il 16 febbraio 2021. Fuori, nel mondo reale, deflagra la rabbia dei
gestori degli impianti sciistici, dei ristoratori, degli albergatori, di gente
che, nell'arco di una notte, si è vista letteralmente togliere il pane di bocca
dai sedicenti esperti del governo. Ma dentro, nella bolla ideologico-mediatica
in cui abita la gran parte dei politici e degli intellettuali italiani, il
problema è uno solo: l'esclusione delle donne del Pd dai ministeri. La senatrice
Monica Cirrinnà, ieri, ha avuto un accesso d'ira: «Siamo un partito che predica
bene sui temi femministi ma poi razzola male, un partito falsamente femminista»,
ha detto a Un giorno da pecora. «Perché? Per debolezza assoluta e per egemonia
degli uomini. Questo è un partito di correnti al cui capo ci sono tutti maschi».
Pure le Signorine Grandi Firme progressiste della carta stampata sono sul
piedino di guerra. Invocano addirittura una sorta di sciopero delle donne, come
nella Lisistrata di Aristofane. Invitano cioè le esponenti del Pd a rifiutare il
ruolo di sottosegretario qualora venisse loro offerto come compensazione. L'idea
del contentino l'ha avuta Nicola Zingaretti: per ovviare al tremendo problema
della sottorappresentanza femminile nell'esecutivo, ha proposto di indicare
«solo donne» per i posti da sottosegretari. Una trovata che non si sa se sia più
ridicola o più triste (del resto l'ha escogitata il segretario dem), che le
intellettuali sinistre hanno respinto al mittente. «C'è da augurarsi che le
donne del Pd, ammesso e non concesso che si offra davvero loro l'occasione per
farlo, non si prestino ancora una volta a interpretare il più sessista dei modi
di dire, accontentandosi di essere grandi sottosegretarie dietro a grandi
ministri», tuona Michela Murgia dalle colonne della Stampa, «perché preferire la
mediazione alla lotta è un lusso che si può permettere solo chi ha già voce in
capitolo». Su Repubblica, invece, Concita De Gregorio ringhia non solo
all'indirizzo degli uomini oppressori, ma perfino contro le donne che sono
rimaste in «silenzio alla vigilia delle decisioni prese dai maschi bianchi che
governano la specie» (perché, fossero neri cambierebbe qualcosa?). Secondo
Concita, lo stesso termine sottosegretarie, in quanto composto da «sotto» e
«segretarie», dovrebbe «di per sé suscitare diniego». Vedremo poi quante
esponenti piddine saranno pronte a rinunciare a incarichi e prebende pur di
tenere il punto e dare battaglia, ma che accettino o meno ci interessa
relativamente. A irritare è, piuttosto, l'arroganza con cui la questione delle
«democratiche al potere» sta rubando tempo ed energie, nonché spazio nel
dibattito. Sul tema si è sentito in dovere di intervenire il sindaco di Milano,
Beppe Sala, che manco a dirlo si è schierato sul lato delle vestali. A suo dire,
le donne «hanno ragione. Arrabbiarsi è giusto. E una delusione». Il primo
cittadino ha colto l'occasione per dire che lavorerà affinché «Milano diventi la
città della parità». Certo, come no. La prima cosa di cui la capitale morale ha
bisogno è più parità. Bar e ristoranti fanno la fame, il traffico è una
catastrofe grazie alle innovazioni «verdi» del sindaco. Ma una bella spolverata
di «diritti» renderà senz' altro la vita migliore a tutti. L'idea delle quote
rosa ha raccolto anche un'altra adesione importante. Quella di Elena Bonetti di
Italia viva, appena riconfermata ministro delle Pari opportunità e della
Famiglia. Per la sua prima uscita ufficiale ha scelto proprio la questione
femminile: «Sulle donne va fatto un passo avanti e vinta l'arretratezza
italiana», dichiara a Repubblica. E annuncia «un pacchetto di misure per la
parità, una sorta di Women act». A suo dire, «affrontare la questione femminile
è prioritario». Ah, davvero? Viene il sospetto che forse una bella fetta di
donne italiane, invece del Women act, preferirebbero la riapertura totale delle
scuole, in modo da non dover farsi carico ogni santo giorno dei figli snervati
dalla didattica a distanza e dei loro compiti. Supponiamo pure che molte donne -
come del resto molti uomini - ritengano prioritaria la fine delle restrizioni, o
l'arrivo di ristori decenti. O, ancora, un investimento una volta tanto efficace
sull'occupazione. Tutto questo, però, passa in secondo piano, perché a dominare
la scena è la «rappresentanza femminile». Il ministro Bonetti, già nel governo
precedente, sembra essersi dimenticata di avere la delega alla Famiglia. Al di
là di qualche parolina dolce, ripetuta anche ieri, per le famiglie italiane non
ha fatto praticamente nulla di concreto. Non si capisce, poi, in che modo abbia
portato a frutto la sua appartenenza al mondo cattolico (cosa di cui si vanta
ogni volta, ribadendo di essersi formata negli scout). Se n'è stata tranquilla e
beata nel governo più arcobaleno di ogni tempo, non ha fiatato per le iniziative
di Roberto Speranza a favore dell'aborto facile, non ha certo protestato per la
mordacchia che si vuole imporre tramite il ddl Zan. Però eccola qui, fulminea, a
intervenire sul dramma delle donne piddine rimaste senza ministero.
Intendiamoci: anche a noi dispiace che ci siano tre uomini del Pd al governo. Ma
ci dispiace perché sono del Pd, non perché sono maschi. Il punto, infatti, sono
le posizioni politiche che i ministri rappresentano, non gli interessi di
genere. Soprattutto, non è garantendo posti di potere a qualche donna già
potente e privilegiata che si risolveranno i guai delle donne comuni, quelle che
- proprio come i maschi - devono faticosamente sopravvivere fra le macerie
lasciate dai giallorossi. Se le donne del Pd vogliono maggiore rappresentanza,
se la prendano. Facciano come Giorgia Meloni, smettano di lagnarsi e creino un
partito, tanto per dire. Ma, sinceramente, dubitiamo abbiano l'umiltà di mettere
da parte la superiorità morale che da sempre le caratterizza e di prendere
esempio dalla destra. No, loro preferiscono restare dove sono, e fare le vittime
allo scopo di ottenere qualche strapuntino. E mentre ministri, sindaci e
segretari cianciano di quote rosa, le piste da sci restano chiuse, gli alberghi
e i ristoranti vanno in malora, le partite Iva arrancano. E la crisi galoppa,
fregandosene allegramente del sesso di chicchessia.
Da liberoquotidiano.it il 18
febbraio 2021. Vittorio Feltri affronta con i telespettatori di LiberoTv un tema
prettamente femminile: "Oggi le donne sono in subbuglio perché sono state
trascurate da Draghi in quanto il governo è composto prevalentemente da uomini.
Io credo che le donne siano mediamente migliori degli uomini, lo dico per
esperienza diretta. Per esempio nel mio giornale ci sono 7-8 donne che se la
cavano molto meglio dei maschi: hanno più volontà, probabilmente hanno studiato
meglio, e sono più tenaci e hanno e persino un fisico più forte. Questo lo devo
dire perché l’ho sperimentato". "Ma questo concetto non riguarda solo il mondo
del giornalismo, per esempio, alle università si iscrivono in prevalenza donne.
Gli uomini sono meno numerosi e ottengono risultati più scadenti. Questo è un
dato di fatto è statistico". "Poi se andiamo a vedere nelle professioni, nella
professione medica, per esempio, le donne stanno eccellendo. Io per esempio ho
una cardiologa che è primario al Niguarda, che è il maggiore ospedale di Milano,
ed è un autentico fenomeno, forse anche perché non ho niente al cuore, ma con
lei mi sono trovato bene e ho trovato un equilibrio che prima non avevo". "Anche
mia moglie è in cura da lei ed è una donna di altissimo livello. Non solo, il
suo reparto è costituito in prevalenza da donne che hanno imparato da lei che
sono bravissime. Qualche anno fa soffrivo di diverticoli e mi sono rivolto a una
donna che si chiama Perrone che nel giro di 15-20 giorni mi ha guarito, sono
passati due lustri e non ho più neanche un sintomo. Dico queste cose perché
servono a titolo di esempio". "Ma come mai in politica le donne non riescono ad
eccellere? Il motivo è molto semplice: il mondo della politica è un mondo
stupido, motivo per il quale gli stupidi fanno più carriera. Devo anche dire che
le politiche italiane non svettano. Giorgia Meloni a parte non mi pare che ci
siano altre fuoriclasse. Non mi sembra che ce ne siano molte che sono in grado
di assumere posti di responsabilità". "Nel caso del governo Draghi c’è la
Cartabia che è il ministro della Giustizia che è sicuramente una donna capace,
una donna bravissima. Ma siamo a livello di eccezioni mentre tutte le altre
donne che fanno la politica, la fanno senza avere attitudini particolari.
Peraltro in politica vincono spesso i cretini e si vede che le donne non sono
abbastanza cretine".
Vittorio Feltri per “Libero quotidiano” il 19
febbraio 2021. Le donne del Parlamento sono molto seccate poiché nella
formazione del governo sono state trascurate. Non è falso che esse sono state
snobbate da Draghi e anche dai partiti, e questo dimostra che il genere è ancora
una questione d' attualità: favorisce i maschi mentre penalizza le femmine. Le
quali nel mondo scientifico e della produzione in realtà eccellono e occupano
giustamente posti importanti. Da quando l'istruzione universitaria è accessibile
alle signore si sono aperti per queste orizzonti fino al secolo scorso
impensabili. Tanto è vero che oggi le laureate e le laureande sono più copiose
dei maschi, il che non può non avere ripercussioni sulla vita nazionale.
Esemplifico. A Libero, il nostro giornale, lavorano parecchie ragazze (un tempo
nelle redazioni erano eccezioni sopportate) e devo testimoniare che mediamente
sono più brave (tenaci e talentuose) dei colleghi. Forse perché hanno studiato
meglio, sono più fantasiose e dispongono altresì di un fisico forte. Non mi
invento nulla, descrivo la realtà che ho sotto gli occhi ogni dì. Volendo essere
generoso, affermo che, a parte le ovvie diversità anatomiche, tra un lui e una
lei non vi sono differenze sostanziali. Un altro esempio che vi propongo. Negli
ospedali le donne primeggiano per numero e perfino per capacità. Io, grazie al
cielo, godo di discreta salute nonostante la non verde età. Tuttavia qualche
volta ho bisogno di un "tagliando", come le auto vecchie. Ebbene, anni orsono
soffrivo di diverticolosi. Un mio amico, pediatra insigne, mi consigliò di farmi
visitare dalla dottoressa Perrone. La quale mi curò (non vi racconto il mio
imbarazzo) e nel giro di un mese mi guarì. A distanza di un paio di lustri non
patisco neanche un sintomo. Ancora. La mia cardiologa si chiama Giannattasio,
primaria al Niguarda. Un fenomeno. È talmente capace da farmi impressione. Non
sbaglia un colpo, come il mio cuore. Da notare che fumo quanto un assassino. A
questo punto nelle discussioni con gli amici sostengo senza temere smentite che
le dame sono più preparate e attente dei loro pari grado. Un' estrema
annotazione riguardante il ramo ospedaliero: allorché qualcosa non funziona alla
perfezione nel mio organismo, telefono alla mia amica Melania Rizzoli e lei mi
fa la diagnosi a distanza azzeccandoci sempre. Un mostro. Ho scritto tutto
questo allo scopo di fornire le prove che stimo le femmine senza riserve. E ciò
spero mi consenta di dire che in politica, invece, tranne alcune eccezioni
lodevoli (Giorgia Meloni si segnala la migliore), non svettano affatto. Certune
sono autentiche asinelle e non sono in grado di aspirare a ruoli di rilievo.
Sono cretine come gli uomini. Per cui vincono costoro che sono più abituati a
gestire la loro stupidità.
Vittorio Feltri contro il matrimonio: "Un
intralcio. Uomo e donna? Non sono fatti l'uno per l'altro".
Vittorio Feltri su Libero Quotidiano il 27 febbraio 2021. Natalia
Aspesi, giornalista di talento, viene letta da decenni su vari giornali ed è
apprezzata dal pubblico perché non scrive mai banalità. Ciò detto, ieri
su Repubblica ho gustato un suo articolo riguardante le donne che sfondano e
quelle che affondano. Conteneva osservazioni interessanti, però complessivamente
ricalcava vecchi concetti, diciamo pure un po' scontati. Ai suoi ragionamenti,
comunque non contestabili, vorrei aggiungere alcune riflessioni compiute
esaminando la realtà. La maturazione femminile è avvenuta molto rapidamente
dalla seconda guerra mondiale in poi. Le ragazze finalmente, spinte dalle
famiglie, hanno spalancato le porte dell'Università e hanno a poco a poco
conquistato le sfere più elevate della cultura. Oggi dimostra di essere
inferiore nell'ambito della erudizione chi suppone che le signore non siano
all'altezza degli uomini. Basta dare una occhiata ai livelli che esse hanno
raggiunto nelle varie professioni un tempo riservate ai maschi. Inutile
ricordare che le loro scalate sono state faticose e intralciate dai noti
pregiudizi. Le più evolute, a mio giudizio, sono quelle che non hanno mitizzato
il matrimonio, la convivenza con un compagno, e non sono ossessionate dal
desiderio di maternità, assai diffuso per questioni naturali. Non è vietato
sposarsi, ovvio, tuttavia ciò può essere un intralcio, una scocciatura,
addirittura un peso. Due persone possono amarsi più a lungo e più intensamente
se non campano sotto lo stesso tetto. La qualcosa comporta difficoltà
insuperabili. Dopo un periodo in cui lui e lei stanno accanto di giorno e di
notte, scatta l'insofferenza. Dormire in due nel medesimo letto poi è contro
ogni logica. Basta uno sbadiglio a disturbare il partner, non parliamo poi se
uno dei due russa, è la fine dell'affetto non solo del trasporto. La questione
sessuale è molto delicata. Il desiderio viene ammazzato dall'abitudine, gli
stessi esercizi ripetuti lo annullano senza soluzione. E qui scattano le corna
che non aiutano certo la concordia coniugale, insomma o due sposi si conquistano
spazi individuali (due stanze separate e due bagni sono il minimo sindacale)
oppure lo sfascio è garantito al 90 per cento. Inoltre, la pace è assicurata
soltanto da patti chiari. La moglie non è una serva, i lavori domestici devono
essere svolti pure dal marito, altrimenti la parità va a farsi benedire. Nel
caso poi ci siano di mezzo dei figli, la spartizione dei compiti va fatta col
bilancino. Altrimenti le donne vengono penalizzate persino sul lavoro, il quale
richiede impegno totale. Lo spirito che eventualmente deve sostituire
l'attrazione fisica, mai duratura, è quello del mutuo soccorso. Le unioni
matrimoniali per resistere devono obbedire alle stesse regole che governano una
società imprenditoriale. In caso contrario il nucleo familiare diventa un
inferno in cui germogliano perfino violenze. Per concludere veniamo alla prole.
Non solo la educazione da impartire occorre sia concordata, ma altresì gli
impegni che essa comporta o sono spartiti tra i genitori oppure anche i bambini
cresceranno pieni di preconcetti. Uomini e donne sono uguali in tutto. Se non ce
ne convinciamo la sofferenza sarà un prodotto ineliminabile. Le donne lo sanno.
Gli uomini mica tanto.
Da lastampa.it il 18 febbraio
2021. Sarà Seiko Hashimoto, fino a oggi ministra per lo Sport con la delega alla
preparazione delle Olimpiadi, la nuova presidente scelta al timone del comitato
organizzatore di Tokyo 2020 dalla commissione ad hoc, istituita a seguito delle
dimissioni repentine dell'ex presidente Yoshiro Mori. Dopo aver accettato
l'incarico in mattinata, Hashimoto ha rimesso il suo incarico di ministra al
premier giapponese Yoshihide Suga. Come atleta ha partecipato a sette Olimpiadi,
quattro invernali ('84, '88, '92 e '94) nel pattinaggio di velocità e tre estive
('88, '92 e '96) nel ciclismo. Nel ‘92 ha vinto una medaglia di bronzo, la sua
unica, nei 1.500 metri, nel pattinaggio. Yoshiro Mori, 83 anni, ex primo
ministro giapponese, era stato costretto a dimettersi la scorsa settimana dopo
aver fatto commenti sessisti sulle donne.
(ANSA il 12 febbraio 2021) Il presidente del
Comitato olimpico giapponese, Yoshiro Mori, conferma la decisione di farsi da
parte, annunciando le sue dimissioni all'apertura del consiglio direttivo a
Tokyo. L'83enne ex premier era stato messo sotto accusa dopo le sue
dichiarazioni fatte a margine della proposta di allargare l'assemblea a un
maggior numero di donne, definendola "problematica" per la tendenza delle stesse
a "parlare eccessivamente". Nel corso della riunione Mori si è scusato per i
suoi commenti "poco opportuni", aggiungendo di non voler essere un ostacolo
all'organizzazione dei Giochi.
"Le donne? Parlano troppo". Olimpiadi
senza quote rosa. Mori, presidente del comitato
organizzatore ed ex premier, costretto a scusarsi. Ma non lascia l'incarico.
Gaia Cesare, Venerdì 05/02/2021 su Il Giornale. L'obiettivo parità di genere è
fissato per le Olimpiadi di Parigi 2024, ma già da quest'anno le donne saranno
poco meno della metà degli atleti in gara a Tokyo, il 48,8%. Eppure anche
stavolta - come ogni buon evento che si rispetti - il copione si ripete. Le
frasi sessiste - o ironiche, secondo qualcuno - di un uomo con ruolo e poltrona
di primo piano, la bufera che ne consegue, le scuse postume di chi ammette di
aver sbagliato, e poi tutto come prima. Fino alla prossima gaffe. Nell'occhio
del ciclone stavolta è finito Yoshiro Mori, 83 anni, presidente del Comitato
Organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo ed ex primo ministro, che con le sue
dichiarazioni ha aggiunto altri guai all'appuntamento sportivo, già colpito dal
rinvio per coronavirus e posticipato di un anno all'estate 2021, con il sospetto
che l'emergenza sanitaria possa ancora costringere alla cancellazione. Ma ecco
le frasi incriminate: «Nei consigli di amministrazione con tante donne si perde
molto tempo». La ragione? Parlano troppo. «Hanno difficoltà a finire i loro
interventi». Anzi peggio: «Le donne hanno spirito di competizione. Se una alza
la mano (per intervenire, ndr), le altre credono che debbano esprimersi anche
loro. E finiscono per parlare tutte», spiega Mori durante una riunione on-line i
cui contenuti finiscono sui giornali. Apriti cielo. Passano pochi giorni e la
marea anti-Mori si alza. La ferita è aperta in un Paese dove la parità di genere
è ancora lontana. Il primo ministro Yoshihide Suga, che nel 2015 era il braccio
destro dell'ex premier Shinzo Abe, si presentò in tv rivolgendosi direttamente
alle donne: «Per favore, fate molti figli». E il suo attuale vice, Tar As, che è
anche ministro delle Finanze, appena un anno fa ha dichiarato che il vero
problema del Paese non sono gli anziani ma le donne senza figli. Secondo il
report 2020 del World Economic Forum sul «gender gap» mondiale, il Giappone
occupa il posto 121, su un totale di 153 Paesi, e questo nonostante il tasso di
occupazione femminile sia cresciuto del 10% in quasi dieci anni e abbia
raggiunto quota 72,6% nel 2019 (dati Ocse) contro il 63,2% del 2010. Le donne
sono sottorappresentate in politica e nei consigli di amministrazione e sono
ancora associate allo stereotipo che le vuole regine del focolare domestico. Ma
il clima sta cambiando anche qui, dove il movimento #MeToo ha visto protagonista
la giornalista Shiori Ito, che è riuscita a ottenere la condanna per stupro del
suo ex capufficio, scoperchiando il vaso di Pandora delle molestie sessuali in
Giappone. Così, dopo aver messo il dito nella piaga, il presidente del Comitato
Olimpico Mori è stato costretto a scusarsi: erano dichiarazioni «contro lo
spirito dei Giochi Olimpici e Paralimpici». Ma del suo futuro nel Comitato non
si discute: «Non mi dimetterò». Eppure la sua stella rischia di venire
definitivamente offuscata in patria, dove le Olimpiadi non sono viste di buon
occhio a causa dell'emergenza sanitaria. I sondaggi dicono che l'80% dei
giapponesi vorrebbe che i Giochi fossero rimandati o annullati. Il governo è
stato costretto ieri a smentire indiscrezioni di stampa secondo le quali si
prepara a cancellare le Olimpiadi. Mori promette: «Si faranno a ogni costo»
Le donne da palcoscenico di Verdi,
Leonora e le eroine del melodramma. Le figure verdiane
(e non solo) raccontate dal soprano Buratto nel 120° anniversario della
morte del compositore. Edvige Vitaliano su Il Quotidiano del Sud il 31 gennaio
2021. Le donne di Verdi? Un universo variegato. Basta un attimo e – per certe
sfumature del carattere, per certe vicende, per certe passioni e certi destini –
ti appaiono quasi in carne e ossa. Ecco Violetta Valéry protagonista de La
Traviata ispirata dalla Marguerite Gautier de “La signora delle camelie” di
Alexandre Dumas (figlio); ecco l’ Abigaille del Nabucco figlia (presunta) del re
di Babilonia, in realtà schiava. Prese a prestito da Shakespeare sia Lady
Macbeth che Desdemona vittima della gelosia di Otello. E poi Amneris figlia di
Amonasro, re dell’ Etiopia e padre della principessa Aida; senza
dimenticare Luisa Miller figlia di un vecchio soldato in ritiro. Ancora: Leonora
de il Trovatore che si avvelena per amore, Elena dei Vespri siciliani sorella
del duca Federigo d’Austria. Infine – ma si potrebbe continuare – Giovanna
D’Arco, e Odabella figlia del signore di Aquileia che sfida e uccide Attila.
Donne da palcoscenico che oggi – con i teatri chiusi – riemergono ancor più dai
cassetti della memoria in occasione del 120° anniversario della morte di
Giuseppe Verdi. Di eroine verdiane e non solo parliamo con il soprano Eleonora
Buratto.
Signora Buratto come ricorda il suo primo incontro
con il repertorio operistico del cigno di Busseto?
«Ricordo che Amelia del Simon Boccanegra fu il
primo ruolo che mi fu proposto e creò anche un po’ di dubbi. Inizialmente pensai
di non essere ancora pronta per affrontare un ruolo così impegnativo, ma a
chiedermelo era il Maestro Muti e mi fidai della sua intuizione. Ancora oggi gli
sono grata per avermi permesso di aprire un nuovo capitolo della mia carriera».
Ma chi è Verdi per Lei?
«Un compositore immenso, un musicista che con la
purezza della sua musica ti obbliga all’onestà nell’affrontare le sue opere.
Quando un cantante o un direttore non rispetta questa semplice regola, perde.
Bisogna sapersi mettere a nudo, bisogna capire il suo cuore e rispettarlo».
Aida, Abigaille, Lady Macbeth, Desdemona, Leonora,
Luisa Miller, Elena, Gilda …Quali tra le “donne” di Verdi lei ama di più e
perché?
«Le donne di Verdi le amo tutte, non c’è
possibilità di scelta se si pensa alla musica. Forzatamente potrei dire che il
ruolo che amo di più è quello di Leonora. In alcune di loro forse posso anche
trovare delle affinità, ma la “donna” alla quale più assomiglio è Alice».
Non si può parlare dei personaggi femminili
verdiani senza accennare alla Traviata e Violetta Valéry… Quale – a suo giudizio
– è la Violetta che tutti dovrebbero ascoltare almeno una volta nella vita?
«Nessun dubbio, quella di Maria Callas».
E veniamo al presente. L’Opera è tornata alla
Scala: in scena “Così fan tutte” di Mozart con la regia di Michael Hampe
(ripresa da Lorenza Cantini). Sul podio Giovanni Antonini. A lei è toccato il
ruolo di Fiordiligi. Cosa le ha lasciato questo personaggio e quanto è stato
emozionante cantare alla Scala sia pure senza pubblico per via delle
restrizioni?
«Il personaggio non aspettava altro che essere
debuttato. Era già pronto a marzo scorso, ma la pandemia mi ha fatto perdere la
produzione a Tokyo. Sono molto felice che la Scala mi abbia dato questa
possibilità e sono orgogliosa di aver fatto parte della prima opera
rappresentata lì dopo la chiusura dei Teatri».
C’è però un precedente scaligero di soli pochi
mesi fa: lei è stata anche tra gli ospiti di “A riveder le stelle” con la
direzione di Chailly e la regia di Livermore lo scorso 7 dicembre. La Scala pur
essendo “vuota” è entrato nelle case di moltissimi italiani grazie al piccolo
schermo nel giorno deputato alla Prima. Che ricordo ne conserva?
«Un ricordo bellissimo. Me lo sono goduto dalla
platea del Teatro alla Scala ed è stato molto emozionante, soprattutto pensare a
quanto lavoro c’era dietro uno spettacolo così complesso, ma per il pubblico da
casa fluido e omogeneo».
Palpiti, emozioni e opera non solo per melomani e
addetti ai lavori. Del resto, La Scala ha scritto pagine importanti della Storia
italiana. Basti pensare all’11 maggio del 1946 quando Toscanini dirige il
concerto di riapertura del Teatro ricostruito…
«Sì, la storia della Scala è fortemente
intrecciata con quella di Milano, della Lombardia e dell’Italia».
Che effetto le fa sapere e vedere i palcoscenici
dei teatri col sipario chiuso a causa della pandemia?
«Per tutti noi artisti è una cosa tristissima. Le
produzioni si sono ridotte ad una recita in streaming e non abbiamo certezze di
quando potremo riavere il pubblico in sala. Non abbandoniamo la speranza di
poter ricominciare la nostra vita, ma per ora non possiamo far altro che
adattarci a questo periodo di transizione».
A parte Muti, lei è stata anche diretta da Daniele
Gatti e da Zubin Mehta, c’è un direttore del passato con cui avrebbe voluto
collaborare?
«Avrei voluto collaborare con molti direttori del
passato. Passando nei corridoi della Scala si leggono i nomi dei direttori che
hanno fatto anche la storia del teatro. Forse uno su tutti, Toscanini. E
Karajan».
Qual è, se c’è, il suo rito scaramantico prima di
salire sul palco?
«Non ho riti scaramantici, ma prego sempre Dio e
la mia mamma».
Quanto le manca l’abbraccio dell’applauso del
pubblico dalla platea o dai palchi?
«Manca moltissimo, il pubblico è parte integrante
dello spettacolo. Senza pubblico è come se fosse solo una prova generale».
Stefano Semeraro per lastampa.it il 30 dicembre
2020. Le tenniste sono fra le sportive più agguerrite nel chiedere un pari
trattamento economico rispetto ai colleghi maschi, ma finanziariamente non se la
cavano comunque male. Una inchiesta di GoBankingRates sostiene infatti che 20
delle 26 più ricche atlete del pianeta, a partire dalla numero 1 Serena
Williams, si guadagnano o si sono guadagnate le vita impugnando una racchetta.
La Williams è accreditata di un patrimonio complessivo di 200 milioni di
dollari: 93 incassati in montepremi, il resto frutto di sponsorizzazioni e
investimenti. Serena è infatti anche una abile imprenditrice, che sa come
differenziare i suoi interessi, fra la sua linea di abbigliamento e
partecipazioni in varie società e start up. Alcune delle quali a sfondo «etico»,
cioè che sostengono iniziative di donne appartenenti a minoranze etniche (ad
esempio nel campo della gioielleria). L’ultimo investimento dell’americana ha
come beneficiaria Alchemy 43, una società californiana specializzata in
trattamenti estetici facciali e microterapie per la conservazione della
pelle. Dopo di lei viene la sua ex grande rivale, Maria Sharapova, altra
businesswoman di successo che dopo 11 anni passati, secondo Forbes, da atleta
più pagata del pianeta, anche da «pensionata» mantiene un patrimonio di 140
milioni di dollari, accumulati in montepremi (39) ma anche attraverso aziende di
successo come Sugarpova, che produce caramelle e dolci. Sul podio, al terzo
posto c’è la prima non tennista, ovvero Alexis DeJoria, la pilotessa made in Usa
molto brava a conquistarsi un posto in un settore decisamente maschile come
quello della NHRA, la National Hot Rod Association, che organizza corse di
drag-car e altre vetture particolari. La DeJoria, che compete con le «Funny
Car», ha un patrimonio stimato di 100 milioni di dollari. Un’altra diva del
volante, la famosissima Danika Patrick, ex stella della IndyCar della Nascar,
occupa il quinto posto (60 milioni) ma già dal quarto ricomincia la teoria delle
tenniste-paperone, con Venus Williams, sorella di Serena, con 95, che precede al
sesto Na Li, la più forte cinese di sempre: 50 milioni che valgono forse il
doppio, visto che Na ha dovuto forzare i paletti imposti dal regime di Pechino.
A pari merito con lei c’è un’altro nome famoso come quello di Anna Kournikova,
che in campo ha vinto pochissimo, ma ha ottenuto molto in sponsor e relative
attività. Sono in effetti parecchie le campionesse del passato che appaiono in
questa speciale classifica: all’ottavo posto troviamo Caroline Wozniacki, al
nono Steffi Graf, al 12esimo Martina Hingis, al 15esimo, a pari merito Billie
Jean King, Monica Seles. Lindsay Davenport e Kim Clijsters (recentemente tornata
alle gare dopo due gravidanze), al 19esimo Chris Evert e al 22esimo la sua
grande rivale Martina Navratilova. Morale: fare la tennista conviene, anche come
fondo pensione.
La lista completa.
1) Serena Williams (tennis) 200 milioni di dollari
2) Maria Sharapova (tennis) 140 milioni
3) Alexis De Joria (automobilismo) 100 milioni
4) Venus Williams (tennis) 95 milioni
5) Danica Patrick (automobilismo) 60 milioni
6) Li Na (tennis) 50 milioni
7) Anna Kournikoa (tennis) 50 milioni
8) Annika Soerestam (golf) 40 milioni
9) Caroline Wozniacki (tennis) 30 milioni
Simona Halep (tennis), Steffi Graf (tennis)
12) Agnieszka Radwanska (25 milioni), Naomi Osaka
(tennis), Martina Hingis (tennis)
15) Monica Seles (20 milioni), 16 Billie Jean King
(tennis), Lindsay Davenport (tennis), Kim Clijsters (tennis)
19) Michelle Kwan (golf) 16 milioni, Ana Ivanovic
(tennis), Chris Evert (tennis)
22) Karrie Webb (golf) 15 milioni, Lorena Ochoa
(golf), Martina Navratilova (Tennis), Jelena Jankovic (tennis), Victoria
Azarenka (tennis).
·
Donne e Sport.
Dagotraduzione dal Sun il 2
novembre 2021. I fan della MMA sono rimasti disgustati dall’incontro che si è
svolto in Polonia tra un uomo e una donna. Uno degli spettatori ha descritto la
scena come «orribile», e l’arbitro è stato costretto a interrompere l’incontro.
Ad affrontarsi sono stati Ula Siekacz, lottatrice di braccio di ferro e
istruttrice di fitness, e Piotrek Muaboy, che si definisce «185 cm di puro
sesso». L’incontro si è svolto in un hotel della città polacca di Czestochowa. I
due all’inizio sferrano colpi abbastanza docili, finché Muaboy non assesta un
paio di colpi in faccia a Siekacz. Le cose precipitano rapidamente e Muaboy
prima la atterra, poi la monta e quindi inizia a sferrarle pugni, finché
l’arbitro non interviene. Quando il video è apparso online, i fan della Mma si
sono precipitati a commentare: «È orribile»; «Fanculo a tutti quelli che hanno
preso parte a questo incontro. E a te per averne postato i momenti salienti»;
«Cosa diavolo è questo, senza rivali?»; «Questo è assurdo» e «Questo non è Mma».
Nella stessa sera si è svolto anche un altro incontro misto, vinto dal "Polish
Ken Doll" Michal Przybylowicz contro Wiktoria Domzalska.
Valeria Palumbo per
il "Corriere della Sera" il 29 giugno 2021. San Pietroburgo, 1902. Una donna, la
britannica Florence Madeleine Cave (1881-1917), si presenta ai Mondiali di
pattinaggio. Nessuno ha pensato di aggiungere «maschili» perché a nessuno è
venuto in mente che una donna possa partecipare. Madge, come la chiamano gli
amici, vince l'argento. Risultato? Dal campionato successivo, del 1908, le donne
sono esplicitamente escluse. Si facessero il loro. Avviene già nel 1906 e Madge
rivince. Però, pensateci, se ancora adesso «l'Italia» è per definizione la
nazionale di calcio maschile, qualcosa non va. Soprattutto, se la storia dello
sport femminile è pavimentata di tanti divieti e, nonostante questo, le donne li
hanno sfidati tutti, vuol dire che il problema non è loro. Che lo sport lo hanno
sempre praticato, come racconta Eva Cantarella, co-autrice con Ettore Miraglia
di Le protagoniste. L' emancipazione femminile attraverso lo sport, edito da
Feltrinelli. Certo, nell' antichità si è andati in ordine sparso. E perfino a
Sparta, dove le ragazze si esercitavano regolarmente, perché così aveva voluto
il leggendario legislatore Licurgo, l'obiettivo era fare di loro madri più
forti, che producessero figli più sani. Così alla grande corsa annuale in onore
di Elena, modello di moglie (gli spartani credevano che fosse stata calunniata a
proposito di Paride), correvano in tante. Ma non veniva proclamata una
vincitrice. Mentre gli uomini gareggiavano soltanto per quello, in barba a
quanto riteneva Pierre de Coubertin, fondatore delle moderne Olimpiadi. A
proposito di de Coubertin, contro le atlete e la «fisiologia» femminile ne disse
di tutti i colori (in buona compagnia): sostenne, per esempio, che maternità e
sport fossero incompatibili, e pazienza per Sparta o per successive campionesse
come Fanny Blankers-Koen, strepitosa protagonista dell'Olimpiade di Londra del
1948, che ebbe anche lo stoicismo di tollerare il nomignolo di «mammina
volante». Certo, la Chiesa infieriva, terrorizzata da tutto ciò che rendesse le
donne più autonome. E gli pseudo-scienziati positivisti, dietro, a immaginare
chissà che danni alla salute. Poi i danni ci sono stati davvero: ma per il
doping, e Miraglia racconta bene il dramma delle atlete dell'Est, negli anni
della Cortina di ferro. Ma anche il coraggio della nuotatrice Christiane Knacke,
bronzo nei cento farfalla di Mosca 1980: diventò, alla caduta del Muro di
Berlino, la principale accusatrice del suo Paese, la Germania dell'Est, e al
processo buttò a terra, per sfregio, la sua medaglia olimpica e restituì le
altre. Ma, a proposito di ormoni, in Le protagoniste si racconta molto bene la
«strana» storia del testosterone: le atlete che ne hanno più di cinque nanomoli
per litro, nel sangue, non possono gareggiare. Che questo sia lo sbarramento per
essere «donne», che incida davvero sulle prestazioni sportive e che, tra gli
uomini, si trovino enormi variazioni nei livelli di testosterone ma nessuno ci
bada, non importa. Tanto che chi, in transizione di genere, ne ha livelli più
bassi perché fa cure ormonali, è ammesso. Il problema sono e restano le donne.
Dice bene Miraglia: la faticosissima battaglia delle donne per poter fare sport
e gareggiare (il saggio elenca tutti i divieti, le censure e gli ostacoli e
sembra incredibile che gli uomini ne abbiamo potuti inventare tanti) è stata
politica, sociale e culturale. Così la ciclista Alfonsina Strada, che si piazzò
tra i pochi superstiti del Giro d' Italia del 1924, ma anche Annette Kellerman,
che pretese di nuotare in costume e non vestita e sopportò per questo l' arresto
(«Non posso nuotare con più abiti di quanti ce ne stiano su un filo per stendere
i panni», fece mettere a verbale), o Wilma Rudolph, la «gazzella» dell'
Olimpiade di Roma del 1960, che rifiutò di partecipare alle celebrazioni post
olimpiche perché il governatore del Tennessee prevedeva un programma a parte per
i neri, hanno aperto per tutte, e per tutti, tempi migliori. Lo slittamento dal
1° giugno 2021 al 2 marzo 2022 al professionismo femminile nello sport, in
Italia, ci indica che la battaglia non è finita.
·
Le
Dominatrici.
Dagotraduzione dal Daily Mail il 14 novembre 2021.
È diventata virale la foto di una donna mascherata che porta al guinzaglio
un’altra donna mentre attraversano la strada. L’immagine è stata scatta da un
automobilista che, sbalordito, ha immortalato la scena mentre era fermo a un
semaforo di Adelaide, in Australia. Nella foto la donna che porta il guinzaglio
indossa un passamontagna integrale. La foto ha generato più di 1.100 commenti su
Reddit, dove è stata pubblicata. Le reazioni sono state diverse. C'è chi si è
preso gioco delle due donne - «È esilarante» - chi si è scandalizzato - «In
quale sobborgo? Non voglio andarci mai più» - e chi le ha difese - «Non stanno
facendo del male a nessuno, lasciale stare».
Simonetta Sciandivasci per Specchio – la Stampa il
14 settembre 2021. Pay Pig. Paga maiale. È così che si chiama il subalterno, lo
schiavo, che è poi il cliente, nel "findom", la dominazione finanziaria che
viene descritta come pratica sessuale, feticista, sadomasochista negli articoli
che ne parlano. L'Urban Dictionary, invece, salta queste categorie e lo
definisce «scambio di potere che implica un trasferimento di denaro da un sub a
una Domme come atto di sottomissione finale». Il sub è il pay pig, lo schiavo;
la Domme è la mistress, la dominatrice - sì, nella maggior parte dei casi è una
donna perché sì, i cultori della pratica sono, 9 su 10, benestanti maschi etero.
La gamma di servizi che la Domme offre va dal controllo del conto in banca al
suo prosciugamento, per mezzo di inviti all'acquisto e richieste di regali
(bonifici, viaggi, beni inessenziali), inoltrati per messaggio, mail, dm, o
rivolti direttamente durante videochiamate, anch'esse a pagamento. Nel findom,
quindi, non è previsto contatto tra i contraenti, perché il cliente compra per
comprare ancora, per farsi sfruttare: «Godevo dell'umiliazione di farmi svuotare
il conto da principesse sadiche che si divertivano a sfruttare pervertiti come
me», ha raccontato a Vice un rispettabile borghese, ricco e sposato, nessun
vizio tranne il sesso in webcam con professioniste lautamente pagate, che però
l'ha annoiato presto e allora s' è messo a cercare altro ed è finito nelle mani
di ragazze che lo hanno ridotto sul lastrico (per comprare gioielli alle sue
padroncine, ha rubato quelli di sua moglie, finché non le ha confessato d'essere
diventato tossicodipendente e tante scuse, ottenendo lacrime e soldi per
disintossicarsi: ora continua a staccare assegni per le padroncine, ma non
supera mai i 100 dollari a settimana). Il finanziariamente dominato non è in
cerca di personal shopper: desidera farsi impoverire, lo scalda il pensiero di
azzerare il conto e di doversi industriare per trovare altro denaro da devolvere
alla sua Domme - «Ho pensato di prostituirmi: considerare una possibilità tanto
degradante mi ha eccitato». È una parte della questione: il successo del findom
è l'ennesima prova della smaterializzazione del sesso, del suo legame con il
potere e del bisogno maschile di liberarsene, facendosi guidare verso la propria
rovina. Sono stufo di essere ricco, previdente, oculato e allora uso i miei
soldi per straviziare qualcuno che non sono io: sembra una punizione, e di certo
lo è, ma è anche manipolazione, perché lo schiavo rimpingua l'avidità della sua
padrona e non la propria, come fa un demonio. Lo schiavo, insomma, è puro: si
sacrifica, non vuole e non fa nulla per sé, è quasi ascetico, quasi si purifica.
Dall'altra parte, lo schiavo agisce come un genitore che lava il senso di colpa
della sua assenza regalando ai figli ciò che desiderano, soddisfacendo qualsiasi
loro richiesta e traendo da questo non solo la pacificazione della propria
coscienza, ma pure il piacere narcisistico di aver reso felice la prole,
potendosi permettere di non dire no. Non c'è niente di più capitalistico. Certo,
a un aperitivo tra amiche è facile dedurre il pensiero più facile, dire che
queste Domme sono geniali perché sfruttano rammolliti terrorizzati dal sedurre
una donna. Ma il findom è un contratto e i contratti non liberano: vincolano,
talvolta riparano. Una pandemia e un biennio di seriosità dopo, in un'intervista
al New York Times, Mistress Marley, dominatrice professionista, 27 anni,
originaria di Harlem e attualmente domiciliata in Messico, in agiato
appartamento con piscina e spiaggia privata, ha detto che per lei il findom è un
risarcimento per gli anni di schiavitù cui gli afroamericani sono stati
costretti, «dal momento che quasi tutti i miei clienti sono bianchi». A questa
connotazione poteva riuscire a pensare soltanto una coetanea di quei ragazzi che
riescono a trasformare in militanza politica anche pomeriggi trascorsi su
Twitter a insultare un giornalista molto anziano. I nuovi servi, servi bianchi,
raccontano tutti la stessa cosa: quanto piacere dia loro perdere il controllo e
appaltarlo completamente alle donne. È storia vecchia, in fondo riassumibile in
quel "amore, fai tu", con cui ci incastrano da sempre.
Dagotraduzione da Rolling
Stone il 31 luglio 2021. Quando all’inizio di quest’anno è uscito il vaccino
contro il Covid, Bob, conosciuto anche come Mannish Boy, non era certo di
volerlo fare. Si sentiva diffidente per la velocità con cui il vaccino era
arrivato sul mercato. E aveva sentito parlare di alcuni dati preliminari che
suggerivano che la versione AstraZeneca, in Europa, avesse un raro effetto
collaterale: provocare coaguli di sangue. Tutto questo lo rendeva ansioso.
«Penso di aver avuto le stesse riserve di molti altri» ha raccontato Bob, che ha
chiesto di restare anonimo. Un giorno Bob ha letto un tweet di Goddess Alexandra
Snow, una dominatrice professionista e proprietaria di Wicked Eden, una prigione
BDSM con sede a Columbus, in Ohio. Il tweet annunciava che i sottomessi che
avessero desiderato un appuntamento con Snow, avrebbero dovuto dimostrare di
essere stati vaccinati. Bob si era abbonato due anni prima al suo canale su
Onlyfans, e così l’ha contattata per discutere della sua situazione. «Non volevo
tanto essere connvinto quanto che mi confermasse che era la cosa giusta da
fare». Bob ha ricevuto la sua seconda dose di vaccino tre settimane fa. «Mi fa
piacere sapere che sto contribuendo (si spera) ad evitare che gli altri si
ammalino gravemente» dice. «E, naturalmente, è gratificante sapere che ho fatto
qualcosa che Goddess Snow approva». Anthony Fauci probabilmente non ha mai preso
in considerazione l’idea di passare dai dominatori sessuali per aumentare il
tasso di vaccinazione negli Stati Uniti. Eppure i dominatori di tutto il paese,
che stanno lentamente riaprendo le porte delle loro prigioni segrete, dicono che
lo sforzo di costringere i sottomessi a vaccinarsi ha avuto un discreto
successo. «Almeno una dozzina di persone mi hanno scritto: “Se questo è quello
che devo fare per vederti, lo farò”. E questo mi rende felice» ha detto Snow.
«Se qualcuno si vaccina per me, è una persona in meno ad avere impatto sulla
comunità». Le dominatrici che usano i loro considerevoli poteri persuasivi sui
loro sub per servire il bene comune non sono una novità: in vista delle elezioni
del 2020, per esempio, alcune dominatrici hanno detto a Rolling Stone che
stavano ordinando ai loro sub di votare per l'attuale presidente Joe Biden. Ma i
dominatori con cui ho parlato non ne hanno fatta una questione politica, e
neanche etica. Credono sia una misura di autoprotezione (in effetti, la maggior
parte delle lavoratrici del sesso sono appaltatrici indipendenti, e quindi se si
ammalano rischiano di dover pagare cifre esorbitanti di tasca propria per
l'assistenza sanitaria). È anche un modo concreto per misurare la devozione dei
sub. «Chi è al nostro servizio dovrebbe rispettare i nostri confini», afferma
Daddy An Li, una domme con sede a Los Angeles che chiede la prova della
vaccinazione dai suoi sub. «O vuoi servirci e ci rispetti, o non lo fai». Altri,
come Goddess Snow, la vedono anche come un'opportunità educativa. «Io non voglio
che qualcuno faccia quello che gli dico solo perché gli ho detto di farlo.
Voglio che lo facciano perché ho ragione», dice. Per questo vuole fornire ai sub
che esitano la letteratura che attesti la sicurezza del vaccino, in modo da
farli decidere da soli. «Una cosa è dire a qualcuno, “non puoi masturbarti per
una settimana”. E un'altra è dire “Voglio che tu prenda questa sostanza estranea
nel tuo corpo”», dice. «Non voglio essere responsabile di questo. Gran parte del
BDSM riguarda l'autonomia corporea, e ho bisogno che abbiano autonomia corporea
lì». Anche Mistress Manouche, una domme con sede nell'East Sussex, nel Regno
Unito, richiede la prova della vaccinazione se i sub desiderano fare una
sessione con lei. Ha problemi di salute specifici: ex malata di leucemia, ha
subito un trapianto di midollo osseo, vive con genitori anziani e gestisce la
sua prigione dalla loro casa condivisa. Sebbene inizialmente avesse chiesto ai
suoi sottomessi di indossare maschere, ha scoperto che non era fattibile in uno
spazio sotterraneo. «Ciò che facciamo è molto intimo», dice a Rolling Stone.
«Sputo in bocca ai miei sub. Li tocco. Io uso le fruste, ma non puoi
semplicemente frustare qualcuno a 10 piedi di distanza. Sei in uno spazio chiuso
e non è sempre pratico indossare solo le mascherine. Non potevo lavorare
correttamente e fare quello che faccio normalmente se devo mantenere le
distanze». In effetti, a seconda di quale sia la loro specialità, alcuni
dominatori non si sentono abbastanza a loro agio nel fare il lavoro di persona a
meno che i sub non siano vaccinati. «Sono specializzato nel gioco del bagno» -
essenzialmente si tratta di «cacare sui tizi» - «e non posso farlo con persone
che non sono vaccinate», dice Daddy An Li. Come molte dominatrici, l'attività di
persona di Mistress Manouche è stata decimata dalla pandemia; anche se ha
cercato di trasferire la sua attività all'online, ha scoperto di aver
rapidamente esaurito il numero di contenuti ed è passata alla vendita di carte e
cioccolatini solo per fare abbastanza soldi per comprare le sigarette. «È stato
assolutamente terribile», dice. Dopo aver ricevuto il suo primo vaccino contro
il Covid a gennaio e il secondo ad aprile, Mistress Manouche ha ricominciato ad
aprire le sue porte e a richiedere la prova della vaccinazione durante le sue
sessioni. All'inizio, «erano un po' incerti», dice, ricordandone uno in
particolare che aveva chiesto un'esenzione, preferendo farsi un test al giorno
se necessario pur di vederla. Ma è riuscita a convincere anche lui a vaccinarsi,
così come altri cinque sottomessi che in precedenza erano incerti. La comunità
BDSM si è organizzata in molti modi per affrontare la pandemia, afferma Mistress
Marley, una dominatrice professionista con sede a Manhattan, anche lei
intransigente sul requisito del vaccino. «L'industria del BDSM è davvero avanti
sui protocolli di sicurezza. Si tratta di sicurezza e consenso. Abbiamo parole
sicure e vogliamo assicurarci che le persone siano al sicuro. Ci prendiamo cura
l'uno dell'altra perché le cose possano diventare davvero fisiche», dice a
Rolling Stone. «L'industria in generale si occupava della sicurezza molto prima
che arrivasse il Covid». Ma non tutte le dominatrici richiedono la vaccinazione,
soprattutto se influisce negativamente sui loro profitti. Snow dice che
l'argomento compare spesso in un canale Slack che gestisce per le prostitute e
che durante il picco della pandemia, c'è stato un lungo dibattito sull'etica di
vedere i clienti di persona. «La cosa tremenda è che le lavoratrici del sesso
hanno avuto redditi decimati durante la pandemia», dice. «Alcune si vergognavano
di confessare che avevano fatto qualche appuntamento». Da quando il vaccino è
diventato disponibile, se ne è iniziato a discutere: «alcune persone non hanno
la capacità di dire “Se non sei vaccinato, non puoi venire”. Devono prendere
decisioni basate sul denaro piuttosto che sulla sicurezza», dice. In effetti,
l'adozione di una politica di vaccinazione obbligatoria ha danneggiato i
profitti di Wicked Eden e Snow stima di aver visto una riduzione del 30% circa
delle prenotazioni dall’introduzione del requisito vaccinale. Dice anche che da
quando ha annunciato la politica, è stata "inondata" di e-mail arrabbiate che
citavano disinformazione relativa al vaccino. «Un link dopo l'altro, tutti che
puntavano a strani siti web contro i vaccini», dice. Eppure la stragrande
maggioranza dei sottomessi esitanti nel vaccino, racconta, ha accettato di
proteggersi. E dopo, «gli dico sempre “ottimo lavoro, sono orgoglioso di te!
Bravo ragazzo!”», dice.
Mauro Zanon per "Libero
quotidiano" il 20 aprile 2021. Les italiens sono i suoi preferiti. «Sono i miei
cocchini, amo coccolarli e loro amano ciò che offro. È sempre un piacere
riceverli perché sono l'eleganza fatta persona, sono sensibili alla raffinatezza
e hanno il senso della seduzione. È qualcosa di naturale per loro. Quando sono
alla porta indovino sempre quando una coppia è italiana. Lo scriva ai suoi
lettori: vi adoro». Inizia così la chiacchierata di Libero con Valérie Hervo, la
proprietaria e regina de Les Chandelles, il club libertino più rinomato e
raffinato di Parigi, oasi di piacere situata a rue Thérèse, nel cuore della
capitale francese, a pochi passi dall' Opéra. «Les Chandelles è anzitutto il
luogo del femminino, uno scrigno dedicato alle donne, alla loro sensualità e
alla loro potenza», dice a Libero Valérie Hervo, che ha appena pubblicato un
libro autobiografico, Les dessous des Chandelles. Une femme en quête de liberté
(Le Cherche-Midi), dove racconta la genesi della sua creatura e i motivi che
rendono Les Chandelles la boîte più concupita dai libertini francesi. E non
solamente. Valérie ha 26 anni (nel 1993) quando decide di creare questo luogo in
cui la donna «deve sentirsi libera, radiosa e al centro di tutte le attenzioni,
non un trofeo da esibire o un bottino da condividere, ma una dea da onorare e
una libertina da adorare».
PASSIONE Alle Chandelles è la
donna a dominare i dibattiti e i momenti di passione, a imporre i suoi desideri
e i suoi capricci, e il sesso è soltanto la ciliegina sulla torta, perché la
cosa più importante, afferma Valérie Hervo, «è il preludio, ciò che viene prima
dell' atto, ossia il gioco di seduzione, l' erotismo, l' eleganza e il mistero».
Quando ci si presenta davanti alla facciata blu notte delle Chandelles, bisogna
essere ben vestiti: completi ben tagliati per gli uomini e abito chic e tacchi
alti per le donne. Poco importa se ti chiami Mick Jagger: se sei vestito con
jeans e scarpe da ginnastica e pensi di poter entrare lo stesso in ragione della
tua celebrità, ti sbagli di grosso, perché Valérie non fa eccezione. «Da me non
ci sono spazi vip. Tratto tutti allo stesso modo. Non faccio differenza tra
persone famose e non. Il mio unico criterio è che la persona sia in un movimento
di seduzione, abbia un gusto per ciò che è bello e sia elegante», spiega Madame
Hervo. Delle Chandelles, è un habitué lo scrittore dandy Frédéric Beigbeder,
autore del bestseller L' amore dura tre anni. Lui non lo ha mai nascosto, anzi
lo ha più volte rivendicato. C' è chi invece preferisce mantenere l' anonimato,
cosa a cui Valérie tiene molto, tanto che all' ingresso, prima di scendere le
scale che portano alle alcove del piacere, bisogna imperativamente lasciare i
telefonini: non sia mai che a qualcuno, inebriato dalla situazione, venga l'
idea di scattare una foto o registrare un video. Ma nonostante lo sforzo per
proteggere la privacy dei clienti, sono comunque usciti sulla stampa i nomi di
due politici che alle Chandelles hanno trascorso notti di estasi: il primo è l'
ex capo del Fondo monetario internazionale Dominique Strauss-Kahn, il secondo è
l' attuale ministro dell' Interno Gérald Darmanin. «Ma qui viene qualsiasi tipo
persona. Di recente, ho accolto una direttrice di scuola materna e suo marito,
entrambi provenienti da un sobborgo chic fuori Parigi», dice la proprietaria
delle Chandelles. Per Valérie, oggi, non c' è nulla di più femminista del suo
club a Parigi. «È diventato un alto luogo del femminismo. Per me è sempre stato
importante proteggere la donna dagli uomini che non la rispettano, dai seduttori
maleducati e dai machi grotteschi che affollano le classiche discoteche. Da me
la donna si sente al sicuro. È la mia principessa», spiega Madame Hervo. Il suo
libro è anche il racconto di un percorso di riscatto, di una donna traumatizzata
dagli abusi sessuali di cui è stata vittima quando era bambina, che a rue
Thérèse, alle Chandelles, ha trovato il suo spazio di riparazione intima.
«Creare Les Chandelles è stato un modo per ricostruirmi», racconta Valérie
Hervo. Quando le chiediamo chi siano i suoi modelli femminili ci dice due nomi:
Elisabeth Badinter, intellettuale laica in guerra contro il neofemminismo di
importazione americana che sta creando una guerra tra i sessi, e Simone de
Beauvoir, scrittrice e egeria del femminismo francese. Per la riapertura
«bisognerà aspettare almeno l' estate», sostiene Valérie. Lei non vede l' ora di
riaccogliere i suoi clienti libertini. Soprattutto quelli italiani.
Margaret Corvid per “The Spectator” il 15 aprile
2021. Quando ho cominciato a fare la dominatrice professionista, sentivo molti
stereotipi: i clienti, in genere, sono uomini molto potenti che vogliono
scaricarsi del fardello delle responsabilità e affidare corpo e desideri a
qualcun altro per un’ora. Ho invece scoperto che i clienti sono di ogni tipo.
Uomini sì, giovani e adulti, ma operai, studenti, marinai, pensionati. E
politici. I media si sono scandalizzati quando hanno scoperto che John
Whittingdale, Segretario alla Cultura, frequentava una dominatrice. Lo ritengono
poco professionale. Secondo me è esattamente l’opposto. E’ perfettamente
comprensibile che un uomo molto potente voglia perdere il controllo e
abbandonarsi. Da me vengono persone che vogliono sfuggire alla routine. Altre
perché sono imprigionate in una forzata recita di normalità. Il mio studio è il
luogo dove tornano ad essere se stessi. Questa presa di distanza dal potere può
essere molto utile, a volte serve a reclamarlo più forte. I politici che vengono
da me differiscono l’uno dall’altro. Hanno il desiderio di sottomettersi,
servire, essere puniti, frustati, umiliati e controllati. Non possono farlo sui
siti preposti e quindi finiscono per esplorare le loro fantasie con operatrici
del sesso. I politici sono indaffarati, lavorano fino a tardi, e vogliono
soddisfare i loro impulsi sessuali senza troppo impegno. A volte, come i
marinai, l’unico contatto umano che hanno nella giornata si limita ad una
stretta di mano. Noi operatrici del sesso rispettiamo i loro orari e la loro
privacy. Ci chiamano perché garantiamo la riservatezza. Se si venisse a sapere
che vanno con le dominatrici, ci farebbero una pessima figura. Se mettessimo da
parte il moralismo e li lasciassimo essere persone normali, credo che, da
politici, ci renderebbero un servizio migliore.
Greta Sclaunich per “Sette - Corriere della Sera”
il 14 aprile 2021. Racconti hot, podcast erotici e, quando le restrizioni lo
consentono, appuntamenti dal vivo come prima del Covid (ma con qualche
accortezza in più sull’igienizzazione degli ambienti). Quello di dominatrice è
un lavoro difficile da reinventare in smart working, così Misungui Bordelle (al
secolo Marion, 32 anni, francese di Aix-les-Bains che vive tra Parigi e la
Borgogna) ha deciso di puntare sulla sua penna e sulla sua voce. E su Zoom, dove
organizza workshop per insegnare lo shibari, l’antica forma artistica di bondage
nata in Giappone. Di rado, però. «Perché ho bisogno di incontrare i partecipanti
di persona. Lo stesso per il mio lavoro di Padrona», puntualizza al telefono con
7.
Come si diventa dominatrici?
Per me il percorso è partito dal femminismo. Il
tema centrale della mia tesi all’università era capire se le donne che guardano
film porno potessero essere considerate femministe oppure no: lavorandoci ho
fatto molte ricerche e conosciuto tante persone che facevano parte di quel
mondo. Così mi sono approcciata al burlesque, al bdsm, allo shibari. Sono
passata alla pratica un po’ per caso e un po’ per curiosità: una mia amica
dominatrice aveva un cliente che le chiedeva due Padrone e un giorno mi ha
proposto di farle da assistente. Non avrei dovuto fare nulla, solo starle
accanto e osservare. È stata un’esperienza profonda e toccante, straordinaria.
Quest’uomo si è mostrato a noi in tutta la sua vulnerabilità, ci ha aperto la
sua dimensione più intima: la prova, per me, che non si può fare sesso senza
metterci testa e cuore. Questo incontro mi è piaciuto e mi ha emozionato. Ecco
perché ho continuato.
Come svolge il suo lavoro?
Ci sono molti modi di fare la dominatrice. Io mi
baso su ciò che mi chiedono i clienti, sia uomini che donne: prima di
incontrarci discutiamo tutto, da cosa loro vorrebbero a cosa io sono disposta a
fare passando per come gestire la comunicazione durante l’incontro. Perché non
sempre si è pronti a realizzare le proprie fantasie e bisogna sapere quando
interrompersi e cambiare programma. Discuterne prima serve anche a costruire una
sorta di copione. Me ne hanno chiesti di molto particolari, per esempio finti
rapimenti che richiedono un’organizzazione complicata. Allora mi devo
organizzare: mi serve un complice che mi aiuti, un’auto per trasportare il
cliente imbavagliato, una cantina dove rinchiuderlo. In genere, però, le sedute
normali le faccio a casa mia e durano circa due ore, con una pausa in mezzo per
rilassarci davanti a un the.
A casa sua? Non sarà facile tenere nascosto
questo lavoro ai suoi cari.
E perché dovrei? La mia famiglia, genitori
compresi, sa tutto e non si stupisce di niente: ho sempre messo in discussione i
tabù, fin da quando ero bambina. Gli amici, se sono diventati tali, è perché mi
accettano per come sono. Fidanzati? Sono piuttosto nota e quando conosco
qualcuno di solito già sa chi sono e cosa faccio
E adesso, con il Covid, com’è cambiato il suo
lavoro?
Quando le norme lo consentono continuo con gli
appuntamenti dal vivo, facendo però molta attenzione all’igiene: biancheria
pulita, giochi igienizzati, doccia prima e dopo l’incontro. Per il resto, ho
sperimentato un’attività nuova: scrivere e registrare racconti erotici, sia per
clienti privati che per piattaforme di podcast.
Anche i costi saranno cambiati.
Le tariffe degli appuntamenti sono sempre le
stesse: dai 250 (quando faccio solo bondage e non c’è alcun tipo di contatto
sessuale) ai 450 euro (quando invece includono alcune pratiche sessuali). I
racconti erotici per i privati, invece, costano circa 150 euro. Le piattaforme
di podcast mi offrono dai 50 ai 100 euro per la scrittura delle puntate e altri
200 per la registrazione.
C’è una differenza fra i racconti che scrive
per i privati e quelli per le piattaforme di podcast?
Quando scrivo per un privato mi baso sulle sue
richieste come farei per un incontro dal vivo e, a volte, inserisco anche
elementi tratti dalla mia esperienza personale. Per i podcast, invece, cerco di
unire l’eros con la consapevolezza del corpo. Tante donne, ancora oggi, non
conoscono il proprio corpo: per questo penso che nella battaglia per la parità
il sesso abbia un ruolo centrale. Anch’io, quando ho cominciato, mi sentivo
fuori posto nel ruolo di dominatrice. Poi ho capito che il mio corpo mi
appartiene e, come donna, ho il diritto di farne ciò che voglio.
Però non è così per tutte.
La mia è una situazione particolare: ho scelto io,
liberamente, di fare questo lavoro. In generale, però, osservo che nella nostra
società molto spesso il sesso tra uomo e donna viene usato come merce di
scambio. Quando fai un lavoro come il mio almeno il lato economico è chiaro e
quindi è possibile avere il controllo della situazione. Sono io a decidere il
mio prezzo e quando dire sì e quando no.
Tutto gira intorno al tema del femminismo,
insomma. Mi pare di capire che per il suo lavoro lo considera cruciale.
Prima del Covid organizzavo una decina di corsi
diversi, aperti a tutti: il fatto che il più frequentato fosse quello
sull’anatomia e la salute delle parti intime femminili la dice lunga. Il mio
impegno comunque non era solo organizzarli ma anche renderli accessibili a
tutti. Perciò non avevo fissato un prezzo, chi partecipava lasciava ciò che
poteva. Ho ricevuto disegni, candele, saponi…a casa mia ho una mensola dove li
raccolgo tutti. A volte, anche cibo fatto in casa. Purtroppo ora, a causa del
Covid, ho dovuto interromperli.
Ha già dei progetti per quando l’emergenza
Covid sarà finita?
Quelli non sono cambianti, anzi. Già prima della
pandemia avevo comprato una vecchia fattoria in Borgogna: vorrei diventasse un
luogo bello e accogliente per riunire un collettivo artistico. È il mio progetto
a lungo termine. Con il Bdsm e con il sesso non c’entra niente, ma è parte della
mia scelta di vivere in modo libero. Frustini, latex, tacchi alti? Quando
immagino il mio futuro, mi vedo con un mazzo di carote in mano e una capretta al
fianco mentre, a piedi nudi, sistemo l’orto.
·
La
Rivoluzione Sessuale.
Francesco Borgonovo per “La Verità” il 7 agosto
2021. Che la rivoluzione sessuale avrebbe in breve tempo rivelato il suo oscuro
doppio se n'era già accorto Julius Evola alla fine degli anni Cinquanta. La
pretesa di abbattere il senso del pudore, spiegava, avrebbe riportato l'uomo a
«considerarsi come nulla più che una delle tante specie naturali», e la potenza,
la bellezza e la sensualità del corpo nudo sarebbero state sacrificate
sull'altare di una medica freddezza, capace di annichilire persino «il potere
elementare del sesso». Scriveva Evola che «l'esibizionismo impudico delle grandi
spiagge estive è, in effetti, la migliore delle scuole di castità []. Lungo
codesta linea, più che maggiore corruzione, può attendersi dunque il formarsi di
uno sguardo dal quale, alla fine, una giovane donna nuda può essere osservata
come si osserva un pesce o un gatto siamese, con naturalezza, curiosità e
estetico disinteresse». A questo genere di sguardo metallico e gelido si è
sempre sottratto Helmut Newton (1920-2004), uno dei più grandi cantori del corpo
che abbiano mai praticato l'arte della fotografia. E infatti, per quasi tutta la
sua carriera, egli fu avversato dal puritanesimo femminista, dalla sessuofobia
dei progressisti che, prima, hanno abbattuto il pudore e poi l'hanno sostituito
con il moralismo. «C'è una categoria di donne che mi irrita profondamente, è la
razza delle donne dette "liberate", le pseudo militanti del Women's lib», disse
una volta il fotografo, che fu accusato dai movimenti femministi di essere un
razzista, un «alto prelato della pornografia», perfino un fascista. Tutto questo
perché? Perché faceva esplodere la sensualità, e ritraeva donne forti, eroiche,
piene di quella «fatalità primordiale» che tanto entusiasmava Valentine de
Saint-Point, autrice del Manifesto della donna futurista. Newton si prese del
«misogino» da Susan Sontag, nientemeno. Si disse che le sue erano «donne
oggetto». Ma in realtà, come ha scritto Michel Guerrin, «con Newton la donna
raramente è una vittima. Anche se nuda, è lei che decide, non perde mai la
propria dignità. Sta dritta, sorride raramente, quasi mai. Percepiamo anche che
porta avanti una storia. Non è più una modella». Gli assalti che Newton subì per
decenni non erano che l'antipasto della burocratizzazione del sesso giunta
all'apice negli ultimi tempi. Dalle allucinanti scomposizioni tecnologiche del
gender alla psicosi sulle molestie, siamo ormai giunti all'approdo che Evola
aveva previsto. Ogni tanto, però, spuntano qua e là piccoli fuochi reattivi. Uno
di questi lo ha acceso, con sorprendente originalità, una donna di una certa
fama che di nome fa Claudia Schiffer. Fu amica e musa di Newton, e ora lo
celebra in una lunga intervista concessa alla rivista francese Marianne e,
soprattutto in una grande mostra intitolata Captivate! dedicata alla fotografia
di moda degli anni Novanta nel Kunstpalast di Düsseldorf. Curiosi rivolgimenti
della storia. Un tempo si pensava che le top model rappresentassero l'apice
della commercializzazione del corpo, e che con i loro tratti tendenti
all'anoressia ne avrebbero infine eliminato il potenziale erotico. Oggi,
infatti, le valchirie da passerella sono state sostituite dalle modelle che
celebrano la «diversità» e l'inclusione. Eppure, a ben vedere, tutta questa
ossessione per le minoranze e i corpi (apparentemente) «imperfetti» non ha
affatto contribuito al ritorno di una fisicità più viva e vitale. Anzi, ha solo
creato nuovi segmenti di mercato, ha completato la politicizzazione e
commercializzazione dei corpi e, in fondo, ha contribuito pure a spegnerne la
forza erotica. In questo quadro, la Schiffer appare come una orgogliosa
avversaria del politicamente corretto quando prende le difese di Newton in
opposizione alla sessuofobia dominante. Il giornalista di Marianne, a un certo
punto dell'intervista, le fa notare che «nella nostra epoca divenuta
impermeabile alla leggerezza», il già mal visto Helmut «non avrebbe chance
d'essere esposto». L'osservazione non è inopportuna, visto che oggi si arriva a
censurare perfino le statue e si bandiscono opere letterarie. Ed ecco la
risposta orgogliosa della Schiffer: «La mostra che sto preparando avrebbe tutto
un altro senso senza l'inclusione del lavoro di Helmut». E tanti saluti alla
censura. Non solo: la bionda Claudia ci tiene a far capire da che parte stia:
«Le fotografie di Helmut mostrano il potere femminile attraverso lo spirito e il
corpo»; «le sue foto sono belle, eleganti, uniche». Chissà, forse davvero ci
voleva una top model per riportare in scena la carica dirompente del corpo. Alla
faccia del sessismo.
Dagotraduzione dal Daily Mail il 16 giugno 2021.
Se c’è una cosa che sappiamo per certo sulla storia dell’umanità, è che fare
sesso non è una cosa di oggi. Nelle società di tutto il mondo, il romanticismo
tra individui è stato a lungo oggetto di interesse sia per le autorità religiose
che per quelle statali. L'esperta Eleanor Janega ha raccontato che i nostri
antenati del Medioevo «non fossero affatto interessati» alla visione della
chiesa medievale secondo cui l'unico tipo di sesso accettabile era quello che
produceva bambini. Parlando con il collega storico Cat Jarman nel podcast
“History Hit's Gone Medieval”, la dottoressa Janega ha invece spiegato che nel
periodo medievale, il sesso «non finalizzato alla procreazione», per esempio i
preliminari, era considerato «la roba buona». Janega è autrice del nuovo libro
“Il Medioevo: una storia grafica”, che è stato pubblicato all'inizio di questo
mese. Quando pensiamo alla sessualità nel periodo medievale, dobbiamo immaginare
le pressioni della Chiesa nel convincere le persone a considerare il sesso
procreativo l'unico tipo di sesso che valeva la pena sperimentare. «Quello che
penso sia abbastanza divertente è che le persone medievali non sembrano essere
affatto interessate a questa visione. Vogliono invece molto sesso non
procreativo, sembrano considerarlo migliore». Secondo Janega le persone che
vivono oggi hanno «interiorizzato» meglio quella che lei chiama «la visione
della chiesa sul sesso», che è «reale» solo quando si parla di «pene nella
vagina». «Le persone medievali sembravano davvero interessate al tipo di sesso
che chiamiamo preliminari», ha detto. «La chiesa si è sforzata molto, ma
l’impressione è che abbiano fatto un lavoro migliore con noi che con i
medievali». La dottoressa Janega ha detto che allora si credeva necessario che
sia uomo che donna raggiunsero l’orgasmo per concepire un bambino, ma le coppie
erano invitate a non andare «troppo oltre». Ha aggiunto che l'influente teologo
Tommaso d'Aquino si scagliava nei suoi scritti contro ciò che chiamava «baci
lascivi». All’epoca la chiesa chiedeva di «non eccitarsi troppo, non fare
troppo, ma la giusta quantità, farla finita e avere il bambino». Oltre a imporre
il sesso solo ai fini della procreazione, la Chiesa sosteneva anche che il sesso
andava evitato di domenica, giorno del Signore. Era proibito anche il giovedì e
il venerdì, perché dovevano essere giorni in cui ci si preparava alla Santa
Comunione della domenica. E durante la Quaresima, che poteva durare fino a 62
giorni, ci si aspettava che la gente comune fosse astinente. Il dottor Janega ha
spiegato che i giocattoli sessuali erano popolari anche nel periodo medievale.
«Sappiamo ad esempio che esistevano molti dildo perché abbiamo le ricevute per
il loro acquisto: i lavoratori della pelle facevano dildo davvero intricati per
le persone. E tendiamo a pensare che siano stati usati in quelle che chiameremmo
“circostanze lesbo” per la maggior parte del tempo. Sappiamo che potevano essere
venduti con finimenti e cose del genere». I nostri antenati medievali non
vedevano la sessualità nello stesso modo in cui la vediamo noi: «Per loro non
esistevano cose come l'omosessualità o l'eterosessualità, o eri un sodomita o
non lo eri. La sodomia comprendeva tutti i rapporti sessuali che non portavano a
una possibile gravidanza».
Dall'articolo di Kathy
Benjamin per cracked.com il 13 giugno 2021. Si parla spesso dei grandi Casanova
della storia, personaggi diventati famosi solo per quanto hanno scopato in giro.
Eppure ci sono molte donne che hanno fatto di più e meglio dei Don Giovanni. La
differenza è che le storie di tizi impegnati a fare sesso tutto il tempo sono di
solito vanterie, mentre quelle di donne che hanno avuto rapporti sessuali giorno
e notte sono quelle tragiche che fanno vincere un Oscar ad Anne Hathaway. Ma non
è sempre una questione di quantità. Ecco qui alcune donne della storia la cui
creatività sessuale avrebbe fatto impazzire qualsiasi uomo.
5. La Contessa di Castiglione
fu così brava a letto da unire un Paese. Virginia Oldoini nacque da nobili
minori in Toscana nel 1837. Quando aveva diciassette anni, la diedero in sposa a
un uomo di dodici anni più grande di lei. Un anno dopo, suo cugino decise che
sarebbe stato molto più conveniente per la sua carriera e il Paese se Virginia
fosse stata disposta a fare sesso con qualcun altro. Quel qualcuno era Napoleone
III. Infatti, in quel momento, quella che oggi noi chiamiamo Italia, non era che
un raggruppamento di piccoli stati e staterelli, e il cugino di Virginia faceva
parte del gruppo che voleva unificarla. Dopo avere dato un’occhiata a quella
seducente e giovane parente stretta, realizzò che il piano migliore era di
convincerla a tradire suo marito con Napoleone III sperando che un po’ di
conversazioni da letto potessero aiutare la causa. Questo perché nel 19 °secolo,
l'Europa era praticamente una specie di universo alla “Trono di Spade”, completa
di nano e relazioni familiari raccapriccianti. Virginia riuscì a diventare
l'amante dell'imperatore per oltre un anno, e poco dopo la fine della relazione,
Napoleone III inviò delle truppe per unire la penisola. Gli storici non sono
d'accordo su quanto influente sia stato l’intervento della contessa in questa
decisione, dal momento che erano in corso, in quello stesso periodo, varie
battaglie, trattati e intrighi; ma lei si attribuì praticamente tutti i meriti e
si scocciò che tutti gli altri non lo fecero. Anche se la contessa fu meno
influente con le sue pudenda di quello che abbia voluto credere, gli uomini
trovavano piacevole averla attorno ed erano disposti a pagare per il piacere. La
contessa ha continuato a tradire il marito e ha guadagnato bene. Alla fine, si
sparse la voce che arrivò all’incredibilmente ricco, ma notoriamente avaro Lord
Hertford, che le fece la prima proposta indecente della storia: 1 milione di
franchi per una notte con lei.
4. Peggy Guggenheim, l’arte
unita al sesso. Potreste aver visitato uno dei vari musei Guggenheim in giro per
il mondo, ma quello che la guida non vi dirà è che una dei mecenati ha avuto una
vita sessuale folle. Peggy si sposò due volte ed ebbe due figli, ma è solo la
punta dell’iceberg. Quando una volta le chiesero quanti mariti avesse avuto,
rispose: "Vuol dire i miei o quelli di altre?" Le sue biografie raccontano che
ebbe circa 1.000 amanti. La sua autobiografia ‘s’intitola “Memoirs of an Art
Lover”, eppure non parla di arte fino a pagina 110 su un totale di 200 pagine,
certamente perché aveva molto da dire sugli uomini e il sesso. Le piaceva,
soprattutto, darsi da fare con personaggi famosi, tra cui la maggior parte degli
artisti moderni che scoprì e il drammaturgo Samuel Beckett. Quando non riusciva
a portarsi gli uomini a letto seducendoli, cercava di usare il suo denaro. Anche
quando invecchiò, aveva ancora voglia di scoparsi bei ragazzi: a settant’anni ci
provava con quelli di venti. Purtroppo per Peggy, non era bella come i dipinti
della sua collezione. Jackson Pollock disse che avrebbe dovuto mettere un
asciugamano sopra la sua testa per scoparla, ma non è che stiamo parlando di sto
gran fico, quindi chi se ne frega della sua opinione. In effetti, aveva un
enorme naso a patata e i commentatori le hanno attribuito una bassa autostima
sia a causa del suo aspetto fisico, che per avere perso il padre in giovane età
(era sul Titanic) come giustificazione del fatto che la desse così tanto
allegramente in giro. Perché a quanto pare, le donne vogliono fare molto sesso
solo se non stanno bene di testa.
3. La regina Nzinga aveva un
harem di uomini costretti a combattere fino alla morte in suo nome. Nzinga Di
Ndongo E Matamba è nata in quella che oggi è l'Angola, nel 1583. Ha trascorso
tutta la sua vita a dare calci in culo a chi non le andava a genio e a fare
sesso. Quando il padre morì nel 1618, i portoghesi commerciavano in schiavi in
tutta l'Africa. Il fratello di Nzinga divenne sovrano, ma concesse agli invasori
tutto quello che volevano. Quando i portoghesi iniziarono a strappare le persone
dalle loro case per inviarle a lavorare in Brasile, la tribù Mbundu si rivolse a
Nzinga per essere salvata. Così, lei fece quello che una signora tosta avrebbe
dovuto fare: uccise suo fratello e assunse il potere. Poi iniziò a combattere.
Una cosa apparentemente folle, dato che il Portogallo era una delle più grandi
potenze mondiali, ma in effetti Nzinga guidò le sue armate in guerriglia e
mantenne il potere per quarant’anni. Con tutte queste battaglie, non doveva
avere molto tempo a disposizione per trovarsi degli uomini. Ovviò a questo
problema mettendo su un harem gigantesco. Sì, anche le donne possono avere
centinaia di schiavi per scopi sessuali. In passato, intendo. Non andate a
controllare nel mio seminterrato. E doveva essere anche un’appassionata di
fetish, perché li faceva vestire tutti da donna. La leggenda vuole che riuscì a
coniugare le sue due cose preferite. E 'difficile scegliere ogni sera con quale
bel ragazzo fare sesso, così escogitò una soluzione infallibile: due uomini
avrebbero combattere fino alla morte e chi avesse vinto avrebbe potuto dormire
con lei. Poi, la mattina dopo sarebbe, comunque, stato ucciso. Nessuna pressione
circa la propria performance sessuale, in questo modo. L’età, tuttavia, ha la
meglio su tutti noi, ad un certo punto della vita. A settantacinque anni, Nzinga
decise di non avere più bisogno dell'harem e lo sciolse, sposandosi poi con uno
dei suoi giovani schiavi sessuali. Ha vissuto altri sette anni, presumibilmente
come una ‘cougar’ sino alla fine.
2. Le mogli di Filippo V di
Spagna scopavano per Dio e per il Paese. Se sei il capo di una nazione, uno dei
vantaggi è che nessuno può dirti di smettere di scopare in giro. Questo è il
motivo per cui quasi tutti i re della storia hanno fatto tonnellate di sesso al
di fuori del matrimonio. In realtà, così pochi re erano fedeli alle loro mogli,
che è degno di nota il fatto che uno di questi lo fosse. Re Filippo V di Spagna
era uno di questi monarchi. Non è che a Filippo non piacesse il sesso. Lo
adorava. Voleva farlo tutto il tempo e dichiarò che si deprimeva se passava
troppo tempo dall’ultimo rapporto. Tuttavia, Filippo era un fervente cattolico e
crebbe nei precetti della Chiesa, interiorizzando le idee sul sesso sconveniente
fuori dal matrimonio. Prese tutto molto seriamente, tanto che persino il suo
pene non riuscì ad avere la meglio sul suo cervello. Sua moglie, quindi, doveva
essere disponibile al coito ogni volta che lui ne aveva voglia. Filippo voleva
avere la moglie sempre sotto mano, tanto che dormivano nello stesso letto in un
periodo della storia in cui era considerato strano e che lei frequentò tutti i
suoi incontri con i consiglieri durante il giorno, nel caso in cui lui volesse
farsi una sveltina all’ora di pranzo. Filippo si sposò due volte, nel 1701 con
Maria Luisa di Savoia e poi, nel 1714, con Elisabetta Farnese. Entrambe queste
donne furono enormemente influenti nella gestione del Paese, per un solo motivo:
tenevano, letteralmente, il marito per le palle. Maria era sposata con lui
durante la guerra di successione spagnola. Quando il marito parlava
dell’argomento, lei esprimeva la sua opinione su quello che lui avrebbe dovuto
fare e se non era d'accordo, allora il sesso era fuori questione. Nel giro di
poche ore, di solito, si faceva a modo suo. Non c'era un attimo di tregua per
queste povere donne. Anche sul letto di morte, Maria dovette rendersi
disponibile tre volte al giorno per fare felice il marito. Appena dieci mesi
dopo, Filippo sposò Elisabetta, perché la frustrazione sessuale provata in meno
di un anno di solitudine era così forte che egli riusciva a malapena a
concentrarsi sulla gestione del Paese.
1. Talullah Bankhead non
poteva essere fermata. Ho accennato in precedenza a Tallulah come una delle
molte, molte amanti di Leslie Hutchinson, l’uomo col pene più grosso e famoso
degli anni '30, ma lei aveva un curriculum sessuale che sminuiva quello di lui,
e il vostro e, probabilmente, quello di molte generazioni future. Tallulah
nacque nel 1902 e iniziò a recitare a quindici anni. Già a quel tempo, andava a
letto con varie persone. E non le interessavano solo gli uomini. In principio,
infatti, iniziò fare sesso nel convento per sole ragazze dove studiava, perché
mettere un sacco di adolescenti in una stanza durante la notte dopo aver
ripetuto loro per tutto il giorno che il sesso è sbagliato, ha sempre prodotto
buoni risultati. Una volta che divenne famosa, però, le sue relazioni lesbiche
diventarono più A-list. In un periodo in cui le relazioni sia interrazziali che
gay erano punibili con il carcere, Tallulah ebbe legami con donne come Greta
Garbo, Marlene Dietrich, Hattie McDaniel e Billie Holiday. Tuttavia, a Tallulah
piacevano gli uomini. Una volta, in un'intervista esclusiva a una rivista si
lamentò del fatto che non avesse avuto rapporti con nessuno da sei mesi,
dicendo: "Sei mesi sono un lungo, lungo periodo. Voglio un uomo!" (Non si sa se
poi saltò addosso al giornalista.) Tallulah non stava mai troppo a lungo senza
fare sesso, però, e non deve essere stata molto attenta al riguardo, dato che a
trent’anni ebbe bisogno di un isterectomia causata da malattie sessualmente
trasmissibili. Mentre lasciava l'ospedale, disse al suo dottore che non aveva
imparato nulla dall'esperienza. Mantenne il suo ritmo abituale e nel 1948
affermò orgogliosamente che "non era colpita dal rapporto Kinsey" e tutto ciò
che vi era scritto era "antiquato" per quanto la riguardava. Riuscì a rimanere
sposata per quattro anni a un attore minore di nome John Emery. Tallulah basò
questa importante decisione riguardante la sua vita sentimentale sul fatto che
lui era estremamente ben dotato. Ma, dichiarò, "L'arma può essere anche di
proporzioni ammirevoli, ma se il tiro è debole…", e lo mollò. Tallulah è morta a
sessantasei anni con un tempismo perfetto, dato che sembrava essersi annoiata
del suo hobby preferito, tanto da dichiarare: "Il sesso? Mi annoia. Di cosa si
tratta, dopotutto? Se si va verso le parti basse di una donna, ti fa male il
collo. Se si va giù, nelle parti basse di un uomo, ti fa male la mascella. E
scopare mi provoca solo la claustrofobia ".
Dagotraduzione dal DailyMail
il 12 giugno 2021. È in uscita per l’editore inglese Hodder & Stoughton Hardback
il libro “Sex: Lessons from History” (Sesso: lezioni dalla Storia) in cui Fern
Riddell, storica, cerca di scoprire «le vite sessuali dei nostri antenati»
attraverso i grandi temi sessuali: dai flirt, alle relazioni lesbiche alla
masturbazione ai giocattoli sessuali. «Questo libro è costruito sui registri
pubblici e privati di coloro che hanno vissuto e amato prima di noi. È un
tentativo di reimpostare la narrativa, di cambiare la nostra memoria culturale
che ritrae il sesso come qualcosa di cui i nostri antenati si vergognavano, per
dimostrare che in realtà il sesso è sempre stato in prima linea nelle nostre
vite», scrive Riddell. Ecco alcuni dei casi raccontati nel libro.
Sposata con una donna. Nel
novembre del 1746 Mary Hamilton, anche nota come Georges o Charles Hamilton, fu
processata per essersi finta uomo e aver contratto matrimonio con una donna,
Mary White. Hamilton era nata nel Somerset, ma la famiglia si trasferì in
Scozia. A 14 anni prese in prestito gli abiti del fratello e, travestita da
maschio, si trasferì nel Northumberland dove si fece assumere a servizio di un
medico. Secondo alcuni rapporti dell’epoca, Hamilton, fingendosi uomo, sposò 14
donne. Mary Price si accorse dell’inganno solo 3 mesi dopo il matrimonio. «Le
pratiche ingannevoli si basavano probabilmente sull’uso di giocattoli sessuali e
vibratori che imitassero l’atto di penetrazione» racconta Riddell. La storia
fece scalpore in tutto il paese e ispirò un romanzo.
Le monache lesbiche. Nel primo
Medioevo la comunità clericale temeva che tenendo chiuse insieme le monache, si
sarebbero abbandonate a «lussuria carnale, atti lesbici e uso di giocattoli
sessuali per la penetrazione». Suor Benedetta Carlini, badessa del convento
della Madre di Dio, in Toscana, all’inizio del 1600 costrinse un’altra suora ad
atti sessuali sostenendo di essere posseduta da uno spirito divino maschile.
«Questa Suor Benedetta, poi, per due anni continuativi, almeno tre volte la
settimana, la sera dopo essersi spogliata ed essere andata a letto aspettava che
la sua compagna si spogliasse, e fingendo di aver bisogno di lei, chiamava.
«Quando arrivava Bartolomea [l'altra suora], Benedetta la prendeva per un
braccio e la gettava a forza sul letto. Abbracciandola, l'avrebbe messa sotto di
sé e baciandola da uomo, le avrebbe rivolto parole d'amore». Le parole sono
state tratte da una testimonianza resa da Bartolomea durante un'indagine sulle
false affermazioni religiose di Benedetta. Nel frattempo, nel XII secolo, una
monaca bavarese di Tegernsee scrisse un versetto appassionato a un'altra
sorella. Il breve verso indica esplicitamente una relazione fisica e sessuale
tra le due donne. Si legge: «Sei solo tu che ho scelto per il mio cuore... Ti
amo sopra ogni altra cosa, tu solo sei il mio amore e il mio desiderio... Quando
ricordo i baci che mi hai dato, e come con tenere parole mi hai accarezzato i
piccoli seni, voglio morire, perché non posso vederti».
Preservativi al primo sexy
shop. Teresia Constantia Phillips (1709-1765) era una bigama benestante e
figlioccia della duchessa di Bolton che gestiva The Green Canister a Covent
Garden, dove vendeva contraccettivi e ausili sessuali che all'epoca non venivano
venduti pubblicamente. La sua specialità erano i "Bandruches Superfines",
preservativi di budello di pecora o di capra fatti a mano e «modellati su stampi
di vetro, lunghi otto pollici (20 centimetri), e decapati o profumati». «Quelli
della migliore qualità erano "assicurati al collo con un nastro, che poteva
essere nei colori del reggimento"; mentre per il gentiluomo deciso a evitare a
tutti i costi o la gravidanza o la malattia, il suo “Superfine Double” era
costituito da "due estremità cieche dell’intestino della pecora, sovrapposte e
gommate"». Teresia, conosciuta come 'Mrs Phillips', è ricordata per le sue
memorie, An Apology for the Conduct of Mrs TC Phillips, che furono pubblicate in
18 parti diverse nel 1748–9 e scandalizzarono l'alta società. La cortigiana
sposò Henry Muilman, un mercante olandese, nel 1724. Lasciò Londra per la
Giamaica nel 1751 sulla scia della pubblicazione delle sue memorie. La signora
Phillips è morta in Giamaica.
Le case di Molly. Nel 18° e
19° secolo, i luoghi di incontro per uomini omosessuali erano conosciuti come
Molly House, dal termine popolare per gli uomini gay, Miss Molly, o
semplicemente "Molly". «Questi club hanno offerto ai loro membri l'opportunità
di incontrarsi, amare ed essere se stessi in un ambiente apparentemente fuori
dalla portata della legge», scrive Riddell. Fino al 1861, il sesso penetrativo
tra uomini era punibile con la morte. All'inizio del XVIII secolo c'erano più di
40 case di Molly sparse per Londra. Alcuni degli uomini di questi club si
vestivano da donne e assumevano nomi femminili come "Miss Fanny Knight" o
Princess Seraphina. Riddell scrive: «A Sukey Bevells, il club era rinomato per
le sue grandi stravaganze, "Gli steward sono Miss Fanny Knight e zia England; e
la graziosa signora Anne Page officia come Clark». Sebbene inizialmente visitate
da uomini della classe operaia, le case dei Molly finirono per attirare anche i
benestanti.
Istruzioni per un orgasmo. Nel
capitolo dedicato all'orgasmo, Riddell riporta l’estratto di una pubblicazione
del XVIII secolo che offre consigli su come sedurre una donna. «Pubblicato in
inglese per la prima volta nel 1709, An Apology for a Latin Verse in
Commendation of Mr Marten's Gonosologium Novum, conteneva una traduzione inglese
del presunto lavoro del chirurgo del sedicesimo secolo, Ambroise Paré». Ecco
l’estratto: «Quando un marito entra nella camera di sua moglie, deve
intrattenerla con ogni tipo di distrazione, comportamento sfrenato e lusinghe;
ma se percepisce che è lenta e più fredda, deve accarezzarla, abbracciarla e
solleticarla, e non irromperà bruscamente nel Campo della Natura, ma anzi si
insinuerà a poco a poco, mescolando baci più sfrenati a parole e discorsi
lascivi, maneggiando le sue parti segrete e i suoi scavi, affinché possa
prendere fuoco e infiammarsi...».
LA RECENSIONE. COSÌ È NATA LA RIVOLUZIONE
SESSUALE. Domenico Bonvegna su ilsudonline.it il 27
marzo 2021. «Nessuno finora ha scritto una storia della rivoluzione
sessuale». Lo scrive Lucetta Scaraffia nel suo «Storia della liberazione
sessuale. Il corpo delle donne tra eros e pudore», Marsilio Editori (2019). «Il
motivo si può ben capire: si tratta di scrivere la storia di una forma di
pensiero che ha causato una trasformazione radicale nei comportamenti, ma che è
stata fatta passare come inevitabile. Quasi fosse un momento obbligato del
progresso, dell’affermazione della libertà individuale, un’altra tappa sulla
strada che porta alla felicità». In questo studio Scaraffia individua il
passaggio epocale tra il declino del pudore e il trionfo del corpo che diventa
protagonista nella società. E’ il tema che occupa i primi capitoli (Liberi dal
pudore). Si parte dall’immagine dei figli dei fiori di Woodstock, il grande
festival del 1969, ormai è diventato il simbolo decisivo del cambiamento sia nel
percepire il corpo, che nel comportamento sessuale. Un avvenimento che richiama
al mito dell’innocenza ritrovata, del paradiso perduto. «I partecipanti alla
manifestazione volevano credere – e soprattutto far credere – di avere
ricostituito il mondo puro e libero da violenza e aggressività quale doveva
essere stato l’eden, dove la felicità sarebbe stata garantita a tutti grazie
alla libertà da ogni proibizione sessuale». La novità di Woodstock non è tanto
la nudità, ma il fatto che i rapporti sessuali avvenissero sotto gli occhi di
tutti: sostanzialmente assenza di pudore e liberazione di quelle regole che
avevano costituito il cuore del pudore dei secoli passati, almeno per quanto
riguarda la cultura occidentale di matrice cristiana. Infatti, la rivoluzione
sessuale, fin dagli inizi, è una pretesa di affrancamento dal senso del
pudore, «ritenuto un condizionamento negativo della cultura borghese che blocca
la spontaneità degli istinti, e quindi impedisce la felicità individuale,
creando nella psiche degli esseri umani nevrosi e aggressività». Pertanto per i
fautori della rivoluzione sessuale, «il tradizionale senso del pudore incentrato
sulla sessualità – inculcato nei bambini fin dall’infanzia – viene considerato
un mezzo subdolo per garantire la repressione sessuale». La fine del pudore, ha
soprattutto interessato lo svelamento progressivo del corpo femminile. Ma il
risultato per la Scaraffia è stato contraddittorio: «da un lato, le donne si
sono liberate dalle costrizioni e pregiudizi, dall’altro, il corpo femminile
svestito è diventato il più frequente oggetto di marketing pubblicitario». Come
del resto appare con la rivoluzione sessuale, soprattutto le donne sembrano
perdere da una parte quello che conquistano dall’altra. Tutto questo
cambiamento, che cosa ha comportato? Ogni ostacolo alle immagini ritenute
offensive al senso del pudore è considerato non solo sbagliato, ma inutile. Lo
vediamo nel cinema, in televisione, in internet, che ormai trasmette a chiunque,
qualsiasi tipo di pornografia. Siamo giunti al punto che «la mancanza di pudore,
equiparata a coraggiosa e moderna apertura a una vita libera, fa sì che oggi
addirittura ci siano persone che diffondono immagini pornografiche di se stesse,
salvo poi pentirsene, soprattutto se giovani donne». A questo proposito la
Scaraffia commentando le dichiarazioni di Saviano, favorevole alla
normalizzazione di certa trasgressione, può scrivere che oggi ormai il concetto
di pudore, il suo significato è stato completamente impoverito. «Secoli di
riflessioni teologiche e antropologiche nonché filosofiche sul concetto di
pudore sono infatti stati dimenticati a favore di un’interpretazione, che si
vorrebbe ‘liberatoria’ da un concetto che ha radici antichissime e così profonde
da definire la stessa natura umana». A questo punto la scrittrice torinese si
avvia a trattare come è stato considerato il pudore nella storia dell’umanità, a
partire dalla nudità di Adamo ed Eva. Passando da come veniva visto il pudore
nell’antichità, nell’antica Grecia, fino alla Bibbia ebraica. Per arrivare al
Novecento e qui la Scaraffia dedica un capitolo al pudore femminile nella
tradizione islamica. La questione del velo, che rappresenta il pudore per
eccellenza, «protegge quello delle donne, impedendo al tempo stesso agli uomini
di trasgredire il loro, mostrando l’eccitazione sessuale». Scaraffia fa
riferimento anche al mondo cattolico come le donne fino a un certo periodo erano
velate, coprivano i capelli. Comunque a dare un’espressione negativa del pudore,
almeno in Occidente ci ha pensato la psicanalisi, disciplina portante dei
profeti della rivoluzione sessuale. Tuttavia come la morale anche il pudore si
oppongono alla soddisfazione sessuale, entrambi creano nevrosi e perversioni,
secondo i guru della rivoluzione sessuale.
«Disgusto, morale, pudore costituiscono una triade che impedisce il piacere:
l’energia sessuale, costretta, può quindi dare origine a nevrosi,
perversioni[…]». Forse la parte più interessante dello studio, è la seconda (Una
guerra alla libertà). Qui si affronta la Rivoluzione Sessuale con tutti i suoi
aspetti aggiuntivi, l’eugenetica, la psicanalisi, il “falso antropologico” che
promuove il libero amore. Sono gli aspetti pseudoscientifici che l’autrice
confuta. La rivoluzione sessuale si incontra presto con quella femminista,
entrambi condividono il problema del «controllo delle nascite: solo la
possibilità di controllare la fertilità, infatti, può permettere sia la
liberazione sessuale che l’emancipazione delle donne». L’alleanza tra i due
movimenti risale alla fine del XIX secolo, nell’ambiente scientifico che
sostiene l’eugenetica. Infatti la contraccezione viene accettata nella
prospettiva di avere un mondo migliore, di persone sane. Ancora non si ha il
coraggio di giustificarla come un desiderio individuale, di fatto egoistico. Il
controllo delle nascite, nel secondo dopoguerra, prende un nome più scientifico
e più positivo: pianificazione familiare. Sostanzialmente, la motivazione più
gettonata per convincere le masse ad adottarla è ancora di tipo utopico: «l’idea
che i bambini desiderati e voluti diventeranno esseri umani migliori, più sani e
più intelligenti, ma anche più equilibrati e più felici di quelli nati per
‘caso’». La svolta per i sostenitori del controllo delle nascite si è avuto con
la pillola, scoperta dal dottor Pincus, che apre nuove e inedite prospettive per
le teorie della liberazione sessuale. Scaraffia, fa nomi e cognomi di chi ha
finanziato le ricerche e poi la diffusione della pillola. E’ tutto un mondo
americano impregnato di teorie utopiche intorno al controllo delle nascite.
Margaret Sanger, Havelock Ellis, George Drysdale, e poi tante associazioni
destinate a diffondere la contraccezione, e poi l’aborto, fino alla Planned
Parenthood Federation of America. Le fondazioni Rockefeller e Ford. Tutti questi
pseudo scienziati, sono legati alla prospettiva eugenistica. Scaraffia non
nasconde che questi signori sono legati all’eugenismo della Germania nazista.
Con la pillola, le donne separano la sessualità dall’amore, dalla famiglia.
Adesso sono sole a scegliere se concepire un figlio. La rivoluzione
sessuale «non solo era destinata a separare definitivamente la sessualità dalla
procreazione, ma anche dal matrimonio e dall’amore, per legittimarla come
semplice ricerca di piacere individuale». In questo modo la sessualità perde la
sua dimensione sociale e pubblica, per divenire un’attività privata e
insindacabile, da questo momento ognuno rivendica il diritto di fare le scelte
che preferisce. La rivoluzione sessuale e la contraccezione a partire dagli anni
sessanta sono le questioni per eccellenza, che si scontrano subito con la
Chiesa, che risponde con l’enciclica Humanae vitae, di san Paolo VI. Tuttavia
questo mondo della rivoluzione sessuale ha partorito anche la sessualità LGBT,
che «a guarda bene sono solo i gay a realizzare, senza supporti biotecnologici,
l’obiettivo desiderato». Infatti nel sesso senza riproduzione si colloca la
sessualità omosessuale. A fronte di questo paradiso di libertà sessuale, arriva
il serpente dell’Aids che rovina tutto. E chi ricorda che per vincere il
contagio di questa malattia si può fare soltanto con la fedeltà di coppia o con
l’astinenza. Chi lo dice o lo scrive viene tacciato di conservatorismo o di
bigottismo. L’essere umano non è fatto per la promiscuità. La Scaraffia affronta
anche la squallida questione del sesso con i minori, che fa parte della
rivoluzione sessuale, delle “conquiste” del sessantotto. Ricordate lo
slogan “vietato vietare”, si pensava che la rivoluzione sessuale dovesse abolire
ogni concetto di perversione, fino ad arrivare alla liberazione della pedofilia.
Altro tema legato alla rivoluzione sessuale, è quello dell’esplosione
della pornografia. Attenzione la Scaraffia ricorda che i guru della rivoluzione
sessuale avevano garantito che la liberalizzazione dei comportamenti erotici
avrebbe comportato la fine della pornografia, considerata solo un effetto della
repressione. Nessuno aveva previsto il suo trionfale aumento. Interessante il
capitolo (Alle origini della rivoluzione), forse quello per cui vale la pena
leggere il pamphlet della storica, giornalista e professoressa torinese. E’
importante perchè Scaraffia sostiene e documenta come la rivoluzione sessuale è
nata negli ambienti dei rigidi scienziati ottocenteschi dell’eugenismo.
Questi «pensavano di poter migliorare l’umanità impedendo la nascita degli
esseri umani deboli e malati, e favorendo invece quella dei sani, belli e
intelligenti». In pratica significava proibire alle persone sospettate di
trasmettere malattie o condizioni fisiche considerate inadeguate al
miglioramento della razza. In molti paesi si sterilizzarono uomini e soprattutto
donne, considerate portatori di malattie. Il primo scienziato ad affrontare la
questione fu un medico caro agli eugenisti, lo psichiatra austro-ungherese,
Richard von Krafft-Ebing. Le sue teorie hanno avuto successo, si trattava di
classificare le deviazioni sessuali, alla quale veniva data una spiegazione
medica, totalmente opposta alla morale cattolica. Altro professore citato è
Havelock Ellis, questi propone la vita sessuale degli animali come modello.
Concludo l’argomento con una tesi significativa di Scaraffia: «E’ interessante
scoprire quanto sia stata proprio la scienza eugenetica a diffondere principi
che poi saranno fatti propri dalla rivoluzione sessuale, contribuendo a renderli
opinione diffusa […] Questa contiguità fra trasformazione del comportamento
sessuale e teorie eugenetiche è confermata dall’inquietante simultaneità fra
l’introduzione della prassi eugenetica e la legalizzazione dell’aborto e della
contraccezione in quasi tutti i paesi in cui l’eugenetica è stata applicata.
Quella che oggi appare e viene raccontata come una vittoria della libertà
individuale, un allargamento dei diritti e della democrazia, deve una parte
importante delle sue origini a una falsa scienza, oggi caduta completamente in
discredito perchè apparentata al nazismo». Collegata alla rivoluzione sessuale
c’è la psicanalisi di Sigmund Freud, che si sviluppa accanto all’eugenetica con
lo schema: perversione-ereditarietà-degenerazione. Freud porta alla nuova
utopia, quella della necessità del piacere per tutti. Scaraffia affronta anche
il tema della “naturalità” nel comportamento sessuale delle cosiddette società
primitive. Si fa l’esempio del paese di Otaiti e poi dei villaggi
nella Melanesia nord-occidentale e poi di Samoa. Gli antropologi erano convinti
che in queste popolazioni c’era una totale assenza di inibizioni sessuali.
Soltanto poi si scoprì che si trattava di favole, non c’era libertà sessuale.
Nella migliore delle ipotesi si trattava di malintesi. Innanzitutto la Scaraffia
sentenzia che la rivoluzione sessuale è stata soprattutto una rivoluzione di
carta: è la nuova utopia, attivata nel secondo dopoguerra da un gruppo di libri,
in prevalenza di matrice anglosassone. Gli ideologi, i padri nobili, di questa
rivoluzione furono principalmente Wilhelm Reich (1857-1957) e Herbert
Marcuse (1898-1979). Sono quelli che hanno fornito la finalità politica e la
speranza di miglioramento nella vita individuale. Per Scaraffia, rileggendoli,
questi libri, si nota una certa infondatezza, superficialità utopistica,
colpevole cecità della natura umana. Tuttavia negli anni sessanta, questi libri
sono stati il vangelo della rivolta. La Scaraffia si sofferma su entrambi
delineando gli aspetti principali dei due leader della rivoluzione sessuale.
Reich creatore del termine rivoluzione sessuale, da cui è nato il testo più
conosciuto della sua opera. L’altro testo di notevole successo è stato La
psicologia di massa del fascismo. Ha criticato in modo particolare la famiglia
che rende l’individuo spaventato e timoroso davanti all’autorità. «Il fascismo
sfrutta ed esalta la struttura familiare autoritaria, repressiva e antisessuale,
proprio perchè questa offre il terreno ideale per il suo sviluppo». Per uscire
dalla deriva fascista per Reich bisogna sostituire la famiglia patriarcale
autoritaria con quella sperimentata dalla rivoluzione russa. Ma il pensiero più
seguito e più letto dal movimento studentesco del ’68 è quello di Marcuse,
attraverso i suoi due libri principali, Eros e civilta e L’uomo a una
dimensione. Nel capitolo (Il piacere sotto inchiesta) la Scaraffia affronta le
teorie dell’ematologo Alfred Kinsey, un profeta-scienziato che con le sue
ricerche ha avuto un grande impatto sociale. Le sue opere furono tradotte in
tutto il mondo e divenne la bandiera di coloro che chiedevano una
liberalizzazione della morale sessuale. I suoi studi forniscono le basi per una
nuova morale sessuale, molto permissiva. Uno dei suoi allievi più fedeli Hugh
Hefner ne coglie l’importanza e fonda un periodico di grande
successo, “Playboy”. Nel capitolo (Il sesso immaginato) si affronta l’era del
sesso, mentre «le scienze umane contribuivano in modo decisivo a cambiare la
mentalità nei confronti del comportamento sessuale presso i ceti intellettuali e
quindi presso le élite occidentali, la rivoluzione sessuale raggiungeva i ceti
popolari attraverso una serie di scandali al cui centro vi erano appunto
romanzi, ma anche film e canzoni». Un ruolo fondamentale nella trasformazione
della mentalità lo hanno svolto il primo Lp dei Beatles e un libro scritto da H.
D: Lawrence, L’amante di Lady Chatterley. Ma non solo la Scaraffia ricorda
l’uscita alla fine degli anni ’70 del disco-scandalo per l’epoca di “je
t’aime…moi non plus”. Il film di Bernardo Bertolucci,“L’ultimo tango a Parigi”.
Un ulteriore altro scandalo è procurato da un libro edito da una piccola casa
editrice legata al movimento studentesco, di“Porci con le ali”. Comunque la
Scaraffia documenta una serie di opere letterarie che praticamente si sono
impadronite dei temi erotici. Il volume si avvia alla conclusione tentando di
fare un bilancio con lo sguardo critico di quelle scelte e nelle scelte
successive del percorso della rivoluzione sessuale o della liberazione delle
donne. E’ una critica serrata da femminista, appartenente al mondo cattolico.
Sostanzialmente per la Scaraffia sono state le donne a pagare il prezzo più alto
per una liberazione che si è mossa in una direzione opposta a quella dei loro
desideri più profondi. Quanto tempo c’è voluto perché le donne capissero. “Si è
raggiunta la felicità prospettata per le donne e gli uomini del nostro
tempo?” Alla domanda non possiamo dare una risposta totalmente
affermativa. «Piuttosto è vivo il sospetto che anche questa promessa utopica
abbia fallito […] confermata dalla costante crescita della depressione che,
secondo l’Oms, entro il 2030 potrebbe diventare la malattia cronica più diffusa
nel mondo». DOMENICO BONVEGNA
·
La
Verginità.
Giulia Villoresi per “il Venerdì di Repubblica” il
21 ottobre 2021. No, la verginità non esiste, almeno non da un punto di vista
medico-anatomico. Su questa base il Royal College of Obstetricians and
Gynecologists (Rcog), che rappresenta gli ostetrici e i ginecologi inglesi, ha
pubblicato un appello sul British Medical Journal per chiedere al governo di
bandire i test di verginità, visite «invasive e prive di basi scientifiche»
volte a verificare l'integrità dell'imene. Il test, si legge nell'editoriale, è
offerto da diverse cliniche private del Regno Unito. Ma è praticato in tutti i
Paesi occidentali. A richiederlo sono soprattutto donne e famiglie di religione
musulmana, ma non solo: ha fatto scalpore il caso del rapper americano T.I., che
ha dichiarato di imporlo ogni anno alla figlia. All'appello dei ginecologi
inglesi ha risposto l'italiana Eugenia Tognotti, docente di Storia della
medicina e della sanità pubblica all'Università di Sassari: la sua lettera,
pubblicata dal British Medical Journal, ricostruisce le origini storiche di un
mito. «Verginità non è un termine medico» dice. «Non lo si trova nei grandi
trattati di anatomia. È una costruzione sociale. Nel Medioevo l'unica incerta
prova della verginità era la tendenza delle donne a sanguinare al primo
rapporto». Poi, nel XVI secolo, il fiammingo Andrea Vesalio, considerato il
padre dell'anatomia moderna, ebbe l'opportunità di dissezionare il corpo di due
donne certamente vergini. «La certezza gli derivava dal fatto che una fosse
suora e l'altra deforme» spiega Tognotti. «Notò un setto di tessuto membranoso
attorno all'ingresso della vagina e si convinse di aver trovato la prova fisica
della verginità». La descrizione dell'imene apparve nel 1543 sul suo De humani
corporis fabrica. In seguito, Vesalio avrebbe precisato che «non tutte le
vergini hanno l'imene». Ma ormai era troppo tardi. «Si tratta forse dell'unico
caso nella storia della medicina in cui l'evolversi della conoscenza non ha
cancellato convinzioni errate. Ancora oggi l'imene è feticizzato. Test non
scientifici vengono eseguiti regolarmente anche nei Paesi occidentali. E il
fatto che il mondo medico non sia riuscito a farli bandire la dice lunga sulla
posta in gioco sociale, morale e simbolica della verginità». Insomma il
problema, oltre che etico, è scientifico, perché l'imene non è un indicatore
affidabile di verginità. Secondo la ginecologa Jennifer Gunter, autrice del
bestseller The Vagina Bible (la Bibbia della vagina), circa il 50 per cento
delle adolescenti sessualmente attive presenta un imene intatto. Altri
specialisti, invece, sostengono che chi ha avuto rapporti presenta quasi sempre
un imene lacerato. Questo disaccordo, secondo diversi medici, deriva dal fatto
che le pubblicazioni scientifiche sull'imene sono quasi inesistenti. «Non si
lacera sempre al primo rapporto» dice Nicola Colacurci, presidente
dell'Associazione ginecologi universitari Italiani. «E di certo non si "rompe"
perché, salvo rari casi, non ostruisce l'ingresso della vagina. Non è un sigillo
che la occlude, ma una membrana che ne circonda l'apertura esterna». In Svezia
hanno addirittura proposto di sostituire "corona" al termine "membrana", che
evoca l'immagine di un'ostruzione; e la richiesta dei ginecologi è stata accolta
dallo Språkrådet, il Consiglio per la lingua svedese. Come spiega Colacurci, il
mito dell'integrità imenale nuoce anche alla clinica: «Tra i medici vige ancora
la consuetudine di non visitare le donne vergini. Quindi se arriva in ospedale
una paziente con sospetta patologia ovarica non posso farle un'ecografia
transvaginale. E neanche un controllo vaginale: sono costretto a farlo rettale.
Con grande disagio per la paziente ed evidenti limiti per la diagnosi». Il test
di verginità, dunque, è solo la prima di molte questioni su cui la comunità
medica comincia a riflettere. In Francia, dopo un dibattito iniziato nel 2020, è
appena diventato illegale. Mentre è di agosto la notizia che l'Indonesia non lo
imporrà più alle reclute dell'esercito. Ma l'appello inglese aggiunge un
tassello importante: la messa al bando dei test «è compromessa senza il divieto
di imenoplastica, visto che le due pratiche sono inestricabilmente legate». Si
tratta della ricostruzione chirurgica dell'imene, e non riguarda solo le donne
musulmane: è parte del grande business della chirurgia intima femminile, una
branca della chirurgia estetica sempre più diffusa, che offre interventi di
rimodellamento e rigenerazione dell'area vaginale. In Italia, l'imenoplastica è
sponsorizzata da una grande quantità di siti che offrono interventi di chirurgia
intima. Alcuni ne illustrano i vantaggi in italiano e arabo. Uno spiega: «La
chirurgia moderna può restituire lo stato di verginità. Dopo questa operazione,
alla prima penetrazione si presenteranno nuovamente la difficoltà e il dolore
tipico della lacerazione con conseguente perdita di sangue». In realtà la
perdita di sangue non è una costante della prima penetrazione. Ciononostante,
come spiega Andrea Garelli, chirurgo plastico che opera tra Roma e Milano, «le
donne che si rivolgono all'imenoplastica vogliono la garanzia del sanguinamento,
soprattutto quelle di religione musulmana. Questa richiesta può essere
soddisfatta chirurgicamente. Ma, in condizioni naturali, il sanguinamento
dipende dalla morfologia e dall'elasticità dell'imene. Molte donne, infatti, non
hanno alcuna perdita». Garelli, diversamente da altri chirurghi, sostiene di
avere tra le sue clienti anche diverse italiane. «Le tipologie sono due. Una è
la ragazza minorenne: a volte viene da sola e poi, quando scopre che serve
l'autorizzazione di un genitore, rinuncia; altre volte è accompagnata dalla
madre. Poi c'è la donna di 45-50 anni. Qui l'imenoplastica è spesso abbinata a
un altro intervento estetico: il seno, la liposuzione. Dovendo fare un'anestesia
generale, ne approfittano. Magari sono donne al secondo matrimonio, che vogliono
fare un "regalo" al marito. C'è un'agenzia specializzata in liste di nozze che
per un periodo proponeva ai suoi clienti questa idea. Alcune donne sono arrivate
così». In Francia lo hanno definito «il business della verginità». Ma di fatto è
difficile farsi un'idea del numero e della tipologia di questi interventi.
ricostruire è una cosa seria Secondo Massimiliano Brambilla della Sicpre,
Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva, «le imenoplastiche non
sono affatto comuni. In ospedale arrivano pochi casi (Brambilla dirige il
servizio di chirurgia plastica genitale al Policlinico-Mangiagalli di Milano).
Sono donne che hanno subito violenza o ragazze inviate dai servizi sociali,
principalmente di origine nordafricana. Ogni caso deve essere valutato da
un'équipe di psicologi. Certo, se un chirurgo si mette a pubblicizzare
l'imenoplastica sul web, è chiaro che riuscirà ad attrarre anche altri tipi di
persone. Ma il ripristino dell'imene non è un gioco. Quindi la procedura deve
essere motivata».
Sfatiamo un mito: la verginità non
esiste. Francesca Favotto il 15 aprile 2021 su Vaniy
Fair. La verginità è solo un costrutto sociale: per esempio, lo sapevate che
l'imene non si rompe? E che la sua forma è simile a uno scrunchie? In quanto
a sesso, a noi generazioni Millennials e anche Boomer (per usare due definizioni
da giovani, appunto!), ci hanno allevato a pane, miti e tabù. Per esempio, a chi
non è stata raccontata la storia del preservare la verginità per essere poi
impalmate dal bravo ragazzo? O a chi non è stato detto che la perdita della
verginità era simboleggiata dalla rottura dell’imene con conseguente perdita di
sangue durante la prima volta? Ebbene, sono tutte fandonie. O meglio, la
verginità è solo un costrutto sociale e non ha nulla a che fare con il corpo.
Abbiamo chiesto delucidazioni alla dottoressa Silvia Gioffreda, medico che si
occupa di salute e benessere sessuale da molti anni, anche attraverso il suo
profilo Instagram (seguitissimo!), dove la trovate come @lapopdoc.
Parliamo di verginità: esiste o non esiste?
«Siccome non c’è alcun modo per provare
scientificamente se qualcuno è vergine oppure no, allora la verginità non
esiste, è solo un costrutto sociale. Il termine “vergine” indica di solito chi
non ha mai avuto esperienze sessuali in generale. Ma in realtà spesso si usa
riferito a una persona con la vulva, per indicare che questa non ha mai avuto un
rapporto sessuale penetrativo».
Quindi l’imene che si rompe e sanguina è una
leggenda?
«L’imene è una struttura che si trova a circa 1-2
cm all’interno della cavità vaginale. Quando me l’avevano spiegata
all’università, me l’avevano definita come una membrana che si trova
all’ingresso della vagina, immaginandomela come una sorta di pellicola che la
sigilla, garantendone la freschezza e l’originalità.
In realtà è molto più simile a uno scrunchie,
l’elastico per capelli in tessuto tipico degli anni Ottanta-Novanta (il famoso
fermacoda che cita Carrie Bradshaw quando litiga con Berger, vi
ricordate?, ndr): è un tessuto ripiegato più volte, appoggiato alle pareti della
vagina che presenta uno o più fori al centro. Tutti questi ripiegamenti gli
permettono di essere molto elastico e proprio per questo motivo può favorire
l’ingresso di pene/dita/sex toys senza rompersi.
A quanto emerge dagli studi, l’imene può variare
in forma, colore, dimensione e flessibilità, da donna a donna, in base all’età o
ai livelli ormonali. Studi fatti in differenti contesti e in differenti Stati
hanno ormai messo in luce che l’imene non può essere indicativo di sessualità
attiva o meno. Come tutte le altre parti del corpo anche l’imene si può rompere.
La maggior parte delle volte, però, succede durante i parti o le violenze
sessuali.
Per quanto riguarda i rapporti penetrativi in
generale, invece, l’imene certo può subire delle microlacerazioni, ma essendo un
tessuto non particolarmente vascolarizzato, è difficile che sanguini durante il
primo rapporto sessuale. Le microlacerazioni poi guariscono da sole senza
lasciare traccia: ecco perché è impossibile distinguere tra l’imene di chi ha
avuto rapporti penetrativi e quello di chi non ne ha avuti».
Allora il sanguinamento da dove deriva durante la
prima volta?
«Sfatiamo il mito che sia normale sanguinare
durante il primo rapporto sessuale. Non solo non è normale, ma non è nemmeno
così comune. Le statistiche riportano che tra il 40 e il 63% delle donne non ha
avuto sanguinamenti durante il primo rapporto.
Se il sanguinamento avviene, è difficile che sia
per colpa dell’imene che si rompe perché come dicevo prima oltre a essere
una struttura molto elastica, è anche povera di circolazione sanguigna (quindi
sanguina poco) e priva di terminazioni nervose (quindi non può essere
responsabile del dolore della prima volta).
Il sanguinamento (e il dolore) invece è spesso
dovuto a delle lacerazioni che il pene determina all’interno delle pareti
vaginali. Questi sanguinamenti sono dovuti al fatto che spesso durante i primi
rapporti si saltano dei passaggi fondamentali che permettono alla vagina di
prepararsi alla penetrazione. Quindi succede che la vagina non è abbastanza
lubrificata e dilatata e per questo il pene può causare delle microlesioni.
Tutto risolvibile con un bel lubrificante e la pazienza necessaria per fare le
cose con calma».
Ho sentito parlare del certificato di verginità:
che cos’è? In cosa consiste?
«È un certificato che può essere emesso in seguito
al test della verginità, che tutt’ora viene fatto in moltissimi Paesi del mondo
(anche in Italia) per garantire la verginità di una persona. Il test consiste
nell’andare a esplorare con due dita la vagina della paziente. Il medico di
turno andrà a verificare la presenza o meno dell’imene e soprattutto la lassità
delle pareti vaginali.
Anche questo falso mito purtroppo è ancora molto
diffuso: la credenza che più si pratica sesso penetrativo e più la vagina si
allargherà e perderà la sua tonicità. Tutti questi criteri non sono affidabili
scientificamente per determinare la verginità di una vulva, ma nonostante questo
i certificati ancora vengono rilasciati, andando a violare molti diritti umani
delle donne.
La comunità scientifica e l’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) sono d’accordo nel dire che non ci sono metodi
scientificamente attendibili per conoscere la vita sessuale di un’altra persona.
E soprattutto che la ricerca di altri test che possano garantire la verginità di
una persona è da sfavorire in quanto causa traumi e viola i diritti di chiunque
debba subire queste pratiche. Bisogna controllare che una donna sia vergine come
se la sua parola non fosse abbastanza o come se non fosse in grado di scegliere
autonomamente con chi e quando fare sesso. Ancora, davvero?».
Arriviamo al punto, quindi: come si fa a capire se
una donna è “vergine” davvero?
«Solo esclusivamente chiedendoglielo. Anche se sei
il più alto esponente della medicina mondiale, un luminare delle vulve, anche in
quel caso l’unico modo per sapere se una persona è vergine oppure no bisogna
chiederglielo».
Diciamoci la verità: la scusa della verginità chi
l’ha inventata, a questo punto, se non ha fondamento scientifico?
«Penso che si cerchino modi per controllare la
sessualità delle donne dall’inizio dei tempi: partendo da quella provocatrice di
Eva che ci ha tolto il posto dal paradiso, passando per le mutilazioni genitali
femminili, le leggi contro l’aborto e i test della verginità: sono infiniti i
modi che si possono utilizzare per controllare la sessualità delle donne.
Delle volte non c’è nemmeno un capro espiatorio
preciso: sono i padri che vogliono che la loro figlia arrivi pura al matrimonio,
ma sono anche le madri che hanno paura che venga additata e derisa per le sue
scelte. Che sembra una storia di altri tempi, ma in realtà qualcuno che ancora
mette fuori il lenzuolo sporco di sangue dalla prima notte di nozze c’è. Ma
soprattutto sono tantissime le adolescenti che mi scrivono per chiedermi se
durante la visita ginecologica la loro madre verrà a sapere se hanno avuto dei
rapporti sessuali oppure no.
Proprio per questa paura, spesso le visite vengono
rimandate all’età adulta, rischiando di ritardare l’inizio di una corretta
educazione sessuale, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e
delle volte anche la diagnosi di molte patologie legate alla sfera
genitale/sessuale.
Il terrore che gira intorno alla libertà sessuale
è ancora tantissimo. Il fatto che ancora oggi una donna con una sessualità
libera e soddisfacente sia vista con un occhio di giudizio ci fa capire che
siamo ancora tutti responsabili dell’esistenza di questi concetti, come appunto
la verginità.
Smettiamola di dire alle ragazzine che qualcuno si
prenderà la loro verginità, o che perderanno la verginità. Altrimenti sembra che
il primo rapporto sessuale ti porti via qualcosa che non ritroverai più.
Invece il sesso dovrebbe essere all’insegna di cose che si acquisiscono e si
imparano: una maggiore conoscenza del proprio corpo, del proprio piacere e della
propria libertà.
Una sessualità sana arricchisce le persone. La
verginità non è un mazzo di chiavi, non si perde. E nessuno sarà mai in grado di
dire con certezza, guardando una vulva, se questa ha mai avuto rapporti sessuali
oppure no. No, nemmeno controllando l’imene».
·
Il
Gang Bang.
Dagospia il 22 aprile 2021. Da "la Zanzara - Radio
24". Valentina Neri, nome reale, moglie di un senatore della Repubblica,
poetessa e scrittrice, ha curato un libro per Santelli editore, appena uscito.
Il titolo è Gang White, Senza Veli, e racconta la storia di un gruppo di uomini
milanesi che anni fa hanno formato un gruppo per organizzare Gang Bang, ossia
un’attività sessuale in cui una donna si concede a più uomini
contemporaneamente. A La Zanzara su Radio 24 Valentina Neri racconta: “Dobbiamo
uscire dalla paura dello stigma sociale, la paura di venire allo scoperto. Più
lo facciamo, più questa cosa diventa normale e accettata”. Dice ancora: “Ho
fatto gang bang prima del matrimonio. Poi mi sono presa un periodo di pausa, e
dopo ho ricominciato. Mio marito lo sa, mi conosce, siamo ancora sposati. E poi
ne scrivo apertamente nei miei libri. Ma non ha mai partecipato, no. Adesso ho
smesso di nascondermi, di mettermi i veli. Quante ne ho fatte? Di gang ne avrò
fatte una decina, per adesso”. Sei consapevole che le donne che hanno queste
esperienze sessuali e lo confessano sono considerate da puttane, nel senso più
spregevole del termine?: “Sì, certo. Proprio per questo bisogna raccontare. E
poi ci sono insulti peggiori di puttana. Una cosa è sicura: se tu confessi di
fare sesso in modo trasgressivo te lo dicono come un insulto e hai addosso uno
stigma sociale, invece è solo un divertimento come un altro. La gente si deve
abituare, ci sono molte cose che non erano permesse, molte cose che non erano
considerate normali”. “Come hanno fatto le battaglie i gay – continua – bisogna
che le donne trasgressive vengano fuori. Oggi chi dice cose del genere rischia
di essere emarginato sul posto di lavoro. Guarda il caso dell’insegnante
siciliana che era stata cacciata per un video hot che circolava, non certo per
colpa sua”. “Va considerato normale – insiste – che una possa giocare con più
uomini e avere una vita trasgressiva”. Con quanti uomini sei andata al massimo
in una gang?: “Non ricordo, credo dieci. Si possono fare tante cose con dieci
maschi. Le persone si alternavano, gente che viene, gente che esce, roba che ti
resta addosso. E’ un gioco, un divertimento, è come fare una giornata al luna
park, una specie di antidepressivo”. E poi?: “Mi da un senso di potere, i maschi
di solito sono quelli dominanti, invece mi sento dominante in quella situazione.
Sono io che devo gestire quei maschi, sono io a dare soddisfazione al maschio”.
Questi di gang White chi sono?: “Sono i principi azzurri della Gang Bang per
educazione, gentilezza, intuito, capacità di mettere a fuoco le situazioni, di
comprendere gli attimi giusti, entrare in sintonia con una donna”.
Barbara Costa per Dagospia il
7 novembre 2021. Una gang-bang 5 contro 1? E se fosse 1 contro 5? E se quell’1
fosse femmina? Chi ve l’ha detto che le gang-bang sottomettano, senza tregua e
sul serio dominino quella donna sola là in mezzo, con tutti i suoi buchi a
disposizione, aperti, sconci, e alcuni più volte riempiti a due, e a tre? Una
gang-bang non soggioga una donna, men che mai la degrada, e specie nei porno di
fascia alta: essi raffigurano la fantasia dell’occhio e del sesso di chi guarda,
e soprattutto di uno sguardo e di un sesso maschili, che si eccitano alla vista
della carne di una donna illusoriamente passiva alle ingordigie di più maschi.
Ma la verità è che l’ingorda è lei, l’avida è lei, è che lo vuole lei, quello
che gli fanno lo decide lei, e sempre se al centro di un tale quadro porno c’è
lei: Angela White. Miei cari Dago-lettori, allegri, che si ricomincia: nel porno
USA hanno ricominciato a girare gang-bang, un segno non di un vero ritorno ai
tempi pre-Covid, bensì di un ritorno al sesso plurimo, multiplo, permesso da
vaccini e tamponi. E si ricomincia come meglio non si potrebbe, con Angela White
che ha firmato una esclusiva con Brazzers e ha scelto come porno di apertura una
gang-bang di quelle che piacciono a lei, con gli stalloni che ha imposto lei. Il
risultato è "Take Control", scena scala classifiche, gang-bang dove ogni
ambizione sessuale di questa australiana femmina insaziabile è di penetrazione
in penetrazione riempita, come ne vengono ristorate brame maschili le più
abiette ma nel porno interpretativamente lecite da affermare. Tu guarda la scena
e dimmi chi comanda, chi si diverte di più tra Angela e i cinque uomini che la
sc*pano (e che sono: Mick Blue, Isiah Maxwell, John Strong, Zac Wild, e Oliver
Flynn). Cinque uomini potenti, bravi a porno-sc*pare non c’è dubbio, ma occhi a
lei: chi comanda lì? I ruoli sono delineati fin dall’inizio, quando Angela White
scende dalla macchina che loro le devono lavare, e quando lei entra nella maison
e li squadra e soqquadra. Sono uomini che servono sesso, servono al sesso,
servono le intenzioni non comuni di una donna non comune. È Angela che ha deciso
di eliminare ogni preliminare, ogni dialogo, futile convenevole. Lei non ha
rivali nel concretizzare i pensieri più immorali dei maschi spettatori suoi
ammiratori. Quando il suo corpo viene afferrato, alzato, posizionato, e
trasformato incavo, e quando lingue e peni dalle sue sapienti mani passano e
entrano nella sua bocca, ne escono per infilzarla, e poi ancora, senza stacchi,
né soste, quasi senza fiato fino a essere due, e tre, nello stesso caldo,
invitante spazio… chi comanda una tale scenografia di carni arrossate,
mischiate, accese, incastrate? Lei, la donna che se ne crede preda. Se non vi ho
persuaso, lascio la parola alla stessa Angela White: “È un 1 contro 5. Sono io
che sto sc*pando 5 uomini, non 5 uomini che fanno gang-bang con me”. Ma in
questo caso chi comanda è anche un’altra, di donna, quella che è vicino ai 6 in
azione e che giustamente non si vede, ovvero Lea Texis, regista scelta apposta
da Angela White affinché la coordinasse in un tal chiasso pornografico. Lea
Texis, rumena, è nel porno da 15 anni, dove ha eccelso in tutto, dal trucco ai
costumi, dalla produzione alla regia. È la prima volta che dirige Angela White,
e insieme a lei ha scelto una lussuosa e appartata villa di Malibu come più
adeguato scenario di "Take Control". Ci aspettano altre rintronanti scene con
Angela White, ed è un paradosso ma la gang-bang "Take Control", con le sue
vigorose fellatio, e le sue doppie e triple penetrazioni, anali e vaginali, è un
goloso antipasto. E adesso va detta questa verità: nel mondo del porno, le
gang-bang girate sono in realtà molte molte meno di quelle che possiamo
scrollare sui siti porno-free. Lì troviamo di una stessa ludica, grandiosa
gang-bang più scene spezzettate, ad arte rimontate, tagliate, rese altro da sé,
e però più frutti della medesima radice primaria. E questo non a causa Covid,
che ha fermato il sesso di gruppo da subito e per primo e che riprende ora con
ogni accortezza sanitaria possibile. Ma perché realizzare una gang-bang è, nel
porno, un lavoro tra i più costosi. Girare una gang-bang costa, tanto, e specie
se la giri con nomi di grido. Non tutte le attrici sono disposte né in grado di
girare amplessi di tal sorta, e né tutti gli attori ne sono all’altezza.
Occorrono “consumati professionisti”, precisa Angela White, pornoattori con
valevole tecnica, gran allenamento, flessibilità di corpi, inusuale dominio dei
peni. E dalla erettile resistenza massima. Una gang-bang di qualità non può
essere garantita da novellini. Se nel porno non esistono paghe standard, e se
l’attrice nella gang-bang onorata è pagata assai di più dei maschi che la
spupazzano, i protagonisti di una gang-bang non prendono meno di 1000 dollari
ciascuno, e questa spesso è nient’altro che la cifra base.
IL “MANIFESTO” DI GANGWHITE SU COME SIA
DAVVERO IL MONDO DELLA GANG BANG E COSA VOGLIA DIRE PARTECIPARVI -
da gangwhite.com il 22 aprile 2021. Aprile 2021.“GangWhite Senza
Veli” di GangWhite, a cura di Valentina Neri (Santelli editore, 2021) sarà
presto disponibile online e in tutte le librerie. Per parlare del libro
“GangWhite Senza Veli” è necessario prima introdurre i suoi “autori”. Alcuni
lettori avranno già riconosciuto il nome di Valentina Neri, che recentemente ha
pubblicato, sempre con Santelli editore, Ridi di me ti prego. Tuttavia, qui la
Neri è solo la curatrice: i veri autori sono anonimi e si presentano come un
gruppo sotto il nome di GangWhite (che non ha niente a che fare con una
possibile accezione razzista). Il libro parla di questa organizzazione
informale, dei suoi scopi, della sua storia e dei suoi obiettivi, quelli veri,
al di là dei pregiudizi. In questo senso si potrebbe quasi dire che questo
saggio è “un’autobiografia” del gruppo.
L’appello di GangWhite. GangWhite si è formato
dieci anni fa dall’impulso del fondatore GangWhite L. e raccoglie individui che
vogliono partecipare a «gang bang». Questa è una pratica molto antica in cui una
donna si offre a più uomini. GangWhite opera nel milanese per far partecipare in
sicurezza le donne e le coppie interessate. Il gruppo, infatti, rispetta un
rigido codice etico che pone al centro dell’attenzione il rispetto della donna
in quanto individuo e della sua privacy. Il pubblico di lettori a cui si rivolge
il testo, quindi, sono tutti gli adulti interessati, in particolare coloro che
già appartengono al mondo Swinger. Tra le sue pagine, infatti, è possibile
trovare testimonianze da entrambi i sessi su questa esperienza sessuale. Il
volume ha un contenuto molto forte e complesso, ma anche un obiettivo ancor più
deciso: sfatare i pregiudizi e gli stereotipi che accompagnano la gang bang.
Infatti, spesso le donne che prendono parte a incontri di questo tipo, aprendosi
alla trasgressione, sono vittima di intolleranza e stigma sociale. Per evitare
questo, il libro ripercorre la storia del GangWhite e indaga i rigidi dettami
etici alla base del gruppo. Le pagine mettono in chiaro come questo mondo non
sia necessariamente legato alla droga e al porno, ma possa essere praticato nel
rispetto della salute dei partecipanti e della donna in quanto persona. Questa,
come tante altre pratiche sessuali trasgressive, non è necessariamente frutto
della perversione o di un rapporto non “sano” con il corpo e la sessualità: a
dimostrazione del fatto che “trasgressivo” non voglia dire “malato”.
Cosa c’è in “GangWhite Senza Veli“. Il saggio, per
mostrare “senza veli” questo modo di vivere la sessualità, è diviso in due
parti: una più sociologica e l’altra più narrativa. La prima è condotta
attraverso le testimonianze dei partecipanti. La seconda, invece,raccoglie
alcuni racconti più romanzati, intervallati alle citazioni dei grandi maestri
dell’eros, come Bukowski, Anais Nin, Simone de Beauvoir e Garcia Marquez. Le
interviste, in particolare, fanno emergere il punto di vista di alcune donne
che, attraverso l’esperienza della gang bang, sono riuscite a rafforzare il
proprio carattere, superando la paura degli uomini e trovando il coraggio di
essere sé stesse. Questo approccio, comunque, non è né la norma né una regola di
buona condotta: le partecipanti scelgono di esprimere in questo modo la propria
sessualità per molti motivi, nessuno dei quali è da etichettare negativamente a
priori. Dalla testimonianza di GangWhite emerge un mondo poliedrico da cui
traggono giovamento tanto le donne single, quanto le coppie. Un mondo in cui
possono nascere nuove amicizie e storie d’amore, che non hanno nulla di diverso
da quelle nate in modo più convenzionale. Ufficio Stampa Santelli editore
La moglie del senatore ex 5S: "Con 10
uomini? Antidepressivo". Francesca Galici il 22 Aprile
2021 su Il Giornale. La moglie di un senatore ex M5S ha scritto un libro sul
sesso trasgressivo e sui piaceri carnali estremi, praticati anche da sposata ma
senza il marito. Valentina Neri è una scrittrice e poetessa che è da poco uscita
in libreria con il volume Gang White, Senza Veli. È un racconto erotico e
disinibito sulle abitudini sessuali di un gruppo di milanesi. Apparentemente si
tratta di un libro per adulti come un altro, come tanti se ne trovano negli
scaffali più nascosti delle nostre pudiche librerie. È la sua autrice a non
essere una firma come altre, perché lei è la moglie di un senatore ex Movimento
5 Stelle, che negli ultimi tempi ha effettuato numerosi cambi di casacca
politica. Tutto si può dire, non che la moglie del senatore non sia disinibita.
Valentina Neri ha raccontato il suo libro a La Zanzara, in onda su Radio24,
spingendosi anche oltre nella narrazione della sua vita privata e sessuale.
Qualcuno potrebbe anche pensare che il nome utilizzato per firmare il volume sia
di fantasia, uno pseudonimo come si usa spesso quando si vuol celare la propria
identità, ma lei no: Valentina Neri ha firmato nero su bianco il libro sul sesso
trasgressivo con il suo nome. E il marito? Bhe, il senatore pare sia consapevole
e consenziente, anche se a quanto dice sua moglie non partecipa agli incontri
sessuali multipli di sua moglie con altri uomini. Valentina Neri è una novella
Giovanna D'Arco del sesso, pronta a rivendicare la libera trasgressione carnale
senza vergogna e senza censura: "Dobbiamo uscire dalla paura dello stigma
sociale, la paura di venire allo scoperto. Più lo facciamo, più questa cosa
diventa normale e accettata". La moderna paladina delle libertà sessuali ha
rivelato di praticare il sesso multiplo e non per sopraggiunta noia coniugale,
visto che era un'estimatrice anche prima del matrimonio col senatore: "L'ho
fatto prima del matrimonio. Poi mi sono presa un periodo di pausa, e dopo ho
ricominciato. Mio marito lo sa, mi conosce, siamo ancora sposati. E poi ne
scrivo apertamente nei miei libri. Ma non ha mai partecipato, no. Adesso ho
smesso di nascondermi, di mettermi i veli". Per la scrittrice e moglie del
senatore, inoltre, il sesso di gruppo al di fuori del matrimonio è da
considerare semplicemente come "un divertimento come un altro". L'obiettivo di
Valentina Neri è quello di abbattere pregiudizi ed etichette sociali, anche se
la donna ha un'idea molto personale di cosa sia un insulto grave, visto che per
lei "ci sono insulti peggiori di puttana". Punti di vista discutibili. Per la
moglie del senatore ex 5Stelle la battaglia per sdoganare il sesso trasgressivo
dev'essere equiparata a quella delle correnti Lgbt+: "Come hanno fatto le
battaglie i gay bisogna che le donne trasgressive vengano fuori". Un paragone
quanto mai azzardato per la scrittrice senza pudori e chissà se il marito
concorda con questa visione. La pasionaria del sesso rivela anche dettagli sui
suoi incontri, tra cui uno con dieci uomini: "Si possono fare tante cose con
dieci maschi. Le persone si alternavano, gente che viene, gente che esce, roba
che ti resta addosso. È un gioco, un divertimento, è come fare una giornata al
luna park, una specie di antidepressivo". E il senatore? Non esce sicuramente
vincente dal racconto di sua moglie, che invece di concedersi il classico
aperitivo con gli amici o una giornata a in un parco divertimenti si concede a
tanti uomini diversi che non sono il marito. Ma se va bene a lui, deve andare
bene a tutti. Senza giudizi, evviva la faccia.
"Siamo separati". Spiazzato dalle dichiarazioni
della scrittrice, il senatore ex M5S è stato raggiunto telefonicamente
dall'Adnkronos. Come riporta l'agenzia, in un primo momento ha preferito
scegliere la strada del no comment ma in un secondo momento ha preso le
distanze: "Siamo separati da un paio d'anni. Cosa faccia è un problema suo. Io
non giudico".
·
Il
Cinema Femmina.
Se l’icona è femminile è grande cinema.
Il grande schermo privilegia protagonisti maschili.
Quando compare l’eroina il successo è assicurato. Gabriele Tornatore su Il
Quotidiano del Sud il 29 marzo 2021. Ci sono voluti decenni per iniziare a
concepire il cinema non solo come sequenza di immagini in movimento, ma di
un’unità omogenea in cui le stesse, oltre a scorrere, raccontino una storia. Ha
richiesto ancora più tempo l’eliminazione dello stereotipo che pone la figura
maschile come unica protagonista di un film, indipendentemente dalla natura
della trama. È innegabile che molte delle grandi glorie creatrici della settima
arte siano di sesso maschile, ma grazie a stimoli come il personaggio di Gilda
Farrel (Miriam Hopkins) che, nella commedia di Lubitsch Partita a quattro
(1933), non sa chi scegliere tra i due uomini che la corteggiano, o l’immortale
Ellen Ripley (Sigourney Weaver) che nel capolavoro di Ridley Scott Alien (1979)
rimane l’unica superstite dopo l’attacco di una creatura aliena, è nata l’idea
che il corpo del cinema può avere forme più delicate e sinuose rispetto a quelle
che ci sono sempre state proposte, ma il percorso che ha reso la donna
protagonista, non è stato semplice. Sia per l’idea in cui la figura maschile è
associata a una primordiale sensazione di sicurezza, che per una radice di
pensiero patriarcale, la donna è sempre stata relegata ad un certo tipo di
comportamenti e modi, perciò il cinema non ha quasi mai conferito ai ruoli
femminili la giusta identità. Ciò che emergeva era una realtà in cui la donna
trovava il suo spazio all’interno dei film, vincolata però nell’interpretazione
di figure legate solo alla sessualità o alla famiglia. Il cambiamento avvenne
con l’evoluzione sociale che, nella seconda metà del Novecento (in particolare
negli anni 60 con l’elevato numero di movimenti culturali e moti di rivolta),
permise alla figura femminile di emergere, ma la svolta fu l’abolizione del
codice Hays, una serie di linee guida morali che fino agli anni 50 governò e
limitò le produzioni cinematografiche, isolando la donna in schemi recitativi e
parti prestabilite. Con questa mutazione si iniziarono a produrre molte più
pellicole che ponevano la donna al centro della storia, creando trame basate
sulle loro gesta, infatti, dalla metà del secolo scorso, nacquero le grandi
icone femminili del cinema, alla pari di quelle maschili, non più così uniche.
Molte sono le pellicole che rappresentano questo passaggio, si guardi, ad
esempio, il film Aurora del 1927 di Murnau, antecedente all’evoluzione prima
citata, importante, infatti, non solo per l’unicità della trama ma anche per il
periodo in cui è uscito. In questa pellicola un uomo, annoiato dalla monotonia
della vita contadina, subisce il fascino di una giovane donna che lo induce a
compiere azioni terribili per fuggire insieme. L’elemento femminile è,
chiaramente, il nodo centrale della vicenda, in grado di plasmare
l’abitudinarietà di un uomo radicato nei propri principi che, fino al suo
arrivo, non avrebbe mai modificato. Andando avanti nel tempo è impossibile non
citare la grande interpretazione di Rita Hayworth che, ne La signora di Shangai
di Orson Welles del 1947, assume la forma della donna infedele che ricerca la
sua libertà tentando di togliersi di dosso il modello di “femme fatale” imposto
da una società vissuta solo dal punto di vista maschile. Passando a ruoli più
drammatici, è unica l’interpretazione di Sophia Loren che, nel film La Ciociara
di Vittorio De Sica del 1960, interpreta Cesira, una povera vedova romana che,
insieme alla figlia, tenta di sopravvivere ai bombardamenti dei tedeschi nella
Seconda Guerra Mondiale. La diva romana ci regala una prova attoriale che è
passata alla storia, riuscendo a rinchiudere tutti i dolori e le frustrazioni di
un’epoca all’interno della figura che rappresenta: una madre preoccupata per la
sopravvivenza della figlia. Il già citato Alien è un altro caso in cui la figura
femminile è al centro del racconto, ma la peculiarità del film è proprio il
ruolo che Sigourney Weaver rappresenta, quello del tenente. Nel film, infatti,
viene descritto un personaggio che già dall’inizio è un elemento di forza,
determinato proprio dal grado militare a cui appartiene. Ultimo, ma non meno
importante, è un altro capolavoro di Scott, ovvero Thelma e Louise del 1992.
Vera e propria metafora dell’emancipazione femminile, raggiunta attraverso un
percorso di distaccamento dalla routine che vive giorno dopo giorno. I volti del
film sono le bellissime Geena Davis (Thelma Yvonne Dickinson) e Susan Sarandon
(Louise Elizabeth Sawyer) che incarnano perfettamente il prototipo di donna
senza paura, in grado di compiere anche gesti estremi per non perdere la libertà
che ha ottenuto.
·
San
Valentino.
DAGONEWS il 13 febbraio 2021. Mentre le coppie si
preparano a celebrare il giorno di San Valentino, l'esperta di appuntamenti
australiana Louanne Ward è pronta a sfatare alcuni luoghi comuni sul giorno
degli innamorati: toglietevi dalla testa che le rose rosse siano i fiori più
romantici da regalare e non è nemmeno vero che gli uomini pensano di più al
sesso rispetto alle donne.
1. Più coppie si lasciano prima (e il giorno di
San Valentino) - VERO. Se è vero che "stagione delle rotture" è comune intorno a
Natale e Capodanno, il nuovo sondaggio mostra che il giorno di San Valentino
"manda tutto all’aria". «Se molti single sono alla disperata ricerca di un
appuntamento prima del 14 febbraio, le persone in coppia non vedono l’ora di
farla finita. Le festività natalizie possono generare tensioni e problemi che,
se lasciati irrisolti nel nuovo anno, si traducono in un accresciuto desiderio
di rompere». La metà degli australiani intervistati ha rivelato di aver litigato
con il proprio partner il 14 febbraio, dimostrando che la stagione delle feste
"rappresenta un momento di accese discussioni per molte coppie". Ward ha
scoperto che la causa principale della rottura è la mancanza di romanticismo.
2. Gli uomini sono meno romantici delle donne -
FALSO (MA ANCHE VERO). Ward sostiene che questa affermazione sia molto
controversa: il 58% degli intervistati crede che le donne siano in realtà più
romantiche degli uomini, mentre quasi l'altra metà è irremovibile sul fatto che
sia il contrario. Secondo la principale antropologa Helen Fisher, gli uomini
hanno maggiori probabilità di innamorarsi a prima vista perché il loro cervello
e il loro sistema ormonale conferiscono loro tendenze romantiche più visive
rispetto alle donne. Secondo Ward le donne “selezionano” il partner, rendendo
gli uomini più inclini a dire prima “ti amo”. In sostanza c’è una sorta di
parità.
3. Gli uomini si preoccupano di più del sesso
rispetto alle donne - FALSO. Non sono solo gli uomini a interessarsi di più al
sesso. Sia donne che uomini si preoccupano del sesso, dell'affetto e
dell'intimità. In effetti, due terzi dei partecipanti al sondaggio lo hanno
valutato come importante il giorno di San Valentino.
4. La lingerie rende felici sia gli uomini che le
donne - VERO. Cosa sarebbe una festa di San Valentino senza la lingerie? Più di
tre quarti degli uomini la comprerebbe per la loro dolce metà e quasi il 70%
spera di vedere il proprio partner in abbigliamento sexy. Un 64% delle donne
sarebbe felice di riceverla in dono dal proprio partner.
5. Acquistare un regalo per dimostrare il tuo
amore è importante - FALSO. Dimentica rose, orsacchiotti e cioccolatini, il 63%
degli uomini e delle donne preferisce sentirsi amati il 14 febbraio piuttosto
che ricevere un regalo obbligatorio. Mentre un regalo può essere apprezzato, i
risultati indicano che è il sentimento che c'è dietro che conta veramente (non
quanti soldi spendi).
6. Le rose rosse sono il fiore più romantico -
FALSO. Le rose rosse sono una scelta sicura per San Valentino, ma non è sempre
la prima scelta per una donna. Il sondaggio ha rilevato che quattro donne su
cinque preferiscono il loro fiore preferito alle tipiche rose rosse che fanno
parte di ogni campagna di marketing di San Valentino.
DAGONEWS il 13 febbraio 2021. Chi ha perso il
proprio partner a causa del Covid si starebbe rivolgendo al mercato delle sex
doll per riempiere il vuoto e tentare di alleviare il dolore. È quanto rivelato
da Silicone Lovers, produttrice di bambole, che ha assistito a un’impennata
delle richieste durante la pandemia. Oltre ad aver ricevuto richieste bizzarre,
con alcuni clienti che chiedevano bambole con scheletri umani o ibridi animale-
umano, chi ha sofferto di solitudine ha deciso di acquistare una sex doll: «Si è
parlato molto sul Web del fatto che le persone sono bloccate nelle loro case e
sono sole e bisognose di compagnia – ha detto co-fondatrice di Silicone Lovers,
Louie Love - Fortunatamente, le nostre bambole soddisfano questa esigenza.
Alcuni hanno perso il partner a causa di Covid e vogliono una bambola che li
aiuti a metabolizzare il lutto, quindi è gratificante far parte di quel processo
di guarigione e sapere che stiamo davvero aiutando le persone. Molte persone che
normalmente non avrebbero mai pensato alle bambole come un'opzione, hanno
rivolto la loro attenzione a questo mercato. Abbiamo visto un enorme aumento di
interesse anche da parte delle coppie che vogliono sperimentare introducendo un
nuovo elemento nella coppia». Il mese scorso, un'altra azienda di bambole del
sesso ha rivelato che i suoi prodotti stavano sostituendo gli umani durante la
pandemia. Sex Doll Genie (SDG), un'azienda statunitense ed europea ha affermato
che l'interesse dei maschi single è aumentato del 51,6% tra febbraio e marzo
2020.
·
Il
Femminismo.
La rana e lo scorpione.
Crescere figli femministi è la nuova moda, ma questa storia non finirà bene.
Assia Neumann Dayan su l'Inkiesta il 13 Novembre 2021. Le maestre nelle scuole
propongono di smantellare la separazione tra maschi e femmine e la diffusione di
stereotipi di genere. E lo stesso fanno i genitori a casa. Quando diventeranno
adolescenti i ragazzi avranno i loro momenti di ribellione. Dopo la prova
ontologica dell’esistenza di Dio di Sant’Anselmo, il chupacabra e il delitto di
via Poma, nella mia mente il più grande mistero irrisolto rimane come facciano i
genitori che lavorano a partecipare alle riunioni di classe alle 17 di un giorno
feriale. C’è un’intera collezione autunno/inverno di sfondi pazzerelli di zoom,
non si capisce se per far finta di essere al lavoro o a casa. Fatto sta che con
una certa vergogna e con una certa apprensione aspetto il verbale della
riunione, con quello stato d’animo proprio dello stare in caserma per una
denuncia, fatta o subita non importa, cosa che mi sembra più un segno
premonitore che altro. Arriva il sacro resoconto, e siamo ancora ai monopattini
che non si lasciano in giardino. Mio Signore, dammi la forza di non prendere
tutti quei monopattini e farne un falò, concedimi la serenità di accettare le
cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso, e la
saggezza di non lasciare tracce dell’incendio che appiccherò fuori da scuola. E
fin qui tutto benino. Ma, all’improvviso, il dramma. Le maestre si propongono di
smantellare la separazione tra maschi e femmine e “la diffusione di stereotipi
di genere”. Pare che i maschi dicano che il rosa è da femmine e che non vogliano
giocare a pettinare le bambole. Dove sono le famiglie? È emergenza stereotipi? È
entrata la filosofia gender nelle scuole? Questi bambini non hanno Twitter? Non
seguono i profili attivisti, transfemministi, antispecisti su Instagram? Stiamo
allevando il patriarcato, e io onestamente vorrei evitare di ritrovarmi la gente
coi cartelli sotto casa. Cos’è che fa dire ai maschi che le femmine sono
inferiori? È biologia? È retaggio culturale? È vuoto delle istituzioni? Il mio
metodo educativo empirico mi fa dire che tutto è solo scorpione e rana. Io da
bambina mi rifiutavo di mettere i pantaloni, mica volevo sembrare un maschio, ed
ora eccoci qui a fare le giornate con i maschi in gonna al liceo. Lo sapevamo
già che il mondo sarebbe finito così, non con un botto ma con una lagna, ma così
sta diventando ingestibile. Puoi crescere un “figlio femminista”, cosa oramai
molto alla moda, così come è alla moda vestire i figli con colori neutri
buttando via anni e anni di studi in armocromia, oppure lasciare ai maschi i
capelli lunghi, se non per poi dare di matto se qualcuno scambia il bambino per
una bambina; ma caro genitore progressista, se hai un figlio maschio odierà
comunque le femmine, anche se a casa tua usate gli asterischi per dirvi che è
pronta la cena. Io già me li vedo i momenti di ribellione adolescenziale di
questi figli, che se tanto mi dà tanto diventeranno tutti dei piccoli
negazionisti dei diritti di chiunque anche solo per dispetto. Idea per un film:
famiglia con casa di proprietà in Piazzale Dateo manda il figlio in una scuola
pubblica. Un giorno il padre legge il verbale di classe, prende il piccolo
Paride (in Piazzale Dateo vanno molto di moda i nomi di antichi eroi) e gli
dice: «Figlio mio, è vero che non vuoi giocare con le femmine?». Il bambino dice
di sì, che le femmine sono diverse dai maschi, e il padre gli tira una serie di
schiaffoni urlando che non bisogna avere stereotipi di genere. Per il finale
scrivetemi in privato.
Femminismo metaverso. Perché ci indigna
più il maschilismo cisgender delle afghane ammazzate.
Carmelo Palma su L'Inkiesta il 26 Ottobre 2021. Il movimento per i diritti delle
donne è sempre più la caricatura di se stesso. Passato da una dimensione
politica a una puramente mediatica, l’unica identità femminile per cui si batte
è quella rappresentata, mai quella vissuta. C’è qualcosa di grottesco
nella nonchalance con cui tutto l’occidente democratico ha riconsegnato milioni
di afghane ai tagliagole talebani, pure giudicando per eccesso di zelo le
ostagge il prezzo giusto per la “decisione epocale”, e nell’acribia e nella
suscettibilità, che le questioni di genere declinate secondo il canone del
sessualmente corretto – tanto impalpabile nella sostanza, quanto implacabile
negli effetti – continuano contestualmente ad accendere nel discorso pubblico
occidentale. Da una parte la cancellazione delle donne dalla realtà di una fetta
di mondo e la loro segregazione nelle galere dell’islamofascismo, dall’altra un
vasto programma di igienizzazione delle dispute e dei conflitti di genere con
l’amuchina della cancel culture e le contro-discriminazioni decretate dal
tribunale dell’Inquisizione del popolo social indignato. Visto dall’Italia,
questo processo di alienazione ideologica e di isteria opportunistica assume
caratteri bizzarri – un mix di intransigenza moralistica e oltranzismo
esibizionistico – ma probabilmente abbastanza rappresentativi di una tendenza
generale. Però, tra le ore di discussioni e le tonnellate di byte, per stare
all’ultimo caso, sulle esternazioni del professor Barbero in tema di spavalderia
femminile e le ore di silenzio e i deserti di pagine bianche guadagnate su
giornali, tv e social media progressisti dalla normalizzazione talebana a colpi
di burqa e di mannaia non c’è solo un’evidente contraddizione. C’è una
correlazione più profonda, come tra due sintomi del medesimo male, che è la
“disincarnazione” della discussione sulle questioni di genere – comprese quelle
LGBT, che ora lasciamo a parte – e l’abbandono del corpo delle donne e dei suoi
diritti come centro della riflessione e dell’iniziativa politica femminista, non
solo e non necessariamente al femminile. Il cuore della lotta si è spostato dai
temi dell’auto-determinazione a quelli della etero-rappresentazione (cosa si
dice delle donne, come si parla di loro, come si rispetta la loro autopercezione
e la loro immagine sociale) e quindi è scivolato dalla dimensione propriamente
politica a quella puramente mediatica, col risultato che l’unica identità
femminile rilevante è quella rappresentata, non quella vissuta. Una deriva
ideologica in piena regola, con manifestazioni poliziesche e disarmanti, tra il
massimo dell’arroganza e il massimo dell’impotenza, perché se il “mediatico” e
il “politico” finiscono per coincidere, le donne invisibili cessano di esistere
e l’universo femminile finisce per comporsi solo di avatar digitali. Un
femminismo “metaverso”, che, come il nuovo progetto di Zuckerberg, rappresenta
un ecosistema virtuale: non un modo per guardare e cambiare la realtà, ma per
surrogarla, adattandola alle esigenze del gestore e non degli utenti. E in
questo caso i gestori sono proprio i softwaristi della macchina ideologica del
femminismo virtuale, i padroni del vapore della correttezza di genere. Visto che
l’unica legge ferrea della storia è l’eterogenesi dei fini, come Zuckerberg con
Facebook non voleva creare una piattaforma totalitaria, ma solo fare quattrini
(e forse, come tutti i nerd, fare colpo sulle ragazze), così anche gli
amministratori di sistema del femminismo virtuale volevano solo fare del bene (e
forse, come tutti gli ideologi, si sono pure convinti di incarnarlo). Ma il dato
di fatto è che questo femminismo è diventato solo un teatro di ombre nella
caverna dei media di massa. Tutto ciò spiega la relazione tossica tra il
pregiudiziale sospetto di maschilismo cisgender in qualunque deviazione dal
codice obbligato di social, giornali e tv e la disponibilità ad accettare la
misoginia politica fuori dalle mura protette del bla bla
bla mediatico-accademico. La stessa relazione, per intendersi, che porta Michela
Murgia a essere insieme paladina dello schwa e simpatizzante di Hamas e a non
avvertire alcuna contraddizione tra le due scelte politiche. Se il femminismo è
stata la rivoluzione universalistica più riuscita nel Novecento occidentale e la
più radicale negli effetti, trasformando in profondità la struttura stessa della
società, a partire dalla famiglia, le sue derive finiscono per sacrificare
insieme all’attributo della corporalità anche quello dell’universalità, cioè del
riguardare le donne in quanto donne, secondo un principio di uguaglianza
prevalente su ogni differenza nazionale, culturale e religiosa. Una violenza
quotidiana, efferata e programmatica contro il corpo delle donne è perpetrata
anche al di là dei confini dei paesi islamisti, ma non è al centro di nessuna
azione e riflessione politica da questo lato di mondo, in cui il femminismo si è
perso per strada la questione del pane e discute animosamente sulla qualità
delle brioches. Per fare un esempio pazzesco, quanto a rilevanza e invisibilità,
le donne cinesi sono state negli ultimi decenni al centro di un mostruoso
esperimento sociale. Prima costrette agli aborti forzati e alle sterilizzazioni
di massa in obbedienza alla politica del figlio unico, poi condannate a aborti
selettivi per giocare quell’unica fiche procreativa sul maschile anziché sul
femminile (nelle nuove generazioni, ci sono 120 nati maschi ogni 100 nate
femmine). Ora che il regime nazionalcomunista ha deciso il dietro front per
contrastare il violento calo demografico (con decine di milioni di feti abortiti
e indesiderabili in quanto femminili), si passerà alla restrizione del diritto
all’aborto per ragioni “non terapeutiche”, cioè si proseguirà la politica
dell’aborto di Stato (imposto) in quella del non aborto di Stato (vietato). Però
la cattività delle donne cinesi – uno dei fattori determinanti degli equilibri
demografici, economici e politici mondiali dei prossimi decenni – non sembra
proprio, diciamo così, al centro delle attenzioni, dei discorsi e degli studi
dei fanatici dei gender studies. Non è cattiveria, appunto, è
autoreferenzialità.
Gloria Steinem: «Difendiamo
i nostri diritti dai maschi bianchi al potere».
La legge del Texas contro
l’aborto. La deriva misogina polacca. La leader femminista americana analizza il
backlash contro le conquiste delle donne. E invita alla resistenza. Insieme a
Laura Boldrini, già presidente della Camera, Steinem sarà protagonista il 24
ottobre di un dialogo sul femminismo, a conclusione del Festival “L’eredità
delle donne”. Francesca Sironi su L'Espresso il 30 settembre 2021. Un dialogo
sul femminismo tra l’attivista statunitense Gloria Steinem e l’ex presidente
della Camera Laura Boldrini, a partire dalla storia del movimento di liberazione
delle donne, con lo sguardo rivolto alle giovani generazioni e alle ragazze di
domani. È l’appuntamento conclusivo (domenica 24 ottobre alle ore 18,15 nella
Sala Festa – Manifattura Tabacchi) del Festival “L’eredità delle donne”,
realizzato da Elastica, con la direzione artistica di Serena Dandini, dal 22 al
24 ottobre dal vivo alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Gloria Steinem,
scrittrice e attivista statunitense, è una delle figure più influenti e
autorevoli del movimento femminista mondiale. La sua vita e le sue battaglie
sono state avanguardia e ispirazione per molte generazioni di ragazze, a partire
dagli anni Sessanta. Oggi, a 87 anni, ripubblica con la casa editrice VandA un
suo bestseller, “Autostima”. Mentre l’ultimo libro di Laura Boldrini, “Questo
non è normale. Come porre fine al potere maschile sulle donne” (2021), è
pubblicato da Chiarelettere. Dal primo settembre di quest’anno gli abitanti del
Texas sono invitati a segnalare cliniche, medici o anche solo tassisti che si
mostrino disposti ad aiutare donne che devono abortire. Se la segnalazione ha
successo, il cittadino-denunciante riceve un premio di almeno 10mila dollari.
Quest’invito a farsi polizia diffusa contro l’aborto è uno degli aspetti
inquietanti fra i molti della nuova legge che impedisce le interruzioni
volontarie di gravidanza in Texas, divieto che agisce dopo la sesta settimana
dalla fecondazione, senza eccezioni per stupro o incesto. Sta succedendo ora,
nel 2021, in una delle più grandi democrazie dell’Occidente. Non in una
dittatura o in un qualche Paese comunemente tacciato di oscurantismo. In Europa
lo stesso: dopo il partecipatissimo referendum che in Irlanda ha introdotto il
diritto all’aborto nel 2018, in Polonia le donne si sono viste togliere quello
stesso diritto a gennaio del 2021, nonostante le oceaniche manifestazioni
popolari degli anni scorsi per impedire che accadesse. Il mondo non fa che
ricordarci insomma che non c’è traguardo sociale che possa esser dato per
scontato. Non c’è vittoria civile di fronte alla quale non si debba scegliere
continuamente da che parte stare, e mobilitarsi per questa. Essere partigiani.
«La cosa positiva, che va sottolineata con forza ogni volta, è che queste
mobilitazioni popolari esistono. E che la maggioranza delle persone è più aperta
e inclusiva di quanto non voglia un manipolo di uomini bianchi che continua a
pretendere il potere sul corpo delle donne». Gloria Steinem è una delle più
famose leader del femminismo mondiale. La sua vita e le sue battaglie sono state
avanguardia e ispirazione per generazioni, a partire dagli anni ‘60. Oggi a 87
anni è veloce e propulsiva come a trenta nel ragionare, durante una
video-intervista che le piace immaginare circolare, dice, anche se siamo in due,
ma circolare perché è interrogandosi alla pari che emergono nuove possibilità,
sulle conseguenze e le radici di quanto sta accadendo intorno al ruolo sociale e
politico delle donne. Steinem sarà a Firenze per l’evento di chiusura del
festival “L’Eredità delle Donne”, che si terrà dal 22 al 28 ottobre. Per
l’occasione la casa editrice Vanda pubblica una nuova edizione di uno dei suoi
bestseller, “Autostima. La rivoluzione parte da te”.
Cominciamo da quanto sta
succedendo in Texas. Come lo interpreta?
«Ci sono tre aspetti che
evidenzierei. Il primo: ci troviamo di fronte, di nuovo, a cosa accade quando
una manciata di uomini bianchi di potere possono esprimere liberamente i loro
sentimenti rispetto al controllo delle donne e delle facoltà riproduttive. Il
secondo: che la maggioranza è già andata avanti rispetto a questi temi. La
risposta popolare è stata enorme e diffusa. Tassisti texani hanno offerto le
corse per le donne che dovranno abortire in Stati vicini. È la natura della
legislazione a livello statale che permette a politici poco rappresentativi ed
eletti purtroppo con maggior indifferenza da parte dell’elettorato, rispetto a
quanto accade a livello centrale, di orientare la legge locale e avere effetti
di questo tipo».
C’è un tema fondamentale di
rappresentanza e di partecipazione politica quindi.
«Esatto, è il terzo elemento
cruciale per capire quello che sta succedendo. I governanti del Texas in questo
momento non rappresentano la maggioranza del loro Stato, così come è stato per
Trump. Siamo di fronte a una classe di potere minoritaria che non accetta la
nuova diversità del Paese. È una minoranza pericolosa di bianchi, al comando,
che non vuole fare i conti con il presente e il futuro della popolazione: fra i
nuovi nati i bambini di colore sono più numerosi dei bianchi. E questa è una
grandissima promessa, che ci permetterà di conoscere meglio il mondo. Ma loro si
rivoltano contro la nostra stessa popolazione. Lo stesso vale per l’uguaglianza
fra uomo e donna: è avanzata in moltissimi settori della società, e per le nuove
generazioni la solidarietà è enormemente più diffusa. Ma ancora siamo di fronte
a possibili leggi come quella in Texas».
Razzismo e politiche
anti-abortiste sono questioni così legate?
«Totalmente. Sto lavorando
adesso a un saggio che mette in luce come la primissima legge promulgata da
Hitler fosse la condanna dell’aborto quale crimine contro lo Stato, e il
controllo dei destini delle donne. Voleva che la popolazione bianca si
riproducesse a forza, mentre sterminava ebrei e persone di colore nei campi di
concentramento. Anche per Benito Mussolini la famiglia, intesa alla
riproduzione, era essenziale, e le donne dovevano solo produrre figli. Tutto
questo per via dell’utero: perché noi abbiamo l’utero e loro no. E allora
vogliono controllare le donne e le loro scelte, per costringerle».
Penso a papa Francesco che ha
detto pochi giorni fa che «l’aborto è un omicidio». Già nel 2018 d’altronde
diceva che abortire «è come affittare un sicario». Fin dal concepimento.
«Di fronte a frasi come
queste, bisogna ricordare che il papato non l’ha sempre pensata in questo modo.
Anzi. Fino a papa Pio IX - siamo nella seconda metà dell’Ottocento - prevaleva
la dottrina di Gregorio XIV, ripresa da Tommaso d’Aquino e da Aristotele,
secondo la quale il feto assumeva un’anima solo quando iniziava a muoversi.
Quindi non dal concepimento. L’interruzione volontaria di gravidanza quindi era
regolata, semplicemente. Non vietata del tutto. Penso che il cambio di dottrina
a riguardo sia stato una scelta politica, un accordo con Napoleone III per
forzare la popolazione a crescere, visto che c’era bisogno di giovani da
esercito».
È politica insomma. Politica
imposta sul corpo delle donne. E ogni volta, mascherata da argomento di
moralità. Ma decidere al posto di tutte le donne, di ogni singola donna di
fronte al suo corpo e al suo futuro, è morale? O politico, appunto?
«Penso a quanti negli Stati
Uniti si dichiarano anti-aborto e sostengono queste leggi, e poi sono a favore
della pena di morte. Non ha senso, evidentemente. A meno di non accettare il
paradosso per cui una vita “colpevole” vale meno».
E sono faglie di fronte alle
quali non tengono, a pensarci, le grandi divisioni fra Oriente e Occidente, ad
esempio, oppure fra una fede e l’altra, fra un sistema culturale e un altro.
Tiene solo la democrazia esercitata o la solidarietà. È così?
«La tendenza egualitaria si
trova dappertutto, così come la ricorrenza del potere, dei pochi uomini intesi a
controllare i corpi di tutte le donne. Penso all’Afghanistan: i talebani sono un
gruppo di suprematisti maschili. E allo stesso tempo, appunto, la forza
dell’egualitarismo attraversa i continenti. Io ho imparato il femminismo in
India, è lì che ho conosciuto le donne che supportavano Ghandi ma anche si
contrapponevano a lui su temi come la contraccezione e il controllo delle
nascite. È lì che ho capito che questa dinamica sul controllo dell’utero era
politica. Le stesse suffragette statunitensi impararono dalle donne native
americane le prime pratiche di controllo della fertilità e l’uso dei pantaloni
per muoversi. L’apporto delle identità e delle culture non-bianche nel movimento
femminista è assolutamente sotto-rappresentato. Ne ho avuto esperienza
personalmente».
In che senso?
«Da ragazza venni messa sulla
copertina di magazine e settimanali, come simbolo delle lotte femministe. Non mi
venne chiesto il permesso, ovviamente, ma il problema principale era lo sforzo
di alcuni media di caratterizzare il movimento delle donne come un movimento
bianco, quando le donne nere erano forse più numerose, e più determinate, nei
cortei. Ci fu una sorta di divisione: il movimento femminista era rappresentato
con donne bianche, quello per i diritti civili con uomini neri. Così le donne
nere che erano la maggioranza delle leader di entrambi i fronti, scomparivano».
In Texas circa il 70 per cento
degli aborti praticati nel 2019 era stato chiesto da donne di colore.
«C’è un enorme problema di
accesso alle cure, alle strutture mediche, agli strumenti di prevenzione. Il
Covid-19, se ci pensiamo, ci ha messo di fronte alla stessa evidenza. Da una
parte ha rivelato la natura arcaica dei confini nazionali, aumentando la nostra
percezione dell’essere parte di una umanità comune. Dall’altra la differenza
dell’impatto del virus e delle misure di restrizione sulle diverse classi
sociali è stata fortissima, e inaccettabile».
Fra le conseguenze delle
restrizioni per la pandemia, c’è stato anche l’aumento della violenza domestica.
«Prima degli anni ‘70 la
polizia che veniva chiamata a intervenire durante casi di violenza in famiglia
aveva come ruolo quello di convincere la coppia a tornare insieme. C’era questa
idea che la legge si fermasse sulla porta della famiglia. Adesso siamo lontane:
ci sono rifugi per le donne, le norme sono migliori, gli strumenti a
disposizione sono molti, ma dobbiamo continuare a investire, e aumentarli.
Dobbiamo formare nuove generazioni che abbiano vissuto in famiglie diverse, e
quindi possano cambiare il discorso pubblico, normalizzando la parità».
È da casa che parte tutto, no?
«È così. Solo se bambine e
bambini vengono educati a credere nella loro libertà, nelle loro aspirazioni, a
sentire se stessi come unici, non ci saranno più basi per il patriarcato».
C’è chi dice che il femminismo
ha stufato, che se ne parla troppo, che ormai la parità è dappertutto. Cosa
rispondere?
«Beh, banalmente, con una dose
di realtà. Solo 26 Paesi hanno donne presidente. Gli Stati Uniti hanno avuto un
solo presidente di colore nonostante la popolazione. Le donne leader, nelle
organizzazioni come nelle aziende devono ancora vergognarsi di essere sincere,
semplicemente perché lo standard della leadership è graniticamente maschile, e
penso ad esempio al piangere quando si è arrabbiati o alle dinamiche di tempo e
potere. C’è una cosa che ho imparato in questi anni di insegnamento, ad esempio,
ed è quella del mettersi in cerchio, di ripartire da un discorso alla pari,
lasciarci alle spalle il modello frontale della Chiesa, dove delle persone
guardano un ragazzo con una gonna che parla da un palco o da pulpito accentrando
su di sé il potere di parola. È condividendo questo potere che cambieremo».
“Eleonora di Aquitania. Una
femminista del Medioevo”.
Lunedì 6 settembre 2021 - Chiostro dell’ex Convento degli
Agostiniani, Manduria. La Voce di Manduria martedì 31 agosto 2021.
Nell’immaginario collettivo, senza dubbio, la donna del Medioevo è vista o come
“domina”, relegata ad un ruolo ben definito, in casa con altre donne, in una
condizione di sudditanza, con scarsa possibilità di accesso all’istruzione e
nessuno alla vita pubblica, contemplata al massimo come oggetto d’amore e
destinataria di rime da parte dei poeti, oppure è ritenuta fonte di ogni male,
demonizzata e perseguitata, come testimonia la famigerata “caccia alle streghe”.
Lunedì 6 settembre alle ore 19:30, nel chiostro dell’ex Convento degli
Agostiniani, nell’ambito del ciclo di eventi che Archeoclub Manduria ha voluto
dedicare a Dante e al Medioevo, il dottor Cristian Guzzo, invece, proporrà la
singolare figura femminile di Eleonora d’Aquitania, una femminista ante
litteram, colta e raffinata, che si accostò allo studio del latino, della
musica e della matematica, moglie e madre di re, donna di potere, non certo
l’unica, come dimostrano Matilde di Canossa e Adelaide reggente di Sicilia, solo
per citare qualche esempio. II Medioevo non fu, dunque, dominato esclusivamente
da figure maschili, indubbiamente preponderanti, ma vide protagoniste anche
alcune donne che in un certo qual modo segnarono il loro tempo, come Eleonora,
che conosceremo attraverso le parole del medievista Guzzo. Spirito libero
dall’intelligenza viva, una delle donne più potenti d’Europa, emancipata, tanto
da non voler vivere solo di luce riflessa, Eleonora d’Aquitania è una figura
del XII secolo decisamente moderna e attualissima, proprio in questi giorni in
cui, in alcune zone del mondo, il destino delle donne è quanto mai incerto ed
oscuro. Si auspica una massiccia partecipazione da parte della cittadinanza, nel
rispetto delle norme anticovid. Archeclub d’Italia - Sede di Manduria
Meloni contro le
femministe: “Vi indignate per la Spigolatrice e non per la Madonna a forma di
vagina”.
Alberto Consoli giovedì 30 Settembre 2021 su Il Secolo d’Italia.
Giorgia Meloni interviene sulla statua della Spigolatrice di Sapri “formosa” che
tiene ancora banco tra mille ipocrisie. La leader di Fratelli d’Italia commenta
con un’osservazione pungente: “Ho saputo che alcune femministe avrebbero chiesto
la rimozione di una statua perché “troppo formosa”. E – a loro dire – offensiva
per le donne. Mi chiedo – ragiona la leader di Fratelli d’Italia – : ma per
caso sono le stesse che hanno promosso o difeso l’imbarazzante iniziativa nella
quale veniva esposta una Madonna a forma di vagina?”. La domanda contiene già la
risposta: “Qualcuno di voi ricorda qualche loro parola di condanna nei confronti
di una squallida rappresentazione che, sì, offendeva le donne?”. Mai una critica
giunse dalle femministe sulla blasfemia grave commessa. Era l’8 marzo scorso. La
spigolatrice di Sapri in abiti succinti, aderenti, con le forme del corpo in
evidenza resta, intanto, dove sta: sul lungomare della cittadina in provincia
di Salerno. I commenti sulla pagina Fb di Giorgia Meloni mettono in luce
l’ipocrisia enorme di chi sta suscitando un finimondo: “È una statua bellissima,
ma perché queste donne se la prendono tanto; invece per quella pubblicità della
nuvenia che fanno sempre nelle ore quando si pranza o si cena tutti zitti
mah!!”. C’è l’ironico: “Beh…le critiche, leggo, arrivano da Cirinnà e
Boldrini…Eh…niente…fa gia ridere cosí”. Tra i commenti c’è chi fa un’esegesi
della statua oggetto di polemiche: “La donna mediterranea, ed in questo caso
cilentana, ha le forme. Non è una donna androgina. Cosa c’è di male? L’ autore
ha spiegato che il vestito è in movimento per rappresentare il vento e la brezza
marina”. Scrive un altro utente: “La sensualità, non ha epoca. Abiti succinti, e
diventa scandalosa? Ma perché la donna deve essere giudicata per questo?E si
dicono pure femministe?”. E a proposito dell’iscena rappresentazipne della
Madonna rappresentata come un vagina un’uutente di Fb sottolinea: “Non offendeva
solo le donne, quella manifestazione offendeva una religione, il pudore, la
sensibilità, chiunque non la pensasse come loro”. Ma allora tutte zitte. Le
femministe si scaldano a corrente alternata. Ricordiamo bene lo scempio accaduto
al quartiere Montesacro di Roma: dove un gruppo di femministe di due centri
sociali protestò contro il parroco dei Santi Angeli Custodi portando in
processione una Madonna a forma di vagina. La colpa di don Mario era di
essere «fascista ed omofobo» per essersi opposto al progetto di pedonalizzazione
di piazza Sempione. Che per chi non è della zona, prevedeva lo spostamento della
statua della Madonna che è lì da una vita.
Femministe fanno
la festa alla Madonna con una statua a forma di vagina. La Meloni: «Blasfemia».
Michele Pezza lunedì 8 Marzo 2021 su Il Secolo d’Italia. Un accordo in
extremis Peppone e don Camillo riuscirono trovarlo. Il Comune doveva costruire
otto alloggi popolari su un terreno ceduto dalla parrocchia su cui insisteva
l’antica edicola raffigurante la Madonna. Fallito ogni tentativo di disfarsene
con la forza, il sindaco comunista si rassegnò a inglobarla nella nuova
costruzione. Gli appartamenti si ridussero così a sette. E qui fu il parroco a
far la sua parte: gli spettava assegnare la metà degli alloggi, ma ne considerò
uno già occupato da un’Inquilina di suo gradimento. Questi erano i racconti che
il Grande Fiume affidava alla pena di Giovannino Guareschi in altri tempi e in
un’altra Italia. Ben diversa da quella di oggi, intossicata da ideologie di
pseudo-liberazione, il cui unico obiettivo è quello di riportare l’uomo nel suo
stato di natura. Non libero, ma primitivo. Basta vedere quanto accaduto al
quartiere Montesacro di Roma, dove un gruppo di femministe di due centri
sociali ha protestato contro il parroco dei Santi Angeli Custodi portando in
processione una Madonna a forma di vagina. La colpa di don Mario, subito bollato
come «fascista ed omofobo»? Essersi opposto al progetto di pedonalizzazione
di piazza Sempione che prevedeva lo spostamento della statua della
Madonna subito prima della scalinata della chiesa. E aver definito «uno scempio»
la bandiera Arcobaleno. Da qui la reazione femminista e la vigilia della festa
della donna trasformata in oltraggio alla Madonna. Era rosa shocking e a forma
di vagina quella portata in processione fino alla scalinata che porta al sagrato
della chiesa. Che cosa volessero dire con questa blasfema carnevalata è un
mistero che certamente svelerà uno di quei so-tutto-io che di solito troviamo
appollaiati nei talk-show o nelle pagine culturali dei giornali. Hanno una toppa
per ogni buco e beccano applausi ad ogni rammendo. Non da tutti, per fortuna.
«Qualcuno si sente rappresentato da questi personaggi che fanno
della blasfemia e del cattivo gusto una bandiera?», chiede Giorgia Meloni in un
post nel quale mostra la foto pubblicata su “Il Giornale” (in alto). In appoggio
alla leader di FdI anche Provita, associazione molto impegnata nelle campagne
antiabortiste: «Ma le donne poi, sarebbero solo la propria vagina?».
Il femminismo non
è bianco.
Djarah Kan su L’Espresso il 29 settembre 2021. Per rispondere
alla violenza patriarcale bisogna analizzare l’intersezione tra le varie forme
di discriminazione. E dare un nuovo volto alle battaglie: indigeno, nero,
messicano, arabo, magrebino, sudamericano. Sono cresciuta con l’immagine della
donna bianca emancipata e accattivante che si contrappone orgogliosamente a
quella della straniera del Terzo mondo, fragile, ignorante e incapace di
rispondere alla violenza del sistema patriarcale. Per come viene raccontato, il
femminismo sembra essere una roba da donne bianche. Un sistema di pensiero
troppo in là per queste donne del Terzo Mondo troppo impegnate a sfornare figli
e a badare alle galline in qualche sperduto villaggio semi deserto a Sud del
Mondo. Tutte le volte che le nostre madri africane ci accompagnavano a piedi
fino a scuola, portandosi le conseguenze della loro marginalizzazione sociale ed
economica alle spalle, così manifeste nella qualità dei libri e dei pessimi
vestiti usati che indossavamo, non potevo fare a meno di sentire addosso il
disprezzo e il pietismo con i quali le donne bianche, madri dei nostri compagni
di classe, guardavano alle nostre famiglie. A volte potevi persino sentirle
chiacchierare tra loro, chiedendosi come mai le nostre madri non facessero
niente per ribellarsi alla misera vita che conducevano. Poi magari tornavano
nelle loro case, e se lo spaghetto al sugo era leggermente più al dente del
solito venivano battute come un tappeto indiano, ma ho sempre pensato che l’idea
di essere bianca e più fortunata ed emancipata di una donna afghana o africana,
in qualche modo fungesse da lenitivo per tutte le botte e i divieti che il
patriarcato nostrano ti riserva. Per la serie «quando vuoi stare bene pensa a
chi sta peggio di te». Vivere alla occidentale è diventato un modo velatamente
razzista – ma nemmeno troppo velato – per affermare l’idea che solo
occidentalizzandosi, ovvero mettendo da parte la propria cultura in favore di
una migliore, noi selvaggi del Terzo mondo potremo considerarci a pieno titolo
delle proto-scimmie in giacca e cravatta che nel fine settimana giocano a golf e
la domenica vanno in Chiesa. Ma questo approccio alla questione di genere fuori
dai confini occidentali è stato anche il peccato originale del femminismo
liberale, che è sempre stato velenosamente bianco, razzista, e che con quel suo
sguardo paternalista non ha mai voluto considerare sufficientemente progressiste
o degne di nota le battaglie di tutte quelle storiche, filosofe, scrittrici,
attiviste e politiche non bianche considerate piuttosto come “sorelle minori un
po’ abbronzate” di una battaglia tutta da apprendere. Poi è arrivato il
femminismo intersezionale ed è tutto cambiato. Ad oggi l’approccio che analizza
l’intersezione tra le varie forme di discriminazione si presenta come la cura
più efficace contro il femminismo bianco che continua ad essere un sistema di
pensiero volente o nolente al servizio dell’imperialismo. Angela Davis, bell
hooks e Nawal El Saadawi sono solo alcune delle grandi assenti che figurano a
stento nel panorama mainstream del dibattito sul femminismo. Eppure è stato il
loro attivismo di accademiche e pensatrici instancabili, a strappare dalle mani
dell’ideologia razzista e coloniale un femminismo che veniva utilizzato come
giustificazione per le discriminazioni razziali di quanti sostenevano che
l’immigrazione dai Paesi in via di sviluppo era un pericolo soprattutto per le
donne. Ed è stata quella stessa mancanza di intersezionalità che porta il
femminismo a prestare il fianco all’ideologia razzista a trasformare Giorgia
Meloni, delfina del centro destra e instancabile islamofoba da manuale, nella
finta paladina dei diritti delle donne, arrivando a strumentalizzare in chiave
razzista, anti-immigrati e islamofoba il caso del femminicidio di Saman Abbas;
morta perché voleva liberarsi dal giogo di una famiglia che, con la scusa della
religione, aveva provato a fare della ragazza un dono per stringere un accordo
tra famiglie. Giorgia Meloni che si risveglia suffragetta, nonostante gli ideali
del suo partito deraglino totalmente dall’idea del mondo pensato da una
femminista intersezionale, è il risultato di un femminismo bianco, che senza le
donne del Sud è destinato ad essere totalmente cooptato dal patriarcato
suprematista bianco, un sistema di potere che era stata la stessa bell hooks,
scrittrice, sociologa e afroamericana ad individuare, partendo dalla sua storia
personale di bambina costretta a fare la spola tra la zona bianca e quella nera
della città, per andare a scuola. Il volto del femminismo è indigeno, nero,
messicano, arabo, magrebino, sudamericano. Non c’è futuro per il femminismo
senza le Marielle Franco, le Berta Càceres, le Losana McGowan, le Catherine Han
Montoya, le Guadalupe Campanur Tapia. Loro e le altre, tutte cadute per mano del
patriarcato armato. La lezione sull’intersezionalità, insegnata dalle donne del
Sud del Mondo all’Occidente tutto, salverà le donne bianche dalla loro stessa
bianchezza.
Gloria Steinem:
«Difendiamo i nostri diritti dai maschi bianchi al potere».
La legge del Texas
contro l’aborto. La deriva misogina polacca. La leader femminista americana
analizza il backlash contro le conquiste delle donne. E invita alla resistenza.
Francesca Sironi su L’Espresso il 30 settembre 2021. Dal primo settembre di
quest’anno gli abitanti del Texas sono invitati a segnalare cliniche, medici o
anche solo tassisti che si mostrino disposti ad aiutare donne che devono
abortire. Se la segnalazione ha successo, il cittadino-denunciante riceve un
premio di almeno 10mila dollari. Quest’invito a farsi polizia diffusa contro
l’aborto è uno degli aspetti inquietanti fra i molti della nuova legge che
impedisce le interruzioni volontarie di gravidanza in Texas, divieto che agisce
dopo la sesta settimana dalla fecondazione, senza eccezioni per stupro o
incesto. Sta succedendo ora, nel 2021, in una delle più grandi democrazie
dell’Occidente. Non in una dittatura o in un qualche Paese comunemente tacciato
di oscurantismo. In Europa lo stesso: dopo il partecipatissimo referendum che in
Irlanda ha introdotto il diritto all’aborto nel 2018, in Polonia le donne si
sono viste togliere quello stesso diritto a gennaio del 2021, nonostante le
oceaniche manifestazioni popolari degli anni scorsi per impedire che accadesse.
Il mondo non fa che ricordarci insomma che non c’è traguardo sociale che possa
esser dato per scontato. Non c’è vittoria civile di fronte alla quale non si
debba scegliere continuamente da che parte stare, e mobilitarsi per questa.
Essere partigiani. «La cosa positiva, che va sottolineata con forza ogni volta,
è che queste mobilitazioni popolari esistono. E che la maggioranza delle persone
è più aperta e inclusiva di quanto non voglia un manipolo di uomini bianchi che
continua a pretendere il potere sul corpo delle donne». Gloria Steinem è una
delle più famose leader del femminismo mondiale. La sua vita e le sue battaglie
sono state avanguardia e ispirazione per generazioni, a partire dagli anni ‘60.
Oggi a 87 anni è veloce e propulsiva come a trenta nel ragionare, durante una
video-intervista che le piace immaginare circolare, dice, anche se siamo in due,
ma circolare perché è interrogandosi alla pari che emergono nuove possibilità,
sulle conseguenze e le radici di quanto sta accadendo intorno al ruolo sociale e
politico delle donne. Steinem sarà a Firenze per l’evento di chiusura del
festival “L’Eredità delle Donne”, che si terrà dal 22 al 28 ottobre. Per
l’occasione la casa editrice Vanda pubblica una nuova edizione di uno dei suoi
bestseller, “Autostima. La rivoluzione parte da te”.
Cominciamo da quanto
sta succedendo in Texas. Come lo interpreta?
«Ci sono tre aspetti
che evidenzierei. Il primo: ci troviamo di fronte, di nuovo, a cosa accade
quando una manciata di uomini bianchi di potere possono esprimere liberamente i
loro sentimenti rispetto al controllo delle donne e delle facoltà riproduttive.
Il secondo: che la maggioranza è già andata avanti rispetto a questi temi. La
risposta popolare è stata enorme e diffusa. Tassisti texani hanno offerto le
corse per le donne che dovranno abortire in Stati vicini. È la natura della
legislazione a livello statale che permette a politici poco rappresentativi ed
eletti purtroppo con maggior indifferenza da parte dell’elettorato, rispetto a
quanto accade a livello centrale, di orientare la legge locale e avere effetti
di questo tipo».
C’è un tema
fondamentale di rappresentanza e di partecipazione politica quindi.
«Esatto, è il terzo
elemento cruciale per capire quello che sta succedendo. I governanti del Texas
in questo momento non rappresentano la maggioranza del loro Stato, così come è
stato per Trump. Siamo di fronte a una classe di potere minoritaria che non
accetta la nuova diversità del Paese. È una minoranza pericolosa di bianchi, al
comando, che non vuole fare i conti con il presente e il futuro della
popolazione: fra i nuovi nati i bambini di colore sono più numerosi dei bianchi.
E questa è una grandissima promessa, che ci permetterà di conoscere meglio il
mondo. Ma loro si rivoltano contro la nostra stessa popolazione. Lo stesso vale
per l’uguaglianza fra uomo e donna: è avanzata in moltissimi settori della
società, e per le nuove generazioni la solidarietà è enormemente più diffusa. Ma
ancora siamo di fronte a possibili leggi come quella in Texas».
Razzismo e politiche
anti-abortiste sono questioni così legate?
«Totalmente. Sto
lavorando adesso a un saggio che mette in luce come la primissima legge
promulgata da Hitler fosse la condanna dell’aborto quale crimine contro lo
Stato, e il controllo dei destini delle donne. Voleva che la popolazione bianca
si riproducesse a forza, mentre sterminava ebrei e persone di colore nei campi
di concentramento. Anche per Benito Mussolini la famiglia, intesa alla
riproduzione, era essenziale, e le donne dovevano solo produrre figli. Tutto
questo per via dell’utero: perché noi abbiamo l’utero e loro no. E allora
vogliono controllare le donne e le loro scelte, per costringerle».
Penso a papa
Francesco che ha detto pochi giorni fa che «l’aborto è un omicidio». Già nel
2018 d’altronde diceva che abortire «è come affittare un sicario». Fin dal
concepimento.
«Di fronte a frasi
come queste, bisogna ricordare che il papato non l’ha sempre pensata in questo
modo. Anzi. Fino a papa Pio IX - siamo nella seconda metà dell’Ottocento -
prevaleva la dottrina di Gregorio XIV, ripresa da Tommaso d’Aquino e da
Aristotele, secondo la quale il feto assumeva un’anima solo quando iniziava a
muoversi. Quindi non dal concepimento. L’interruzione volontaria di gravidanza
quindi era regolata, semplicemente. Non vietata del tutto. Penso che il cambio
di dottrina a riguardo sia stato una scelta politica, un accordo con Napoleone
III per forzare la popolazione a crescere, visto che c’era bisogno di giovani da
esercito».
È politica insomma.
Politica imposta sul corpo delle donne. E ogni volta, mascherata da argomento di
moralità. Ma decidere al posto di tutte le donne, di ogni singola donna di
fronte al suo corpo e al suo futuro, è morale? O politico, appunto?
«Penso a quanti
negli Stati Uniti si dichiarano anti-aborto e sostengono queste leggi, e poi
sono a favore della pena di morte. Non ha senso, evidentemente. A meno di non
accettare il paradosso per cui una vita “colpevole” vale meno».
E sono faglie di
fronte alle quali non tengono, a pensarci, le grandi divisioni fra Oriente e
Occidente, ad esempio, oppure fra una fede e l’altra, fra un sistema culturale e
un altro. Tiene solo la democrazia esercitata o la solidarietà. È così?
«La tendenza
egualitaria si trova dappertutto, così come la ricorrenza del potere, dei pochi
uomini intesi a controllare i corpi di tutte le donne. Penso all’Afghanistan: i
talebani sono un gruppo di suprematisti maschili. E allo stesso tempo, appunto,
la forza dell’egualitarismo attraversa i continenti. Io ho imparato il
femminismo in India, è lì che ho conosciuto le donne che supportavano Ghandi ma
anche si contrapponevano a lui su temi come la contraccezione e il controllo
delle nascite. È lì che ho capito che questa dinamica sul controllo dell’utero
era politica. Le stesse suffragette statunitensi impararono dalle donne native
americane le prime pratiche di controllo della fertilità e l’uso dei pantaloni
per muoversi. L’apporto delle identità e delle culture non-bianche nel movimento
femminista è assolutamente sotto-rappresentato. Ne ho avuto esperienza
personalmente».
In che senso?
«Da ragazza venni
messa sulla copertina di magazine e settimanali, come simbolo delle lotte
femministe. Non mi venne chiesto il permesso, ovviamente, ma il problema
principale era lo sforzo di alcuni media di caratterizzare il movimento delle
donne come un movimento bianco, quando le donne nere erano forse più numerose, e
più determinate, nei cortei. Ci fu una sorta di divisione: il movimento
femminista era rappresentato con donne bianche, quello per i diritti civili con
uomini neri. Così le donne nere che erano la maggioranza delle leader di
entrambi i fronti, scomparivano».
In Texas circa il 70
per cento degli aborti praticati nel 2019 era stato chiesto da donne di colore.
«C’è un enorme
problema di accesso alle cure, alle strutture mediche, agli strumenti di
prevenzione. Il Covid-19, se ci pensiamo, ci ha messo di fronte alla stessa
evidenza. Da una parte ha rivelato la natura arcaica dei confini nazionali,
aumentando la nostra percezione dell’essere parte di una umanità comune.
Dall’altra la differenza dell’impatto del virus e delle misure di restrizione
sulle diverse classi sociali è stata fortissima, e inaccettabile».
Fra le conseguenze
delle restrizioni per la pandemia, c’è stato anche l’aumento della violenza
domestica.
«Prima degli anni
‘70 la polizia che veniva chiamata a intervenire durante casi di violenza in
famiglia aveva come ruolo quello di convincere la coppia a tornare insieme.
C’era questa idea che la legge si fermasse sulla porta della famiglia. Adesso
siamo lontane: ci sono rifugi per le donne, le norme sono migliori, gli
strumenti a disposizione sono molti, ma dobbiamo continuare a investire, e
aumentarli. Dobbiamo formare nuove generazioni che abbiano vissuto in famiglie
diverse, e quindi possano cambiare il discorso pubblico, normalizzando la
parità».
È da casa che parte
tutto, no?
«È così. Solo se
bambine e bambini vengono educati a credere nella loro libertà, nelle loro
aspirazioni, a sentire se stessi come unici, non ci saranno più basi per il
patriarcato».
C’è chi dice che il
femminismo ha stufato, che se ne parla troppo, che ormai la parità è
dappertutto. Cosa rispondere?
«Beh, banalmente,
con una dose di realtà. Solo 26 Paesi hanno donne presidente. Gli Stati Uniti
hanno avuto un solo presidente di colore nonostante la popolazione. Le donne
leader, nelle organizzazioni come nelle aziende devono ancora vergognarsi di
essere sincere, semplicemente perché lo standard della leadership è
graniticamente maschile, e penso ad esempio al piangere quando si è arrabbiati o
alle dinamiche di tempo e potere. C’è una cosa che ho imparato in questi anni di
insegnamento, ad esempio, ed è quella del mettersi in cerchio, di ripartire da
un discorso alla pari, lasciarci alle spalle il modello frontale della Chiesa,
dove delle persone guardano un ragazzo con una gonna che parla da un palco o da
pulpito accentrando su di sé il potere di parola. È condividendo questo potere
che cambieremo».
La rete delle
“zie d’Europa” che aiuta chi non può abortire in sicurezza.
Finanziano viaggi,
spediscono farmaci. A chi le contatta dalla Polonia, da Malta, ma ultimamente
anche dall’Italia. E risparmiano a tante giovani i rischi della clandestinità.
Claudia Torrisi su L’Espresso il 30 settembre 2021. Ai primi di settembre la
Corte Suprema degli Stati Uniti ha reso sostanzialmente illegali la quasi
totalità degli aborti in Texas, decidendo di non bloccare la legge che vieta
l’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) oltre la sesta settimana. È
l’ennesimo atto di una guerra all’aborto che viene da lontano, ma che è
tutt’altro che localizzata. Anche in Europa si contano Stati con normative molto
restrittive, e altri in cui l’accesso è molto limitato. Malta è il paese con la
legislazione più dura: l’aborto è illegale in ogni circostanza e senza
eccezioni, con una pena fino a tre anni di carcere. Interrompere volontariamente
una gravidanza è vietato anche nei piccoli Stati di Andorra e Liechtenstein. A
San Marino e a Gibilterra l’aborto è stato recentemente depenalizzato grazie al
voto popolare, ma le maglie restano strettissime. E poi c’è la Polonia, dove
nell’ottobre del 2020, dopo diversi tentativi parlamentari, una sentenza della
Corte Costituzionale ha ulteriormente ridotto l’accesso all’Ivg, eliminando i
casi di gravi malformazioni fetali (che costituivano la gran parte di quelle
censite). A questi si aggiungono paesi come l’Irlanda, l’Ungheria o la Romania,
dove l’aborto seppur legale è di difficile accesso. O l’Italia, con l’altissimo
tasso di obiezione di coscienza e gli ostacoli al metodo farmacologico,
specialmente durante la pandemia. I divieti, le restrizioni e le difficoltà,
però, non hanno mai fermato gli aborti. Negli ultimi anni si è formata una rete
di gruppi che garantiscono informazioni, finanziamenti e supporto per
organizzare i viaggi delle donne che devono abortire verso Paesi dove è
possibile farlo in sicurezza o per permettergli di farlo in casa grazie alla
telemedicina. Mara Clarke, trasferitasi in Inghilterra nel 2005 dagli Stati
Uniti (dove c’è una lunga tradizione in questo senso), è una pioniera in Europa:
nel 2009 ha fondato Abortion support network, un’associazione non profit per
finanziare i viaggi delle donne da Irlanda, Irlanda del Nord, Isola di Man e
recentemente Gibilterra e Malta per abortire nel Regno Unito, dove il limite per
l’Ivg è di 24 settimane. Nel 2020 si sono rivolte all’organizzazione circa 780
persone. «Le legislazioni restrittive sull’aborto non hanno effetti sulle
persone ricche, ma su quelle più povere o marginalizzate. Quello che facciamo è
aiutare chi ne ha bisogno ad accedere all’aborto, specialmente nel secondo
trimestre di gravidanza. Suona come una cosa facile, ma ci sono molti ostacoli»,
spiega Clarke. Gli ostacoli a cui si riferisce riguardano ad esempio i documenti
di viaggio, situazione peggiorata con Brexit, o le condizioni particolari delle
donne che devono spostarsi: alcune escono da una relazione violenta o vivono con
un partner controllante, la maggior parte ha già dei figli. E poi la pandemia,
con tutte le limitazioni. Abortion support network opera ufficialmente con
alcuni Paesi, ma secondo la sua fondatrice l’organizzazione «è pronta ad aiutare
chiunque, caso per caso». Nel dicembre 2019 ha aperto anche alla Polonia,
lanciando insieme ad attiviste di cinque organizzazioni con sede in diversi
Paesi d’Europa l’iniziativa Abortion without borders. Le richieste arrivano a
una helpline gestita da volontarie che da anni lavorano per diffondere
informazioni corrette sulla salute riproduttiva in Polonia. Da qui, a seconda
della settimana di gestazione, le utenti vengono smistate tra gruppi che
organizzano viaggi in altri Paesi europei e Women help women, una non profit che
si occupa di fornire consulenza e assistenza medica per l’aborto farmacologico
in telemedicina nei Paesi in cui l’Ivg è illegale, inviando le pillole a casa.
Nel 2021 le richieste finora arrivate ad Awb sono state 4.135. La speranza di
Clarke è che sorgano sempre più gruppi di questo tipo, così come sta accadendo
negli ultimi anni soprattutto ad opera di attiviste polacche. «Siamo un esercito
in crescita», commenta. Esiste una rete di collettivi, alcuni dei quali nati
dopo la decisione della Corte Costituzionale di Varsavia dello scorso ottobre,
con nomi simili tra loro: Ciocia Basia (che fa parte di Abortion without borders
e ha sede a Berlino), Ciocia Frania (a Francoforte), Ciocia Monia (a Monaco di
Baviera), Ciocia Wienia (a Vienna), Ciocia Czesia (Repubblica Ceca). «Ciocia»
significa «zia» in polacco e quello che queste volontarie fanno è mettere a
disposizione contatti, informazioni, organizzare supporto psicologico, prendere
appuntamenti e aiutare anche economicamente chi ne fa richiesta ad accedere
all’aborto in Germania, Austria o Repubblica Ceca, paesi con normative più
elastiche. La stessa attività viene svolta da Abortion network Amsterdam
(anch’essa nel network di Awb) con sede nei Paesi Bassi, dove la legislazione
permette l’Ivg fino a 22 settimane. «La maggior parte delle persone che ci hanno
contattato venivano dalla Polonia, ma abbiamo ricevuto richieste anche da Stati
molto lontani», spiega Kasia, una delle volontarie. Tra le utenti ci sono anche
donne immigrate o senza documenti. Altre organizzazioni si occupano di aborto
farmacologico in telemedicina, nelle prime settimane di gravidanza. Oltre a
Women help women, è attiva Women on web, non profit fondata nel 2005
dall’attivista olandese Rebecca Gomperts. «L’Europa costituisce almeno metà del
traffico delle email che riceviamo, parliamo di almeno 70 mila email all’anno.
Ci contattano soprattutto da Polonia, Malta, Irlanda. Occasionalmente anche da
Paesi in cui l’aborto è legale, ma le persone non hanno accesso alle strutture
per varie ragioni: questioni di documenti, privacy, situazioni di violenza.
Alcune mail sono arrivate anche dall’Italia, specialmente durante la pandemia»,
afferma Kinga Jelinska, co-fondatrice e direttrice esecutiva di Women help
women. «L’equivoco è pensare che se l’aborto è legale, allora va tutto bene. Ma
più che alle normative, bisognerebbe guardare quante persone riescono ad
accedere: ci sono posti con buone leggi e un pessimo accesso al servizio».
Il delirio della Murgia:
vietato ringraziare le mogli.
Roberto Vivaldelli il 13
Settembre 2021 su Il Giornale. Per la nota scrittrice, il mito della musa
ispiratrice è uno dei "fondamenti essenziali dell’immaginario del patriarcato".
Gli uomini che dedicano un premio alla moglie come Benigni sottolineano di aver
raggiunto traguardi "preclusi alle donne". I maschi devono stare attenti, d'ora
in poi: perché dietro un semplice "grazie" può nascondersi, in realtà, una
concezione discriminatoria della donna figlia della società patriarcarle. Se
nella vostra carriera avete raggiunto un traguardo importante e volete
ringraziare pubblicamente per il sostegno la vostra moglie, fidanzata o amante,
attenzione: potrebbe trattarsi di un traguardo precluso alla vostra metà. A
sostenere questa bizzarra tesi è la scrittrice Michela Murgia, che ha preso in
esame la dedica alla moglie di Roberto Benigni al Festival del Cinema di
Venezia. Il problema, in questo caso, non sono le accuse di plagio o le
citazioni nascoste Jorge Luis Borges ma, secondo Murgia, il concetto stesso di
musa ispiratrice. Roba da Medioevo. "Il mito della musa ispiratrice, scrive
Murgia in un articolo pubblicato su L'Espresso, "creatura ultraterrena che nel
segreto guida l’uomo alle imprese epiche", è uno dei "fondamenti essenziali
dell’immaginario del patriarcato". Il racconto della donna in ombra, che con la
sua "silente forza sostiene il percorso luminoso del suo compagno", è retto da
due "pilastri retorici" che Benigni, certamente in buona fede, ai microfoni
veneziani ha "evocato alla perfezione". Il primo di questi "dispositivi retorici
si può sintetizzare nella frase" devo tutto a te. È molto frequente che gli
uomini che raggiungono un traguardo personale affermino pubblicamente che senza
la loro compagna non ci sarebbero mai arrivati". Sembra un riconoscimento, ma in
realtà, spiega la Murgia, specie in un contesto come quello cinematografico,
dove "le donne non hanno mai avuto le stesse possibilità di emergere dei loro
colleghi o compagni" è la "dimostrazione plastica della sua negazione". In un
sistema dove le "donne possono dare luce, ma mai avere luce, se non riflessa",
devo tutto a te equivale a dire "mi sto intestando per intero quello che in un
mondo equo avremmo dovuto dividere". Si può dire tutto di Roberto Benigni, si
può apprezzare o meno come artista, ma non c'è nulla di male né di
potenzialmente discriminatorio in ciò che ha detto e nelle parole d'amore per la
moglie. Quella della Murgia è una dietrologia inutile e senza né capo né coda:
chi lo dice che che dietro a quel "grazie" vi siano traguardi irragiungibili
dalle donne? Nicoletta Braschi ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti nella sua
lunga e proficua carriera di attrice tanto da non invidiare quasi nulla al
merito e di sicuro non ha mai vissuto di "luce riflessa". È la realtà stessa a
smentire l'assurda teoria di Michela Murgia e la sua ossessione per il
patriarcato. Sembra quasi che tutto ciò che fanno gli uomini sia sbagliato a
prescindere - persino dire "grazie" - o sia il riflesso di una società
maschilista che ai salotti delle femministe progressiste non piace. Pazienza.
Roberto Vivaldelli. Roberto
Vivaldelli (1989) è giornalista dal 2014 e collabora con IlGiornale.it, Gli
Occhi della Guerra e il quotidiano L'Adige. Esperto di comunicazione e relazioni
internazionali, è autore del saggio Fake News. Manipolazione e propaganda
mediatica dalla guerra in Siria al Russiagate pubblicato per La Vela. I suoi
articoli sono tradotti in v
Cosa si nasconde dietro
quel “grazie”.
Michela Murgia su L'Espresso il 13 settembre 2021. Gli uomini che
dedicano, come Benigni a Venezia, un premio alla moglie sottolineano in realtà
che hanno raggiunto traguardi preclusi alle donne. C’è una storiella che si
raccontava negli Stati Uniti durante la presidenza Obama. Narra di come, durante
uno dei viaggi della coppia presidenziale in giro per gli stati del nord,
Michelle e Barack si siano fermati a mangiare in un grosso fast food, cibo di
cui colpevolmente il presidente, in barba alle campagne da lui stesso promosse
per l’alimentazione corretta, andava in realtà ghiotto. A servirli venne il
padrone in persona e Michelle riconobbe in quell’uomo un ex compagno di liceo
con cui aveva avuto un flirt. Dopo una breve conversazione in cui i due si
ricordarono scherzosamente a vicenda i trascorsi, la storiella vuole che Obama,
rimasto solo con la moglie, abbia commentato dicendo: «pensa, se avessi sposato
lui, oggi saresti la padrona di questo fast food». «Non credo. Se lo avessi
sposato», replicò Michelle sorridendo, «oggi sarebbe lui il presidente».
L’aneddoto, vero o falso che sia, ha una sua efficacia retorica e a
raccontarmelo fu una donna tutta orgogliosa, suggerendomi di servirmene come
esempio per spiegare l’empowerment femminile. Non ebbi il coraggio di dirle che
piuttosto era vero il contrario: se c’è una cosa che questa storiella spiega
bene è proprio il modo in cui nel sistema patriarcale le donne sostengono e
rafforzano il potere degli uomini. Non a caso mi è tornata in mente quando
Roberto Benigni, ritirando a Venezia il leone d’oro alla carriera, ha
ringraziato la moglie Nicoletta Braschi nel suo discorso di accettazione. Al
netto dell’entusiasmo coniugale di Roberto Benigni, della cui genuinità nessunə
dubita, dal punto di vista della rappresentazione pubblica del rapporto
uomo-donna le parole dell’attore riproducono un cliché secolare, quello della
grande donna dietro al grande uomo, dove la parola che fa scattare il meccanismo
tossico non è “grande”, ma “dietro”. Il mito della musa ispiratrice, creatura
ultraterrena che nel segreto guida l’uomo alle imprese epiche, è uno dei
fondamenti essenziali dell’immaginario del patriarcato. Il racconto della donna
in ombra, che con la sua silente forza sostiene il percorso luminoso del suo
compagno, è retto da due pilastri retorici che Benigni, certamente in buona
fede, ai microfoni veneziani ha evocato alla perfezione. Il primo di questi
dispositivi retorici si può sintetizzare nella frase «devo tutto a te». È molto
frequente che gli uomini che raggiungono un traguardo personale affermino
pubblicamente che senza la loro compagna non ci sarebbero mai arrivati. Sembra
un riconoscimento, ma in realtà - specie in un contesto come quello
cinematografico, dove le donne non hanno mai avuto le stesse possibilità di
emergere dei loro colleghi o compagni - è la dimostrazione plastica della sua
negazione. In un sistema dove le donne possono dare luce, ma mai avere luce, se
non riflessa, «devo tutto a te» equivale a dire «mi sto intestando per intero
quello che in un mondo equo avremmo dovuto dividere». Se accade una volta è
romantico e ci si può anche commuovere. Se però accade tre volte al giorno in
tutti gli ambiti di riconoscimento, diventa necessario chiedersi perché le donne
siano sempre le persone ringraziate per i premi altrui e mai quelle che
ringraziano per i propri. Il secondo meccanismo retorico di questa narrazione è
conseguenza diretta del primo: è quello che racconta il genio femminile, o - per
dirla con le parole di Benigni nel suo discorso - l’enigma della femminilità,
che vuole che le donne siano creature che «hanno qualcosa che noi uomini non
comprendiamo, un mistero senza fine». Il pregiudizio che le donne siano esseri
alieni che procedono per vie incomprensibili, oltre ad apparentare gli uomini
alla semplicità degli organismi unicellulari che evidentemente non sono, le
porta in un empireo dove esse possono solo ispirare, mai agire. La storiella
perfetta non è quindi quella in cui una donna straordinaria fa diventare
presidente o premio Oscar qualunque uomo finisca per sposare. È quella in cui
nessunə trova romantico vivere in un sistema dove una donna viene ringraziata
per aver fatto raggiungere a un uomo traguardi che a lei sono negati.
FRANCESCO BORGONOVO per la
Verità il 12 settembre 2021. Una settimana fa era stato il settimanale
britannico The Economist a lanciare l'allarme riguardo l'ascesa della «sinistra
illiberale», che ampia riempirsi la bocca con i diritti ma, alla prova dei
fatti, si rivela più propensa che mai alla censura. Ebbene, forse è ora che
qualcuno si accorga dell'esistenza del fenomeno (e della sua pericolosità) anche
dalle nostre parti, soprattutto dopo quanto accaduto al Festival della
letteratura di Mantova. La nota kermesse letteraria aveva in programma un
incontro con Rebecca Solnit, autrice femminista americana divenuta celebre per
l'invenzione del «mansplaining». In un libro che ha avuto grande successo,
denunciava una orribile discriminazione: gli uomini sono così arroganti e
sessisti che pretendono di «spiegare le cose» alle donne. A quanto pare, però,
la suscettibile autrice ha lo stesso vizietto: pretende di spiegare le cose agli
altri (maschi e femmine) senza accettare non soltanto il contraddittorio, ma
persino una normalissima interlocuzione. La faccenda si è svolta più o meno
così. Gli organizzatori del Festival di Mantova avevano chiesto a Marina
Terragni, nota intellettuale femminista, di presentare la Solnit al pubblico e
di intervistarla. La Terragni ha accettato, e si è preparata per l'incontro,
previsto ieri sera. La Solnit, come spesso fanno gli intellettuali radical, si è
mostrata parecchio esigente. Ha chiesto che le fosse mostrata in anticipo la
lista delle domande che le sarebbero state poste durante l'intervista, ed è
stata accontentata. Poi, però, alcune ore prima di andare in scena ha fatto
sapere ai vertici del Festival che non si sarebbe fatta intervistare: si sarebbe
limitata a tenere un discorso, rispondendo alla fine a una domanda dal pubblico.
Qual è stato il problema? Semplice: la presenza di Marina Terragni. Come i
nostri lettori sanno, Marina da anni conduce battaglie molto coraggiose contro
l'utero in affitto, per la modifica del ddl Zan e contro le derive del
cosiddetto «transfemminismo». Combatte, da sinistra, l'ideologia Lgbt,
rifiutandosi di accettare il dogma secondo cui un transessuale sarebbe una donna
a tutti gli effetti. Ecco, questo è il motivo per cui la Solnit non l'ha voluta
accanto a sé. In alcune mail private inviate agli organizzatori mantovani, la
simpatica Rebecca ha indicato la Terragni come una pericolosa «Terf», acronimo
che sta per «femminista radicale trans escludente». Capito? Poiché la Terragni
sostiene che un uomo operato non sia una donna, non deve avere diritto di
parlare, deve essere considerata una razzista e messa a tacere.«Per "chiamare le
cose con il loro nome" (citando un titolo di Solnit), il nome di questa cosa è
"bavaglio" e non somiglia affatto a quello che lei scrive nei suoi saggi», ha
commentato la Terragni. «Li ho letti tutti anche se non potrei dire che Solnit
sia esattamente la mia passione. Ma Solnit è certamente una voce eminente, gode
di un grande seguito, e mi era sembrato interessante poter dialogare con lei.
Abbiamo esperienza del no-debate praticato con fermezza dal mondo Lgbtq,
l'abbiamo sperimentato anche in Italia con i sostenitori del ddl Zan che si sono
metodicamente sottratti a ogni confronto: ma da Rebecca Solnit non me lo sarei
aspettato». Purtroppo, come sempre più spesso avviene, chi cerca il dialogo e il
confronto viene puntualmente respinto. Gli intellettuali come la Solnit, grandi
sostenitori della massima libertà per la galassia arcobaleno, fanno di tutto per
togliere spazio a chi dissente, e nella gran parte dei casi ci riescono, come
dimostrano innumerevoli storie che arrivano da Stati Uniti e Inghilterra. Nel
mondo anglosassone lo chiamano «no platforming», noi preferiamo chiamarla
censura. E forse i responsabili del Festival di Mantova avrebbero dovuto
mostrare un poco più di coraggio, e rifiutare di far parlare Rebecca Solnit: o
il confronto o niente. Bisogna smettere di farsi dare lezioni di tolleranza
dagli intolleranti, non è più possibile permettere ai razzisti del pensiero come
la Solnit di accusare gli altri di razzismo. L'Economist, ad esempio, rifiuta di
utilizzare il termine Terf. Lo considera offensivo, e non tollera che gli
attivisti trans lo usino per intimidire i loro nemici. Il Guardian, notoriamente
schierato a sinistra, ha preso una posizione leggermente diversa in una vicenda
che ha riguardato un'altra illustre portavoce della Cattedrale del Politicamente
corretto: Judith Butler, la madrina del gender.Nei giorni scorsi, il quotidiano
britannico ha pubblicato una intervista alla Butler firmata da Jules Gleeson.
Già il titolo era raccapricciante: «Dobbiamo ripensare la categoria di donna»
(la cara Judith, tra le altre cose, pretende che con la parola «donna» si
indichino anche maschi operati). Il contenuto della conversazione, ovviamente,
era anche peggio, ma nessun intellettuale vip ha pensato di indignarsi per le
scemenze proferite dalla Butler. A risentirsi invece è stata proprio lei, la
Madre Superiora della Cattedrale. Proprio così: la Butler ha frignato di essere
stata censurata dal Guardian e immediatamente la notizia ha fatto il giro del
mondo, ripresa con un certo sussiego anche dal Corriere della Sera. In effetti,
i redattori del Guardian hanno ritenuto di tagliare un passaggio
dell'intervista. Diceva così: «L'ideologia anti-gender è uno dei ceppi dominanti
del fascismo dei nostri tempi. Quindi le femministe radicali trans escludenti
non faranno parte della lotta contemporanea contro il fascismo». La frase era
evidentemente insultante e violenta verso le presunte Terf, ma il Guardian non
l'ha tolta per questo. L'ha levata perché faceva parte di una risposta più ampia
riferita a una storia che ha suscitato parecchio scalpore negli Usa. Si tratta
del cosiddetto «Wi Spa Incident»: una donna di Los Angeles ha pubblicato un
video, divenuto virale, dichiarando che un maschio si aggirava nella zona
riservata alle donne con il pene in bella vista. Come è facile intuire, si
trattava di un trans che, seppur dotato di genitali maschili, si è riservato il
diritto di stare nudo nell'area femminile. Nella conversazione incriminata,
Judith Butler ha presentato il caso della «Wi Spa» come un esempio
dell'intolleranza dei fascisti omofobi e transfobici. Sia lei che la sua
intervistatrice, tuttavia, si sono dimenticate di dire che il trans «vittima di
odio» era in realtà un signore di 52 anni registrato nelle liste dei «sex
offender» e con due condanne per atti osceni alle spalle. È per questo che il
Guardian ha eliminato un passaggio dell'intervista: per evitare di difendere un
molestatore con la scusa della battaglia contro l'accusa di transfobia.Comunque
sia, la censura inesistente subita da Judith Butler ha ottenuto titoloni. Quella
vera subita da Marina Terragni ne otterrà molti meno. Tocca prenderne atto:
viviamo in un modo in cui i molestatori sono trattati da vittime e gli
intellettuali seri sono considerati molestatori.
Annalisa Chirico
contro Michela Murgia: "Voi indignate con Berlusconi dove siete ora coi
talebani?" Annalisa
Chirico su Libero Quotidiano il 18 agosto 2021. Se non ora quando? Quale sarà il
momento giusto per dire che il patriarcato islamista fa a pugni con i diritti
delle donne, che non c'è spazio per compromessi con chi intende imprigionare il
corpo delle donne in un sudario di pietra? Se non scendiamo in piazza adesso, a
Roma come a Parigi e a Londra e a New York, per protestare contro il ritorno dei
barbuti, quale sarà il momento giusto? Forse quando sarà troppo tardi. In questi
giorni di immagini da Kabul, di conferenze stampa in mondovisione, di uomini
ammassati attorno agli aerei in partenza, sui carrelli e sulle ruote, di uomini
che cadono dagli aerei in volo, le donne afghane sono le grandi assenti, come
tutte le grandi vittime della storia. Le donne afghane non si mostrano, anzi si
nascondono in attesa di capire che cosa riserverà loro il destino, e le donne
occidentali più valorose in battaglie epocali come quella sulle desinenze da
declinarsi rigorosamente al femminile si chiudono in un silenzio ipocrita e
colpevole. In alcuni casi, forse, contano le aperte simpatie per gruppi
terroristici come Hamas che ha accolto trionfalmente la restaurazione talebana,
di certo conta la prudenza di chi teme le accuse di razzismo e islamofobia.
ONTOLOGICAMENTE INFERIORI - Il
risultato è il silenzio, il "missing in action" che unisce insieme le femministe
per comodità e i ministri degli Esteri che nei giorni della crisi se ne stanno a
mollo in acque pugliesi (è il caso dello spensierato Di Maio) o in acque
cipriote (assai gradite all'omologo britannico Raab). Le donne afghane non si
vedono, stanno mute e nessuno parla per loro, neanche le pseudofemministe in
servizio permanente effettivo, quelle pronte a fare tanto rumore per difendere
le donne occidentali che, per fortuna nostra, sono libere di vivere come
vogliono, di andare a scuola e di lavorare, di abbronzarsi in topless, di
scegliere se e quando copulare con qualcuno, per amore o peraltre ragioni. Le
pseudofemministe che affollavano le piazze contro il Cav e firmavano articolesse
agguerritissime, assecondando la narrazione delle giovani vergini vittime del
Caimano (risate), sembrano ignare di ciò che accade in Afghanistan; forse le
signore non aprono i giornali, forse non guardano la tv, eppure sarebbe questo
il momento di scendere in piazza contro il ritorno del patriarcato talebano che
a Kabul, prima dell'arrivo degli occidentali nel 2001, governava
ininterrottamente da quindici anni. Con il ritorno dei barbuti al potere, torna
la sharia, il primato della legge coranica, che considera la donna un essere
ontologicamente inferiore. Vent' anni di presenza militare, di soldati morti
ammazzati, di ingenti risorse investite on the ground non hanno realizzato una
struttura statuale accettata e sostenuta dagli afghani ma hanno postole
condizioni per un sistema di vita rispettoso dei diritti di donne e bambine. Il
diritto all'istruzione, a girare in istrada con il capo scoperto e senza
l'obbligo di un guardiano maschile, il diritto al lavoro e alle cure mediche, la
libertà di indossare i tacchi con le caviglie in bella mostra, tutte queste cose
bellissime, per noi occidentali così dannatamente scontate, erano tornate realtà
in Afghanistan grazie a una guerra imperfetta ma giusta. Adesso, le lancette
della storia tornano indietro, le afghane piangono in preda alla paura di subire
violenze, soprusi, matrimoni forzati, e le intellò occidentali sembrano guardare
da un'altra parte.
UN PAESE «LIBERATO» - Nella
prima conferenza stampa in mondovisione, i barbuti affermano, con orgoglio, di
aver "liberato" il Paese, in effetti hanno ragione: costoro liberano il Paese
per imprigionare le donne, liberano il Paese per legittimare agli occhi del
mondo una visione teologicamente totalitaria della società. Di fronte allo
scempio dei diritti e della democrazia, è il momento di scendere in piazza, di
mobilitare l'opinione pubblica internazionale affinché i governi occidentali si
uniscano nella condanna unanime dell'occupazione afghana e dicano chiaramente
che mai il regime degli usurpatori avrà un riconoscimento internazionale. Mai
alcun compromesso sarà possibile con i talebani che a parole aprono alla
presenza di donne nel governo ma "sotto la sharia", puntualizzano. Se la Cina è
pronta ad integrarli nella via della Seta, l'Occidente sta da un'altra parte. La
legge islamica è incompatibile con i diritti delle donne, l'identificazione tra
legge di dio e legge dello stato fa a pugni con lo stato di diritto. Non sarà
allora qualche presenza femminile in un futuro esecutivo a legittimare il potere
fondamentalista che sogna il nuovo Emirato islamico nella ex centrale del
terrore. Con i talebani a Kabul, nessuno di noi può dirsi al sicuro.
Michela Murgia per “La
Stampa” il 23 agosto 2021. Se qualcuno ci dicesse che ci offrirà un'ora d'aria
purché da domani andiamo a vivere in galera, chi di noi accetterebbe? Se gli
stessi che abbiamo visto uccidere i nemici politici, perseguitare le minoranze e
violentare le donne per sottometterle ci promettessero col mitra in mano che da
domani smetteranno, noi gli crederemmo? Se la risposta ovvia è no, è facile
immaginare lo stato d'animo di chi da Kabul ha sentito i tagliagole talebani
dichiararsi pronti a garantire un governo inclusivo e diritti alle donne, purché
«in accordo» con quello sgorbio dell'islamismo che è la Sharia. Le diplomazie
europee stanno però già facendo finta di crederci, perché la realpolitik vince
su ogni altra logica quando c'è di mezzo un territorio ricco e strategico come
l'Afghanistan. Non appena è partita la smobilitazione militare e la storiella
dei liberatori occidentali si è rivelata per la panzana che era, in meno di due
settimane lo scenario politico ha mostrato tutte le possibili sfumature
dell'ipocrisia e del cinismo, tanto in Afghanistan quanto nei nostri parlamenti.
I taleban che ora hanno preso Kabul detenevano già il controllo di metà del
paese e in questi anni lo hanno governato indisturbati secondo i loro principi,
nella piena consapevolezza degli occupanti occidentali, che sapevano benissimo
che le donne afghane nelle zone rurali il velo dalla faccia non lo hanno mai
potuto togliere. Ora che i taleban sono dichiaratamente i nuovi padroni, con
loro si tratterà anche sulla pelle delle donne, tanto i nostri eserciti non
erano andati certo là per promuovere l'emancipazione delle afghane. Se è vero
che la democrazia non si esporta, ma si testimonia, verrebbe da pensare che la
testimonianza occidentale in Afghanistan debba essere stata veramente poca cosa
se dopo dieci anni una parte non piccola della popolazione ha più voglia di dare
credito ai taleban piuttosto che ai nostri governi. I numeri che conosciamo ci
dicono il perché: dei miliardi occidentali investiti in Afghanistan, solo il 10%
ha finanziato infrastrutture e progetti di sviluppo. La quota restante è servita
a comprare armi per rafforzare i corrotti poteri locali, quelli che si sono dati
alla fuga appena gli eserciti stranieri hanno levato le tende. A noi, cittadini
atterriti dallo scenario di oppressione che si prospetta, resta solo la
solidarietà fattiva e la pressione sulle istituzioni perché accolgano quanti più
esuli è possibile. A chi invece in questi giorni dalle file della destra
nostrana ha gridato «dove sono le femministe?», Linda Laura Sabbadini ha
risposto ieri da queste pagine con la consueta forza e precisione: sono dove
sono sempre state, cioè a cercare di fortificare le reti internazionali delle
donne, le associazioni contro la violenza e le Ong che con i loro progetti di
educazione e di empowerment hanno reso possibile un futuro per donne e bambine
che altrimenti non lo avrebbero mai avuto. Non hanno tempo, le femministe, per
curare anche la strana malattia intermittente del sovranismo locale, che si
manifesta invocandole quando c'è da criticare gli abusi stranieri, ma
sbeffeggiandole in tutte le circostanze in cui si occupano degli abusi in casa
nostra. Le penne che in queste ore hanno provato a depotenziare il lavoro delle
donne italiane a sostegno delle afghane sono le stesse che tutti i giorni dai
loro social e testate irridono alla richiesta di pari opportunità e alle lotte
contro violenza, obiezione all'aborto, linguaggi sessisti e divario salariale.
Non è un caso: come una matrioska, la cultura patriarcale ha gabbie che variano
di dimensione a seconda del luogo e dei tempi. La forma però, a Kabul come a
Roma, la riconosci sempre.
Fabrizio Boschi per “il Giornale” il 23 agosto
2021. Dallo chador al menefreghismo è un attimo. Facile attaccare il politico o
il volto famoso di turno. Ma se c'è da muovere le labbra per la violenza dei
talebani, il burqa, l'islam, la sharia e i diritti delle donne (e madri) afghane
violati, allora scatta il silenzio, anzi peggio, si fa finta di niente. Le
femministe di Mee too, sempre pronte a scendere in piazza con i soliti slogan e
a dare battaglia, sono in ferie. Dalle loro barche, dalle spiagge private in
Sardegna o a mollo nelle spa in montagna, hanno perso il loro proverbiale
scilinguagnolo e stanno ferme a guardare in tv le orrende immagini provenienti
da Kabul. Da parte delle femministe di sinistra sono arrivati solo messaggi di
opportunità: «aiutiamo le donne afghane», «apriamo a corridoi umanitari»,
«accogliamole». Da loro ci aspettavamo una rivoluzione femminile in piena regola
e, invece, niente. Nessuna levata di scudi. Nessun sermone sui diritti e le
libertà violati. Cosa fa ad esempio per l'Afghanistan la pasionaria palestinese
Rula Jebreal dai suoi palazzi dorati di New York? Pronta ad indossare l'abito da
sera sul palco dell'Ariston per sentenziare contro i maschi che sfruttano le
donne ma altrettanto decisa nello scaricare le colpe su altri: «La destra ha
appoggiato e finanziato questa guerra. Le femministe non la volevano. Questo è
un fallimento di tutto l'Occidente, non delle femministe». E dov' è in questi
giorni la rossa di capello e di idee Fiorella Mannoia? In tour con «Padroni di
niente», sempre pronta a fare politica dai suoi palchi, l'unica voce che tira
fuori adesso è quella per cantare le sue canzoni. Niente in favore delle donne
afghane ad eccezione di qualche tweet di circostanza. Dalle pagine del Giornale
Maria Elena Boschi fa appello alle compagne: «Vorrei che si facessero sentire»,
lamentando lei stessa questo imbarazzante silenzio. E che dire dell'ex
presidenta della Camera Laura Boldrini, che ha fatto dello chador il suo secondo
abito negli anni in cui lavorava per l'Alto commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati, pronta a stracciarsi le vesti per i diritti delle donne e
adesso fuggevole, se si esclude la sua partecipazione alla festa dell'Unità di
Grottammare per parlare della parità di genere insieme alla deputata Pd Patrizia
Prestipino. Tutto si riduce ad un mieloso tweet: «Conosco e amo l'Afghanistan.
La presenza militare multinazionale non è mai stata la soluzione. Penso alle
minoranze, alle donne: che ne sarà di loro?». Anche Lucianina Littizzetto ha
smesso di farci piangere con i suoi monologhi faziani e al Mee too per le donne
preferisce il relax in Costa Azzurra. Lo stesso per il volto Rai Giovanna
Botteri, corrispondente da Pechino, che dopo aver difeso il diritto alla sua
capigliatura poco curata, non trova parole per tutto il resto. Battagliere per
discussioni marginali, si fermano davanti alla regina di tutte le lotte che la
Storia offre loro. Più facile indignarsi per le performer alla festa di Diletta
Leotta, per i testi di Sfera Ebbasta e per il ddl Zan che per le donne afghane.
Pure la femminista chic Michela Murgia tace. E per una che fa la scrittrice e si
è sempre spesa come attivista della parità di genere e dell'antifascismo, ciò
stride un po'. «Bella ciao» è ciò che ha detto Joe Biden, idolo della sinistra
italiana, alle afghane dopo averle lasciate nelle fauci dei talebani. A Kabul
stilano gli elenchi delle donne non sposate per scegliere che carne dare in
pasto ai generali e qui sembra di assistere alla scena del Titanic quando ad un
elegante lord viene offerto il giubbotto di salvataggio e lui gentilmente lo
rifiuta: «No grazie, siamo vestiti con i nostri abiti migliori e ci prepariamo
ad affondare da signori. Però gradiremo un brandy».
Michela Murgia “il pistolotto sulle donne
afghane”: Nicola Porro, parole disastrose sui talebani.
Libero Quotidiano il 23 agosto 2021. “Finalmente Michela
Murgia si è svegliata e sulla Stampa scrive un pistolotto sulle donne afghane”.
Così Nicola Porro nel corso della sua zuppa quotidiana si è espresso sulla nota
scrittrice, che dopo giorni di silenzio ha deciso di affrontare la questione
dell’Afghanistan, soprattutto in relazione al Medioevo in cui sono ripiombate le
donne per colpa dei talebani. “La Murgia riesce a scrivere che ‘noi donne
lottiamo per le sorelle afghane’, allora siamo apposto”, ha commentato Porro.
Che poi sobbalza leggendo la riga successiva: “‘I nostri eserciti non erano
certo andati lì a promuovere l’emancipazione femminile’, ecco perché le nostre
femministe non si inginocchiano per l’Afghanistan. Il motivo lo svela
chiaramente la Murgia, lì c’erano gli americani e gli eserciti occidentali che
non promuovevano l’emancipazione”. “L’idea fondamentale - ha aggiunto Porro - è
che gli eserciti fanno solo schifo e che agli occidentali interessa solo
trafficare oppio e fare affari di guerra. Nel frattempo, però, negli ultimi 20
anni le donne afghane erano libere, lavoravano, avevano i centri bellezza e
soprattutto sono andate a scuola anziché in ospedale per partire a 13 anni.
Hanno potuto studiare, sanno cos’è la scuola e le classi miste. Gli eserciti
saranno pure cattivi ma adesso non esageriamo”, ha chiosato.
Chi si inginocchia per le donne afghane?
Serena Pizzi il 21 Agosto 2021 su Il Giornale. Nessuna lezioncina, nessuna
tirata d'orecchie, nessuna condanna al fondamentalismo islamico. Dove sono
finite le femministe e la sinistra? Il 15 agosto i talebani sono entrati
a Kabul. In un attimo, ci siamo trovati di fronte a una drammatica crisi
umanitaria, ingestibile con i soliti slogan. Dal 15 agosto, i giornali, i
social, le tv stanno informando i cittadini su ciò che sta accadendo in
Afghanistan. Fra corridoi umanitari e ritorno alla sharia, il Paese si trova
ancora una volta nel caos più totale. Interpreti, collaboratori, giornalisti,
civili, qualche migliaio di afghani e militari sono già riusciti ad abbandonare
la terra dell'inferno, ma purtroppo sono molti di più quelli che si ritrovano
fra le grinfie di invasati islamici. Come è ormai risaputo, a pagare il prezzo
più alto di questo cambio di potere sono le donne. "Siamo impegnati a rispettare
i diritti delle donne sotto il sistema della sharia", ha detto il portavoce dei
talebani, Zabihullah Mujahid, durante la sua prima conferenza stampa in favor di
telecamera. Una conferenza stampa fuffa, volta a ingannare tutto il mondo.
Perché le loro intenzioni sono altre (le donne non possono più uscire di casa,
andare a scuola, vestirsi all'occidentale etc) e perché il loro volto violento
non è mai cambiato (giorno e notte ammazzano civili e funzionari di Stato come
fossero mosche). Ma per capire la loro tattica da quattro soldi non ci vuole un
genio. Solo sentendo pronunciare "donne", "sharia" e "diritti" nella stessa
frase deve suonare più di un campanello d'allarme. Ma questo non è accaduto
a Giuseppe Conte che ha creduto ai talebani ben accomodati nel Palazzo
presidenziale. Giuseppi, infatti, ha trovato nelle loro parole, nelle
fucilazioni, nei rastrellamenti un "atteggiamento abbastanza distensivo" tanto
da sentirsi in dovere di intavolare un dialogo con questi soggetti. E se l'ex
presidente del Consiglio per un attimo (ha fatto marcia indietro poi) ci ha
creduto, i talebani no. Ci spieghiamo. Dopo "l'atteggiamento distensivo" - per
non sembrare troppo buoni - hanno voluto precisare: "Sotto il dominio dei
talebani, l'Afghanistan non sarà una democrazia ma seguirà la legge della
sharia. Non ci sarà affatto un sistema democratico perché non ha alcuna base nel
nostro Paese. Non discuteremo quale tipo di sistema politico dovremo applicare
in Afghanistan perché è chiaro: è la legge della sharia e basta". Parole
inequivocabili e vergognosamente vere. Ecco, tutto questo discorso per dire
cosa? Per evidenziare un silenzio assordante. Da parte delle femministe e della
sinistra sono arrivati solo pochi messaggi monotoni "aiutiamo le donne afghane",
"apriamo a corridoi umanitari, "accogliamole". Messaggi sporadici. Eppure,
eravamo convinti che le Boldrini di turno avrebbero iniziato a stracciarsi le
vesti per le condizioni disumane nelle quali vengono costrette a vivere le
donne. Eravamo convinti che dal 15 agosto in poi avremmo trovato su tutti i
social mani scarabocchiate con l'hashtag Afghanistan. Addirittura, eravamo
convinti di imbatterci nel Letta-maestrino che ci sgrida perché non ci siamo
inginocchiati di fronte a tale tragedia. E invece... niente. Qualche condanna
qua e là, qualche tweet di solidarietà, qualché pensierino della sera senza mai
pronunciare quella parola: islam. Nessuno è stato in grado di dire che il
fondamentalismo islamico sta ammazzando migliaia di persone. Nessuno si è
inginocchiato per queste donne che vogliono solo essere libere. Che non vogliono
più essere trattate come bestie. Ps: questa sera è ricominciato il campionato di
Serie A. Non ho visto fasce con la bandiera dell'Afghanistan, non ho visto
calciatori inginocchiati. Ma non ho nemmeno visto lo sdegno della politica per
la mancanza di tutto ciò.
Serena Pizzi. Nasco e cresco a Stradella, un
piccolo paese che mi ha insegnato a stare al mondo. Milano, invece, mi ha dato
la possibilità di realizzare il mio sogno più grande: fare la giornalista. Amo
conoscere, osservare e domandare. Mi perdo nei dettagli delle cose e delle
persone. Del resto sono i dettagli a fare
Il silenzio delle femministe chic.
Valeria Braghieri il 19 Agosto 2021 su Il Giornale. E nel
2021 è forse il caso di ammettere che le femministe sono finite. Disponibili
come sono solo, ormai, per i lavori già fatti, per le battaglie marginali, per i
tic dell'Occidente. E nel 2021 è forse il caso di ammettere che le femministe
sono finite. Disponibili come sono solo, ormai, per i lavori già fatti, per le
battaglie marginali, per i tic dell'Occidente. Forse le femministe sono finite
se nel momento in cui la Storia offre loro una causa degna di questo nome, si
trasferiscono in guardiola. Gonfie di certezze fino a ieri, quando si trattava
di indignarsi per le performer alla festa di Diletta Leotta, per i testi di
Sfera Ebbasta, o quando si incendiavano di battaglia per il Ddl Zan. Tutte
barricate sul MeToo. Quella sì è una causa glamour: vip, slogan, volti famosi,
retroscena succulenti. Niente femministe per le donne afghane. Si sono fatte
evanescenti come se avessero preso un'enorme boccata di elio. Troppo faticose o
troppo scomode le vite diversamente complicate delle donne di Kabul. I Talebani,
il burqa, la sharia, le botte e la sottomissione: e poi il peggio. Perché c'è
ancora un peggio: anni di emancipazione scorticati in un istante. Tutto daccapo,
da rifare. Lo sfregio della democrazia le risputa indietro di anni. Ma non ci
sono parole di solidarietà e di indignazione. Nessun sermone sui diritti e
l'uguaglianza violati, che di solito leccano la pelle come bava di lumaca. A
Kabul stilano gli elenchi delle donne non sposate per sapere che carne dare in
pasto a quale comandante, per capire quale trofeo distribuire a chi. Ma non si
tratta di produttori cinematografici, di attrici o di figlie d'arte. Non ci sono
hashtag e braccia alzate mentre si ritira una statuetta, nulla per cui
riconoscersi e far vedere che si appartiene. A una causa ganza, tra gente ganza.
Non ci sono microfoni o telecamere aperti, non c'è nulla di aperto lì, in
realtà. A parte la finestra sul baratro, l'unica cosa spalancata su Kabul. Qui
sono chiuse le bocche, inspiegabilmente. Le pasionarie, le arrabbiate perenni,
le «contro». Tutte sparite. Tutte silenziosamente uguali e omologate nelle loro
diversità. Intanto la vernice bianca imbratta le pubblicità di parrucchieri e
centri estetici a Kabul. Si chiude. Finita, la strada per «indietro» è di qui.
Si torna al «prima». Ed è solo l'inizio. Certo che è solo l'inizio. E quelle
protestano, a rischio di essere massacrate. Perché mostrare un cartello con
slogan a Kabul non è come mostrarlo alla consegna degli Oscar. Lì ci sono la
polvere, le mitragliette e i rastrellamenti. Hashtag un bel niente. Non ci sono
le femministe dove si fa sul serio. Quindi non ci sono più le femministe.
Immerse come sono, in silenzio, nello sciroppo vischioso dell'indifferenza.
Valeria Braghieri
Femminismo da cortile.
In Afghanistan la donna ritorna agli Anni 50, ma in Italia si lotta contro
#tuttimaschi. L’avvelenata Guia Soncini su L'Inkiesta il 17 agosto 2021. Le
trentenni che si chiedono cosa abbiano fatto mai, le novantenni, per i diritti
delle donne, danno per scontato che i diritti ci siano sempre stati, eppure non
potevano votare, abortivano con un ferro da calza e la società si aspettava da
loro solo che si trovassero un marito. Ma oggi, mentre a Kabul torna il burka,
ci indigniamo perché in quel talk show non hanno invitato nessuna delle nostre
amiche. La seconda scena della Guerra di Charlie Wilson, l’ultimo film che girò
Mike Nichols, è ambientata in un idromassaggio nell’aprile del 1980. Ci sono Tom
Hanks, il parlamentare Charlie Wilson, un tizio che vuole convincerlo a fargli
avere i finanziamenti per girare «un Dallas ambientato a Washington», e tre
mignotte (scusate: belle ragazze). In tv c’è Dan Rather, e Charlie Wilson è
abbastanza alieno da chiedere, in un bordello di lusso, d’alzare il volume del
tg. «C’è Dan Rather con un turbante» «Sta facendo una cosa dall’India» «È
l’Afghanistan». Oggi Aaron Sorkin, che scrisse la sceneggiatura, verrebbe
accusato di maschilismo per aver fatto la mignotta così scema da confondere
l’India e l’Afghanistan. Ma, se sospendiamo per un istante le segnalazioni di
virtù, l’ovvia verità è che, se la scena fosse ambientata oggi, quarant’anni
dopo, e al posto della mignotta ci fossero un assessore, un cardiochirurgo, uno
studioso di matematica, nessuno di loro saprebbe trovare l’Afghanistan sul
mappamondo, o mettere in fila i rivolgimenti dall’81 a oggi (a parte quelli più
clamorosi: ah, già, i talebani; ah, già, l’undici settembre). La verità è che
dell’Afghanistan non ci importa niente (in formulazione più citazionista: la
verità è che l’Afghanistan non ci piace abbastanza). Sorkin lo sapeva, e infatti
alla scena successiva è la segretaria di Wilson a dire «Uzbekistan?» quando lui
nomina Kabul, e questo ci dice non che gli uomini sono più svegli ma che Wilson
è un ossessivo: nomina Kabul perché è uno che corre a leggersi le agenzie appena
battute invece di, com’era normale fare quarant’anni fa, aspettare i giornali
del mattino dopo. La segretaria ha il lusso di non leggere le agenzie, di non
sapere dove sia Kabul, di decidere cosa vuole sapere e cosa no, se vuole
studiare o no, se vuole fare la mignotta o no: è una donna occidentale. Molti
anni fa, quando i giornali non venivano indicizzati sull’internet, scrissi un
articolo su una tizia ammazzata di botte da quello con cui stava: sostenevo ci
fossero donne cui piace farsi menare. Ci ripenso ogni tanto, più che altro per
dirmi che certo, i miei detrattori sono proprio scarsi: neanche sono capaci di
rintracciare la più formidabile fesseria che abbia mai scritto e usarla per
sputtanarmi. Ma in questi giorni ci ho ripensato chiedendomi se il feticcio del
multiculturalismo non sia gemello di «le piace farsi menare, chi sono io per
oppormi»; non sia lo stesso tic, solo meno impresentabile giacché tipico di
gente che si posiziona sempre e solo dalla parte giusta, e quindi sostiene il
diritto delle donne a essere fondamentaliste per scelta e non per costrizione,
il che è bislacco considerato che le fondamenta d’ogni fondamentalismo
consistono nel non lasciar scelta alle donne.
Dice: eh ma come la mettiamo
con quelle che si vogliono mettere il velo anche quando vivono libere in
occidente. Of course ci saranno donne cui piace non poter uscire senza che un
maschio le accompagni, but maybe quelle donne vanno salvate da sé stesse. Nel
1981, quarant’anni fa, l’Italia somigliava così poco all’idromassaggio di
Charlie Wilson e così tanto all’Afghanistan, che c’era ancora il matrimonio
riparatore. Fu abolito quell’anno, quindici anni dopo la vicenda di Franca
Viola. Ogni tanto mi chiedo se oggi si potrebbe girare, due anni dopo Franca
Viola e col matrimonio riparatore in vigore per tredici anni ancora, uno dei
miei film preferiti, La ragazza con la pistola. Carlo Giuffré dà mandato di
rapire una ragazza chiatta che gli piace, ma si sbagliano e gli rapiscono la
cugina secca, Monica Vitti. Che è innamorata di lui («tua sono, e con me ti
porterò, fino alla tomba») e a quel punto pretende il matrimonio riparatore, ma
lui non ne vuole sapere. È una commedia, e oggi ci indignerebbe: le ragazze sono
costrette a sposare i loro stupratori e voi ne ridete. Oggi non c’indigneremmo
con la legge, o almeno non quanto con la commedia. Oggi –- in Italia, in
occidente, nel paese in cui ci balocchiamo col considerare il fondamentalismo
una scelta – abbiamo risolto così tanti problemi pratici che ci concediamo il
lusso di crearne di immaginari. Of course si può essere suscettibili allo
sberleffo, but maybe ti resta più tempo libero per farlo se i tuoi diritti
fondamentali sono assicurati. Quei diritti che dai così tanto per scontati da
esser convinta le donne li abbiano sempre avuti, da essere insofferente nei
confronti di donne che sono nate quando le donne italiane non potevano votare,
quando si abortiva con un ferro da calza, quando tutto quel che la società si
aspettava da noi era che ci trovassimo un marito. Ogni tanto sento chiedere da
trentenni convinte d’essere informate cos’abbiano fatto mai, le novantenni, per
i diritti delle donne, e penso che ci meriteremmo un po’ di talebani. Ci
meriteremmo di ricordare come funziona in quei luoghi del mondo che ci prendiamo
il lusso di considerare folkloristici, anche se siamo troppo colti per usare
l’espressione “folkloristico”, ma quello è: il lusso di pensare che carucci
questi sud del mondo coi turbanti, che riposante questa cosa che se sei donna
stai a casa ad aspettare il marito, che mancanza di stress questi matrimoni
combinati, che scelta interessante il velo. Noialtri che straparliamo di
vessazioni patriarcali se in un programma televisivo parlano deputati e
giornalisti maschi, non essendoci mai venuto in mente che ci sono posti in cui
le femmine non diventano proprio deputate e giornaliste. Noialtri che
cancellettiamo #AllMenPanel se a un dibattito non ci sono signore perché
l’organizzazione non ne ha trovata nessuna disponibile, non perché viviamo in
una società in cui non è previsto che le signore parlino in pubblico. Noialtre
così prive di discriminazioni specifiche – è se sei donna che non puoi comparire
in pubblico, andare a scuola, fare quel che ti pare – da inventarcene:
immaginiamo un mondo in cui sono sempre gli uomini a star seduti scomposti e
interrompere chi parla, mai noi. Noialtre del femminismo da cortile. In una
puntata di vent’anni fa di The West Wing, la serie televisiva scritta anch’essa,
come Charlie Wilson, da Aaron Sorkin, la portavoce della Casa Bianca dà in
escandescenze per il rinnovo degli accordi col Qumar, una nazione di fantasia
che Sorkin usava per dire tutte le cose che voleva dire sui fondamentalismi
senza che a nessuno di nessuna nazione realmente esistente venisse voglia di
farsi esplodere in Times Square. In Qumar le donne venivano trattate come
nell’Afghanistan dei talebani, per capirci. CJ, la portavoce, discuteva con
Nancy, la consigliera per la sicurezza nazionale, che le diceva di darsi una
calmata, che avevano bisogno della base militare in Qumar per fare rifornimento
ai voli. Nancy, oltre che donna, era nera, e quando chiedeva perché CJ fosse
così agitata quella rispondeva ricordando a lei e a noi quant’è miserabile che
ci freghi solo delle cose che ci riguardano: «L’apartheid era una grigliata agli
Hamptons, in confronto a come trattano le donne in Qumar, e se quindici anni fa
avessimo venduto armi al Sudafrica tu avresti dato fuoco all’edificio: meno male
che non abbiamo mai dovuto fare rifornimento a Johannesburg». Non c’importa
niente delle donne afghane, se non per portarci la mano al giro di perle e
sospirare «poverine», perché esse sono lontane da noi almeno quanto la Julia
Roberts di Charlie Wilson, la miliardaria assai anticomunista che è responsabile
dei quarant’anni successivi, avendo ingiunto a un deputato di far sul serio
contro i russi in Afghanistan; l’unica che sapesse davvero cosa stesse
succedendo lì, e non perché terzomondista ma perché attenta agli equilibri del
mondo, che sono sempre economici.
Le donne senza diritti e
quelle con troppo potere non sono il nostro specchio, quindi perché
interessarcene? È tanto meglio stare qui, e indignarci perché in quel talk show
non hanno invitato nessuna delle nostre amiche. Quel talk show in cui si parlava
del nostro cortile, perché l’Afghanistan mica fa share.
La storia di “Donna Circo”,
il primo disco femminista: fu inciso 50 anni fa, ma esce solo oggi.
Aborto,
femminicidio, disparità salariale. Le canzoni incise nel 1974 da due musiciste
d’avanguardia non vennero pubblicate per ragioni di mercato. Ma sono ancora
attuali e ora finalmente si possono ascoltare. Patrizio Ruviglioni su L'Espresso
l'8 luglio 2021. Come suona “Donna Circo”, il primo disco femminista della
musica italiana? «Come una fotografia scattata da due donne della loro
condizione nel 1974, cioè quando è stato scritto. Infatti nelle sue canzoni si
parla di aborto, femminicidio, disparità salariale. Insomma, il dibattito di
allora; ma senza militanza ideologica, solo per necessità di raccontare noi
stesse e le nostre difficoltà». Gianfranca Montedoro – cioè Giulia Zannini
Montedoro, cantante jazz classe 1940, catanese poi trapiantata a Roma – su
quell’album ha messo faccia, voce, musica. I testi, invece, li ha firmati Paola
Pallottino, paroliera già al fianco di Lucio Dalla in “4/3/1943” nel 1971. E che
oggi ricorda all’Espresso: «Io e lei, insieme, eravamo un’eccezione,
un’assurdità negli anni Settanta dei cantautori maschi impegnati nel sociale».
Un’eretica, Paola Pallottino. «All’epoca le donne in Italia venivano considerate
solo come interpreti, mai come autrici. Di conseguenza venivo vista come
un’aliena perché scrivevo le parole per Lucio». E quali parole: nella sua
versione, “4/3/1943” si intitola “Gesù Bambino” e descrive una ragazza madre che
gioca “alla Madonna” con un bambino che, da adulto, “bestemmia” fra “i ladri e
le puttane”. Poi, prima di presentarsi all’Ariston, la censura avrebbe
edulcorato quei passaggi, ma senza impedirle di arrivare al pubblico in una
veste un minimo fedele all’originale, fino a diventare un classico di Sanremo. E
dire che «il Festival, se proprio dovevo guardarlo, lo vedevo per riderne».
Tradotto: «Come ragazza non mi sentivo rappresentata da quel modo di intendere
lo spettacolo». È anche da questo distacco che nascono le liriche “Donna Circo”,
che manda all’amica Montedoro con la richiesta di far loro ciò che di solito
faceva Dalla – «Prendere le mie poesiole, trasformarle in canzoni».
Risultato: due donne appena più che trentenni, per la prima volta, mettono in
musica la loro condizione. O meglio, ci provano. Perché poi le parole si
perdono, di nuovo. Non per censura stavolta, ma per questioni di mercato: l’lp
dopo essere stato registrato non viene mai pubblicato. «E io», spiega
Pallottino, «conosco solo la versione ufficiale dei fatti: la nostra etichetta
di allora, la Basf Fare, a giorni dall’uscita si ritira non ritenendo più
conveniente investire nella musica. Col tempo mi hanno raccontato di altri
lavori pronti alla distribuzione che hanno subito lo stesso destino». Certo è
che, al posto loro, degli uomini avrebbero avuto meno difficoltà a far arrivare
il disco sulla scrivania di un editore disposto a offrirgli una seconda chance.
Problema di contatti? «Non so. Col senno di poi avrei potuto presentarlo ad
altri, è vero. Ma per la delusione non riuscivo a ragionare su come rimediare a
quanto successo». Tant’è che da lì si sarebbe defilata dal mondo dello
spettacolo per dedicarsi allo studio dell’illustrazione, mentre Montedoro si
sarebbe ritirata dalle scene per una decina d’anni, prima di tornare al jazz e
non pubblicare più un album solista. Giusto adesso ne parla volentieri: «Fu una
crisi profonda, che coincise con problemi personali. In realtà avevo provato a
far girare un po’ quei nastri. Ho bussato a qualche porta. Nessuna risposta».
Rimpianti? «Che fossi sola in tutto ciò: il produttore dell’epoca, Roberto
Marsala, non fece nulla per aiutarci a trovare un’altra etichetta. Al tempo
stesso io e Paola eravamo cani sciolti: mentre si formavano i primi clan, non
frequentavamo salotti e amici potenti, e in questo senso partivamo svantaggiate;
a me interessava solo la musica, ed è inutile dire che la strada era tutta in
salita». Così, nell’indifferenza generale, “Donna Circo” rimane un album
fantasma di cui si perdono le tracce. Nessuno ne parla, tantomeno lo si può
ascoltare, e questa mosca bianca della nostra musica resta sepolta per
quarantasette anni. Fino alla scoperta recente: fra amicizie e passaparola, nel
2019 la cantante Suz – cioè Susanna La Polla – e Pallottino stessa riescono ad
aprire una raccolta fondi per pubblicare i nastri originali e un loro remake,
“Donnacirco”, a opera di artiste. Entrambi sono finalmente in uscita proprio in
queste settimane per La Tempesta dischi. E fra i nomi che hanno partecipato, ci
sono voci come Angela Baraldi e Alice Albertazzi, Eva Geatti e Francesca Bono,
Enza Amato, NicoNote, Vittoria Burattini dei Massimo Volume, per un totale di
dodici interpreti, quattro musiciste, l’illustratrice Francesca Ghermandi per la
copertina ed Ezra Capogna – l’unico uomo nel progetto – alla produzione. «A
livello di suoni, l’originale è un po’ invecchiato, con arrangiamenti
progressive, barocchi in stile anni Settanta, su cui com’è normale che sia,
siamo intervenute», spiega Burattini. Poi puntualizza: «Come molte colleghe non
sapevo niente di questa storia; ma ci ha colpite subito l’attualità dei testi».
«La sensazione», precisa Baraldi, «è che la musica da allora si sia evoluta,
mentre la condizione femminile sia rimasta la stessa». «E infatti “Donna Circo”
parla ancora a tutti, ma questo non è certo un bel segnale», sorride amara
Pallottino. I suoi versi, ribadisce, non sono militanti ma surreali, pieni di
metafore, concreti più che idealisti. «E nati non dalla rabbia, ma
dall’imbarazzo di essere ragazza nell’Italia degli anni Settanta, dal non
sentirmi rappresentata, né protetta. Dalle contraddizioni che vedevo. Basti
pensare che era ammesso il delitto d’onore. Volevo rispondere a un’urgenza,
parlare della nostra situazione». Il risultato è senza precedenti, spiazzante,
con pochi riferimenti a cui aggrapparsi anche oggi. E oltretutto figlio di un
periodo in cui le donne erano ai margini della musica specie dal punto di vista
autorale. «Ma direi proprio della canzone stessa», precisa Montedoro. «Eravamo
ritratte in maniera superficiale dentro storie d’amore piatte, oppure sempre col
filtro di cantautori uomini. Facevamo finta di niente, ma nel registrare l’album
eravamo isolate: era un sistema maschilista. In questo senso, i testi di Paola
mi avevano folgorato perché avevano una profondità diversa rispetto al resto».
Appunto, quegli stessi testi che – nel Paese degli anni di piombo che scopre i
primi diritti civili, il divorzio, l’emancipazione – avrebbero dovuto funzionare
da bussola, con la metafora del circo e dei suoi numeri a mascherare una corsa a
tappe su aborto, femminicidio, disparità salariale e stereotipi di genere,
sempre dal punto di vista di chi viene discriminato. Per esempio, fra i brani
c’è “A cuore aperto” che allude all’interruzione di gravidanza clandestina fra
corpi tagliati e illusionisti («Lei gli dà il bisturi senza lamento / e lui
comincia l’esperimento»), mentre “La tigre del Bengala” è un’allegoria di uomini
che uccidono le compagne (come pure “Trenta coltelli”, in cui l’immagine dei
prestigiatori si presta al racconto dei rischi della convivenza forzata) e “Che
pazzi i pagliacci” se la ride del patriarcato. «Siamo nel 2021, e non è cambiato
nulla rispetto 1974», dice Pallottino. «C’è bisogno di un lavoro come questo.
Spero possa arrivare a un pubblico giovane», compiere la sua missione originale,
«sensibilizzare, magari indurre all’autocoscienza le ragazze». Anche per questo
è uscito “Donnacirco”, remake aggiornato nel suono e volutamente intatto nei
testi, più vicino all’indie-rock delle interpreti che al progressive di allora.
Un’operazione che, per Burattini, ha pure «un valore simbolico». Cioè?
«L’originale è scritto e composto da donne, è vero, ma ha avuto “bisogno” di
uomini – cioè dei componenti della band Murple – per essere suonato e
registrato. Stavolta invece gli aspetti della produzione sono tutti al
femminile, segno che nel frattempo si sono formate quelle musiciste che prima
mancavano». Pure per questo, sostiene, per le ragazze che oggi salgono su un
palco è tutto «difficile ma non difficilissimo», perlomeno rispetto agli anni
Settanta. «L’ambiente non è misogino in senso attivo; è gestito da maschi che
per cultura e abitudine ne chiamano altri quando serve qualcosa. Ma finalmente
stiamo alzando la voce, andando oltre stereotipi come quelli che ritengono che
il rock sia un genere da uomini. Il prossimo passo è un aumento della nostra
presenza nelle professioni tecniche, come il fonico. Ne vedremo delle belle. E
un disco che fotografa una situazione come questo, per me, è schierato anche più
di uno “politico” in senso stretto». Perché «una canzone può e deve essere
impegnata, non solo intrattenimento», puntualizza Baraldi. Che poi riflette:
«“Donna Circo” ci insegna che nel dibattito cambia la forma, non il contenuto.
Il femminismo serve ancora, eccome. Quando io ho iniziato a cantare, nel 1990,
sentivo diffidenza intorno; ora ho vissuto parte del cambiamento sulla mia
pelle, qualcosa si sta sbloccando. Ma la strada è lunga». «Se ripenso che
all’epoca non potevo affidarmi a delle musiciste semplicemente perché non ce
n’erano», conclude Montedoro, «mi sembra assurdo. Ora che tutti possono
ascoltare quest’album, credo si chiuda un cerchio. Mi sento meglio. E vorrei che
le donne continuassero a unirsi come me e Paola nel 1974. Anche per dimostrare
ai maschi che è ora di “darsi una calmata”». E per chiudere per sempre il
“circo” in cui, dopo quarantasette anni, la protagonista dell’album è ancora
intrappolata.
I dirigenti politici a scuola di parità
di genere: debutta “Femministi!” Ilaria Donatio,
Giornalista freelance, su Il Riformista il 30 Giugno 2021. Ma davvero alle donne
manca qualcosa per avere successo in politica o è, piuttosto, la politica, in
particolare i partiti in quanto organizzazioni che selezionano la leadership,
che funzionano secondo logiche che allontanano le donne? A questa domanda
proverà a rispondere una scuola di formazione politica per la parità di genere
rivolta a dirigenti politici uomini che debutta venerdì 2 luglio e prosegue il
venerdì successivo, 9 luglio 2021, presso la sede dell’Istituto Luigi Sturzo,
vicino al Pantheon a Roma. Dal nome provocatoriamente declinato al maschile,
“Femministi! – Laboratorio per un altro genere di politica” è promosso da
+Europa, grazie alla quota del 2×1000 che per legge tutti i partiti dovrebbero
(il condizionale è d’obbligo!) destinare a iniziative dedicate alla promozione
della parità di genere, e partecipato, per ora, anche da PD, Azione, Verdi,
Italia Viva, M5S e Lista Sala. Un’iniziativa transpartitica, dunque, che fa
seguito alla prima esperienza di formazione realizzata, lo scorso anno, da
+Europa – “Prime Donne” – che aveva formato 23 aspiranti leader politiche. “Alla
fine dell’esperienza dello scorso anno ci siamo rese conto che non sono le donne
ad avere bisogno di una formazione specifica per fare politica” – spiega
Costanza Hermanin, fellow dell’Istituto universitario europeo e fondatrice della
scuola – “Ci sono prassi escludenti e politiche pubbliche che rendono difficile
il raggiungimento della parità, soprattutto in politica. Questi elementi devono
essere portati all’attenzione degli uomini politici, perché ne prendano
coscienza e affianchino le donne nella battaglia per la parità in politica, su
cui l’Italia sconta un ‘gap’ più grande che in qualsiasi altro settore”. La
prima edizione di “Femministi!” prevede 15 ore di formazione, con laboratori che
spaziano dalla valutazione d’impatto di genere delle politiche pubbliche – una
metodologia richiesta dalla stessa Commissione europea per i programmi di spesa
del Recovery Fund – all’applicazione della politica delle quote, passando per il
“trattamento” che i media riservano alle campagne elettorali delle donne.
“Parleremo di stereotipi e pregiudizi di genere che applichiamo inconsciamente e
di come la comunicazione tradizionale e sui social media esiga più dalle
candidate donne che dagli uomini”, prosegue Hermanin. “Ci occuperemo delle
regole elettorali e di partito e di come queste siano costantemente aggirate
riproducendo una leadership maschile. Affronteremo le questioni dell’analisi
economica e dei bilanci di genere, nonché delle politiche pubbliche, mostrando
dati, ricerche ed esempi concreti di come una leadership paritaria porti a
risultati politici più efficaci e a politiche più efficienti”. Lo schema del
laboratorio non sarà quello classico: la prima delle due giornate si aprirà con
una performance di “forum teatro” – un genere di teatro dell’oppresso in cui si
mette in scena una situazione che rappresenta una condizione oppressiva – in cui
“i performer riprodurranno le dinamiche tipiche della politica attuale per
aumentare la consapevolezza nei partecipanti”. A cui sarà richiesto, alla fine,
un impegno preciso, volto a riprodurre i modelli condivisi durante il
laboratorio, nell’ambito delle rispettive formazioni politiche. “Femministi!
Lab” sarà l’evento finale, pubblico e in diretta streaming, che includerà anche
le donne “per mettere in scena le dinamiche che vorremmo per un altro genere di
politica, a partire proprio da spezzoni di dibattiti parlamentari e conferenze
stampa tradizionali”. Il 9 luglio, dopo l’intervento della ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, saranno consegnati 10 riconoscimenti
per la parità di genere. Tra i premiati, la direttrice del Giornale Radio Rai e
Radio1 Rai Simona Sala, per la promozione della campagna “No Women No Panel –
Senza donne non se ne parla”. A seguire, la senatrice Emma Bonino risponderà
alle domande del conduttore radiofonico Carlo Pastore.
Il corso per farci
diventare femministi convinti. Roberto Vivaldelli il 3
Luglio 2021 su Il Giornale. S'intitola "Femministi!" ed è la scuola di
formazione nata "per colmare il divario di genere in politica". Ennesimo
tentativo della sinistra italiana di importare l'Identity Politics. Femminismo,
minoranze etniche ed Lgbt, politicamente corretto: sono i nuovi mantra
ideologici di una sinistra italiana che, a dirla tutta, non è mai stata troppo
originale né creativa, e che prende come modello e ispirazione tutto ciò che fa
la sinistra liberal Usa. Nello specifico, sta tentando di importare e replicare
nel nostro Paese il modello identitario che sta polarizzando il dibattito
politico americano: come lo definisce Mark Lilla, si tratta di un credo
professato da un'élite urbana, isolata dal resto del Paese, la quale vede i
problemi di ogni giorno attraverso la lente dell'identità. Lilla, nel suo saggio
di qualche anno fa L'identità non è di sinistra. Oltre l'antipolitica (Marsilio)
accusava il "panico morale su razza, genere, identità sessuale che ha distorto
il messaggio del liberalismo e impedito che divenisse una forza unificante".
Anziché rafforzare il concetto di comunità, infatti, il progressismo identitario
divide la società in tribù e minoranze in costante competizione fra loro, senza
peraltro apportare alcun vantaggio specifico alle minoranze interessate da
questo nuovo catechismo ideologico in salsa politically correct.
Il corso di femminismo di + Europa. È nell'ottica
dell'identity politics, dunque, che va visto il corso di femminismo per i
politici promosso da +Europa, il partito fondato da Emma Bonino. Seminari di
economia o altri temi che potrebbero essere - davvero utili - per i nostri
politici? No, +Europa pensa ad indottrinare i politici della sinistra italiana
nel nome del femminismo chic. "Femministi! - si legge sul sito web del partito
-nasce per colmare il divario di genere in politica. Cerchiamo uomini già
impegnati in politica, per superare barriere e stereotipi spesso nascosti. Il
laboratorio offrirà, grazie ad un programma innovativo, gli strumenti necessari
per navigare attraverso l’arcipelago giuridico, organizzativo e semantico che
ruota attorno alla parità di genere". E ancora: "Perché ci focalizziamo proprio
sui partiti politici? I partiti, infatti, sono unanimemente identificati dalla
letteratura scientifica come i principali canali inibitori della carriera
politica di donne, persone Lgbt e minoranze etniche". Il progetto, prosegue la
descrizione della scuola di formazione, è stato elaborato sulla base di
esperienze dirette all’interno di partiti politici italiani ed europei e un
focus group tra dirigenti ed elette di partito, un sondaggio su un campione di
1000 persone, e la conduzione di Prime Donne.
La sinistra italiana inciampa nell'Identity
Politics. La prima giornata del seminario si è svolta ieri - 1° luglio - a Roma,
mentre la seconda è in programma il 9 luglio, per un totale di cinque sessioni
tutte dedicate alla parità di genere. Come riporta La Repubblica, "alla fine
dell'esperienza dello scorso anno ci siamo rese conto che non sono le donne ad
avere bisogno di una formazione specifica per fare politica- dichiara Costanza
Hermanin, fellow dell'Istituto universitario europeo e fondatrice della scuola
-. Ci sono prassi escludenti e politiche pubbliche che rendono difficile il
raggiungimento della parità, soprattutto in politica. Questi elementi devono
essere portati all'attenzione degli uomini politici, perché ne prendano
coscienza e affianchino le donne nella battaglia per la parità in politica, su
cui l'Italia sconta un 'gap' più grande che in qualsiasi altro settore".
Hermanin, che è anche docente di politica e istituzioni europee al Collegio
d'Europa di Bruges, ha collaborato anche con l'Open Society Foundations, la rete
filantropica fondata da George Soros: questo tanto per far capire qual è l'humus
culturale dietro questo tipo di iniziative. L'obiettivo è sempre il medesimo:
imporre un'egemonia culturale politicamente correttissima secondo la quale il
nemico è la società patriarcale e il maschio bianco - ovviamente eterosessuale -
è il diavolo in carne e ossa. Esattamente ciò che sta tentando di fare la
sinistra Usa. E la "nostra" sinistra che fa? Copia. La nuova religione della
sinistra liberal è, infatti, la politica dell'identità e queste forme di
rivendicazioni identitarie che di certo non contribuiscono a risolvere i
problemi reali e rimangono sul piano retorico.
Roberto Vivaldelli. Roberto Vivaldelli (1989) è
giornalista dal 2014 e collabora con IlGiornale.it, Gli Occhi della Guerra e il
quotidiano L'Adige. Esperto di comunicazione e relazioni internazionali, è
autore del saggio Fake News. Manipolazione e propaganda mediatica dalla guerra
in Siria al Russiagate pubblicato per La Vela. I suoi articoli sono tradotti in
varie lingue e pubblicati su siti internazionali
Dagotraduzione dal Daily Mail
il 29 giugno 2021. «Femminista con capelli corti e piercing cerca marito che non
scoreggia, non rutta e possiede una fattoria di almeno 20 acri per invertire
abilmente gli stereotipi di genere nel mercato matrimoniale indiano». L’ironico
annuncio è stato pubblicato su 12 giornali del nord dell’India ed è stato
rilanciato dalla comica Aditi Mittal, di Mumbai, che l’ha condiviso su Twitter.
L’annuncio è molto dettagliato. La donna cerca un uomo «bello, ben fatto, figlio
unico di 25-28 anni con un’attività stimata e che sappia cucinare. Parlando con
la Bbc, la donna che ha inviato l’annunciato ha spiegato che era solo uno
scherzo per un trentesimo compleanno. All’annuncio, ha raccontato poi, hanno
risposto una sessantina di persone. «Molti pensavano che fosse uno scherzo e lo
hanno trovato divertente». Un uomo si è definito «perfetto» perché «docile e non
supponente» mentre altri l’hanno etichettata come «cercatrice d’oro», l’hanno
insultata per il suo fisico o le hanno scritto che «tutte le femministe sono
idiote», fino ad arrivare anche ad alcune minacce di morte. «Gli uomini chiedono
sempre spose alte, belle e magre, si vantano della loro ricchezza, ma quando le
cose sono cambiano, non possono sopportarlo. Come potrebbe una donna stabilire
tali criteri?» dice la femminista. «Presumo che le persone che si attivano
siano le stesse che pubblicano questo tipo di annunci del tipo "cerca una sposa
magra, bionda e bella" in primo luogo». In India, il 90% dei matrimoni è ancora
combinato, con razza, religione e casta come fattori importanti nelle decisioni.
Mattia Cialini
per arezzonotizie.it l'11 giugno 2021. "Mi sono dimessa dalla commissione Pari
Opportunità, sono uno spirito libero e l'uso di una terminologia soft non è
nelle mie corde. Ho usato parole incompatibili con un incarico istituzionale".
Dalle frequenze di Radio Effe Rossella Angiolini annuncia le proprie dimissioni
dopo le polemiche nate a seguito del suo post facebook, in cui aveva scritto:
"Delitto di Saman, ma quelle zoccole femministe di sinistra dove sono?".
Intervistata dal collega Massimo Pucci, Angiolini ha detto: "La presidente della
Provincia Silvia Chiassai non ha chiesto le mie dimissioni, sono io che ho
insistito. Non volevo metterla in difficoltà. Era giusto e corretto fare così,
lei era dispiaciuta della mia scelta". Anche se poi in un post di questa
mattina, la presidente della Provincia e sindaca di Montevarchi ha scritto: "Le
ho chiesto io, responsabilmente, di dare le dimissioni dal ruolo che occupa".
Il post facebook sulle
"zoccole femministe di sinistra". Tutto è nato da una pubblicazione sul proprio
profilo facebook di un giorno e mezzo fa. Rossella Angiolini, avvocata e
insegnante che corse nel 2006 per il centrodestra come sindaca di Arezzo in
contrapposizione a Giuseppe Fanfani, da un paio di anni ricopre il ruolo di
presidente della commissione Pari Opportunità della Provincia di Arezzo, scelta
dalla presidente dell'ente Silvia Chiassai. Nel post si richiama la tragedia di
Saman, la ragazza di origine pakistana e residente a Novellara (Reggio Emilia),
che è scomparsa dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Gli inquirenti
sospettano che siano stati parenti a ucciderla, proprio per aver rifiutato le
nozze imposte. Secondo Angiolini si sarebbero viste poche prese di posizione sul
caso nell'alveo politico di sinistra e per lamentarsi della cosa ha usato parole
sessiste: "ma quelle zoccole di femministe di sinistra dove sono?". Proprio lei
che era, fino a quel momento, presidente della commissione Pari Opportunità. Il
post ha raccolto peraltro numerosi commenti di sostegno, ma parallelamente è
sorta l'indignazione e la conseguente richiesta di dimissioni.
La bufera social. Sul caso, in
breve esondato dall'ambito provinciale, è intervenuta ieri anche la giornalista
Selvaggia Lucarelli, riportando il post originale ha scritto: "Rossella
Angiolini, presidente della commissione per le pari opportunità della Provincia
di Arezzo, avvocata, candidata sindaca di Arezzo nel 2006 per il centrodestra.
Anche duchessa, a quanto pare". Tra le prime dichiarazioni di denuncia quella
del segretario della federazione del Pd di Arezzo Francesco Ruscelli: "Mi chiedo
se questo linguaggio, gravemente sessista, possa essere utilizzato dalla
presidente della commissione provinciale pari opportunità e soprattutto se una
persona che utilizza questo linguaggio possa continuare a rivestire quel ruolo".
A stretto giro di posta è arrivata la presa di posizione di Silvia Russo,
segretaria Cisl di Arezzo: "Sono consigliera di parità da 4 anni e segretaria
generale della Cisl di Arezzo. Non posso essere annoverata come femminista di
sinistra, né come femminista di destra. Sono fortemente "femminilista",
schieratissima contro ogni forma di violenza sulle donne, che purtroppo non ha
pregiudizi politici di nessun colore. Stasera però mi sento più triste perché la
presidente provinciale del comitato pari opportunità certi epiteti non può
permetterseli. Mai! #Siamotuttezoccole". E anche la sindaca di Talla Eleonora
Ducci è intervenuta: "Da consigliera provinciale e componente della commissione
non posso che chiedere le dimissioni di Rossella Angiolini o la sua rimozione da
parte della residente della Provincia che l'ha nominata in questo importante
ruolo. Il fatto è intollerabile. Provvederò domani stesso a inviare una lettera
a Chiassai".
Mugnai (Cgil): "Sdoganato il
sessismo. Ora si potrà dare della zoccola?" C'è poi il commento di Alessandro
Mugnai, segretario Cgil: "Avvocata, insegnante, presidente della Commissione
pari opportunità. Non una qualsiasi militante di destra. Non una qualsiasi
leonessa della tastiera. E’ una donna che può aprire strade e sdoganare
linguaggi e comportanti. Perché un giovane non potrà dare della zoccola ad una
coetanea visto che questa parola viene usata dalla presidente della Commissione
pari opportunità? Perché uno studente non potrà definire zoccola un’insegnante
che gli ha dato un brutto voto, visto che un’insegnante ha pubblicamente usato
questa parola? E non mi permetto di entrare nei riflessi penali che può avere il
dare della zoccola ad una donna che ha un pensiero divergente dal suo". Quindi
l'appello alla presidente della Provincia, Silvia Chiassai: "Se condivide quanto
detto da Angiolini, la tenga al suo posto e condivida con lei tutte le
responsabilità. In caso contrario, le revochi il mandato. A lei la scelta.
Infine un’ammissione personale di angoscia: tutto questo nasce in seguito
all’omicidio di una giovane donna che voleva semplicemente vivere libera. Forse
chi l’ha uccisa, nella sua mente ha usato la stessa parola di cui parliamo oggi
rivolgendosi alla vittima. Dovremmo pensare a Saman e alle ragazze come lei ma
stiamo facendo altro. Strano e preoccupante paese, il nostro".
La formale richiesta di
dimissioni. Una slavina, tanto che ieri sera la conferenza provinciale delle
donne democratiche ha inviato alla presidente della Provincia di Arezzo, Silvia
Chiassai Martini, una lettera con la quale veniva chiesta la revoca
dell’incarico a Rossella Angiolini. "Abbiamo letto le sue parole nel post che ha
pubblicato su Fb - hanno scritto Donella Mattesini e Alessandra Nocciolini -
parole di una violenza inaudita, non solo scritte nel post, ma ribadite dalla
stessa Angiolini nelle risposte al post stesso , altrettanto violente, che sono
rivolte alle “zoccole femministe di sinistra” come ci ha definito, ma che in
realtà offendono tutte le donne e disegnano una deriva pericolosa in cui la
libertà di pensiero lascia il posto all’arroganza, al buio dell’inciviltà e
della becera strumentalizzazione politica. Per non parlare del livello degli
oltre 240 commenti sottostanti, che usano lo stesso livello di violenza e
sessismo. Ci domandiamo come può la Presidente di una Commissione provinciale
per le pari opportunità svolgere tale ruolo essendo essa stessa protagonista di
linguaggi e contenuti discriminatori e sessisti. Come può una avvocata che
dovrebbe osservare dignità, decoro per salvaguardare l’immagine della
professione forense, scrivere un post così? Come può una insegnante svolgere un
ruolo educativo quando scrive frasi così violente? Come può una persona “usare”
la tragedia di Saman per puri scopi politici? Una politica becera, violenta che
uccide Saman una altra volta. Una politica che non si ferma neanche di fronte al
dolore della morte di una ragazza che voleva scegliere la propria vita. Una
caduta di stile? No, questo è il vero volto di una certa destra, non di tutta. È
per questo che ci aspettiamo prese di distanza dalle parole di Angiolini e anche
la remissione del suo incarico".
Azione rincara la dose. Nella
notte, anche Azione Arezzo è intervenuta con un comunicato parlando di violenza
verbale "inaudita". "Non ha alcun senso - si legge nella nota inviata alla
stampa - avallare un messaggio politico apparentemente a tutela di una donna,
Saman, attraverso l’uso di stereotipi femminili ad alto contenuto denigratorio
contro altre donne. La comunicazione politica finalizzata alla contestazione
della cultura dell’accoglienza e della gestione dell’immigrazione, come quella
espressa attraverso il post, ha quale fine quello di consolidare una politica di
odio e di scontro. A fronte del gravissimo messaggio relativo ad un contesto
femminile dove si mettono a contrasto per scopi di propaganda elettorale donne
vittime di violenza con donne che hanno sempre lottato per contrastare questa
violenza, Arezzo in Azione chiede che Rossella Angiolini di dimetta
immediatamente dal suo ruolo pubblico di presidente della commissione pari
opportunità della Provincia di Arezzo e che tale esito, difettando l’iniziativa
personale della Angiolini, sia comunque immediatamente preteso dalla presidente
della Provincia che l’ha nominata Silvia Chiassai Martini".
L'annuncio del passo indietro.
E stamani, infine, è arrivato il passo indietro di Rossella Angiolini. "Le dirò
che io sono molto dispiaciuta di essermi fatta prendere dalla rabbia - ha detto
a Massimo Pucci su Radio Effe - chiedo scusa a tutte le donne che si sono
sentite offese, è montata la rabbia per un omicidio per cui non ho visto alcuna
manifestazione, rispetto a quelle per il Ddl Zan o quelle fatte in ginocchio nei
mesi scorsi". Il riferimento è alle manifestazioni a seguito della morte di
George Floyd in America. "La stampa ha avuto una grande attenzione, ma non
chiedo scusa alle femministe di sinistra. Per Saman ci sono state prese di
posizione molto fredde e molto contenute a sinistra. Sollevazione popolare non
c'è stata".
Chiassai: "Ho chiesto ad
Angiolini di dare le dimissioni". Questa mattina è arrivato un lungo post
facebook di Silvia Chiassai Martini sull'episodio, pubblicato sul suo profilo
istituzionale di sindaco di Montevarchi. E ha parlato in qualità di presidente
della Provincia spiegando che "il comportamento" di Rossella Angiolini nella
circostanza è "inaccettabile ed è per questo motivo che le ho chiesto
responsabilmente di dare le dimissioni dal ruolo che occupa". Si tratta però
della conclusione di un lungo intervento, che dedica poche righe alla questione
del linguaggio sessista, per concentrarsi sul delitto Saman, ribadendo, in
sostanza, quanto detto da Angiolini, con altre parole. "Non ho sentito nessuno
in questi giorni indignarsi per Saman, una ragazza 18enne pakistana sparita nel
nulla da oltre un mese, sulla cui scomparsa gli inquirenti sono ormai certi che
si tratti di omicidio premeditato. Una giovane donna, vittima della sua
famiglia, dell'integralismo, della assenza di libertà, di matrimoni combinati.
Una vicenda raccapricciante di una ragazza sola contro una cultura che considera
le donne come merce di scambio senza dignità. Una cultura che può arrivare
perfino ad uccidere se non si rispettano quelle regole, con l'incapacità di
integrarsi. Il silenzio su questa vicenda da parte della politica è stato
evidente perché non possono esserci casi dove indignarsi e altri dove indignarsi
di meno per non dare 'ragione' a chi sostiene la necessità di condannare e di
non tollerare 'culture' della violenza". E poi la chiosa: "Su Rossella Angiolini
- ha concluso Chiassai - il linguaggio da lei utilizzato è inaccettabile, ma non
ho sentito nessuno di quelli che oggi pubblicamente si indignano, indignarsi per
Saman che resta una vittima. Non ci si può indignare ad orologeria. Su le offese
a Giorgia Meloni la politica non si è espressa a sostegno, anzi, oggi invece
vedo attivarsi e tornare a parlare contro Angiolini, il cui comportamento resta
inaccettabile ed è per questo motivo che le ho chiesto responsabilmente di dare
le dimissioni dal ruolo che occupa". Successivamente, attraverso una nota stampa
diffusa dalla Provincia, Chiassai ha aggiunto: "Mi preme anche precisare che
appena diventata presidente della Provincia ho voluto fortemente ricostituire la
commissione Pari Opportunità che per anni era stata soppressa, tanta era
l’attenzione dei miei predecessori verso le donne”. Infine l'epilogo, come
spiegato dalla Provincia: "Le dimissioni da parte di Rosella Angiolini
dall’incarico di presidente della commissione Pari Opportunità sono già
pervenute questa mattina alla presidente della Provincia Silvia Chiassai
Martini".
La condanna delle Acli: In
giornata si è aggiunto il commento delle Acli di Arezzo: "Il linguaggio
istituzionale deve ritrovare dignità ed etica: questa urgenza è evidenziata
dalle Acli provinciali di Arezzo in seguito all’agghiacciante dichiarazione di
Rossella Angiolini relativa al delitto di Saman. L’associazione, preso atto
delle dimissioni della stessa Angiolini dal proprio ruolo alla guida della
Commissione Pari Opportunità, da tempo evidenzia il degrado della comunicazione
da parte di soggetti con ruoli politici e istituzionali aggravato ancor di più
dall’utilizzo dei social network su cui spesso i pensieri vengono condivisi
senza filtro. La dimostrazione più recente e più grave arriva proprio dal
linguaggio e dai concetti espressi sul caso Saman da parte dell’avvocato
Angiolini che sono caratterizzati da sessismo e che risultano fortemente lesivi
della dignità delle donne, con messaggi diametralmente opposti a quello che
dovrebbe essere lo scopo della commissione Pari Opportunità di rimozione di
comportamenti discriminatori e sessisti. Le Acli ribadiscono la necessità delle
istituzioni di ogni grado (politiche, sociali, sindacali ed economiche) di
tornare ad essere un punto di riferimento anche etico e morale del territorio a
partire dalla comunicazione, acquisendo credibilità e recuperando il ruolo di
esempio per le giovani generazioni".
Crociata contro il femminicidio? No,
razzismo. La vicenda di Saman ha scatenato l’ira
contro l’Islam, ma noi siamo meno violenti? Fabrizio Mastrofini su Il Riformista
il 17 Giugno 2021. I “cattivi” stanno “sicuramente” tutti dalla parte
dell’Islam. È l’ultima parola nel dibattito che infiamma il web, i giornali, i
social: la ragazza pachistana uccisa dai suoi parenti perché ha rifiutato un
matrimonio combinato è l’ultimo esempio di violenza in nome della religione da
parte dei crudeli musulmani. Già, ma siamo davvero sicuri che la violenza
religiosa stia tutta e sempre da una parte sola? Siamo sicuri che la
nostra Italia dove i femminicidi imperversano e gli incidenti sul lavoro ogni
giorno riportano casi allucinanti, sia indenne da matrimoni combinati o forzati
o da stigmatizzazioni in base alle preferenze sessuali, religiose, culturali?
C’è da andarci più piano con i giudizi: il fondamentalismo religioso non è mai
sconfitto una volta per tutte e risorge con motivazioni economiche, politiche,
sociali, o peggio ancora per strumentalizzazioni partigiane. Intanto guardiamo
storicamente la “cosa”. Ogni religione è una galassia tutt’altro che monolitica.
L’Islam ad esempio è sciita o sunnita – e già sono due. Ma consideriamo che la
fascia del Nord Africa, lo stesso Medio Oriente, o
il Bangladesh, il Pakistan, diverse zone della Cina, dell’India, tutta
l’Indonesia, sono portatici di forme diverse e di pratiche diverse nei rapporti
tra società e religione con lo Stato. A guardare meglio esplodono differenze
teologiche ed ermeneutiche notevoli. I “coranisti” ad esempio negano
l’importanza della “Sunna”, la raccolta di detti e precetti che indicano come
vivere da buon musulmano e formano, dopo il Corano, il secondo “pilastro” della
religione. Per i “coranisti” vale solo il Libro Sacro e hanno come principale
esponente il principe ereditario dell’Arabia Saudita: in un’intervista
televisiva il 27 aprile ha richiamato il Corano come fonte suprema di governo,
la Costituzione del paese. Sarebbe una rivoluzione perché significherebbe
lasciarsi alle spalle tutti i testi normativi elaborati nei secoli e attenersi
al solo Libro, lasciando uno spazio molto più ampio di adeguamento della fede
alla realtà in costante trasformazione. In qualche misura – con le dovute
cautele, ovviamente – i “coranisti” assomigliano al protestantesimo del Lutero
in versione “sola Scriptura” che voleva fare piazza pulita delle interpretazioni
successive e dare alle persone la possibilità e la libertà di leggere
la Bibbia senza passare per la casta del clero. Nel mondo cattolico – per
limitarci solo a questo – siamo sicuri di essere immuni dall’estremismo nel nome
della religione? Può rispondere di sì solo chi faccia finta di non vedere le
varie forme di “alleanza cattolica” o le sigle che inneggiano a “Lepanto” e alla
sua attualità – grande battaglia che ha rigettato in mare la progettata
invasione islamica – o a chi non si imbatta in rete e nei social in quei gruppi
di “chiesa militante” che nel nome di un’interpretazione rigida della “legge
naturale” condannano qualsiasi “differenza” politica, religiosa, culturale o –
eresia! – la differenza di “genere”. E nel nome dell’ortodossia più compatta
danno dell’eretico al Papa e fermano l’orologio della storia al Concilio di
Trento, tollerando il Vaticano I. Il Vaticano II semplicemente non esiste.
Lavorano in maniera sotterranea, ed emergono nei casi in cui serve, tipo quando
a Roma il terzo Municipio vorrebbe ristrutturare Piazza Sempione e spostare un
po’ la statua della Madonna. Mal gliene incolse all’improvvido presidente di
Municipio, che ha dovuto fare marcia indietro rispetto alle manifestazioni di
protesta. Un po’ vere manifestazioni, un bel po’ strumentalizzate. Perché dietro
il simbolismo religioso si cela un forte senso di appartenenza culturale. Poi
nella pratica i dettami della religione non si seguono affatto e a messa ogni
domenica non ci si va. Però l’appartenenza religiosa è sentita come identitaria.
Ed è avallata da un clero e da una gerarchia cui piacciono le folle, poco
importa il resto. Basta che si veda gente attorno tipo processione, altrimenti
si soffre della paura di estinguersi. Esiste naturalmente un potente antidoto,
anzi più di uno. A patto di saperli usare e dosare. Ad esempio
il cristianesimo (ambito più grande del cattolicesimo) sarebbe (dovrebbe essere)
pluralista e non monolitico per definizione e per caratteristiche fondative. La
Trinità è garanzia di pluralismo, nella dialettica tra Spirito – “carisma”,
ispirazione, passione – e la razionalità del Padre che è Creatore di tutti e del
Figlio che ci rende partecipi e consapevoli della presenza di Dio nella storia.
Oltre alla teologia ci sono i Vangeli: ci sarà un motivo se per i cristiani ce
ne sono 4 ufficiali più gli Atti degli Apostoli e le Lettere (soprattutto San
Paolo), mentre altre religioni hanno un unico testo sacro. Anche così la
pluralità dei testi non ha messo al riparo i cristiani dal macchiarsi di tante
atrocità storiche, dai genocidi allo sterminio dei dissidenti. Dimenticando la
vicenda della pagliuzza nell’occhio dell’altro per non guardare la trave nel
mio, o quel fulminante “chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Come la
psicologia della religione sa bene, dietro l’appartenenza religiosa si giocano
complessi e sofisticati meccanismi identitari e debolezze di personalità, che
possono venire sfruttate da agitatori senza scrupoli, in cambio delle promesse
del paradiso a portata di mano. Se l’istinto “gregario” può dominare chi
appartiene a una religione – farsi dire dal prete di turno cosa è giusto o
sbagliato – esiste per fortuna una generazione nuova che vuole coniugare
appartenenza religiosa a capacità di giudizio e trova nella fede uno stimolo per
la libertà. Come la giovane pachistana che voleva riaffermare un modo di
credere, senza per questo dover per forza obbedire a decisioni prese da altri,
sia pure i genitori, e sempre nel nome della fede. Come spesso ripete Papa
Francesco, la religione è libertà interiore per ascoltare la voce di Dio nella
vita; la religione è misericordia e dialogo; meno precetti rigidi e più
attenzione al prossimo. Già, ma non a tutti piace, soprattutto quando si toccano
interessi finanziari ed economici o quando “ne va” della reputazione di una
famiglia o della libertà di una figlia o di un figlio. Lì scatta la religione
intesa in senso repressivo, con esiti drammatici. O forse si dovrebbero chiamare
le “cose” con il loro vero nome: chi uccide, umilia, delinque mettendosi addosso
un manto religioso, non è un fanatico. È un criminale, un furbo che cerca alibi
e giustificazioni per far sembrare meno grave il suo delinquere. E i leaders
religiosi – tutti insieme, papi, rabbini, parroci, imam – dovrebbero prenderlo e
consegnarlo alle autorità. Forse così finirebbe il terrore nel nome di qualche
Dio.
Fabrizio Mastrofini. Giornalista e saggista
specializzato su temi etici, politici, religiosi, vive e lavora a Roma. Ha
pubblicato, tra l’altro, Geopolitica della Chiesa cattolica (Laterza 2006),
Ratzinger per non credenti (Laterza 2007), Preti sul lettino (Giunti, 2010), 7
Regole per una parrocchia felice (Edb 2016).
"Troppo silenzio sul caso.
Razzismo delle femministe".
Manila Alfano l'8 Giugno 2021
su Il Giornale. Il "mea culpa" della giornalista: "Fosse stata una ragazza
italiana ne avremmo parlato molto di più". Ha puntato il dito perché attorno
alla storia di Saman ha sentito troppo silenzio. Ma prima lo ha puntato contro
se stessa. «Niente giustifica noi femministe» ha scritto in un lungo post su
Facebook. Delusa e scandalizzata, così si è sentita Ritanna Armeni, classe 1947,
giornalista e scrittrice, che di battaglie femministe ne ha fatte tante e che
continua a interrogarsi sul movimento di liberazione della donna, lo ha fatto
anche con il suo ultimo libro, Per strada è la felicità (Ponte alle Grazie).
Cosa le ha dato fastidio nella
storia di Saman?
«Il non trovare il dramma. Che
la storia di una ragazza di diciotto anni scomparsa, probabilmente uccisa dalla
sua stessa famiglia, sia passata così, senza clamore, come una notizia normale.
Ma incolpo anche me stessa, e lo dico con grande umiltà. Sento ancora il rimorso
per non aver detto nulla».
Perché questo silenzio?
«Razzismo. Un sottile razzismo
è scattato in me come in molte di noi».
Non mi dica che lei è
razzista...
«Credo che inconsciamente lo
siamo un po' tutti. Certo, se me lo domandassero risponderei di no, ovvio che
non sono razzista. Eppure esistono dei condizionamenti sociali che entrano in
gioco quando meno ce lo aspettiamo. Quando ho letto della sua storia, dentro di
me non è scattato nulla. Come se non mi riguardasse. Come se fosse altro dalla
mia vita. Come se avesse a che fare solo e soltanto con il modo di vivere di
questa famiglia di immigrati».
Se fosse stata italiana non
sarebbe successo?
«Credo proprio di no. Anzi,
avremmo parlato di femminicidio. Con lei no. Come se per lei la parola non
dovesse essere scomodata. Terribile».
Eppure non che il femminicidio
non sia una piaga nel nostro Paese...
«Eppure qualcosa sta
cambiando. Culturalmente intendo. Le donne continuano a essere uccise ma nessuno
osa più dire che lui l'ha fatto per amore. Le parole cambiano la cultura,
cambiano l'essere umano. E noi femministe serviamo anche a questo. A squarciare
il velo. A far riflettere su cose che ci sembrano normali, ma che di normale non
hanno niente».
Perché una femminista si
dovrebbe sentire più in colpa?
«Questa ragazza voleva quella
libertà che il nostro mondo occidentale le aveva mostrato e offerto. Poi
l'abbiamo lasciata sola. Eppure in Italia abbiamo dovuto attendere fino al 1981
per buttare nel cestino il delitto d'onore. Se le femministe, e le donne in
generale, non riescono a vedere uno stretto collegamento tra la battaglia per i
loro diritti e la morte di una ragazza che voleva difendere la sua libertà,
allora abbiamo perso qualcosa di fondamentale per strada».
Cosa è successo alle
femministe?
«Purtroppo credo che la
battaglia delle donne si sia ristretta alle proprie ragioni».
Le femministe di oggi sono più
egoiste di ieri?
«Rinchiuse nella difesa delle
nostre libertà abbiamo perso di vista il resto. Noi lottiamo per temi sacrosanti
e terribilmente seri: le molestie, la parità di genere, il divario salariale. Ma
in questo dibattito occorre trovare uno spazio anche per storie così drammatiche
come quelle di Saman. Perché invece nessuna ne ha parlato? Perché si racconta il
fatto senza scavare come se fosse un quadretto da lasciare così, senza scavare a
fondo?».
Abbiamo forse perso la
speranza di integrazione?
«Ci sono stati altri casi
purtroppo in Italia. La storia di Hina Saleem ad esempio, uccisa nel 2006 dal
padre che non la accettava perché voleva vivere da occidentale, ma allora c'era
stata una attenzione diversa. Noi dobbiamo tornare a farci domande».
"Saman? A sinistra femministe a giorni
alterni", "E per la destra son tutti cattivi".
Francesco Curridori il 4 Giugno 2021 su Il Giornale. Per la rubrica Il bianco e
il nero, sul caso di Saman Abbas, abbiamo intervistato la deputata dem Lia
Quartapelle e la forzista Gabriella Giammanco. Fa ancora discutere caso di Saman
Abbas, la 18enne d'origine pachistana scomparsa da un mese dopo essersi
rifiutata di accettare un matrimonio combinato. Per la rubrica Il bianco e il
nero, su questo tema, abbiamo intervistato la deputata dem Lia Quartapelle e la
forzista Gabriella Giammanco.
Cosa pensa del caso Saman?
Giammanco: "Una tragedia, una storia terribile ma
più comune di quanto si immagini. Sono tante le giovani donne vittime di
violenza di matrice islamica, costrette a sposarsi dalla famiglia che sceglie
per loro il futuro marito. Se si ribellano a un matrimonio combinato vengono
rapite o, addirittura, uccise. Ricordo il caso di Hina, a cui il padre tolse
brutalmente la vita perché voleva vivere da occidentale, o la terribile fine di
Sanaa, uccisa perché voleva sposare un italiano. C’è da chiedersi quante siano
in realtà le storie di costrizioni e soprusi sommerse...L’Italia dovrebbe aprire
una seria indagine su questo fenomeno, per capirne la portata e mettere a punto
misure efficaci per contrastarlo".
Quartapelle: "Continuo a sperare, anche contro
l’accumularsi di notizie, che Saman sia ancora viva. È un crimine orrendo,
contro natura, quello che porta dei genitori a uccidere la figlia per tutelare
il proprio onore. Spero che la storia di Saman finisca in modo diverso dalla
storia di Hina Saleem, la ragazza di origine pachistana uccisa in provincia di
Brescia nel 2006 dai parenti per essersi sottratta a un matrimonio combinato, o
di Sana Cheema, la ragazza italo-pachistana uccisa nel 2018 in Pakistan dopo
aver rifiutato un matrimonio combinato".
Perché le femministe si stracciano le vesti sul
sessismo, sulla Rai e altro, ma tacciono su questo tema?
Giammanco: "Evidentemente sono femministe a giorni
alterni. C’è molta ipocrisia, si glissa su eventi così gravi ma si grida allo
scandalo per questioni insignificanti. Il testo di una canzone o un complimento
suscitano indignazione ma sarebbe bene guardare alla sostanza più che alla
forma. La difesa dei diritti non dovrebbe avere colore politico né etichette.
Femministe o meno, dovremmo difendere le donne oppresse dall’estremismo
islamico. In nome di questa religione si diventa ciechi. Si commettono attacchi
terroristici, si uccidono persone innocenti, si considerano le donne schiave
degli uomini e se ne calpesta la volontà. Alcune donne, ho notato con sconforto,
sono arrivate a fare apologia del burqa perché lo considerano espressione di
libertà quando, al contrario, è simbolo dell’oppressione per eccellenza. Oriana
Fallaci ha raccontato bene cosa fosse questo indumento nel suo primo reportage
sull’Islam: 'Vi sono donne nel mondo che ancora oggi vivono dietro la nebbia
fitta di un velo come attraverso le sbarre di una prigione'”.
Quartapelle: "Perché i giornali non danno spazio a
quanto femministe e persone di buona volontà stanno dicendo e facendo sul caso
Saman? C’è stata una grandissima mobilitazione civile e politica sul caso.
Venerdì 28 maggio nel comune di Novellara, il comune di Saman, è stata
organizzata dalla sindaca una fiaccolata di solidarietà. Ci sono state
dichiarazioni di tante e tanti, tra cui il collega Andrea Rossi, a sostegno di
Saman. Non ne ho visto traccia né sul vostro giornale, né su tanti altri mezzi
di informazione. Non è abbastanza tragica la vicenda in sé? Che senso ha
strumentalizzare politicamente la scomparsa di una giovane donna?".
Perché una parte della sinistra sembra
sempre voler proteggere l'islam a prescindere?
Giammanco: "È una difesa meramente ideologica. Si
difende il multiculturalismo a prescindere, dimenticando che una società
multiculturale funziona se tutti ne accettano i valori e i principi fondanti
altrimenti si rischia il caos. Una certa sinistra ha nei confronti del tema
'donne e Islam' lo stesso approccio che ha con gli omosessuali: in Italia spinge
per dare loro, giustamente, maggiori tutele ma poi fa finta di non vedere che in
alcuni Paesi islamici vengono perseguitati e lapidati. Dobbiamo smetterla di
avere paura di rivendicare la nostra cultura occidentale, la nostra identità, il
nostro stile di vita. Mi viene in mente il paradosso della tolleranza di Popper,
non possiamo tollerare gli intolleranti perché corriamo un grande rischio: una
collettività caratterizzata da tolleranza indiscriminata è destinata ad essere
dominata dalle frange più intolleranti presenti al suo interno".
Quaratapelle: "La lotta contro il terrorismo di
matrice islamista, contro i matrimoni forzati, i delitti d’onore, contro ogni
forma di oscurantismo, estremismo religioso e fanatismo, devono vedere unita la
politica. In questi anni ho partecipato a varie manifestazioni di ragazze
musulmane che si ribellavano a imam che avevano proibito l’uso della bicicletta
alle musulmane, a iniziative di associazioni di donne musulmane contro la
violenza sulle donne. Non ho mai visto esponenti della destra. Come mai? Forse
perché per una certa destra è più semplice dire che tutti i musulmani sono
cattivi, e così si occultano e dimenticano le giuste battaglie di donne
musulmane che lottano per essere libere?".
Può esistere un islam moderato?
Giammanco: "Sono molto scettica su questo...".
Quartapelle: "Esistono gli imam che ieri in Italia
emesso una fatwa contro i matrimoni combinati forzati e l'altrettanto tribale
usanza dell'infibulazione femminile. Più che le etichette mi interessano i
fatti, e questi sono fatti importanti".
Come si possono prevenire altre situazioni di
questo tipo?
Giammanco: "L’Italia con il PNRR sta affrontando
seriamente la questione di genere, c’è grande attenzione alla parità salariale,
al gender gap, alle quote rosa, alle misure a sostegno della natalità, alla
conciliazione dei tempi di vita familiare coi tempi del lavoro. Le istituzioni
possono fare molto così come la scuola. Nel 2021 ci sono donne che nel nome di
un credo religioso vengono ancora sottoposte a coercizione fisica e morale.
Ecco, credo che la politica dovrebbe iniziare ad accendere un faro su di loro,
lasciando da parte ogni ideologia per mettere in campo ogni strumento possibile
per prevenire certi abusi".
Quartapelle: "Quello che colpisce del delitto di
Hina, e quello che colpisce della storia di Saman, è che in entrambi i casi le
ragazze, dopo un periodo di lontananza, sono tornate a casa. Ed è in quel
frangente che Hina è stata uccisa e Saman è scomparso. Sono ragazze che si sono
rese conto del pericolo, che hanno cercato aiuto, e che poi però hanno risposto
alla chiamata della famiglia. È su questo che si deve lavorare. Sulla
prevenzione, sulle misure di sostegno, e sul non lasciare mai sole queste
ragazze, che vivono un dramma esistenziale che fatichiamo a capire. Queste
ragazze sono ragazze che vivono divise tra la propria voglia di libertà e
l’affetto che provano per la propria famiglia, per quanto questa possa essere
soffocante e pericolosa. Vanno aiutate, sostenute, liberate. È a loro che
dobbiamo pensare, non a fare una polemica politica basata sul nulla che non
serve davvero a evitare altre morti".
Francesco Curridori. Sono originario di un paese
della provincia di Cagliari, ho trascorso l’infanzia facendo la spola tra la
Sardegna e Genova. Dal 2003 vivo a Roma ma tifo Milan dai gloriosi tempi di
Arrigo Sacchi. In sintesi, come direbbe Cutugno, “sono un italiano vero”.
Se credi che il femminismo islamico non
esista fai un salto virtuale a Glasgow. Attiviste e
scrittrici. Per dieci giorni di dibattiti sui diritti delle donne musulmane. Che
non sono affatto zitte e sottomesse come crede l’Occidente. Dalla newsletter de
L’Espresso sulla galassia della cultura araba. Angiola Codacci-Pisanelli su
L'Espresso/La Repubblica il 15 giugno 2021. Si parla molto di femminismo
islamico in questi giorni in Italia: è un effetto delle discussioni – accese e
non sempre condivisibili ma comunque positive – che hanno accompagnato la
scoperta del tragico destino di Saman Abbas, la diciottenne italo- pachistana di
Novellara fatta uccidere dai genitori perché non accettava che fossero loro a
decidere chi farle sposare. O meglio, si ripete sempre lo stesso concetto: il
femminismo islamico non esiste, sono due termini che non possono stare nella
stessa frase. È innegabile che la via dell'emancipazione femminile sia
particolarmente difficile nei Paesi islamici, e anche nelle comunità islamiche
sparse nel resto del mondo. Ma non è un buon motivo per negare gli sforzi delle
donne – attiviste, avvocate, mediche, scrittrici – che lavorano in questo senso,
nei paesi arabi e nel resto del mondo. Per rendersi conto di quanto lavoro è
stato fatto non bisogna andare lontano. Basta aprire “Femminismo interrotto”
dell'afrodiscendente inglese Lola Olufemi (Giulio Perrone Editore). Un saggio
che fa il punto sulle lotte per i diritti delle donne, che in un capitolo
particolarmente denso chiarisce punto per punto le difficoltà che le femministe
di origine araba incontrano perché combattono su due fronti: il patriarcato
islamico e il paternalismo “bianco”, che le vede sempre bisognose di un
salvatore europeo capace di liberarle da pregiudizi più forti di loro. Arriva
dalla Gran Bretagna un'altra occasione per rendersi conto di quanto sia
effervescente il campo di quel femminismo islamico che tanti e tante occidentali
considerano morto in culla. Inizia venerdì 18, e andrà avanti per dieci giorni,
la nuova edizione del Dardishi Festival, evento annuale di una no-profit di
Glasgow dedicata alla produzione culturale di donne arabe e nordafricane.
Quest'anno il festival sarà su zoom, quindi a disposizione di una platea
virtualmente infinita. In programma, incontri e conferenze centrati su ogni
aspetto dei diritti delle donne e delle minoranze di genere e tenuti da persone
arabe o nordafricane. Molti sono centrati sulla letteratura: “Nawal El Saadawi:
Fierce, Fearless, Feminist!” è un omaggio alla scrittrice, psichiatra e
attivista egiziana scomparsa nel marzo scorso. Lo terrà Ebtihal Mahadeen, che
cura anche un focus su “Leggere voci femministe dal Medio Oriente e dal
Nordafrica”, dedicato ad autrici e testi impegnati su temi di sessualità,
identità di genere e vita quotidiana nei Paesi della zona. Politica, guerra e
vita quotidiana si mescolano anche in “Palestine is a Feminist Issue” con
Jennifer Mogannam e Nesreen Hassan, mentre “Mainstream Subaltern Writing”
incrocia le esperienze di quattro scrittrici provenienti da Gran Beratgna,
Canada, Egitto e Sudan per tracciare una via di espressione per donne che vivono
in un contesto di profonda inferiorità sociale. Film e documentari racconteranno
gli sforzi delle comunità che combattono «sorveglianza e censura» nei paesi
arabi e nella diaspora. “Jasad and the Queen of Contradictions” racconta le
controversie nate intorno alla rivista “Jasad” (il corpo) fondata dalla
scrittrice e giornalista libanese Joumama Haddad, conosciuta in Italia per saggi
come “Ho ucciso Shahrazad. Confessioni di una donna araba arrabbiata” e Superman
è arabo. Su Dio, il matrimonio, il machismo e altre invenzioni disastrose".
L'organizzazione segnala gli incontri che non sono consigliati a un pubblico di
minorenni, e propone al pubblico abbonamenti a prezzi diversi, da zero a 10
sterline, da decidere in base ai propri interessi e alle possibilità economiche:
«Non ci sarà nessun controllo, ma vi chiediamo solo di essere onesti perché
tutti possano godere di questi eventi». In programma, anche appuntamenti più
leggeri. Come un documentario sulla rappresentazione dell'harem nei film di
Hollywood, lezioni di yoga e di “terapia somatica”. Per finire, una passeggiata
in podcast, una colonna sonora da ascoltare mentre si cammina in qualsiasi posto
sentendosi immersi in un paesaggio ancestrale. L'accompagnamento è fatto da
suggestioni auditive scelte da Layla Feghali, libanese cresciuta in California
che studia culture e medicina ancestrale della zona d'origine della sua famiglia
e delle comunità nativo-americane dell'ambiente in cui è cresciuta: un mix di
cultura araba e degli indiani d'America che può dare risultati sorprendenti.
Quelle Saman uccise in nome della sharia.
Serenella Bettin il 15 Giugno 2021 su Il Giornale.
Quante Saman ancora? In Italia e in Europa l'elenco delle donne vittime della
Sharia o dell'immigrazione incontrollata è lungo. Quante Saman ancora ci
dovranno essere prima che una certa parte politica arrivi a chiamare le cose con
il loro nome senza ricorrere a espedienti ridicoli, ingannevoli, persuasivi, che
non tengono conto della realtà. Saman Abbas è sparita, o è stata fatta fuori,
non perché vittima di femminicidio come ha esordito qualcuno dopo giorni di
imbarazzante silenzio, ma è sparita perché Saman Abbas negli occhi aveva la
voglia di vivere, voleva vivere all’occidentale, ma era stata promessa in sposa.
E si è ribellata. Saman Abbas non è l’unica. Sono vittime di mariti padroni,
schiave di estremisti islamici. Figlie di padri padroni, mogli di uomini con
altrettante mogli. Sono madri di quelle figlie che a loro volta diventeranno
vittime. Dietro l’universo femminile concepito dall’Islam violento c’è tutto un
palcoscenico dell’orrore. Ci sono donne in Afghanistan costrette a vivere dentro
a sacchi di stoffa, dove il niqab, che molti in Italia hanno sbandierato come
simbolo dell’integrazione e del rispetto verso le altre culture, lascia scoperti
soltanto gli occhi. Ci sono donne anche in Italia che preferiscono farla finita
anziché finire condannate a spose di chi è stato loro destinato. E ci sono donne
in Italia morte ammazzate seviziate e stuprate da mani e occhi che le vedevano
troppo occidentalizzate. O prese e ammazzate da riti tribali ancestrali, messi
in pratica da chi ha abusato di loro e poi le ha lasciate lì agonizzanti a
morire. Le ha tagliate a pezzi. Le ha fatte fuori. Ha squarciato loro il ventre
come si squarciano gli animali. Pamela Mastropiero è stata ammazzata da un
nigeriano il 30 gennaio 2018, il suo corpo venne ritrovato mutilato in due
valigie. Desirée Mariottini, 16 anni, drogata, stuprata, violentata a turno. Si
erano messi in fila per dilaniarle il corpo. Poi quando hanno visto che non dava
più cenni di vita l’hanno lasciata lì agonizzante a morire. Due ragazze vittime
della stessa mano: l'immigrazione incontrollata. Rachida Radi invece, 35 anni,
egiziana, rientra nei delitti d’onore. Voleva integrarsi, avvicinarsi al
Cristianesimo ma è stata uccisa a martellate dal marito nel 2011 perché viveva
all’occidentale. Lui le ha sfondato il cranio. Hina Saleem, classe 1985,
pachistana, è stata ammazzata dai parenti a coltellate l’11 agosto 2006 perché
non voleva adeguarsi agli usi tradizionali della cultura d'origine. Venne
sgozzata e sepolta nell'orto di casa a Brescia. Quando la trovarono aveva la
testa rivolta verso la Mecca e il corpo avvolto in un sudario. Sanaa Dafani, di
origini marocchine, a Pordenone è stata ammazzata dal padre a coltellate in un
bosco, mentre era in compagnia del fidanzato italiano. La tradizione non
consente di vivere con un uomo senza sposarsi. Souad Alloumi invece è scomparsa
nel 2018. E ce ne sono tante altre. Sono ragazze belle, solari, radiose, con
quegli occhi luminosi e raggianti. Le loro colpe: rifiutarsi di indossare il
velo islamico, vestire all'occidentale, fumare qualche sigaretta, farsi qualche
selfie, indossare jeans, frequentare amici cristiani, avere amici non musulmani,
studiare o leggere libri “impuri”, ascoltare musica o suonare, voler divorziare,
essere troppo indipendenti emancipate. Portare disonore alla famiglia. Accade in
Italia e anche nel resto d’Europa. Sohane Benziane è stata torturata e bruciata
viva il 4 ottobre del 2002 in Francia. Le hanno dato fuoco con un accendino. La
gente in diretta assisteva alla sua morte. Aveva 17 anni. In Svezia Fadime
Sahindal è stata uccisa a colpi di pistola perché si era avvicinata alla cultura
occidentale. È stata uccisa dal padre dopo essersi segretamente incontrata con
la madre e le due sorelle più piccole, alle quali era stato vietato di vederla.
Morì tra le braccia della madre. Era stata espulsa dalla famiglia quattro anni
prima per una sua relazione con un giovane svedese-iraniano. Ci hanno fatto un
libro. Il The Guardian riporta come Sahindal, 26 anni, abbia “pagato il prezzo
più alto per essersi innamorata dell'uomo sbagliato e aver sfidato i valori
patriarcali della sua cultura. Suo padre era un contadino curdo analfabeta che
si trasferì in Svezia nel 1980. La sua famiglia arrivò quattro anni dopo, quando
Fadime aveva sette anni. I suoi genitori la scoraggiarono dal parlare ai bambini
svedesi a scuola. Invece, le è stato detto che l'importante era tornare in
Turchia e sposarsi. È cresciuta sotto il controllo di suo padre e del fratello
minore”. Anche a Heshu Yones, curda irachena, molto bella, hanno tagliato la
gola perché aveva un fidanzato cristiano. Aveva 16 anni. La figlia secondo il
padre era diventata troppo “occidentalizzata” e aveva intrattenuto una relazione
contro i suoi ordini. Rukhsana Naz a Londra, addirittura ancora nel lontano
1998, è stata uccisa perché aveva rifiutato un matrimonio combinato. Aveva 19
anni. Per non parlare dei padri padroni che tengono segregate in casa le mogli,
le picchiano, le violentano, non accettano che le figlie possano diplomarsi.
Questo fenomeno che per i sordi viene derubricato come violenza domestica, si
chiama Sharia. Quello che la sinistra si ostina a chiamare femminicidio.
Serenella Bettin
"Una "cultura" che punisce le donne",
Samira sparì come Saman. Rosa Scognamiglio il 15
Giugno 2021 su Il Giornale. La procura di Ivrea ha archiviato il caso di
scomparsa di Samira Sbiaa. Il marito della 32enne era stato indagato per
omicidio 17 anni dopo. Nessuna verità per Samira Sbiaa, la 32enne di origini
marocchine residente a Settimo Torinese di cui si sono perse le tracce dal 7
aprile del 2002. Lo scorso 8 giugno la Procura della Repubblica di Ivrea ha
deciso di archiviare il fascicolo per le indagini di scomparsa dopo che, appena
tre anni fa, il caso sembrava fosse giunto a una svolta decisiva. Nel 2017 il
marito della donna, Salvatore Caruso, ex guardia giurata convertita
all'Islam con il doppio degli anni di Samira, era finito nel registro degli
indagati con l'ipotesi di reato per omicidio volontario. Ma la pista delittuosa,
nel contesto della relazione coniugale, è scemata a fronte di un carico
probatorio inconsistente. "Le indagini sono state tardive e Caruso non è stato
correttamente interrogato sui fatti", spiega alla nostra redazione la
criminologa Ursula Franco, esperta in Statement Analyst, una tecnica di analisi
del linguaggio che permette di ricostruire i fatti relativi a un caso
giudiziario attraverso lo studio di ogni parola presente nelle dichiarazioni di
sospettati, indagati e testimoni. Resta il dubbio e il "giallo" di una scomparsa
misteriosa. Dov'è finita Samira? "Dato che Samira è scomparsa improvvisamente
senza lasciare traccia, l’accusa dovrà dimostrare che sia stato il marito a
essere l'autore di un presunto reato. E non sarà facile poiché non abbiamo una
vittima, né una scena del crimine. In questi anni non vi è stata alcuna traccia
della sua esistenza: un bancomat, una carta di credito, nulla. Scomparsa",
spiega a ilGiornale.it il professor Simone Borile, antropologo della violenza,
criminologo e docente di antropologia della violenza presso il corso di studio
triennale in Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale del Campus Ciels
di Padova Brescia e Roma.
La scomparsa. Samira Sbiaa è scomparsa da Settimo
Torinese il 7 aprile del 2002. Era approdata in Italia a seguito
del matrimonio con Salvatore Caruso, una ex guardia giurata col doppio dei suoi
anni, convertito all'Islam. Lui e Samira si erano conosciuti in Marocco tramite
un parente della donna e, dopo le nozze in Africa, si erano stabiliti
nell'hinterland torinese. Lei, appena 32enne, usciva pochissimo di casa e mai da
sola. Era stato Caruso, nel 2002, pochi giorni dopo la sua scomparsa, a
segnalare l'allontanamento denunciando la moglie per appropriazione indebita di
denaro. A suo dire, Samira avrebbe abbandonato volontariamente il tetto
coniugale portando via con sé via poco più di un milione di vecchie lire. Poi
però, qualche mese dopo, aveva ritirato la denuncia e chiesto il divorzio. "Io
sono stato bidonato. Sono io la vittima", rispondeva Caruso ai cronisti che lo
incalzavano con le domande quando, tre anni fa, finì sotto la lente
d'ingrandimento degli investigatori. Ma la sua versione dei fatti, spesso
contraddittoria, non ha mai convinto fino in fondo nessuno.
Le indagini 17 anni dopo. Dopo 17 anni di silenzi,
il giallo della scomparsa di Samira sembrava fosse giunto a un punto di svolta.
La procura di Ivrea aveva deciso di aprire un fascicolo per omicidio
volontario in cui risultava indagato Salvatore Caruso. Era stato il padre della
32enne a chiedere di indagare sull'ex guardia giurata tramite un'amica della
figlia. "Samira raccontava alla sorella di essere stata segregata, di mangiare
cibi scaduti – spiegò al tempo, Touria Bouksibi, dell'associazione 'Donne e
bambini in difficoltà' – Per questo la famiglia si era rivolta a me. Vogliono
sapere che fine abbia fatto la figlia". Così nella primavera del 2017 i
carabinieri avevano eseguito un primo sopralluogo nell'appartamento coniugale,
sequestrando 4 pistole, una carabina e diversi proiettili, tutti detenuti
regolarmente. Agli inizi di marzo, i militari dell'arma, guidati dal capitano
Luca Giacolla, assieme alla polizia locale, erano tornati nella palazzina a due
piani al civico 12 di via Petrarca, a Settimo Torinese, nella speranza di
trovare qualche traccia della donna. Dapprima avevano svuotato la fossa settica
poi, avevano perlustrato il garage della proprietà: il sospetto era che Samira
fosse stata uccisa e sepolta in casa. Alcuni vicini, anni prima, avevano
raccontato di aver sentito dei rumori provenire dalle mura di una delle rimesse.
E Caruso, accumulatore seriale, da tempo non le utilizzava più lasciando il suo
Doblò sempre in cortile. Raggiungere i box, strapieni di oggetti accatastati
l'uno sopra l'altro, non era stato facile. All'interno erano accatastate
finestre rotte, secchi sporchi, televisori inutilizzabili, persino stracci e
vecchi vestiti. Per non parlare dei sacchi della spazzatura maleodoranti, comodo
rifugio per topi e altri animali.
Le ricerche coi cani molecolari. Il 21 marzo del
2017 la verità sembrava fosse a un passo. In casa di Caruso intervennero
nuovamente i carabinieri, stavolta in compagnia dei cani molecolari del nucleo
cinofilo dell'Arma di Bologna e degli esperti Sis (Sezione investigazioni
scientifiche). Dopo circa 8 ore di attività, Aska e Simba, due pastori tedeschi
in grado di segnalare la presenza di cadaveri in stato di decomposizione nel
sottosuolo, fiutarono tracce sospette nel giardino e al piano terra
dell'abitazione. A quel punto gli investigatori decisero di rivangare la
superficie circostante la palazzina di via Petrarca nella speranza di ritrovare
il corpo di Samira. Sul luogo arrivò anche una squadra di operai, muniti di
picconi e martelli, un escavatore e un camion per lo spurgo delle acque nere.
Dal cortile furono recuperate una scarpa da donna e una serie di "ossa piatte",
verosimilmente uno sterno e una testa d'omero. I reperti furono analizzati dalla
genetista Monica Omodei del laboratorio di analisi di Orbassano che accertò
trattarsi di frammenti ossei di animali. Da quel momento le indagini subirono
una battuta di arresto. Lo scorso 8 giugno il procuratore di Ivrea Giuseppe
Ferrando, a capo dell'inchiesta, ha annunciato l'archiviazione del caso. "Ad
oggi non abbiamo elementi per sostenere in giudizio che Samira sia stata uccisa
dall'ex marito", ha riferito alla stampa. Eppure troppe cose ancora non tornano.
Le dichiarazioni di Caruso. Durante
gli scavi nell'appartamento di via Petrarca, Caruso spiava i lavori degli uomini
con le tute bianche da dietro le imposte chiuse. Quando gli dissero che era
indagato per omicidio, si sfogò coi cronisti dicendo che erano "soltanto balle"
che "Samira era fuggita" e lo aveva pure derubato. "Scappata dove, signor
Caruso?" gli domandarono. E lui spiegò che era tornata in Marocco: "L'ho
accompagnata io stesso a Torino a prendere il bus per tonare giù. Voleva
raggiungere la famiglia per il Ramadan". "Guardate che sono io la vittima di
questa storia", si difendeva. Poi, raccontò di averla cercata dopo qualche mese
che era partita. Di aver chiamato i parenti e gli amici. Disse di averla
denunciata per i "beni spariti" – a suo dire, circa 1 milione di vecchie lire -
e per "abbandono del tetto coniugale". Le sue dichiarazioni furono spesso
contraddittorie, a tratti confuse e approssimative. Mentiva? "Caruso non ha mai
negato in modo credibile di aver ucciso sua moglie Samira e ha preso le distanze
da lei - spiega la criminologa Ursula Franco - Si è riferito a lei con 'questa
persona', gender neutral, un modo per prenderne le distanze. È poi inaspettato
che il Caruso abbia detto 'Dovevo impiccarmi pure io. Dovevo impiccarmi?' e 'non
si è fatta più viva' e 'non s’è fatta viva', viene da chiedersi a cosa stesse
pensando. Servirebbe un interrogatorio ben condotto sui suoi movimenti del
giorno della scomparsa di Samira".
Analogie con la vicenda di Saman Abbas. La storia
di Samira Sbiaa suggerisce delle analogie - seppur marginali - con la scomparsa
di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane residente a Novellara di cui non
si hanno più notizie dallo scorso 30 aprile. La procura di Reggio Emilia ha
aperto un fascicolo per omicidio premeditato e occultamento di cadavere in cui
sono indagati il padre, la madre, lo zio e due cugini della giovane. "Ciò che è
avvenuto a Saman è definito reato culturalmente orientato. Donne che vengono
punite, e uccise poiché infrangono codici e riferimenti della cultura di origine
- spiega il professor Simone Borile - Una vergogna cui solo la stessa famiglia,
per evitare il propagarsi dell’onta ricevuta, può porvi rimedio. Sono reati
commessi con chiara predeterminazione, in modalità collegiale, posti in essere
dagli stessi membri della famiglia, obbligati culturalmente a ripristinare un
disonore derivante da una condotta ritenuta immorale e inadeguata. Questi
episodi di maltrattamenti e di violenze intradomestiche sono, ahimè,
frequentissimi e provengono da un conflitto culturale scatenato tra aderenza ai
valori della cultura di origine e apertura e verso patrimoni culturali nuovi, in
cui non sempre però i processi di inclusione e di incorporazione valoriale hanno
dato esiti positivi". Resta il mistero e il dramma di due giovani donne che
potrebbero aver pagato a caro prezzo il sogno della libertà negata. "Scomparse".
Rosa Scognamiglio. Nata a Napoli nel 1985 e
cresciuta a Portici, città di mare e papaveri rossi alle pendici del Vesuvio. Ho
conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere nel 2009 e dal 2010 sono
giornalista pubblicista. Otto anni fa, mi sono trasferita in Lombardia dove vivo
tutt'oggi. Ho pubblicato due romanzi e un racconto illustrato per bambini.
Cosa è cambiato
per le donne in Afghanistan dopo vent’anni di presenza militare della Nato e
dell’Italia. La guerra, almeno nelle
dichiarazioni, è stata combattuta anche in nome dei diritti femminili. Ma oggi
resta il Paese più maschilista del mondo. E con il ritiro degli occidentali
torna la paura, non solo dei talebani. Giulia Ferri su L'Espresso il 15 giugno
2021. Vent’anni dopo, la missione in Afghanistan è finita. Ma ora c’è da capire
cosa resterà davvero di questa guerra. Il ritiro dei contingenti Nato sarà
completato entro luglio 2021 e lo scorso 8 giugno anche la bandiera italiana è
stata ammainata. Se in questi anni i militari italiani hanno contribuito alla
costruzione di strade, ospedali e scuole, restano non pochi interrogativi sul
raggiungimento degli obiettivi della missione, quelli più volte ripetuti da
tutte le forze politiche in campo: portare stabilità, garantire i diritti umani
e liberare le donne dalla condizione di sottomissione in cui versavano sotto il
regime talebano. Sì perché, almeno a parole, la ventennale guerra d’Afghanistan
è stata combattuta anche per le donne. «Sono intervenuti per cacciare i talebani
e difendere i diritti delle donne. Dopo vent’anni vanno via con un accordo con i
talebani e certamente le donne saranno abbandonate al loro destino». L’amaro
bilancio lo traccia la principessa Soraya d’Afghanistan, nipote di re Amanullah
e della regina Soraya, di cui orgogliosamente porta il nome, sovrani di
Afghanistan dal 1919 al 1929, prima di dover lasciare il Paese e venire in
esilio in Italia. «I miei nonni furono i primi a tentare di modernizzare il
Paese e garantire i diritti delle donne», racconta, «emanando la prima
Costituzione afghana, e di tutta l’Asia, puntando sull’istruzione e
sull’associazionismo femminile». La regina Soraya è stata considerata una delle
prime femministe, tanto influente che il Time Magazine le dedicò la sua
copertina nel 1927. Ma quel progresso fu bloccato allora, come nei decenni a
seguire. Perché la storia si ripete sempre, spiega la principessa Soraya, e
questo vale ancor di più per le donne afghane, che più volte hanno acquisito e
poi visto svanire le loro libertà nel corso del tempo. Oggi la nipote della
regina porta avanti quel processo, sostenendo l’artigianato femminile afgano e
le cooperative come “Azezana”, dove lavorano oltre 400 donne per produrre
foulard di seta o “Kandahar Treasure”, che produce i pregiati ricami di
Kandahar, e promuovendoli in Italia e in Europa. Ci tiene però a sottolineare
che quei pochi diritti conquistati finora dalle donne in Afghanistan, si devono
agli sforzi delle associazioni femminili locali. Proprio con operatrici afghane
lavora Pangea, una delle associazioni italiane presenti sul territorio da più
tempo. A Kabul dal 2003, porta avanti il programma “Jamila”, implementato grazie
a più di trenta ragazze e donne afghane, che oggi lavorano in una decina di
distretti per l’empowerment femminile. Nella capitale Pangea ha anche aperto la
prima scuola per bambini e bambine sordi del Paese, che accoglie circa 600
ragazzi, con classi miste e una squadra di calcio femminile. Le ragazze che si
diplomeranno quest’anno saranno le prime donne sorde afghane a poter accedere
all’università. «La chiave è l’economia, fare in modo che le donne possano
essere indipendenti e autonome, per questo i nostri interventi sono di
microcredito e cerchiamo di fare in modo che tutte abbiano un conto corrente in
banca» spiega Luca Lo Presti, presidente e fondatore dell’associazione. Il
processo di auto emancipazione per migliaia di donne che Pangea ha assistito, è
passato anche da una serie di altri servizi, come l’educazione ai diritti umani,
igienico sanitaria, sessuale, o il supporto ginecologico. Ma passa anche
dall’istruzione maschile. «Le ragazze che sono state nostre beneficiarie, quando
sono diventate mamme, non hanno forzato le figlie al matrimonio, questo perché
abbiamo iniziato con le donne ma abbiamo lavorato poi anche con i mariti e i
figli maschi, altrimenti si sarebbe creato un percorso di consapevolezza
sbilanciato e ulteriore conflitto tra i generi», sottolinea Lo Presti. «In
questi anni abbiamo visto un cambiamento ma solo nelle città, e neanche in tutti
i distretti: al centro di Kabul si vedono donne truccate o sedute al ristorante.
Quello però non è lo specchio dell’Afghanistan: già nelle cittadine ai margini
della capitale non c’è una donna senza velo», spiega ancora il presidente di
Pangea. Che racconta poi come le donne afghane oggi siano più forti, ma anche
che tra le operatrici a Kabul, ci sono diverse paure per il futuro. Il più
comune è che con il ritiro degli occidentali scoppi una guerra civile e che il
ritorno dei talebani possa cancellare i diritti acquisiti. Perché quei diritti
sulla carta ci sono. Dal 2004 l’Afghanistan ha una Costituzione avanzata anche
sul fronte dei diritti: sancisce l’uguaglianza tra i sessi, la parità di
trattamento davanti alla legge, stabilisce una quota minima di deputate. Nel
2008 è stata approvata una legge nazionale contro la violenza e nel 2018 è stato
rinnovato il codice penale con un’intera sezione dedicata alla protezione delle
donne. È vietato il matrimonio tra minori di 16 anni, proibito quello forzato o
compensatorio e i delitti d’onore, in cui gli uomini uccidono mogli, donne o
sorelle, devono essere puniti come qualsiasi altro omicidio. Tutto cambia però
se si sposta lo sguardo dalla forma alla sostanza. Lo dicono i dati e i rapporti
internazionali. Il Gender Inequality Index 2020 del programma delle Nazioni
Unite per lo sviluppo, posiziona l’Afghanistan al 157esimo posto su 162 Paesi,
con solo il 13,2% delle donne che ha accesso a un’educazione secondaria e solo
il 21,6% che lavora o cerca lavoro. Ultimo addirittura su 156 Stati secondo le
stime del Global Gender Gap Report 2021. E critico sull’effettiva applicazione
della legge è anche il report di dicembre 2020 dell’Unama, la Missione Onu in
Afghanistan, che ha segnalato come i delitti d’onore continuino, così come gli
stupri, e che molte donne ricorrono all'auto-immolazione o al suicidio per
fuggire alla violenza, ritenendo che il sistema giudiziario non offra loro reali
garanzie. Ma lo conferma anche la cronaca quotidiana. Il video diffuso lo scorso
aprile di una donna condannata da un tribunale talebano a 40 frustate in una
zona rurale alle porte di Herat, così come l’uccisione di almeno 55 giovani
ragazze lo scorso 8 maggio all’uscita di una scuola nella capitale, sono solo
l’ultima parte di un racconto di violenza estrema nei confronti delle donne che
purtroppo resta la norma. «L’Afghanistan è il Paese più maschilista del mondo».
Ne è convinta la principessa Soraya, che spiega come il problema non siano solo
i talebani, ma una cultura spesso ancora basata su codici tribali, fondati sul
possesso e la difesa delle tre zeta: zan, zard e zamin, rispettivamente donna,
oro e terra. C’è molta violenza, di cui le donne pagano il prezzo più alto,
anche in termini di vite perse: tra il 2010 e il 2020 secondo l’Unama, sono
state uccise 3.219 donne, 390 solo nel 2020. Secondo Soraya l’obiettivo è
alimentare questa violenza negando l’accesso alla cultura: «Per questo si
continua a far esplodere le scuole, a non volere l’istruzione femminile e molti
uomini continuano ad avere maggior interesse a vendere o far sposare le proprie
figlie piuttosto che mandarle a scuola». Al tempo stesso però è convinta che un
miglioramento ci sia stato: «Qualcosa è cambiato se oggi oltre 3 milioni di
bambine possono andare a scuola, se le donne possono essere giornaliste, speaker
radiofoniche o televisive, parlamentari. Non credo invece che i talebani siano
cambiati», conclude. Una delle cose che preoccupa maggiormente le donne afgane è
proprio l’avanzata dei talebani, le cui dichiarazioni sulla volontà di
continuare a garantire i diritti delle donne, ma “sulla base della sharia”,
hanno suscitato più di qualche timore. Non è però l’unica preoccupazione, come
spiega Emanuele Giordana, presidente dell’associazione “Afgana”, giornalista e
scrittore che in Afganistan ha vissuto a lungo e che ha approfondito le
dinamiche del Paese anche nel suo ultimo libro, “La grande illusione”. «C’è la
possibilità che i talebani decidano di dare una spallata perché non riconoscono
il governo di Kabul» spiega, «ma preoccupa anche la debolezza del governo, per
di più delegittimato con l’esclusione dai colloqui di Doha, condotti tra
americani e talebani. Così come la presenza di gruppi regionali guidati da
vecchi signori della guerra, che stanno organizzando la “seconda resistenza” per
contrastare i talebani, ma in realtà per occupare il vuoto di potere. E infine
le schegge di Daesh, ciò che resta dell’ex stato islamico». Per la società
civile e le donne afghane sono state spese troppe parole e pochi soldi. «Dopo 20
anni l’Italia ha speso in cooperazione civile circa 320 milioni di euro e in
operazioni militari 8 miliardi e mezzo: l’impegno nei confronti della società è
stato pari a meno del 5% di quello militare. Cosa può restare di quel misero
5%?» si domanda Giordana. Secondo l’esperto sarebbe stato meglio investire
sull’economia reale del Paese, mentre i soldi sono stati usati prevalentemente
per le armi e proprio la presenza di troppe armi oggi è uno dei problemi
principali di un Paese in guerra da 40 anni. Sul futuro dell’Afghanistan c’è
incertezza, e la direttiva dell’ambasciata italiana, che consiglia anche ai
civili di lasciare il Paese, non è certo un segnale positivo. «Ciò che
servirebbe è un progetto politico internazionale. Ma per ora non ci sono notizie
su questo fronte», afferma ancora Giordana. Per questo con l’Atlante delle
guerre sta organizzando per l’autunno una conferenza a Trento, con associazioni,
esperti e diplomatici, per discutere su cosa si può e si vuole fare, se non
altro a livello italiano: «Siamo un Paese piccolo ma che può giocare un ruolo
importante», e conclude: «I movimenti femminili in Afghanistan oggi sono molto
forti, si tratta di vedere se continueremo a sostenerli oppure no».
Cosa insegna alla sinistra la tragedia di
Saman Abbas. Sofia Ventura su La Repubblica il 15
giugno 2021. Il relativismo culturale ha finito per indebolire la difesa dei
principi universali. E questa terribile vicenda potrebbe essere l’occasione per
riscoprirla. La società nella quale i singoli sono chiamati a prendere decisioni
personali, scriveva Karl Popper, (è chiamata) società aperta». La giovane Saman
Abbas, probabilmente uccisa nel contesto familiare, una famiglia immigrata
pakistana, voleva essere libera di assumere proprio quelle decisioni personali.
Voleva uscire dalla «società chiusa» di provenienza per vivere con le libertà
offerte dalle società aperte occidentali, non sottostare a un matrimonio
combinato, essere una «Italian girl», come aveva scritto su Facebook. La tragica
vicenda di Saman, scomparsa, e probabilmente uccisa, alla fine di aprile, sta
diventando un caso. Anche perché, a fronte delle scarse reazioni iniziali, donne
di sinistra, come Ritanna Armeni e Giuliana Sgrena, si sono fatte sentire,
denunciando la difficoltà della loro parte a trattare quel tipo di eventi;
difficoltà che rischia di assumere la forma di un più o meno velato razzismo. Da
destra, come già in analoghi casi, sono invece subito provenute accuse di
colpevole silenzio. Quelle accuse sono fondate, anche se troppo spesso viziate
non solo dal desiderio di stigmatizzare gli immigrati e la loro religione,
l’Islam, ma da un errore non troppo diverso da quello che si compie sovente a
sinistra: ipostatizzare la diversità. A sinistra, proprio il timore che
illuminare le violenze che originano nei contesti di immigrazione, soprattutto
islamici, dia spazio al razzismo, è proposto come giustificazione della
«prudenza». Questa assomiglia però a un alibi, più o meno consapevole, che cela
una ragione più profonda: un relativismo culturale che nel momento in cui porta
a valorizzare tradizioni altre, spesso perché viste come vittime di un Occidente
imperialista, conduce a tollerare comportamenti che non sono invece tollerati
nella società in generale. Come se gli immigrati avessero meno diritti. Vi è una
via di uscita? Sì, anche se nulla è facile. La via di uscita è nelle
potenzialità della società aperta, in quei valori universali sui quali poggia. E
che non possono essere distrutti dalla pluralità delle visioni. I cittadini (e i
residenti) condividono doveri e diritti. Il dovere di rispettare la legge e il
diritto di essere tutelato dalle autorità pubbliche. Non vi possono essere
recinti entro i quali immaginare altri diritti e doveri. Non sono dunque
necessarie misure diverse, più o meno tolleranti, verso chicchessia. E non sono
tollerabili arretramenti verso la tutela dei diritti di chiunque. Nei fatti
questo, certo, porta a conseguenze diverse quando si affrontano casi collocati
in contesti diversi: laddove l’individuo è inserito in ambiti più chiusi, la
lacerazione necessaria, così come lo sforzo di educazione e socializzazione,
sono inevitabilmente maggiori. Per intenderci: il diritto di una giovane a non
essere forzata a un matrimonio o a uno stile di vita va tutelato in nome di
principi universali e in prima battuta con gli strumenti che si adottano per
ogni cittadino; la realtà dell’immigrazione va affrontata con uno sforzo di
socializzazione ed educazione (che sino ad oggi non appare soddisfacente) che
prenda in considerazione lo iato tra culture. Questo comporterebbe una politica
che per integrare in parte «assimila»? Sì, ed è inevitabile che una integrazione
non conflittuale e che estenda agli immigrati i diritti liberali richieda un
certo grado di assimilazione, quella ai valori e comportamenti fondamentali
della società aperta occidentale. La sempre più illiberale destra italiana
sfrutta tragedie come quelle di Saman per stigmatizzare (e far apparire come
immodificabile) la diversità altrui, ma ha gioco facile nel denunciare le
contraddizioni di una sinistra che si perde nei particolarismi. L’una e l’altra
hanno perso di vista la dimensione universale alla base del nostro vivere
civile. La tragica vicenda di Saman Abbas potrebbe essere l’occasione per
riscoprirla.
Vittorio Feltri, lezione di femminismo
alla sinistra: "Cosa dovrebbero guardare oggi".
Vittorio Feltri su Libero Quotidiano il 09 maggio 2021. Le cronache famigliari,
cioè delle nostre famiglie, siamo erroneamente convinti siano poco o niente
interessanti, pertanto difficilmente esse trovano ospitalità sui giornali.
Tuttavia, in alcuni casi, sono invece meritevoli di essere raccontate poiché
significative, utili per ricostruire mentalità superate, epoche di cui abbiamo
perso memoria. Ricordare il passato aiuta a capire il presente. Ecco perché oggi
ho deciso di rendervi nota una vicenda risalente all'inizio del secolo scorso.
Riguarda l'ambiente in cui crebbero mio padre e le sue due sorelle, i cui
genitori erano nati entrambi nell'Ottocento. Allora soltanto i figli maschi
avevano il diritto di studiare, le femmine al massimo potevano frequentare la
scuola fino alla terza media, poi dovevano arrangiarsi, in quanto i genitori
erano persuasi che fossero destinate a sposarsi e a fare le schiave di un
marito. Cosicché solamente il mio papà, Angelo, ebbe modo di completare studi
superiori regolari, le due ragazze, Narcisa, la più grande, e Armida, di qualche
anno più giovane, vennero addestrate per compiere lavori domestici. Ma Narcisa
aveva un temperamento da combattente, non si rassegnò al ruolo di sg**ra e
pretese di guadagnarsi da vivere sgobbando per conto suo. Si fece prestare una
carretta da un contadino e cominció a trasportare merci in vari negozi. Caricava
qualsiasi cosa sul carro trainato da lei mediante le due stanghe, aiutata in
questa attività dalla sorella minore. Per due anni si sfiancò come un
mulo finché non riuscì ad accantonare una somma di denaro sufficiente per
riprendere gli studi. Si iscrisse alle magistrali e le terminò in un
battibaleno, animata come era da sacro fuoco. Nessuno in casa le impedì di fare
di testa sua. Quindi si trasferì a Pavia dove frequentò con successo la facoltà
di pedagogia. A laurea conseguita, conquistò una cattedra e insegnò. Era
talmente brava o, meglio, volonterosa, che a furia di schiaffoni obbligò anche
Armida a studiare e a garantirsi un avvenire migliore di quello che si
attendeva. In effetti, fu assunta all'ospedale Maggiore di Bergamo come capo
dell'amministrazione. Narcisa nel giro di pochi anni fece carriera e divenne
direttrice didattica. Mio padre invece era trionfalmente entrato alla Banca
diocesana e percepiva uno stipendio discreto. Peccato che l'istituto di credito
dei preti di lì a qualche anno fallì e lui rimase disoccupato. Mia nonna, Ester,
non disse nulla al marito, Daniele, pertanto vendette una parte delle sue
proprietà, ereditate dal babbo, e col ricavato dava l'equivalente dello
stipendio perduto al suo erede affinché ogni mese potesse consegnare la busta
col denaro a suo papà, il quale non si accorse mai che il figlio fosse rimasto
senza impiego. Non passò molto tempo prima che Angelo vincesse un concorso
all'Amministrazione provinciale e si rimettesse alla scrivania nel ruolo di
segretario aggiunto, qualifica non disprezzabile. Mia zia Armida morì a 70
anni, era tifosa dell'Atalanta oltre che lesbica, però per le sue preferenze
sessuali nessuno osò mai criticarla, erano affari rigorosamente suoi. La zia
Narcisa invece spirò a oltre 90 anni ancora in forma, aveva la postura di un
generale dei carabinieri, impartiva ancora lezioni private di latino e italiano
e, dal momento che mi sapeva direttore di quotidiani, mi trattava da
collega, con rispetto. Quanto a mio nonno, egli campò fino a 87 anni senza mai
distruggersi dalla fatica, ma vantandosi della abilità e dell'impegno della sua
prole. La nonna lo raggiunse presto nella tomba, pure lei orgogliosa delle due
ex bambine sue. Questa breve narrazione nel mio intento ha un unico scopo:
quello di dimostrare che il femminismo d'antan, quello dei tempi che furono, era
glorioso e merita di essere celebrato. Un femminismo di fatti e non di
retorica bolsa per quanto ridondante. Le donne sono sempre state un esempio di
forza e di carattere e quelle di oggi guardino a quelle di ieri, grandiose,
esempi da imitare.
Chi sono le «Terf», le
femministe «critiche del genere» che si oppongono al ddl Zan.
Elena Tebano il 6/5/2021 su Il Corriere della Sera. Uno dei luoghi comuni nella
discussione del Ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia e gli altri
reati d’odio, è che vi si oppongano anche «le femministe» e «le associazioni
lesbiche». Come molti luoghi comuni non è vero: vi si oppone una minoranza di
femministe, con una netta connotazione generazionale (sono soprattutto, anche se
non solo, donne over 50), e un’unica associazione lesbica, Arcilesbica, rimasta
ormai isolata nell’associazionismo lgbt+. La maggior parte delle associazioni
lesbiche italiane infatti ha preso posizione a favore del Ddl Zan, così come lo
ha fatto la parte più corposa dei gruppi e delle militanti femministe,
soprattutto quelle più giovani. Le femministe critiche del genere, meglio
conosciute come Terf («Trans Exclusionary Radical Feminists», «femministe
radicali trans escludenti») — un acronimo nato nei circoli femministi degli anni
70 che loro rifiutano definendosi solo «femministe radicali» — hanno infatti una
visibilità sovradimensionata rispetto alla loro diffusione reale nel movimento
delle donne e in quello lgbt+, soprattutto nei media tradizionali, grazie a due
motivi principali. Uno è il fatto che le sue esponenti di punta vengono per lo
più dal mondo dei media, di cui conoscono bene i meccanismi, come la regista e
scrittrice Cristina Comencini e la giornalista Marina Terragni (autrice di «Gli
uomini ci rubano tutto»). L’altra è l’alleanza con il mondo del cattolicesimo di
destra: Arcilesbica, per esempio, era quasi scomparsa negli ultimi anni sia in
termini numerici — l’associazione non rende pubblici i dati sulle sue tesserate
— che di visibilità pubblica. Ma grazie alle sue posizioni critiche nei
confronti delle persone transgender e contro la gestazione per altri, rilanciate
spesso da siti e testate che si riconoscono nel conservatorismo cattolico, ha
acquisito una rilevanza mediatica che non aveva mai avuto. Il conflitto tra
questa minoranza e il resto del movimento femminista e lgbt+ però non è
irrilevante, perché mette in luce alcuni dei nodi principali che riguardano la
condizione delle donne in Italia e in generale nel mondo più ricco. Per capirlo
appieno è utile vedere come si è sviluppato questo «femminismo radicale».
L’attivismo delle «femministe critiche del genere», o Terf, italiane è legato
infatti a doppio filo con quello britannico, che infatti esso cita costantemente
come proprio riferimento politico e culturale, e che vede nella scrittrice JK
Rowling la propria esponente più nota. Mentre negli Stati Uniti l’opposizione
alle istanze lgbt+ e in particolare transgender è guidata soprattutto dalla
destra religiosa, in Gran Bretagna è portata avanti da attiviste che vengono
dal mondo progressista e della sinistra. Come è possibile? In un’inchiesta su
Lux la giornalista Katie J.M. Baker spiega che la fazione femminista «critica
del genere» si è sviluppata quando nel Paese veniva discusso il Gender
Recognition Act («Legge per il riconoscimento di genere», o Gra) del 2004, una
legge che sul modello di altri Paesi, come Argentina, Irlanda e Portogallo,
avrebbe permesso alle persone trans di cambiare il loro genere legale sui
documenti senza l’obbligo della sterilizzazione forzata e senza una diagnosi
medica. La cosa interessante è che in Gran Bretagna la legge per il
riconoscimento di genere — come già il matrimonio egualitario, le nozze gay —
era stata proposta dal governo conservatore dei Tory, allora guidato da Theresa
May. E quindi anche per questo trovava “naturalmente” opposizione a sinistra. A
diffondere le idee delle femministe trans-escludenti in Gran Bretagna, però, è
stato soprattutto un sito, Mumsnet, la «rete delle mamme», un social network
creato 21 anni fa che verteva soprattutto — scrive Baker — su «consigli su come
disincrostare la lavastoviglie e associato a mamme compiaciute e snob che
confrontavano passeggini di fascia alta e si lamentavano del cane del vicino che
mangiava le loro begonie». Mumsnet si definisce «la comunità online più popolare
del Regno Unito “per i genitori”», ma le ricerche mostrano che quasi tutti i 7
milioni di Mumsnetters (le utenti di Mumsnet) sono donne. «Più specificamente —
spiega ancora Baker —, si ritiene che siano per lo più donne bianche, borghesi
ed eterosessuali» di reddito medio alto. La sua base di utenti «è considerata
ricca e influente, ed è molto attraente sia per i commercianti che per i
politici» (vi ha tenuto incontri anche Hillary Clinton).
Ddl Zan e il dibattito su
genere e sesso. È proprio l’esperienza della maternità condivisa online, secondo
Baker, che ha portato le utenti di Mumsnet a radicalizzarsi contro le donne
transgender, che non considerano tali e definiscono spesso «uomini mascherati».
«Leggendo una discussione dopo l’altra, ho notato che molte delle donne che
postavano hanno scritto di essersi sentite di nuovo prive di diritti e isolate
dopo aver partorito; buttate fuori da una società in cui avevano precedentemente
goduto di potere in virtù della loro relativa ricchezza e istruzione.
Organizzandosi intorno a questo tema “tabù” stavano sperimentando la solidarietà
e il senso di avere uno scopo che era mancato nelle loro vite post parto —
racconta Baker — . “Non sto dicendo alle persone trans che sono sbagliate perché
sono trans, sono arrabbiata perché le donne vengono chiamate transfobiche se
dicono che le loro funzioni biologiche sono solo loro”, ha scritto una donna in
un thread di giugno 2020 intitolato “Pro Women, Not Anti Trans - Why Biology Is
Important” (“Pro donne, no anti trans. Perché la biologia è importante”). Ha
continuato: “Non si tratta di genere, si tratta di sesso e anatomia e di come
influenzano le donne ogni giorno, e di quanto sia dannatamente ingiusto per gli
altri negare i nostri corpi, come funzionano o le nostre opinioni perché non
sono considerate inclusive per coloro che non potranno mai essere biologicamente
gli stessi”». «Essere incinta, partorire e allattare sono l’unico momento della
mia vita in cui ho sentito una giusta consapevolezza di essere femmina» scrive
un’altra utente. «Non intendo in senso di identità di genere, ma in senso di “ho
un corpo femminile e sto facendo qualcosa che solo una persona con un corpo
femminile può fare”». L’insistenza sull’importanza del legame biologico nella
maternità è anche il tema ricorrente delle attiviste Terf italiane. In Italia
però, a differenza che nel Regno Unito, lo hanno sostenuto soprattutto a
proposito della gestazione per altri (gpa). Non è un caso che le «femministe
radicali» italiane se la siano presa soprattutto con i gay che ricorrono
alla maternità surrogata, che pure sono una minoranza rispetto alle coppie
etero. Non dipende solo dal fatto che i gay sono più visibili (non possono
fingersi genitori biologici dei bambini che nascono da madri surrogate). Ma
anche perché — come ha detto con la chiarezza intellettuale che la
contraddistingue la filosofa Luisa Muraro —: la gpa dei gay «fa sparire le
mamme». Priva l’atto biologico del partorire di quel valore simbolico — il
Materno — intorno al quale questa corrente femminista costruisce l’identità
delle donne. Secondo Baker insomma le community online hanno radicalizzato le
donne fornendo loro un «capro espiatorio» (le persone transgender) a
un malessere che è motivato da questioni molto reali. «Alcune di queste nuove
Mumsnetters “gender critical” erano donne relativamente privilegiate che non si
erano mai sentite emarginate fino a quando non hanno partorito e si sono sentite
isolate nelle loro famiglie nucleari e (giustamente!) indignate per la mancanza
di sostegno alle madri nel Regno Unito» scrive. «Il forum sui diritti delle
donne di Mumsnet non ha solo offerto alle donne uno spazio sicuro per
organizzarsi. Fornendo una piattaforma che tollerava l’ideologia Terf, ha anche
consegnato alle utenti un comodo capro espiatorio per tutti i loro problemi: non
l’austerity, non la misoginia, ma la relativamente piccola ed estremamente
marginalizzata e oppressa popolazione trans». In una società in cui le donne
hanno fatto passi avanti nella rivendicazione di diritti e opportunità, la
gravidanza e la maternità rimangono ancora uno scoglio che le rigetta nella
solitudine (e nella sensazione di una condizione unica) perché non ci sono
servizi adeguati per chi ha figli piccoli. Manca una cultura della condivisione
e della responsabilità comune — anche sociale (gli asili, una società che non
sottometta la vita al lavoro) —nei confronti della genitorialità. Ed è proprio
qui l’equivoco di fondo delle «femministe critiche del genere». Non è tornando
all’idea di sesso che riusciranno a uscire dall’isolamento a cui la società
consegna le donne facendone le uniche depositarie della cura dei figli. La
soluzione non sta nell’attribuire alla riproduzione biologica la fonte di
legittimità del valore delle donne, ma nel condividere la cura dei bambini (e
degli anziani) a prescindere dal genere di appartenenza. Il concetto di genere,
storicamente, è stato il più grande strumento di emancipazione delle donne.
Sintetizzato nella famosa frase di Simone de Beauvoir («Donne non si nasce, si
diventa») è servito a emancipare le donne dal loro destino biologico. Ha
permesso di capire che nascere con i cromosomi XX o i genitali femminili non
significa avere un libretto di istruzioni per la vita che verrà: le donne sono
libere di riempire quella vita come vogliono. Le nuove generazioni hanno portato
questa emancipazione un passo più in là: sanno che quei cromosomi o
quell’anatomia non obbligano a un orientamento sessuale. E neppure
necessariamente a definirsi donne (o uomini). E infatti ci sono sempre più
persone transgender che rifiutano di essere definite in base a una dicotomia di
genere. Questo spiega la frattura delle «femministe radicali» con le nuove
generazioni. Questo spiega perché un rapper maestro dei social come Fedez ha
potuto dare voce alle istanze di quei ragazzi e quelle ragazze: «rappresenta —
come nota lo scrittore Jonathan Bazzi su Domani — anche una nuova generazione di
genitori, più liberi, in grado di anteporre il bene dei figli al copione che la
società ha predisposto per loro». Perché parlare di genere non significa
negare la libertà delle donne, ma potenziarla.
(Questo articolo è tratto
dalla newsletter «Il Punto» del Corriere della Sera.)
Dagotraduzione da France24.com l'1 maggio 2021.
C'è una nuova generazione di attiviste in Francia, donne lesbiche che sulla scia
del #MeToo stanno abbracciando il femminismo per denunciare secoli di
oppressione maschile. Hanno ispirato una marcia ma anche innescato polemiche.
Domenica a Parigi migliaia di persone hanno partecipato a una marcia lesbica, la
prima dal 1971, ispirata alle «Dyke March» statunitensi (marce di protesta delle
lesbiche). Le manifestanti hanno chiesto l'approvazione di una legge che
consenta alle coppie lesbiche e alle donne single di accedere ai trattamenti per
la fertilità. Tra le bandiere arcobaleno hanno sfilato anche l'attrice Adele
Haenel, la regista Celine Sciamma e la politica Alice Coffin, tutt'e tre
celebrate da numerosi striscioni e cartelli. Adele Haenel è diventa un simbolo
del movimento #MeToo in Francia quando ha denunciato le molestie subite tra i 12
e i 15 anni dal regista Christophe Ruggia. Mesi dopo contestò, al grido di
«Vergogna», i premi Césars, gli Oscar francesi, per la decisione di premiare
Roman Polanski come miglior regista nonostante la condanna per stupro (di una
tredicenne). Un gesto che ha raccolto l'adesione di molte donne, tra le quali la
scrittrice francese Virginie Despentes, una delle più influenti e popolari
femministe (lesbiche) francesi. Haenel e Despentes sono alcune delle figure di
prestigio che stanno iniziando a promuovere il femminismo dal punto di vista
delle lesbiche in Francia. Ma il movimento è una novità di adesso. Tanto che
l'autrice e attivista Monique Wittig, che negli anni Settanta cercò di creare
una sezione lesbica del Movimento di liberazione delle donne, fu costretta a
fuggire negli Stati Uniti. Oggi invece le teorie di Wittig sono diventate
popolari. Ma c'è chi è critico. La filosofa Elisabeth Badinter, da sempre voce
del femminismo, ha denunciato un emergente «odio per gli uomini» e un
«neofemminismo bellicoso». Ad accendere ancora di più il dibattito è stata la
pubblicazione a settembre del saggio "The Lesbian Genius" di Alice Coffin,
giornalista e politica. Un passaggio in particolare ha scatenato le proteste
della classe politica francese. Recita così: «Non basta aiutarci a vicenda,
dobbiamo cancellare (gli uomini) dalle nostre menti, dalle nostre immagini,
dalle nostre rappresentazioni».
I testi dell'autrice Usa. Gloria Watkins,
la scrittrice che smonta i luoghi comuni del femminismo.
Filippo La Porta su Il Riformista il 29 Aprile 2021. «Non sono
una donna, io?» («And ain’t I a woman?»): il punto di partenza di Scrivere al
buio, intervista di Maria Nadotti a Gloria Watkins, alias bell hooks (scritto
con le iniziali minuscole), intellettuale militante afroamericana nata nel Sud
povero e rurale, è semplice e insieme illuminante. Si tratta di una frase
enunciata nel 1851 da una schiava di colore, poi liberata, in una convention di
donne nell’Ohio. Commenta acutamente Nadotti che quella frase interroga la
problematicità della parola-concetto “donna” e ne suggerisce una definizione mai
conclusa, “mai stabile”, uno sguardo altro che vede altre cose e “produce un
pensiero critico”. Il libro si compone di testi prodotti dal 1991 al 1998 e poi
da una intervista di Nadotti all’autrice. Soffermiamoci sull’intervista, uno
scambio ricco di stimoli teorici e di interrogativi non convenzionali.
Ricostruendo le origini del movimento femminista americano bell hooks nota come
il limite di Betty Friedan consistesse nell’identificare libertà femminile e
potere di classe (le donne devono solo trovarsi un lavoro, guadagnare bene, e
così acquisire un controllo sulla propria vita) mentre lei rivendica
puntigliosamente un’ottica “di classe” e, tra l’altro, dichiara di credere
soprattutto nel valore della condivisione, e perfino nel dare una parte dei
propri guadagni ai meno fortunati (visto che il criterio che domina la vita
sociale è quello della “acquisizione”). Quando andò a insegnare a Stanford non
volle assimilarsi alla classe media, all’ambiente professionale-manageriale, per
non voltare le spalle alla propria classe. Un equivalente maschile che mi viene
in mente è Orwell. Poi se la prende con il linguaggio oscuro, metalinguistico di
molta teoria femminista (ad es. Donna Haraway), nato dal desiderio di
legittimazione all’interno delle strutture accademiche, riproducendo le stesse
barriere gerarchiche ed elitarie. In genere diffida di libri “femministi” che
non nascono dal «processo trasformativo dell’autocoscienza e della relazione con
altre donne», come quelli di Camille Paglia, superficialmente provocatori e
filo-patriarcali. Ancora una volta, per la diffidenza verso l’esoterismo della
lingua. A proposito della propria attività prolifica di scrittura (dalla poesia
alla saggistica) fa una osservazione spiazzante. In genere si ritiene che si
scriva per reagire alla depressione, per elaborare il disagio. Questo aspetto
della scrittura è ineliminabile, però lei invece “scrive per pienezza”. In che
senso? Colpisce in bell hooks un’attitudine costruttiva, il rifiuto di qualsiasi
deriva nichilista: vorrebbe che il femminismo parlasse più di liberazione
sessuale che di antipornografia o di aborto, temi questi «che costruiscono il
corpo come luogo di pericolo e minaccia, invece che come sito di possibilità e
di piacere». Inoltre sottolinea la natura politica del femminismo: così sul
piano individuale una donna può anche essere contro l’aborto ma come femminista,
e dunque sul piano pubblico, non può che difendere il diritto alla libertà di
riproduzione delle donne. Certo, la sua idea di politica riguarda più la
coscienza personale che l’appartenenza a un partito politico: è anzitutto un
invito alla responsabilità: «quando aprite un rubinetto provate a pensare al
gesto che state facendo e alle conseguenze che può avere». Altre posizioni
andrebbero discusse approfonditamente ma costituiscono pur sempre uno sguardo
appunto “altro” sulle cose, come quando contrappone alla maternità la
genitorialità, per impedire la sopravvalutazione della madre e la conseguente
associazione patriarcale tra donne, determinismo biologico e maternità. Filippo
La Porta
La fecondità simbolica della differenza
sessuale. Il dualismo sessuale e il potere maschile. Una risposta a Christian
Raimo. Lea Melandri su Il Riformista il 29 Aprile
2021. Nell’articolo uscito il 27 aprile sul blog letterario minima et
moralia scrive Christian Raimo: «La fecondità simbolica della differenza
sessuale rimane ancora una promessa». Certo, ma per chi? Sicuramente per quel
sesso vincente che lacerando l’organismo unico da cui è nato ha riservato solo a
sè stesso la parte vincente, la consegna di figlio unico inseparato e
inseparabile in quanto parte di un organismo considerato il suo necessario
complemento. Le costruzioni di genere del maschile e del femminile che si sono
via via succedute nel corso dei secoli, con una fissità sempre maggiore tanto da
sembrare dati naturali, sono in realtà, a guardare bene, soltanto
delle “funzioni” rispetto a quell’organismo unico che è il corpo materno: non
organismi viventi, non corpi, né passioni, né carne costrette al medesimo tempo
a reclamare, in condizione di servitù, la loro parte mutilata. Alla base di
quella preistoria che sta tra inconscio e coscienza, tra l’immaginazione del
figlio nella sua infantile dipendenza e l’onnipotenza femminile, si colloca quel
dualismo sessuale che in forme diverse attraversa la storia privata e pubblica,
portando dentro il sogno di una appartenenza intima a un altro essere, ma anche
la certezza della propria esistenza e il desiderio della sua integrità. Del
possesso della donna l’uomo si è impadronito prima ancora di sapere che parte
aveva nel processo generativo, lo ha fatto stuprando, violentando, pensando di
aver visto nascere da quel corpo materno un altro se stesso, inerme e poi armato
contro quella carne che gli ha assicurato vita, cura, riconoscimento, poi
famiglia, continuità della specie. La centralità della figura della donna madre
è stata esaltata e vilipesa dal patriarcato: legame con la materia vivente di
tutti gli umani, portatrice dei segni della vita e della morte, della coscienza
e della radice biologica degli umani. È stata il grande feticcio, per non dire
il fondamento stesso del patriarcato: esaltata per un verso e dall’altro
sottoposta a un rigido controllo del dominio maschile. Prima del principio
materno legato alla terra, al corpo e ai suoi limiti c’è quello
che Bachofen chiama “principio paterno spirituale”, che non solo si è già di
fatto impadronito del corpo materno ma ha preteso di essere l’unico erede.
Comincia così il possesso del corpo femminile, la pretesa maschile di
controllarlo e di tenere insieme parti tra loro inscindibili (appunto come
corpo, natura, cultura). Il dualismo sessuale e la complementarietà delle sue
parti è la maledizione di un dominio che ha confuso il desiderio, la violenza,
la libertà e le necessità. Nella rigidità fisica essenzialista con cui sono
stati definiti i caratteri sessuali del maschio e della femmina si perde la
possibilità di ogni possibile cambiamento e disgregazione, si perde soprattutto
quel carattere di naturalità che si è voluto dare loro. La Ragione di Otto
Weininger, che lo porterà al suicidio giovanissimo nel 1903, è aver visto agli
inizi del secolo crollare quell’edificio platonico che sembrava avere fermato
per sempre la storia al mistero del dualismo sessuale. Sotto la razionalità e la
modernità dei secoli, non era la prima volta che si scopriva l’azione
sotterranea e devastante delle viscere della storia che hanno continuato a
dirigerla, a spingerla, suo malgrado e che ci riporta ogni volta “a quelle acque
insondate delle origini”, a cui va ricondotto l’enigma della relazione
controversa e duratura tra i sessi. Lea Melandri
Dagospia l'11 marzo 2021.
Dall'account twitter di Giuseppe Candela. Da
qualche tempo la Panicucci si veste come una persona normale. #mattino5
Dall'account facebook di Federica Panicucci.
Stamattina un giornalista che si chiama Giuseppe Candela, ha pubblicato questo
tweet che mi riguarda. Permettetemi qualche considerazione. Verrebbe naturale
chiedere innanzitutto al Signor Candela quali sono secondo lui le “donne non
normali“ e come si vestono, sempre secondo lui, le “donne non normali”. Ma vado
oltre perchè la questione secondo me e ben piu seria e a questo proposito vi
chiedo: ma davvero ancora oggi, nel 2021, si può giudicare una donna basandosi
su come e vestita? Dalla lunghezza della sua gonna o dai suoi pantaloni
aderenti? Ma davvero ancora oggi, nel 2021, l’aspetto esteriore di una donna, o
meglio, il suo guardaroba, può essere motivo di giudizio? Può davvero ancora
accadere che un uomo, un giornalista come in questo caso, giudichi la
“normalita” di una donna attraverso i suoi vestiti? Intendiamoci, un vestito può
piacere o meno, ed e lecito ma la “normalita” di una donna non può certo passare
da questo. Varrebbe la pena ricordare al Signor Candela, che oggi fortunatamente
le donne non sono più “oggetti” da valutare in base alla misura del tacco che
portano. Sono stanca di leggere ancora messaggi come questi dopo anni di
battaglie, stanca come tutte le donne che vengono giudicate sulla base di
criteri idioti e insensati. La prego Signor Candela, la prossima volta che vorrà
scrivere di me, critichi la mia professionalità ed eviti di scivolare in
stereotipi che oggi, mi lasci dire, sono francamente inaccettabili. Perchè Lei,
oggi, con il suo tweet, non ha offeso me, ma ha offeso tutte le donne
giudicandole “normali” o non “normali” in base al vestito che indossano.
Vogliamo essere libere, noi donne, di vestirci e di mostrarci come più ci piace.
Buona vita Signor Candela.
Dall'account facebook di Giuseppe Candela. Faccio
questo lavoro da tempo, ne ho viste di tutti i colori e ho smesso di stupirmi.
Il post che la signora Panicucci mi ha dedicato ha suscitato sorrisi e
battutine, messaggi di solidarietà ma anche numerose offese. So di non essere
molto simpatico alla signora Panicucci e, come molti possono immaginare, questo
non mi ha tolto il sonno. Non sento il bisogno di rispondere a chi come metodo
sceglie di darmi in pasto a due milioni di follower senza cercare alcun
confronto privato, senza coinvolgere la comunicazione dell'azienda e scrivendo
un pippone insensato, esagerato e fuori luogo. Lo spiego a chi mi legge ma
soprattutto alle persone che nei commenti dei post della signora Panicucci mi
stanno riservendo i peggiori insulti. Da molti anni tra gli addetti ai lavori,
sui social e non solo, i look mattutini della conduttrice fanno "notizia",
talvolta in onda con abiti serali alle otto del mattino, così come spesso si è
parlato dell'eccesso di illuminazione (ricordo numerosi servizi di Striscia la
notizia, in quel caso non ci furono post ad hoc). Per me la Panicucci può
vestirsi come vuole, tutti possono scegliere come vestirsi. Doverlo precisare mi
offende. Questa mattina nel tweet sottolineavo il cambio di look con tono
ironico "da persona normale": inteso come un look forse più consono alla fascia
di messa in onda. Se la Carlucci va in onda con il pigiama in prime time, se
Magalli si presenta in smoking alle undici del mattino, se Mentana al tg va in
onda con un maglioncino io lo segnalo, magari con il sorriso. È la logica del
contesto, non una questione di libertà. E lei può scegliere come vestirsi, può
scegliere come condurre, come comportarsi in onda con gli ospiti e con i
colleghi, anche dietro le quinte (il rispetto vale anche per gli uomini). Alla
signora Panicucci dico solo una cosa: non si permetta di dirmi che ho offeso le
donne. Le sue battaglie le faccia su cose serie, magari dopo aver letto e capito
quanto scritto.
Federica Panicucci è troppo intelligente
per cadere nella trappola femminista. Paolo Gambi il
12 marzo 2021 su Il Giornale. Federica Panicucci è una donna che ha saputo
seminare e raccogliere un’indiscussa stima e ammirazione fra gli italiani.
Sempre garbata, sempre dotata di un impeccabile stile – oggi rarissimo a
trovarsi – continua a mostrare un volto dell’Italia che non può non piacere. Io
sono fra coloro che l’hanno sempre stimata e apprezzata, pur non avendola mai
conosciuta di persona. Ecco perché sono rimasto molto perplesso per la polemica
che è scoppiata sui social. Un giornalista di Dagospia, Giuseppe Candela, ha
pubblicato su Twitter un commento: “Da qualche tempo la Panicucci si veste come
una persona normale”. Certo, non era un commento carino.
Ma la reazione di Federica, lo confesso, mi ha
lasciato molto perplesso. Ha infatti scritto un post su Facebook, in cui si
legge tra l’altro:
“ma davvero ancora oggi, nel 2021, si può
giudicare una donna basandosi su come è vestita? Dalla lunghezza della sua
gonna o dai suoi pantaloni aderenti?
Ma davvero ancora oggi, nel 2021, l’aspetto
esteriore di una donna, o meglio, il suo guardaroba, può essere motivo di
giudizio?
Può davvero ancora accadere che un uomo, un
giornalista come in questo caso, giudichi la “normalità” di una donna
attraverso i suoi vestiti?
(…)
Sono stanca di leggere ancora messaggi come questi
dopo anni di battaglie, stanca come tutte le donne che vengono giudicate sulla
base di criteri idioti e insensati.
La prego Signor Candela, la prossima volta che
vorrà scrivere di me, critichi la mia professionalità ed eviti di scivolare in
stereotipi che oggi, mi lasci dire, sono francamente inaccettabili.
Perché Lei, oggi, con il suo tweet, non ha offeso
me, ma ha offeso tutte le donne giudicandole “normali” o non “normali” in base
al vestito che indossano.
Vogliamo essere libere, noi donne, di vestirci e
di mostrarci come più ci piace”.
Se non fossi sicuro che quello è il suo profilo
facebook avrei potuto pensare che a scrivere queste parole, che riassumono gli
assunti base del femminismo, fossero la rabbia e l’odio di Michela Murgia.
Invece no.
E qui mi sono preoccupato.
Mi permetto allora, molto sommessamente, di
condividere un solo pensiero rivolto a Federica: non hai bisogno di questo. Non
hai bisogno di “murgismo”, né di ideologia. Anzi. Ci piaci per ciò che sei, ci
piace il tuo sorriso. Non ci piacciono i ringhi delle femministe che oramai
affollano ogni pulpito.
Chiunque ti stima e ti apprezza, come il
sottoscritto, anche per questo. Non cadere nella trappola dell’odio che sta
minando il rapporto fra uomini e donne. Io non conosco Candela, ma un commento
poco simpatico resta semplicemente un commento poco simpatico.
Rispondi con il tuo sorriso. Continua a
regalarcelo.
Resta ciò che sei sempre stata. Perché di Murgia è
ahinoi già pieno il mondo.
Aldo Grasso per il “Corriere della Sera” il 13
marzo 2021. La forza della televisione e la cultura del tempo. Ancora una volta,
la tv si rivela essere un formidabile campo di prova di un principio
ermeneutico: quello che oggi appare volgare domani potrà tramutarsi nel suo
contrario o viceversa. Al posto di «volgare» possiamo usare un altro aggettivo,
ma il principio non cambia. Penso alle moltissime polemiche suscitate dal
commissario Salvo Montalbano che nell'episodio Il metodo Catalanotti si è
innamorato di una collega, Antonia, molto più giovane di lui, e in maniera
laconica e telefonica ha liquidato Livia, dopo tanti anni di relazione a
distanza. È stato un duro colpo, come se Montalbano avesse tradito milioni di
spettatori, non solo Livia. E ce n'è anche per Anna, bella e passionale, la
nuova responsabile della Scientifica. Per tutto il tempo parla di indipendenza e
di emancipazione e poi cede al fascino dell'uomo maturo. Tutto questo,
nonostante Andrea Camilleri parlasse degli «ultimi fuochi» del suo eroe,
nell'intervista che ha preceduto la messa in onda dell'episodio. Tutto questo,
nonostante la sceneggiatura fosse molto fedele al libro uscito da Sellerio nel
2018. All'epoca, se la memoria non mi tradisce, non c'è stata nessuna rivolta
contro il tradimento, anzi le critiche parlavano di fragilità del commissario,
di «una sorta di crisi di mezza età che lo porterà non solo ad accrescere le sue
malinconie ma, forse, anche a prendere decisioni importanti che cambieranno il
corso della sua vita». Non so quanti abbiamo letto il libro, forse qualche
decina di migliaia di fedelissimi. In tv, l'episodio è stato visto da più di
nove milioni di spettatori. Però in tre anni sono cambiate anche molte
sensibilità, sta cambiando lo «spirito dei tempi», molti/e si ribellano alle
stereotipie dei comportamenti e dei ruoli. Insomma, se cambia il punto di vista
cambia il testo, con buona pace dei «traditori» Montalbano e Camilleri.
Elena Stancanelli per "la Stampa" l'11 marzo 2021.
Prima di tutto non dovevano baciarsi in quel modo. Siamo tutti saltati sul
divano guardando "Il metodo Catalanotti", l' ultima puntata di Montalbano. Come
se per sbaglio avessimo aperto la porta della stanza dei nostri genitori e li
avessimo sorpresi nell' ardore dell' amplesso. Non lo vogliamo sapere come fanno
sesso i nostri genitori, né com' è Montalbano quando si abbandona alla passione.
Ci imbarazza. La serie televisiva che ha per protagonista il commissario è, da
sempre, un luogo confortevole. Come una vecchia poltrona, ne conosciamo pregi e
difetti, sempre gli stessi. E' un prodotto televisivo un po' antico, ma ha la
solida lealtà dei classici. E in più c' è Montalbano, il personaggio che ci ha
regalato Andrea Camilleri.
In tutti questi anni Luca Zingaretti lo ha
impersonato perfettamente e in milioni ce ne siamo innamorati. Perché?
Perché Montalbano è uno degli ultimi esemplari di
una razza in estinzione: l' uomo adulto. Che non si lagna, non si sposa, non ha
una madre che lo reclama, non si sdilinquisce per la paternità, mangia, beve e
preferisce dormire da solo. Lo abbiamo visto allontanarsi a nuoto e abbiamo
pensato, un po' come Livia, vai vai, tanto non è l' amore che va via E invece
stavolta se n' è andato. Mai lo avevamo visto sbavare per qualcosa, mai lo
avevamo visto farfugliare scuse ai colleghi Mimì Augello e Fazio. Ma l' altra
sera Montalbano si è innamorato. Dopo tanti anni di relazione a distanza con una
donna, Livia, ne ha incontrata un' altra, Antonia, e si è innamorato. Capita.
Come capita, quasi sempre, di sbagliare tutto nel momento della separazione. Ma
quel momento lì è sempre sgraziato, volgare, spesso violento. Non abbiamo ancora
imparato a dirci addio senza rabbia, non sappiamo trovare le parole giuste.
Anche perché le parole giuste non ci sono e quindi tanto vale, come ha fatto
Montalbano l' altra sera, tacere. Camilleri voleva che questo Montalbano del
tramonto sperimentasse lo sgomento, e la felicità di un avvenimento inaspettato.
La follia di quando si pensa che la vita non ci riserverà più alcuna sopresa e
invece ci si innamora di nuovo. Come ragazzini, o forse anche di più, visto che
da ragazzini siamo meno vulnerabili rispetto al desiderio e la passione.
Montalbano dunque, trafitto, si comporta in maniera sconclusionata, irrazionale,
diventa vulnerabile e fanciullo. E saremmo anche stati disposti ad accettarlo,
anzi, forse addirittura a invidiarlo. Sarà che siamo tutti chiusi in casa, ma
chi non ha sognato, in questo anno, un amore fou, una sterzata della vita tutta
strepito e passione? Il fatto è che Montalbano si innamora di una donna,
Antonia, che ha 25 anni meno di lui. Cosa che probabilmente è una delle ragioni
per cui la bacia con tanto trasporto e lingua, e bocca proprio davanti ai nostri
occhi. E quei 25 anni di differenza, che in un altro momento della Storia l'
avrebbero fatta franca, adesso sono un' insegna al neon che lampeggia davanti ai
nostri occhi. La pelle di lei, fresca e luccicante, il volto di lui, con le
rughe legittime di un sessantenne. Qualcosa è cambiato, penso mentre mi infurio
contro Montalbano ma soprattutto contro Antonia che alla fine scende dal treno,
e dopo tutto il suo discorsino sull' indipendenza, la carriera e la giovinezza
si arrende al fascino del sessantenne. L' arte fa quello che vuole, per carità,
ma Montalbano è Montalbano. Mi chiedo: sono io che ho interiorizzato l' odio
verso il patriarcato, o il patriarcato che ormai è impresentabile, persino
nascosto dove abbiamo sognato di nasconderci in tanti, dentro la camicia bianca
perfettamente stirata del nostro commissario preferito?
Massimo Gramellini per il "Corriere della Sera"
l'11 marzo 2021. Vorrei dare il mio personale benvenuto al commissario
Montalbano nella sterminata congrega dei maschi vili e indecisi a tutto. Il modo
in cui la sera dell' otto marzo si è fatto lasciare al telefono da Livia,
storica fidanzata a distanza, attinge a un repertorio perfezionato nei secoli.
L'archetipo resta il marito interpretato da Vittorio Gassman ne «I Mostri»,
quello che convinceva l' amante a mollarlo («per il tuo bene, cara») e subito
dopo raggiungeva la nuova fiamma. Però Luca Zingaretti - che rispetto a suo
fratello come collaboratore ai testi annovera Camilleri, mica Bettini - non è
stato da meno nell' indurre Livia a toglierlo dall' imbarazzo, trascinandola a
pronunciare la frase-tabù, «Forse è meglio che ci lasciamo», di fronte alla
quale lui non ha potuto fare altro che prendere dolorosamente atto. A leggere i
commenti sui social, le donne invece l' hanno presa malissimo. Dopo trentasette
episodi si erano convinte che il commissario fosse diverso da noi, patetici
maschi-coniglio, e riuscisse ad affrontare i marosi sentimentali con lo stesso
coraggio con cui si tuffa tra le onde che lambiscono il suo terrazzo. Erano
persino disposte ad accettare che, atrofizzato da una relazione infinita e
sempre più virtuale, perdesse la testa per una collega giovane e tosta. Ma
pretendevano che saltasse sul primo aereo per andare da Livia a dirglielo di
persona, guardandola negli occhi. Figuriamoci. Camilleri replicherebbe che
Montalbano è un romanzo giallo, non di fantascienza.
Estratto dell’articolo di Leonetta Bentivoglio
per “la Repubblica” il 28 marzo 2021. (…) Cambiando registro: lei, in tivù, è la
fidanzata "storica" di Montalbano, Livia, e nell'ultimo episodio il commissario
l'ha lasciata. «Quell'abbandono ha provocato una specie di rivoluzione (ride).
Tutti indignati contro Salvo! Tutti a favore di lei! L'Italia è insorta. A dire
il vero Livia non era mai stata simpatica al pubblico. Un po' perché Camilleri
si divertì a farla "distante" e un po' in quanto legata a Salvo malgrado la
lontananza, il che destava gelosie. Ma il fatto che Salvo si sia innamorato di
una giovane e vilmente l'abbia piantata al telefono è stato considerato
inammissibile. In tal modo Camilleri ha reso Livia una gloriosa eroina. Il
paradosso è che, nei libri successivi, Livia torna in campo come se niente
fosse».
Gianni Bonina per “Libero quotidiano” il 28 marzo
2021. Nell' estate in cui Camilleri moriva, nel Ragusano si girava Il metodo
Catalanotti, regia di Luca Zingaretti, e si tradiva l' autore per il
ribaltamento di una vicenda, quella tra Montalbano e Livia, che ha indignato l'
Italia televisiva per il modo come il commissario la lascia: al telefono, senza
aprire bocca se non per dire sì, e cioè di essere in linea. Da mascalzone. A
"Che tempo che fa" l' interprete dell' eterna fidanzata Sonia Bergamasco ha
proposto di pensare a una specie di sogno fatto da Camilleri, giacché della
nuova fiamma non c' è traccia nel romanzo successivo, Il cuoco dell' Alcyon,
sicché Fabio Fazio ha potuto gridare allo spoiler supponendo il seguito, fermato
però dalla precisazione dell' attrice che "è tutto pubblicato". Infatti. Ma non
è stato perché la differenza tra il ciclo letterario e la serie televisiva -
come diceva Camilleri - è in rapporto di migliaia di lettori e milioni di
telespettatori se la reazione di questi è stata così vistosa, il motivo essendo
la diversità della storia raccontata da Zingaretti, che ha voluto una Livia
abbandonata mentre gira le spalle al pubblico come uscendo di scena. Nella
versione di Camilleri è piuttosto Livia a piantare infuriata Montalbano
dicendogli al culmine di una sfuriata: «Perdonami, forse non è giusto dirtelo
per telefono ma sono esausta. Per me la nostra storia è alla fine»: senza
peraltro sapere niente di Antonia, la nuova dirigente della Scientifica della
quale il commissario si innamora. Nel romanzo, al contrario, Montalbano sta
tutt' altro che zitto perché più volte ripete di non potere parlare mentre Livia
rivendica le proprie ragioni, reclama la libertà e dichiara che vuole pensare a
se stessa. Nulla c' è peraltro nello sceneggiato della sentita riflessione che
Montalbano fa giorni prima della telefonata quando si interroga sul legame con
Livia e si propone di andare quanto prima a Boccadasse, non bastando parlare al
telefono circa un legame invero precario già da La luna di carta che è del 2005
quando solo un anno prima, nel 2004, in La pazienza del ragno, quel legame aveva
portato Montalbano, preda di un attacco di panico, a trovare aiuto proprio nelle
braccia di Livia che gli dice «Non lo senti che sono qui?». A ben vedere non è
comunque la prima volta che Montalbano tradisce Livia. Senza contare il rapporto
con la svedese Ingrid, sempre tenuto ambiguo, benché abbiano dormito più di una
notte insieme, è stato con la ventenne Adriana in La vampa d' agosto, poi con la
quarantenne Rachele in La pista di sabbia (dove Livia ha comunque tradito Salvo
andando con il cugino in barca) e ancora con Angelica Cosulich in Il sorriso di
Angelica. E molto più che di Antonia, ma riuscendo a fermarsi a un passo dall'
alcova, è stato davvero innamorato di Laura della quale in L' età del dubbio si
sono infatuati pure i lettori. La Antonia del Metodo Catalanotti non è allora
che la Laura dell' Età del dubbio sommata alle altre con cui Montalbano è stato
in intimità: e come Salvo era allora tornato al suo difficile rapporto con
Livia, è da supporre che avrebbe anche ora ripreso il tran tran con la donna
della sua vita. La supposizione non viene, come suggeriva Sonia Bergamasco, dal
ritorno di Livia in Il cuoco dell' Alcyon, dove Antonia scompare, ma dal fatto
che questo romanzo (che precede l' avulso Riccardino) risale a una decina di
anni prima il 2019 per stessa ammissione di Camilleri e per la presenza di
figure come gli agenti Gallo e Galluccio, il dottore Lattes, lo stesso questore
Bonetti-Alderighi, Ingrid, i giornalisti Zito e Ragonese, che sono tutti usciti
di scena negli ultimi episodi. Ne è passato di tempo, ma mentre Camilleri ha
sempre tenuto insieme Salvo e Livia, pur spingendoli a lasciarsi, ma poi
riavvicinandoli, non sentendosela mai di dare loro un taglio definitivo e un
dolore ai lettori, Zingaretti proprio questo ha fatto, benché in programma
fossero altri due episodi da girare, con Livia nel suo ruolo, La rete di
protezione e addirittura un "Salvo amato", "Livia mia" tratto da un racconto che
avrebbe riportato in superficie un amore da lui invece cinicamente affondato.
Il decalogo femminista delle frasi
"proibite". Michela Murgia elenca le locuzioni da
eliminare e rinchiude le donne in "aree linguistiche protette". Giulia
Bignami - Gio, 11/03/2021 - su Il Giornale. È da poco uscito il nuovo,
fiammante, decalogo femminista di Michela Murgia con tutte le frasi che «noi
donne» (generalizzazione che già mi fa rabbrividire) non vorremmo più sentirci
dire. Si inizia con «Stai zitta» che, oltre a dare il titolo al libro (Einaudi,
pagg. 128, euro 13), è anche il modo in cui un palesemente maleducato
interlocutore ha apostrofato l'autrice durante una trasmissione radiofonica. Si
continua con analoghi esempi, citando poco eleganti frasi pronunciate
dall'onorevole La Russa o dallo scrittore Corona ai danni delle loro
interlocutrici televisive. Mi pare evidente che gli esemplari di maschio in
questione non si possano esattamente definire dei gentiluomini di antico stampo,
ma mi pare altrettanto evidente che una generale vittimizzazione femminile sia
un po' inopportuna, soprattutto per quanto riguarda i dibattiti televisivi.
Recentemente, oltre agli usuali berciamenti e zittimenti tipici di entrambi i
sessi su qualsiasi rete o programma, mi riferiscono ci sia stata in prima serata
anche una raffinata minaccia femminile di lancio di stiletto con annesso
conficcamento del medesimo nel cranio dell'interlocutore, maschio. Vi invito a
riflettere su cosa sarebbe successo se fosse stato un uomo a compiere un simile
gesto, minacciando in diretta televisiva di zittire a scarpate la sua
interlocutrice. Anzi, non c'è neanche bisogno di starci troppo a riflettere,
probabilmente sarebbe già partita una cavalcata di valchirie social armate
dell'hashtag #shoetoo. Ma andiamo avanti con un altro capitolo del libro,
dedicato ad un'altra deprecabile frase maschilista, «Ormai siete dappertutto».
Qui si inizia a fare la conta delle donne in posizioni di visibilità o di
rilievo e si scopre che «Contare è essenziale e rivoluzionario, perché rileva
immediatamente il tasso di biodiversità sociale e quindi di giustizia». Dunque,
a parte che «biodiversità sociale» non si può sentire e fa sembrare la presenza
femminile una questione ecologica, contare è sempre importante nella vita, ma
non è su semplici conteggi che si costruisce il merito. Come si dice a scuola,
per il voto finale quello che conta non è solo il risultato, ma soprattutto come
ci si è arrivati, ossia lo svolgimento del problema. Bisogna partire
dall'inizio, facendo in modo che sia data a tutti la stessa possibilità di avere
accesso ad una determinata posizione. Chi poi ci si siederà sarà scelto per le
sue competenze e non dovrebbe certo rispondere o sottostare a generali e
generiche esigenze di conteggi. Si passa poi ad affrontare lo spinosissimo tema
del «Come hai detto che ti chiami?», cioè come chiamare una donna, e qui ci si
incastra subito: non bisogna usare nomi o soprannomi (espressioni di
paternalismo), solo cognomi, ma senza articoli, sennò si potrebbe finire nella
sgradevole situazione dell'autrice, il cui cognome, se preceduto da articolo
determinativo femminile, risulta assimilabile ad un altopiano della Puglia. Mi
raccomando anche niente «signora» o «signorina», le donne devono prima di tutto
avere un «perché» e non essere definite «per chi». Attenzione anche ai «brava» e
ai «bella», pericolosissimi complimenti usati dal patriarcato per stabilire la
propria superiorità sessuale nella gerarchia del pensiero. Un'altra delle frasi
stigmatizzate è «Le donne sono le peggiori nemiche delle altre donne», che
invece mi trova in totale accordo, in particolare quando si tratta di certi
nazi-femminismi. Ma l'amara realtà è che non vi potete fidare neanche della
femmina che vi sta scrivendo perché, Murgia ci svela, il patriarcato, servendosi
di tattiche astute e subdole, ha bisogno di ottenere la complicità di un piccolo
numero di donne per poter fare funzionare i suoi sordidi e perversi meccanismi
di potere. Morale della favola, se criticate il femminismo e siete femmine
allora siete state plagiate, mentre se la critica viene da un maschio, ovviamene
sarà marchiato come maschilista. E cari maschi non provateci neanche a dire «Io
non sono maschilista», perché Murgia ci spiega: «Ogni maschio eterosessuale che
nasca dentro il patriarcato deve essere consapevole di abitare lo scalino più
alto di una gerarchia di ingiustizia». Niente, non avete scampo, se non forse
un'unica via di redenzione: quella di innamorarvi di una femminista dimostrando
così di voler espiare i vostri peccati patriarcali. «Patriarcato» che, pagina
dopo pagina, diventa come le logge della massoneria, come i microchip dentro i
vaccini, come le onde del 5G, come i poteri forti, cioè la scusa perfetta, in
mancanza di altre argomentazioni, per una vittimizzazione fine a sé stessa.
L'obiettivo dichiarato di questo libro è quello di scardinare l'impianto verbale
che sostiene e giustifica il maschilismo, con la speranza che tra dieci anni
nessuno più dica le frasi catalogate. Ma mi chiedo se questo sia quello che
realmente vogliamo e, ancora più significativamente, quello a cui dovremmo
aspirare. Vogliamo veramente trattare le donne come una specie in via di
estinzione piazzandole in aree protette del linguaggio, trasferendole in riserve
innaturali di frasi controllate o addirittura censurate? È questo il terreno su
cui vogliamo portare le battaglie per la parità dei diritti? Per inciso,
l'articolo avrei potuto scriverlo anche senza leggere l'imperdibile decalogo
murgico, ma il mio rigore scientifico me lo ha impedito e il libro l'ho letto
tutto e pure sottolineato. Questo per dire che non sono io ad essere prevenuta,
ma sono questi femminismi ad essere diventati stucchevolmente prevedibili. E
comunque, quando qualcuno, maschio o femmina, mi chiede come voglio essere
chiamata, tipicamente offrendomi la scelta tra «signora», «signorina» o
«dottoressa», io rispondo sempre senza esitazione «principessa».
Uomini, noi non siamo il
nostro lato B.
Scoprite i lati (gli altri) migliori delle donne. Ogni commento
che riduce a una parte o evoca un atto è un colpo alla fragile unità
dell’essere. Giovanna Stanzione su Il Quotidiano del Sud il 7 marzo 2021. Di
recente ho comprato un jeans nuovo. È un jeans morbido, ma dalla bella linea. Un
modello espressamente pensato per “esaltare le curve”, come dice l’etichetta.
Non amo fare shopping e non compro spesso vestiti, ma entrare in quel jeans mi
ha fatta sentire felice, a mio agio, la stessa sensazione di quando mi calo
nell’acqua calda della vasca. Inutile dire che è diventato presto il mio
indumento preferito. Ora, i jeans, oltre ad avere molteplici usi pratici o
psicologici, hanno anche un’altra funzione che fino a oggi tendevo a
sottovalutare: ricoprono, sostengono e contengono il culo umano. Il culo è
un’appendice meravigliosa di cui la natura ci ha dotato per ammantare di
bellezza una funzione naturale piuttosto disgustosa. È un tempio morbido e
carnoso il cui ingresso remoto cela infiniti, oscuri misteri e che, come
l’oracolo di Delfi, può dispensare gioie e dolori. Bisogna saperlo capire e
interpretare. A parte i suoi usi più profondi, il culo ha altre utili funzioni.
La mia preferita è quella di essere un comodo cuscino termico, portatile,
imbottito di lipidi e riscaldato da vasi sanguigni, che rende agevole la seduta
su quasi tutte le superfici su cui vogliamo poggiarlo. È una parte del corpo tra
le più simpatiche. Con quella fessura che lo percorre tutto come un sorriso
sornione e le chiappe che sembrano due belle guance tonde e paffute. O magre o
cadenti o grandi o rientranti. Perché i culi, come le facce, sono tanti e
differenti e si può preferire un culo come si preferisce una faccia. Solo che il
culo ce lo portiamo dietro senza controllo e, per quanto possiamo contorcerci
davanti allo specchio, avrà sempre per noi il fascino dell’ignoto: esempio
costante di come gli altri possano avere l’accesso a una visione di noi che non
potremo mai avere. Il culo è per il corpo l’equivalente del punto cieco della
nostra anima. I culi a me piacciono. Non ho un particolare feticismo ma ne
apprezzo uno ben fatto, di uomo o di donna, e il contemplarlo mi attiva gli
stessi neuroni che si esaltano nel godimento dell’arte. Per quanto riguarda
quello che mi porto dietro, gli sono grata per una serie di ragioni. Ma non
avendolo spesso sott’occhio tendo a dimenticarlo, salvo quando si fa
dolorosamente sentire se lo schiaccio per ore su una sedia rigida. Ci sono dei
momenti in cui, però, sono altrettanto dolorosamente consapevole di avere un
culo. Uno di questi è stato qualche tempo fa. Sono stata fuori tutto il giorno e
ho camminato a lungo da sola. Il mio culo sempre con me. Avevo messo il jeans,
quello comodo ma carino, e la cosa mi faceva sentire piacevolmente fasciata ma
libera nei movimenti. Ero in uno stato d’animo raro ma benvenuto di buona intesa
di tutto il mio corpo. Ora, è molto facile mandare in frantumi l’armonia e
l’unità di un corpo o di una persona, quando di lei si isola una parte e si dà
peso e importanza solo ad essa. Non avendo usato da tempo jeans aderenti, mi ero
dimenticata come la mera e ovvia circostanza di avere un culo, provochi in
alcuni uomini pensieri e atteggiamenti irrazionali e atavici. Ho ricevuto dei
commenti, del tutto gratuiti e non richiesti, sul mio culo. E all’improvviso
sono stata consapevole in modo abnorme di averne uno. Non importa fossero
positivi o meno. Hanno avuto l’effetto di farmi diventare un culo che cammina.
Di rompere la mia unità e armonia. Di deformarmi, schiacciando il resto di me e
gonfiando come una mongolfiera una parte, utile ma limitata, del mio corpo. Non
ho mai avuto la reazione pronta, avrei voluto girarmi, tornare indietro, e
gridare in faccia a quei tipi che io non sono il mio culo. Che non lo porto in
giro per il loro piacere o perché sia valutato per consistenza e rotondità come
fosse una cassetta di pomodori. Ognuno ha il diritto di avere i propri gusti
sull’estetica di un corpo, ma nessuno può arrogarsi quello di gettare
apprezzamenti o commenti su di te per la sola ragione di avere una protuberanza
di carne e vasi sanguigni in mezzo alle gambe. Il loro genere ce l’ha da
millenni e quest’unica casuale circostanza li ha resi erroneamente convinti,
forse da generazioni, che la cosa rendesse le donne un piacevole fodero da
scegliere, valutare, stimare. Il fatto che anche loro avessero un culo
valutabile non li ha sfiorati neanche. Perché non hanno mai visto nessuno
degradare un uomo a quella sola parte del corpo, mentre, ci scommetto, avranno
visto molte volte una donna ridotta a mera portatrice di culo o tette. E
l’avranno imitato. Sono cresciuti con questa mai intaccata convinzione che un
culo femminile abbia bisogno del loro giudizio, anzi che sia lì senz’altro scopo
che permettergli di valutarlo e classificarlo, non importa se lo vedranno per
dieci secondi nella vita e poi mai più. Devono avere in testa vasti schedari
pieni solo di accurate valutazioni di culi femminili. E probabilmente
nient’altro. Complici le infinite e tramandate guerre di spogliatoio ingaggiate
dai fautori del culo contro gli apologeti delle tette o viceversa, che fanno
sembrare, in confronto, la guerra di Troia una scaramuccia durata poche ore, la
maggior parte degli uomini ha preso a cuore la faccenda di trovare propri,
solidi, canoni per stabilire la conformità dei vari culi (o tette) femminili a
quello che è il proprio Ideale culico, l’eterno femminino – fondoschiena
edition. Il che, se compiuta con le migliori intenzioni, potrebbe anche essere
una ricerca lodevole e remunerativa. Ognuno, poi, nei meandri della propria
mente è libero di fare quello che più gli piace. Ma deve essere una ricerca
interiore, un viaggio spirituale che ti innalza, e non uno sputo del proprio
limitato e limitante senso estetico sulla pelle di un’altra persona, che
accidentalmente è una donna. Non portiamo le nostre parti del corpo in giro
perché voi possiate appuntarci le vostre considerazioni. Nulla vi dà il diritto
di apprezzarci o non apprezzarci solo perché ci vedete per la strada. Questo è
un discorso femminista solo perché non ho mai visto una donna gridare dietro a
un uomo sconosciuto per strada che bel pacco che ha o quello che avrebbe fatto
col suo culo. Detto così sembra bellissimo. Ma, credeteci, ne soffrireste: ogni
commento che ti riduce a una parte di te o all’evocazione di un atto o di una
funzione è un colpo assestato a quella fragile unità che tiene insieme in un
equilibrio precario corpo, coscienza, autostima, sessualità, senso di sé. Unità
fragile e difficile che avete anche voi uomini, ma che nessuno vi nega, con
faciloneria, con distrazione, quasi automatismo, un giorno qualsiasi, mentre
portate in giro per strada tutto questo pericolante, sfaccettato, complesso,
personalissimo apparato che è il vostro io.
L'EVENTO. 8 marzo, la
«festa della donna» attraverso i femminismi.
Libri e idee: filosofia
dell’essere. Pietro Polieri su La Gazzetta del Mezzogiorno l'08 Marzo 2021.
Avvertenza generale preliminare: questo articolo è pieno di -ismi! Quelli che,
nel solco di una tradizione denominativa ormai inveterata, servono a
rappresentare le innumerevoli declinazioni che il femminismo ha assunto nel
corso del tempo, e che si ripromettono di esaltare una particolare componente
della cultura/ prassi femminista, giudicata centrale da una specifica sua
corrente. Ma gli -ismi, recentissimi, qui introdotti, sono o già ampiamente
formati o proposti per la prima volta per mostrare linee tendenziali che già
suggeriscono un evidente orizzonte di senso e un territorio operativo di
approdo. Composto e rigoroso è l’oblativismo di Genevieve Vaughan, che propone
con i suoi studi sul legame tra dono e donna una delegittimazione dell’economia
dello scambio, ma anche l’affermazione di un principio comunitaristico fondato
sulla donatività unidirezionale (non contra-cambiata) e di cura, emergente dal
ruolo sociale femminilmente materno che riconosce alla donna. Spigoloso e
irriverente si presenta invece l’anti-patriarcalismo di Mariam Irene Tazi-
Preve, che nella famiglia cosiddetta tradizionale e naturale legge non solo una
costruzione del capitalismo maschiocentrico, ma anche il dispositivo
privilegiato della sua stessa riproduzione, finalizzata addirittura allo
sfruttamento della capacità procreativa della «femmina » per eliminare la madre
dallo scenario socioantropico e insediare definitivamente al suo posto la
«creazione maschile ». La Tazi-Preve come la Vaughan è pienamente convinta che
un’articolazione femminile della società sulla base di un potere totalmente
gestito dalle donne sarebbe capace di imporre valori e paradigmi del tutto
antitetici a quelli competizionali e conflittuali sorgenti dall’esercizio di un
potere concepito maschilmente. Tale convinzione, poi, non tarda a essere
robustamente confermata proprio dallo studio sul cosiddetto «regno delle donne»
di Ricardo Coler, di recentissima ripubblicazione in Italia, ovvero sul
probabile ultimo matriarcato storico incarnato dalla società/cultura
matrilineare cinese dei Mosuo, in cui dissidi, violenze e ansie da prestazione,
mostrine del maschile, lasciano il posto a un godimento indeterminato e a un
salutare ozio condiviso che distendono le relazioni interumane. Su questa strada
si incammina, in modo più filosofico-politico, l’anti-familismo riformista di
Carole Pateman che, interpretando il matrimonio come contratto sessuale, svela
che sia questo in realtà, e non quello sociale, il luogo di fondazione della
civiltà occidentale asimmetrica del diritto maschile sulle donne. E che dire
dell’anti-maternalismo, diversamente graduato, di Corinne Maier, Lina Meruane,
Flavia Gasperetti, Valeria Arnaldi, Elena Rosci, o quello dell’israeliana Orna
Donath, che inaugura il filone del pentitismo post-partum, capace di far
affiorare con determinazione lo sguardo scettico e polemico della donna ebrea (e
non solo!) moderna sulla sacralizzazione della maternità-per-legge-morale? E si
vorrebbero trascurare l’elettrismo corporale di Jennifer Guerra, che poggia su
un soggetto carnale, intonato su un desiderio liberante, o lo xenofemminismo di
Helen Hester, inteso come oltre-femminismo tecnomaterialista, che, come
l’elettrismo, chiede l’abolizione del genere? Per non parlare del deformismo,
declinato sull’idea di «mostruositrans» di Filomena «Filo» Sottile o
sull’anti-grassofobi - smo, crititico rispetto allo stigma normo-estetico della
«vergogna grassa». Tanti -ismi: ma per quante donne attuali?
Mirella Serri per “la Stampa”
l'8 marzo 2021. Oggi ricorrono 75 anni dalla prima festa della donna bell'Italia
post-bellica con le strade e le piazze piene di mimose. E il 10 di questo stesso
mese ricordiamo il trionfale battesimo delle donne che nel 1946, per la prima
volta nella storia d'Italia, divennero elettrici ed entrarono anche come
protagoniste nell'agone della politica con incarichi decisionali, di
responsabilità e di prestigio. Le prime dieci che indossarono la fascia
tricolore di sindaco erano Ninetta Bartoli, Elsa Damiani, Margherita Sanna,
Ottavia Fontana, Elena Tosetti, Ada Natali, Caterina Tufarelli Palumbo, Anna
Montiroli, Alda Arisi e Lydia Toraldo Serra. Con la tornata elettorale che
coinvolse 5722 tra città e paesi irruppe nei consigli comunali la carica delle
duemila neonominate. Errore o lapsus freudiano? L'orgoglio femminile per questa
doppia ricorrenza era alle stelle ma la parità di genere rimaneva un miraggio.
Si inaugurò in quel primo momento di gloria una tradizione che arriva ai nostri
giorni: dal governo De Gasperi II, il primo della Repubblica, al Conte II, su
4.864 presidenti del Consiglio, ministri e sottosegretari, le esponenti di sesso
femminile sono state solo 319, il 6,56 per cento del totale. Le donne occupano
oggi solo un terzo delle cariche politiche nazionali e nei governi in cui sono
entrate non hanno mai ottenuto alcuni ruoli chiave come il ministero
dell'Economia, e tantomeno, la carica di presidente del Consiglio. L'avventura
nell'emiciclo parlamentare e in generale nelle istituzioni si è trasformata in
un perenne braccio di ferro poiché, come ha affermato la storica Michelle
Perrot, in Italia le donne in politica non sono facilmente accettate. Questo si
capì fin dal primo approccio: le candidate che si presentarono alle
amministrative del 1946 furono ammesse per il rotto della cuffia. Il decreto
legge del primo febbraio 1945 che sanciva il suffragio femminile per un errore
(o lapsus freudiano? chissà!) riconosceva alle donne l'elettorato attivo ma non
quello passivo, cioè potevano votare ma non essere elette. Rimediata la svista,
le deputate entrate a far parte dell'Assemblea Costituente furono uno sparuto
gruppetto, 21 su 556 membri. Nel discorso per l'insediamento a Montecitorio la
democristiana Angela Maria Guidi Cingolani rivendicò che il voto alle italiane
non era «un premio ma un diritto». La partigiana Teresa Mattei Non la pensavano
così gli onorevoli colleghi: nella commissione composta da 75 membri incaricati
di stendere il progetto generale della Costituzione le donne furono solo 5. Nel
comitato di redazione che scrisse il testo finale vi erano solo uomini. Alle
deputate furono assegnati come temi peculiari «la famiglia e l'uguaglianza dei
coniugi», ricordò Nilde Iotti, nonché «il diritto al lavoro e la tutela dei
figli anche illegittimi». Ma le grandi madri costituenti erano state
protagoniste della lotta partigiana, del mondo del lavoro e dell'impegno
sindacale. I giornali ne sminuivano continuamente l'autorevolezza. Di Alcide De
Gasperi sottolineavano il «piglio onesto e infaticabile», Luigi Longo lo
descrivevano come «laborioso e diligente» e Palmiro Togliatti come un grande
leader persino attento alla famiglia. Ma della deputata venticinquenne Teresa
Mattei ricordavano solo che i partigiani la chiamavano Chicchi. Sorvolavano sul
fatto che, durante un'azione di combattimento, la Mattei era stata catturata,
torturata e selvaggiamente violentata dai tedeschi. Quando Chicchi rimase
incinta di un uomo sposato, Togliatti giudicò sconveniente che proseguisse
l'esperienza politica. L'«onorevolessa» Le maggiori testate si deliziavano poi
per il vestito à pois di Nilde Iotti, trascurandone l'adesione ai Gruppi di
difesa della donna; della Cingolani, definita per «scherno l'«onorevolessa»,
deprecavano l'abito nero senza rilevarne la competenza sul mondo del lavoro, e
della socialista Bianca Bianchi dicevano che era la più bionda di Montecitorio
ma non rammentavano il curriculum di valente giornalista. Tutte le signore,
inoltre, erano accomunate dal fatto «che non fumano e vestono con sobrietà». Le
deputate, anche se di orientamenti politici diversi, riuscirono a imporsi e a
fare squadra: per esempio, fu esclusivamente loro il merito di aver introdotto
il principio dell'uguaglianza dei diritti con l'articolo 3 il quale recitava che
«i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali». I padri costituenti non volevano comunque
lasciare libero il campo alle esigenze femminili. Le onorevoli Maria Maddalena
Rossi e Teresa Mattei proposero l'emendamento secondo cui «le donne hanno
diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della magistratura». Per battersi
a favore di questa soluzione la Rossi evocò Teresa Labriola e pure il
personaggio di Porzia nel Mercante di Venezia di Shakespeare perché dotate «di
sensibilità e di conoscenza profonda del diritto». Femminilità vs razionalità Ma
il democristiano Giovanni Leone, futuro presidente della Repubblica, ebbe la
meglio discettando che la «femminilità» era in conflitto con la «razionalità»
maschile necessaria per operare nei tribunali. Insomma le donne non avevano una
testa e un cervello adatte a presiedere una Corte. Solo nel 1965 venne varato il
primo concorso perché la magistratura potesse tingersi di rosa e adesso il
numero delle donne magistrato ha superato quello dei colleghi maschi, mentre
sono ancora poche le toghe femminili che accedono agli incarichi di
vertice. Passi avanti e passi indietro Bisognò poi aspettare il 1976 per avere
la prima donna ministro, con Tina Anselmi al dicastero del Lavoro e della
Previdenza sociale, ma l'Italia è ancora oggi tredicesima in Europa per
percentuale di donne ministro, decisamente sotto la media dell'Ue. Per le donne
in politica a ogni passo avanti ne corrispondono parecchi indietro. L'esecutivo
guidato da Matteo Renzi raggiunse la parità tra i due sessi ma solo per otto
mesi. Nei governi successivi l'incremento della rappresentanza femminile ha
avuto di nuovo varie battute di arresto e oggi nel governo presieduto da Mario
Draghi le donne sono 8 contro 15 uomini: una partita squilibrata.
Le sindache in Italia sono
solo il 15 per cento. E buon otto marzo.
Fabiana Martini su L'Espresso
l'8 marzo 2021. Perché nel nostro Paese è così difficile per le donne fare
politica? Lo abbiamo chiesto a chi ci ha provato. Da Nord a Sud. Come la ex
prima cittadina di Rosarno: «Ogni giorno entravo in Comune e dicevo adesso mi
metto il casco per fare la guerra». Sono passati settantacinque anni da quando
le italiane hanno votato per la prima volta e dal decreto che il 10 marzo 1946
ha sancito la loro eleggibilità; quarantacinque da quando Tina Anselmi è
divenuta la prima ministra della Repubblica. Nel frattempo un’italiana è andata
nello spazio e sembra che nel nostro Paese sia un’impresa più semplice che
governare una città. Nel 2021, infatti, soltanto il 15 per cento dei Comuni
italiani è guidato da una donna; sono decisamente di più le assessore, che
raggiungono il 44 per cento, ma solo per merito della legge 56/2014, la così
detta Delrio, che prevede che nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore
a 3000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento; se poi andiamo a rilevare le consigliere e le
presidenti dei Consigli comunali, le percentuali scendono nuovamente al 34 e al
26 per cento (secondo i dati del ministero dell’Interno, dati aggiornati al
27/01/2021). Ma perché in Italia è così difficile per le donne fare politica,
tentare di erodere quel privilegio maschile ormai istituzionalizzato, che nei
secoli ha fatto incetta di posti e non è disponibile a mollarli? In un viaggio
che ha attraversato tutte le regioni lo abbiamo chiesto a chi ci ha provato:
donne al primo incarico o politiche di lungo corso, espressione dei vari partiti
o della società civile, con o senza figli. Tutte si sono candidate per dare un
contributo mettendo le proprie competenze a servizio del territorio, un
territorio spesso difficile e “in salita” non solo geograficamente, dove hanno
deciso di restare nonostante tutto: un modo — dicono — per andare oltre la
lamentela e la critica sterile, per esercitare responsabilità e agire il
cambiamento in prima persona. «In fondo per una donna entrare in politica non
significa fare qualcosa di lontano dalla propria quotidianità, ma lavorare per
il territorio nell’interesse collettivo», dice Elena Meini, consigliera comunale
a Cascina (Pisa). Emilia Delli Colli, prima cittadina di Rocca d’Evandro
(Caserta), da vent’anni lavora nella farmacia del paese e da dieci fa politica,
ma per essere eletta ha dovuto fare il triplo degli sforzi, perché «nella
mentalità il sindaco è una figura autorevole e un sindaco donna non si può
sentire»; eppure — racconta Francesca Arcadu, consigliera comunale a Sassari dal
2014 al 2019 — dove le donne governano dimostrano che «sanno fare, hanno
visione, sono capaci di andare dal problema alla soluzione; sono in quei posti
per fare delle cose, non per occupare spazi di potere». La pensa allo stesso
modo Luisa Guidone, presidente del Consiglio comunale di Bologna: «Quando le
donne s’impegnano, sono imbattibili: le sindache che lavorano sui territori sono
difficili da demolire, resistono, hanno più pazienza, savoir faire». Entrambe
credono che il cambiamento vada accelerato e sostengono con forza le quote e la
doppia preferenza di genere, perché secondo Guidone «quello maschile è un
sistema che si autorigenera e si autoalimenta e le leggi sono l’unico modo per
scardinarlo». Nessuna pensa che si debba votare una donna perché è donna, ma
perché lavorano bene, sono più sintetiche, più mediatrici, non si fanno
governare dal consenso, hanno obiettivi ambiziosi a lungo termine che forse non
vedranno realizzati ma per i quali s’impegnano con la stessa determinazione,
sono meno portate alla ribalta. A volte ci finiscono loro malgrado, ora più di
un tempo, grazie alla macchina del fango alimentata dai social. Confessa Arcadu:
«Tu fai tanto, poi basta un post a caso per distruggere tutto. Se non hai le
spalle forti e sei un po’ sensibile, questa roba ti asfalta». Motivo per cui
anche una millennial come Alice Chanoux, sindaca di Champorcher (Aosta), 393
abitanti divisi tra 27 frazioni, è molto diffidente nei confronti della Rete:
«Sui social è sempre in agguato il rischio di fraintendimenti con maggiori
disagi rispetto ai benefici». E se i fraintendimenti possono intossicare la
comunicazione, gli attacchi personali possono fare davvero molto male e non solo
a chi è in prima linea. È il caso ad esempio di Elisabetta Tripodi, sindaca di
Rosarno dal 2010 al 2015, che definisce la sua esperienza un Vietnam, devastante
soprattutto sul piano umano: «Ogni giorno entravo in Comune e mi dicevo: mi
metto il casco per fare la guerra». Contro la cosca dei Pesce, che l’hanno
costretta alla scorta, un’esperienza dura in particolare per i suoi figli:
«Abbiamo sperimentato un isolamento totale: ho perso tante amicizie, che forse è
più corretto definire conoscenze, ma non sono pentita, perché quando sei in
ballo devi ballare», ma anche nei confronti dei suoi consiglieri e dei compagni
di partito, responsabili della conclusione anticipata del mandato. Con il
rammarico che si sia parlato di lei solo in relazione alla tutela ottenuta,
offuscando i non pochi risultati conseguiti: opere per 30 milioni di euro e non
solo. Anche Sumaya Abdel Qader, consigliera a Milano, durante la campagna
elettorale è stata travolta da un’ondata di cattiveria, che l’ha fatta stare
molto male: «Il momento in cui ho avuto veramente paura è stato quando hanno
cominciato a toccare i miei figli, lì non ci ho più visto: li ho chiusi in casa,
non li lasciavo uscire; poi ho capito che non potevo farli vivere così e dopo
aver creato una rete di protezione ho allentato la presa. Inoltre non volevo che
odiassero il mondo perché il mondo odia la mamma». Un prezzo molto alto l’ha
pagato anche Cettina Di Pietro, sindaca di Augusta dal 2015 al 2020 dopo trenta
mesi di commissariamento a causa di presunte infiltrazioni mafiose: «Ho ricevuto
una quantità incredibile di attacchi personali, che non credo avrei ricevuto in
egual misura se fossi stata un uomo. Dimenticando che sono anche una mamma,
hanno dato sfogo non solo a critiche, ma a vere e proprie dicerie: ero
naturalmente l’amante di tutti, ero un’ubriacona, chi sa poi cosa significava il
fatto che avessi nominato una giunta prevalentemente femminile…». Insinuazioni
che non entrano nel campo degli uomini, a cui non viene chiesto di dimostrare la
loro irreprensibilità, al pari dei loro meriti, regolarmente dati per scontati,
quasi facessero parte del patrimonio genetico. Se poi aggiungiamo il fattore
tempo, il vantaggio irrecuperabile è servito. Per Simona Lembi, presidente della
Commissione Pari Opportunità dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani),
infatti, «fino a quando le donne non avranno un tempo sufficiente per sé e per
scegliere, se lo desiderano, di rappresentare una parte della cittadinanza,
parliamo di niente. E il tempo delle donne è un tempo ancora non libero. Quando
va bene hanno un lavoro pagato (ce l’ha meno di una su due), ma la cura è ancora
tutta sulle loro spalle». Aggiunge Angela Fiore, assessora a Matera dal 2018 al
2020: «Per quanto si possa cercare di delegare, il tempo che ci rimane a
disposizione è troppo poco, perché la gestione e il controllo spettano sempre a
noi». In un contesto caratterizzato da riunioni infinite a orari improbabili,
con tempi scomodissimi tutti decisi dagli uomini, nel quale capita però che il
numero legale in giunta lo garantiscano le donne, gli esempi possono avere una
grande forza. Stefania Proietti, sindaca di Assisi, ingegnera impegnata in una
svolta green dalla sua postazione in municipio, in alcune occasioni pubbliche
sceglie di portare i suoi figli: «È un modo per incoraggiare le altre donne, per
dire loro che impegno politico e maternità possono convivere». Ed è un messaggio
anche per le più giovani, che spesso hanno poca fiducia in se stesse: «È
importante far capire loro che valgono mentre sui ragazzi bisogna lavorare per
superare la rigida divisione dei ruoli», dice Elisabetta Anversa, vice sindaca
di Camogli. Un lavoro che per molte comincia in famiglia con i propri figli e i
propri mariti e compagni: Antonella Matticoli, assessora ad Isernia, sostiene
che «è fondamentale trasmettere che mamma e papà devono avere gli stessi
diritti. La cosa più difficile è stata rieducare mio marito, abituato al fatto
che io ero a casa, ma mi ha sostenuto molto». Esigenze di conciliazione in
risposta alle quali servono, secondo la maggior parte delle nostre
amministratrici, cultura e servizi. Ma c’è anche chi pensa, come Paola Pisano,
assessora a Torino e poi ministra nel Conte 2, — una che non si spaventa davanti
alla complessità e che è riuscita a organizzare uno spettacolo di droni in
piazza San Carlo, che non si ferma di fronte ai «non si è mai fatto così» o alla
mancanza di risorse, perché «i soldi ti ammazzano la fantasia» — che «una
soluzione non c’è: anche ci fossero gli asili per tutti, i bambini si ammalano.
Ma questo non significa che una volta cresciuti non si possa far carriera». E
poi c’è chi, come Francesca Toffali, assessora a Verona, è convinta che «la
prima conciliazione te la devi trovare in casa: devi prima chiederlo a chi dorme
con te e non pretenderlo da altri. Se quando torni la sera non hai nessuno che
ha preparato la tavola o fatto la spesa, come fai a trovare il tempo per
impegnarti in politica?». Il tempo, tuttavia, non è l’unico problema: «Noi donne
scontiamo un complesso d’inferiorità, che ci fa sentire perennemente inadeguate.
Abbiamo due strade per superarlo: adottare uno stile autoritario per sopperire
alla mancanza di autorevolezza oppure impegnarci al massimo per far emergere al
meglio le nostre competenze», dice Laura Marzi, sindaca di Muggia (Trieste).
Quasi sempre scelgono la seconda strada e non si sottraggono a sfide
apparentemente impossibili: semplificare una realtà ipercomplessa come Roma,
progettare di sfamare il territorio con la canapa anziché con gli
elettrodomestici, riattivare una centrale idroelettrica, decretare l’uscita di
Bari dalla situazione di povertà estrema attraverso la promozione di reti a
sostegno delle persone fragili. Queste le scommesse accettate rispettivamente da
Flavia Marzano, assessora della giunta capitolina dal 2016 al 2019, a servizio
della quale ha messo tutto il suo bagaglio di analista dell’impatto sociale e
organizzativo dell’innovazione; dall’assessora di Fabriano Barbara Pagnoncelli,
che con una disoccupazione al 30 per cento ha smesso di guardare al glorioso
passato; dalla sindaca di Villetta Barrea (L’Aquila) Giuseppina Colantoni, che
non si è arresa alla burocrazia; dall’assessora Francesca Bottalico, che ha
ridisegnato il sistema di welfare barese lavorando sull’analisi dei dati e dei
fenomeni in cambiamento, con un’attenzione particolare al bisogno non
esplicitato: «È un lavoro partito dal basso, senza soluzioni predefinite e
proponendo sempre un patto educativo con gli attori coinvolti. Welfare per me ha
a che fare con benessere e non può ridursi a una borsa della spesa o a un
sussidio mensile». Un investimento di speranza nel futuro, che non
necessariamente porta voti. E benessere, inteso come sentirsi a casa,
riconoscersi in una comunità, è una parola chiave anche per Rosmarie Burgmann,
sindaca di San Candido (Bolzano) dal 2015 al 2020, che durante il suo mandato ha
organizzato periodicamente delle assemblee aperte alla cittadinanza, convinta
che «ci dev’essere spazio in una democrazia per esprimere opinioni diverse, non
solo al bar o dietro una porta chiusa», come spesso fanno gli uomini nelle
segreterie di partito o addirittura negli spogliatoi, dopo aver giocato a
calcio. Uno stile fatto di ascolto ma anche molto concreto: potremmo azzardarci
a definirlo femminile, ma non vogliamo ingabbiare le donne, neanche in veste di
amministratrici, in un unico cliché. Perché le donne sono tante e diverse, ma in
politica ancora troppo poche per fare la differenza. E la sotto rappresentazione
di più di metà della popolazione non è un problema delle donne, ma incide sulla
crescita dell’intero Paese, alimentando le disuguaglianze sociali. «La presenza
femminile in politica, nei posti cosiddetti “di potere”, non serve soltanto alle
donne, serve a migliorare la qualità della società. Per tutti». Lo diceva Tina
Anselmi e non lo abbiamo ancora capito.
Agnès Varda, la gioia di
essere femministe.
La lezione di una grande artista scomparsa due anni fa: trovare
la propria identità femminile nella società, nella vita privata, nel rapporto
con il proprio corpo. Carolina Germini su Il Quotidiano del Sud l'8 marzo 2021.
Agnès Varda si fece strada coraggiosamente in un universo di uomini nel 1955,
con un film che il critico André Bazin definì “miracoloso”, per quanto fosse
lontano dal cinema francese contemporaneo, fissato su rigidi schemi filmici e
narrativi. Si tratta di La Pointe Courte, che, per la sua struttura, anticipa
già i suoi lavori successivi: immagini documentarie di un villaggio di pescatori
si alternano alla storia di una coppia parigina. Quando Agnès Varda con il suo
caschetto bianco e rosso varcò la soglia dell’aula, in cui ogni martedì i
ragazzi dell’École Normale Supérieure di Parigi organizzavano il Cineforum,
capimmo immediatamente che si trattava di un essere straordinario.
Aveva 89 anni ma l’energia di
una ragazza. Quella sera venne proiettato Le Bonheur, il suo primo
lungometraggio a colori. Come lei stessa spiega in Varda by Agnès –
retrospettiva del suo lavoro di artista – le scene che incontriamo in questo
film, per l’uso dei colori, richiamano i quadri dei pittori impressionisti.
Varda, nella stessa retrospettiva, racconta che nel suo lavoro è sempre stata
mossa da tre elementi: ispirazione, creazione, condivisione. L’ispirazione è il
motivo per cui si fa un film: le motivazioni, le idee e gli eventi che scatenano
il desiderio. La creazione è il modo in cui si realizza: la scelta dei mezzi e
della struttura. La terza parola è condivisione: i film non sono fatti per
essere guardati da soli, ma per mostrarli agli altri. Varda è profondamente
cosciente del processo creativo che accompagna il suo lavoro. La sua formazione
filosofica e la professione di fotografa l’hanno portata a creare nel tempo una
forma del tutto personale di cinema, che lei stessa ha definito “cinécriture”:
un metodo che prevede la scrittura del soggetto insieme alla lavorazione del
film. Questa scelta si rivelerà fondamentale poiché farà dell’imprevedibile la
cifra distintiva del suo lavoro, rendendola fin da subito riconoscibile.
Conquisterà così un preciso stile cinematografico, non confondendosi con il
filone della Nouvelle Vague, a cui viene spesso associata. La sua originalità va
ricercata nella totale libertà di sperimentazione, nel modo unico in cui
intreccia la finzione al documentario. Ne è un esempio Cléo de 5 à 7, il suo
secondo film e il primo di una lunga serie in cui le donne sono le protagoniste
assolute della scena. Non avendo a disposizione un grande budget per
realizzarlo, Varda scelse di girarlo a Parigi in una sola giornata. Ma, una
volta iniziate le riprese, l’idea si fece ancora più radicale: concentrare tutto
il tempo del film in sole due ore. La centralità assegnata alle figure femminili
trova la sua massima espressione nel film L’Une chante l’autre pas (1975), che
racconta la storia di due amiche molto diverse che si ritrovano dopo dieci anni
ad una manifestazione per la legalizzazione dell’aborto in Francia, che venne
approvata nell’anno in cui fu realizzato. Sempre nel 1975, a Varda venne chiesto
da una rivista femminista di girare sette minuti sul tema “Che cos’è essere una
donna?”. Il risultato di quel lavoro è Réponse de femmes, in cui undici donne,
nude in alcune scene, rispondono a questa domanda. Mostrare il corpo nudo per
Varda ha un significato preciso. Ciò che le interessa non è tanto parlare della
condizione femminile quanto scoprire la donna fisicamente, analizzando come
reagisce a ciò che la società occidentale chiede al suo corpo. Una richiesta
quasi schizofrenica: “Copriti, sii pudica” e allo stesso tempo “Mostra le gambe
per vendere collant”. La Varda, scomparsa due anni fa all’età di 91 anni, è
stata originale non solo nel suo lavoro di cineasta ma anche nel modo di essere
femminista. Potremmo dire che il suo cinema e il suo femminismo appartengono
alla stessa ricerca: trovare la propria identità femminile nella società, nella
vita privata, nel rapporto con il proprio corpo.
Mario Platero per “Robinson -
la Repubblica” l'8 marzo 2021. Cominciamo con una premessa: prima di essere la
più grande scrittrice americana del nostro tempo, Joan Didion è stata una donna
che dal suo debutto, alla fine degli anni Cinquanta ha bruciato le tappe dell'
emancipazione femminile in un mondo occupato da uomini. Lo ha fatto in modo
originale, solitario, determinato, efficace. Le chiedo quanto fosse decisa a
farcela in questo mondo dominato dai maschi, se si rendeva conto di aprire con
la sua opera, con la sua vita, nuove frontiere per le donne: «Non avevo
coscienza di essere una donna che apriva nuove strade per altre donne, non
pensavo a me stessa in quell' ottica», mi dice in un' intervista a New York
dalla sua casa sulla 71 East dove è in prudente lockdown dall' inizio della
pandemia e da dove si concede al massimo una puntata a Central Park. Mi torna in
mente una sua frase in una delle sue prime collezioni di saggi, ‘’Verso
Betlemme’’ (riuscito in Italia, come gli altri titoli, da il Saggiatore): «Sono
così piccola fisicamente, così discreta per temperamento e così nevroticamente
inarticolata che la gente tende a dimenticare che la mia presenza va contro i
loro migliori interessi». È un tema ricorrente. Lo ripropone in uno dei saggi
del suo ultimo libro e quando le chiedo di commentare mi conferma: «La mia
apparente fragilità era davvero la mia arma segreta». Dietro questa fragilità
solo apparente, fisica, di allora, c'erano anche incertezze, insicurezze,
disperazione, sentimenti ricorrenti nella sua opera e nei suoi umori. Ma su
tutto, sul lutto, sulle paure, sul senso di vuoto, hanno sempre prevalso la
tenacia, il carattere, la precisione, il metodo. Anche per questo - pur provata
fisicamente come è oggi - Joan Didion è riuscita a darci a 86 anni questo altro
libro, Let Me Tell You What I Mean, pubblicato a New York da Knopf appena poche
settimane fa, una collezione di saggi scritti fra il 1968 e il 2000. I più
vecchi, quelli del 1968, ci portano a un passato remoto denso di nostalgia per
il lettore di oggi. In "Pretty Nancy" nella cornice di un' intervista con Nancy
Reagan, quando Ronald era ancora governatore della California, c' è una
descrizione puntuale dell' America contemporanea di allora, che non esiste più.
In "Non essere scelta dall' università preferita" c' è il ricordo, umiliante e
deprimente, della lettera con cui veniva respinta la sua domanda di ammissione a
Stanford. Fu poi ammessa a Berkeley e, come ci racconta, andò anche meglio. In "
Why I Write" confessa che ci volle del tempo, anche all' università, per capire
che la sua era una vocazione da scrittore. Solo dopo, dopo le raccolte di saggi,
a partire da White Album ci avrebbe dato alcuni capolavori. Penso a ‘’L' anno
del pensiero magico’’ del 2005. È scrivendo il Pensiero magico che Joan riesce a
superare la disperazione per la perdita improvvisa nel 2003 di suo marito John
Gregory Dunne, del compagno della sua vita, dello scrittore amico, irascibile,
con cui confrontare opere e pensieri. Proprio nel 2005 muore anche sua figlia
Quintana Roo a 39 anni. Un altro immenso dolore. A Quintana, unica figlia,
adottata a Hollywood, dedica un altro libro, Blue Nights. Ma è con ‘’L' anno del
pensiero magico’’ che ha vinto il National Book Award ed è intuitivo pensare che
questa sua opera sia adatta a questo momento terribile per l' America, travolta
dal più grande lutto collettivo della sua storia. La fuga nel "pensiero magico"
potrebbe aiutare, ma di questo nella nostra intervista Joan non ne vuole
parlare, non vuole fare confronti o collegamenti tra il suo libro e questa
tragedia contemporanea. Piuttosto, come spesso le succede (pensiamo a quante
anticipazioni ci sono nella sua opera!) preferisce guardare in avanti, al dopo,
e, pensando al futuro, non può fare a meno di essere angustiata: «Sono
preoccupata per quel che succederà quando il Covid sarà superato - mi dice - lo
sono per quel che, per molti, potrà essere la conseguenza in termini di
stabilità mentale » . Se ne parla ovviamente, quanto del nostro equilibrio pre
Covid resterà intatto nel post Covid? La domanda è profonda e spaventosa allo
stesso tempo. E per ora non abbiamo risposte. Quella con Joan non è stata un'
intervista facile. Già, in generale, tutto avviene a distanza, via Zoom o al
telefono. Ma con Joan neppure Zoom è possibile. È oltremodo affaticata. Parla
pochissimo. Le sue frasi sono brevissime, spesso monosillabiche. L' ultima volta
che la vidi, un paio di anni fa, la sua fragilità era preoccupante. Oggi è
ancora più magra, sembra un fuscello pronto a volare con un soffio di vento. È
di nuovo un' apparenza, perché poi, come abbiamo visto, lavora e pubblica
ancora. Il suo pensiero, come mi sono accorto dall' interazione su domande e
risposte, è arguto e selettivo. Alla fine, con l' aiuto della sua editor
storica, Shelley Wanger di Knopf, siamo arrivati all' unica soluzione possibile,
quella di contattarci via mail. Mi dispiaceva non ascoltare la sua voce esitante
ma chiara, non sorprendermi per la sua risata gioiosa e improvvisa o non seguire
il suo gesticolare teatrale e complementare al movimento del suo pensiero. Lo
avevo seguito in altre occasioni. Ci si vedeva, ormai molti anni fa a casa di
Camilla e Earl McGrath, sulla 57esima West, proprio davanti alla Carnegie Hall.
Era uno dei grandi salotti intellettuali di una New York di un altro tempo.
Oltre a John Dunne e Joan Didion c'erano il fratello di John, Nick e suo figlio
Griffin. Griffin è un regista, alcuni anni fa ha girato uno splendido e
commovente documentario su Joan che potete trovare su Netflix. C' erano Ahmet
Ertegun, di origine turca, il leggendario raffinatissimo fondatore della
Atlantic record - che lanciò tra gli altri Ray Charles e i Rolling Stones in
America - e sua moglie Mica; artisti come Larry Rivers o Cy Twombly, se era di
passaggio a New York. Editori come Sonny Mehta e molti altri. Earl, un mercante
d' arte, era un amico da sempre, dai tempi della California, nella seconda metà
degli anni Sessanta, ben prima del ritorno a New York. Joan lo ricorda più volte
nell' Anno. E pensando al momento difficile che stiamo passando mi concede due
riflessioni, una sull' amicizia e l'altra sulla nostalgia che diventano elementi
chiave per il conforto e per la fuga mentale in questi lunghi momenti di
isolamento. « L' amicizia o la famiglia sono un pilastro quando si affronta una
perdita - dice Joan - se penso a Earl penso a un' ancora, lo stesso vale per
Harrison». Harrison è Harrison Ford, il grandissimo attore. Prima della sua
orbita fra le stelle di Hollywood, faceva il falegname. Come racconta lui stesso
in varie occasioni, andò a vivere con John e Joan per ampliare la loro casa.
Erano già celebrità, lui, invece, uno sconosciuto. Ma lo invitavano con la
moglie e i figli alle feste comandate. E lui andava con riconoscenza. Il
rapporto, dopo, non è mai più cambiato. Chiedo a Joan se un balzo nostalgico nel
passato può aiutare, se può essere un balsamo per i momenti di sconforto, anche
quelli dal lockdown pandemico. « Non so se la nostalgia sia un balsamo per
curare lo spirito quando sei giù - risponde, confermando quanto la sua
concezione di nostalgia sia avulsa dal rischio di cadere in un romanticismo
sdolcinato - ma so che per me le cose importanti nella nostalgia sono l' insieme
del ricordo di un posto, di un umore, di una luce, di un singolo momento
particolare, di una interazione con amici o con altra gente ». Al momento
nostalgico non poteva mancare la sua città, New York. Le manca la città di un
tempo? La ritroveremo nel post Covid? « Certo che mi manca New York come la
conoscevo prima della pandemia. E sì, credo che New York ce la farà, tornerà
alla sua grandezza come ha fatto in passato». Qui Joan risponde indirettamente
anche a un editoriale di Peggy Noonan uscito giorni fa sul che definisce New
York come una città finita. Ma Joan con questa città ha intrecciato un rapporto
creativo e di vita indimenticabile: pensare a una sconfitta non è possibile. E
c' è da capirla, basta leggere il ricordo del suo arrivo a Manhattan dopo aver
vinto un concorso di il Prix de Paris, che la portava a lavorare al più
importante mensile "intelligente" per la donna. Scrive: « Arrivando avevo vent'
anni, sentivo l' aria calda dell' estate e un qualche istinto programmato da
tutti i film che avevo visto, da ogni canzone che avevo sentito cantare e da
ogni storia che avevo letto su New York, mi informava che niente sarebbe stato
davvero più lo stesso. E infatti nulla poi è più stato lo stesso». Didion viene
risucchiata dal vortice di energia della città e dal lavoro. È a New York che
incontra John alla fine degli anni Cinquanta. È a New York che capita per caso
la svolta letteraria: manca un articolo di copertina e lo affidano a lei. Titolo
"Il rispetto di sé: la sua origine, il suo potere". Esce il 1° agosto 1961. Per
le donne lettrici di scrive: « Coloro che hanno rispetto di sé mostrano una
certa durezza, un certo coraggio mortale, esibiscono quello che una volta si
chiamava carattere, una qualità che, sebbene sia apprezzata in astratto, a volte
perde terreno rispetto ad altre virtù più negoziabili. Eppure, il carattere, la
volontà di prendersi la responsabilità della propria vita, è la fonte da cui
sprizza il rispetto di sé » . Joan diventa un autore di cui si parla. È il
momento in cui, « senza averne coscienza » come mi ha detto, si inserisce in un
mondo di uomini. Gli scrittori del suo tempo erano presenze forti: Norman
Mailer, Truman Capote, Tom Wolfe, Philip Roth, Hunter Thompson. Ma in quello
spazio occupa una casella importante. Con John si sposano nel 1964 e decidono di
trasferirsi in California. E quasi subito lei viene intervistata da un
giovanissimo Tom Brokaw per la rete Nbc sulla meravigliosa terrazza della casa
di Hollywood, su Franklin Avenue. Vediamo Joan giovane, bella, capelli al vento,
occhialoni neri da sole anni Sessanta. Non sempre tutto è facile sul piano
personale. Il suo percorso continua con una riflessione sulla sua condizione di
donna, di moglie di un "irlandese" con "temperamento", di madre di una bambina
di tre anni, Quintana Roo, adottata a Hollywood: nel 2005, dopo L' anno del
pensiero magico, Didion perderà improvvisamente anche lei. Ma intanto, negli
anni Sessanta, Joan vive in bilico all' interno di un rapporto matrimoniale che
si è fatto difficile e scrive: «Voglio che tu sappia che cosa ho in mente.
Voglio che tu capisca quello che hai, hai una donna che per qualche tempo si è
sentita separata in modo radicale da gran parte delle idee che sembrano
interessare le altre persone. Hai una donna che a un certo punto lungo il
cammino ha perduto quel poco di fiducia che poteva avere nel contratto sociale,
nei principi per migliorare, nel complessivo grande modello dell' avventura
umana». Nel saggio "Nelle isole", incluso nel suo libro Didion racconta il posto
dov' erano in vacanza, il Royal Hawaiian Hotel: le onde e il vento che fanno da
cornice al momento: «Siamo qui, in quest' isola nel mezzo del Pacifico - annota
- invece di chiedere il divorzio». Poi, anni dopo, tornano a New York. Le chiedo
di alcune sue immagini del periodo californiano, del servizio fotografico di
Julian Wasser. Nella foto è in piedi, sigaretta in mano, appoggiata alla sua
Corvette Stingray giallo Daytona, un elemento scenografico normalmente maschile.
Lei è molto cool. C' è un' aria di sfida. Forse, senza quella foto, Thelma &
Louise, che viene girato 23 anni dopo, non sarebbe stato possibile. Il suo
vestito, una tunica lunga, leggera, morbida, attillata, rivela una flessuosità
inaspettata per una donna che dice di essere piccola fisicamente, discreta per
temperamento e nevroticamente inarticolata. Le chiedo perché ha comprato la
Corvette: « I just loved it » , risponde. Le chiedo se gli stilisti avevano
organizzato la foto e il vestito: «Quello era il mio vestito - dice - l' ho
scelto io».
Così sono cambiate le
eroine delle serie tv.
Dai primi del '900 a oggi, le donne sono cambiate, così come le
eroine delle serie tv. La Donna Bionica è stata sostituita da personaggi più
umani e reali. Qual è la vostra eroina moderna preferita? Marina Lanzone - Lun,
08/03/2021 - su Il Giornale. Anche quest’anno è arrivata la festa della donna.
È il secondo 8 marzo passato senza grandi eventi, a distanza, probabilmente a
casa, ma non in silenzio. Dopo tanti anni, le donne lottano ancora per far
rispettare i loro diritti, le loro scelte e il loro corpo. Dagli scioperi delle
operaie fuori dalle fabbriche statunitensi nei primi anni del ‘900 al Movimento
del Me too, ci sono stati degli innegabili passi avanti (o indietro in alcuni
casi): le donne sono generalmente più consapevoli, giustamente più pretenziose
ed ambiziose, soprattutto meno sole a combattere queste battaglie. In tutti
questi anni, il piccolo schermo è stato testimone dei cambiamenti e anche
le eroine delle serie tv hanno subito un’evoluzione, passando dalla fintissima
Donna bionica alla complessa ma quanto mai vera Annalise Keating. Le eroine
moderne hanno perso lo status di semi-dee, non combattono più i mostri ma le
loro fragilità: soffrono per amori sbagliati, si ammalano di depressione, hanno
delle dipendenze, a volte tradiscono la fiducia dei loro cari. Sbagliano, cadono
e si rialzano tutte le volte e per questo possono diventare un modello da
seguire per le telespettatrici. Quali sono le migliori eroine delle serie tv?
Difficile dirlo, è una scelta soggettiva: ogni donna è diversa per età,
carattere e stile di vita, tutte hanno la loro gatta da pelare. In questa lista
di dieci personaggi (più uno), dal più giovane al più anziano, ogni lettrice
potrà rivedersi trovando la propria protagonista del cuore.
La regina degli scacchi. Beth
Harmon è l’eroina del momento (specie dopo la recentissima vittoria al Golden
Globe di Anya Taylor-Joy come "miglior attrice in una serie drammatica" per la
sua interpretazione nella serie Netflix): giovane, ribelle, affascinante più che
bella, tormentata dal suo passato e dai ricordi della madre suicida, volutamente
sola perché fatica a fidarsi delle persone. Ha un grande talento per
gli scacchi, attività a cui si appassiona perché "prevedibile". Entra in diretta
competizione con una lunga schiera di uomini, e gara dopo gara diventa la
migliore. Da lei, possiamo imparare la capacità di non arrendersi davanti al
primo ostacolo.
Buffy-L’ammazza vampiri. Un
po’ attempata (la serie è stata trasmessa dal 1997 al 2003) ma sempre di
moda, Buffy rimane una delle eroine più amate. Come le protagoniste delle serie
tv anni ’70-’80, ha dei poteri sovrannaturali che le permettono di riconoscere e
affrontate vampiri e demoni. Quello che piace di questa storia, però, è la parte
più umana. Buffy è prima un’adolescente e poi una donna come molte: soffre per
la fine del suo primo amore, non sa fuggire dai rapporti tossici, cade in
depressione dopo la perdita di una persona cara e tenta di scappare dai problemi
piuttosto che affrontarli. Ma alla fine cresce e impara, come tutti, a gestire
le sue ferite.
L’allieva. Alice Allevi,
protagonista della serie tv Rai "L’allieva", ispirata ai romanzi di Alessia
Gazzola, all’inizio è la tipica universitaria indecisa sul futuro. Studia
medicina ma teme di non essere un bravo medico, fino a quando trova la sua
strada, la medicina legale. La curiosità l’aiuterà, puntata dopo puntata, a
trovare tutti gli assassini, portando un po’ di giustizia là dove non c’è. Tra
un’autopsia e un’indagine, troverà anche il tempo di innamorarsi, regalando una
punta di romanticismo a questo giallo.
Le amiche geniali.
Lila e Lenu, le protagoniste della saga de "L’amica geniale", la fiction Rai
tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, ci mostrano quanta fatica è
necessaria per "riscattarsi" e quanto sia più facile farlo con un’amica a
fianco. Sono una l’opposto dell’altra: Lila è bruna, Lenu bionda; la prima è
sfacciata e impulsiva, l’altra timida e razionale; Lila ha studiato per strada,
Lenu tra i libri della Normale di Pisa. Eppure riescono a trovare un loro
equilibrio, a perdonarsi ogni qualvolta si feriscono, rimanendo un punto di
riferimento costante l’una per l’altra.
Jane The Virgin. Jane
Villanueva è l’esuberante protagonista della soap opera americana "Jane the
Virgin" (visibile sulla piattaforma Netflix). La serie racconta la storia di una
23enne che vuole arrivare vergine al matrimonio, perché profondamente credente.
Jane sogna delle nozze da favola con il suo storico fidanzato Michael e di
diventare una scrittrice, nonostante non possieda un eclatante talento. La sua
esistenza di ragazza comune viene stravolta da una gravidanza non desiderata:
durante una banalissima visita ginecologica di controllo, viene inseminata
artificialmente. Questo avvenimento cambia i suoi piani, ma non li sconvolge.
Jane the Virgin riesce a realizzare i suoi sogni e a trovare il tempo per se
stessa, non perdendo mai di vista i valori in cui crede. Non ha paura di essere
anticonvenzionale e incompresa e la sua tenacia alla fine viene premiata.
L’ancella guerriera. June
Osborne di "The Handmaid's Tale" (su TIMVision e Amazon Prime Video) è una madre
a cui è impedito di crescere sua figlia. Per la società in cui vive,
l’immaginaria Repubblica di Gilead, lei è solo un corpo. June Osborne sarebbe
un’ancella, cioè una donna fertile, assegnata a una famiglia, il cui unico scopo
è quello di dare degli eredi ai padroni. Ma l’eroina di "The Handmaid's Tale" sa
bene di non essere solo questo: è intelligente, coraggiosa, determinata e
ironica. Sa cosa vuole e probabilmente riuscirà a riprenderselo.
Una moderna Xena. La
regina Lagertha di "Vikings" (anche questa serie è visibile su TIMVision) è una
guerriera, ma con la sua predecessora Xena ha davvero poco in comune. Lagertha
ha delle incredibile doti belliche, ma è anche una moglie, una madre e poi una
donna divorziata, un modello raggiungibile rispetto alla vecchia Xena. Affronta
ogni difficoltà, dalla perdita della sua bambina al tradimento e separazione dal
marito, con grande dignità. Sono queste le caratteristiche che fanno di lei una
donna con la "D" maiuscola.
AK, la regina del foro e del
riscatto. L'avvocatessa Annalise Keating, protagonista de "Le regole del delitto
perfetto", visibile su Netflix, è probabilmente una delle eroine più amate e
complesse dell’era moderna. Pantera astuta e spietata nelle aule di tribunale,
trae la sua forza dalle mille battaglie che ha dovuto combattere nella vita: ha
subito violenze e molestie tra le mura domestiche, ha dovuto affrontare il
dolore per la maternità mancata, ha lottato contro la dipendenza dall’alcool che
è arrivata quasi a ucciderla in più occasioni, ha sopportato tradimenti e la
perdita dell’amato marito Sam. Non importa quanto sia profonda la ferita
inferta, Annalise Keating riesce ad alzarsi tutte le volte. Nonostante non viva
in una realtà perfetta, crede e lotta per un mondo migliore.
La fantastica signora Maisel.
Un’altra maestra indiscussa del "riscatto" è Miriam Maisel, la protagonista
della serie visibile sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video. Miriam è
un modello per qualunque donna che a una certa età deve reinventarsi. Dopo anni,
passati ingiustamente all’ombra del marito, un comico che non fa ridere, la
fantastica signora Maisel riesce a trovare la sua strada, conquistando il
pubblico e l’indipendenza.
The Crown. La regina
Elisabetta II non poteva certamente mancare in questa carrellata perché, data la
veneranda età, ha molto da insegnare. Innanzitutto la sovrana immaginata da
Netflix in "The Crown" incarna più di tutte il senso del dovere, dimostrando che
essere regina non ha niente a che vedere con i cartoni della Disney. Non
destinata fin dalla nascita a regnare, ha indossato la corona all'età di
venticinque anni, dopo la morte prematura del padre, re Giorgio V, e da quel
momento è diventata regina prima che donna, moglie e madre, con tutte le
difficoltà che questo comporta. Ha affrontato e sopportato le scappatelle del
marito, le gelosie famigliari, i colpi di testa dei figli: con
una classe surreale ha saputo "aggiustare" situazioni che chiunque altro avrebbe
fatto naufragare. Un personaggio a cui si può solo aspirare.
Franca Giansoldati Alessia
Marani per "il Messaggero" il 9 marzo 2021. «Dobbiamo lottare per la dignità
delle donne, sono loro che portano avanti la Storia». Tornando dall'Iraq, con
ancora negli occhi le immagini delle ferite alla città di Mosul dove i jihadisti
stupravano e vendevano al mercato le ragazze yazide, Papa Francesco ripercorre
tanto orrore e - non a caso - sceglie l'8 Marzo per denunciare con forza le
violenze cui sono soggette, persino «nel Centro di Roma», tante giovanissime
straniere. Una piaga sommersa e molto remunerativa per il racket che ben
conoscono tante associazioni che operano nella Capitale. Talitha Kum, la
Giovanni XXIII, le Scalabriniane e l'eroica suor Eugenia Bonetti, 80 anni ma
ancora attiva, l'emblema mondiale di questa campagna di salvezza. Tutte realtà
religiose sostenute concretamente dal Papa per salvare dal marciapiede ragazzine
spesso minorenni, senza documenti, ricattate, schiavizzate. Praticamente
fantasmi.
L'APPELLO. Ai giornalisti
Francesco ha affidato un appello rendendo omaggio al mondo femminile senza
nascondere la preoccupazione per un fenomeno che non accenna a diminuire. «Le
donne sono più coraggiose degli uomini, è vero, ma la donna anche oggi è
umiliata, e vorrei andare all'estremo». L'estremo a cui fa riferimento è la
storia di Nadia Murad, la yazida ex schiava, fuggita miracolosamente fino a
diventare la testimone all'Onu dei crimini contro l'umanità commessi dal
Califfato a Mosul. Il suo libro autobiografico ha pietrificato il Papa. «C'era
la lista dei prezzi delle donne. Non ci credevo. Le donne si vendono, si
schiavizzano. Ma succede anche nel Centro di Roma. E il lavoro contro la tratta
è un lavoro di ogni giorno». Lo sanno bene le realtà cattoliche. Durante il
Giubileo della Misericordia Francesco ha visitato con monsignor Fisichella una
casa protetta dove ha incontrato una ragazza mutilata. «Le avevano tagliato
l'orecchio perché non aveva portato i soldi giusti. Era stata trasportata da
Bratislava nel bagagliaio della macchina. Una schiava, rapita. Quindi questo
succede anche fra noi, i colti». Francesco ha destinato alcuni edifici
destinandoli al recupero delle ragazze, ha finanziato progetti e ha messo
all'asta una Lamborghini Huracane che gli era stata regalata. Aveva persino
scomunicato gli uomini che alimentavano questo turpe fenomeno («sono dei
criminali»). Don Aldo Bonaiuto, il sacerdote anti-tratta, non ha dubbi che con
il Covid il fenomeno a Roma sia più nascosto. «Quando il Papa si riferisce al
Centro di Roma parla della zona dentro al Raccordo. Ne abbiamo discusso assieme
qualche settimana fa: sono andato a trovarlo e assieme abbiamo fatto una
videochiamata con alcune di queste ragazze salvate. Il racket in questo periodo
di pandemia ha solo spostato le ragazze nelle strade laterali alle grandi
arterie, la Colombo, la Salaria eccetera. Se il fenomeno della schiavitù a Roma
è esteso la colpa è dei clienti. Se non ci fosse la domanda non ci sarebbe
nemmeno questo mercato ignobile, frutto di una mentalità maschilista e
vergognosa».
B&B E VIDEOCHIAMATE. A Roma,
stando ai dati dell'associazione anti-tratta Parsec, si cela la più grande fetta
del mercato delle schiave del sesso, circa il 15% di quello nazionale. Un
esercito di 2500 donne e trans che sono letteralmente vendute in strada, a cui
se ne aggiungono almeno altre 1500 costrette a farlo nelle case o nei centri
massaggi. Si contano più di trenta differenti nazionalità, con in cima le
potenti mafie nigeriana e albanese che gestiscono le rotte dall'Africa e
dall'Est. Nel migliore dei casi le schiave con la loro attività si comprano il
costo del viaggio e poi tornano libere. Ma, spesso, non riusciranno mai a
sottrarsi al giogo. Il Covid, però, ha imposto, prima una battuta d'arresto, poi
dei cambiamenti. I pattuglioni della polizia lungo le consolari con tanto di
multe, ostacolano e spostano il fenomeno. Solo pochi giorni fa i carabinieri di
piazza Dante, rione Esquilino, hanno scoperto e chiuso tre centri massaggi a
luci rosse gestiti da cinesi tra San Giovanni e il Nomentano, ma le indagini
erano partite da una casa d'appuntamento in zona Prati. Nel Centro di Roma,
appunto. E in Centro, adesso, trans e schiave del sesso cominciano il loro
calvario già nel primissimo pomeriggio. «Ma scalfire il sistema delle tratte è
difficile - spiega un investigatore di lungo corso - perché difficile è rompere
il muro dell'omertà e della paura».
L’8 marzo è la Festa
dell’Ipocrisia.
Gianluigi Nuzzi su Notizie.it l'08/03/2021. Il Papa, nella sua
omelia, dice parole che accudiscono e coccolano tutti noi, ma se c'è una società
maschilista questa è proprio la Città del Vaticano. Buon 8 marzo. Questa
dovrebbe essere la festa della donna, ma in realtà è la festa dell’ipocrisia.
Ognuno dice la sua sventolando una bandiera di diritti come se questi non
dovessero essere già naturali, connaturati, sedimentati nelle coscienze. Ma così
purtroppo non è. Ho riascoltato le parole di un’omelia di Papa Francesco nella
quale il pontefice dice che la donna è armonia, che il suo compito non è lavare
i piatti ma dare poesia e bellezza alla vita. La donna, continua, è stata creata
da Dio perché sia madre di tutti. Ma se c’è una società maschilista e
assolutamente incentrata sull’uomo, questa è proprio la Città del Vaticano, una
monarchia assoluta dove le donne sono figure marginali. Le suore lavano le
mutande e i piatti ai vecchi porporati e, più in generale, la donna nella storia
della Chiesa non ha mai ricoperto un ruolo di rilievo. Non ci sono donne che
hanno potere nello Stato Pontificio. I cardinali e i vescovi detengono
strettamente il comando e tutta la struttura di potere è formata da uomini. Il
Papa, nella sua omelia, dice parole che accudiscono e coccolano tutti noi,
ma qualche passo (vero) nel suo mondo andrebbe ancora fatto.
Gianluigi Nuzzi. Giornalista,
ha iniziato a scrivere a 12 anni per il settimanale per ragazzi Topolino. Ha,
poi, collaborato per diversi quotidiani e riviste italiane tra cui Espansione,
CorrierEconomia, L'Europeo, Gente Money, il Corriere della Sera. Ha lavorato per
Il Giornale, Panorama e poi come inviato per Libero. Attualmente conduce Quarto
Grado su Rete4 ed è vicedirettore della testata Videonews. È autore dei libri
inchiesta "Vaticano S.p.A." (best seller nel 2009, tradotto in quattordici
lingue), "Metastasi", "Sua Santità" (tradotto anche in inglese) e "Il libro nero
del Vaticano".
Da "il Giornale" il 9 marzo
2021. Quando si tratta di alzare l'asticella dello scontro con le altre donne,
nemmeno la scrittrice Michela Murgia ci va giù leggera. Nonostante sia una
femminista in prima linea, autrice di un libro uscito proprio ieri, intitolato
Stai Zitta, tutto a tema lotta al patriarcato e libertà delle donne. Sacrosanto.
Eppure anche la Murgia ha individuato nell'unica donna leader di partito,
Giorgia Meloni, un bersaglio perfetto. Così la leader di Fratelli d' Italia
diventava autrice di «squadrismo mediatico» nel 2019 per le critiche alla
direttrice artistica di un festival culturale de L' Aquila. E ancora, nello
stesso anno, diceva: «La Meloni usa il crocifisso e il presepe come corpi
contundenti». Con commenti sulla vita privata: «Questa è una donna che nella sua
vita personale ha fatto delle scelte che certamente non sono congruenti con
l'idea di famiglia cristiana». La Murgia nel 2014, dopo le elezioni regionali
sarde, riusciva a offendere le donne del Pd sardo e Daniela Santanché nella
stessa frase. Si diceva vittima di «livore e menzogne» da parte delle donne dem,
colpevoli di «aver idolatrato la Santanchè solo perché mi attaccava in
pubblico».
Donne, donnesse e donnole.
Liberare le donne da chi vuole liberarle.
Emanuele Ricucci su
culturaidentita.it il 7 Marzo 2021. Nella madre con il bambino non c’è uno
stereotipo, vi è il centro della vita. Vi è la dolcezza di una madre che
contiene la vita, contro l’odio di una donna arida che contiene la sua
frustrazione. Donne e donnesse, ovvero le donne del politicamente corretto, in
un’imposizione che dalla speculazione elettorale, corre alla psicosi della
Cultura della debolezza, elevazione del capriccio invadente di pochi come regola
per tutti, abbassamento all’impossibilità che si manifesta nel lamento per
continui diritti, esaltazione della fragilità, di un’eterna minoranza che ha
bisogno di paladini che la difendano, sinistra pappona che diventa supereroe
sociale. Nella sconfitta la nuova vittoria. Cultura della debolezza, donna come
donnola in via d’estinzione, resa fragile, protetta dalla asfissiante
precauzione che le dice quando e come esistere. Come se la donna di una “visione
alternativa” a quella femminista fosse una stupida prostituta incapace e
autolesionista. Nella madre che sorride al bambino vi è la pace, contrapposta al
delirante disordine di chi non ha pace. Vi è l’asse su cui da millenni si
reggono gli uomini, Natura, Bellezza e Assoluto. Le donne, sono sicuro, vogliono
liberarsi proprio da chi vuole liberarle, da chi le usa, da chi vuole
inquadrarle in uno schizofrenico destino, quello della donna che deve fare anche
l’uomo affinché gli uomini non servano più a nulla. Dare la vita non può essere
uno stereotipo. Per quanto viene da chiederci se Nostra Signora dell’acidità di
stomaco, #lauraboldrini, sia nata da un incrocio mistico/spirituale. Dunque,
nella gravosa offesa all’intelligenza umana che l’oltranzismo femminista
rappresenta, mi piace pensare che chiamando “direttrice” un direttore
d’orchestra donna, le donne stuprate o infibulate in Africa, quelle umiliate
come madri o dall’assenza di lavoro, infilate in qualche miniera a marcire,
purtroppo, non cambieranno il proprio destino. Non basta, sig** Boldrina/i/e/o/*
l’ingegneria semantica per salvare il destino delle donne. Un pensiero a voi,
complici, sorelle, guerriere, spose, splendidi angeli, libere di esistere.
Festa della donna,
Casellati: “Passare dalle quote rosa al merito”.
Mauro Armadi su Notizie.it
l'08/03/2021. Nel 2021 c'è chi si interroga se la cosiddetta "Festa della donna"
abbia ancora senso, ma la crisi ci ha ricordato pesantemente la sua importanza.
Passare dalle quote rosa alla meritocrazia per raggiungere la vera
emancipazione: questo l’invito di Maria Elisabetta Alberti Casellati, dal 2018
presidente del Senato della Repubblica, che ha auspicato di non dover più
commemorare queste ricorrenza, perchè in tal caso vorrebbe dire che la parità di
genere è stata raggiunta. La crisi sanitaria globale, infatti, ha dimostrato
quanto sia stato pesante il prezzo pagato dalle donne italiane. Degli
oltre 440mila posti di lavoro persi durante la pandemia, ben il 70% di essi era
di donne e giovani. A Dicembre dei 101mila posti persi, 99mila appartenevano a
donne, dunque la quasi totalità dei casi. Un’emorragia professionale che ha
esposto quanto le donne siano ancora lontane da una parità di genere. È lo
stesso presidente Casellati che ha sottolineato come aveva previsto all’inizio
delle crisi che le donne avrebbero pagato una caro prezzo. Una larga fascia di
esse si è ritrovata rinchiusa in casa, in contesti famigliari problematici, tra
violenze e lavori di assistenza forzata a bambini e anziani. La Casellati
sostiene che le quote rosa, ormai da circa dieci anni dalla loro
introduzione, non hanno inspirato quel cambiamento culturale necessario a veder
premiate le donne di talento e valore. La stessa recente formazione del governo
ne è stata simbolo, con una scarsa presenza di donne.
Riflessioni
dopo la giornata dell’8 marzo. Le quote rosa hanno fatto il loro tempo, ora è il
momento del merito.
Clelia Crisci su
Il Riformista il 9 Marzo 2021. Quando, nel 2001, ho deciso di lanciarmi nella
produzione di compound di polipropilene e di fondare la Lapo Compound, la legge
sulle quote rosa nei consigli di amministrazione delle imprese non era stata
ancora approvata. Quell’impegno ha rappresentato per me una sfida non da poco
sotto il profilo imprenditoriale, ma anche sotto quello umano. Non erano pochi,
infatti, i pregiudizi verso una donna giovane che si inseriva in un contesto
economico prevalentemente maschile. Questi, però, non mi hanno mai influenzata
né scoraggiata. E ciò è stato possibile perché ho sempre creduto
nell’emancipazione delle donne, del Sud e, prima ancora, del merito. Lo dimostra
l’impostazione che, sin dal primo momento, ho impresso alla mia impresa. Ho
investito in formazione e ricerca con l’obiettivo di valorizzare i diversi punti
di vista che caratterizzano ciascun genere e che, se opportunamente amalgamati,
possono aiutare un’azienda a diventare leader del mercato. In più, ho dato
valore al merito, soprattutto a quello femminile che c’è e dev’essere
riconosciuto. Ciò mi ha consentito di centrare due importanti traguardi. Il
primo: all’interno della mia azienda, le posizioni apicali sono occupate da
donne che, nel tempo, si sono segnalate per competenze e capacità di affrontare
anche i contesti più complessi. Il secondo: anno dopo anno, la Lapo Compound è
diventata una realtà industriale forte e, a breve, aprirà alcuni stabilimenti
all’estero. E questo anche grazie al determinante apporto della componente
femminile della mia squadra. Dieci anni dopo la nascita dell’azienda, ecco la
legge che ha imposto una certa percentuale di donne all’interno dei consigli di
amministrazione. Questo provvedimento è stato duramente osteggiato, anche da
parte del mondo industriale. Eppure ha sortito effetti importanti: i cda sono
stati svecchiati, visto che le donne che lavorano sono mediamente più giovani
dei colleghi uomini, e al loro interno è aumentata la percentuale di laureati e
di componenti che vantano dottorati o titoli post laurea. A certificarlo è uno
studio dell’università di Torino che sottolinea anche come i gruppi dirigenziali
misti siano mediamente più produttivi di quelli composti da soli uomini (nei
fatti) o da sole donne (in teoria). Fare impresa e promuovere il ruolo delle
donne, dunque, si può e si deve. Ma, a dieci anni dalla legge sulle quote rosa,
con un approccio diverso. E cioè garantendo quei servizi pubblici – dalla scuola
agli asili nido – che consentano alle donne di esprimere le loro competenze, il
loro carattere, la loro creatività. È una strategia che può contribuire
al rilancio del Sud. La mia esperienza ne è la garanzia.
Anna Lombardi per “la
Repubblica” l'8 marzo 2021. Hanno perso nome, mascotte e ora anche cheerleader:
le tradizionali ragazze pon pon sostituite col primo "dance team" misto
d'America, un gruppo di ballo aperto a uomini e donne. Non si ferma lo sforzo di
rinnovamento della squadra di football fino alla scorsa stagione conosciuta come
Redskins. Un tempo la più conservatrice d'America, visto che fu l'ultima ad
accettare afroamericani - nel 1962 e solo dopo la minaccia di un'azione legale
da parte dell'allora presidente John Fitzgerald Kennedy - e il cui allenatore
George Allen, negli anni '70, dovette addirittura chiedere a Richard Nixon di
non sbandierare troppo il suo esserne tifoso, temendo che gli arbitri
fischiassero falli per motivi politici. Il team di Washington, secondo la
definizione attuale dei commentatori sportivi, ha abbandonato lo scorrettissimo
"pellerossa" in uso fin dal 1933, all'indomani delle proteste scatenate dalla
morte dell'afroamericano George Floyd. Cedendo ad anni di polemiche contro quel
nome dai connotati razzisti, offensivo per i nativi. Mettendo in cantina pure la
mascotte, caricatura di un capo tribù, con tanto di piume e nasone. Tutte
decisioni prese da Jason Wright, 38 anni, chiamato alla presidenza della squadra
lo scorso agosto: primo afroamericano nella storia della lega football in quel
ruolo. Ex giocatore, uomo d'affari fino a quel momento consulente di McKinsey -
la società chiamata dal premier Mario Draghi a supportare il Recovery Plan
italiano - è d'altronde specializzato nell'aiutare le aziende a diventare più
inclusive. È stato proprio lui a convincere tutti della necessità di sciogliere
pure le "First Ladies of Football", il gruppo di 36 tifose "professioniste" in
minigonna e, appunto, quei pon pon colorati (le cui radici affondano nelle
protuberanze di lana dei cappelli usati dall'esercito napoleonico, i cui colori
distinguevano gradi e battaglioni militari) animatrici del tifo sul campo. Il
fatto è che quel primo club di cheerleader d'America, vecchio di 60 anni, è
stato di recente sconvolto pure da uno scandalo legato a un servizio fotografico
per uno dei loro celebri calendari: quando alle cheerleader venne imposto di
posare nude - nonostante la pubblicazione non preveda immagini integrali -
davanti a una piccola folla di sponsor, invitati senza chiedere loro il
permesso. Le ragazze non hanno preso bene lo scioglimento. Semmai, avrebbero
preferito accettare nelle loro fila dei maschi come già fatto dai Los Angeles
Rams e i New Orleans Saints, pronte a condividere le loro esibizioni con
colleghi dell'altro sesso: «Non capiamo la necessità di distruggere la nostra
storia. Siamo un gruppo affiatato ed inclusivo» si lamenta in tv la capitana
Erica Hanner. Ma il presidente è inamovibile: «Dobbiamo usare questo periodo tra
la fine e l'inizio del nuovo campionato per diversificare il brand. Presto
sveleremo il nuovo nome e offriremo ai nostri fan un'esperienza sportiva
rinnovata».
La fatica che
fanno le donne per affermare la propria intelligenza.
Elisabetta
Sgarbi, Publisher – La nave di Teseo Presidente dell’Ente dei Sacri Monti del
Piemonte e della Lombardia, su Il Quotidiano del Sud il 9 marzo 2021. Donne. Non
so parlare di donne in generale. È una mia lacuna. Sono cresciuta con dentro la
figura di mia madre, donna molto moderna e capace di muoversi nel mondo con la
forza della sua intelligenza che riusciva a sedurre i propri interlocutori; e
con una frase della professoressa Maria Corti, la quale diceva che
“l’intelligenza non ha sesso”: l’intelligenza è qualcosa di molto singolare, che
si esprime nella unicità irripetibile della persona e di quello che fa. D’altra
parte, non possiamo non sottolineare quanta fatica abbiano fatto le donne, e in
parte ancora facciano, per avere l’opportunità di affermare la propria
intelligenza, in ogni ambito della vita pubblica, e spesso privata. E non
possiamo tacere la quantità di femminicidi che le cronache fanno fatica a
coprire, perché numericamente esorbitanti. Molto è stato fatto, e molto ancora
resta da fare. Però, a questo punto della Storia, il tratto di strada che
occorre percorrere, necessita di misura. Bisogna evitare che il movimentismo
ottunda l’intelligenza. Che sia un alibi per mettere da parte la crescita e la
fatica personali. Che l’idea di essere donna, l’appartenenza a un genere – che è
un dato di natura – distolga dalla necessità di essere persone di valore. C’è
stato qualche esempio di recente. È un tratto di strada difficile. Ma non è il
più difficile.
Non gridiamo sempre al sessismo diamo
invece voce ai maschi pentiti. A Ferrara la “Maestà
sofferente” di Pesce: metafora della violenza sulle donne, un corpo femminile
infilzato di centinaia di frecce. Vittorio Sgarbi su Il Quotidiano del Sud l'8
marzo 2021. La festa della donna ha a Ferrara la sua capitale. In tempi in cui
tutto è fermo, la vita sociale è sospesa, i valori di umanità mortificati, la
paura dell’altro dominante, era molto facile dimenticarsi della donna e dei suoi
valori. A Ferrara non sarà possibile dimenticarla: l’amministrazione comunale ha
infatti, attraverso una mia proposta, accettato il dono alla città della
monumentale “Maestà sofferente” di Gaetano Pesce, straordinaria metafora della
violenza sulle donne, impresa di cinquant’anni di vita che raffigura un corpo
femminile infilzato di centinaia di frecce, e che fu già esposto in piazza del
Duomo di Milano. Dopo un sopralluogo in alcuni siti cruciali della città, dal
Parco di Palazzo Prosperi Sacrati, all’area della Porta degli Angeli al termine
di corso Ercole d’Este, a Piazza Ariostea, al prato davanti alla Certosa, alla
rotatoria di Porta Mare, si è stabilita una collocazione temporanea in piazza
della Fiera, a partire dall’8 marzo. Ferrara onora così la donna e la sua
forza. Ed è la forza del suo generoso corpo di madre, con il monito a respingere
ogni violenza che mortifichi i diritti e l’intelligenza della donna. Qualche
donna ha ritenuto, incredibilmente che fosse più giusto affidare a un donna
l’impegnò di celebrare la dignità della donna. È una possibilità, non un
obbligo, se l’arte è libera. Lasciamo gli uomini liberi di esprimere
quell’archetipo femminile che hanno nel loro immaginario e di interpretare un
tema così delicato. L’educazione dei ragazzi al rispetto, cui si consacrano
giornate del ricordo, passa anche per questa strada: far emergere le loro
emozioni, insegnare il rispetto, l’accettazione della diversità. Non vediamo le
contrapposizioni dei ruoli ma la loro complementarità, non gridiamo sempre al
sessismo; la grandiosa immagine di donna burrosa e materna che Pesce aveva nel
1969 è rimasta identica dopo cinquant’anni, amplificando e approfondendo un tema
che ancora non sussisteva così forte, a riprova che il suo non è maschilismo.
Oggi, l’esistenza e la dignità della donna sono ancor più esposte e più
minacciate di allora, ma fortunatamente sono sempre di più le voci che si levano
a sua difesa nel mondo, come quella di Pesce. Ed è necessario che siano anche
di uomini. Convinti o pentiti. Cosa dire, poi, nella storia, degli artisti
ossessionati dal corpo femminile? Qualche femminista punterebbe il dito contro
Velasquez per la sua Venere allo specchio? O con Goya per la Maja desnuda?
Sdraiate sul letto, le due donne offrono la loro sessualità agli occhi di chi
guarda: ritratte in posizione passiva, di offerta, con il corpo in attesa di chi
lo ammiri, dandovi un senso, legato al desiderio del maschio. Evitarlo?
Negarlo? Accusare di sessismo Velazquez e Goya? Ancor peggio Marylin di Warhol
non è più neanche corpo: perde ogni forma di spiritualità e di individualità per
manifestarsi come proiezione di uno stereotipo di massa. Un’ultima
considerazione: nessuno si scandalizzò per le enormi tette che per due giorni
hanno campeggiato sui tetti di Londra, simbolo della campagna per l’allattamento
al seno. Quelle tette giganti, gonfiabili, che con orgoglio hanno fatto mostra
di sé, non dovrebbero essere anch’esse una esibizione del corpo femminile? La
causa è nobile, si potrebbe obiettare. Anche le intenzioni di Gaetano Pesce lo
sono. E così Pesce sigilla la sua invenzione: “L’arte fa discutere e fa crescere
il nostro cervello. Secondo me, questa opera è una festa, anche se triste perché
si ricorda che le donne sono vittime di violenza, ma è meglio ricordarlo che
negarlo. Oggi questa è un’occasione per discutere della violenza sulle donne ,e
direi che ci siamo riusciti”. Ferrara è femmina.
Da liberoquotidiano.it l'8
marzo 2021. Il direttore di Libero Vittorio Feltri parla della Festa della
donna: “Le donne hanno già raggiunto la parità e lo dicono i fatti: la
maggioranza degli avvocati, per esempio, è donna. Ci sono ancora eccezioni,
certamente, ma mi irrita sentir dire che le donne rispetto agli uomini
guadagnano meno: non è possibile perché nel nostro Paese esistono contratti di
lavoro collettivi che non distinguono tra maschio e femmina. Sia nel pubblico
che nel privato. La verità è che le donne si sono conquistate la loro
indipendenza soprattutto studiando: fino al secolo scorso era difficile che una
ragazza s’iscrivesse all’università, poi le porte degli atenei si sono
spalancate anche per loro. Le donne studiano, meglio e di più degli uomini, sono
più tenaci e devono dimostrare a se stesse e agli altri di essere all’altezza
dei compiti che vengono loro assegnati. Sono convinto che non sia il caso di
fare una questione sui termini che vengono utilizzati, è una pratica oziosa. Le
donne non sono hanno raggiunto la parità, ma nella maggior parte dei casi,
grazie all’applicazione, la sensibilità, l’intelligenza, alla resistenza, sono
più brave degli uomini. Io non voglio festeggiare l’8 marzo, voglio festeggiare
le donne: nel mio giornale ce ne sono tante e brave. Hanno il problema della
maternità e a volte non sanno a chi far accudire i loro figli. Io allora ho
aperto le porte del giornale ai bambini. Forza donne, non fatevi intimidire da
nessuno, siete superiori”.
Vittorio Feltri per "Libero
quotidiano" il 9 marzo 2021. Come ogni anno, il calendario ieri ha segnato l'8
marzo dando la stura alle celebrazioni della donna che, mediamente, oltre a
lavorare più degli uomini - in ufficio e a casa - deve periodicamente subire
ondate di retorica femminista. La quale provoca un senso di noia e talvolta di
ribellione. Non se ne può più di lagne riguardanti i generi. Io sarò un cretino,
ma considero solo le persone e non mi importa un fico secco se abbiano il
pisello o la passera. Esse vanno considerate per ciò che valgono e non per la
loro morfologia. Ormai la parità fra lui e lei è un dato di fatto che non vede
solo chi ha le fette di salame sugli occhi. Qualche giorno fa Libero ha
pubblicato una notizia che in proposito deve far riflettere: il numero delle
avvocatesse in Italia ha superato quello degli avvocati, e il 45 per cento dei
medici sono signore. Quindi dove è il problema? La livella non è il cimitero,
come diceva il grande Totò, bensì l'università. E i migliori studenti, quelli
che hanno i voti più alti, sono fanciulle capaci di impegnarsi e di trarre dallo
studio il maggior profitto. Nonostante ciò sia documentato dalle statistiche,
infallibili nell'elaborare i macrodati, c'è ancora chi sostiene senza
vergognarsi che le signore guadagnano meno dei signori. Impossibile, poiché nel
nostro Paese le remunerazioni sono regolate da contratti collettivi nazionali.
In effetti gli insegnanti, i magistrati, i giornalisti eccetera ricevono lo
stesso stipendio a prescindere dal loro sesso. Lo stesso accade ovviamente nel
settore privato dove la paga è identica per qualunque dipendente. Si dice che a
causa del virus ci siano più disoccupate che disoccupati. Motivo? Pare che
licenziamenti in massa siano avvenuti al Sud, notoriamente meno sviluppato
rispetto al Nord. Indagheremo più a fondo. Lunedì ho seguito il bel programma di
Milo Infante su Rai Due che trattava delle violenze e delle molestie di cui sono
vittime tante fanciulle. Non c'è dubbio, i femminicidi sono poco più di cento
ogni dodici mesi. Sempre troppi, ma calcoliamo che il Paese conta 60 milioni di
abitanti, e cento imbecilli assassini sono il minimo sindacale. I maschi
trucidati invece sono 200 circa, quindi non sono messi molto meglio. Quanto alle
violenze non colpiscono solo le donne, ma anche e soprattutto i vecchi e i
bambini. Le maestre che menano di brutto negli asili si segnalano ogni dì, e
sorvoliamo sugli ottuagenari che negli ospizi vengono maltrattati di brutto con
una frequenza impressionante. Dal che si evince che tocca ai deboli purtroppo
soccombere sempre ai prepotenti. E veniamo alle molestie che colpirebbero le
ragazze. Non mi pare tanto difficile respingerle: basta un vaffanculo. Tra
l'altro capita a tutti di subirne, perfino a me. Ci sono madame di ogni età che
telefonano, tampinano, opprimono, sono insistenti, viene voglia di prenderle a
schiaffi, altro che di possederle. Sono gli esseri umani a rompere le scatole, a
prescindere dal loro sesso. Facciamola finita con i luoghi comuni e
l'autocompatimento tedioso. Femmine e maschi imparino a reagire e smettano di
frignare. Un'ultima non banale annotazione. A Roma, domenica, si è svolta una
manifestazione femminile per festeggiare il citato 8 marzo. Il corteo è stato
fotografato, e nell' immagine spicca una grande vulva portata a spalla da alcune
sfigate. Non direi che il monumento alla figa sia un capolavoro di eleganza e
neppure un simbolo culturale raffinato. È una volgarità. Pensate se un gruppo di
uomini avesse organizzato una sfilata reggendo un pene. Cosa sarebbe successo?
Luca Monaco
per roma.repubblica.it l'8 marzo 2021. "Like a virgin". Alla vigilia dello
sciopero dell'8 marzo le femministe calano in piazza Sempione e rispondono alla
propaganda neofascista dei militanti di Militia Christi, alle polemiche
alimentate dal parroco della chiesa dei Santi Angeli e Custodi don Mario Aceto
contro il progetto di pedonalizzazione della piazza messo a punto dal municipio
III amministrato dalla larga coalizione di centrosinistra costruita sul modello
Zingaretti. Don Aceto proprio domenica scorsa era sceso in piazza con l'abito
talare aveva tuonato contro il municipio: "Lo striscione contro lo spostamento
della statua della Madonnina della Misericordia dicevano che non andava bene. Ma
questi affissi sul Municipio? - aveva detto don Mario - d'accordo per quello per
Regeni, preghiamo per lui, ma l'altro arcobaleno è uno scempio". Toni
decisamente sopra le righe. A tal punto da punto da suscitare l'intervento del
Vicariato, che adesso starebbe anche lavorando per risolvere la questione e
consentire finalmente lo spostamento della statua a ridosso della scalinata.
Cosa che secondo il prelato invece toglierebbe spazio "ostacolando la
celebrazione dei funerali e dei matrimoni". Domenica pomeriggio la risposta
delle femministe: davanti alla statua della Misericordia è stata esposta una
maxi vagina. Simbolo della prima "frocessione che il nostro territorio abbia mai
visto - affermano le femministe e i militanti del centro sociale Astra in via
Capraia, al Tufello - le strade sicure le fanno le donne e le libere
soggettività che le animano. Ci troverete sempre in piazza contro ogni
discriminazione di genere". Il parroco replicherà?
Femministe fanno la festa
alla Madonna con una statua a forma di vagina. La Meloni: «Blasfemia».
Michele Pezza
lunedì 8 Marzo 2021 su Il Secolo d'Italia. Un accordo in extremis Peppone e don
Camillo riuscirono trovarlo. Il Comune doveva costruire otto alloggi popolari su
un terreno ceduto dalla parrocchia su cui insisteva l’antica edicola
raffigurante la Madonna. Fallito ogni tentativo di disfarsene con la forza, il
sindaco comunista si rassegnò a inglobarla nella nuova costruzione. Gli
appartamenti si ridussero così a sette. E qui fu il parroco a far la sua parte:
gli spettava assegnare la metà degli alloggi, ma ne considerò uno già occupato
da un’Inquilina di suo gradimento. Questi erano i racconti che il Grande
Fiume affidava alla pena di Giovannino Guareschi in altri tempi e in
un’altra Italia. Ben diversa da quella di oggi, intossicata da ideologie di
pseudo-liberazione, il cui unico obiettivo è quello di riportare l’uomo nel suo
stato di natura. Non libero, ma primitivo. Basta vedere quanto accaduto al
quartiere Montesacro di Roma, dove un gruppo di femministe di due centri
sociali ha protestato contro il parroco dei Santi Angeli Custodi portando in
processione una Madonna a forma di vagina. La colpa di don Mario, subito bollato
come «fascista ed omofobo»? Essersi opposto al progetto di pedonalizzazione
di piazza Sempione che prevedeva lo spostamento della statua della
Madonna subito prima della scalinata della chiesa. E aver definito «uno scempio»
la bandiera Arcobaleno. Da qui la reazione femminista e la vigilia della festa
della donna trasformata in oltraggio alla Madonna. Era rosa shocking e a forma
di vagina quella portata in processione fino alla scalinata che porta al sagrato
della chiesa. Che cosa volessero dire con questa blasfema carnevalata è un
mistero che certamente svelerà uno di quei so-tutto-io che di solito troviamo
appollaiati nei talk-show o nelle pagine culturali dei giornali. Hanno una toppa
per ogni buco e beccano applausi ad ogni rammendo. Non da tutti, per fortuna.
«Qualcuno si sente rappresentato da questi personaggi che fanno
della blasfemia e del cattivo gusto una bandiera?», chiede Giorgia Meloni in un
post nel quale mostra la foto pubblicata su “Il Giornale” (in alto). In appoggio
alla leader di FdI anche Provita, associazione molto impegnata nelle campagne
antiabortiste: «Ma le donne poi, sarebbero solo la propria vagina?».
Ecco le quote rosa del Pd:
tutte le poltrone inutili alle donne, la solita ipocrisia di sinistra.
Brunella Bolloli su
Libero Quotidiano il 23 febbraio 2021. Che smacco per le paladine delle quote
rosa. Quando si sono trovate davanti la fotografia del neonato governo più d'una
ha dovuto ammettere: «Berlusconi sì che è un leader. Valorizza le donne del suo
partito». Che fatica dichiararlo, eppure l'odiato Cav è mejo del segretario
Pd Nicola Zingaretti, hanno sentenziato in coro le erinni del Nazareno, alle
quali mai in passato sarebbe venuto in mente di complimentarsi con il nemico
azzurro. Scendevano in piazza al grido di Se non ora, quando?, mentre adesso
nella piazza virtuale dei social, sfogatoio di ogni cocente frustrazione,
attaccano i maschietti della sinistra che non valorizzano le loro donne e
preferiscono tenere il potere tutto per sé. Compagne sì, ma che stiano un passo
indietro. Ora, siamo certi che dopo una settimana di imprecazioni da parte delle
signore Pd che hanno messo su un quarantotto tra sfuriate, riunioni al femminile
organizzate dalla portavoce delle donne dem, Cecilia D'Elia, prese di posizione
di ex ministre, editoriali sdegnati e, insomma, dopo che è scoppiato il casus
belli delle femmine snobbate contro i maschi, non potrà che esserci la grande
toppa al buco scavato nella scelta dell'esecutivo. Non nutriamo dubbi, cioè, sul
fatto che nella lista dei sottosegretari e viceministri del governo Draghi che
sta per essere diffusa, Zingaretti avrà piazzato le dem in posti chiave così da
farsi perdonare lo sgarbo iniziale ed evitare che alla direzione del 25
febbraio, convocata proprio per rimettere al centro la parità di genere, la
truppa in gonnella si presenti agguerrita e pronta a contestarlo ancora. Però la
toppa, per quanto grande, non nasconde la realtà delle cose: nel Partito
democratico le donne contano poco. Sono schiacciate dagli uomini, relegate a
poltroncine senza pretese, perfino silenziate se è il caso. Avete sentito
pronunciare una parola da Valentina Cuppi? È la presidente del Pd, non proprio
la stagista appena arrivata al Nazareno, è una professoressa di Storia e
Filosofia e poi è il sindaco (o la sindaca se vogliamo attaccarci alle vocali)
di Marzabotto; dovrebbe stare al fianco del segretario dem nelle occasioni
istituzionali, non dietro. Invece la giovane Cuppi era presente nella
delegazione salita al Colle, unica donna tra Zinga, il suo vice Orlando e i due
capigruppo, ma non uno dei signori con lei che abbia fatto il gesto di cederle
il passo, sarà per questo che l'hanno chiamata "l'invisibile" o "la figurina".
«Non cerco visibilità, ma spero in un premier donna in futuro», ha replicato
lei. Per ora il suo partito non ha ministre donne e neppure una vicesegretaria:
l'ultima che c'era, Paola De Micheli, ha lasciato il ruolo due anni fa, promossa
al dicastero dei Trasporti, ma ovviamente non è stata rimpiazzata. numeri due
Più mediatica della Cuppi è Debora Serracchiani, già governatrice del Friuli ,
ex europarlamentare e vicepresidente del partito. Sveglia e appassionata, nel
2018 era in lizza per occupare l'ufficio più prestigioso, ma poi chissà come
mai, la candidatura è sfumata. Forse per via delle troppe correnti che
soffiavano tutte in un senso: a favore degli uomini. Vicepresidente è anche Anna
Ascani, rimasta con i democrat dopo la scissione dei renziani forse perché
sperava di avere più peso politico nella creatura originaria. Dopo avere corso
alle primarie nel 2019, è arrivato il contentino: l'incarico di facciata della
vicepresidenza, quindi la nomina a viceministro dell'Istruzione nel Conte bis.
Lecito che a questo giro puntasse più su. La senatrice Monica Cirinnà, "madre"
dell'omonima legge sulle unioni civili, fa politica dal lontano '93, sempre
dalla stessa parte. Eppure non c'è traccia di lei al governo e oltre al ruolo di
segretaria del gruppo a Palazzo Madama non va. Quest' anno avrebbe voluto
lanciarsi nelle primarie Pd per il Campidoglio, ma c'è da scommettere che il
partito schiererà un uomo (l'ex ministro uscente dell'Economia Gualtieri) senza
indire le primarie. Anche la toscana Caterina Bini è segretaria del gruppo al
Senato. Tra le sue proposte ne spicca una di modifica della legge Merlin per
sanzionare i clienti delle prostitute, i quali non hanno gradito e le hanno
mandato lettere minatorie. Considerato che l'esecutivo Draghi è sprovvisto di
ministri toscani, potrebbe ambire a un posto da vice di qualcuno. capigruppo I
capigruppo sono rigorosamente uomini, le donne si accontentino di essere vice,
come la deputata cuneese Chiara Gribaudo, papabile sottosegretaria. È stata tra
le più accese a battersi affinché si rimediasse all'assenza di ministre dem.
«Mettiamo sempre la parità di genere nei documenti e poi la neghiamo di fronte
al Paese? Brutto», ha dichiarato. Alle piddine lasciano le funzioni più noioise:
segretarie d'Aula. Lo sono Barbara Pollastrini e Stefania Pezzopane, indignate
come le colleghe Titti Di Salvo, Valeria Fedeli e Laura Boldrini. Zingaretti si
è giustificando dicendo che il premier ha scelto da solo la sua squadra e che il
Pd è l'unico partito che ha la parità di genere nello statuto. Peccato che
scriverlo su un testo e poi non rispettarlo nella pratica è puro tafazzismo. O
solo l'ennesima conferma che a sinistra si predica bene, ma poi si razzola
male.
Roberto Vivaldelli per ilgiornale.it il 7 marzo
2021. Non mimose ma una nuova toponomastica femminista. In attesa dello
"sciopero globale femminista e transfemminista" in programma domani, 8 marzo, in
concomitanza con la Giornata internazionale della donna, le attiviste del
collettivo "Non una di meno" hanno cambiato, con un blitz nel cuore della notte
- e con buona pace del coprifuoco in vigore - i nomi di alcune piazze e vie a
Milano. E così Piazzetta Maurilio Bossi è diventata piazzetta Sylvia Rivera,
icona e militante per i diritti lgbtqia+, 1951-2002, Foro Bonaparte è stato
ribattezzato Foto Tina Modotti, fotografa, attrice, militante rivoluzionaria,
1896-1942 e via Mogadiscio è diventata invece piazza Isabella Marincola,
attrice, italiana, nera, antifascista, 1925-2010; per non parlare di via della
Spiga, ribattezzata provocatoriamente "via della Figa".
"Vie e piazze sempre dedicate a uomini bianchi".
Il problema, secondo il colletivo, è che troppe vie sono intitolati a maschi
bianchi. "Le vie e le piazze della nostra città sono quasi sempre dedicate a
uomini e a persone bianche, a volte degne di nota, ma spesso perché
colonizzatori e stupratori o sterminatori in qualche guerra", spiega il
movimento femminista, come riporta La Stampa, aggiungendo che "questo 8 marzo
abbiamo deciso di modificare la toponomastica, scegliendo alcune donne e persone
lgbtqia+ da ricordare nello spazio pubblico". L’obiettivo è "iniziare ad
abbattere il muro dell’invisibilità dietro al quale, da secoli, le donne e le
persone lgbtqia+ vengono relegate". Le ultra-femministe del collettivo di
sinistra Non una di meno si preparano così allo sciopero in programma di domani
con il linguaggio tipico del femminismo rivoluzionario di sinistra degli anni
'70 e i soliti richiami alla lotta globale figli dell'internazionalismo
comunista.
Le femministe pronte allo sciopero globale dell'8
marzo. Nulla di nuovo, insomma, se non - rispetto agli anni '70 - l'ossessione
progressista e contemporanea per il genere e i riferimenti all'odiato "maschio
bianco", come accade sempre più spesso nel mondo anglossassone e, in
particolare, negli Stati Uniti, dove la politica dell'identità sta assumendo
toni quasi grotteschi. Come scrivono sulla loro pagina Facebook, "Siamo
Rivoluzione. Feministe Transfronterizas contro ogni violenza. Dai nostri diversi
femminismi, intrecciati e potenziati dalla nostra connessione transnazionale,
convochiamo tutt* l* donne, lesbiche, non binarie, trans, intersex, queer,
migranti, indigen*, ner*, afrodiscendenti, allo sciopero femminista globale
dell’8M 2021". "Invitiamo tutte e tutt* - scrivono, con i soliti asterischi -
"ad interrompere ogni tipo di lavoro produttivo e riproduttivo, a riacquisire
visibilità ovunque, soprattutto in quegli spazi che ci sono stati
tradizionalmente negati e che la pandemia ci ha sottratto, verso lo sciopero
femminista globale dell’8 Marzo e oltre, per continuare a costruire le nostre
ribellioni collettive e transnazionali".
Le manifestazioni contro il femminicidio.
Il sessismo questione maschile, oggi lo dicono gli uomini.
Lea Melandri su Il Riformista il 6 Marzo 2021. È da molto tempo
che il rapporto tra i sessi non è più visto come “questione femminile” e le
donne come un gruppo sociale svantaggiato, a cui riconoscere diritti e parità.
Eppure, questa ottica non è mai scomparsa del tutto e a lungo si è atteso che
gli uomini riconoscessero nel patriarcato la storia che ha visto il loro sesso
da millenni arrogarsi il governo del mondo, sottomettere e sfruttare il corpo
che li ha generati. Di quale violenza siano stati capaci i dominatori non sembra
sia mancata la consapevolezza, per cui dovrebbe venire spontaneo chiedersi
perché arrivi così tardi una presa di parola che dica con chiarezza “il sessismo
ci riguarda”, interroga il modello di civiltà che abbiamo creato e le nostre
vite. «L’uomo non è una creatura mansueta – si legge nel saggio di Freud
Il disagio della civiltà del 1929 -, bisognosa d’amore, capace, al massimo di
difendersi se viene attaccata; ma occorre attribuire al suo corredo pulsionale
anche una buona dose di aggressività. Ne segue che egli vede nel prossimo non
soltanto un eventuale aiuto e oggetto sessuale, ma anche un invito a sfogare su
di lui la propria aggressività, a sfruttarne la forza lavorativa senza
ricompensarlo, ad abusarne sessualmente senza il suo consenso, a sostituirsi a
lui nel possesso dei suoi beni, a umiliarlo, a farlo soffrire, a torturarlo e a
ucciderlo». A fronte di tanta lucidità non può che apparire inspiegabile
l’affermazione dello stesso Freud che l’unico rapporto «esente da ambivalenze» è
quello tra la madre e il figlio maschio, e che un matrimonio diventa stabile
quando la donna diventa anche la madre del proprio marito. Quanto può aver
contato l’idealizzazione e il prolungamento dell’amore nella sua forma
originaria nell’occultamento del potere e della violenza con cui l’uomo si è
appropriato del corpo femminile, quanto aver confinato le donne nel ruolo
“naturale” di madri, quasi fossero un tutto omogeneo, e aver riservato a sé una
individualità sottratta alle sue radici biologiche? Gli uomini che hanno sfilato
in silenzio per le strade di Biella, Potenza, Torino, Genova, Milano, Roma in
questi giorni portavano mascherine e scarpe rosse, simboli della violenza
maschile nelle sue forme più arcaiche e selvagge, i femminicidi, ma al medesimo
tempo rivelazione di ciò che di inquietante sta sotto la “normalità”,
l’apparente sicurezza degli interni di famiglia. Dover ammettere che in
quella “diade amorosa” che è l’unità madre-figlio, marito-moglie, tanto esaltata
dai teorici dell’amore romantico e dagli adoratori della madri, si annidano i
risvolti più feroci del patriarcato è stata sicuramente la molla che ha fatto
cadere arroccamenti difensivi, prese di distanza dalla mano armata dei propri
simili. Quando “il re è nudo”, anche i suoi più timidi servi possono alzare lo
sguardo su di lui. Non è sempre stato il giudizio dei propri simili a
scoraggiare gli uomini, fin dalla più tenera età, a deporre quella maschera di
virilità che li garantiva di un privilegio, di una appartenenza, di una
protezione? Nel saggio Einaudi del 1985, L’ultimo paradosso, Alberto Asor
Rosa, scrive: «Sediamo da secoli in gruppo intorno ad una tavola impartendo il
comando cui la nostra funzione ci abilita, distribuendo il potere che il nostro
ruolo ci assegna. Anche fra amici indossiamo la corazza: i momenti più intimi
della nostra conversazione passano tra celate accuratamente abbassate. Le nostre
mani sono chele in riposo (…) Talvolta ci sorge il sospetto che il nostro
sacrificio, offerto a divinità tanto astratte quanto crudeli come quelle che
compongono la religione dell’ascetismo guerriero, sia scontato ed inutile, e
persino oggi un poco patetico: ed aspiriamo ad uscire da qualche crepa della
vecchia armatura, a scivolare furtivi sotto quel tavolo, per guadagnare la porta
della riunione e uscire a respirare aria pura. Ma appena fissiamo lo sguardo
nello sguardo dei nostri compagni, attraverso la fessura della celata e vi
scorgiamo la nostra stessa disperazione, la nostra prigionia, il nostro stesso
dolore, il nostro stesso smisurato orgoglio (…) non appena sguardo con sguardo
di nuovo si incatena, subito il desiderio di libertà, l’ansia di gioia ci
abbandonano – e scopriamo che non potremo mai lasciarli».
Eppure, qualche fessura della celata guerresca
deve essere rimasta alzata se gruppi, sia pure isolati di uomini decisi a
prendere parola per dire che la violenza sulle donne “li riguarda”, ha avuto con
immediatezza sorprendente l’effetto di un raro benefico contagio, tanto da
interessare città diverse e da sollecitare iniziative simili nei prossimi
giorni. Se può dispiacere o sollevare critiche il fatto che in alcuni cartelli o
slogan comparisse la parola “protezione”, in altri l’assunzione di
responsabilità, sia per quanto riguarda l’aspetto strutturale della violenza che
il vissuto del singolo, era chiara: «Come uomini dobbiamo metterci la faccia e
rompere quel silenzio assordante nel quale siamo colpevolmente avvolti. Deve
arrivare per noi il tempo della consapevolezza e della responsabilità. E di una
modifica radicale della società che è ancora profondamente patriarcale, sessista
e maschilista». Con la pandemia, il confinamento nelle case, sappiamo che sono
aumentate le violenze, oltre a un sovraccarico di lavoro per le donne. Ma nella
generale insicurezza, nel venire allo scoperto di differenze di genere, di
classe, di età, di culture, nella centralità che ha preso la cura come impegno
di una collettività e non più destino “naturale” della donna, nell’evidente
necessità di riconoscere fragilità e interdipendenza degli umani, si può pensare
che siano cadute anche alcune delle barriere ideologiche che finora – come ha
scritto Antonella Picchio – hanno coperto la “enorme debolezza” degli uomini e
il “delirio di onnipotenza” delle donne, che si sono assunte per secoli, sia
pure forzatamente, il compito di rendere loro “buona la vita”. Un movimento di
uomini, capace di chiedersi che cosa significa oggi essere uomo, se è possibile
«andare oltre la frustrazione e il rancore» (Stefano Ciccone), è ciò che
possiamo augurarci. Che questi primi segnali di “sollevazione” contro il dominio
maschile, da parte di chi ne ha conosciuto il privilegio ma anche il peso e la
disumanità, avvengano in prossimità dello “sciopero delle donne dal lavoro
produttivo e riproduttivo”, indetto come da alcuni anni a questa parte
dalla rete femminista e transfemminista di Non Una Di Meno, forse non è casuale
e lascia intravedere alleanze là dove finora c’era indifferenza o ostilità.
Palombelli alle donne: "Non
andremo mai bene ma non arrendiamoci".
La giornalista, co-conduttrice
della quarta serata del festival di Sanremo, ha fatto un monologo dedicato alle
donne spronandole ad essere rinascita dell'Italia. Novella Toloni - Sab,
06/03/2021 - su Il Giornale. Barbara Palombelli ha puntato sulle donne per il
suo monologo al festival di Sanremo. Co-conduttrice della quarta serata della
kermesse canora, la giornalista e conduttrice di Stasera Italia ha raccontato la
sua storia intrecciandola con quella delle canzoni del festival di Sanremo a lei
più care, per inviare un chiaro messaggio alle donne e soprattutto alle ragazze:
"Non vi arrendete mai, lottate per i vostri sogni". Un lungo monologo che ha
rallentato la maratona canora dei ventisei cantanti in gara. Barbara Palombelli
ha conquistato il centro del teatro Ariston a metà serata, abbondantemente dopo
la mezzanotte, portando l'attenzione dei telespettatori sul ruolo della donna
nella nostra società: "Le donne italiane hanno un compito fondamentale: tengono
il Paese, le scuole aperte, le famiglie tranquille, accudiscono tante persone
positive". L'occasione per citare brani come "Non ho l'età" di Gigliola
Cinquetti, "Ciao amore ciao" di Luigi Tenco e "Chi non lavora non fa l'amore" di
Adriano Celentano. Canzoni simbolo della sua gioventù di donna con sogni da
realizzare: "Volevo fare l'amore ma anche lavorare e lottare per i miei diritti.
Voi giovani li avete trovati già fatti, noi li abbiamo costruiti andando in
piazza. Ora sta a voi difenderli con il sorriso determinato che sapete avere".
Racconta di come da "ragazzina ribelle" si è trasformata nella prima donna della
redazione politica del Corriere della Sera e invita le ragazze a ribellarsi
sempre "tanto non andremo mai bene: ci umilieranno, cercheranno di metterci le
mani addosso, non saremo mai perfette". E allora Barbara Palombelli cita
l'esempio di Liliana Segre, senatrice 91enne "che non può andarsi a vaccinare
contro il Covid senza scatenare odio micidiali". Con gli occhi diretti nella
telecamere, la Palombelli - che sul palco ha scherzato con Fiorello svelando di
chiamare "cucciolo" nell'intimità il marito Francesco Rutelli - ha invitato le
donne a non arrendersi, anche quando il prezzo da pagare è molto, troppo alto.
"Le donne forti, le donne vere in questa Europa guidata dalle donne - ha
concluso la giornalista citando brani come "Vacanze romane" dei Matia Bazar,
"Uomini soli" dei Pooh e "Portami a ballare" di Luca Barbarossa - devono
contribuire alla grande rinascita del nostro Paese. Io sono sicura, ci credo, è
qualcosa che sento che sta per avvenire. L'ho ha detto anche Papa Francesco: non
dobbiamo essere prudenti, non vi arrendete. Fate rumore".
Sanremo: Palombelli, bufera
social, commenti ironici e sarcastici. Il monologo non è piaciuto.
Eugenio Marchetti
il 6/3/2021 su Firenze Post. Palombelli, bufera sui social. «Ma cosa sta
dicendo?, Così i vecchi si addormentano, Pallosissima, Noi andiamo un attimo al
bar»’. Il monologo dedicato alle donne, intervallato da grandi canzoni che hanno
fatto la storia del festival, di Barbara Palombelli a Sanremo non sembra essere
piaciuto al popolo dei social che, appena pochi secondi dopo la fine della
performance della giornalista sul palco dell’Ariston, si è scatenato in una
serie di commenti ironici e sorpresi. Palombelli: Poi mi imbarcai su un cargo
battente bandiera liberiana…, scrive un internauta. Se dico che la #Palombelli è
stata pallosissima, sono contro o a favore delle donne?, aggiunge un altro.
Forse ho capito perché Rutelli non si fa più vedere in giro”, è la battuta di
SpinozaLive, che scrive anche: Durante l’omaggio della Palombelli, dalla tomba
di Tenco si è sentito un altro sparo. Noioso anche per il giornalista musicale
Ernesto Assante: Lo Stato Sociale ha svegliato tutti quelli che si erano
addormentati con la Palombelli, twitta. Seguito da un altro utente: Strategica
la Palombelli a quest’ora, così i vecchi si addormentano proprio poco prima di
quando avrebbero spento la tv mantenendo gli ascolti alti. Aridatece Zlatan, è
il definitivo commento di un altro ancora. Ancora più drastico e sarcastico il
commento di Selvaggia Lucarelli: «Tenco che giocava con le pistole, Segre, le
donne che accudiscono, la commessa, il corriere, vacanze romane ma che robe
sconclusionate sta dicendo? #sanremo2021».
Giampiero Mughini per Dagospia il 6 marzo 2021.
Cara Barbara (Palombelli), ho appena finito di ascoltare il tuo bel monologo
pronunziato ieri sera dal palco sanremese. Perdonami non averlo fatto ieri sera,
ma c’è che io non vado mai a letto dopo mezzanotte. E comunque è il solo
spicchio del Sanremo 2021 che abbia visto, e non per spregio del lavoro dei
tanti che fanno del Festival uno spettacolo da otto milioni e passa di
spettatori, l’unica cosa al mondo nata 70 anni fa che duri ancora. Un miracolo,
o un prodigio. Fate voi. Ma non è questo il punto. E bensì, ma tu lo sai perché
ci conosciamo a puntino da un po’ più di quarant’anni, che a me non piace la
partizione del mondo per come tu l’hai disegnata ieri notte, le due “metà del
cielo” distinte e separate, da una parte gli uomini e dall’altra le donne. Fare
questa distinzione ti serviva narrativamente, certo, e avevi tutto il diritto di
farla. Solo che io a solo sentirla accennata, sobbalzo. Sobbalzo all’idea di far
parte di una categoria di persona - gli uomini - che se escono con una donna
provano a “metterle le mani addosso”, come tu hai accennato a un certo punto del
tuo monologo. E’ un argomento, è una materia, è un pezzo del nostro vivere e del
nostro campare di cui credo di essere uno dei massimi specialisti al mondo:
conosco molto meglio le guerre tra i sessi che non le guerre in Congo dove sono
morti di recente nostri due connazionali, due persone per bene, due uomini. Ma
non è nemmeno questo il punto. Tu hai raccontato le tue stagioni, il tuo
apprendistato, la tua carriera, i tuoi lavori come segnati dal fatto di esser
donna. Non è così. Tu sei una macchina da guerra oltre che una donna e la prima
cosa credo sia stata più decisiva della prima. Hai detto che eri l’unica donna
che faceva parte del servizio politico del “Corriere della Sera”. Se è per
questo ho conosciuto bene Gianna Preda, che era stata l’unica donna in un
giornale con 150 giornalisti. Era stata una protagonista ai miei occhi di grande
valore. Le feci un’intervista che un giornale esitò a lungo prima di
pubblicarla, perché non si usa trattare con eleganza (come io facevo) una
giornalista accentuatamente di destra. No, non credo che l’esser donna o uomo
cambi così tanto la condizione di chi lavora nei giornali, nei giornali in cui
abbiamo lavorato io e te. E siccome nei giornali non ho mai avuto alcun potere -
se non quello sconfinato di essere padrone di me stesso e di quello che scrivevo
- ho avuto tante donne miei “superiori”. La mia amica Pialuisa Bianco da
direttore dell’ “Indipendente”, da cui venne cacciata via. Marilù Agnese che
dirigeva il “Sette” cui collaboravo. Una che faceva parte del gruppo dirigente
dell’ultimo “Panorama” nel quale ho lavorato, e alla quale eruttai per telefono
tutto il disprezzo intellettuale che nutrivo per lei. Non erano “donne”, erano
persone, chi meglio chi peggio. E’ stato sempre così, ci misuravamo tra persone
e nel bene e nel male. Semplice, semplicissimo. Non uomini e donne, ma persone.
Ciascuna diversissima e differentissima dall’altra. E nel bene e nel male.
Ps. Cara Barbara, inutile dirti che è stata una
donna, una sindacalista della Rai, a sputare veleno contro il fatto che tu fossi
stata chiamata sul palco di Sanremo. Altro che “sorellanza” femminile.
Sanremo 2021, Laura Boldrini replica a
Beatrice Venezi: "Direttrice è bellissimo, rifletta sui sacrifici delle donne".
Libero Quotidiano il 06 marzo 2021. Laura
Boldrini replica a Beatrice Venezi, il direttore d'orchestra che ieri ha
condotto la prima parte del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus. La Venezi ha
detto molto chiaramente di voler essere chiamata direttore e non direttrice: "La
posizione ha un nome preciso e nel mio caso è quello di direttore d'orchestra".
Non ci sta però la Boldrini, che da presidente della Camera decise di lanciare i
mestieri declinati al femminile nei media. "Il femminile è bellissimo", ha
commentato. "Più che una scelta individuale della direttrice d'orchestra Venezi,
è la scelta grammaticale a prevalere e quella italiana ci dice che esiste un
genere femminile e un genere maschile. A seconda di chi riveste il ruolo si fa
la declinazione. Chi rifiuta questo lo fa per motivi culturali", ha spiegato la
dem in un'intervista all'Adnkronos. Poi ha continuato dicendo che "la
declinazione femminile la si accetta in certe mansioni come "contadina",
"operaia" o "commessa" e non la si accetta quando sale la scala sociale,
pensando che il maschile sia più autorevole. Invece il femminile è bellissimo".
Secondo lei si tratta di "un problema serio che dimostra poca autostima".
"Inviterei la direttrice Venezi a leggere cosa dice l'Accademia della Crusca, la
più alta autorità linguistica del nostro paese. Se il femminile viene nascosto,
si nascondono tanti sacrifici e sforzi fatti", ha aggiunto la Boldrini.
Continuando a rivolgersi alla protagonista della quarta serata del Festival, ha
detto: "Mi permetto di invitarla a riflette su queste cose. Anche perché non è
affatto brutto o cacofonico 'direttrice', ma rappresenta l'affermazione di un
traguardo. Spero si renda conto che usare il femminile possa aiutare tante
ragazze ad avvicinarsi a questo lavoro che per secoli è stato solo di uomini".
Da ilfattoquotidiano.it il 6 marzo 2021. “Non ho
seguito in diretta, ma dico in primis bravo Amadeus a rispettare il genere
femminile. Più che una scelta individuale della direttrice d’orchestra Venezi, è
la scelta grammaticale a prevalere e quella italiana ci dice che esiste un
genere femminile e un genere maschile. A seconda di chi riveste il ruolo si fa
la declinazione. Chi rifiuta questo lo fa per motivi culturali“. Così
all’Adnkronos l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini sulle
polemiche di Sanremo generate da Beatrice Venezi che ieri ha puntualizzato sul
suo mestiere. “Direttrice d’orchestra? No, meglio direttore”, ha detto Venezi.
La Boldrini spiega che “la declinazione femminile la si accetta in certe
mansioni come "contadina", "operaia" o "commessa" e non la si accetta quando
sale la scala sociale, pensando che il maschile sia più autorevole. Invece il
femminile è bellissimo – dice la deputata del Pd – E’ un problema serio che
dimostra poca autostima. Inviterei la direttrice Venezi a leggere cosa dice
l’Accademia della Crusca, la più alta autorità linguistica del nostro paese. Se
il femminile viene nascosto, si nascondono tanti sacrifici e sforzi fatti”. “Un
atteggiamento che non rende merito al percorso che tante donne hanno fatto per
raggiungere queste posizioni – sostiene Laura Boldrini – Mi permetto di
invitarla a riflettere su queste cose. Anche perché non è affatto brutto o
cacofonico "direttrice", ma rappresenta l’affermazione di un traguardo. Spero si
renda conto che usare il femminile possa aiutare tante ragazze ad avvicinarsi a
questo lavoro che per secoli è stato solo di uomini”, conclude.
"Direttore? Poca autostima...". La
Boldrini processa la Venezi. Laura Boldrini ha
commentato le polemiche sulla richiesta della Venezi di declinare al maschile il
suo ruolo di direttrice d'orchestra senza risparmiare critiche alla 31enne.
Novella Toloni - Sab, 06/03/2021 - su Il Giornale. Quando si dice non perdere
l'occasione per tacere. Mentre tutti applaudono alle parole di Beatrice Venezi,
che ha scelto di dare un calcio al politically correct definendosi direttore
d'orchestra, la voce fuori dal coro è quella di Laura Boldrini. L'esponente del
Pd, intervistata dall'Adnkronos, è tornata sulla questione di genere criticando
la scelta della Venezi ammettendo, oltretutto, di non aver neanche visto la
diretta di Sanremo. "Non ho seguito in diretta, ma dico in primis bravo Amadeus
a rispettare il genere femminile - ha commentato la Boldrini all'Adnkronos - Più
che una scelta individuale della direttrice d'orchestra Venezi, è la scelta
grammaticale a prevalere e quella italiana ci dice che esiste un genere
femminile e un genere maschile. A seconda di chi riveste il ruolo si fa la
declinazione. Chi rifiuta questo lo fa per motivi culturali". Il commento
dell'ex presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini arriva il giorno
dopo le parole di Beatrice Venezi, che nella quarta puntata del Festival - dopo
essere stata chiamata direttrice - ha puntualizzato sul suo mestiere: "La
posizione ha un nome preciso e nel mio caso è quello di direttore d'orchestra,
non di direttrice. E così voglio essere chiamata, me ne assumo la
responsabilità". Parole che Laura Boldrini ha voluto subito commentare in tono
critico, forte della battaglia personale che sta conducendo, insieme ad altre
cento donne, contro la Treccani sul termine "donna". E così ecco arrivare la
lezione di linguistica: "La declinazione femminile la si accetta in certe
mansioni come "contadina", "operaia" o "commessa" e non la si accetta quando
sale la scala sociale, pensando che il maschile sia più autorevole. Invece il
femminile è bellissimo". La Boldrini non si è risparmiata, alla fine,
la critica diretta alla 31enne: "Direi che è un problema serio che dimostra poca
autostima. Inviterei la direttrice Venezi a leggere cosa dice l'Accademia della
Crusca, la più alta autorità linguistica del nostro paese. Se il femminile viene
nascosto, si nascondono tanti sacrifici e sforzi fatti. Un atteggiamento che non
rende merito al percorso che tante donne hanno fatto per raggiungere queste
posizioni. Mi permetto di invitarla a riflette su queste cose. Anche perché non
è affatto brutto o cacofonico “direttrice”, ma rappresenta l'affermazione di un
traguardo. Spero si renda coto che usare il femminile possa aiutare tante
ragazze ad avvicinarsi a questo lavoro che per secoli è stato solo di uomini". E
sulle parole della Venezi è intervenuto anche l'ex ministro Fedeli: "Già quando
sono entrata nel sindacato Cgil mi facevo chiamare "la segretaria nazionale" e
non "il segretario". Poi "ministra" e 'la vice presidente del Senato'. La lingua
italiana ci offre termini corretti per non escludere e non imporre. Sulla
questione del direttore o direttrice di orchestra, prendo atto che Beatrice
Venezi, bravissima e preparatissima, abbia scelto di farsi chiamare "direttore".
Avrei preferito il contrario, ma bisogna essere liberi di scegliere, di farci
chiamare come ci si sente meglio", ha affermato all'Adnkronos.
DAGONOTA l'11 marzo 2021. Si dice direttore o
direttrice? Il “Corriere della Sera” ha messo in croce Beatrice Venezi per la
sua scelta di farsi chiamare e di scrivere “direttore d’orchestra”, e non
direttrice, come testimonial pubblicitario per il lato b-ioscalin. Ha tirato
fuori gli arzigogoli di un linguista e una giornalista ha accusato la Venezi di
“patriarcato introiettato” (cos’e’? Una nuova malattia mentale per non
femministe?). Ma cosa scrive proprio il “Corriere della Sera” nella sua gerenza?
Scrive: “Vicedirettore vicario Barbara Stefanelli” e scrive “Vicedirettore”
Fiorenza Sarzanini, tutto al maschile! Come si dice predicare male e scrivere
bene in via Solferino?
Giuseppe Antonelli per corriere.it l'11 marzo
2021. «Il mestiere ha un nome preciso e nel mio caso è quello di direttore
d’orchestra». Così giovedì sera Beatrice Venezi sul palco di Sanremo ha spiegato
la sua scelta di voler essere chiamata direttore e non direttrice. Se questo è
il principio, un paio di sere fa, Alessia Bonari avrebbe potuto dire ad Amadeus
che non voleva essere chiamata infermiera: «Il mio mestiere ha un nome preciso
ed è quello d’infermiere». Perché infermiera sì e direttrice no? Forse perché è
un femminile che non si fa con una a, ma si costruisce con un suffisso diverso?
Ovviamente no. Se questo fosse il punto, qualche anno fa – sempre su quello
stesso palco – Virginia Raffaele avrebbe potuto chiedere di essere chiamata non
imitatrice o attrice, ma attore o imitatore e mai e poi mai presentatrice o
conduttrice, ma presentatore o conduttore: «il nome del mio mestiere è quello».
Volendoci scherzare un po’ su – è bene sdrammatizzare anche le discussioni
linguistiche! – si potrebbe evocare persino la quinta edizione del Vocabolario
della Crusca (1863), in cui alla voce beatrice si legge: «femminile di beatore».
La questione, ancora una volta, è culturale: perché la lingua cambia con la
cultura e con la mentalità della comunità che la parla e la scrive. E allora –
per una vecchia mentalità – ci sarebbero mestieri che si possono declinare al
femminile (come l’infermiera o la segretaria) e altri che invece dovrebbero
rimanere al maschile. È per questa mentalità che si fatica ad accettare parole
che ormai dovrebbero risultare perfettamente normali, visto che la società è
finalmente cambiata: parole come architetta, avvocata, notaia, ingegnera e
persino una parola vecchia – se non antica – come direttrice. Non sarà un caso
che la parola direttrice esista fin dal Medioevo per indicare una linea, ma si
usi solo dalla fine del Settecento per indicare una donna che dirige un gruppo o
un istituto. Gruppo o istituto che a lungo poteva essere solo femminile: perché
una donna che dirigesse degli uomini non era immaginabile. Così come, fino a due
secoli fa, non era immaginabile una donna laureata o una donna in cattedra: e
infatti ci si faceva beffe di parole come dottoressa o professoressa. Agli
ultimi decenni del Settecento risalgono anche le prime attestazioni in italiano
dell’espressione «direttore d’orchestra», ma bisogna aspettare il 1905 per
leggere la notizia di «una donna direttrice d’orchestra nell’attuale stagione
lirica al Politeama di Livorno». Comunque, più di un secolo fa. Eppure ancora
oggi, in un’edizione del Festival in cui i direttori d’orchestra sono tutti
uomini, vediamo salire sul palco una donna che per mestiere dirige l’orchestra e
le sentiamo dire che non è una direttrice, ma un direttore. Come se il femminile
non fosse ancora contemplato da quel mestiere o come se implicasse una
diminuzione del suo prestigio; come se essere una maestra fosse meno o peggio
che essere un maestro.
Estratto dell’articolo di Chiara Maffioletti
per corriere.it l'11 marzo 2021.
La declinazione al femminile non dovrebbe essere
una diminutio. Non è giusto correggere questa percezione?
«Potremmo puntare a un termine neutro. Ma prima mi
concentrerei sul farlo diventare un lavoro a cui possano accedere egualmente
uomini e donne. Ho lavorato sodo per quello che faccio, conoscendo i pregiudizi
e le difficoltà che incontrano le donne: non si risolvono declinando al
femminile».
Quindi per lei è un non problema?
«È una tematica polemica un po’ sterile, penso
anche che per le giovani generazioni. Oltretutto credo che non ci sia niente di
più potente che essere chiamata direttore e arrivare donna, con i capelli biondi
e un bel vestito. Dimostro il mio valore con il lavoro».
Ma una cosa non nega l’altra. Anche la parola
«ministra» non era molto usata. Le cose sono cambiate, anche passando per il
lessico.
«Capisco la posizione di chi dice che dovrei
chiamarmi direttrice, secondo me non sposta l’ago bilancia».
La sua collega Gianna Fratta l’ha criticata per la
sua uscita.
«Sì, poi vai sul suo sito e cosa c’è scritto?
Direttore d’orchestra. Dimostra quanto sia ideologica la critica».
Sono intervenuti molti politici.
«Ho espresso un pensiero già esternato solo che
qui è diventato gigante».
Il suo è patriarcato introiettato?
«Macchè. Ci si divide su questo anziché
concentrarsi perché una donna venga riconosciuta per la sua qualità, azzerando
ogni differenza».
Selvaggia Lucarelli: "La Venezi da donna
avrebbe pulito gli spartiti anni fa". Anche Selvaggia
Lucarelli si è unita al coro delle femministe contro Beatrice Venezi, che dal
palco di Sanremo ha rivendicato il titolo di direttore d'orchestra. Francesca
Galici - Sab, 06/03/2021 - su Il Giornale. Beatrice Venezi è stata la
co-conduttrice della prima parte della quarta serata del festival di Sanremo,
quella dedicata ai giovani. È stata sul palco per circa un'ora, ha fatto due
cambi d'abito e affiancato Amadeus. Poco nota al grande pubblico, è molto famosa
in ambito musicale, essendo pianista e direttore d'orchestra. Non direttrice:
direttore. Ci ha tenuto a specificarlo sul palco dell'Ariston davanti a una
platea televisiva di milioni di persone, per rivendicare la parità dei sessi e
del suo ruolo rispetto a quello dei suoi colleghi uomini. Una presa di posizione
che non è piaciuta ai radical chic e alle femministe integraliste, che da ieri
sui social danno battaglia a Beatrice Venezi. Tra loro anche Selvaggia
Lucarelli, che non si ha mancato occasione di dire la sua, schierandosi contro
il direttore d'orchestra. Qual è il punto della questione? L'attribuzione del
titolo maschile che si è data Beatrice Venezi. Il direttore d'orchestra ha
rivendicato il diritto che il suo titolo non venga declinato al femminile, ma
rispetti quello che è il nome della sua professione, così come riportato nel
titolo di studio conseguito dopo lunghi anni di studio e di fatica. Beatrice
Venezi è il più giovane direttore d'orchestra del Paese, segno che nella sua
carriera ha saputo imporsi e dimostrare il suo valore al di là del maschile o
del femminile del titolo. "Me ne prendo la responsabilità", ha detto la Venezi,
consapevole che le sue parole avrebbero scatenato l'ira social delle femministe.
E, infatti, così è stato. D'altronde non è la prima volta che Beatrice Venezi
rivendica questo diritto e che viene criticata. Ma senz'altro il palco di
Sanremo le ha dato la possibilità di rivolgersi a una platea molto ampia.
Selvaggia Lucarelli, giornalista de Il Fatto Quotidiano, non ha gradito le
parole del direttore d'orchestra: "Quello che penso è che Beatrice Venezi
dovrebbe rivendicare con fierezza il fatto di essere una direttrice visto che
anni fa, in quanto donna, avrebbe potuto al massimo pulire gli spartiti con un
panno caldo. Sono le donne che trattano il femminismo come un qualcosa di
ideologico, anziché di necessario". Un attacco frontale a Beatrice Venezi da
parte di Selvaggia Lucarelli, che attraverso l'Adnkronos si è unita al coro di
dissenso delle femministe. "Peccato", ha concluso la Lucarelli, che si è unita a
quanto detto nelle scorse ore anche da Laura Boldrini. Eppure, il discorso di
Beatrice Venezi è stato molto più femminista rispetto a molte altre battaglie
vacue.
Selvaggia Lucarelli contro Maria Monsè:
la foto scandalosa in costume con la figlia, "fermate questa donna".
Libero Quotidiano il 06 marzo 2021. "Fermate Maria Monsè". La
foto "scandalosa" della showgirl in costume ridottissimo, abbracciata alla
figlia 14enne Perla Maria scatena la rabbia di Selvaggia Lucarelli, che in
quella foto vede tutto tranne che un sano rapporto madre-figlia
(adolescente). "Qualcuno dovrebbe fermare questa donna anziché invitarla in tv
con la figlia 14enne, che non ha colpe. Capito Barbara D'Urso?", scrive la
giornalista del Fatto quotidiano in una delle sue Instagram Stories,
condividendo lo scatto in questione. Il riferimento diretto è alla conduttrice
Mediaset, con cui la Lucarelli non è mai tenera. L'accusa è quella di dare
troppo spazio alla Monsè, spesso ospite dei programmi di Carmelita su Canale 5,
peraltro lanciata insieme alla figlia poco più che bambina da una vecchia
edizione del Grande Fratello Vip. "C'è qualcosa di profondamente disturbante in
tutto questo - ha aggiunto poi la Lucarelli, in una delle Instagram Stories
successive -. Nessuno dovrebbe portare in questa roba. Nessuno. Ha fatto
bene Zingaretti a dimettersi. Chiunque difenda la tv della D’Urso in un paese
serio dovrebbe dimettersi, a pensarci bene". Il confine tra la critica e
l'ironia è molto labile, conoscendo Selvaggia e l'astio personale che la divide
dalla D'Urso. La Monsè e la figlia Perla Maria erano già finite nella bufera per
la decisione di far sottoporre la figlia a un'operazione chirurgica per ridurre
il naso, considerato troppo "ingombrante".
Da ilmessaggero.it l'8 marzo
2021. Maria Monsè contro Selvaggia Lucarelli, il botta e risposta al vetriolo
incalza. Stavolta è Maria Monsè a consegnare al Messaggero la replica alla
Lucarelli che aveva fortemente criticato le fotografie postate dalla Monsè sul
suo profilo Instagram con la figlia minorenne Perla Maria, immagini giudicate
troppo sexy e audaci. «Cara Selvaggia Lucarelli, in riferimento al post
pubblicato ieri sulla tua pagina instagram ci tengo a precisare che il rapporto
con mia figlia Perla Maria rappresenta un sano rapporto madre -figlia», scrive
Maria Monsè. Cosa era successo? In sintesi, la Monsè si è mostrata sul social
assieme alla figlia quattordicenne Perla Maria: entrambe in sexy (troppo?)
costume da bagno, e in pose considerate un po' troppo audaci, in una vasca. Le
immagini non a caso avevano scatenato la reazione dei fan sulla rete. Fino
all'intervento social di Selvaggia Lucarelli: «C’e qualcosa di profondamente
disturbante in tutto questo - ha scritto in un post di Instagram - E per
“questo”, oltre la foto che neppure commento, oltre alle copertine con la figlia
quattordicenne di cui mostra i ritocchi dal chirurgo, intendo dire che nessuno
dovrebbe portare in tv questa roba. (ovvero il mondo di questa tizia) Nessuno».
La palla passa a Maria Monsè. «Quello che dispiace - scrive Monsè - è che un
sano rapporto madre-figlia debba essere oggetto di critica offensiva nei miei
confronti oltre ad essere usato per proferire attacchi alla signora Barbara
D’Urso amatissima dal pubblico visti i milioni di telespettatori che ogni giorno
seguono i suoi programmi televisivi». «Mi viene mossa una critica per una foto
pubblicata senza autorizzazione, esclusivamente con scopo denigratorio e che di
certo non può essere qualificata da te "disturbante"; disturbante secondo i miei
criteri di valutazione è quella persona che prima partecipa al reality “la
fattoria“ (partecipammo insieme nel 2006 ) mandato in onda sulla stessa rete
televisiva che oggi invece attacchi unitamente alla sua conduttrice di punta
ovvero la Signora Barbara d’Urso anziché esserle riconoscente». «Forse ciò che
disturba è il fatto che io a 47 anni posso permettermi ancora di fare degli
scatti mettendo in mostra quanto natura mi ha dotato e purtroppo c’è chi invece
alla mia stessa età non può farlo... e per andare in spa, avrei dovuto mettere
il burqua a mia figlia?» Cara Selvaggia Lucarelli, in riferimento al post
pubblicato ieri sulla tua pagina instagram ci tengo a precisare che il rapporto
con mia figlia Perla Maria rappresenta un sano rapporto madre -figlia. Quello
che dispiace è che un sano rapporto madre-figlia debba essere oggetto di
critica offensiva nei miei confronti oltre ad essere usato per proferire
attacchi alla signora Barbara D’Urso amatissima dal pubblico visti i milioni di
telespettatori che ogni giorno seguono i suoi programmi televisivi. Mi viene
mossa una critica per una foto pubblicata senza autorizzazione , esclusivamente
con scopo denigratorio e che di certo non può essere qualificata da te “
disturbante “ ; disturbante secondo i miei criteri di valutazione è quella
persona che prima Partecipa al reality “la fattoria “ ( partecipammo insieme nel
2006 ) mandato in onda sulla stessa rete televisiva che oggi invece attacchi
unitamente alla sua conduttrice di punta ovvero la Signora Barbara d’Urso
anziché esserle riconoscente . E come si può qualificare la condotta di un
minore di anni 16 che nel luglio del 2020 va in piazza ad offendere il leader
del partito di maggioranza Italiano di centro destra?? (Notizia ampiamente
diffusa da ogni mezzo stampa). Forse ciò che disturba è il fatto che io a 47
anni posso permettermi ancora di fare degli scatti mettendo in mostra quanto
natura mi ha dotato e purtroppo C’è chi invece alla mia stessa età non può
farlo... e per andare in spa , avrei dovuto mettere il burqua a mia figlia? Come
qualificheresti quella persona che passa di colore in colore a seconda delle
esigenze o dei vantaggi ricavabili, che un giorno è di destra e un giorno è di
sinistra un po’ come farebbe una farfallina che salta di fiore in fiore?
Sanremo 2021, Selvaggia
Lucarelli "sessista": "Molto meglio degli uomini", lei può dire che i maschietti
fanno pietà.
Libero Quotidiano il 03 marzo 2021. La sacerdotessa del giusto,
alias Selvaggia Lucarelli, da assidua frequentatrice del mondo dello spettacolo
quale è, non ha ovviamente risparmiato il suo acume durante la prima serata
del Festival di Sanremo 2021. Un diluvio di tweet, di cinguettii
dall'impareggiabile successo, quello che i fan consegnano a Selvaggia-la-giusta
ogni volta che proferisce frasettina sul social. Beata lei, insomma. Evviva. E
poiché sacerdotessa del giusto, Selvaggia ha emesso sentenze, battute, sparate,
plausi e bocciature. Non gradisce granché la gag Amadeus-Zlatan Ibrahimovic:
"Sul vocabolario, alla parola cringe da oggi ci sarà una foto della gag
Amadeus-Ibrahimovic", performance insomma bollata come imbarazzante. Epperò
sembra gradire lo sketch di Fiorello che parla delle dita dei piedi:
"Avanguardia pura". Epperò Fiorello viene anche strigliato: "Se Fiorello si
sposta un attimo vediamo anche Sanremo", gli rimprovera (curioso) l'eccessivo
protagonismo. Bocciato Fedez: "Era meglio quando lanciava banconote dal
finestrino". Una porzione speciale del twitter-pensiero della sacerdotessa
Selvaggia spetta però a Matilda De Angelis, la bellissima - e bravissima -
attrice bolognese co-conduttrice in questa prima serata (davvero notevole il
pezzo sul bacio con Amadeus). La Lucarelli gradisce assai l'operato di Matilda,
tanto che cinguetta: "La De Angelis è così brava da farci dimenticare la
bruttezza di quello che le fanno fare". Eppoi, in un secondo cinguettio,
Selvaggia la giusta aggiunge: "Matilda De Angelis è molto più brava di tutti gli
uomini visti fino ad ora sul palco, conduttore compreso". Oh perbacco, sessismo!
Discriminazione! Le donne meglio degli uomini! Ovviamente - noi - si scherza. Ma
ci si interroga: cosa avrebbe detto la sacerdotessa del giusto se qualcuno
avesse detto che il maschietto x "è molto più bravo di tutte le donne viste ad
ora sul palco?". Chissà...
Sanremo, Beatrice Venezi
schiaccia il politically correct: "Sono direttore, non direttrice d'orchestra".
Poche parole
ma chiare e dette col sorriso dal palco più importante d'Italia: in pochi
secondi, Beatrice Venezi calcia via il femminismo integralista. Francesca
Galici - Ven, 05/03/2021 - su Il Giornale. Dopo l'impalpabile presenza di
Vittoria Ceretti sul palco del teatro Ariston nella terza serata, al festival di
Sanremo è arrivata Beatrice Venezi. Di professione pianista e direttore
d'orchestra, la co-conduttrice della quarta serata ha voluto immediatamente
mettere in chiaro il suo ruolo nella serata ma, in generale, nell'ambito
musicale, dimostrando che non sono le etichette a qualificare un professionista
ma la sua bravura. Con una semplice frase, la pianista ha messo a tacere i ben
pensanti del politically correct radical chic, sempre pronti a violentare la
lingua italiana con le loro teorie campate per aria. In un momento storico in
cui una certa parte politica sembra avere come priorità quella di eliminare il
maschile generico dalla lingua italiana e forzare determinate parole in nome di
una presunta parità tra i sessi, che sembra passare dalla forma e non dal
contenuto, Beatrice Venezi ha voluto fare chiarezza sul suo titolo. "Io sono
direttore d'orchestra", ha detto la Venezi sul palco del teatro Ariston
ad Amadeus, che la stava presentando come direttrice. "La posizione ha un nome
preciso e nel mio caso è quello di direttore d'orchestra, non di direttrice", ha
spiegato la Venezi. Uno schiaffo morale alle femministe a ogni costo, con un
discorso molto più femminista di quanto non vogliano farci credere gli
integralismi della declinazione linguistica. Beatrice Venezi non vuole
discriminazioni nella sua professione, non vuole sentirsi diversa rispetto ai
suoi colleghi. "Mi assumo la responsabilità di questa cosa", ha detto Beatrice
Venezi, "perché è importante quello che sai fare". Poche parole e un calcio al
femminismo integralista per il direttore d'orchestra, come ama definirsi, come è
scritto sui documenti faticosamente conseguiti dopo tanti anni di studi. La sua
presa di posizione, potente seppur fatta con il sorriso, ha scatenato la
polemica dei soliti benpensanti da tastiera, incapaci di accettare le forme e le
regole della lingua italiana o, almeno, la decisione di una professionista che
se ne infischia delle battaglie di contenuto e punta a dimostrare sul campo il
suo valore. Beatrice Venezi non sarebbe diventata il più giovane direttore senza
la determinazione e il coraggio mostrati sul palco, dove ha puntato i piedi
consapevole che le sue parole avrebbero scatenato l'ira delle femministe dure e
pure. Ma, forse, proprio questa sua voglia di affermare il suo ruolo senza le
sovrastrutture inutili è molto più utile alla battaglia femminista rispetto a
tante altre battaglie pressoché inutili.
Dagoreport il 7 marzo 2021. Beatrice Venezi aveva
tutto per piacere alla sinistra conformista: il cognome giusto (quello di una
città), brava in quanto donna, un lavoro da sempre appannaggio dei maschi,
“impegnata” nelle buone cause seguite dai giornali (come Terre des Hommes),
vestiti firmati, vacanze in luoghi fighi... Poi è caduta su due leggi
fondamentali che i sacri sacerdoti del politically correct non possono
perdonarle: una pubblicità che cede ad allusioni sul corpo della donna e il
rifiuto di accettare una neolingua imposta ex nihilo. E così, dopo la pubblicità
per Bioscalin dove si dice “Tira fuori il tuo lato B-ioscalin” (chiara allusione
al lato B di una donzella), e dopo la preferenza a farsi chiamare “direttore”
(come firmato nella pubblicità) e non “direttrice d’orchestra”, i vari Michela
Murgia, Montanari e compagnia “cantante” si sono scatenati sulla tastiera. Anche
con eccessi comici, come quelli di Laura Boldrini che ha dichiarato: “Beatrice
Venezi ha poca stima di sè se si fa chiamare direttore”. A dire il vero, la
Venezi è piuttosto piena di sé, sin da quando dichiarava per il “Corriere” che
persino “una ragazzina di 13 anni sta preparando una tesi su di me collegandomi
all’emancipazione femminile” (25-06-2018). Il “Corriere”, che l’aveva assoldata,
ha subito fatto cadere il suo anatema per mano di un linguista chiamato a
sostenere che la Venezi sbaglia perché la “lingua cambia” (sì, ma cambia dal
basso; quando cambia per imposizione si chiama comunismo o fascismo!)
accusandola anche di “patriarcato introiettato”!!! E dire che, prima di
bacchettarla, il “Corriere” la portava in punta di bacchetta: nel 2018 un
articolo per lei intitolato (forzando) “Non voglio i pantaloni”; il blog
neofemminista del “Corriere” chiamato “La 27ma ora” la aveva invitata alla
kermesse “Il tempo delle donne” nel 2019 mentre nel 2017 l’aveva inserita tra le
50 donne dell’anno per il “Corriere”. Poco importa se i critici musicali
ridacchiassero dietro le quinte della direttrice/ direttore dell’Orchestra della
Toscana, dell’Orchestra Milano Classica e della Nuova Orchestra Scarlatti Young
che dirigeva quello che per loro è un non-tenore, Andrea Bocelli. Lei, trentenne
biondona, e in quanto biondona direttore con merito, era la direttrice non in
pantaloni e con il plus di essere appassionata di moda (cioè degli inserzionisti
pubblicitari): “Mi piace dirigere in gonna, ho diversi abiti da sera, mi piace
il rosso. Non dobbiamo imitare gli uomini quando dirigiamo”. Donna emancipata,
donna… ma senza esagerare perché la confraternita del politically-correct ha le
sue leggi: su Yuja Wang, giovane pianista cinese che suona in minigonna o con
spacchi vertiginosi, la Venezi aveva detto: “Quello non va bene, non credo sia
sexy, né indice di femminilità suonare musica classica in minigonna”: ma come,
uno dei capisaldi del neofemminismo non è quello che una donna si veste come
vuole, anche con il microabito di notte in periferia? Una personalità troppo sua
e troppo piena di sé, questa Venezi, agli occhi dei sacri sacerdoti del
conformismo. Tu devi stare o di qua o di là! O direttora/direttrice e senza lato
B pubblicitario oppure sei con gli altri. Tra gli altri, ricordiamolo, c’era il
critico musicale Paolo Isotta il quale, la prima volta che vide alla Scala una
direttrice d’orchestra (non era la Venezi) si alzò sconcertato in platea è urlò:
“So io dove ti metterei quella bacchetta…”. Durante un’intervista con Freeda ha
dichiarato che il suo idolo è Elisabetta I. La ritiene una grande donna poiché è
riuscita a comandare tutto da sola, rifiutando il matrimonio come sistema
politico e diventando completamente indipendente.
Da liberoquotidiano.it il 7 marzo 2021. "Non
chiamatemi direttrice", aveva avvertito Beatrice Venezi, appena arrivata sul
palco del Festival di Sanremo accolta da Fiorello e Amadeus. Un messaggio che ha
stizzito non poco Laura Boldrini, che ha invitato il direttore d'orchestra a
"non dimenticare i sacrifici delle donne". Come se il loro destino e il rispetto
dei loro diritti, insomma, dipendessero da un nome declinato al maschile o al
femminile. Alla deputata Pd ed ex presidenta della Camera (che verrà ricordata,
d'altronde, solo per battaglie politiche di questo tenore), la Venezi ha
risposto per le rime con una intervista al Corriere della Sera, un
trattato-bignami di cosa significhi davvero essere orgogliose di essere donna,
al di là di ipocrisie ed etichette. "La posizione ha un nome preciso e nel mio
caso è quello di direttore d'orchestra, non di direttrice. E così voglio essere
chiamata, me ne assumo la responsabilità", ha ribadito la 31ennne. Selvaggia
Lucarelli addirittura le ha ricordato che se non fosse stato anche per le
battaglie della Boldrini, "da donna avrebbe pulito gli spartiti anni fa",
anziché dirigere altri musicisti. Risposta? "L’ambiente da cui vengo è
conservatore. Ci sono le figure del Maestro e del Direttore d’orchestra. La
declinazione al femminile non solo non aggiunge niente — non sento la necessità
del femminile per sentirmi riconosciuta — ma ci sono dei connotati peculiari:
maestra rimanda alla maestra di scuola, un altro lavoro". Insomma, non viene da
un altro pianeta e tantomeno è una privilegiata: "Ho lavorato sodo per quello
che faccio, conoscendo i pregiudizi e le difficoltà che incontrano le donne: non
si risolvono declinando al femminile. Ci si divide su questo anziché
concentrarsi perché una donna venga riconosciuta per la sua qualità, azzerando
ogni differenza".
Valentina Dardari per ilgiornale.it il 7 marzo
2021. Beatrice Venezi, attaccata per una frase che in molte pensiamo, è finita
da giorni in una disputa che ha preso anche colori politici. Le è bastato
esprimere il proprio pensiero sul palco del festival di Sanremo per ritrovarsi
in mezzo alle polemiche. Poche parole che hanno creato il marasma: “La posizione
ha un nome preciso e nel mio caso è quello di direttore d'orchestra, non di
direttrice. E così voglio essere chiamata, me ne assumo la responsabilità".
La lezione della Venezi. La 31enne ha solo
sottolineato qualcosa che ha sempre pensato ma che non aveva mai detto sul palco
più importante d’Italia. E lì, anche un semplice respiro acquisisce tutto un
altro suono. Come lei stessa ha ammesso: “Eppure sono anni che dico di essere un
direttore d’orchestra: farlo all’Ariston ha avuto un altro peso”. Già, un altro
peso che in pochi minuti ha scatenato il putiferio e attacchi da altre donne che
invece di essere solidali le hanno dato contro.
"Direttore? Poca autostima...". La Boldrini
processa la Venezi. Laura Boldrini ha processato la Venezi criticandola e
tacciandola di avere poca autostima. Perché secondo la Boldrini, se il femminile
viene nascosto, si nascondono tanti sacrifici e sforzi fatti. Come se tutto
dipendesse dall’uso del femminile. E così anche Selvaggia Lucarelli ha attaccato
frontalmente il direttore d’orchestra, che a suo dire avrebbe dovuto rivendicare
con fierezza il fatto di essere una direttrice. Sottolineando che anni fa
avrebbe solo potuto, come donna,“pulire gli spartiti con un panno caldo”. Né la
Boldrini, né la Lucarelli si sono accorte che con una semplice frase, la Venezi
è stata molto più femminista di loro. Beatrice Venezi, intervistata dal Corriere
della Sera, ha asserito che ridirebbe quanto detto sul palco, perché secondo lei
le lotte importanti, quelle vere che riescono a cambiare qualcosa, sono altre.
“L’ambiente da cui vengo è conservatore. Ci sono le figure del Maestro e del
Direttore d’orchestra. La declinazione al femminile non solo non aggiunge niente
— non sento la necessità del femminile per sentirmi riconosciuta — ma ci sono
dei connotati peculiari: maestra rimanda alla maestra di scuola, un altro
lavoro” ha spiegato. Anche perché, se l’obiettivo è avere pari opportunità, per
la Venezi non ha senso stare a sottolineare una differenza di genere, serve solo
a dividere ulteriormente. Nei paesi anglofoni per esempio direttore d’orchestra
si dice conductor, senza possibilità di sbagliare o polemizzare.
Ha lavorato sodo per arrivare dov'é. La 31enne ha
poi pensato che si potrebbe arrivare a usare un termine neutro, così da non
scontentare nessuno. Ma ha anche tenuto a dire che prima di questo sarebbe il
caso che diventasse un lavoro a cui accedono in modo uguale uomini e donne. La
Venezi ha spiegato fiera: "Ho lavorato sodo per quello che faccio, conoscendo i
pregiudizi e le difficoltà che incontrano le donne: non si risolvono declinando
al femminile". Il direttore ha definito la polemica sterile. "Non ho voglia di
travestirmi da uomo per dimostrare che so dirigere un'orchestra. Non serve lo
sguardo accigliato per essere autorevoli. E chi l'ha detto poi che una figura
cristallizzata sia sinonimo di professionalità? Rifiuto gli stereotipi della
musica classica, un mondo sostanzialmente maschile, e ai pregiudizi rispondo
salendo sul podio con la gonna". Come riportato dal Messaggero, la Venezi aveva
raccontato di aver portato avanti le suee battaglie fina da quando ha cominciato
a fare questo lavoro. Perché "voglio dimostrare che la musica classica è
sinonimo di libertà e non di costrizione. Abbattere dall'interno i cliché e
avvicinare i giovani a questo mondo di bellezza e di valori. Renderla più
democratica, parlandone anche sui social, sulle riviste e in tv". Il direttore
vanta 50mila followers. Ma adesso esiste la ministra, l’avvocata, la sindaca.
Anche la collega Gianna Fratta ha criticato la Venezi per le sue parole sul
palco dell’Ariston, ma sul suo sito personale ha usato il termine direttore
d’orchestra. Qualche controsenso c’è, anche in chi attacca. “Ci si divide su
questo anziché concentrarsi perché una donna venga riconosciuta per la sua
qualità, azzerando ogni differenza” ha chiosato la Venezi, direttore
d’orchestra.
Piera Anna Franini per
Dagospia l'8 marzo 2021. L’Italia non è un Paese per meritevoli, si sa. Vi sono
comunque due categorie dove la meritocrazia si applica in automatico: sport e
arte. Se sei un grande atleta vinci medaglie, campionati e coppe del mondo. Se
sei un grande artista - restringiamo il campo alla musica d’arte, classica e
lirica - riempi le sale da concerto che contano, ottieni ingaggi importanti, le
orchestre di classe ti rispettano e quindi ti richiamano. In tal senso, è
interessante il fenomeno Beatrice Venezi. Direttrice d’orchestra di 31 anni. Si
muove fra la classica e il pop, è al centro della scena mediatica strettamente
nostrana, ha un buon seguito sui social e presta il volto a campagne
pubblicitarie, anche se non glam come accade ai colleghi artisti che si muovono
fra Bottega Veneta, Cartier, Audi, Rolex, Mandarin Oriental…Venezi è stata la
co-conduttrice della quarta serata di Sanremo. Ha innescato un certo dibattito
la sua posizione anti-sessista in tema di lingua: ritiene che direttora o
direttrice non funzioni. “Chiamatemi direttore d’orchestra” è il mantra oltre
che uno degli ingredienti della sua storytelling. E qui sta il punto: Venezi è
una campionessa di personal branding, ha strategie, visione e senso del
tempismo. Ma soprattutto sa che di fronte a sé ha una prateria: gli artisti non
sono propriamente maestri del marketing, salvo rare eccezioni. E così, accade
che Venezi venga indicata come uno dei punti di riferimento della direzione
d’orchestra. Per la verità, nel mondo della musica d’arte è un’araba fenice: che
vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. E per “dove” intendiamo i
palcoscenici di serie A, italiani e stranieri, quelli, per dire, che frequenta
abitualmente Beatrice Rana, pianista di classica under30, con un portfolio ricco
di concerti nei luoghi che contano. I dovuti distinguo già li abbiamo fatti, nel
senso che sappiamo che un pianista arriva in vetta prima di un direttore, il
punto è che Rana è numero uno da anni ed è più giovane. Venezi manca (oppure va
ma non vi torna) su quei palcoscenici frequentati dagli omologhi di ieri e di
oggi: l’under30 Claudio Abbado già veniva incoronato dal NYTimes e adocchiato da
Leonard Bernstein; Riccardo Muti aveva un contratto stabile con il Maggio di
Firenze dei tempi d’oro; Riccardo Chailly aveva debuttato alla Scala ed era
fisso alla Radio di Berlino; Lorenzo Viotti (classe 1990) è stato più volte
alla Scala, ha vinto un Premio a Salisburgo e ora ha un contratto a Amsterdam.
Idem per la lituana Mirga Grazinyte-Tyla, oggi ha 35 anni ma da under30 aveva
vinto il Premio Nestlé a Salisburgo, lavorato con la Filarmonica di Los Angeles
e un contratto con l’orchestra di Birmingham e diretto ai Proms. Si sta
allungando la lista delle donne direttrici che frequentano i podi di lusso:
Marin Alsop, Keri Wilson, Simone Young, Alondra de la Parra, Julia Jones, Eva
Ollikainen. E allora il sessismo, se proprio di sessismo vogliamo parlare, sta
nell’assenza di Beatrice Venezi sui podi apicali della classica. O non è
questione di sessismo? Forse Venezi paga lo scotto della sua natura ibrida per
cui dare un colpo al cerchio del pop e l’altro alla botte della musica classica
non paga? Forse è peccato - nel mondo della classica - fare personal branding?
Altro?
Giovanni Sallusti per
Dagospia, autore del libro ''Politicamente Corretto - la dittatura
democratica'' - Giubilei Regnani editore, l'8 marzo 2021. Caro Dago, avrei una
domandina facile facile per le sacerdotesse dell’8 marzo, per le Laura Boldrini
in lotta dura contro il sessismo dell’enciclopedia Treccani, per le Michela
Murgia che approfittano della ricorrenza per lanciare il loro ultimo libro
contro i soprusi del maschio italico (in passato già paragonato dall’augusta
scrittrice a un boss mafioso), per le Selvaggia Lucarelli che scomunicano
quell’eretica di Beatrice Venezi, rea di non sentire come imprescindibile
battaglia di civiltà il cambio linguistico da “direttore” a “direttrice”.
Insomma, per tutte quelle tardofemministe che hanno monopolizzato il tema dei
diritti delle donne in cartello ideologico. La domandina è davvero semplice:
qual è, oggi, anno del Signore 2021, la cultura che maggiormente opprime,
calpesta, nega i suddetti diritti delle suddette donne? La risposta fattuale,
faziosa quanto lo può essere la cronaca, quindi per nulla, è: la cultura
islamica. La quale non è un monolite, grazie, lo sappiamo perfino noi bavosi
fallaciani suprematisti, bensì un arcipelago di esegesi teologiche, pratiche di
culto, Stati più o meno confessionali (nessuno comunque basato sulla
contrapposizione nitida tra “cioè che è di Cesare e ciò che è di Dio”, che del
resto sta in un altro testo sacro, non nel Corano), rami che divergono tra loro,
gruppi, gruppuscoli e perfino cellule terroristiche (di rado nel mondo si uccide
urlando “Buddha è grande!”, e di nuovo non è colpa dello scrivente). Ma alcuni
dati di fondo pur esistono, e paiono costituire una trave nell’occhio altrui,
mentre ci intratteniamo a sezionare la pagliuzza nostrana, le desinenze, i
suffissi, le quote-ghetto. C’è quel lievissimo particolare della “Dichiarazione
islamica dei diritti dell’uomo”, una versione della Dichiarazione universale
modificata da molti Paesi musulmani, tra cui Arabia Saudita e Iran, perché fosse
compatibile con la sharia (quindi a tutti gli effetti un ossimoro). Che infatti
alla voce famiglia e matrimonio riprende una Sura: “Le donne hanno dei diritti
pari ai loro obblighi, secondo le buone convenienze. E gli uomini hanno tuttavia
una certa supremazia su di loro”. Ci sono le concrete condizioni di vita delle
donne sotto le varie cappe teocratiche islamiche, un calvario del diritto e
della morale (almeno così come abbiamo pensato questi due aggeggi noi sporchi
occidentali) quotidiano, chiedetelo alle splendide eroine iraniane che
ciclicamente si liberano del velo in pubblico sfidando il totalitarismo omicida
degli ayatollah in nome della libertà del corpo (e che le nostre varie Bonino,
Mogherini, Serracchiani hanno insultato ogni volta che si si sono recate velate
e ridanciane in visita diplomatica a Teheran), chiedetelo alle saudite che
rischiano la lapidazione per adulterio o la decapitazione per stregoneria,
chiedetelo alle yazide per anni schiavizzate e cosificate dalle bestie
dell’Isis. Ci sono simpatiche consuetudini del “diritto” islamico, per cui la
testimonianza di un uomo vale come quella di due donne, il marito può ripudiare
la moglie anche senza ricorrere a un tribunale in presenza di due maschi, la
donna non può sposare un non musulmano a meno che questi non si converta. C’è il
doppiopesismo istituzionalizzato della poligamia consentita e incentivata, a
fronte ovviamente della poliandria proibita. C’è quella maledetta aritmetica,
che racconta come il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e quello
delle spose-bambine siano maggiormente diffusi in Paesi in cui l’Islam è
religione ufficiale, o comunque fortemente radicato (tra i primi posti di queste
tetre classifiche Somalia, Guinea, Egitto, Niger, Sudan, Bangladesh). C’è il
tema enorme del velo integrale, mortificante e sessuofobo, quello “stupido
cencio medievale” che Oriana gettò in faccia all’ayatollah Khomeini, e che in
questi giorni è stato bandito per legge in Svizzera, che non risulta una landa
di estremisti neonazi. Allora la domanda, care professioniste permanenti dell’8
marzo a colpi di tweet e mimose, non può che suonare: perché tutto questo
corrisponde a un gigantesco rimosso, anzitutto da parte vostra? Perché infierite
sulla Treccani, e non nominate mai il Corano?
Francesco Olivo per “La
Stampa” l'8 marzo 2021. Con il volto coperto dalle mascherine gli svizzeri hanno
deciso che non si può andar in giro con la faccia occultata. Il referendum di
ieri non aveva nulla a che fare con le misure anti Covid, l'obiettivo era
piuttosto il cosiddetto «estremismo islamico». Da oggi niente passamontagna o la
bandana, ma nemmeno il velo integrale. Un modo per contrastare la criminalità,
secondo le associazioni che hanno proposto il quesito, ma anche e soprattutto un
modo per scatenare un dibattito identitario. Il referendum proposto da partiti e
organizzazioni conservatrici è stato letto (e raccontato) come un attacco
«all'Islam radicale». Il quesito ufficiale, «sei favorevole al divieto delle
coperture totali del viso?», non menzionava esplicitamente burqa o niqab. Ma in
campagna elettorale si è capito dove andava a parare il dibattito. Da una parte
i difensori del multiculturalismo, a sostegno del No, dall'altra i proponenti
che invitavano a votare Sì, in nome non solo della sicurezza, ma soprattutto a
difesa «dell'uguaglianza e delle libertà delle donne sottomesse
dall'estremismo», tanto che la legge proposta è stata ribattezzata «anti burqa»
e anche alcune associazioni femministe si sono aggiunte ai comitati per il Sì.
Se i termini della questione non fossero stati abbastanza espliciti ci hanno
pensato i manifesti elettorale a chiarirli: una donna coperte integralmente con
accanto lo slogan: «Fermare l'estremismo», islamico, va da sé. Il governo
federale si era schierato per il No, anche perché si tratta di situazioni
marginali. È rarissimo, infatti, in Svizzera incontrare donne che coprono
integralmente il volto e spaccare il Paese in un dibattito identitario per poche
centinaia di persone è sembrato a molti una mossa propagandistica della destra,
visto che, sempre ieri, si votava per le elezioni amministrative. Alcuni
cantoni, come il Ticino, già dal 2016 aveva adottato una misura simile e in
cinque anni le forze dell'ordine sono dovute intervenire assai di rado, in meno
di 30 casi, secondo i media locali. Ma il dibattito è andato al di là dei casi
concreti e ha investito il modello multiculturale, con argomenti, pro e contro,
già ascoltati in altri Paesi, anche confinanti, come l'Austria e la Francia,
dove in questi mesi il presidente Emmanuel Macron ha lanciato la sua battaglia
contro quello che ha definito il «separatismo islamico». Misure simili sono in
vigore anche in Belgio e Bulgaria. Il divieto prevede che nessuno possa coprirsi
il viso completamente in pubblico, sia nei negozi che all'aperto. Sono previste
eccezioni per i luoghi di culto e ovviamente nell'ambito privato. Il bando
prevede anche un'eccezione anche per «il carnevale». Visti i tempi, il
legislatore ha dovuto subito chiarire che le mascherine anti virus non sono
incluse nel divieto.
Vittorio Feltri per “Libero
quotidiano” l'8 marzo 2021. Ormai i concetti e le idee contano meno delle parole
che ne esprimono il senso. Se dici negro invece che nero sei un razzista, mentre
i due vocaboli sono sinonimi. Se dici zingaro invece di rom sei un farabutto
indegno di vivere nel consorzio civile. E non parliamo degli uomini che amano
andare a letto tra di loro: un tempo erano definiti culattoni, checche,
finocchi, invertiti, pederasti, froci. Oggi tutte queste parole sono severamente
vietate. Un giornalista che si esprimesse con uno di questi termini verrebbe
fucilato dall' Ordine professionale più conformista d' Italia, oltre che più
inutile. I soli sostantivi ammessi sono gay (inglese) e omosessuale. La guerra
al dizionario della nostra ricca lingua è stata vinta dai sacerdoti del
politicamente corretto e per noi poveri tapini non c' è verso: siamo stati
sconfitti e ci tocca adeguarci al nuovo misero lessico o tacere. Dovremo
rassegnarci. Un tempo, anche abbastanza recente, la Crusca prendeva atto che la
lingua nasceva dal popolo e la codificava secondo criteri culturali, senza
dimenticarne l' origine. Oggi anche l' Accademia si assoggetta ai gusti dei
progressisti, ai quali peraltro si inchina chiunque per fare bella figura con i
propri simili, ignoranti compresi, assai numerosi. In questa assurda polemica le
persone normali, che parlano come mangiano, di norma bene, sono soccombenti.
Senza contare che la lite si è arricchita di un altro tema caro alla ex
presidente della Camera, Boldrini, la quale raccomanda di femminilizzare la
denominazione dei mestieri. L' ultimo scontro a questo proposito è avvenuto
durante il festival di Sanremo allorché una signora, Beatrice Venezi, per altro
abile, si è chiamata direttore d' orchestra anziché direttrice. Capirete che
dramma. La donna è stata massacrata: doveva definirsi direttrice d' orchestra
per compiacere non solamente la Boldrini, ma anche tutti coloro - troppi - che
la pensano come lei, trascurando che l' idioma è un elastico adattabile alla
persona che lo utilizza, riferendosi alla tradizione, al costume familiare. Il
bisticcio che ne è derivato ha assunto connotazioni comiche, dato che da sempre
ciascuno parla come cacchio gli pare. Perfino un commentatore del Corriere della
Sera, Giuseppe Antonelli, si è inserito nel dibattito futile asserendo in forma
professorale che si dice direttrice e non direttore. Magari non ha tutti i
torti, ma dovrebbe sapere che la consuetudine, sorella dell' abitudine, fa
premio sulle pedanterie tardofemministe. Cosicché gli segnalo una piccola cosa:
a dirigere la Nazione di Firenze, quotidiano storico, c' è una ragazza abile:
Agnese Pini. Nella gerenza del foglio è scritto il suo nome alla voce direttore
responsabile. E allora perché è vietato affermare che Beatrice Venezi è un
direttore d' orchestra?
Laura Boldrini, Dagospia a
valanga: "Dopo il caso Venezi a Sanremo, come la mettiamo col vicequestore
Lolita Lobosco?"
Libero Quotidiano l'08 marzo 2021. “E ora, dopo il caso-Venezi,
come la mettiamo con il vice questore Lolita Lobosco?”: è questa la domanda che
si pone uno dei lettori di Dagospia. Il riferimento è a Beatrice Venezi,
co-conduttrice di una delle serate del Festival insieme ad Amadeus, che ha
spiegato di voler essere chiamata direttore d’orchestra e non direttrice. Da
quel momento in poi polemiche a valanga. A intervenire sulla questione qualche
giorno fa anche Laura Boldrini, che anni fa – da presidente della Camera – si
battè proprio per lanciare i mestieri declinati al femminile. La deputata dem ha
rimproverato la Venezi, invitandola a riflettere sui sacrifici delle donne.
Adesso, però, la regola dovrebbe valere per tutti. “Urge una reprimenda della
Boldrinova alla Rai e un invito perentorio a correggere l'ultima puntata della
fiction prima di mandarla in onda domenica”, continua il lettore nella sua
ironica lettera a Dagospia. Allora bisognerebbe scegliere, prosegue il lettore,
tra vice questora e vice questuressa. Nella lettera, tra l’altro, si parla della
necessità di una consulenza dell’Accademia della Crusca, che potrebbe aiutare a
scegliere il termine più adatto. Anche in questo caso c’è un riferimento
ironico alla Boldrini che, rimproverando la Venezi, ha detto: “Inviterei la
direttrice Venezi a leggere cosa dice l'Accademia della Crusca, la più alta
autorità linguistica del nostro paese. Se il femminile viene nascosto, si
nascondono tanti sacrifici e sforzi fatti”.
Mamma lavoratrice. E papà
lavoratore?
Serena Coppetti l'8 marzo 2021 su Il Giornale. Mentre mi scorrono nella testa i
fiumi di parole e righe di giornali e interviste e controinterviste su quanto
sia opportuno e giusto e offensivo e antistorico oppure, viceversa, inutile e
paradossale (e potrei andare avanti senza un punto e una virgola per righe e
righe anche io ma sono già senza fiato…) che un direttore d’orchestra donna
possa chiamarsi (non “essere” ovviamente) direttrice, tanto che alla fine mi
sembra che abbiano ragione e un po’ torto tutti, non so più se devo stare
attaccata e ben salda al gambetto di quella «a» o lasciarmi scivolare giù, su un
altro piano, più terra terra, diciamo. Sto lì, aggrappata a quella lettera
scivolosa, cercando appigli più forti a destra e a manca, cioè a sinistra, dove
troneggiano donne e pure uomini con le idee chiare, chiarissime, senza un
dubbio, una sfumatura, sicuri e convinti che di quella «a» non si possa fare a
meno (sinistra) oppure proprio non serva (destra). Per l’appunto, avendo tre
figli, due femmine ma soprattutto un maschio, non vorrei mai pentirmi di aver
perso quell’aggancio al gambetto così importante per la parità di genere con
conseguenze disastrose come mi terrorizzano a sinistra. Così chiacchieriamo e
richiacchieriamo su questa parola e sulle altre, sul perché si possa dire
giornalista e pilota e astronauta senza che schiere di uomini alzino le
barricate al grido di «giornalisto» «piloto» e «astronauto». Ascolto chi ne sa
parecchio, quelli che hanno studiato la lingua e spiegano che ci sono parole e
parole. Non si deve confondere. Ci sono quelle puoi trasformare e quelle che
invece no. Parole e parole. E parole e parole. E parole e parole. Poi tutte
queste parole cariche di grandissimo o nessunissimo significato, si schiantano
con violenza contro altre parole. E lì mi areno. Con una domanda. Ha senso
spendere fiumi di inchiostro e di pensiero sul direttore/direttrice quando non
ci preoccupiamo mai, neppure minimamente di riflettere sul fatto che
pronunciamo tutti e con grandissima scioltezza le parole «mamma lavoratrice»?
Sono una mamma lavoratrice. È una mamma lavoratrice. Lo dicono gli uomini, lo
dicono le donne, lo diciamo noi di noi stesse. Per dire che siamo uno e l’altro
dobbiamo specificare. Dobbiamo assemblare e già dà l’idea di un’architettura che
richiede un certo studio per stare su. Ma quante volte avete mai sentito dire a
un uomo Sono un papà lavoratore? Quante volte è stato necessario che un uomo si
qualificasse come papà lavoratore? E in qualche modo giustificarsi per esserlo?
Sei un papà lavoratore? E come fai? Che orari fai? Ma riesci? Tutte domande che
fatte alla mamma lavoratrice improvvisamente acquistano significato. Papà
lavoratore sì che suona male, anzi malissimo anzi non suona proprio in un mondo
dove non ha senso dire papà lavoratore ma invece ne ha eccome «mamma
lavoratrice». Noi ne andiamo orgogliose di definirci così e di esserlo. E
vogliamo esserlo, ogni giorno combattiamo per esserlo. Ma se ragioniamo di
parole, pure e semplici parole, allora mettiamole insieme al papà lavoratore.
Due parole. Due mestieri. Due missioni. «Due» che devono diventare una cosa
sola. Ecco perché (ma me ne rendo conto solo ora… ) quando ho scritto la
descrizione del «perché faccio questo blog» ho scritto mammalavoratrice tutto
attaccato. La riporto qui sotto:
… Eccomi: “YO”, con la “Y”
invece della “I”, con l’incognita irrisolvibile. Espressioni di vita che non
quadrano quelle delle mammelavoratrici, che siano al quadrato, al cubo o anche
semplicemente “alla prima” (figlia o figlio). Mammelavoratrici, comunque, tutto
attaccato perché ogni giorno non si sa dove comincia l’una e finisce
l’altra. Ogni giorno è una scommessa che mi sembra regolarmente di
perdere…Quindi, per concludere, rimarrò a rimuginare senza approdare credo da
nessuna parte tra il direttore e la direttrice ma in questa giornata di festa
della donna mi piacerebbe che ragionassimo comunque meno di parole e più di
fatti. Perché dentro la parola donna c’è già magari la mammalavoratrice tutto
attaccato così come in un uomo il papàlavoratore. E quindi parlando di
fatti, cliccate qui «Femministe, come liberarsene», i consigli non richiesti
(ma essenziali) della mia bravissima collega Gaia Cesare sul suo blog qui
sul Giornale.it. Repetita iuvant e lei lo ha ripetuto benissimo. Invece il mio
consiglio non richiesto è un libro. Si intitola «Il silenzio delle ragazze» lo
ha scritto Pat Barker storica americana. Racconta la guerra di Troia vista da
Briseide, la schiava di Achille. L’altro modo di guardare la storia, quella
epica, grandiosa. Quella dove le donne erano trofei e premi. Per cambiare il
punto di vista perché guardare le cose da un’altra parte è sempre un buon
esercizio.
Benedetta Perilli
per repubblica.it il 5 marzo 2021. Lo sapevi che la versione della Treccani
online indica nel dizionario dei sinonimi, in riferimento alla parola "donna",
eufemismi come "buona donna" e sue declinazioni come "puttana", "cagna",
"zoccola", "bagascia", e varie espressioni tra cui "serva"?". Inizia così la
lettera che l'attivista Maria Beatrice Giovanardi, insieme a cento persone del
mondo della politica, della cultura, della linguistica e della finanza come
Laura Boldrini, Michela Murgia, Imma Battaglia, Alessandra Kustermann ma anche
la vice direttrice generale Banca d'Italia Alessandra Perrazzelli, indirizza
all'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani per
chiedere la modifica della voce. Più inclusiva, meno sessista, più aderente al
ruolo della donna nella società, più paritaria perché "allo stesso tempo, l'uomo
è definito come "essere cosciente e responsabile dei propri atti", "uomo
d'affari", "uomo d'ingegno", "uomo di cuore" o "uomo di rispetto"", si legge in
un altro estratto della lettera. A promuovere l'iniziativa è la manager italiana
Giovanardi che lo scorso novembre si era distinta per aver convinto, dopo una
campagna durata quasi un anno e una petizione con oltre 35mila firme, il
prestigioso vocabolario inglese Oxford Dictionary a eliminare i riferimenti
sessisti dalla definizione della parola woman. Dopo la vittoria ottenuta nel
Regno Unito, dove la 29enne vive, un primo tentativo viene avviato anche in
Italia con l'invio di una richiesta di revisione alla Treccani. L'enciclopedia
risponde, con un intervento nella sezione dedicata alle domande del sito
ufficiale e aggiungendo alcune righe alla voce online. Una richiesta, dicono,
"che ci pungola a rivedere con attenzione quanto abbiamo scritto" ma che non può
essere accolta perché il dizionario deve registrare l'evoluzione della lingua
senza censura e specificando, dove necessario, il livello (ovvero se volgare,
spregiativo, eufemistico), pur considerando "il marchio misogino che, attraverso
la lingua, una cultura plurisecolare maschilista, penetrata nel senso comune, ha
impresso sulla concezione della donna". Non abbastanza per Giovanardi che torna
alla carica con la lettera aperta e le sue cento firme, grazie all'aiuto di un
team composto da cinque attiviste, e spiega: "Donna è il 50% della popolazione,
continuo perché la voce rimane non corrispondente alla realtà e poiché reputo la
risposta dell'Istituto civilmente non esauriente. Anche in Inghilterra
dall'Oxford hanno risposto rivendicando l'aspetto descrittivo ma hanno poi avuto
il coraggio di essere autocritici, e non autocratici". Dal fronte Treccani Luigi
Romani, responsabile sezione Lingua italiana, sull'avvio di una nuova iniziativa
da parte di Giovanardi commenta: "C'è un equivoco di fondo, si prendono come
sinonimi di donna i corredi sinonimici di alcune espressioni presenti nel
dizionario che non sono i sinonimi per Treccani. Volendo innescare polemiche che
non hanno fondamento si inquina la possibilità di avere una comunicazione
corretta". E sul perché al posto, o insieme, a "donna da marciapiede", prima
espressione che appare nella versione online, non trovino spazio espressioni
positive come "donna manager" risponde: "Donna manager non è una espressione che
può entrare nella voce sinonimi. Il corredo di espressioni sinonimiche è nutrito
e così rappresentato per ragioni non linguistiche ma di natura culturale". Ora
le 100 persone che firmano la lettera aperta, pubblicata in anteprima sul sito
di Repubblica, domandano a Treccani di ripensare la scelta sulla definizione del
sinonimo di donna eliminando "i vocaboli espressamente ingiuriosi" e "inserendo
espressioni che rappresentino, in modo completo e aderente alla realtà di oggi,
il ruolo delle donne nella società". Una richiesta che, secondo le persone che
sostengono la campagna tra le quali spiccano anche accademiche come Giuliana
Giusti, professoressa in glottologia di Ca' Foscari, Marica Calloni,
professoressa di Filosofia politica della Bicocca, Elena Ugolini, preside già
sottosegretario all'Istruzione del governo Monti, non è destinata a "porre fine
al sessismo quotidiano, ma potrebbe contribuire a una corretta descrizione e
visione della donna".
Da repubblica.it il 5 marzo
2021. Pubblichiamo la lettera indirizzata all'Istituto dell'Enciclopedia
Italiana Treccani per chiedere di eliminare i riferimenti sessisti che compaiono
nel sinonimo della parola "donna" della versione online del vocabolario. La
firmano cento persone, tra le quali Laura Boldrini, Michela Murgia, Imma
Battaglia, Alessandra Kustermann ma anche la vice direttrice generale Banca
d’Italia Alessandra Perrazzelli, più un gruppo di attiviste guidate da Maria
Beatrice Giovanardi, l'italiana che ha ottenuto che l'Oxford Dictionary
modificasse in chiave non sessista la definizione di "woman". Lo sapevi che la
versione della Treccani online (treccani.it) indica nel dizionario dei sinonimi,
in riferimento alla parola “donna”, eufemismi come “buona donna” e sue
declinazioni come “puttana", “cagna”, “zoccola”, “bagascia”, e varie espressioni
tra cui “serva”? Con queste espressioni associate al concetto di "donna" trovano
posto inoltre una miriade di esempi ed epiteti dispregiativi, sessisti, talvolta
coraggiosamente definiti eufemismi: “baiadera”, “bella di notte”, “cortigiana”,
“donnina allegra”, “falena”, “lucciola”, “peripatetica”, “mondana”,
“passeggiatrice”, e molti altri. Simili espressioni non sono solo offensive ma,
quando offerte senza uno scrupoloso contesto, rinforzano gli stereotipi negativi
e misogini che oggettificano e presentano la donna come essere inferiore. Questo
è pericoloso poiché il linguaggio plasma la realtà ed influenza il modo in cui
le donne sono percepite e trattate. Allo stesso tempo, l’uomo è definito come
“essere cosciente e responsabile dei propri atti”, “uomo d’affari”, “uomo
d’ingegno”, “uomo di cuore” o “uomo di rispetto”, etc...Brilla per assenza
qualunque espressione positiva che raffiguri la donna in modo altrettanto
completo e aderente alla realtà, come per la definizione di uomo: donna
d’affari, donna in carriera, etc…Inoltre l’assenza sotto la voce “uomo” di
parole quali “uomo violento”, “uomo poco serio”, “orco”, “ometto”, “omaccio”,
“omuccio”, “gigolò” rischia di apparire come un’incongruenza, se non addirittura
una discriminazione, a fronte del “dovere di registrare” e descrivere il
“patrimonio lessicale italiano” che la Treccani rivendica nel giustificare le
sue scelte. I vocabolari, i dizionari dei sinonimi e contrari, le enciclopedie
sono strumenti educativi di riferimento e la Treccani.it, in quanto tale, è
consultata nelle scuole, nelle biblioteche e nelle case di tutti noi. Ed è anche
una fonte linguistica italiana tra le più visibili. Chiediamo cortesemente
pertanto all’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
S.p.A. che:
in prima battuta elimini i
vocaboli espressamente ingiuriosi riferiti alla donna, limitandosi a lasciarli
sotto la lettera iniziale di riferimento;
inserisca espressioni che
rappresentino, in modo completo e aderente alla realtà di oggi, il ruolo delle
donne nella società.
Ciò non porrà fine al sessismo
quotidiano, ma potrebbe contribuire a una corretta descrizione e visione della
donna e del suo ruolo nella società di oggi. Le firme:
Maria Beatrice Giovanardi ed
il team della campagna: Alessandra Colonna, Denise Ottavi, Carlotta Fiordoro,
Cecilia Comastri, Azzurra Pitruzzella, Angela Cavezzan
Rachele Antonini,
professoressa, Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Università di
Bologna
Stefania Ascari, deputata e
avvocata
Raffaella Baccolini, docente,
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Università di Bologna, Forlì
Campus
Lucio Bagnulo, Head of
Translation, Amnesty International
Marcella Balistreri, Partner,
KPMG S.p.A.
Flavia Barca, componente del
Consiglio Superiore del Cinema, consulente Rai, esperta di politiche culturali,
economia culturale ed economia dei media
Stefania Bariatti,
professoressa di Diritto Internazionale Università degli Studi di Milano
Imma Battaglia, attivista
storica LGBTQ+
Massimo Bernardo, consulente
d’azienda
Maurizio Bernardo, consulente
d’azienda
Luca Bettonte, CEO ERG S.p.A.
Magda Bianco, capo
dipartimento Tutela e Educazione Finanziaria Banca d’Italia
Laura Boldrini, deputata, già
Presidente della Camera
Paola Bonomo, vice presidente,
Italian Angels for Growth
Marina Calloni, professoressa
ordinaria di Filosofia politica e sociale, Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale - Università degli Studi di Milano-Bicocca
Paolo Campinoti, presidente di
Confindustria Toscana Sud
Filomena Campus, artista e
accademica
Giuseppe Castagna, Ceo Banco
Bpm
Roberto Castaldi, direttore
Centro studi, formazione, comunicazione e progettazione sull’Unione europea e la
Global Governance (CesUE, spin-off della Scuola Sant’Anna di Pisa), Direttore
Euractiv Italia
Donatella Conzatti, senatrice
Cristina Corradini,
consigliere delegato di Fondazione Amplifon Onlus
Marcella Corsi, professoressa
ordinaria di economia politica, coordinatrice MinervaLab, Sapienza Università di
Roma
Antonia Cosenz, BANCO BPM
Legale E Regulatory Affairs
Ottavia Credi, ricercatrice
junior, Istituto Affari Internazionali (IAI)
Giuseppe Luigi Salvatore
Cucca, senatore
Marco Cucolo, imprenditore e
personaggio televisivo
Sara D’Amario, attrice e
scrittrice
Federica Dall’Arche,
ricercatrice, Istituto Affari Internazionali (IAI)
Monica De Virgiliis,
amministratrice indipendente Prysmian Group
Diana De Vivo, Senior
Stakeholder Engagement Executive Coordinator, NATO Communication and Information
Agency
Paolo Decker, imprenditore
Giovanna Declich, sociologa,
Conoscenza e Innovazione srls
Lory del Santo, attrice e
personaggio televisivo
Paola Diana, imprenditrice
Irene Facheris, formatrice,
scrittrice e attivista
Roberta Famà, Responsabile -
Comunicazione, Investor Relations & Regulatory Affairs, Banca Carige SpA
Elvira Federici, per il
direttivo della Società Italiana delle Letterate
Gabrielle Fellus, presidente
di I Respect
Ornella Ferrajolo,
ricercatrice, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Andrea Fey, notaio in Firenze
Elena Gallo, VP HR South
Europe & Middle East, VIACOM CBS Networks
Laura Garavini, senatrice
Nadia Ginetti, senatrice
Giovani Europeisti Verdi
Giuliana Giusti, professoressa
ordinaria in Glottologia e Linguistica, Dipartimento di Studi Linguistici e
Culturali Comparati, Università Ca' Foscari Venezia
Chiara Gribaudo, deputata
Leonardo Grimani, senatore
Gianluca Guaitani, CCO – Chief
Commercial Officer, Banca Carige SpA
Laura Guazzoni, docente,
Università L.Bocconi
Alessandra Kustermann,
ginecologa
Mauro Mancini, regista
Vincenza Marina Marinelli,
avvocata, Ordine degli Avvocati di Torino, già Ricercatrice confermata di
Diritto del Lavoro nell'Università La Sapienza di Roma e Consigliera di Fiducia
del Comitato Pari Opportunità dell'Ateneo
Fabrizio Marrazzo, portavoce
di Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale
Francesca Marrucci, assessora
Valorizzazione e Gestione Patrimonio Culturale, Turismo, Politiche Sociali, Pari
Opportunità, Politiche Giovanili e Comunicazione Comune di Pantelleria
Elena Mazzoni, segreteria
nazionale Rifondazione Sinistra Europea
Lea Melandri, scrittrice
Armando Meletti, Ceo/Country
Manager Italy, Esmalglass Itaca Group
Monia Monni, assessora
all'ambiente, economia circolare, difesa del suolo, protezione civile e lavori
pubblici della Regione Toscana
Angela Montanari, partner
YourGroup
Roberta Mulas, professoressa a
contratto, Dipartimento di Scienze Politiche, LUISS
Michela Murgia, scrittrice
Renata Natili Micheli,
presidente nazionale CIF Centro italiano Femminile Nazionale
Giovanna Paladino, direttore e
curatore del Museo del Risparmio
Alessandra Perrazzelli, vice
direttore Generale Banca d’Italia
Massimo Persotti, giornalista,
autore e conduttore di Salvalingua su Radio Radio
Valeria Picconi, Distribution
Excellence Officer AXA Partners
Maria Pierdicchi, consigliere
indipendente Autogrill, Unicredit e Presidente di Nedcommunity
Ilaria Pitti, ricercatrice,
dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, Università di Bologna
Riccardo Pittis, ex campione
italiano di basket
Emanuela Poli, direttore
generale di Confindustria Assoimmobiliare
Paola Poli, CEO Women Security
Barbara Pontecorvo, avvocata
Patrizia Pozzo, Press and
Media, Diem25 in Italia
Prime Donne, scuola di
politica di Piu’ Europa volta ad una maggiore partecipazione femminile in
politica
Annalisa Rabitti, assessora
alla Cultura, Pari Opportunità, Marketing territoriale e Città senza Barriere
del Comune di Reggio Emilia
Agostino Re Rebaudengo,
presidente di Asja Ambiente
Anna Maria Reforgiato
Recupero, Head of Strategic Investors Group Generali Investments
Cristina Rossello, presidente
di Progetto Donne e Futuro
Silva Rovere, presidente di
Woman Care e CEO di Sensible Capital
Paolo Sacco, COO – Chief
Operating Officer, Banca Carige SpA
Florinda Saieva, fondatrice di
Farm Cultural Park
Ingrid Salvatore,
professoressa associata, Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università di
Salerno
Daniela Sbrollini, senatrice
Toni Scervino, amministratore
unico Ermanno Scervino
Elly Schlein, assessora
regionale
Alessandra Scipioni, direttore
Commerciale di Assolombarda Servizi Spa
Claudia Segre, presidente,
Global Thinking Foundation
Catterina Seia, vice
presidente e Co-fondatrice della Fondazione Fitzcarraldo e Fondatrice di Acume
Anna Simone, sociologia
giuridica, della devianza e del mutamento sociale, Sociologia Generale
Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Roma 3
Manuela Soffientini, Managing
Director, Electrolux Appliances Spa
Alessia Sorgato, avvocata
penalista esperta di difesa di donne vittime di violenza
Michela Sossella, responsabile
- strategie Commerciali e Pricing, Banca Carige SpA
Maria Grazia Speranza,
presidente della International Federation of Operational Research Societies
Elena Sheila Speroni,
responsabile Comunicazione Biocell Center Spa
Nathalie Tocci, direttrice,
Istituto Affari Internazionali (IAI)
Elena Ugolini, preside Liceo
Malpighi di Bologna, già sottosegretario di stato all'Istruzione governo Monti
Viviana Valastro, esperta
diritti minori migranti
Francesca Vitelli, presidente
dell'associazione EnterprisinGirls
Gelsomina Vono, senatrice
Antonio Zappulla, manager e
giornalista
“Grombre”, il movimento al femminile che
esalta i capelli grigi. Roberto Vivaldelli su Inside
Over il 5 marzo 2021. Tinta, addio. L’ultima frontiera del
femminismo liberal contro l’odiata società patriarcale passa dal movimento
globale “Grombre”, fatto di donne che mostrano con orgoglio i loro capelli grigi
o bianchi. Nato come una piccola comunità su Instagram nel 2016, Grombre,
riporta il sito web di riferimento, è diventato un “vero e proprio stile di
vita”. “Crediamo che ci siano cose più importanti nella vita degli standard di
bellezza che alle donne vengono imposti per definire il loro valore, e stiamo
trovando la liberazione e il potere di vivere pienamente e celebrare le
complessità che ci rende belle in ogni stagione della nostra vita”. La
fondatrice del movimento è Martha Truslow Smith, una “creativa” di 28 anni che
nel 2016 ha deciso di non tingersi più i capelli e di aprire l’account Instagram
di Grombre. “Voglio sfidare il modo in cui pensiamo a ciò che consideriamo
"bello" e perché, e proporre di parlare di cose più importanti su cui spendere
il nostro tempo, energia e risorse preziose”.
“Orgogliose dei nostri capelli grigi”. Con più
di 200 mila follower su Instagram da tutto il mondo, Martha Truslow Smith è
riuscita a diffondere il verbo di Grombre in tutto il pianeta. Sull’account del
movimento vengono pubblicati i selfie delle donne che hanno deciso di non
tingersi più i capelli e le motivazioni che le hanno spinte a prendere questa
decisione: “Invecchiare con grazia non significa rinunciare a se stessi” scrive
ad esempio la signora Campbell. “Sto abbracciando la natura selvaggia che ho
trovato con i miei capelli grigi. Voglio anche mostrare alle mie figlie che a
volte inseguendo standard di bellezza non realistici, perdiamo. La vera bellezza
si irradia da una libertà che proviene dall’interno, e questa risplende più
luminosa quando impariamo ad abbracciare chi siamo veramente!”. “Ho deciso di
smettere di usare tutte le sostanze chimiche sui miei capelli circa 2,5 anni fa”
scrive un’altra utente. “È stata una delle migliori decisioni che abbia mai
preso. Amo semplicemente i miei capelli grigi naturali che fanno parte del mio
processo di invecchiamento. Sto abbracciando tutto ciò che viene con
l’invecchiamento. Amo l’eleganza del mio grigio, sono io”. In Italia chi
raccoglie lo scettro a diffondere il verbo della “grey revolution”, come viene
chiamata, è Ele Barante fondatrice del gruppo Facebook Silver sisters Italia,
che sta cercando di dare visibilità al movimento. Il confronto con gli uomini
non poteva passare inosservato. E c’è chi si chiede a tal proposito come mai gli
uomini “brizzolati” siano considerati “accettabili” ed eleganti le donne no. Lo
nota Igiaba Scego sul quotidiano Domani: “Pensiamo solo a George Clooney o a
Barack Obama. Capelli d’argento, fascino d’oro. Non si dice così? E infatti un
po’ tutti i ministri, chi più chi meno, primo ministro compreso, sfoggiano il
loro capello naturale. Il presidente della Repubblica poi li batte tutti, ha una
criniera candida come le nuvole del cielo. Bellissima. E molto regale. Spesso mi
ricorda il buon Gandalf de Il Signore degli anelli. Insomma il giuramento,
almeno la parte maschile di esso, è un trionfo di sale, di pepe, di nuvole e
panna montata. Ma una donna mi chiedo sarebbe definita bella se un po’
brizzolata?”. Il nemico – riprendendo gli slogan del femminismo anni settanta –
rimane sempre la società patriarcale che “opprime” la donna: “In fondo –
sottolinea Scego – il patriarcato si sconfigge unendo tanti punti, e portare in
giro la propria chioma grigia può essere un manifesto” osserva. In effetti, a
ostentare orgogliosamente i capelli bianchi tra le chiome ci avevano già provato
le femministe negli anni ’70.
Ma “Grombre” è anche business. La fondatrice del
movimento sembra essere però più pragmatica. Perché non capitalizzare tutta
questa visibilità internazionale? Consultando il sito di Grombre ci si imbatte
anche in una nutrita sezione “shop” – affiliata ad Amazon – tutta dedicata
alla vendita di prodotti e accessori: dai prodotti per capelli alle scarpe e
t-shirt passando per creme e profumi, e perfino i turbanti. Un vero e proprio
negozio che, precisa la fondatrice del movimento, “serve a sostenere il blog”.
Sarà anche così, ma quella di Martha Truslow Smith sembra non limitarsi ad
essere una battaglia di soli ideali ma anche una geniale mossa di marketing.
Sanremo 2021 e quel mazzolin di fiori.
Sembrava uno scherzo invece è una solida realtà: il
bouquet è una roba da donne. Beatrice Dondi su L'Espresso il 5 marzo 2021.
Sanremo, abbiamo un problema. Lo scorso anno, situato in quel passato remoto
altrimenti detto prima della pandemia, la polemica pre festival era stata tutta
sulle donne bellissime capaci di fare un passo indietro rispetto al loro uomo.
Si alzò un polverone sontuoso, al punto che il festival fu inzeppato oltre modo
di signore parlanti, monologhi contro la violenza, scarpette rosse, e altri
mirabili seppur zoppicanti sforzi di ammantare lo show con un abitino dal sapore
della parità. Insomma ci si era impegnati. Poi il festival ricomincia, edizione
2021, e lo sforzo per non sbagliare si sente, è palpabile, Fiorello e Amadeus
sono concentrati a non infilare la scarpa lucida nella pozzanghera del sessismo.
Ma non ce la possono fare, è più forte di loro. Gli esce spontaneo, provano a
reprimersi, a mordersi il labbro senza risultato alcuno. Così comincia il gran
valzer dei fiori. Solo alle donne, solo alle signore bellissime ed elegantissime
che quest'anno l'otto marzo è vicino e una mimosa tira l'altra. Agli uomini
invece no, che non sai quanto ci viene da ridere a vedere un maschio che stringe
quel mazzo colorato. Figuriamoci poi se si tratta di Ibra, che dall'alto dei
suoi due metri di calciatore riceve con un imbarazzo ai limiti del rumoroso
quell'oggetto del mistero e Fiorello ridacchiando si giustifica: «tanto non c'è
più il genere, siamo fluidi». E tutti in campo a tirare due calci al pallone,
per recuperare l’attimo di cedimento. Insomma, più che passo indietro il
problema è la fatica di farne qualcuno in avanti e si resta ancora fermi lì, al
rossore del macho. E mentre i cantanti scompigliano le carte, con Victoria dei
Maneskin che cede il suo mazzo a Manuel Agnelli, Francesca Michielin lo regala a
Fedez, Arisa a Michele Bravi e così via, i due conduttori si rasano in diretta e
i baffi cadono sul palco. Altro che petali, vuoi mettere?
Mauro Zanon per “il Giornale” il 31 gennaio 2021.
Quando pubblicò Il singhiozzo dell' uomo bianco, nel lontano 1983, alcuni dei
suoi ex compagni della gauche militante dissero che quel libro era «in odore di
razzismo», perché Pascal Bruckner, figura di spicco dei «Nouveaux philosophes»,
denunciava il sentimentalismo terzomondista che dominava in una certa sinistra e
l' autolesionismo di un' élite bianca consumata da un delirante odio di sé,
dall' idea che tutti i mali della terra trovassero origine in Occidente. Oggi,
nonostante le previsioni di Bruckner trovino sempre più riscontro nella realtà,
a colpi di strade sbattezzate, università «decolonizzate», statue abbattute e
libri censurati perché infarciti di «stereotipi razzisti», il filosofo francese
viene trattato come un «reazionario» irredimibile, un «vecchio maschio bianco
eterosessuale», nostalgico di un mondo che non esisterà più. Bruckner di questi
«marchi d' infamia» che gli vengono appiccicati addosso ne ha fatto un motivo di
fierezza, e combatte contro i suoi avversari con l' arma che sa utilizzare
meglio: la penna. Il suo recente Un coupable presque parfait. La construction du
bouc émissaire blanc (Grasset) - che non smette di far discutere - è il grido di
allarme di uno dei più lucidi intellettuali francesi viventi, che osserva
preoccupato la progressiva decadenza dell' Occidente e del progetto
universalista dei Lumi, a beneficio di una società tribalizzata in preda alla
lotta di generi, razze e comunità, dove l' uomo bianco è «il nuovo Satana». «Non
invoco la rivincita dell' uomo bianco, denuncio l' idea che sia considerato come
il capro espiatorio: il discorso femminista, antirazzista e decoloniale che
designa l' uomo bianco e la donna bianca come la fonte di tutte le disgrazie
dell' universo è un discorso semplicistico», ha dichiarato Bruckner a France
Culture. Il femminismo tradizionale era universalista, «il neofemminismo»,
invece, «è apertamente separatista, se non addirittura suprematista, e mette i
sessi l' uno contro l' altro», attacca il filosofo parigino, secondo cui «il
femminismo del progresso si è trasformato in un femminismo del processo». Un
esempio di questa tendenza è la recente esternazione della femminista radicale
Alice Coffin, autrice del libro Le Génie lesbien, che ha invitato le donne a
«eliminare gli uomini dalle nostre menti: non dobbiamo più leggere i loro libri,
né guardare i loro film, né tantomeno ascoltare la loro musica». Molte
neofemministe americane, a cui le colleghe francesi si ispirano, presentano l'
uomo bianco come uno «stupratore in potenza», ontologicamente predatore, dice
Bruckner, ma tacciono quando a macchiarsi di episodi di aggressione sessuale
sono le minoranze arabe e africane che vivono in Occidente, come è accaduto con
le violenze di massa del Capodanno di Colonia del 2016. Il neofemminismo va a
braccetto con il nuovo antirazzismo, che non ha nulla a che vedere con l'
antirazzismo originario, difensore di un' idea di umanità comune al di là della
diversità delle origini e delle culture. Il nuovo antirazzismo esaspera le
identità, si concentra sul colore della pelle e resuscita un concetto di razza
che si credeva abolito, creando le condizioni di un nuovo apartheid. «Oggi
vengono denigrati i volti di gesso, per celebrare gli altri colori della pelle
attribuendo loro tutte le virtù», spiega Bruckner. La nuova ideologia
antirazzista, dietro cui si nasconde un razzismo anti-bianco alimentato dalle
minoranze e un autorazzismo folle delle élite occidentali, si sta diffondendo in
tutti i settori della società francese. Delphine Ernotte, direttrice di France
Télévisions, ha dichiarato che nella tv pubblica del futuro «gli uomini bianchi
di più di cinquant' anni» avranno sempre meno spazio, a favore delle persone
figlie della «diversità». Sulla sua scia, anche il presidente della Repubblica,
Emmanuel Macron, ha dato prova di apprezzare certe idee di provenienza
americana. In un' intervista al settimanale L' Express di poche settimane fa,
Macron ha infatti evocato l' esistenza in Francia di un «privilegio bianco», uno
dei capisaldi del movimento Black Lives Matter. La frase ha fatto trasalire
Bruckner, perché «parlare di privilegio bianco significa risvegliare l' idea di
un peccato originale». In nome del multiculturalismo, l' Occidente sta
cancellando se stesso, la sua storia millenaria, i suoi capolavori, e l' uomo
bianco eterosessuale occidentale, ormai, «è in fondo alla gerarchia», afferma
Bruckner, prima di aggiungere: «Meglio essere scuri che pallidi, omosessuali o
transgender che eterosessuali, donne piuttosto che uomini, musulmani anziché
ebrei o cristiani, africani, asiatici e indigeni piuttosto che occidentali».
Secondo Bruckner, «l' unica identità che ai bianchi viene ancora concessa è
quella della contrizione. I professatori di vergogna, le neofemministe, i
decolonialisti e gli indigenisti dilagano, e ci invitano a pentirci». E ancora:
«È in corso una vasta impresa di rieducazione, all' università, sui media, che
chiede ai bianchi di rinnegare se stessi. L' ultima volta che abbiamo subìto la
propaganda razziale è stata con il fascismo negli anni Trenta: la scomunica a
priori di una parte della popolazione. Eravamo vaccinati, grazie. Ma ci torna
indietro da oltreoceano mascherata da antirazzismo, con nuovi protagonisti». I
nuovi fanatici della «cancel culture» che vogliono affossare l' Occidente. E l'
uomo bianco.
Nella neolingua femminista "man" è una
parolaccia. Gli uomini (fratelli compresi) diventano
prefissi dispregiativi. E chi non ci sta finisce... "incel". Giulia Bignami,
Sabato 30/01/2021 su Il Giornale. Se vi dicono che state facendo manspreading,
sapete di cosa vi stanno incolpando? E se invece vi accusano di bropriating,
avete idea di che cosa abbiate combinato? Se la risposta è no, allora questo è
il glossario di cui non sapevate di avere bisogno, ma di cui non potrete più
fare a meno. È il risultato di una lunga e sistematica ricerca che ho
intrapreso, con la mia mentalità scientifica, nel tentativo, quanto mai senza
speranza, di capirci qualcosa tra le nuove parole inventate in nome di una non
meglio specificata causa politicamente corretta o femminista, o tutte e due le
cose messe insieme. Alcune, molte, di queste parole sono partite come hashtag su
Instagram o Twitter per poi diventare dei trend e, di conseguenza, delle
battaglie fondamentali per l'umanità. Si inizia con manel, termine utilizzato
per definire un panel formato da soli uomini (men), neologismo diventato
bandiera di tutte le battaglie contro la discriminazione di genere nella scelta
dei partecipanti a giurie, comitati, gruppi o eventi in generale. Per quanto si
tratti di una giusta causa, bisogna stare attenti a non generalizzare e
specialmente a non perdere di vista il merito e l'uso del buon senso. Per
esempio, è inutile strillare contro i manel di oggi per poi rimanere del tutto
indifferenti, anzi accettare e andare a Milano nel refettorio di Santa Maria
delle Grazie ad ammirare uno dei manel forse più famosi della storia, dove il
direttore del comitato è lì a spezzare il pane e dispensare vino agli altri
dodici membri, tutti rigorosamente maschi. Almeno nell'Ultima cena sono tutti
seduti più o meno composti e non possono certo essere accusati di manspreading,
comportamento tipico di un uomo che allarga eccessivamente le gambe prendendosi
troppo spazio sull'autobus, sulla metro, in aereo, al cinema, a teatro o in
tutti i posti pubblici dove si sta seduti vicini, che sono in ogni caso dei
brutti posti perché è sempre meglio stare seduti lontani e in posti non
pubblici. Credo che però la pandemia abbia efficacemente risolto questo modo di
fare maschile, percepito come una barbarica invasione dello spazio vitale delle
femmine. Per quanto mi riguarda, purché venga mantenuto il distanziamento
sociale, gli uomini possono allargare le gambe quanto vogliono. (Non c'entra con
i femminismi, ma, a proposito di distanziamento, viaggiando da Edimburgo a
Milano, facendo scalo a Amsterdam, ho notato che la distanza raccomandata
diminuisce progressivamente da due metri nel Regno Unito, a un metro e mezzo in
Olanda, fino ad un metro in Italia, da cui si deduce scientificamente che la
gittata di starnuti e sputacchi si accorcia con la latitudine). Continuando con
il nostro glossario, finché un uomo, pur in un comitato e a gambe aperte, sta
zitto va ancora bene, è quando inizia a parlare che cominciano i problemi.
Manterrupting è l'atteggiamento arrogante di un uomo che interrompe una donna
mentre sta parlando e non lascia che finisca quello che stava dicendo. Di
solito, alla terza volta (le prime due do il beneficio del dubbio) che qualcuno
mi interrompe, maschio o femmina che sia, lo mando a quel paese e dico quello
che devo dire senza stare lì ad inventarmi una nuova parola per giustificare e
legittimare l'interruzione. Tuttavia, se perseverate con il manterrupting,
potreste finire con il fare mansplaining, cioè dare spiegazioni non richieste e
paternalistiche a una donna. Ritengo che la cosa più bella del mansplaining
siano le traduzioni italiane proposte, ne ho trovate almeno due: maschiarimento
oppure minchiarimento, un chiarimento, letteralmente, del cazzo. Qui il problema
mi sembra più sostanziale che sessuale e mi spiego con un esempio. Di questi
tempi ci ricordano spesso che è importante lavarci bene le mani, ma voi lo
sapete perché i saponi ci puliscono le mani? Ci riescono grazie a delle molecole
chiamate tensioattivi che, nella loro struttura, hanno una parte idrofila,
affine all'acqua, e una parte lipofila, affine ai grassi, cioè allo schifo vario
e eventuale. Grazie a questa particolare struttura, lo sporco, altrimenti
insolubile, viene inglobato, incapsulato e trasportato via sotto l'acqua e noi
rimaniamo con le mani pulite. Ecco, vi siete sentiti minchiariti o, meglio nel
mio caso, vaginaspiegati? No, perché è una spiegazione fatta con il cervello, un
brainsplaining (questa volta una parola nuova la invento io), che è l'unica cosa
che dovrebbe contare, a prescindere dal fatto che il cervello sia maschio o
femmina. Ma, continuando imperterriti nel vostro mansplaining, vi potreste
trovare anche a fare del bropriating (dall'inglese bro/brother, fratello, e
appropriating, appropriarsi), apparentemente una condotta molto comune
nell'ambiente di lavoro. Il bropriating succede quando un uomo si appropria
dell'idea messa a punto da una collega donna, come se ne fosse lui l'autore,
prendendosene il merito. Ancora una volta, io non trovo che sia necessario un
neologismo per questo comportamento, un uomo che si comportasse in quel modo con
me lo chiamerei semplicemente stronzo. Comunque, nel caso vi riconosciate in uno
o più dei comportamenti descritti fin qui allora sareste quasi sicuramente un
incel (involuntary celibate): trattasi, letteralmente, di un celibe
involontario, cioè di un esemplare appartenente ad un gruppo di maschi bianchi
misogini, narcisisti, frustrati, insicuri e con gravi problemi psicologici in
quanto non ricevono il sesso che credono di meritare. E qui niente, non vi posso
aiutare, sono cazzi vostri. Però, ora, con questo glossario essenziale, non
potrete più dire di non conoscere i neologismi femministi e se non vi piacciono,
amen, anzi no, adesso bisogna dire a-woman.
Francesco Olivo per "La Stampa" il 27 gennaio
2021. La battaglia culturale covava da anni ed è esplosa in periferia.
Un'anonima sala del consiglio municipale di Ciudad Lineal, circoscrizione a Est
di Madrid, si è trasformata nel cuore di un conflitto tra due visioni del mondo.
Al centro dello scontro, un murale che esalta il ruolo delle donne nella storia,
un'opera realizzata da un gruppo di artisti del quartiere, che la destra, su
proposta di quella estrema (Vox), ha deciso di cancellare, per contrastare
«l'ideologia di genere», scatenando le proteste dell'opposizione e di molte
associazioni. La contromossa del centrodestra è stato proporre la sostituzione
dell'opera con un omaggio agli atleti paralimpici. Diritti delle donne contro
quelli dei disabili. Una piccola vicenda locale, insomma, che simbolizza bene un
conflitto ormai permanente nella politica spagnola. Il murale di Ciudad Lineal
rende omaggio a 15 figure internazionali, che in tempi e modi molto diversi,
hanno lottato per l'uguaglianza di genere. Era il 2018, ultimo anno del Comune
di Manuela Carmena, ex magistrata eletta nelle liste vicino a Podemos, e i
personaggi da rappresentare erano stati scelti con una votazione dagli abitanti
del quartiere. Nell'opera compaiono figure molto diverse, fra le quali la premio
Nobel Rigoberta Menchú, l'attivista delle Black Panter Angela Davis, la
musicista Nina Simone, l'artista Frida Khalo, il simbolo della lotta alla
segregazione Rosa Parks. La polemica si è concentrata in particolar modo sulla
presenza di Liudmila Pavlichenko, cecchina dell'Armata Rossa, eroina della
Seconda guerra mondiale, invitata da Roosevelt alla Casa Bianca e sulla
comandante Ramona, un'indigena che guidò l'esercito zapatista del Subcomandante
Marcos. Scelte «troppo politicizzate» secondo la destra. Alla proposta di Vox
hanno votato sì anche il Partito Popolare e Ciudadanos, che insieme governano la
capitale spagnola, grazie all'appoggio dell'ultradestra. Il sindaco del Pp José
Luis Martinez-Almeida, alle prese con una nevicata storica, con un palazzo del
centro crollato, oltre all'emergenza sanitaria, forse avrebbe evitato questa
battaglia, ma alle fine ha assecondato gli alleati: «È stato democratico fare il
murale, ed è democratico rimuoverlo», ha argomentato, prima di passare
all'attacco del premier socialista, su un terreno più comodo per i popolari:
«Pedro Sánchez pensasse a rimuovere gli omaggi all'Eta sui muri dei Paesi
Baschi». Dietro al muro, quindi, c'è una battaglia culturale e più strettamente
politica. Il punto è che il femminismo in Spagna è diventato egemone, il governo
ne rivendica le battaglie («siamo un governo femminista» ripete spesso Sanchez),
con l'orgoglio di avere più ministre che ministri. La capacità di mobilitazione
dell'associazionismo femminile è potente, come in nessun altro Paese europeo
(per lo meno nel Sud del continente), le piazze dell'8 marzo sono sempre
stracolme e la lotta ai femminicidi (che continuano a essere molto numerosi)
coinvolge i cittadini: dopo ogni assassinio di una donna ci si riunisce davanti
al municipio per mostrare dolore e protesta. Insomma, il Paese dei diritti sta
vivendo un secondo tempo di una partita iniziata con il governo di José Luis
Rodriguez Zapatero, che portò avanti riforme molto audaci per un Paese cattolico
(matrimoni omosessuali, protezione dei trans, divorzio, aborto). Leggi che la
destra ha contrastato duramente con l'appoggio della Chiesa, salvo poi, una
volta tornata al potere, evitare di cancellarle. Secondo il politologo
dell'università Carlos III, Pablo Simón, «Vox ha bisogno di queste battaglie
simboliche perché in questo campo può fare concorrenza al Partito Popolare.
Quando poi si scatena la reazione della sinistra, a quel punto i populisti
ottengono il loro scopo: essere al centro della scena». L'ascesa rapida di Vox,
infatti, si spiega soprattutto come una reazione all'indipendentismo catalano e
all'egemonia del femminismo e più in generale alle politiche di parità di
genere. «La Spagna è cambiata molto in fretta - conclude Simón - e questo ha
lasciato il segno. Quelli che hanno vissuto durante il franchismo, convivono con
quelli che hanno lottato per i diritti dei trans». Ma non è solo Vox a criticare
«l'utilizzo di parte del tema femminista», secondo Cayetana Àlvarez de Toledo,
ex capogruppo del Partito Popolare al Congresso dei deputati, nota per le sue
battaglie a viso aperto, «la sinistra ormai non chiede l'uguaglianza, ma ci usa
per una squallida operazione politica. Identifica le donne con la sinistra e gli
uomini con la destra. E poi, arrogandosi il diritto di parlare a nome di tutte
noi, definisce gli uomini come artefici di un presunto sistema patriarcale,
capitalista e oppressore». No, non si tratta di un murale di periferia.
·
Le
Quote rosa.
Quote rosa, cosa sono e perché non
funzionano: i meccanismi beffa per le donne. Milena
Gabanelli e Simona Ravizza su Il Corriere della Sera il 28 marzo 2021. L’ha
detto Mario Draghi, chiedendo la fiducia al Senato lo scorso 17 febbraio: «Una
vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa
richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni
competitive tra generi». Lo prevede l’articolo 51 della Costituzione che dice:
«Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge». Ma l’aggiunta della frase «A tal fine la
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini», è arrivata il 30 maggio 2003, dopo un iter di quasi due anni, su
iniziativa dell’allora premier Silvio Berlusconi e dei ministri Stefania
Prestigiacomo e Umberto Bossi. Il neosegretario del Pd Enrico Letta ha appena
nominato una segreteria di otto uomini e otto donne e si è battuto per due donne
capogruppo alla Camera e al Senato. Ma l’introduzione degli «appositi
provvedimenti» non ha prodotto granché: il 3 novembre 2017, con l’approvazione
dell’attuale legge elettorale (il Rosatellum) vengono introdotte le «quote di
lista». Ebbene, l’analisi dei risultati delle elezioni Politiche del 2018 lascia
pochi dubbi: la parità formale è uno specchietto per le allodole. Ecco quali
sono i meccanismi che beffano le donne.
Candidature che penalizzano. In Italia votiamo con
un sistema misto. Il 37% dei seggi è assegnato con il maggioritario, dove vince
chi prende un voto in più (collegi uninominali). Mentre il 63% dei seggi è
distribuito con il proporzionale, ossia in base alle percentuali ottenute dai
diversi partiti (collegi plurinominali). Politiche 2018, Camera dei Deputati:
nei 232 collegi uninominali il 40% dei candidati di ciascuna coalizione deve
essere donna. Ai nastri di partenza le quote sono sempre rispettate, ma
all’arrivo la musica cambia, e i dati dimostrano che la scelta di candidare in
un collegio un uomo o una donna è un po’ studiata a tavolino.
I partiti, che i territori li conoscono bene visto
che i collegi sono di piccole dimensioni, tendono a candidare le donne dove
prevedono meno chance di successo. Infatti nel centrodestra su 139 candidati
uomini vincono in 72 (52%), mentre su 92 donne candidate le elette sono 39
(42%). M5S, 134 candidati uomini, eletti in 59 (44%); 98 candidate donne, elette
34 (34%). Centrosinistra candidati uomini 137, eletti 18 (13%); candidate donne
95, elette 8 (8%). Significa che un candidato uomo dei due schieramenti più
votati – il centrodestra e il M5S – ha il 10% di possibilità in più di essere
eletto rispetto alla candidata donna del suo stesso partito, e il 5% se è di
centrosinistra. Inoltre tra quelle che conquistano il seggio, il 25% lo fa per
il rotto della cuffia, mentre gli uomini eletti con un margine altrettanto basso
sono solo il 16%. Risultato: gli uomini eletti alla Camera sono 150 (65%), e le
donne 82 (35%). Se poi guardiamo i numeri di chi arriva secondo vediamo che gli
uomini sono 130, cioè meno di quelli che hanno vinto, e 106 le donne, ben di più
delle elette. Ma i «secondi» non vanno tutti a casa, perché c’è il ripescaggio,
e anche qui, come vedremo, è furbescamente organizzato a vantaggio degli uomini.
Collegi sicuri e paracadutati. In pratica ciò che
conta non è tanto l’essere uomo o donna, ma piuttosto quanto è blindato il
seggio per cui corri. Si salvano le candidate con peso politico. Mariastella
Gelmini trionfa nel collegio storicamente di centrodestra di Desenzano del Garda
con il 51,6% dei voti e un vantaggio del 30%. Idem Maria Elena Boschi a Bolzano,
forte dell’alleanza del Pd con la locale Svp, batte Micaela Biancofiore, che
però alla Camera entra comunque come capolista in un collegio plurinominale
dell’Emilia-Romagna. Infatti quando la situazione è incerta, il partito può
proteggerti candidandoti contemporaneamente anche nei collegi dove si vota con
il proporzionale, e se sei capolista il seggio è in pratica assicurato. Ma per
le donne i trattamenti di favore sono eccezioni. Prendiamo il collegio
uninominale di Scandiano (Reggio Emilia), uno dei più combattuti delle ultime
elezioni: lo vince la candidata di centrosinistra Antonella Incerti, che batte
Rossella Ognibene del M5S con uno scarto dell’1,2% e Maura Catellani del
centrodestra con uno scarto del 2,2%. La battaglia è difficile e tutte e tre
rischiano di andare a casa, però nessuna di loro viene candidata anche nel
proporzionale. Nel centrosinistra i paracadutati invece sono 12, di cui 10
uomini. Tra gli altri spiccano Dario Franceschini, l’ex ministro Marco Minniti,
Matteo Orfini, il figlio del presidente della Campania Piero De Luca, e l’ex
magistrato Cosimo Ferri, già membro del Csm.
Le sicurezze dei secondi in lista. Nei 63 collegi
plurinominali i seggi si ripartiscono in proporzione ai voti di ogni partito, e
per legge si hanno liste bloccate. Anche qui il 40% dei capilista deve essere
donna, con obbligo dell’alternanza di genere: se il capolista è un uomo, il
secondo è una donna e viceversa. Eletti 247 uomini (64%) e 139 donne (36%). Come
mai? Dove si confida di prendere molti voti capolista è una donna, poiché sono
alte le probabilità che entri anche il secondo in lista. Al contrario, se la
storia è incerta piazzi per primo un uomo: mal che vada viene eletto, e pazienza
se non si porta dietro la seconda. La prova, ancora una volta, nei numeri: su 38
eletti arrivati secondi nel centrodestra, 28 sono uomini e 10 donne. Un po’ più
equo il centrosinistra: su 24 eletti, 15 uomini e 9 donne. Per la parità di
genere il M5S: su 50, 26 uomini e 24 donne. Risultato: le donne in Parlamento
oggi sono 334, prima del Rosatellum 299. Solo 35 in più. Erano aumentate di 97
dal 2008 al 2013, quando le quote di lista non esistevano.
Le Regioni. Le Regioni hanno invece adottato le
quote di lista progressivamente dal 2009, in seguito ad un’altra legge
costituzionale del 2001, che inserisce nell’articolo 117 della Costituzione la
frase: «Le leggi regionali promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive». La prima a recepirla è la Campania (marzo 2009),
l’ultima la Calabria (settembre 2020). All’appello manca soltanto il Piemonte,
dov’è aperta la discussione. Inoltre, 16 hanno previsto la doppia preferenza di
genere: se vuoi dare due voti, i candidati devono essere di sesso diverso.
Questi meccanismi hanno contribuito ad aumentare la presenza femminile solo
nelle assemblee regionali dove le donne erano già superiori alla media.
Confrontando prima e dopo, in Emilia-Romagna le elette passano da 10 a 20, in
Toscana da 10 a 14, in Veneto da 11 a 18, ma in Basilicata si va da 0 a 1, in
Liguria addirittura diminuiscono, passando da 5 sono a 3 dopo le elezioni
regionali del 2020.
Il caso della Puglia. In Puglia il Consiglio
regionale si rifiuta di introdurre la doppia preferenza di genere, e così lo fa
d’imperio il Governo nazionale a luglio 2020 in vista delle elezioni di
settembre. L’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di origini
pugliesi, commenta così: «Oggi abbiamo scritto una nuova pagina nella storia
italiana dei diritti politici e, in particolare, dei diritti delle donne. Per il
Governo l’empowerment femminile è un imperativo morale, politico e
giuridico». Risultato storico? Dopo le elezioni di settembre le donne in
consiglio regionale pugliese passano da 5 a 7. Nei fatti, oggi in 13 regioni le
donne elette sono meno del 25%. (ha collaborato Alessandro Riggio)
·
Le donne di sinistra che odiano le
donne.
Marco Leardi
per davidemaggio.it l'1 dicembre 2021. Francesca Fagnani ha fatto la belva tra
le Iene. La giornalista, co-conduttrice per una sera nel programma di Italia1,
ha pronunciato ieri un monologo un po’ diverso da quelli a cui la trasmissione
aveva abituato il pubblico. Parlando dei diritti delle donne nel mondo del
giornalismo, anche alla luce del recente caso di Greta Beccaglia, Fagnani ha
svelato un retroscena televisivo che l’ha vista protagonista. “Una signora del
giornalismo non gradiva la mia presenza perché intorno a sé voleva solo colleghi
maschi”, ha raccontato la Iena per una sera, scatenando curiosità sull’identità
della donna. “Pochi giorni fa mi è successo qualcosa a cui non ero preparata:
sono stata invitata in una trasmissione dove c’era una donna che faccio perfino
fatica a definire collega, tanto è importante e prestigiosa e meritata la sua
carriera. Una vera regina del giornalismo. Ho sempre apprezzato le sue parole –
e ne ha spese tante – per chiedere posti di potere per le donne, però ho capito
che questo per lei vale solo se quei posti sono lontani dal suo. Infatti, alla
vigilia della trasmissione, mi hanno fatto sapere che questa signora del
giornalismo non gradiva la mia presenza perché intorno a sé voleva solo colleghi
maschi. Ma come? Proprio lei? La stessa donna che rimprovera agli uomini di non
darci lo spazio che meritiamo!” ha affermato Francesca Fagnani nel suo monologo
a Le Iene, senza però dare indizi sulla giornalista non sempre solidale con il
gentil sesso, anche se le “regine del giornalismo” alla guida di talk sono poche
e il nome più “quotato” sembra una donna de La7 che avrebbe avuto anche dissidi
con il fidanzato della Fagnani, Enrico Mentana. Denunciando l’ipocrisia che
spesso avvolge il tema dei diritti delle donne e della loro difesa, la
giornalista ha infine aggiunto: “La verità è che sul tema della parità anche noi
che facciamo informazione e che vogliamo insegnare agli altri come si fa, non
siamo meglio di loro”. Poco prima, iniziando il suo intervento, la stessa
Fagnani aveva portato all’attenzione alcune dinamiche del giornalismo
televisivo: “Negli ultimi anni ho visto accadere molte cose bizzarre nel mondo
del giornalismo: talk show dove il politico di turno può scegliere le domande e
scegliersi pure il giornalista che gliele fa, trasmissioni che ti invitano come
giornalista ma poi si aspettano che tu faccia l’ultras di Salvini, di Conte, di
Letta o di Draghi. Poi mi sono persino abituata alla domanda, dopo che si sono
decisi gli altri ospiti, ‘ma come donna chi invitiamo?”, come se fosse un
obbligo la quota rosa del talk. Una categoria da proteggere, come i panda”. A
febbraio, la giornalista tornerà in seconda serata su Rai2 con 10 nuove puntate
(e 20 interviste) del suo programma Belve.
Stefano Montefiori per
il "Corriere della Sera" il 24 ottobre 2021. «Ogni anno protestiamo contro
questo concorso che diffonde valori sessisti, ma non cambia niente. Abbiamo
quindi deciso di usare il diritto per fare avanzare la causa delle donne», dice
Alyssa Ahrabare, una delle portavoci dell'associazione «Osez le feminisme!».
L'avvocata Violaine De Filippis-Abate ha presentato una denuncia al collegio dei
probiviri del tribunale di Bobigny, per conto dell'associazione femminista e di
tre candidate respinte perché non rientravano nei criteri stabiliti degli
organizzatori. Il ricorso riguarda Endemol, che produce ogni anno la
trasmissione in onda sul primo canale Tf1, e la società Miss France. Il primo
obiettivo è che venga riconosciuto il carattere lavorativo della partecipazione.
Le ragazze «hanno il coraggio di mettere tra parentesi un mese e mezzo delle
loro vite», ha ammesso in un'intervista la stessa presidente di Miss France
Alexia Laroche-Joubert. Sono chiamate a fare molte prove, a sfilare, ballare,
provare i costumi, un impegno notevole non tutelato da alcun contratto di
lavoro. Poi c'è la questione dei criteri di accesso. «In base al regolamento,
una candidata deve essere alta almeno 1 metro e 70, non fumare né bere alcol in
pubblico - spiega l'avvocata di Osez le feminisme! -, avere un comportamento
"elegante", non avere tatuaggi più grandi di 3 centimetri, non fare ironia sulla
politica in pubblico». Infine non deve essere mai stata sposata e non deve avere
figli. Il concorso è stato fondato nel 1920 dal giornalista di origine belga
Maurice de Waleffe, che voleva premiare la «donna più bella di Francia» con
l'idea che «la scelta della maggioranza indicherà il tipo istintivo di una
nazione». Un secolo dopo la manifestazione è spesso occasione di polemiche -
come nel 2019 quando venne premiata la non magrissima polinesiana Vaimalama
Chaves - ma esiste ancora con ottimi ascolti (quasi nove milioni di
telespettatori nel dicembre 2020). La pur battagliera Marlène Schiappa,
all'epoca vice-ministra per la Parità uomo-donna, qualche anno fa ha difeso Miss
France: «È meno sessista della maggioranza delle pubblicità o dei reality», ma
ora «Osez le feminisme!» torna alla carica, e tenta l'attacco sul piano legale.
Secondo l'organizzatrice Alexia Laroche-Joubert «così si colpevolizzano le
ragazze, ma perché non dovrebbero avere il diritto di sognare? Perché togliere
loro la speranza di fare carriera?». Le tre ricorrenti chiedono un euro di
danni, il che rende ancora più evidente il carattere simbolico della denuncia.
Nel 2013 i probiviri accertarono l'esistenza di un legame di lavoro in un
concorso analogo, e accolsero il ricorso contro Mister France. Difficile negare
ora alle donne quel che è stato già riconosciuto agli uomini.
Perché una donna sceglie di stare
a destra. Francesco Maria Del Vigo e Domenico Ferrara
il 28 Settembre 2021 su Il Giornale. Pubblichiamo uno stralcio dal terzo
capitolo, dedicato agli anni Ottanta, di La donna s'è destra. L'altra storia
della cultura e della politica femminile italiana di Francesco Maria Del Vigo e
Domenico Ferrara. Per gentile concessione dell'editore Giubilei Regnani,
pubblichiamo uno stralcio dal terzo capitolo, dedicato agli anni Ottanta, di La
donna s'è destra. L'altra storia della cultura e della politica femminile
italiana di Francesco Maria Del Vigo e Domenico Ferrara. Il saggio (pagg. 228,
euro 17) è in libreria dal 25 settembre. Italia, 1988. Un anno prima della
caduta del muro di Berlino, due anni prima dell’implosione dell’Unione
Sovietica. Nel mondo si stava alzando un refolo di cambiamento che da lì a poco
sarebbe esploso in una tempesta che avrebbe lavato via tutte le scorie
dell’inizio del Novecento, ma in Italia era ancora tutto fermo: il clima per i
giovani di destra era sempre quello di vent’anni prima. Tutto doveva essere
conquistato, giorno per giorno, con tenacia, incoscienza e molta testardaggine.
Secondo alcune, quegli anni sono stati una sorta di naja, la costruzione di un
metodo – «nulla è dovuto, tutto va conquistato» – che poi utilizzeranno nel
corso delle loro carriere professionali o politiche. Ma il clima di caccia alle
streghe nei confronti delle donne di destra arriva, in modo meno violento ma
sempre insidioso, fino agli anni Duemila. «Io non ho vissuto ovviamente gli anni
di Piombo per questioni di età», racconta Chiara Colosimo, prima mi- litante di
Azione Giovani e ora consigliere regionale della Regione Lazio, «ma essendo
cresciuta nella sezione di Giorgia Meloni ho conosciuto i compagni. Parliamo dei
primi anni del Duemila, la Garbatella è l’unico municipio di Roma con otto
centri sociali, era un laboratorio politico di extraparlamentari di 75 sinistra.
Io ho iniziato a scuola molto presto, subito dopo la scuola sono andata alla
sezione di Garbatella e per un periodo ho fatto anche il segretario giovanile.
Ero in prima linea e ci sono stati diversi episodi di violenza. Una notte siamo
stati aggrediti e alcuni miei amici sono finiti al pronto soccorso. La sezione
era molto attiva, quando apriva, tutti i pomeriggi si trovavano scritte sopra la
serranda, il clima fino a sette-otto anni fa era molto diverso rispetto a quello
che succedeva nel resto della città e delle città». Altri tempi, certo. Ma
serpeggia sempre lo spettro dello scontro fisico, l’idea che impegnandosi
attivamente in politica si debba mettere in conto anche la violenza. A
quarant’anni di distanza da Acca Larenzia e dall’omicidio di Sergio Ramelli,
essere di destra può essere ancora pericoloso. A questo punto non si può evitare
un quesito: perché così tante donne, nel corso degli anni, hanno deciso di
schierarsi a destra, di imboccare la strada più scomoda, di rischiare di essere
sequestrate, insultate o più generalmente emarginate? Sicuramente hanno
contribuito la forza dell’ideologia, la spericolatezza dell’età, il gusto per il
rischio e un po’ di spirito da bastian contrario. Ma anche la fascinazione per
le proprie radici, il peccato originale di essere germogliati nel prato
sbagliato della storia del Novecento e di volerlo rivendicare con orgoglio. Il
mito 76 della Repubblica Sociale e i racconti delle rappresaglie partigiane a
guerra finita, il senso di vendetta per le ingiustizie che si riteneva di aver
subito, contribuiscono a consolidare un mondo a parte. Una società dentro la
società, che ha le sue regole, i suoi riferimenti culturali, i suoi linguaggi e
le sue liturgie. Un mito che rafforza la propria identità, ma che rischia di
trasformare il ghetto in una comfort zone dalla quale non è facile uscire. «La
forza ce la dava il fatto di credere fortemente in qualcosa, il senso di
cameratismo, ti sembrava di tradire i tuoi amici se anche tu ti fossi tirato
indietro, il fatto di essere attaccati in questo modo non faceva che convincerci
di più. A 20 anni hai il mondo in mano, ti senti immortale, c’è un coraggio
anagrafico e un coraggio di gruppo e poi la convinzione di essere sempre più
democratica a fronte dell’intolleranza insopportabile», rammenta Stefania
Paternò.
Francesco Maria Del Vigo. Francesco Maria Del Vigo
è nato a La Spezia nel 1981, ha studiato a Parma e dal 2006 abita a Milano. E'
vicedirettore del Giornale. In passato è stato responsabile del Giornale.it. Un
libro su Grillo e uno sulla Lega di Matteo Salvini. Cura il blog Pensieri
Spettinati.
La destra italiana? Parla
al femminile.
Eleonora Barbieri il 22 Settembre 2021 su Il Giornale. Idee,
lotte e vite delle donne "non di sinistra": spesso vituperate, tutt'altro che
irrilevanti. L'altra metà del cielo è facilmente divisa a sua volta. Succede
perfino nella lotta alla discriminazione, come dimostrano decine di polemicucce
trite, i j'accuse e l'indifferenza calibrati col bilancino, a seconda dell'area
di appartenenza. Donne, sì, ma non proprio tutte uguali... E, anche nella storia
del nostro Paese (o meglio, nella sua autorappresentazione politico/ideologica)
ci sono donne e donne, cioè donne di sinistra - portabandiera della narrazione
del femminismo e della battaglia femminile - e donne di destra - curiosamente,
quasi inesistenti o, se esistenti, da criticare. Eppure, le donne a destra ci
sono state, e ci sono, nel senso che nel corso del Novecento italiano è esistito
«un mondo femminile politicamente impegnato, culturalmente attivo e socialmente
partecipe» anche «al di là della sinistra», come raccontano Francesco Maria Del
Vigo e Domenico Ferrara in La donna s'è destra (Giubilei Regnani, pagg. 228,
euro 17; in libreria dal 25 settembre); in appendice al saggio, una intervista a
Giorgia Meloni, unica donna a capo di un partito nel nostro Paese. Una realtà
nonostante la quale, ancora oggi, molti e molte rimangono convinti che certe
battaglie siano appannaggio di una parte sola, quella «giusta», cioè la
sinistra. E basta. Certo, come spiegano Del Vigo e Ferrara, per molti anni la
destra ha proposto una narrazione di sé fatta di una «realtà virilmente
rappresentata dal corpo del capo, dall'epica delle marce e delle trincee, dallo
sforzo e dallo scontro fisico»; ma, dal Futurismo in poi, passando per Fiume, il
Ventennio e la Seconda guerra mondiale e, in seguito, attraverso la fondazione
dell'Msi, le battaglie degli anni Ottanta, la nascita di An e poi l'arrivo al
governo dopo il '94, a destra le donne hanno un ruolo, portano avanti le loro
idee e hanno vite a volte straordinarie (come Margherita Besozzi o Piera
Gatteschi), a volte terribilmente segnate dalla violenza, come accade negli anni
Settanta. Un capitolo, guarda caso, facilmente dimenticato...«Ci sono storie,
esperienze ed esistenze dimenticate per pigrizia, per indolenza, per il timore
di confrontarsi con un'idea differente dalla propria e poi magari scoprire di
avere qualcosa in comune» dicono gli autori e, forse, proprio queste cose in
comune sono quelle che incutono più timore, soprattutto sotto la stessa metà del
cielo. Invece sono storie che vale la pena (ri)scoprire. Eleonora Barbieri
Insulti, sputi, violenze,
sequestri e minacce. Così i "compagni" attaccavano le ragazze.
Francesco Maria Del Vigo e
Domenico Ferrara il 22 Settembre 2021 su Il Giornale. Le testimonianze
sconvolgenti delle giovani di destra negli anni Settanta. Per alcuni, gli anni
Settanta sono stati una scuola di vita: in quel periodo hanno gettato le
fondamenta del proprio futuro politico e hanno intessuto quella trama di
rapporti di amicizia e fratellanza che ancora oggi sussiste. Per altri, sono un
passato scomodo, magari rinnegato, del quale si preferisce non parlare. E anche
sulla violenza le testimonianze sono discordanti: c'è chi la ricorda come
un'esperienza necessaria, chi come una persecuzione e chi invece tende a
minimizzarla o a rimuoverla. Ma tutti tratteggiano un paesaggio fosco, nel quale
la caccia al camerata era tollerata, se non addirittura incentivata dai ceti
intellettuali dominanti. Alcuni diritti basilari, come il diritto allo studio o
il diritto di esprimere le proprie idee, erano di fatto sospesi per chi stava a
destra. Picchiare, sputare, insultare, sequestrare, svilire una donna di destra,
in alcuni contesti, era considerato normale. Lo ripetiamo: visto con gli occhi
di oggi sembra una follia. Ma stiamo parlando di un Paese nel quale i camerieri
si rifiutavano di servire un caffè a Giorgio Almirante perché fascista e nel
quale si sosteneva che «uccidere un fascista non è un reato». Questo è il
contesto, la cornice all'interno della quale si muovono le ragazze del Fronte
della Gioventù, del FUAN. Erano nel mirino perché chi vedeva nei giovani missini
un nemico da combattere pensava di stare lottando per la libertà. Nel nome della
quale credeva fosse legittimo utilizzare qualunque mezzo. Per calarsi in
quell'epoca bisogna rivedere il concetto di situazione di pericolo e, come
vedremo, non era necessario infilarsi in una manifestazione tra le croci
celtiche e le fiamme tricolori per finire nei guai. «Il clima terribile degli
anni di piombo registrava episodi di violenza persino nell'acquisto di un
giornale all'edicola se, per esempio, era una testata ritenuta di destra. Per
quanto mi riguarda, ricordo l'episodio di bullismo accaduto il giorno della
discussione della mia tesi di laurea su Ugo Spirito a Scienze Politiche con
relatore Augusto Del Noce. All'uscita della facoltà mi aspettavano un centinaio
di studenti di sinistra che pensarono bene di accompagnarmi in corteo, con tutta
una serie di insulti e cori non certo di simpatia, solo perché avevo trattato un
autore che non rientrava nei loro paradigmi. Alcuni anni più tardi anche sotto
all'ufficio spesso e volentieri mi ritrovavo scritte con il mio nome che mi
imputavano la responsabilità dei più efferati fatti di cronaca. Per non parlare
di altri episodi più gravi di discriminazione che mi sono accaduti addirittura
quando ero sul posto di lavoro e in gravidanza», ricorda Marina Vuoli, militante
e moglie di Teodoro Buontempo, storico esponente del MSI. Sembrano cronache di
guerra: centinaia di persone che accompagnano una ragazza nel giorno della sua
laurea solo perché ha trattato argomenti non di sinistra, intimidazioni,
insulti, minacce. E poi la discriminazione, un termine ancora oggi molto in voga
e, a volte, usato in modo improprio. (...) «Io mi sono reso conto della
pericolosità del periodo quando è morto uno della mia sezione, Acca Larenzia.
Quella è stata una tragedia, un evento che ha segnato la mia vita. È stato un
episodio di rottura, perché ti rendi conto che il contesto è drammatico e
tragico. Non c'era alcuna differenza tra ragazzi e ragazze. Anche le ragazze si
difendevano bene davanti alle manifestazioni non autorizzate e alle cariche
della polizia, però c'era una protezione fortissima da parte dei maschi. Erano
molto paterni, non le consideravano inferiori, nelle sezioni del MSI non ho mai
visto episodi di maschilismo esasperato», spiega Annalisa Terranova, ex
animatrice di Eowyn e del Centro Studi Futura, autrice del libro Camicette Nere
e poi redattrice del Secolo d'Italia, introducendo un duplice tema.
Innanzitutto, quello della tragedia, dell'evento drammatico che svela i rischi
che stanno correndo dei ragazzi in alcuni casi nemmeno del tutto consapevolmente
semplicemente facendo politica. E poi il tema della violenza che si abbatte in
egual misura e senza nessuna distinzione su ragazzi e ragazze. Una guerra
invisibile che si protrae per anni, nell'indifferenza generale. «Credo di poter
dire che quel periodo, dal secondo semestre del 1970 sino al 1980, fu
caratterizzato da un vero e proprio stato di guerra civile. Ricordo mio padre
che metteva i sacchetti di sabbia dietro la porta di casa per paura di incendi
dolosi. La caccia al fascista era diffusa nelle scuole, e all'università il FUAN
di fatto chiuse i battenti per qualche anno», racconta Andrea Augello, ex
militante del Fronte della Gioventù, poi saggista e parlamentare italiano.
Scegliere di stare a destra ed essere una donna, in quegli anni, significava
quindi imboccare una via in salita. E significava, soprattutto, scegliere la
strada della ghettizzazione e della marginalizzazione, perché l'etichetta, il
marchio a fuoco, era qualcosa che difficilmente si poteva cancellare. Entrando
in una sezione del Fronte della Gioventù o del FUAN, mettendo una firma su
quella tessera si entrava in un club esclusivo, ma al rovescio.
Francesco Maria Del Vigo è
nato a La Spezia nel 1981, ha studiato a Parma e dal 2006 abita a Milano. E'
vicedirettore del Giornale. In passato è stato responsabile del Giornale.it. Un
libro su Grillo e uno sulla Lega di Matteo Salvini. Cura il blog Pensieri
Spettinati.
Domenico Ferrara. Palermitano
fiero, romano per cinque anni, milanese per scelta. Sono nato nel capoluogo
siciliano il 9 gennaio del 1984. Amo la Spagna, in particolare Madrid. Sono
stato un mancato tennista, un mancato giocatore di biliardo, un mancato
calciatore, o forse preferisco pensarlo...Dal 2015 sono viceresponsabile del
sito de il Giornale e responsabile dei collaboratori esterni. Ho scritto "Il
metodo Salvini", edito da Sperling & Kupfer. Per la collana Fuori dal coro del
Giornale ho pubblicato: "Gli estremisti delle nostre vite"; "La sinistra dei
fratelli
Elvira Serra per il “Corriere della Sera” il 18
aprile 2021. «Schiaparelli? Ah! Quell' artista italiana che fa vestiti...».
«Chanel? È una noiosa piccolo borghese specializzata in cimiteri». Scambi di
affettuosità tra «colleghe», culminate una sera di luglio del 1939 al sontuoso
«Ballo della foresta», nella campagna di Mortefontaine dell' Alta Francia,
quando Gabrielle Bonheur Chanel, per tutti Coco Chanel, 56 anni, invita a
ballare Elsa Luisa Maria Schiaparelli, «la Schiap», vestita per l' occasione da
quercia surrealista, e la spinge graziosamente verso un candelabro da cui il
tronco dell' albero prende fuoco. Bastò una spruzzata di soda a spegnere l'
incendio, ma non la rivalità tra le due stiliste, che continueranno a detestarsi
fino alla morte: nel 1971 per Coco, due anni dopo per Elsa. Eppure sarebbero
potute essere amiche, mai più diverse, ma accomunate dalla stessa fame di
rivalsa, specchio reciproco nella continua gara di collezioni, profumi,
accessori, che identificavano sempre in maniera netta l' una e l' altra. La
sorellanza, questa sconosciuta, anche quando i vincoli di sangue dovrebbero
aiutare. E per certo fu un gesto molto amichevole la segnalazione al regista
George Cukor di Joan Fontaine in favore della sorella Olivia de Havilland per l'
immortale ruolo di Melania in Via col vento. Salvo non essersene pentita mai
abbastanza (di aver sbagliato il provino, ufficialmente). «Con la decisione di
diventare un' attrice, Joan ha rovinato la confortante intimità della famiglia»,
disse l' angelica Olivia, più grande di un anno. «Sono stata la prima a
sposarmi, la prima a vincere l' Oscar, la prima a diventare madre. Se mi
toccasse di morire per prima, l' avrò battuta anche in quello», chiosò Joan, che
in effetti anticipò la sorella nell' aldilà nel 2013, a 96 anni. Olivia morì nel
2020, a 104. A colpi di scoop si batterono Hedda Hopper e Louella Parsons,
stelle del gossip fino alla fine degli anni Cinquanta. Anche di loro la
scrittrice e giornalista Paola Calvetti racconta trionfi, invidie e miserie nel
suo Le rivali. Dieci donne di talento che hanno cambiato la storia , in libreria
da martedì con Mondadori (276 pp., 20 euro). «Louella Parsons è una cronista che
cerca di fare la pagliaccia», sparò una. «Hedda Hopper è una pagliaccia che
cerca di fare la cronista. Vuole fare in due anni quello che io sono riuscita a
fare in trenta», replicò l' altra. Si rincorsero a suon di esclusive,
contendendosi le confidenze delle star di Hollywood. Attrice mancata Hedda,
giornalista di costume affermata Louella, da un certo momento in poi le loro
penne si incrociano sul campo del pettegolezzo. Se Hedda ferma le rotative per
spifferare l' imminente divorzio di James Roosevelt, figlio maggiore del 32°
presidente degli Stati Uniti, Louella annuncia la scandalosa gravidanza di
Ingrid Bergman con Roberto Rossellini. La rivalità non ha risparmiato il mondo
del beauty. «Bella pelle, un bel collo, ma troppi colori in faccia per la sua
età!», sentenziò Helena Rubinstein sulla sua antagonista Elizabeth Arden. La
quale la liquidò con poche parole: «Quella donna spaventosa». Intraprendenti,
nate poverissime, perfino Franklin Delano Roosevelt le invitò alla Casa Bianca,
separatamente, per non fare uno sgarbo a nessuna, raccontando a entrambe lo
stesso aneddoto sulla soldatessa salvata al fronte che prima di un calmante
chiese il suo rossetto. «Eppure - scrive Calvetti - non si sono mai incontrate».
Restano le Divine del teatro: Eleonora Duse e Sarah Bernhardt, la prima di 14
anni più giovane dell' altra, ma determinatissima a emularne l' indipendenza. In
realtà tutte queste donne hanno superato soprattutto se stesse. Grazie alle loro
carissime rivali.
Da "il Giornale" il 9 marzo
2021. Quando si tratta di alzare l'asticella dello scontro con le altre donne,
nemmeno la scrittrice Michela Murgia ci va giù leggera. Nonostante sia una
femminista in prima linea, autrice di un libro uscito proprio ieri, intitolato
Stai Zitta, tutto a tema lotta al patriarcato e libertà delle donne. Sacrosanto.
Eppure anche la Murgia ha individuato nell'unica donna leader di partito,
Giorgia Meloni, un bersaglio perfetto. Così la leader di Fratelli d' Italia
diventava autrice di «squadrismo mediatico» nel 2019 per le critiche alla
direttrice artistica di un festival culturale de L' Aquila. E ancora, nello
stesso anno, diceva: «La Meloni usa il crocifisso e il presepe come corpi
contundenti». Con commenti sulla vita privata: «Questa è una donna che nella sua
vita personale ha fatto delle scelte che certamente non sono congruenti con
l'idea di famiglia cristiana». La Murgia nel 2014, dopo le elezioni regionali
sarde, riusciva a offendere le donne del Pd sardo e Daniela Santanché nella
stessa frase. Si diceva vittima di «livore e menzogne» da parte delle donne dem,
colpevoli di «aver idolatrato la Santanchè solo perché mi attaccava in
pubblico».
Le donne di
sinistra che odiano le donne.
Invocano parità e
solidarietà, ma sono pronte a demolire chi non la pensa come loro. Domenico Di
Sanzo - Mer, 10/03/2021 - su Il Giornale. Eccoli, i danni di alcune donne nei
confronti di altre donne. Da sinistra verso destra. Perché soprattutto in questa
direzione è concessa la «licenza di uccidere», dialetticamente e metaforicamente
si intende, i personaggi dello stesso sesso ma dello schieramento politico
opposto. E così, nella ricorrenza dell'8 marzo, da sinistra verso destra, non si
contano le aggressioni sguaiate, gli sfottò ai limiti del bullismo. Sempre in
questo senso di marcia parte la caccia alla donna non allineata, all'anomalia,
alla voce stonata. Addio al femminismo, bando anche alla cara vecchia
solidarietà femminile. In uno schema secondo cui gli avversari politici uomini
sono da colpire, ma le donne che la pensano diversamente devono essere fiaccate,
umiliate, aggredite. I bersagli di certa sinistra non cambiano. Da Mara Carfagna
a Giorgia Meloni, lo spartito è collaudato.
L'ultimo
bersaglio della Lucarelli: la Palombelli. Evidentemente non basta essere
chiamata «Vacca» o «Scrofa» per ottenere la solidarietà di Selvaggia Lucarelli
(nella foto). Ne sa qualcosa Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Dopo
gli insulti che le sono piovuti addosso dal professore universitario Giovanni
Gozzini sembrava che proprio tutti e tutte fossero d'accordo nel condannare
l'accaduto, esprimendo di conseguenza solidarietà alla Meloni. Invece no.
L'unanimità è una chimera per la donna di destra. La Lucarelli non se la sente
di solidarizzare. «Non esprimerò alcuna solidarietà a Giorgia Meloni. E non la
esprimerò nonostante mi faccia orrore il linguaggio del professore Giovanni
Gozzini», ha scritto su Facebook la giornalista dopo aver appreso la notizia. E
perché mai? Niente solidarietà a «chi ha fatto dell'intolleranza e della
divisione il suo credo politico». Inconcepibile la solidarietà, se l'altra donna
la pensa in modo diverso. Violenta anche la critica a Barbara Palombelli. La
firma del Fatto ha definito «imbarazzante» il monologo sanremese della
giornalista Mediaset in un articolo sul giornale online Tpi. Un lungo sfottò,
non privo di attacchi personali e colpi bassi sferrati alla Palombelli.
Murgia, la
scrittrice che detesta la destra "rosa". Quando si tratta di alzare l'asticella
dello scontro con le altre donne, nemmeno la scrittrice Michela Murgia (nella
foto) ci va giù leggera. Nonostante sia una femminista in prima linea, autrice
di un libro uscito proprio ieri, intitolato Stai Zitta, tutto a tema lotta al
patriarcato e libertà delle donne. Sacrosanto. Eppure anche la Murgia ha
individuato nell'unica donna leader di partito, Giorgia Meloni, un bersaglio
perfetto. Così la leader di Fratelli d'Italia diventava autrice di «squadrismo
mediatico» nel 2019 per le critiche alla direttrice artistica di un festival
culturale de L'Aquila. E ancora, nello stesso anno, diceva: «La Meloni usa il
crocifisso e il presepe come corpi contundenti». Con commenti sulla vita
privata: «Questa è una donna che nella sua vita personale ha fatto delle scelte
che certamente non sono congruenti con l'idea di famiglia cristiana». La Murgia
nel 2014, dopo le elezioni regionali sarde, riusciva a offendere le donne del Pd
sardo e Daniela Santanché nella stessa frase. Si diceva vittima di «livore e
menzogne» da parte delle donne dem, colpevoli di «aver idolatrato la Santanchè
solo perché mi attaccava in pubblico».
Venezi, il
"direttore" mobbizzato dalle femministe. «Direttrice d'orchestra? No, chiamatemi
direttore». È bastato poco per far scoppiare il pandemonio al Festival e fuori.
Galeotta Beatrice Venezi (nella foto), che sul palco dell'Ariston ha
specificato: «Per me quello che conta in realtà è il talento, la preparazione
con cui si svolge un determinato lavoro, la posizione, il mestiere ha un nome
preciso, e nel mio caso è quello di direttore d'orchestra». Frasi semplici,
forse addirittura banali, seguite dall'ennesimo dibattito monstre sulle
desinenze femminili. Parole che bastano a far percepire la Venezi come una voce
fuori dal coro. Ed ecco le reazioni. La solita Lucarelli le ha ricordato che «da
donna avrebbe pulito gli spartiti anni fa». Più soft all'inizio Laura Boldrini,
che ha invitato il direttore d'orchestra a «non dimenticare i sacrifici delle
donne». Salvo poi attaccare: «È un problema serio che dimostra poca autostima».
Si butta nella canea la collega Gianna Fratta, che parla di «salto indietro di
50 anni» e di messaggio «pericoloso». Peccato che la stessa Fratta nel suo sito
si definisca «direttore d'orchestra» e «direttore artistico» in un curriculum
vitae facilmente reperibile sul web.
Insulti legati al
fisico: la vera violenza della Argento. Ed ecco Asia Argento. Dal metoo al
bodyshaming è un attimo. Paladina dei diritti delle donne, bulla contro una
donna al tavolo del ristorante. Dottor Jekyll e Mister Hyde. Siamo nel 2017 e
l'attrice immortala di nascosto Giorgia Meloni mentre mangia in un locale
romano. Foto a tradimento pubblicata su Instagram, con tanto di commento che
dovrebbe far rabbrividire e saltare sulla sedia qualsiasi femminista. Nel
messaggio della Argento c'è tutto: odio politico e insulti sul fisico di una
donna. «La schiena lardosa di una ricca e senza vergogna - scriveva la figlia di
Dario Argento - Make Italy Great Again. Fascista sorpresa a brucare». Un
compendio di intolleranza tradotto anche in inglese, per i followers stranieri:
«Back fat of the rich and shameless - Make Italy great again - #fascist spotted
grazing». Tanto per essere sicuri di fare arrivare il messaggio a ogni
latitudine. Anche qui, dopo le proteste, il solito copione. Con le scuse
rituali, il dietrofront fuori tempo massimo. «Il mio tweet è stato
inappropriato. Non avrei dovuto farlo - si arrampicava sugli specchi,
indipendentemente da idee personali o politiche, contro una donna. Chiedo
scusa». Dall'Argento scuse di bronzo.
La Cristallo e le
Sardine che vomitano cattiverie. Alessandra Caiulo non è soltanto una delle
militanti più attive del gruppo delle Sardine del Salento. È soprattutto la
portavoce del presidente del consiglio regionale della Puglia Loredana Capone,
del Pd. Ed è anche una cantante di musica popolare pugliese, esperta di pizzica
salentina. Caiulo è solo l'ultima della lista delle donne che, negli anni, hanno
offeso gratuitamente Mara Carfagna, ministro per il Sud, storica esponente di
Forza Italia. Caiulo il 12 febbraio scorso scivolava su Facebook. Questo il post
di cattivissimo gusto: «Ma è brutto se dico che mi viene da vomitare al solo
pensiero della Carfagna ministro del Sud?», si chiedeva in un messaggio in cui
seguitava a insultare tutta la delegazione azzurra al governo. Poi arrivano le
piroette e le scuse di rito. Il post viene cancellato. Intanto la star della
notte della Taranta conserva il posto in consiglio regionale, a 5mila euro netti
al mese. Di sardina in sardina, arriviamo a Jasmine Cristallo (nella foto),
leader nazionale del gruppo insieme a Mattia Santori. Domenica la Cristallo in
un'intervista ha detto che se la Meloni diventasse premier sceglierebbe
«l'espatrio». Ieri la precisazione: «Era solo una battuta».
Mara Carfagna, gli insulti
della Sardina Alessandra Caiulo: "Mi fa vomitare".
Brunella Bolloli su Libero
Quotidiano il 24 febbraio 2021. La portavoce a volte deve sapere tenere a freno
la lingua, soprattutto se usa i social dove i messaggi non passano inosservati.
Nello specifico, Alessandra Caiulo, nome sconosciuto a livello nazionale ma noto
in Puglia, il 12 febbraio ha scritto uno squallido post su Facebook che faceva
più o meno così: «È brutto brutto se dico che mi viene da vomitare al solo
pensiero della Carfagna ministro per il Sud?». Il messaggio, corredato da foto,
prendeva di mira anche Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, gli altri due
azzurri che Mario Draghi ha scelto nella squadra di governo e il leghista
Giorgetti e conferma ciò che era chiaro da molto tempo: la sinistra predica bene
e razzola male. Caiulo, cantante della Notte della Taranta, esperta di pizzica e
fedelissima della presidente Pd del consiglio regionale pugliese, Loredana
Capone, di cui è, appunto, portavoce, è stata anche una delle più attive Sardine
del Salento, proprio quel movimento di giovani fondato da Mattia Santori e
compagni e così impegnato a cambiare il linguaggio della comunicazione politica
affinché si rispettasse l'avversario e non lo si insultasse più. Inoltre è donna
e quindi dovrebbe essere attenta alla solidarietà femminile, alle quote rosa e a
tutto il contorno d'indignazione che le compagne hanno sempre rivendicato nelle
loro battaglie contro il sessismo dilagante degli uomini e, ormai è chiaro,
anche di certe donne. Invece Caiulo, pagata 91mila euro l'anno di soldi pubblici
per ricoprire un ruolo istituzionale del quale molti sostengono non abbia le
competenze, ha dimenticato i buoni propositi delle Sardine e il suo incarico in
Regione e ha fatto l'ultrà come una Gozzini qualunque. Poi ha rimosso il post
"vomitevole", ma intanto il centrodestra si è scatenato. Il capogruppo di
Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo, ha chiesto le dimissioni della portavoce della
Capone perché, ha detto, «i toni usati non possono essere consoni a chi è il
portavoce del presidente del Consiglio regionale della Puglia, che rappresenta
non solo la maggioranza, pur essendo un consigliere regionale del Pd, ma tutti i
50 consiglieri, quindi anche il centrodestra». Accuse alla Sardina canterina
sono giunte anche dal gruppo di Forza Italia, secondo cui il contenuto del post
«ha leso, ancor prima che l'immagine di membri del governo e autorevoli
rappresentanti di Fi, il principio del rispetto delle altrui opinioni e
posizioni». La questione è stata sollevata anche ieri sia in ufficio di
presidenza che nella capigruppo, ma centrosinistra e M5S hanno detto no alla
revoca della nomina. Intanto, ieri, Laura Boldrini ha fatto sapere che è stato
condannato a 6 mesi di reclusione e al risarcimento del danno l'uomo che su
Facebook aveva scritto: «Per la Boldrini sempre più piombo delle P38». L'ex
presidente della Camera si era costituita parte civile ed era andata a
testimoniare. «Dobbiamo denunciare l'odio online», ha detto l'esponente Pd,
«minacce e insulti non possono restare impuniti. È un modo anche per
"riprenderci" la Rete come spazio di confronto. Una battaglia di libertà».
Francesca Bernasconi
per ilgiornale.it l'8 marzo 2021. "Se Giorgia Meloni diventa presidente, lascio
la Nazione". Jasmine Cristallo, esponente del movimento delle Sardine, non usa
mezzi termini e, in un'intervista rilasciata a Nextquotidiano, si scaglia contro
la leader di Fratelli d'Italia.
Il ritorno delle Sardine. Le
dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd hanno scatenato il panico.
Tanto che, due giorni fa, le Sardine sono corse a Roma per un incontro con il
Partito Democratico: "Chiediamo a tutti di fare un passo in più - aveva spiegato
il leader del movimento, Mattia Santori - la crisi del Pd è parte della
ricostruzione di un campo progressista, di cui abbiamo disperatamente bisogno.
Al Nazareno si sta costruendo il futuro del centrosinistra". La crisi scoppiata
all'interno del Pd, infatti riguarderebbe "tutti quelli che guardano a
sinistra", spiega Jasmine Cristallo: le dimissioni di Zingaretti, infatti,
potrebbero portare all'avanzata della parte destra del Pd che, a detta della
Sardina, sarebbe rappresentata da Renzi e Bonaccini. "È la parte sinistra del Pd
quella che ci interessa- spiega Cristallo- non i renziani o i destri. Bonaccini?
È ovvio che io sto andando lì al Nazareno per evitare che possa avere la meglio
Bonaccini, e che possa diventare segretario. Lui è un destro per quanto mi
riguarda, è un liberale". E su Bonaccini, che aveva rinnegato il merito delle
Sardine nella sua riconferma a governatore, Cristallo sottolinea: "Noi ci siamo
resi conto che la posta in ballo era molto più alta della riconferma di
Bonaccini: dovevamo fermare l’avanzata delle destre a trazione salviniana, e non
potevamo permettere che il leader della Lega arrivasse con lo scalpo della
regione "rossa" da sempre".
L'attacco alla Meloni. Dal
punto di vista nazionale, poi, il Pd rappresenta "un partito importante" e di
peso nella maggioranza. Per questo, "quello che sta accadendo ora all’interno
del Partito Democratico non può lasciarci indifferenti, perché l’implosione del
Pd in questo momento, l’approccio di guerre tribali che è in atto, non può che
nuocere alla possibilità di creare un fronte largo che possa arginare le
destre". Una paura che coinvolge "tutti quelli che hanno un approccio alla
sinistra", che "non possono non pensare che una cosa che riguarda il Pd non
riguardi tutti". E il timore di un cambio di rotta verso destra è così forte da
aver scatenato le dure parole di Jasmine Cristallo contro Giorgia Meloni: "Noi
ci auguriamo che il Pd possa dialogare con Leu, con i 5 Stelle, con la società
civile, con i movimenti per creare un fronte largo per porre un argine alla
deriva populista e sovranista - ha detto l'esponente delle Sardine a
Nextquotidiano - Se Giorgia Meloni diventa presidente del Consiglio io devo
lasciare la Nazione. Per questo a Zingaretti, quando ho letto l’annuncio delle
sue dimissioni, ho detto: 'Ti prego non ci puoi fare questo'".
·
I
Transessuali.
Estratto dell'articolo di Franco Zantonelli
per repubblica.it il 26 dicembre 2021. La Svizzera, che soprattutto nelle sue
zone rurali ha una lunga tradizione maschilista, sta velocemente cambiando. Nel
2019 un tenente colonnello transgender, Christine Hug, ha assunto il comando di
un battaglione dell’esercito, dal prossimo primo gennaio basterà recarsi
all’ufficio di stato civile del proprio comune per cambiare sesso. Lo ha deciso
nell’ottobre 2020 il Parlamento federale. Il quale ha preso atto di una realtà
sempre più difficile da ignorare. “È una legge - ha spiegato un portavoce del
Governo – rivolta a tutti coloro che hanno la convinzione intima di non
appartenere al sesso con cui sono stati iscritti all’ufficio dello stato
civile”. Ogni anno, nella Confederazione, nascono una quarantina di bambini il
cui sesso è difficile da determinare. Per non parlare del fatto che, nei diversi
cantoni, vivono diverse centinaia di transgender, mentre dai 100 ai 200
cittadini hanno subito o sono in attesa di subire un intervento chirurgico per
cambiare sesso. Con la nuova legge chi da donna vuole diventare uomo o viceversa
non dovrà più sottoporsi come in passato a umilianti esami medici e pure la
parte burocratica della questione è stata sveltita e ridotta all’essenziale.
Dachau, il carcere, l’impegno: le mille
vite di Lucy Salani, la nonna trans d’Italia.
Sopravvissuta al campo di concentramento e ad altre vicende drammatiche, è stata
prostituta e ballerina, fino all’operazione. Oggi, a 96 anni, si racconta in un
documentario. Simone Alliva su L'Espresso il 2 dicembre 2021. È un frammento di
storia che arriva dal Novecento. Eppure, non trova spazio nei libri di scuola,
nelle serie tv, nei salotti buoni. Per entrare nella vita di Lucy Salani bisogna
attraversare strade, carceri, forni crematori e manicomi. Entrare in quelle
fessure di un mondo che da tempo è stato lasciato ai margini, invisibile
soltanto perché abbiamo deciso di non guardarlo, non vogliamo.
Dario Cresto-Dina per repubblica.it il 5 dicembre
2021. Due vite in un corpo solo. Quella di Priscilla, la più famosa drag queen
italiana, anche se il suo regno è a Mykonos, e l'altra di Mariano Gallo, 45
anni, che ne è l'identità storica e anagrafica. Priscilla e Mariano vivono
schiena contro schiena, non si incontrano mai faccia a faccia. Quando arriva
Priscilla sparisce Mariano e viceversa.
Priscilla, che cos'è una Drag Queen?
«Semplicemente un personaggio che fa spettacolo.
Drag Queen tradotto vuol dire regina dello strascico, oppure regina dei
trascinatori. Puro intrattenimento fatto di costumi, parrucche e make-up
esagerati. Drag è una forma d'arte e non ha genere. Certo, il vissuto di una
persona incide molto sulla sua voglia di fare drag, molte di noi sentono il
palco come fiera affermazione di se stesse. Per me una drag deve sempre farsi
portavoce della comunità LGBTQI+ e diffondere un messaggio di libertà e
inclusione».
Non si è mai sentita costretta in un corpo
sbagliato?
«No, fin dall'infanzia ho intuito di avere una
sensibilità diversa dagli altri bambini che mi faceva apparire più debole e
quindi facile bersaglio dei bulli. Preferivo la danza al calcetto, la compagnia
delle femminucce a quella dei maschietti. Non amavo il mio corpo perché ero
cicciottello, altro pane per il bullismo. Mi sentivo sbagliato non perché ero un
maschietto, ma per le sensazioni e la curiosità che provavo proprio nei
confronti degli altri maschi».
Quando è stata la prima volta che ne ha parlato
con qualcuno?
«Con un prete durante la confessione. Sa, ero un
adolescente e facevo il chierichetto. La sua risposta fu: prega e allontana
questi pensieri impuri. Qualche anno dopo l'ho incontrato in una discoteca
gay».
In famiglia come andò?
«Più che bene. Mia nonna Vincenza, detta Nonna
Rossa per il colore infuocato dei capelli, mi regalò la mia prima Barbie.
Rigorosamente pezzotta, falsa. Fumatrice accanita, andava a comprare le
sigarette di contrabbando in un basso camuffato da negozio di giocattoli e
dolciumi e spesso mi portava con sé: tornavo sempre a casa con un bottino.
Quella volta, quando mi chiese di scegliere, ebbi il coraggio di indicare una
Barbie e lei senza dire una parola la prese dallo scaffale e me la mise tra le
mani. In quel momento mi sono sentito il bambino più felice al mondo».
Quando ne parlò con i genitori?
«Genitori e amici, ho fatto tutto in un giorno
solo. La mia famiglia ha accettato la mia omosessualità dopo una prima reazione
di smarrimento. Avevo 19 anni. Ho capito che dovevo aiutarli e dare loro le
giuste informazioni per accettarmi. E così è stato: gli ho fatto solo
comprendere che avere un figlio gay non è diverso dall'avere un figlio etero. E
gli ho trasmesso la mia serenità nell'essere stato finalmente sincero con loro.
E così è cominciata la nostra storia di famiglia rainbow. Mamma Antonietta ha
cucito i primi vestiti di Priscilla, papà Bruno le ha fatto da bodyguard».
Come è nata Priscilla, la sua vena en travesti?
«Da piccolo mi piaceva creare abiti con le
lenzuola del mio letto. Amavo ballare, recitare, esibirmi, insomma, stare al
centro delle attenzioni, non necessariamente in abiti femminili. Ho lavorato in
teatro, come ballerino e come attore. Poi ho scoperto la passione per il
trasformismo e l'arte drag partecipando al programma tv "Al posto tuo", condotto
da Alda D'Eusanio. Era il 2002. Interpretavo la parte di un ragazzo che confessa
alla fidanzata di fare la drag queen. Fu la prima volta che mi vidi nei panni di
Priscilla e me ne innamorai».
Napoli è stato il luogo ideale, un grande
palcoscenico?
«Non poteva esistere posto migliore. Quando è nata
Priscilla i napoletani l'hanno accolta come una figlia del Vesuvio. Certo, mi
hanno anche messo a dura prova perché troppo spesso facevano un po' di
confusione: Priscilla è nu travestit.. . è nu femmenell... è na femmena over?
Insomma che sì? Quante volte ho dovuto rispondere a queste domande. La mia
gavetta è stata intensa e tutta napoletana. Non mi sono fatto mancare nulla:
matrimoni, comunioni, battesimi, compleanni, lauree, addii al celibato e
nubilato, sagre e feste di piazza. Ho fatto pure un addio al laicato per un
ragazzo che entrava in seminario. Il mio primo costume di scena è stato
realizzato proprio da un amico napoletano utilizzando le piume di uno
spolverino».
Quanto è stato difficile essere ciò che senti di
essere in una comunità che si rivela spesso arretrata e ostile?
«È complicato essere omosessuale in una società
maschilista che non accetta sfumature e discrimina chi non risponde a specifici
canoni di eterosessualità. La storia ci insegna che la comunità LGBTQI+ ha
sempre dovuto combattere e deve continuare a farlo per veder riconosciuti i
propri diritti di persone».
Come reagì il pubblico dei primi spettacoli?
«All'inizio con insulti e offese. Quando ci
troviamo di fronte a qualcosa di nuovo che non riusciamo a inquadrare alziamo un
muro, ci mettiamo sulla difensiva e diventiamo aggressivi. Succedeva esattamente
questo con me. Ho imparato a rispondere agli insulti con ironia e severità. Poco
alla volta è subentrato il rispetto. Molti credono che, visti i nostri look
esagerati, indossiamo una maschera per nasconderci e un'armatura per difenderci.
È l'esatto contrario: noi drag ci mettiamo a nudo sul palco, mostriamo e viviamo
la nostra parte più intima con umanità e vulnerabilità».
La battaglia politica sui nuovi diritti dura da
anni. Visto dai suoi occhi a che punto siamo?
«Ho riscontrato cambiamenti positivi con la legge
sulle unioni civili anche se avrei preferito un provvedimento che prevedesse il
matrimonio tra persone dello stesso sesso, il riconoscimento dalla nascita da
parte di entrambi i genitori dei figli delle coppie omogenitoriali e, in
generale, l'accesso a tutti gli istituti che il nostro Paese già prevede per gli
eterosessuali, per esempio l'adozione. Con l'affossamento del ddl Zan l'Italia
ha sicuramente fatto parecchi passi indietro in tema di diritti civili: è una
legge che tutela tutte le cittadine e i cittadini, non solo le persone LGBTQI+.
Nel mondo ci sono 72 Stati in cui l'omosessualità è reato, in sette viene punita
con la pena di morte. Per fortuna non siamo a questi livelli ma in Italia c'è
ancora tanto lavoro da fare per definirci un paese civile e democratico».
Se Priscilla è un artista, Mariano che cos'è?
«Un attore teatrale. Anche se non si è mai
limitato a questo: ha fatto il cameriere, il dj, l'animatore, il ballerino e
l'istruttore di fitness. Durante la pandemia, visto che Priscilla era a riposo
forzato a causa del blocco degli spettacoli, è diventato insegnante di italiano
per i ragazzi stranieri che dovevano affrontare l'esame per il permesso di
soggiorno».
Lei è uno dei giudici, sulla piattaforma
Discovery+, di Drag Race Italia. A chi si ispira?
«La drag per eccellenza che ammiro è RuPaul, che
noi tutte chiamiamo Mama Ru. È lei la mia musa. È lei che ha sdoganato l'arte
drag nel mondo e ha dato a noi tutte la possibilità di uscire dall'ombra. Ci ha
fatto sentire fiere. Con RuPaul, a partire dal 2009, Drag Race ha cominciato una
rivoluzione che ha coinvolto tutto il mondo e finalmente ora anche il nostro
Paese».
Vorrebbe poter rinascere donna?
«No, mai. Sono una persona cisgender ovvero mi
riconosco nell'identità di genere attribuitami alla nascita, quella maschile.
Vorrei rinascere esattamente come sono: non mi sento affatto donna e non
desidero esserlo».
Chi c'è nella sua vita privata?
«La mia famiglia e i miei amici. Dedico a loro
tutto il mio tempo libero e le mie energie. Non ho un compagno, a 45 anni posso
definirmi zitello. Ma sento che è il momento giusto per costruire qualcosa di
mio. Voglio un marito e dei figli. Aspetto il principe azzurro. Magari è al
galoppo e sta per raggiungermi».
Valentina Lupia per “la Repubblica - ed. Roma” il
3 dicembre 2021. «Mi sento Andrea, ma sul registro c'è ancora scritto Anna e io
sono stufo». È lo sfogo di Andrea G., 19 anni, che non sa più «come farsi
ascoltare». Giocare col suo aspetto, ammette, gli piace: così nel video- appello
pubblicato sui social appare coi suoi «nuovi» capelli rossi, ombretto color
pesca. È stato vittima di bullismo, ma ora non ne può più e per questo si
espone. Così come meglio lo fa sentire. All'occupazione del liceo che frequenta,
il Cavour, si è parlato di «riprendersi i propri spazi». E così lui è potuto
andare al bagno dei maschi: «Vorrei che fosse mio diritto». E invece, nel terzo
scientifico della Capitale secondo Eduscopio della Fondazione Agnelli, la "
carriera alias" ancora non è realtà. Si tratta del «sistema che consente di
riconoscere un profilo alternativo e temporaneo a chi è in fase di transizione
di genere» , spiega Michele Sicca della Rete degli studenti medi, che ha aiutato
i collettivi di diverse scuole ad adottare questo modello, già prassi in alcune
scuole del Lazio. Mentre qui, ha spiegato in un colloquio del 30 novembre la
dirigente ad Andrea, c'è ancora da attendere: «Non sono né a favore né contraria
all'istituzione della carriera alias - spiega la dirigente, Claudia Sabatano -.
Per me sono sovrani il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, appena
rieletto. Non ostacolo la discussione, il mio ruolo è assicurare che tutti si
esprimano democraticamente. Se il Cavour è pronto alla carriera alias? Lo è come
il resto del mondo: in parte. Alcuni sì, altri meno. Vedremo se il consiglio
d'istituto accetterà di sentire il ragazzo in una audizione».
Cosa pensa di fare nel frattempo?
«La dottoressa del Saifip, Servizio di adeguamento
tra identità fisica e identità psichica, che mi segue parlerà con la preside,
intanto mi sono messa in contatto col Collettivo Tommie Smith chiedendo aiuto.
Nel frattempo continuare a firmare le verifiche col nome che mi è stato dato
alla nascita e non con quello che mi identifica. Perché si tratta di "un
documento ufficiale", mi dicono i docenti. Non tutti: la prof di italiano scrive
solo "A." e poi il mio cognome».
Come la fa sentire scrivere Anna e non Andrea?
«È particolarmente faticoso. Se dovessi dirlo con
delle immagini, direi che in quel momento sento degli aghi conficcarsi nel
corpo, poi una coltellata, mi sa di acido. Però la prof di italiano, almeno lei,
scrive "A." e poi il mio cognome».
Se ci fosse la carriera alias utilizzerebbe il
nome che ha scelto.
«La preside mi ha detto che questo è un momento
delicato, che ci vorrà del tempo affinché venga approvata e che devo avere
pazienza affinché questo sistema capisca la mia situazione. Ma questa situazione
è la mia vita, la mia quotidianità».
Qual è stata la reazione dei suoi compagni quando
ha fatto coming-out come persona trans?
«La mia è una situazione particolare: sono orfano,
dislessico, mi sono trasferito dall'artistico al Cavour, sto sotto ormoni. Non è
stato semplice fargli capire cose magari banali per loro ma dolorose per me, ma
ora mi sembra siano tutti tranquilli, come anche alcuni prof, anche se non
tutti.».
Perché ha aspettato l'occupazione per andare nel
bagno dei maschi? Non avrebbe potuto farlo anche prima, sperando che i suoi
compagni capissero?
«Mi sono ripreso i miei spazi. Sembra banale ma
per le persone trans è particolarmente significativo. Lo ammetto: non ci sono
mai andato perché ho paura di incontrare persone sbagliate».
È mai stato vittima di bullismo?
«Sì, fuori. Sputi, "frocio". E al mio partner dei
coattelli hanno messo una scatola in testa. Eravamo in Centro, in mezzo alla
gente e nessuno ha fatto niente. Quel che mi fa più male è vedere soffrire anche
le persone che amo».
Nel video ha lanciato un appello alla
condivisione. Cosa spera di ottenere da questa battaglia?
«Voglio diventare ingegnere e costruire protesi
per persone trans. Ma per ora il mio rimpianto più grande sarebbe uscire da
questa scuola, dopo la maturità, senza vedere il mio nome cambiato sul
registro».
Fabrizio Accatino per “La
Stampa” il 28 novembre 2021. «Necessario» è un termine piuttosto abusato quando
si parla di cinema, per definizione meravigliosa arte del superfluo. Però sì,
per «C'è un soffio di vita soltanto» di Matteo Botrugno e Davide Coluccini il
termine calza a pennello. Perché la storia della 97enne Lucy (all'anagrafe
Luciano Salani), la più anziana transessuale d'Italia, ci restituisce le
ambiguità irrisolte (sempre le stesse) di due epoche: la sua e la nostra. Il
documentario verrà presentato lunedì sera al Torino Film Festival, alla presenza
della protagonista e dei registi, due indipendenti che da quindici anni si
sudano la produzione di ogni film. Per questo lavoro non hanno avuto paura di
affrontare un budget prossimo allo zero, pur di portare a casa ciò che volevano.
«L'unica cosa che ci importava era raccontare la storia di Lucy, perché non
venisse dimenticata», spiegano. «Lei l'abbiamo conosciuta per caso, in una
piccola intervista ripubblicata su Facebook, in una di quelle sere in cui scorri
annoiato le bacheche social. Abbiamo trovato un contatto, le abbiamo telefonato
e per spiegarle il progetto l'abbiamo incontrata nella sua casa di Bologna, in
cui vive sola. Si è subito lamentata dei politici che approfittano di lei in
campagna elettorale, la prendono sotto braccio e la esibiscono come un trofeo,
senza mantenere mai le promesse. Probabilmente ha capito che noi non eravamo
così e ha deciso di fidarsi». Ci stanno dieci vite nella vita di Lucy. Bambina
dentro da sempre, abusata da un sacerdote, le prime marchette, la diserzione
dall'esercito tedesco, una fuga rocambolesca finita con una gamba lesa da un
proiettile, la deportazione a Dachau, la liberazione, l'attività da travestito
nel dopoguerra, una figlia adottiva morta prima di lei, il cambio di sesso nella
Londra degli anni Ottanta, la discriminazione e infine l'oblio. «Non sapevo
proprio cosa aspettarmi dai registi», racconta lei. «Ho avuto una vita molto
lunga e piena di difficoltà, tra avventure, momenti durissimi, piccole e grandi
gioie. Ho risposto alle loro domande, ho raccontato quello c'era da raccontare,
mi sono fatta seguire dalla loro cinepresa. Giorno dopo giorno si è iniziato a
creare un rapporto molto profondo, ho cominciato a credere che forse ne valeva
davvero la pena. Soprattutto, Davide e Matteo mi hanno trasmesso un grande
entusiasmo, visto che da qualche anno il mio non era proprio alle stelle». Tra
scioccanti memorie delle atrocità subite e delicati ricordi del passato (come la
poesia composta in gioventù, a cui il titolo ruba un verso), il film segue Lucy
in una quotidianità fatta di noia alla finestra e civetterie allo specchio,
visite di amici e film di fantascienza in dvd. Restituendo una figura
sfaccettata e complessa, che la fantasia di nessun romanziere sarebbe mai stata
capace di creare. «In questo film ho raccontato tutto quanto mi è capitato nella
vita», spiega ancora lei. «Ci sono il campo di concentramento, le lotte per
diventare la donna che sentivo di essere, gli amori, gli affetti, le
disavventure. Non è stata però soltanto una valvola di sfogo. Dopo le riprese mi
rendevo conto che quello avrebbe potuto essere d'aiuto anche per altri. Non
voglio sembrare presuntuosa, ma forse la mia storia potrà essere d'esempio, una
speranza per chi si trova a lottare per la propria identità e dignità
personale». Nell'estate 2020 Lucy avrebbe dovuto andare a Dachau, invitata per
le celebrazioni del 75esimo anniversario della liberazione del campo, poi è
scoppiata la pandemia. Il Covid ha fermato tutto, ma non i registi. «Ce
l'abbiamo portata comunque, perché ci sembrava giusto che la narrazione si
chiudesse lì dove tutto ha avuto inizio. Noi siamo rimasti un passo indietro, a
seguirla con la macchina da presa. Forse è stato persino meglio che fossimo da
soli. Il suo monologo davanti al memoriale delle vittime ci ha tolto il fiato,
lì ci siamo resi conto definitivamente del suo straordinario spessore umano,
della saggezza che tutte quelle esperienze hanno sviluppato in lei». Nello
struggente finale, Lucy fissa quella grande croce scura sul muro di pietra,
eretto dove una volta venivano bruciati i prigionieri, e si sfoga piangendo: «Se
ci fosse veramente un Dio, tutte queste cose non sarebbero mai successe. Ma non
c'è purtroppo. Il Dio siamo noi, perché è la nostra volontà che comanda il
mondo, non Dio. Quale Dio? Per fortuna sono arrivata in fondo, almeno ho potuto
constatare che non valeva la pena rimanere su questo pianeta».
Azzurra Della Penna per “Chi” il 19 novembre 2021.
Prima di tutto Giorgio Armani, un signore della moda che ormai potrebbe
limitarsi a sistemare la linea delle spalline della giacca beige e, invece, si
prende la briga di scegliere Valentina Sampaio quale nuova testimonial della sua
linea beauty «perché la bellezza sia significativa e trasversale», dice. Poi
Ryan Murphy, che nella terza stagione di Pose mette in scena il matrimonio di
una trans con una forza emotiva che non ha precedenti: lei si chiama Angel, le
sue amiche sono Elektra, Lulu, Blanca…Si sposerà all’hotel Plaza di New York con
una cerimonia da mille e una notte, con le invitate vestite da sposa pure loro
dicendo - lei che è, in effetti, una sorta di unicorno - «Sono la prima, non
sarò l'ultima». E vogliamo parlare della vita reale? Lasciamo stare la magia
della moda e quella delle serie tv. Parliamo di Wanda Nara, una che davvero non
discrimina, che tratta con la stessa intensa aggressività verbale - leggere i
messaggi per capire - le amanti, presunte o tali, del suo Maurito Icardi: sia la
donna, Eugenia Suarez, che la trans, Guendalina Rodriguez. Persino i tempi in
cui il gelato Magnum aveva preso una transgender per la sua pubblicità sembrano
anteguerra. Troppo si occhieggiava, era il 2015, allo stupore misto alla
volgarità, come a dire: "Se parliamo di Magnum, dovrà pure avere qualcosa di
più" (il meta messaggio, in effetti, è sempliciotto). Ora, appunto, di
transessualità si parla, ma in maniera differente, si allude a qualcosa di più,
ai sentimenti, alle emozioni che dovrebbero, in fondo, essere di tutti quanti. E
si parla anche di niente: togli tutto, persino il sesso. «Questo dovrebbe essere
lo scatto decisivo: la transessualità dovrebbe essere una qualità neutra»,
sottolinea Vladimir Luxuria, «non qualcosa che rende migliore o peggiore una
persona, qualcosa che ne limita o ne esalta il talento, non si dovrebbe cambiare
idea su una persona se ti dice che è trans: se fai un colloquio di lavoro dici
che sei laureata, che hai esperienza, che hai, magari, una specializzazione...».
Piccolo inciso: non si può non notare che l'ex deputata ha già nel nome un
richiamo alla sensualità: «Sensualità, appunto. Ho sempre pensato alla
“lussuria” anche come esaltazione dei sensi: il gusto, l’olfatto, il tatto… Alla
fine tutto è lussuria, non solo quella che riguarda il peccato capitale, che per
me, del resto, peccato non è. Anzi, è una virtù». Giochi di parole a parte, il
re dell'hard Rocco Siffredi avverte: «Ormai tutto si lega e abbraccia il
politically correct, oggi fa figo mettere in tutte le serie tv due uomini che si
baciano, due donne che si baciano, una transgender. Lo si fa solo per apparire
meno ipocriti». A X Factor hanno passato due puntate a dire che avevano
eliminato le categorie: «E a me sta terribilmente sul ca**o questa
strumentalizzazione: fallo e non dirlo. Invece lo dici e lo ripeti per apparire
avanti, ma in realtà sei vecchissimo e fai ridere le nuove generazioni (che,
invece, sono giustissime visto che se ne fregano di tutto). E aggiungo che in
certe manifestazioni di fluido non c'è niente, è un fluido pericoloso che ti fa
sbattere contro blocchi di marmo». Sul tema il deputato e critico d'arte
Vittorio Sgarbi rincara la dose: «Mettono in campo la storia del politically
correct nella speranza che qualcuno tiri su qualche polemica». Proprio lui che
anni fa aveva portato in tv la transgender Eva Robin's. «Ma infatti leggi come
il Ddl Zan contro l'omotransfobia andavano fatte, forse, 20 anni fa, mica
adesso. Oggi vogliono "normare" ciò che è "normale". Quando ero piccolo io a
Sanremo c'erano Orietta Berti e Iva Zanicchi, oggi c'è Achille Lauro vestito da
donna che canta Me ne frego: funziona, fa moda e quindi normalizza». In effetti
va detto che la bellezza, la moda, lo spettacolo sono un lasciapassare favoloso:
«Infatti io rivendico il diritto di essere trans e brutta», tiene a sottolineare
Luxuria. «Passare il messaggio che solo la bellezza, la giovinezza, il vigore
siano vincenti è, quanto meno, devastante». D'accordo, ci sarà una Rita Levi
Montalcini anche fra le trans: «E magari sono io», scherza Luxuria. L'immagine
comunque conta e non da oggi, come Sgarbi, meglio di chiunque altro, sa
rimarcare: «Pensate all'angelo che sta davanti a San Giuseppe nel Riposo durante
la fuga in Egitto di Caravaggio: quella è una figura ambigua, è a metà strada
fra una trans e Belen. In fondo non ci voleva Armani per arrivare a capire che
ciò che è al confine fra una sessualità e l'altra è più interessante». Dunque si
arriva all'incanto, all'attrazione. Ma che cosa ci avvince davvero del mondo
trans? «C'è un'attrazione psicologica per le donne e una fisica per l'uomo»,
spiega Rocco Siffredi, che è anche autore del manuale Sex Lessons (Mondadori).
«Magari hai bisogno di uscire da una vita sessuale non appagante, magari vai
oltre la tua sessualità, magari ti vengono dubbi... Questo almeno è quello che
mi raccontano gli uomini, le donne e le trans. Non dimentichiamoci che faccio
film porno e ne conosco tante». D'accordo, ma se non bisogna più fare
differenze? «La discriminazione non si batte con l'omologazione. Chi l'ha detto
che "diverso" non va bene? A me va benissimo», conclude Siffredi. Gli fa eco
Vittorio Sgarbi: «Anche la trasgressione ha i suoi diritti». Non è invece
d'accordo Vladimir Luxuria sul fascino della trans, quello che, oltre a molto
altro, ci ricorda anche una cosa semplice semplice: tutte le volte che, anche
chi trans non è, non si è sentito a suo agio o aderente al suo corpo: «Io spero
che il mio fascino sia legato al mio carattere, al mio carisma e non alla mia
identità di genere. Se un po' di carisma ce l'ho, lo vorrei legare di più alla
mia intelligenza che ad altro», dice. Sempre secondo Vladimir Luxuria: «Il punto
nodale della discussione sul Ddl Zan, soprattutto fatta dai vecchi senatori, è
stato proprio quello di mettere nero su bianco l'identità di genere. Proprio
quei vecchi senatori, gente che ha fatto del trasformismo una carriera». E
questa volta Vittorio Sgarbi le dà ragione: «Già, i trans della politica non
hanno votato il Ddl Zan...».
Da “ANSA” il 16 ottobre 2021.
Il Senato del Texas ha votato una legge che obbliga gli studenti transgender a
competere nelle squadre che corrispondono al genere con cui sono stati
registrati alla nascita, e non quello in cui si identificano. Il controverso
provvedimento era già stato varato dalla Camera dell'assemblea statale e ora è
approdato sulla scrivania del governatore repubblicano Greg Abbott. Quella di
introdurre il divieto ai transgender di gareggiare negli sport o nelle squadre
femminili è una delle crociate da tempo portate avanti dall'ex presidente Donald
Trump. Le associazioni per la difesa dei diritti civili definiscono la legge
discriminatoria.
Dagotraduzione dal Daily Mail
il 14 ottobre 2021. Colin Wright, biologo evoluzionista americano, è stato
censurato da Instagram per aver condiviso sul social i risultati di uno studio
sui transgender di un’importante rivista medica. La ricerca affermava che in
molti sport gli uomini sono biologicamente superiori alle donne. Lo studio,
confotto dall’Università di Manchester e del del Karolinska University Hospital
di Stoccolma, intitolato Transgender Women in the Female Category of Sport:
Perspectives on Testosterone Suppression and Performance Advantage, era stato
pubblicato su Medicine& Sports, rivista scientifica fondata nel 1969. Colin
Wright, che ha collaborato con il Wall Street Journal ed è stato nel mondo
accademico per 12 anni, aveva condiviso un grafico tratto dallo studio che
mostrava come chi nasce biologicamente maschio ha un vantaggio in termini di
prestazioni rispetto a chi nasce biologicamente femmina in molti degli sport in
cui i transgendere sono stati ammessi alle Olimpiadi. A conclusioni scientifiche
simili sono arrivati anche i ricercatori dell’Università di Loughborough, che
sul British Journal of Sports Medicine hanno pubblicato uno studio dal titolo:
“In che modo la transizione ormonale nelle donne transgender modifica la
composizione corporea, la forza muscolare e l’emoglobina?”. Entrambi gli studi
sono stati pubblicati prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020, a cui per la prima
volta hanno partecipato atleti transgender. Gli studi hanno concluso che anche
dopo tre anni di terapia ormonale le donne transgender conservano ancora
vantaggi in termini di forza rispetto alle donne biologiche. Gli studi sono
stati realizzati per verificare se i criteri del Comitato Olimpico
Internazionale (CIO) per l’idoneità degli atleti eliminassero effettivamente il
vantaggio nelle prestazioni di possedere corpi maschili. Il Cio ha stabilito che
i livelli di testosterone totale di un atleta devono essere al di sotto di 10
nanomoli per litro per almeno 12 mesi prima e durante la competizione. Entrambi
gli studi hanno scoperto che le riduzioni di forza, massa magra, massa muscolare
e densità ossea attraverso l'uso di regimi tipici di soppressione del
testosterone mostrano una differenza minima rispetto alla differenza media tra
uomini e donne biologici, lasciando i primi con un vantaggio in termini di
prestazioni. Il grafico condiviso da Wright mostrava il vantaggio prestazionale
maschile che i corpi degli uomini cisgender consentivano loro rispetto alle
donne cisgender. L'illustrazione mostra che, anche se gli uomini hanno un
vantaggio in termini di prestazioni, esso varia nei diversi eventi sportivi a
seconda del livello e del tipo di abilità fisica o fisiologica o della misura
del successo che ogni sport richiede. Lo studio di Medicina dello Sport
suggerisce che invece di una linea guida per tutti gli atleti transgender, le
singole federazioni sportive dovrebbero determinare le proprie condizioni per i
loro eventi.
La Baviera sul linguaggio
gender. "Va salvaguardato il tedesco".
Daniel Mosseri il 22 Settembre
2021 su Il Giornale. Il governo contro le università che impongono ai loro
studenti una scrittura più neutra e inclusiva. No all'indottrinamento del
linguaggio «inclusivo» e no ai poliziotti del linguaggio. Il governo regionale
di Monaco di Baviera ha lanciato un avvertimento alle università e alle
accademie che operano sul territorio del Libero Stato di Baviera: gli studenti
che non adoperano gli asterischi o le schwa, che non declinano i nomi anche al
femminile ma che insisteranno con l'uso tradizionale delle desinenze al maschile
non dovranno ricevere voti più bassi. Il gendern, così si indica con neologismo
tedesco la pratica di trasformare il linguaggio depurandolo dall'uso prevalente
del maschile, «non deve essere rilevanti a fini degli esami», ha dichiarato lo
stesso Söder a seguito di una riunione dell'esecutivo regionale. Dello stesso
avviso il ministro bavarese per la Scienza, Bernd Sibler. Smentendo alcune voci
circolate nei giorni scorsi secondo cui ad alcuni studenti allergici al gendern
sarebbero stati assegnati dei voti più bassi, il ministro del partito cristiano
sociale bavarese (Csu) di Söder ha affermato che nel Land meridionale tedesco
non è stata registrata alcuna protesta o denuncia da parte di studenti ma che
tuttavia «l'uso del linguaggio di genere non dovrebbe essere un criterio di
valutazione». La sollecitazione dell'esecutivo, ha poi aggiunto lo stesso Söder,
è di natura provvisoria e il governo di Monaco si riserva di verificare e
approfondire la questione in futuro. Abituato a far notizia per i suoi modi
assertivi, a meno di una settimana dalle elezioni per il rinnovo del Bundestag,
Söder sposta su di se la luce dei riflettori della politica. Ma l'annuncio era
nell'aria: la settimana scorsa la Conferenza delle Università bavaresi e il
governo di Monaco avevano polemizzato a distanza in materia. Ad agosto una serie
di università ha preparato alcune linee guida per consigliare agli studenti di
non utilizzare le desinenze maschili e femminili ma al contrario di impiegare un
linguaggio più neutro e inclusivo anche grazie all'uso di asterischi. A ruota
gli atenei bavaresi hanno ribadito che «gli studenti sono liberi di scegliere la
lingua per loro più appropriata. Nessuno può quindi essere valutato in maniera
peggiore». Troppo poco per il governo di Söder, il governatore che fino alla
scorsa primavera ha cercato di farsi accreditare quale candidato cancelliere di
tutti i moderati. Parlando al congresso della Csu e in una serie di interviste,
Söder ha etichettato le linee guide degli atenei come «indottrinamento»,
ricordando che il linguaggio non si impone dall'alto e che tali indicazioni
finiscono poi in eccessi secondo cui non si potrà più dire «padre e madre» ma
«genitore 1 e genitore 2». «Io non voglio che i miei figli mi chiamino
genitore», ha affermato. Il gendern non è esclusiva delle università: molte
amministrazioni prediligono l'uso di termini neutri. Così per non dire elettori
ed elettrici si dirà «persone votanti» e per non dire lavoratori o lavoratrici
si dirà «forza lavoro». La settimana scorsa il 96% dei delegati al congresso
della Csu ha respinto «gli eccessi politicamente indottrinati e artificiali
delle acrobazie linguistiche gender-moralistiche». Daniel Mosseri
Il Papa: «Il gender è
un’ideologia pericolosa e diabolica. E non c’entra con la questione gay».
Sveva Ferri martedì 21 Settembre 2021 su Il Secolo d'Italia.
L’ideologia gender è «pericolosa», perché «è astratta rispetto alla vita
concreta di una persona, come se una persona potesse decidere astrattamente, a
piacimento, se e quando essere uomo o donna». Papa Francesco è tornato sulla
tema nel corso della discussione coi Gesuiti di Bratislava, avuta nel corso del
recente viaggio apostolico in Slovacchia, durante la quale il Pontefice ha
ribadito che «questo non ha nulla a che fare con la questione omosessuale» e che
la Chiesa deve dimostrarsi accogliente con le persone gay.
L’ideologia gender
«pericolosa» e «diabolica». Il testo integrale della conversazione, che si è
tenuta il 12 settembre, è stato pubblicato oggi dalla rivista dei gesuiti, La
Civiltà cattolica. Vi si legge che, in risposta a uno dei presenti che citava
l’ideologia gender tra le «diaboliche colonizzazioni ideologice» cui spesso fa
riferimento il Pontefice, lo stesso Bergoglio ha chiarito che «l’ideologia ha
sempre il fascino diabolico, come dici tu, perché non è incarnata». «In questo
momento – ha proseguito il Papa – viviamo una civiltà delle ideologie, questo è
vero. Dobbiamo smascherarle alle radici. La ideologia del gender di cui tu parli
è pericolosa, sì. Così come io la intendo, lo è – ha spiegato papa Francesco –
perché è astratta rispetto alla vita concreta di una persona, come se una
persona potesse decidere astrattamente a piacimento se e quando essere uomo o
donna. L’astrazione per me è sempre un problema».
Il Papa: «La questione gay è
un’altra cosa». «Questo – ha poi avvertito Francesco – non ha nulla a che fare
con la questione omosessuale, però. Se c’è una coppia omosessuale, noi possiamo
fare pastorale con loro, andare avanti nell’incontro con Cristo. Quando parlo
dell’ideologia, parlo dell’idea, dell’astrazione per cui tutto è possibile, non
della vita concreta delle persone e della loro situazione reale». Dunque, il
Papa, nella conversazione con i gesuiti di Bratislava, ha invitato
ad abbandonare rigidità e atteggiamenti controproducenti, sia nei confronti
delle coppie gay sia verso quelle risposate.
Le coppie di risposati «non
sono condannate all’inferno». «Penso al lavoro che è stato fatto, padre Spadaro
(il direttore di La Civiltà cattolica, ndr) era presente al Sinodo sulla
famiglia per far capire che le coppie in seconda unione non sono già condannate
all’inferno. Ci dà paura accompagnare gente con diversità sessuale. Ci fanno
paura gli incroci dei cammini di cui ci parlava Paolo VI. Questo è il male di
questo momento. Cercare la strada nella rigidità e nel clericalismo, che sono
due perversioni».
L’elogio della «libertà del
Vangelo». «Oggi – ha osservato Bergoglio – credo che il Signore chieda alla
Compagnia di essere libera, con preghiera e discernimento. E un’epoca
affascinante, di un fascino bello, fosse anche quello della croce: bello
per portare avanti la libertà del Vangelo. La libertà! Questo tornare indietro
lo potete vivere nella vostra comunità, nella vostra Provincia, nella Compagnia.
Occorre stare attenti e vigilare. La mia non è una lode all’imprudenza, ma
voglio segnalarvi che tornare indietro non è la strada giusta. Lo è, invece – ha
concluso il Pontefice – andare avanti nel discernimento e nell’obbedienza».
Ratzinger e le femministe: alleanza
contro il pensiero gender che violenta la natura umana.
Adele Sirocchi venerdì 17 Settembre 2021 su Il Secolo d'Italia.
Anche l’uomo possiede una “natura” che gli è stata data, e il violentarla o il
negarla conduce all’autodistruzione. Questo sostiene Benedetto XVI mettendo in
guardia contro il gender. E proprio in difesa della natura femminile minacciata
dalla nuova religione gender fluid prendono posizione alcune femministe
storiche, realizzando un’inedita alleanza tra il teologo Ratzinger e le ultime
paladine della femminilità minacciata. Lo fa notare Giulio Meotti in un articolo
di oggi sul Foglio. Nel suo libro “Trans”, la editor dell’Economist Helen
Joyce denuncia proprio le stesse cose contro cui polemizza Ratzinger. E’ in atto
una rivoluzione culturale che intende cancellare il sesso biologico a vantaggio
dell’identità di genere autodichiarata. Dopo la pubblicazione, Joyce afferma di
essere stata boicottata dalla Bbc e dalle altre tv e che la catena di librerie
Waterstones sta facendo di tutto per non venderlo. “Le leggi nazionali –
denuncia la Joyce – le politiche aziendali, i programmi scolastici, i protocolli
medici, la ricerca accademica e le guide dei media vengono riscritte per
privilegiare l’identità di genere autodichiarata rispetto al sesso biologico”.
Helen Joyce parla “di fondazioni di beneficenza controllate da miliardari che
uniscono le forze con gruppi di attivisti per pompare denaro in lobby dietro le
quinte per un cambiamento legale. Hanno conquistato grandi partiti politici, in
particolare i democratici americani, e grandi imprese, compresi i giganti della
tecnologia. Sono supportati dalle industrie farmaceutiche, che ci vedono già una
montagna di affari”. L’articolo del Foglio cita inoltre la filosofa
inglese Kathleen Stock, che insegna all’università del Sussex, e che nel suo
libro “Material Girls” spiega come i politici di tutti i grandi partiti,
celebrità, leader di enti di beneficenza e aziendali, medici, media e molte
istituzioni hanno aderito alla nuova ideologia transgender. Così gli organismi
di sanità pubblica, che hanno eliminato parole come “donne” e “madri”. Nel nuovo
libro, Stock sintetizza così l’importanza del sesso biologico: “La ragione più
semplice e ovvia per cui i sessi sono importanti è che senza di essi la nostra
specie finirebbe”. Infine, Giulio Meotti cita un terzo libro, quello di Claude
Habib, docente alla Sorbonne Nouvelle, saggista e scrittrice, La question Trans.
“La specie umana è composta da due sessi: come mai una posizione così banale,
così ragionevole, è stata esclusa dal dibattito? Come spiegare che la
maggioranza è stata espropriata senza il diritto di formulare ciò che pensa?
Tutti lo sanno e la scienza lo conferma”.
Tre femministe che pongono la stessa questione: è
possibile cancellare il sesso biologico? Occorre una riflessione profonda sul
fatto che gli adolescenti non possono più sopportare la loro natura data. Chi li
spinge? Chi li incoraggia? E a cosa condurrà tutto questo?
Barbara Costa per Dagospia
l'11 settembre 2021. Quest’uomo ha una vagina. Sicuro. Pelosa. Guarda un po’ là
sotto? Eppure da sempre più fan è considerato sexy e virile. Lui piace perché è
maschio. Anche senza caz*o. Lui è uomo con la vagina. Un uomo che può farsi fare
– e si fa fare – la doppia penetrazione. Anale e vaginale. Godendo di entrambe.
Si può essere uomini senza pene e con vagina? Sì, da sempre, non solo da oggi,
anche se è da oggi, da poco, pochissimo tempo che se ne parla e che queste
persone hanno preso forza e coraggio di mostrarsi per quello che sono e non per
quello che sono stati registrati all’anagrafe e che la società vuole e si
aspetta da loro. Lui si chiama Trip Richards, ha 30 anni, è americano, ed è il
più famoso tra i pornostar trans-man. Trip è un uomo nato dentro un corpo (e un
sesso) da donna. Identità maschia che lui ha sempre avvertito nettamente dentro
di sé e che a 20 anni ha esplicitato iniziando il percorso di transizione. Trip
ha preso ormoni che gli hanno mutato il corpo facendo ciò che per un uomo nato
donna è nodale, basilare: arrestare il ciclo mestruale, modificare il petto, far
crescere tanti peli, barba, cambiare voce. Modificazioni estetiche
dall’importanza che trapassa l’estetica: sebbene con la transizione ormonale
Trip si sia “visto allo specchio e mi sono riconosciuto”, e sebbene “per la
prima volta mi sono sentito bene con me stesso”, per ogni persona trans, da
maschio a femmina o viceversa, il cambiamento estetico che gli fa ottenere un
corpo corrispondente alla propria, esatta identità, porta al dovuto
(ri)equilibrio di una vita fisicamente e psicologicamente vissuta in gabbia,
tutt’altro che autentica. Come molte altre persone trans, Trip non sente il
bisogno di cambiare sesso, di mettere al posto della sua vagina un pene
ricostruito e impiantato con parti di se stesso (nelle operazioni di cambio di
sesso, il clitoride è asportato, lavorato e poi usato come parte ricostruttiva
di un pene in cui conserva e permette stimolo e godimento sessuale). Trip sta
bene così, nella sua mascolinità a cui la sua “f*ghetta rosa e stretta” non
toglie nulla né disturba. Trip Richards non è entrato nel porno "perché" trans,
per il fatto di essere un uomo con una vagina ed essere nato con un corpo
anatomico "errato": lui ha iniziato a pornare in web-cam prima della
transizione, smettendo e tornando nel porno col suo corpo "giusto". Il porno non
c’entra con la sua storia identitaria e sessuale, sebbene il fatto di possedere
una vagina “là sotto!” lo faccia emergere in un settore pornografico di nicchia,
con un pubblico che lo segue fedele: gran parte si avvicina a lui, lo cerca nei
suoi social mosso da genuina curiosità e attrazione. E qui entra la missione di
vita di Trip Richards, quella di informare un mondo ancora troppo estraneo alle
realtà sessuali erroneamente chiamate "diverse", cioè tutte quelle identità che
non rientrano nel canone etero. Trip ha ragione da vendere a dire che i non
etero non hanno nulla di diverso, di meno o di più dei non etero, e che fino a
oggi è stata sbagliata la narrazione in cui i media mainstream li ha rinchiusi,
dando loro accettazione solo a patto che rientrassero in schemi da menti etero
stabiliti. Ma come far rientrare in un cammino a tappe etero qualunque
personalità non etero che per maturare ha dovuto affrontare (e affronta) un
percorso a ostacoli reso impervio proprio da una società etero- normata? Trip
Richards è una persona "non comune" per una certa mentalità, e che fa un lavoro
che ti stigmatizzano pure se a farlo sei etero, figurarsi trans-man. Trip
combatte brandendo il suo corpo come arma, a simbolo e prova, insieme al suo
passato: benché da adolescente fosse timido, con poche o nulle relazioni, e non
abbia fatto sesso prima del diploma, poi si è laureato e, dopo vari lavori
saltuari, tra cui escortaggio, è nel porno da sei anni. Attualmente Trip vive da
solo, è un lavoratore autonomo, cioè un performer porno che ha intero controllo
e responsabilità di ciò che fa (gira, anche con donne, con lo strap-on e falli
finti) e anche fa pissing (esce sempre da lì, uguale a prima): fa tutto quello
che nel porno una vagina può e sa e vuol fare, e poi lui dirige, sceglie dove e
con chi e come, si occupa di pre e post produzione. Oggi se fai porno da
professionista su piattaforme private, significa che non sei solo un attore
porno, bensì un imprenditore fatto e finito. Trip Richards al porno associa
l’attività di divulgatore (tramite social, interviste, podcast) che lui fa per
togliere le ragnatele sull’esistenza dei trans-man, uomini nati femmine che si
tengono la loro vagina e che amano uomini etero e non, ma pure donne, etero e
non. Nella sua vita privata, Trip Richards è un trans-man pansessuale,
tranquillo, casalingo, fin troppo: a lui piace starsene a casa, cucinare, fare i
lavori domestici, vedere le serie tv, e occuparsi dei 4 gatti diversamente abili
che ha preso con sé.
“Il dogma gender non si discute”. Gli
esperti rossi in audizione in Parlamento fanno muro.
Carlo Marini giovedì 8 Luglio 2021 su Il Secolo d'Italia. Arrivano tristi
conferme dall’audizione (in videoconferenza alla Commissione Infanzia della
Camera) sulle pratiche della transizione di genere dei soggetti minori di età.
Il dogma gender regna anche tra gli addetti ai lavori. Ne scrive oggi il
quotidiano La Verità, citando la seduta della commissione parlamentare per
l’Infanzia presieduta dal leghista Simone Pillon, convocata per far luce su
quelle linee guida che avevano suscitato clamore sia per l’impostazione –
favorevole al «cambio di sesso» dei minori con disforia di genere -, sia per le
prese di distanza da parte della Regione e dell’Azienda ospedaliera San Camillo
Forlanini di Roma. Il quotidiano riporta a mo’ di esempio, l’intervento del
dottor Luca Chianura. Il responsabile di Psicologia clinica presso il SAIFIP
(Servizio di adeguamento tra identità fisica ed identità psichica) del San
Camillo Forlanini di Roma. «Mi trovo un po’ a disagio, non capisco qual è il
senso di questa audizione», ha detto il dottor Chianura. Mistero fitto anche sul
rapporto, avviato dal 2005, tra il Saifip e il Tavistock, l’ospedale britannico
che ha seguito centinaia di «cambi di sesso» di minori. Tutto questo prima di
finire al centro di uno scandalo giudiziario. Sono diverse le denunce di ex
medici e di ex pazienti, che hanno denunciato d’essere stati prematuramente
avviati all’iter di riassegnazione sessuale. Lo stesso Chianura da una parte ha
preso le distanze dalla struttura britannica («noi abbiamo un protocollo
diverso»), ma dall’altra al Tavistock ha riservato parole d’encomio: «È ancora
oggi il punto di riferimento per tutti i servizi dell’età evolutiva del mondo».
Si è alzato un muro di gomma anche quando i commissari hanno chiesti ragguagli
sulla collaborazione del Saifip con lo psichiatra Domenico Di Ceglie, che del
Gids è stato direttore e che risulta vicino al gruppo autore delle linee guida
laziali. Linee che vorrebbero imporre il ddl Zan di fatto. «Di Ceglie è uno dei
massimi esperti della sua disciplina», ha minimizzato la psicoterapeuta
Maddalena Mosconi, responsabile “Area Minori” del SAIFIP presso l’A.O. San
Camillo Forlanini di Roma. Un buco nell’acqua anche quando i membri della
Commissione Infanzia hanno citato il caso di Keira Bell, trans pentita, che ha
citato i medici inglesi per danni. “Un caso isolato”, hanno tagliato corto gli
esperti. Guai a mettere in discussione il dogma gender.
Maria Teresa Martinengo per "la Stampa" l'8 luglio
2021. Il primo caso è arrivato nel 2005, il secondo nel 2007, un altro due anni
dopo. Poi sempre di più, fino a contarne 37 nel triennio 2019 - 2021 e 162 in
totale. È la crescita esponenziale delle famiglie con bambini, bambine, ragazzi
o ragazze con disforia di genere che si sono rivolte ai servizi torinesi
dedicati, quelli che possono aiutarle nell' accompagnare i loro figli e figlie a
comprendersi e a seguire il percorso che in una minoranza di casi, nella
maggiore età, può portare al cambiamento di sesso. Chi vive questa condizione
non percepisce la sua identità di genere come corrispondente all' assegnazione
avvenuta alla nascita. Le prime famiglie si sono rivolte al Cidigem, il Centro
Interdipartimentale Disturbi Identità di Genere dell'ospedale Molinette, mentre
dal 2009 è entrato in funzione l'ambulatorio Varianza di Genere dell'ospedale
infantile Regina Margherita, entrambi appartenenti alla Città della Salute e
della Scienza di Torino, i cui medici e psicologi collaborano e si confrontano.
Di questi tempi molto si discute di «identità di genere», ma rispetto ai minori
la questione emerge soprattutto attraverso vicende drammatiche. L'ultima, poche
settimane fa, dolorosissima, è stata quella di Orlando Merenda, diciottenne
torinese, morto suicida sotto un treno. «La domanda di aiuto da parte delle
famiglie oggi è diventata molto più frequente che in passato, e i centri, con le
forze che hanno, sono sommersi», racconta Damiana Massara, psicologa,
coordinatrice del Gruppo di lavoro minorenni del Cidigem (che accoglie dai 16
anni) e coordinatrice della Commissione Minorenni dell'Osservatorio Nazionale
sull' Identità di genere a cui fanno riferimento quasi tutti i centri italiani
dove è possibile effettuare l'intervento chirurgico. «L' osservazione dei 162
casi dice qualcosa: 100 sono minori "assegnate femmine alla nascita", 62 sono
"assegnati maschi". Un tempo si diceva maschi o femmine "biologici". Quando
abbiamo cominciato - prosegue Massara - era il contrario, arrivavano più maschi.
Le famiglie erano spaventate, si preoccupavano per loro, la condizione delle
femmine aveva meno risonanza. Nel tempo è cresciuta la sensibilità e oggi
arrivano le femmine». In questo momento sono 16 le famiglie che attendono un
primo colloquio al Regina Margherita. Per la dottoressa Massara non ci sono
cause «sociali» per questo aumento. «I casi sono tanti perché il servizio è
conosciuto dai pediatri, dagli psicologi, dalle stesse famiglie. Noi ne parliamo
in tutti i corsi che teniamo. Il problema è sempre esistito - osserva la
psicologa - ma ora viene affrontato e chiamato col suo nome. Cambiamento
significa riconoscimento della dignità, del rispetto. Tanti bambini e ragazzi
che non si sentono "nella norma" si isolano, non vanno più a scuola, hanno paura
di essere evitati, temono il bullismo. Il punto è riconoscere il loro travaglio,
assicurare loro lo spazio nella società, nella scuola». La neuropsichiatra
infantile Chiara Baietto, che coordina l'ambulatorio del Regina Margherita,
parla di «un percorso decisamente lungo, che per qualche bambino può
incominciare a 2-5 cinque anni, ma l'età media è 14-15 anni, ed è differente da
caso a caso. Le famiglie ci presentano il problema di un figlio che non si sente
di appartenere al sesso assegnato e chiedono una consulenza. Sono famiglie
attente, non liquidano la cosa proibendo comportamenti, ma cercano di capire».
Con i più piccoli lavoriamo per eliminare le paure in loro e nella famiglia,
facciamo prevenzione delle psicopatologie. Naturalmente, più i bambini e i
ragazzi crescono in un ambiente sereno, meno cadono in ansia, depressione, meno
mettono in atto tentativi di suicidio o forme di autolesionismo, molto comuni in
questi casi». La dottoressa Baietto spiega che «spesso il bambino o la bambina,
il ragazzo o la ragazza si sentono "strani". Per questo il percorso per
comprendere è molto lungo, capita che i ragazzi non sappiamo inquadrare il loro
problema e vadano per tentativi, vedono magari una persona transgender su
internet e dicono "forse sono così". Arrivando poi alla pubertà, solo un terzo
conferma la disforia di genere». Ancora: «La pubertà è il momento spartiacque.
Se dopo l'inizio l'adolescente si vive male si può intervenire con i farmaci
bloccanti, per dare ancora tempo al ragazzo o alla ragazza per considerare cosa
è meglio per lui o lei. Dai 16 anni si può avviare la terapia con ormoni che
inducono il sesso desiderato. La transizione non è certamente una scelta facile.
Tutto il percorso è molto complesso, comunque si risolva. Per questo in tutta
Italia i servizi dovrebbero essere più strutturati e numerosi».
Da "liberoquotidiano.it" il 10
luglio 2021. Tutta la follia gender riassunta dalla storia di Keira Bell, trans
inglese che ha cambiato sesso a soli 23 anni. Nata femmina, è diventata maschio
e oggi, a 23 anni, ha fatto causa alla clinica Tavistock and Portman NHS Trust
di Manchester, dove è stata operata perché a suo dire i medici non le avrebbero
spiegato nel dettaglio tutte le implicazioni e le ripercussioni di una scelta
così radicale, maturata da adolescente. Keira ha raccontato al sua storia al
seguitissimo show mattutino Good morning Britain del canale Itv: "Non si possono
prendere decisioni simili a 16 anni, così in fretta. I ragazzi a quell’età
devono essere ascoltati e non immediatamente assecondati. Io ne ho pagato le
conseguenze, con gravi danni fisici. Ma così non va bene, servono cambiamenti
seri". "Era il percorso sbagliato", ammette ora la ragazza diventata ragazzo.
"Ero molto depressa da ragazzina, non mi sentivo a mio agio nel mio corpo da
donna e così ho sviluppato presto una disforia di genere", riconosce la 23enne,
che accusa poi le autorità sanitarie: "Non c’è stato un vero esame psichiatrico
nei miei confronti, è stato tutto così rapido e basato sul mio passato. Non c’è
mai stata una vera discussione: i miei sentimenti dovevano essere scandagliati e
non semplicemente accettati per quello che erano. Perché quando inizi il
percorso, poi è molto complicato tornare indietro". Con buona pace di chi crede
che la vita si possa decidere già quando si è ancora bambini, come fosse
semplicemente una scuola da cambiare nel caso non andasse come sperato.
Si fa presto a dire Zan, la clinica
inglese dei gender riconosce: “Certi cambi di sesso affrettati”.
Luisa Perri mercoledì 7 Luglio 2021 su Il Secolo d'Italia. Sul
palmo della mano al posto del Ddl Zan dovrebbero scrivere Keira Bell. E’ il nome
della trans pentita, che a 16 anni fu indotta a cambiare sesso. E che ora ha
fatto causa alla clinica britannica Tavistock, considerata la Mecca dei
minorenni gender.
Il caso di Keira Bell, trans “pentita”. Keira,
nata biologicamente di sesso femminile, da bambina si è sentita uomo. Così, ad
appena 16 anni, ha deciso di cambiare sesso. La clinica a cui si è rivolta, la
Tavistock and Portman NHS Trust, ha approvato abbastanza velocemente la sua
decisione di intraprendere il suo percorso transgender. Ora, però, Keira, che
nel frattempo di anni ne ha 23, si è pentita della scelta fatta, accusando le
autorità mediche di aver “acconsentito troppo presto al desiderio di cambio di
identità e di genere”. “Ero troppo giovane per decidere, non dovevano
assecondarmi. Non si possono prendere decisioni simili a 16 anni, e così in
fretta. I ragazzi a quell’età devono essere ascoltati, e non immediatamente
assecondati”, ha dichiarato Keira a Good Morning Britain su Itv.
Le dichiarazioni allarmanti dalla clinica di
Londra. Per il trattamento dei casi della cosiddetta disforia di genere la
clinica di Londra è un punto di riferimento in Europa. In questo centro bambini
e ragazzi, in un’età compresa fra i 24 mesi e i 17 anni, vengono sottoposti a
terapie per cambiare sesso. Dal 2014 al 2019, sono stati 2.500 tra bambini e
adolescenti e il fenomeno è in aumento. Uno psicologo che ha lavorato presso la
stessa clinica Tavistock, ha confidato al Times dei suoi timori che la clinica
stesse eseguendo una “terapia di conversione per bambini gay”. Il dottor Matt
Bristow ha affermato di temere che la clinica Tavistock e Portman NHS stesse
ignorando la possibilità che i ragazzi e le ragazze che hanno affermato di voler
cambiare sesso possano essere semplicemente gay. L’affermazione di Bristow è
emersa nelle dichiarazioni dei testimoni per Sonia Appleby, una psicoterapeuta
responsabile della salvaguardia dei bambini presso la clinica per l’identità di
genere, che sta facendo causa alla fiducia. La scorsa settimana ha detto a un
tribunale del lavoro di essere stata “denigrata” per aver sollevato
preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini sottoposti a trattamento, che
includeva la clinica che segnalava bambini di appena 12 anni per farmaci che
bloccavano la pubertà. Come riferisce Panorama, un’indagine interna, voluta dal
dottor Dinesh Sinha, a capo del Tavistock and Portman Nhs Trust ha raccolto
“decine di testimonianze di medici e infermieri, tutti dubbiosi sull’effettiva
moralità dei trattamenti ormonali per bambini e bambine affetti da presunta
disforia di genere. Bambini magari depressi, anoressici o autistici o
semplicemente incerti, incoraggiati a una transizione senza ritorno. Il tutto in
nome di una tendenza, di una propaganda. Anzi, forse di una moda”. E mentre in
Gran Bretagna si riconoscono gli errori qui, con le lezioni di transomofobia
imposte con la legge Zan, si vorrebbe fare lo stesso.
La Ferragni parla del Ddl Zan, ma sa di che cosa
parla? Il caso di Keira non è l’unico, in merito ai danni fisici procurati dagli
ormoni bloccanti. Come riporta il sito Provita e famiglia, l’endocrinologo
Michael Laidlaw, ha pubblicato sui Social i dati sulla fascia d’età dei giovani
transgender, ai quali erano stati somministrati i farmaci, in età compresa tra i
di 12 e i 15 anni. Lo studio in questione, come spiega Laidlaw, avrebbe
confermato una “massiccia diminuzione della densità ossea di questi pazienti
rispetto ai loro coetanei”, tramite un grafico che ne mostrava la diminuzione
graduale nel tempo, soprattutto sulla spina dorsale. Quello che la Ferragni di
turno non dice è che si fa presto a scrivere “Ddl Zan” sul palmo della mano.
Tornare indietro, per molti bambini e ragazzi, sarebbe troppo tardi.
Adriana Marmiroli per “La Stampa” il 16 giugno
2021. Non un solo giorno e una grande manifestazione di massa, colorata,
allegra, danzante, talvolta sfacciata. Quest' anno più che mai, in memoria dei
fatti dello Stonewall Inn del 1969, il Gay Pride è tutto un mese, giugno, e
tanti appuntamenti diffusi: Covid sconsiglia le grandi masse che si accalcano.
«L'onda Pride è pronta a travolgerci», proclamano comunque gli organizzatori.
Tra ddl Zan di cui sollecitare l'approvazione e crescenti atti di omofobia, la
guardia va tenuta alta, i diritti proclamati. Anche - e mai come quest' anno -
in tv, dove tra Disney + e Netflix molte sono le serie che rievocano la
battaglia per l'eguaglianza. A partire dalla serie documentaria Pride, che
Disney+ lancia in Italia il 25 giugno: in sei episodi, decennio dopo decennio,
ricostruisce 70 anni di lotte per l'eguaglianza del mondo LGBTQI+ americano.
Dagli anni postbellici dell'omofobia di Stato e delle persecuzioni pianificate
dal senatore McCarthy al nuovo millennio della conquistata visibilità mediatica
(come non ricordare l'importanza di serie come Tales of the City, Will & Grace,
Modern Family, L Word, Orange Is New Black, Grace & Frankie, Transparent?) e
della nuova sensibilità, con l'erompere delle tematiche cisgender, ma anche gli
arretramenti del trumpismo e delle nuove destre estreme. Celebra (e piange) un
momento cruciale della storia LGBTQI+ anche Pose: Netflix programma le prime due
stagioni, mentre la terza e ultima è ancora senza data, forse in autunno. In
America invece è stata lanciata proprio in questo periodo. Ideata da Ryan
Murphy, Brad Falchuk e Steve Canals, nel 2018 ha portato in primo piano il mondo
queer, facendo dei suoi protagonisti delle star: MJ Rodriguez, Indya Moore,
Dominique Jackson, Billy Porter, primo uomo dichiaratamente gay ad avere vinto
l'Emmy. Nella prima stagione c'era il «vogueing», la follia vitale e
trasgressiva delle «ballroom» dell'underground newyorchese degli Ottanta, e
insieme l'orgoglio di esserci e contare di donne e uomini, neri e ispanici,
emarginati e rifiutati. Nella seconda c'era soprattutto l'irrompere dell'Aids:
scioccanti le immagini di Hart Island, l'isola-cimitero dei «morti di nessuno»
dove New York seppelliva le vittime dell'Aids (e oggi di Covid-19). Con la terza
stagione si passa al 1994: l'Hiv è strage di massa, le troppe morti non si
riescono più a elaborare, c'è rassegnazione e rabbia. Ballroom e vogueing sono
decaduti. La vita ha imposto nuove scelte alla protagonista, Blanca: la cura dei
sieropositivi, l'impegno come attivista per la diffusione a tutti e a poco delle
nuove cure salvavita anti Aids, anche se le ballroom restano nel cuore. «Fin
dall'inizio è stato un progetto di passione - ha detto Murphy -, uno dei momenti
più creativi della mia carriera. Abbiamo potuto raccontare la storia che
volevamo, come volevamo. Portare un personaggio LGBTQ in tv era quasi
impossibile. E invece, con il più grande cast LGBTQ mai ingaggiato, abbiamo
fatto la storia della tv e del costume». Minimizza Canals, che del progetto è il
vero ideatore: «Non volevo cambiare la tv, ma solo raccontare una storia sulla
famiglia, la resilienza, l'amore». Più radicale, da attivista qual è, la regista
Janet Mock, prima transgender di colore a dirigere e sceneggiare un episodio tv:
«Stiamo combattendo per un mondo in cui le persone trans siano accettate. Perché
queste donne - prima outsider, rinnegate e pioniere - possano dire di esserci e
di realizzarsi». E c'è ancora Ryan Murphy, produttore e sceneggiatore, dietro ad
Halston (Netflix), altra serie che racconta gli Anni 80, l'Aids, la genialità di
una personalità gay «bigger than life». Ma qui si parla di moda e dell'upper
side di New York: quasi il contraltare di Pose. Con Warhol e il Club 54 come
punti di contatto. Ma anche Roy Halston Frowick, star del fashion Usa negli Anni
70 e 80 (nella serie interpretato da Ewan McGregor rimasto affascinato, dice,
«dalla sua straordinaria creatività e dedizione al suo lavoro»), era un
outsider. Famoso per avere creato il cappello a tamburello tanto amato da
Jacqueline Kennedy, fondò una propria casa di moda e la perse, ebbe stile
inconfondibile e rivoluzionario. Amico di Liza Minelli, Andy Warhol, Martha
Graham, fu lui stesso personaggio dello star system. Eppure fu schiacciato da un
senso di inadeguatezza che lo portò all'autodistruzione. A fine Anni Ottanta
creò bellissimi costumi per le coreografie della Graham: il suo canto del cigno.
Come gli outsider di Pose fu anche lui vittima dell'Aids nel 1990. Ed è giusto
ricordarlo nei giorni di un Gay Pride nuovamente minacciato da un virus.
Ddl Zan, Renato Farina dalla parte di
Giorgia Meloni: "Perché ha ragione", ecco l'imbroglio sinistro.
Renato Farina Libero Quotidiano il 04 maggio 2021. «La nuova
legge alimenta la censura» La verità elementare sulla censura e la guerra alla
libertà di pensiero e di parola l'ha detta Giorgia Meloni. «Parla di censura chi
vorrebbe introdurre con il ddl Zan la censura per legge e punire con il carcere
chi non si allinea al pensiero dominante». A queste parole tutti si alzano
indignati a dire: non è vero, ma è una furbizia dialettica, un modo per stare
nei binari della Costituzione. Questo disegno di legge già approvato alla
Camera e oggi sul tavolo dei senatori non è così sfacciato. Non dice: vi
censuro, e vi mando in galera per le vostre opinioni. Ma è già adesso un
permesso all'aggressione verbale e alla reclusione morale nel lazzaretto dei
malati nella testa, di chi non scatta negli applausi verso chi non è pronto a
scattare in un applauso entusiasta alle tesi sul sesso fluido e l'educazione
gender (stimolare la decisione a quale genere appartenere sin dall'asilo, a
prescindere dal sesso biologico) e l'utero in affitto che sono l'ipertesto non
dichiarato del disegno di legge (ddl) Zan, di cui il Concertone dei sindacati è
stato il manifesto appeso grazie alla Rai nelle case degli cittadini, e senza
contraddittorio.
SOLO UNO SPOT. Ha detto Meloni al Messaggero: «Il
Concertone è stato usato come pretesto per battaglie ideologiche, come il ddl
Zan, che non c'entrano nulla con il lavoro e i diritti dei lavoratori. Il tutto
sulla tv pubblica e a spese degli italiani. In questo contesto c'è chi usa quel
palco per farsi pubblicità e confezionarsi un megaspot, utile per affermarsi
ulteriormente nei circuiti che contano». Questa ideologia è stata perfettamente
visibile nelle proclamazioni, cosiddetta trasgressiva perché in topless e con il
fiocchetto sui cap**li con i colori arcobaleno della "libertà di amare", come se
ci fosse una legge che lo vieta e impedisce espressione dei sentimenti. Nelle
dichiarate intenzioni il ddl Zan vorrebbe punire le discriminazioni e aggravare
le pene per reati di violenza contro disabili, omosessuali e transessuali
(peraltro le aggravanti ci sono già, e giustamente, non solo nel codice ma nella
prassi dei tribunali). E allora perché questa urgenza? Lo scopo di questa norma
che ha per primo firmatario il deputato del Partito democratico Alessandro
Zan (socio di una ditta che organizza il Padova Pride, fonte L'Espresso) è
l'imposizione del catechismo della morale politically correct. Essa, come
dimostrano le censure inflitte ad esempio dall'Ordine dei giornalisti, ancora
non c'è, ma è già fatta valere come una spada morale per sbudellare i
diversamente pensanti. La punizione in realtà non è ancora penale ma tutto
lascia intendere che un avviso di garanzia a chi parla contro il matrimonio omo
sessuale, le adozioni per coppie gay o lesbiche con annesso il diritto ad aver
figli con l'utero in affitto, non mancheranno. Come si spiega questa urgenza? La
sinistra e i 5 Stelle temono di non riuscire a condurre a termine il programma
di vaccinazione forzata delle loro idee sulla vita e sulla famiglia. Persino le
inoculazioni anti-Covid sono su base volontaria, invece qui si vuole iniettare
l'ideologia nel popolo con la minaccia di sanzioni e piantando uno spillone
voodoo per isolare socialmente chi abbia idee suscettibili di essere definite
omofobe.
ESEMPIO PRATICO. Un esempio pratico? Tempo fa lo
aveva spiegato la stessa Meloni: «Vengo definita omofoba decine di volte al
giorno solo perché considero l'utero in affitto una pratica barbara. Questo non
vuol dire che odi qualcuno, ma che voglio soltanto difendere il sacrosanto
diritto di un bambino ad avere un padre e una madre. Per amore, e non per odio,
conduco queste battaglie. Siamo davanti ad una proposta di legge profondamente
sbagliata, che rischia di creare davvero delle discriminazioni e dei
cortocircuiti incredibili». Basti leggere l'articolo 4 intitolato «Pluralismo
delle idee e libertà delle scelte» per capire a cosa si riferisce la leader di
FdI: «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di
convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al
pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a
determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o
violenti». Se si sente il bisogno di precisare l'ovvio significa che l'impianto
trascina in una situazione di regime da pensiero unico. E la frasetta finale è
minacciosa. Parole che spingano «al concreto pericolo di atti discriminatori»,
che vuol dire? È discriminante vietare l'utero in affitto? È pericoloso, dunque
sarebbe reato, mobilitarsi per contestare questa pratica? Chi lo decide? Fedez?
Gender: da Soros in su, ecco brand e
imprenditori che sponsorizzano la causa. E fanno business.
Bianca Conte mercoledì 26 Maggio su Il Secolo d'Italia. Causa
trans e business: da Soros in su, sono molti e tutti degni di nota, i brand e
gli imprenditori che sponsorizzano la crociata gender e il suo giro d’affari
socio-umanitari, oltre che particolarmente rispondenti a logiche politiche e di
marketing. Del resto, è vero: le idee camminano sulle gambe degli uomini, come
ebbe a dire il grande Giovanni Falcone all’epoca delle sue inchieste. Ma senza i
soldi di alcuni Paperoni mondiali non arriverebbero molto lontano, si potrebbe
aggiungere oggi. E allora, sempre seguendo gli insegnamenti e le strategie del
magistrato siciliano, urge anche rispolverare il metodo «follow the money». Ed è
proprio partendo da questo presupposto che Francesco Borgonovo, vice direttore
de La Verità, muove i suoi circostanziati passi alla ricerca di flussi e
transazioni di denaro che hanno «ridato motivazioni a tante Ong arcobaleno ormai
a corto di obiettivi». E da Soros a Stryker. Da aziende e istituzioni. Tra
passaggi societari ascrivibili al mondo dell’attivismo Lgbt, l’inchiesta
giornalistica indica tutti i «ricchi maschi bianchi» affezionati alla causa. E
altrettanti finanziamenti utili alla causa gender…
Trans, il business e i numeri del censimento.
Tutto parte, nella ricostruzione de La Verità, all’inizio del 2020: quando
l’Università di Firenze. L’azienda ospedaliera Careggi. La fondazione The
bridge. L’Osservatorio nazionale sull’identità di genere e l’Istituto superiore
di sanità, hanno dato il via a un’indagine chiamata Spot. Ossia: «Stima della
popolazione transgender adulta in Italia». Lo scopo dello studio mirava a
ricostruire, in una sorta di censimento, quanti fossero effettivamente – a
transizione avvenuta o in procinto di raggiungimento – i transgender sul
territorio italiano. Ebbene, come riferisce il quotidiano diretto da Maurizio
Belpietro, «nel presentare l’indagine, Marina Pierdominici dell’Istituto
superiore di sanità, parlando con Repubblica, azzardò una stima: «I dati della
letteratura scientifica internazionale suggeriscono che la percentuale di
popolazione transgender dovrebbe essere compresa tra lo 0,5 e l’1,2% del totale.
Se confermata anche nel nostro Paese, consterebbe in circa 400.000 italiani».
Una cifra che rimanda a percentuali piuttosto basse. E allora, la domanda sorge
spontanea: al di là del fatto incontrovertibile secondo cui anche le minoranze
hanno diritto e necessitano di rappresentanza, come mai la crociata gender ha,
specie da un punto di vista mediatico, tanta rilevanza e spazi ad hoc nel mondo
dell’intrattenimento televisivo? E, soprattutto, come e perché si è approdati al
punto di asserire come improcrastinabile la necessità di una legge che, come
prima cosa, prevede l’autodeterminazione dell’identità di genere, idea
chiaramente caldeggiata dai movimenti trans, ma altrettanto palesemente invisa
in chiave bipartisan, da molti sia a destra che a sinistra?
Causa trans e business mondiale, il ruolo della
britannica Stonewall. Ma tant’è: ci si domanda, però, come sia possibile che
argomenti come quello del «gender Id» siano diventati prioritari nel dibattito
politico, nonostante la evidente residualità numerica asserita negli studi
statistici? Domande che si affastellano a domande e che alimentano una
discussione che va ben oltre i limiti etici e giuridici. Sui cui aspetti
economici l’inchiesta de La Verità rileva quanto segue: «La prima organizzazione
a compiere un massiccio investimento sulla promozione delle istanze trans è
stata la britannica Stonewall, una delle più grandi in Europa».
L’ombra di uno «scarso impegno sui diritti
transgender». E ancora: «Proprio in questi giorni la Commissione per
l’uguaglianza e i diritti umani (Ehrc) britannica – finanziata con denaro
pubblico – ha cancellato la sua adesione al programma «Diversity champions»
di Stonewall. Il motivo ufficiale è il cattivo rapporto qualità-prezzo del
servizio. In realtà dietro la rottura ci sono tensioni legate soprattutto alle
questioni trans, dato che Stonewall ha pubblicamente criticato l’Ehrc per il suo
presunto scarso impegno sui diritti transgender». Dunque, a parte il fatto
che La Verità sottolinea che l’associazione britannica in questione, che nasce
nel 1989 con l’obiettivo di occuparsi per lo più di gay e lesbiche, ha iniziato
a occuparsi di problematiche trans dopo il 2013, cioè l’anno in cui nel Regno
Unito sono state approvate le unioni omosessuali.
Il contributo delle Associazioni sostenute anche
da denaro pubblico. Va detto, più in generale, che la causa transgender nel
tempo è riuscita ad avocare a sé spazi e protagonisti per associazioni Lgbt
molto influenti. Che rischiavano di venire depauperati, almeno in parte, e il
loro operato svuotato di senso. «Queste associazioni – scrive infatti Borgonovo
– sostenute pure da soldi pubblici (come nel caso della britannica Mermaids che
si occupa di ragazzini con varianza di genere), hanno conquistato negli anni un
forte peso mediatico e politico, e lo sfruttano con furbizia e un pizzico di
cinismo». Il punto, allora, resta quello dell’importanza. Quasi della centralità
che il tema ha acquisito. Prendendo piede dal punto di vista sociale, anima
istituzionale e corpo economico. Per cui, per esempio, sottolinea l’inchiesta
giornalistica in oggetto, «attualmente del programma Diversity champions fanno
parte circa 850 aziende e istituzioni: Stonewall (dietro pagamento di una quota)
offre loro consigli su come «gestire le diversità», poi emette una sorta di
bollino arcobaleno. Iniziative come queste hanno contribuito a creare un
patrimonio di circa 8 milioni di sterline».
Il ruolo della Open society foundations di George
Soros. Ma non è ancora tutto. Perché l’improvvisa accelerazione che la crociata
trans ha registrato negli ultimi tempi non può essere giustificata soltanto con
l’ausilio del lavoro promosso da associazioni Lgbt particolarmente attive e
capaci. Dietro, infatti, secondo il lavoro svolto da Borgonovo, ci sarebbero
anche «organizzazioni dotate di notevole potere economico, ad esempio la
solita Open society foundations di George Soros». E su questo, Borgonovo, cita
cifre e dati ben precisi. Quelli, per esempio, riferiti già da Kelly Riddell
Sadler – giornalista, già consulente per la comunicazione di Donald Trump alla
Casa Bianca – il quale diede sostanza numerica a dubbi e ipotesi, «calcolando
che tra il 2013 e il 2016 Soros avesse finanziato associazioni come la Gay
straight alliance (100.000 dollari nel solo 2013) o la Gate (Global action for
trans equality, 244.000 dollari nello stesso periodo)». Tutto verificabile,
rilancia La Verità: «Del resto basta farsi un giro sul sito di Open society per
trovare più di un articolo in cui si sostiene che è tempo di «dare all’attivismo
trans il supporto di cui ha bisogno».
Trans e business, tutti gli imprenditori al soldo
della causa. Un business, quello legato al mondo Lgbt che si è incrementato nel
tempo e dilatato nello spazio. E che, a un certo punto, registra un’impennata
che fa parlare proprio di svolta, dovuta soprattutto al contributo dell’attività
svolta da Arcus. Una Ong, illustra Borgonovo nel suo ampio servizio, «fondata e
curata da Jon Stryker, ricco magnate dell’industria sanitaria. Come ha
documentato la giornalista e attivista Jennifer Bilek (i cui articoli sono stati
ben sintetizzati da Feministpost.it), “tra il 2016 e l’aprile 2021 Arcus ha
investito quasi 74 milioni di dollari in promozione della giustizia sociale. La
maggior parte dei suoi beneficiari avevano a che vedere con l’ideologia
dell’identità di genere”».
La crociata trans, un business a livello globale.
Non solo. A detta del servizio, «Arcus è stata una delle principali promotrici
della causa trans a livello globale. Finanzia associazioni Lgbt storiche e
potenti come Ilga. Arcus ha sovvenzionato anche la britannica Stonewall. Arcus,
nel 2013, «ha scelto come direttore del programma internazionale per i diritti
umani Adrian Coman, proveniente dalla Open society foundations. Nel 2015,
invece, la Arcus ha raccolto 20 milioni di dollari per la New global trans
iniziative in collaborazione con una fondazione chiamata Novo, che si occupa
anche di sostenere Black lives matter e altri movimenti analoghi».
Tutti i Paperoni che foraggiano la causa trans e
il suo business. Ebbene la Arcus haq il suo padre nobile nella figura di Peter
Buffett, figlio di Warren Buffett. Ma nbon sarebbe il solo Paperone a foraggiare
la causa trans. «Secondo Jennifer Bilek – riferisce infatti La Verità – , dietro
l’esplosione delle istanze trans ci sarebbero principalmente “uomini. Bianchi.
Estremamente ricchi e con un’enorme influenza culturale”. Tra cui il già citato
Soros, Jennifer Pritzker (imprenditore trans con un patrimonio da due miliardi
di dollari circa). L’attivista, imprenditrice e transumanista orgogliosa Martine
Rothblatt. L’imprenditore Tim Gill (il primo gay dichiarato nella lista dei 400
ricchissimi di Forbes). In effetti, tutti costoro risultano finanziare e
spalleggiare a vario titolo i movimenti transgender.
Ecco i brand e le firme illustri che appongono il
marchio di fabbrica alla crociata trans. E insieme a loro, compaiono le sigle di
grandi holding. Perché La causa trans gode del sostegno, se non altro
propagandistico e mediatico, di alcune tra le più grandi aziende del mondo. Come
dimostrato quando, nel «settembre 2020, Stonewall ha organizzato un grande
evento a sostegno della causa trans intitolato «Trans rights are human rights».
Lo hanno sostenuto 136 grandi aziende tra cui Amazon, Aviva, Citi, Google,
Deliveroo, Deloitte, Microsoft, JP Morgan, Disney, Visa, P&G, Zurich». Brand e
marchi illustri che hanno apposto il loro marchio di fabbrica sulla causa
gender. Insieme ad altre grandi firme, scrive Borgonovo, «schierate
politicamente per bloccare “le leggi che influenzerebbero l’accesso alle cure
mediche per le persone transgender. I diritti dei genitori. I servizi sociali e
familiari. Gli sport studenteschi o l’accesso a strutture pubbliche come i
bagni”. Tra queste ci sono Apple, Airbnb, Dell, Facebook, Hilton, Ibm, Ikea,
Nike, Pepsi, Pfizer, Uber, Unilever, Wells Fargo. Nulla di illegale».
Semplicemente tutti sono concordi nell’alimentare un business su cui si urla
tanto alla congiura. Ma che, a ben vedere, ha più crociati al suo soldo che
frondisti contro. Tutti solerti nel foraggiare e godere di un business che di
sicuro non langue…
Francesco Borgonovo per "la Verità" il 26 maggio
2021. All' inizio del 2020, l' Università di Firenze, l' azienda ospedaliera
Careggi, la fondazione The bridge, l' Osservatorio nazionale sull' identità di
genere e l' Istituto superiore di sanità hanno dato il via a un' indagine
chiamata Spot, cioè «Stima della popolazione transgender adulta in Italia». A
che cosa serve la ricerca? Ovvio: a fare un censimento dei trans sul territorio
italiano, perché ad oggi non sappiamo esattamente quante siano le persone che
hanno modificato il proprio genere o sono in procinto di farlo. Nel presentare
l' indagine, Marina Pierdominici dell' Istituto superiore di sanità, parlando
con Repubblica, azzardò una stima: «I dati della letteratura scientifica
internazionale suggeriscono che la percentuale di popolazione transgender
dovrebbe essere compresa tra lo 0,5 e l' 1,2% del totale. Se confermata anche
nel nostro Paese, conterebbe circa 400.000 italiani». I numeri sono in aumento,
soprattutto per quel che riguarda i minorenni, ma parliamo ancora di percentuali
piuttosto basse. Viene da chiedersi, allora, come mai la causa trans goda di
così tanta pubblicità a livello mediatico e ottenga tanto spazio nel mondo dell'
intrattenimento, soprattutto quello di marca statunitense. Chiaro: una fetta di
popolazione, per quanto esigua sia, ha comunque diritto a essere rappresentata.
Però qui si parla addirittura di approvare una legge che, come prima cosa,
prevede l'autodeterminazione dell' identità di genere, idea carissima ai
movimenti trans ma avversata da molti sia a destra sia a sinistra. Ci si domanda
allora come sia stato possibile che temi come quello del «gender Id» siano
diventati centrali nel dibattito pubblico nonostante l' evidente marginalità sul
piano statistico (la quale permetterebbe, per giunta, di seguire adeguatamente e
con rispetto ogni singola situazione, senza bisogno di nuove norme che impongano
discutibili decostruzioni della natura umana).
Il ruolo di Stonewall. La prima organizzazione a
compiere un massiccio investimento sulla promozione delle istanze trans è stata
la britannica Stonewall, una delle più grandi in Europa. Proprio in questi
giorni la Commissione per l' uguaglianza e i diritti umani (Ehrc) britannica -
finanziata con denaro pubblico - ha cancellato la sua adesione al programma
«Diversity champions» di Stonewall. Il motivo ufficiale è il cattivo rapporto
qualità-prezzo del servizio, in realtà dietro la rottura ci sono tensioni legate
soprattutto alle questioni trans, dato che Stonewall ha pubblicamente criticato
l' Ehrc per il suo presunto scarso impegno sui diritti transgender. Attualmente
del programma «Diversity champions» fanno parte circa 850 aziende e istituzioni:
Stonewall (dietro pagamento di una quota) offre loro consigli su come «gestire
le diversità», poi emette una sorta di bollino arcobaleno. Iniziative come
queste hanno contribuito a creare un patrimonio di circa 8 milioni di sterline.
L' associazione britannica, che dalla nascita nel 1989 si è occupata per lo più
di gay e lesbiche, ha iniziato a spingere sui temi trans dopo il 2013, cioè l'
anno in cui nel Regno Unito sono state approvate le unioni omosessuali. Come ha
scritto Jo Bartosch su Spiked, «quando Ruth Hunt è stata nominata Ceo di
Stonewall nel 2014, si è trovata a capo di un ente di beneficenza ricco di
personale e denaro ma improvvisamente privo di una causa. Hunt ha trovato la
nuova causa - e i donatori - grazie alla "lotta" per i diritti dei trans». Ecco
una prima risposta al quesito iniziale: la causa trans crea nuovi spazi per
associazioni Lgbt molto influenti che rischiavano di esaurire, almeno in parte,
la propria funzione. Queste associazioni, sostenute pure da soldi pubblici (come
nel caso della britannica Mermaids che si occupa di ragazzini con varianza di
genere), hanno conquistato negli anni un forte peso mediatico e politico, e lo
sfruttano con furbizia e un pizzico di cinismo. Ma dietro l' exploit trans non
ci sono soltanto associazioni Lgbt particolarmente scaltre. Ci sono anche
organizzazioni dotate di notevole potere economico, ad esempio la solita Open
society foundations di George Soros. Kelly Riddell Sadler - giornalista, già
consulente per la comunicazione di Donald Trump alla Casa Bianca - calcolò che
tra il 2013 e il 2016 Soros avesse finanziato associazioni come la Gay straight
alliance (100.000 dollari nel solo 2013) o la Gate (Global action for trans
equality, 244.000 dollari nello stesso periodo). Tutto alla luce del sole,
ovviamente. Del resto basta farsi un giro sul sito di Open society per trovare
più di un articolo in cui si sostiene che è tempo di «dare all' attivismo trans
il supporto di cui ha bisogno». Come farlo? Ad esempio sostenendo iniziative
come l' International trans fund, che riunisce attivisti da tutto il mondo.
La svolta improvvisa. Le sigle arcobaleno hanno
cominciato a ottenere maggiori donazioni già all' inizio degli anni Duemila. Ma
se fino al 2013/2014 - lo scrive sempre Open society - le associazioni trans
potevano contare su budget che in media si aggiravano intorno ai 10.000 dollari
l' anno, da quel momento le cose hanno iniziato a cambiare. E se la situazione è
mutata lo si deve molto all' attività di Arcus, una Ong fondata e curata da Jon
Stryker, ricco magnate dell' industria sanitaria. Come ha documentato la
giornalista e attivista Jennifer Bilek (i cui articoli sono stati ben
sintetizzati da Feministpost.it), «tra il 2016 e l' aprile 2021 Arcus ha
investito quasi 74 milioni di dollari in promozione della giustizia sociale. La
maggior parte dei suoi beneficiari avevano a che vedere con l' ideologia dell'
identità di genere». Arcus è stata una delle principali promotrici della causa
trans a livello globale. Finanzia associazioni Lgbt storiche e potenti come Ilga
(una sorta di sigla ombrello che riunisce tantissimi gruppi arcobaleno di tutto
il mondo), la quale guarda caso ha da poco espulso dalla sezione europea le
femministe di Arcilesbica, considerate «trans escludenti». Arcus ha
sovvenzionato anche la britannica Stonewall: ben 142.000 dollari versati «appena
prima che ampliasse il suo mandato per coprire le questioni transgender». Nel
2013, Arcus ha scelto come direttore del programma internazionale per i diritti
umani Adrian Coman, proveniente dalla Open society foundations. Nel 2015,
invece, la Arcus ha raccolto 20 milioni di dollari per la New global trans
initiative in collaborazione con una fondazione chiamata Novo, che si occupa
anche di sostenere Black lives matter e altri movimenti analoghi. Sapete chi l'
ha fondata? Peter Buffett, figlio di Warren Buffett. Secondo Jennifer Bilek,
dietro l' esplosione delle istanze trans ci sarebbero principalmente «uomini,
bianchi, estremamente ricchi e con un' enorme influenza culturale», tra cui il
già citato Soros, Jennifer Pritzker (imprenditore trans con un patrimonio da due
miliardi di dollari circa); l' attivista, imprenditrice e transumanista
orgogliosa Martine Rothblatt, l' imprenditore Tim Gill (il primo gay dichiarato
nella lista dei 400 ricchissimi di Forbes). In effetti, tutti costoro risultano
finanziare e spalleggiare a vario titolo i movimenti transgender.
Le grandi corporation. Non sono i soli. La causa
trans gode del sostegno, se non altro mediatico, di alcune tra le più grandi
aziende del mondo. Nel settembre 2020, Stonewall ha organizzato un grande evento
a sostegno della causa trans intitolato «Trans rights are human rights». Lo
hanno sostenuto 136 grandi aziende tra cui Amazon, Aviva, Citi, Google,
Deliveroo, Deloitte, Microsoft, JP Morgan, Disney, Visa, P&G, Zurich All' inizio
di maggio, un altro centinaio di corporation hanno firmato un documento di
protesta contro gli Stati americani che avevano approvato leggi «anti Lgbtq»,
con particolare attenzione alle norme riguardanti «i giovani transgender». In
sostanza queste aziende (così spiegano in una dichiarazione congiunta) si sono
schierate politicamente per bloccare «le leggi che influenzerebbero l' accesso
alle cure mediche per le persone transgender, i diritti dei genitori, i servizi
sociali e familiari, gli sport studenteschi o l' accesso a strutture pubbliche
come i bagni». Tra queste ci sono Apple, Airbnb, Dell, Facebook, Hilton, Ibm,
Ikea, Nike, Pepsi, Pfizer, Uber, Unilever, Wells FargoNulla di illegale. E
nessun complotto, per carità. Però quando si parla di persecuzioni,
discriminazioni e ingiustizie, beh, forse conviene un po' abbassare i toni.
Il dibattito sul ddl zan. L’identità di
genere merita riflessione, c’è il rischio caos.
Giovanni Guzzetta su Il Riformista il 26 Maggio 2021. La radicalizzazione dello
scontro politico sul ddl Zan è particolarmente grave perché sta trasformando una
questione delicatissima in un conflitto manicheo all’insegna della
semplificazione. Rischiano così di rimanere schiacciate le due dimensioni reali
che dovrebbero interessare. La prima è quella della comprensione dei fenomeni
che si intende disciplinare. La seconda è quella degli specifici problemi
tecnico-giuridici per farlo. Il primo aspetto è oggetto di un dibattito che
interessa non solo la cultura e gli orientamenti sociali, ma anche settori
disciplinari specifici come la sociologia, la psicologia e persino la filosofia.
È noto che tale dibattito, legato agli studi di genere, non è recente, ma è
altrettanto noto che nel tempo si è andato arricchendo di nuovi contenuti e
“frontiere”. Non è un caso ad esempio che la American Psychological
Association (Apa) solo nel dicembre 2015 abbia diramato delle linee guida per i
propri associati su come affrontare il fenomeno delle persone Transgender e Non
conforming, coloro cioè che abbiano un’ “identità di genere non completamente
allineata con quella del sesso loro riconosciuto alla nascita”. Nel 2017, una
speciale inchiesta del National Geographic è stata dedicata alla Gender
Revolution in tutto il mondo. In quel contesto, Susan Goldberg ricordava come
l’app Tinder avesse identificato circa 40 identità di genere a fronte delle 50
di Facebook. Non stupisce che di fronte a un tale fenomeno si possa sviluppare
ogni sorta di atteggiamento, dal più scettico al più entusiasta. E forse non è
nemmeno compito della politica prendere una posizione epistemologica su processi
culturali così complessi, radicali e, soprattutto, in divenire. Nella
prospettiva dell’identità di genere, infatti, anche i confini con le altre
manifestazioni culturali o sociali dell’identità rischiano di attenuarsi. Sono
le stesse linee guida dell’Apa a ricordare che l’espressione di genere
può “avere una notevole intersezione con altri aspetti dell’identità”. Di fronte
alla vastità di tali problematiche, che finiscono per investire il cuore della
soggettività, la questione di come il diritto si debba porre, e con quali
tecniche e modalità, non può essere frettolosamente liquidata. E per questo la
strumentalizzazione politica del dibattito è gravissima. La complessità delle
manifestazioni umane ha indotto i costituenti italiani (al pari di altri) a
prevedere una tutela generale della dignità umana e sociale, senza
discriminazione alcuna (art. 3). Ciò non esclude che possano esservi ulteriori
interventi di speciale protezione o di specifica promozione (si pensi
all’accesso ai pubblici uffici dei cittadini “dell’uno e dell’altro sesso”, art.
51, o alla tutela del lavoro, art. 37 Cost.). La discrezionalità legislativa in
materia non esime, però, da una valutazione delle tecniche e delle modalità
degli interventi. Il dibattito sul ddl Zan, per quanto inquinato dalla
polarizzazione partitico-ideologica, non è dunque inutile, ed è anzi
giustificato dalla salienza delle questioni che intende affrontare. Questioni
che forse, riguardando una concezione della società e dei suoi componenti che si
è molto trasformata dal 1948, richiederebbero un dibattito costituzionale. Vi
sono tre specifici profili critici del ddl quanto alle tecniche di politica del
diritto. Innanzitutto, aspirando a una sistemazione giuridica di categorie, esso
ricorre a definizioni, in parte nuove, senza considerare che alcuni termini
erano già presenti nell’ordinamento, ma con significati diversi. Ciò pone un
problema di coordinamento di notevole complessità. Si pensi al concetto di
genere o di identità di genere che, per lo più, sono stati sinora utilizzati dal
legislatore e dalla giurisprudenza (anche costituzionale) come sinonimo
di identità o di orientamento sessuale, mentre le nozioni proposte dal ddl Zan
alludono a concetti sensibilmente differenti. Ciò genera un secondo problema.
Nel definire tali nuove categorie il legislatore ricorre ai cosiddetti concetti
giuridici indeterminati (cioè extra-giuridici), il cui significato deve, cioè,
ricavarsi al di fuori dell’ordinamento, ricorrendo ad altre scienze, alla
coscienza sociale o alla “percezione di sé”. Definendo il “genere” come
“qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o
contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso” si assume che
qualcuno sia in grado, fuori del diritto, di compiere un’attendibile
ricognizione delle (mutevoli) aspettative sociali. Certo, i concetti giuridici
indeterminati esistono (si pensi al senso del pudore), ma bisogna aver chiaro
che, nel ricorrere ad essi, il legislatore compie una precisa scelta di
trasferimento del potere. Rinuncia in larga misura a definire, e rinvia alle
definizioni di altri operatori, a cominciare dai giudici, con le oscillazioni
che ne possono derivare. Ciò vale a maggior ragione per concetti nuovi, della
cui esatta portata si discute ancora anche negli ambiti scientifici in cui sono
stati elaborati. Circostanza ulteriormente preoccupante atteso che la scelta di
affrontare e codificare tali nozioni si trova in un progetto che ha ad oggetto
la materia penale, nella quale vige il principio costituzionale di tipicità dei
reati (art. 25 cost.) e in cui le conseguenze sanzionatorie sono le più
afflittive. A ciò si aggiunga che, per limitare la portata delle norme penali
introdotte, il ddl ricorre a nozioni anch’esse piuttosto indeterminate, per cui,
ad esempio, sarebbero fatte salve le opinioni e le condotte
legittime “riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle
scelte”. Mettendo di fronte due concetti indeterminati o scarsamente
determinati, difficilmente il risultato sarà una chiarezza dei reciproci
confini. Oltre alle opzioni culturali di merito politico, ci sono dunque
importanti problemi di tecnica legislativa. Per questo discutere non è inutile,
tanto più se lo si facesse in modo laico e non nel contesto assordante del
rullare di tamburi e del sibilare di pifferi. Giovanni Guzzetta
Luca Fazzo per “il Giornale”
il 21 maggio 2021. Un rugbista donna ma con un passato e fisico da uomo può
competere con rugbiste che sono femmine dalla nascita? A lanciare il sasso è
stato ieri Paolo Vaccari, una icona della pallaovale italiana, 64 presenze in
Nazionale e 107 punti segnati. Che ieri legge l' annuncio della federazione
francese sull' apertura del rugby femminile ai transgender e - sulla sua pagina
Facebook - lancia l' interrogativo. Vaccari non si sbilancia, invita praticanti
e appassionati a esprimersi. Ma quello che si scatena è un diluvio a senso
unico. La svolta francese, dicono praticamente tutti, rischia di essere la tomba
del rugby femminile, dove potranno fare irruzione giocatrici che sono tali per
l'anagrafe ma non per peso e masse muscolari. E a quel punto per le donne native
non ci sarà più partita. Vaccari nel suo post ricorda come appena un anno fa la
federazione internazionale, World Rugby, avesse scritto che «la sicurezza e l'
equità non possono attualmente essere garantite per le donne che gareggiano
contro le donne trans nel rugby a contatto»; eppure «da lunedì la federazione
francese consentirà alle donne transgender di giocare a rugby femminile a
partire dalla prossima stagione». E per assurdo l'immagine di un Mathias
Basteraud che, esaurita la sua carriera come maschio, si riconverte al gentil
sesso con i suoi 120 chili viene fatalmente evocata. Così ecco le reazioni:
anche di donne, che dicono «questa situazione transgender ci sta sfuggendo di
mano», o «credo che una cosa sia la lotta alla discriminazione di genere, un'
altra è permettere a chi si sente donna ma è nato uomo di sfruttare
caratteristiche fisiche maschili contro quelle femminili». Da un lato nei
commenti si coglie la cultura inclusiva del rugby, il Dna che lo porta a non
escludere nessuno dai campi. Ma dall' altro, a prevalere nettamente, è la
constatazione tecnica: «A rugby si gioca con le gambe, le mani, le braccia... se
l'apparato muscolo scheletrico è maschile, tecnicamente è un uomo e non deve
giocare insieme alle donne». Se l'esempio francese dovesse venire seguito, la
previsione che fanno quasi tutti è secca: «Sarebbe la fine del rugby femminile».
Laura Della Pasqua per "la Verità" il 17 maggio
2021. Lo sballo diffuso, il rifiuto delle regole, le forme di violenza
rilanciate sui social con cinico compiacimento, la contestazione dei genitori, i
nonni usati come bancomat ma che possono essere sacrificati con il Covid in nome
dell'annullamento delle restrizioni. Cosa sta succedendo ai nostri giovani? La
pandemia ha portato a galla, come la schiuma del mare, il caos in cui vive
un'intera generazione, sospesa in una dimensione in cui tutto è consentito e
giustificato. In barba a qualsiasi morale. Sul tema della sessualità e
dell'identità di genere la confusione dei giovani raggiunge l'apice. Il gender
fluid è la nuova moda. E tra i giovani si stanno moltiplicando gli interventi
per cambiare sesso, spesso sull'onda del condizionamento sociale. C'è chi arriva
a sostenere che già a 2 o 3 anni si possano manifestare problemi di genere, il
che giustificherebbe la somministrazione di farmaci sin dalla più tenera età. A
ciò contribuisce il progressivo allentarsi dei vincoli anagrafici e sanitari.
Fino al 2015, per modificare i connotati sulla carta di identità bisognava
operarsi: ora questo obbligo è caduto. Inoltre, l'Organizzazione mondiale della
sanità ha riconosciuto la disforia di genere, ossia il disagio legato al non
riconoscersi nel proprio corpo, non come un disturbo psichico ma una condizione
sessuale. E ai minori può essere somministrato un farmaco, la triptorelina, per
bloccare la pubertà. Spesso è il primo passo per un percorso che porta i ragazzi
dritti verso la somministrazione di ormoni e poi all'intervento chirurgico con
effetti irreversibili. Dal monitoraggio della Società italiana di chirurgia
plastica ricostruttiva-rigenerativa ed estetica (Sicpre), nell'anno prima della
pandemia circa 120 persone si sono sottoposte a interventi di cambio di sesso
nei cinque ospedali pubblici italiani specializzati. Il 60% dei pazienti chiede
di diventare donna, il restante 40% uomo. L'ospedale che fa più interventi è
quello di Pisa. Quando ha iniziato, nel 2011 eseguiva 6 operazioni all'anno: ora
circa 60. Al San Camillo di Roma, nell'Area minori del Saifip (Servizio di
adeguamento tra identità fisica e identità psichica), una delle realtà pioniere
del settore che da più di 20 anni accoglie bambini e adolescenti gender variant,
nei primi tre mesi di quest'anno il numero di minori arrivati con un'ipotesi di
disforia di genere è aumentato del 150% rispetto allo stesso periodo del 2020.
Al Policlinico universitario di Palermo le richieste di interventi chirurgici
sono cresciute del 30%. Come mai questo incremento esponenziale? Il movimento
Lgbt e parte della comunità scientifica sostiene che il fenomeno è sempre
esistito, ma ora le persone escono allo scoperto. Altri psicologi e chirurghi
sottolineano fenomeni di emulazione e di contagio sociale. Questo il pensiero di
Adriana Cordova, professore di chirurgia plastica dell'università di Palermo ed
ex presidente di Sicpre: «Numerose persone che arrivano da noi per il cambio del
sesso hanno effettuato percorsi psicologici inadeguati. Le terapie psicologiche
dovrebbero durare 2 anni, ma non tutti completano il ciclo o perché non se lo
possono permettere o perché nelle strutture pubbliche hanno di fronte psicologi
sempre diversi che non garantiscono la continuità. Sono venute da me persone che
avevano avuto l'autorizzazione del tribunale per il cambio di sesso dopo appena
un paio di incontri con lo psicologo. Ho l'impressione che si parli del cambio
di sesso con leggerezza e che non si sottolinei la drasticità del gesto
chirurgico. Per alcuni pazienti la transizione era necessaria e ha portato a una
migliore qualità della vita, ma per altrettanti casi il bisturi non ha risolto i
problemi psicologici». Il blocco della pubertà è un'altra pratica che si
diffonde con facilità. Uno studio realizzato dall'associazione Scienza & vita e
dal centro studi Rosario Livatino sottolinea i dubbi su questo trattamento: che
cosa succede se, dopo due o tre anni di somministrazione della triptorelina (il
minino per ottenere qualche risultato) un adolescente cambia idea? Il suo
sviluppo ormonale riprenderà regolarmente? La fertilità sarà mantenuta? E come
riallineare lo sviluppo cognitivo, che nessuno può arrestare, con quello
puberale che nel frattempo è stato sospeso chimicamente? C'è anche chi ipotizza
che il blocco ormonale possa finire per compromettere la definizione morfologica
e funzionale di quelle parti del cervello che contribuiscono a strutturare
l'identità sessuale. E con quali conseguenze? Lo studio sottolinea «la
sostanziale carenza di letteratura scientifica che attesti evidenze di efficacia
e di sicurezza di questo tipo di trattamento». Caso emblematico è quello della
giovanissima Keira Bell, sottoposta a trattamento con bloccanti ormonali dopo
una frettolosa diagnosi di disforia emessa dalla Tavistock clinic di Londra,
l'unica clinica per l'identità di genere per bambini trans del Regno Unito. Dopo
questo scandalo, denunciato dalla ragazza, sono venuti allo scoperto numerosi
pentiti (cosiddetti detransitioner) perché sottoposti a trattamenti
irreversibili anziché essere aiutati psicologicamente a risolvere la confusione
mentale che li affliggeva. Come hanno documentato medici e pentiti, i danni
seguiti ai trattamenti ormonali non sono solo di tipo estetico (voci femminili
mutate per sempre in maschili, peli su volti femminili o crescita di seni su
corpi maschili) ma anche alla salute (fragilità ossea e sviluppo di altre
malattie croniche). In Gran Bretagna nell' arco di 10 anni c'è stato un aumento
del 2.500% dei trattamenti sulle bambine. Da 97 casi del 2009-2010 si è passati
a 2.519 del 2017-2018. Fra loro 45 bambini di 6 anni o meno. Ha fatto scalpore
l'intervento sul Guardian dell'ex psichiatra del Tavistock, David Bell, che ha
accusato la facilità con cui è somministrato il farmaco bloccante della pubertà.
In Italia la triptorelina è consentita con semplice perizia medica. La campagna
sull'identità di genere comincia a entrare nelle scuole. Ed è legittimo
chiedersi se non ci sia il rischio che il tema sia trattato in modo
semplicistico. Il Consiglio comunale di Torino ha approvato una mozione che
impegna gli educatori dei nidi e delle materne a una formazione continua sul
genere. In alcune scuole si sperimenta l'inserimento della «carriera alias» che
consente ai transgender di cambiare il nome sui registri elettronici. Cominciato
in alcuni licei, si sta facendo largo anche nelle elementari. Ma i bambini sono
pronti ad affrontare temi così delicati? L'identità di genere è al centro del
ddl Zan. Ci sono aspetti scottanti come il «self Id», o libera
autocertificazione di genere, consentita con un semplice atto all'anagrafe senza
perizie. Il percorso verso l'annullamento della differenza sessuale è avviato.
Davide Giancristofaro Alberti
per ilsussidiario.net il 10 aprile 2021. Nelle ultime ore si sono accesi i
riflettori su Rosalynne Montoya, modella americana e attivista trans, che ha
raccontato di come uno scanner aeroportuale non abbia riconosciuto la sua
identità sessuale, sottoponendola così a numerosi controlli e perquisizioni da
parte della polizia. La protagonista ha esternato la sua disavventura attraverso
i suoi canali social, ed in particolare TikTok, dove vanta ben 481mila follower.
Attraverso un video ha spiegato che lo scorso 20 marzo, mentre stava per passare
attraverso un bodyscanner per un normale controllo, sia “scattata l’allarme”.
Nell’aeroporto in questione vi erano due scanner, uno per gli uomini e uno per
le donne, e la Montoya aveva deciso giustamente di passare sotto quello
femminile in quanto, come spiegato dalla stessa, il suo aspetto è decisamente
“rosa”, così come i suoi documenti di identità che attestano che sia una donna.
Peccato però che la modella latinoamericane non si sia ancora sottoposta
all’operazione per la rimozione del pene, ed evidentemente lo scanner deve aver
rilevato l’organo sessuale maschile segnalando quindi l’errore. La ragazza è
stata quindi avvicinata dagli addetti alla sicurezza, e la stessa ha cercato di
spiegare che fosse una trans, accusando poi gli stessi scanner di non essere
programmati per riconoscere le persone come lei. Peccato però che le guardie
dell’aeroporto non abbiano voluto sentire storie, e di conseguenza hanno
costretto la stessa Montoya a subire una perquisizione: “Mi hanno chiesto – il
racconto della modella nel video pubblicato su TikTok – se volessi farmi
perquisire da un uomo, ma ho risposto: ‘Assolutamente no'”. Il video denuncia ha
fatto il giro del web ottenendo ben 22 milioni di visualizzazioni ricevendo la
solidarietà di numerose associazioni pro-Lgbt che hanno denunciato la
“transfobia” dei programmatori degli scanner aeroportuali Usa. In seguito la
stessa Montoya ha poi pubblicato un altro video in cui è tornata a parlare della
sua disavventura, spiegando come il pregiudizio nei confronti dei trans sia
radicato “in ogni sistema di potere della nostra nazione”.
Da corriere.it il 5 aprile
2021. Tutte le attrici e modelle transgender più sexy e con storie incredibili
alle spalle. A partire dalla bellissima modella Lea T, prossima ai 40, abbiamo
selezionato alcune tra le più belle e famose star transgender. Come per esempio
Indya Moore che, a soli 26 anni, si è affermata come attrice grazie alla serie
tv Pose ma è da quando ne ha 14 che lotta per affermare se stessa, difendendosi
da attacchi di bullismo e transfobia. Geena Rocero è una top model americana ma
è anche la fondatrice della casa di produzione Gender Proud, che racconta storie
legate al mondo LGBT, oltre ad aver portato avanti le sue cause alla Casa Bianca
e alle Nazioni Unite. Angelica Ross deve la sua notorietà alla serie tv Pose ma
è anche un'imprenditrice di successo. Programmatrice autodidatta, ha fondato la
TransTech Social Enterprises, un'azienda che aiuta la comunità transgender ad
approcciarsi all'industria tech. Abbiamo raccolto le storie di modelle, attrici
e attiviste del mondo transgender, che con la loro carriera hanno abbattuto
barriere e conquistato primati.
Lea T è la figlia del
calciatore brasiliano Toninho Cerezo. Quando il padre viene ingaggiato dalla
Roma, si trasferisce in Italia con tutta la famiglia. Lea T trascorre qui
l'infanzia e l'adolescenza e a 25 anni annuncia di voler iniziare il percorso
del cambio di sesso. La carriera nella moda inizia grazie a Riccardo Tisci, che
in qualità di direttore creativo di Givency la sceglie per la campagna invernale
del 2010. Un anno più tardi Lea T entra nella lista delle 50 top model più
pagate. In Italia è nota anche per aver partecipato a Ballando con le stelle.
Valentina Sampaio è una modella
brasiliana, la prima transgender a entrare, nel 2019, nella squadra di
Victoria's Secret. Nel 2020 la modella, che con Sara Sampaio ha in comune solo
il cognome ma nessuna parentela, ha infranto un'altra barriera per il mondo
LGBT: è stata la prima a posare per la copertina di Sports Illustrated Swimsuit
Issue. Nella sua carriera, inoltre, Valentina Sampaio è stata scelta per la
copertina di Vogue ed Elle, oltre a essere stata selezionata da L'Oreal che l'ha
voluta come una delle sue ambasciatrici.
Stav Strashko è una modella e
attrice israeliana, la prima transgender a conquistare una nomination come
miglior attrice agli Ophir Award (gli Oscar israeliani) grazie alla sua
interpretazione nel film Flawless. Nel film israeliano Flawless, Stav Strashko
interpreta una delle tre protagoniste adolescenti che decidono di mettere in
vendita il loro rene per potersi sottoporre a interventi di chirurgia estetica.
Geena Rocero è una top model e
attivista americana. Ha fondato Gender Proud, una società di produzione che
racconta la comunità transgender. Geena Rocero, inoltre, è una speaker TED e si
batte per i diritti della comunità transgender in diversi ambiti, dalle Nazioni
Unite alla Casa Bianca, fino al World economic forum.
Classe 1991, MJ Rodriguez è
diventata celebre grazie al ruolo di Blanca Rodriguez-Evangelista nella serie tv
Pose, ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Steven Canals. La serie tv è
ambientata nella New York degli anni '80 e '90 e ha ottenuto numerosi
riconoscimenti dalla critica tra cui due Golden Globe: miglior serie drammatica
e miglior attore in una serie drammatica (Billy Porter).
Anche Jamie Clayton deve la sua
notorietà a una serie tv di grande successo distribuita da Netflix, Sense8.
Nella serie interpreta l'hacker Nomi Marks. Jamie Clayton è impegnata nella
lotta per i diritti della comunità LGBT. Di recente ha criticato Scarlett
Johansson, quando quest'ultima aveva accettato di interpretare un personaggio
transessuale nel film Rub & Tug "rubando" potenzialmente la parte a un'attrice
transgender. La Johansson aveva poi rifiutato il ruolo.
Angelica Ross è una delle
protagonista di Pose, dove interpreta Candy Abundance. L'attrice ha lavorato
anche sul set di American Horror Story. Forse non tutti sanno, però, che
Angelica è anche un'imprenditrice. Programmatrice autodidatta, ha fondato la
TransTech Social Enterprises, un'azienda che aiuta la comunità transgender ad
approcciarsi all'industria tech. Ha posato insieme a Lady Gaga a una
manifestazione per i diritti LGBT.
Indya Moore ha solo 26 anni ma
è già nota in tutto il mondo grazie alla sua interpretazione di Angel
Evangelista nella serie tv Pose. Indya Morre ha lasciato la sua casa e la sua
famiglia quando aveva solo 14 anni e ha poi raccontato di essere stata vittima
di bullismo. Alcuni anni più tardi è stata la prima modella transessuale a
posare per la copertina di Elle. La sua carriera di modella è continuata con
Louis Vuitton e il Calendario Pirelli del 2020. Time l'ha inserita nelle persone
più influenti del 2019.
Hari Nef è un'attrice, modella
e scrittrice americana. Ha debuttato in passerella nel 2015 alla New York
Fashion Week. Hari Nef ha conquistato un premio SAG nel 2016 per il suo ruolo
nella serie tv Amazon, Transparent.
Andreja Pejic è una modella e
attrice bosniaca naturalizzata australiana. Ha cominciato a lavorare nel mondo
della moda a 17 anni. Nel 2011 ha sfilato alla settimana della moda di Parigi
per gli uomini di Marc Jacobs e per le donne di Jean Paul Gaultier.
Laverne Cox è nota al grande
pubblico per il ruolo di Sophia Burset in Orange is the New Black. Con questo
ruolo Laverne Cox è entrata nella storia poiché è stata la prima attrice
transgender a ottenere una candidatura a un Emmy Award.
Carmen Carrera è una modella e
attrice televisiva americana, nota al grande pubblico per aver preso parte alla
serie televisiva Logo reality RuPaul's Drag Race. Classe 1985, Carmen Carrera ha
partecipato anche alla serie spin-off RuPaul's Drag U.
Dominique Tar Jackson è
un'attrice e scrittrice triniddadiana che abbiamo visto di recente nella serie
tv di Amazon American Gods. Dominique è diventata famosa per il ruolo di Elektra
Abundance nella serie televisiva Pose.
Hailie Sahar è un'attrice
americana nota per la sua interpretazione di Lulu Abundance, co-fondatrice della
House of Ferocity nella serie TV Pose. Hailie Sahar ha lavorato anche sul set di
Mr Robot e Transparent, ricoprendo ruoli minori.
Da repubblica.it il 31 marzo 2021. "Professore,
vorrei che lei non usasse con me il termine Sir o Mr quando si rivolge a me, ma
usasse un termine femminile". La richiesta era arrivata da una studentessa
transgender al corso di filosofia politica della Shawnee State University,
ateneo pubblico nell'Ohio. Nicholas Meriwether, docente da oltre vent'anni, non
conosceva la studentessa, che negli atti processuali è identificata come Jane
Doe, ma non aveva avuto dubbi su come rispondere: non l'avrebbe chiamata Sir o
Mr ma neanche Miss e non avrebbe usato altri pronomi femminili, perché i suoi
convincimenti cristiani glielo proibivano. La storia risale a tre anni fa, ma
adesso è diventato un caso legale negli Stati Uniti dopo che il giudice ha dato
ragione al docente: potrà avviare causa di risarcimento danni contro
l'Università che aveva minacciato di sospenderlo per essersi rifiutato di
riconoscere l'identità di genere. La Corte di appello federale dell'Ohio ha
riconosciuto a Meriwether il diritto a usare un termine neutro, in nome del
primo emendamento della Costituzione americana, che sancisce la libertà di
espressione e di religione. Il suo credo cristiano non permetteva al professore
di "riconoscere un'identità biologica ritenuta falsa". Quello che poteva essere
lo spunto per un confronto accademico in un corso di filosofia politica, è
diventato il primo atto di una lunga disputa legale. La direzione
dell'università aveva avviato un'indagine interna, durata un mese, al termine
della quale era emerso come il corso fosse caratterizzato da un "ambiente
ostile". Il board aveva inviato a Meriwether un avvertimento scritto, in cui lo
minacciava di sospensione senza paga, se non avesse accettato di trattare da
ragazza la studentessa transgender. Il docente si è ribellato e ha deciso di
fare causa all'università, appellandosi al primo emendamento. In quanto
cattolico, hanno sostenuto i suoi legali, doveva essere rispettata la posizione
personale. Il giudice, Amul Thapar, nominato dall'ex presidente Donald Trump,
gli ha dato ragione. Nella sentenza, composta da trentadue pagine, si sottolinea
come la posizione di Meriwether rappresenti un caso perfetto di libertà
d'espressione. "Se i professori non potessero avere questo diritto quando
insegnano - ha spiegato il giudice - un'università potrebbe costringerli a
sottomettersi dal punto di vista ideologico. "Nessuno - ha commentato un legale
della Alliance Defending Freedom, che ha difeso il docente - dovrebbe essere
forzato ad abiurare il proprio credo solo per conservare il posto di lavoro".
Per alcuni, la sentenza segna la "vittoria della libertà di espressione". Per
altri, è un passo indietro nel rispetto dell'identità di genere, proprio
nell'epoca in cui per la prima volta nella storia americana una transgender, la
psichiatra Rachel Levine, è entrata a far parte di un governo federale, come
vicesegretario per la Salute. Gli effetti della sentenza verranno misurati in
altri casi legali. In Virginia un insegnante di francese ha fatto causa al
liceo: è stato licenziato perché si era rifiutato di usare pronomi maschili nei
confronti di una ragazza avviata alla transizione di genere.
Da "ilmessaggero.it" l'1 marzo 2021. Gli atleti
transgender uccideranno lo sport femminile. E ancora: le pale eoliche uccidono
gli uccelli. Sono alcuni dei passaggi più curiosi dei quasi 90 minuti di
discorso tenuto da Donald Trump alla conferenza dei conservatori americani
(Cpac) ad Orlando, in Florida, in cui ha assicurato di non voler fondare un
partito concorrente di quello repubblicano e non ha escluso di ricandidarsi nel
2024. «Se gli atleti transgender continueranno a gareggiare, se questo non
cambierà, gli sport femminili moriranno», ha sostenuto l'ex presidente
americano. Questo per denunciare come Joe Biden e i democratici spingono per
politiche che vanno in questa direzione, probabilmente un riferimento
all'Equality Act teso ad espandere le protezioni nei confronti della comunità
Lgbtq e votato la scorsa settimana alla Camera del Congresso americano. «Molti
nuovi record sono stati battuti nello sport femminile, troppi sono stati
frantumati», ha proseguito Trump, spiegando come «le giovani atlete sono furiose
perché sono adesso costrette a competere contro chi é biologicamente nato
maschio». Passando all'energia eolica Trump ha quindi ripetuto come in passato
di non averla mai capita, perché rumorosa e uccide gli uccelli: andate sotto le
turbine, è un cimitero di volatili.
È trans anche il "genere": da bisogno a
ideologia. Negli Stati Uniti persino le scuole fanno
propaganda spingendo molti giovanissimi a cambiare sesso. Marco Gervasoni,
Sabato 13/02/2021 su Il Giornale. La questione del «genere» (o gender in
inglese) è una delle battaglie fondamentali dei prossimi anni. Ed è massimamente
politica, perché i sostenitori di tale teoria intendono attuare un'autentica
rivoluzione antropologica, ribaltare la natura umana, costruire una comunità in
cui l'individuo possa scegliere se essere uomo, donna o qualcosa d'altro.
Un'opzione che viene presentata come «diritto» ma che in realtà fuoriesce dalle
decisioni dei singoli per cercare di farsi modello di una nuova comunità, in cui
l'ordine biologico dell'uomo da un lato e dall'altro il legame con la tradizione
e con la consuetudine siano completamente spezzati. Come ogni progetto politico,
anche quello gender possiede un'ideologia forte e granitica: ed è questa che
bisogna conoscere per chi intenda combatterla, come dovrebbe fare secondo noi
qualsiasi conservatore o anche semplicemente ogni persona di buon senso.
All'interno della teoria gender un peso importante è occupato dalla questione
trans, cioè del passaggio di sesso, in particolare tra gli adolescenti. In
Italia si tratta di un fenomeno ancora marginale, benché veda già il suo
bell'esercito di supporter, ma negli Usa sta diventando sempre più diffuso. Il
libro di Abigail Shrier, giornalista del Wall Street Journal, dal titolo
Irreversible Damage. The Transgender Craze Seducing Our Daughters (Regnery
Publishing) va letto quindi per diverse ragioni. La prima è che si tratta di una
seria indagine giornalistica, non di una requisitoria ostile al
«transgenderismo». E nell'indagine si parla con ragazze e ragazzi (ma
soprattutto femmine) che hanno intrapreso assai presto il percorso di
«transizione», con i loro genitori, con gli insegnanti, con scienziati e medici.
Ne esce un ritratto decisamente inquietante, che smonta pezzo per pezzo la
narrazione ideologica gender. Essa ci dice che la decisione di cambiare sesso
sarebbe libera, spontanea, un diritto appunto dell'adolescente, che in tal modo
si sentirebbe libero di scegliere la propria sessualità, non imprigionata più
nel proprio corpo estraneo. Shier non nega certamente il disagio e anzi il
dolore in cui le adolescenti si trovano, ma mostra come questa scelta sia spesso
indotta da attori sociali che circondano le teenager. I genderisti affermano che
il loro bisogno sarebbe sempre esistito, solo che nel passato religione e
tradizioni l'avrebbero impedito. In realtà nel passato, anche recente, il
fenomeno era ultra marginale e si è espanso negli ultimi anni perché, secondo
l'autrice, gli attori della propaganda gender costruiscono le menti delle
adolescenti. Sono i social e la scuola i due pilastri che convincono le ragazze
che il senso di spaesamento, tipico dei quella età, ha origine dal sexual
distress. Sui social infatti la propaganda gender imperversa. Più sorprendente è
che essa sia presente anche a scuola, e invece in quelle statunitensi gli
educatori, cioè i docenti, sono già loro molto spesso diffusori di questa
dottrina. Quanto alla repressione familiare, Shrier mostra come molte
adolescenti che hanno intrapreso la «transizione» vengono da famiglie atee,
progressiste, favorevoli ai matrimoni gay e tutto il resto, ma certo non pronte
ad accettare come se nulla fosse il cambio di genere delle loro figlie. Ma il
libro, bellissimo, un modello di giornalismo purtroppo assente in Italia, ci
mostra anche lo stato pietoso della libertà di parola negli Usa. La giornalista
è stata più volte minacciata e censurata, prima, dopo e durante la pubblicazione
del libro. Coloro che criticano la dottrina gender sono emarginati dalle scuole
e dalle università, mentre agli scienziati che eccepiscono vengono rivolte
minacce e pressioni dai gruppi organizzati, fino a far perdere loro il posto di
lavoro negli ospedali (privati). Come ai tempi della caccia alle streghe di
Salem, chi muove anche un dubbio nei confronti della propaganda gender viene
additato come moderna strega, attraverso lo stigma della «omofobia». Sotto cui
finiscono per cadere, come mostra Shrier, persino le lesbiche, accusate di
essere ostili ai trans per ragioni di «sessismo». Un tale scenario di
dissoluzione ha ora, alla Casa Bianca, chi ne sostiene le ragioni. Un motivo in
più perché i conservatori o semplicemente le persone di buon senso si attrezzino
per combatterlo.
Lady Oscar, mito transgender prossimo ai
50 anni. Valeria Arnaldi su Il Quotidiano del Sud l'1
febbraio 2021. Lunghi capelli biondi, pressoché perennemente mossi dal vento.
Grandi occhi celesti, simbolo di quella trasparenza d’animo che il destino le ha
negato. Lunghe ciglia che ombreggiano di malinconia ogni sguardo. E un sorriso a
metà, cinicamente segnato, che a volte sfocia in risate piene, maschera di alte
– e altre – inquietudini. Lady Oscar è bella. Oltre ogni immaginazione, oltre
ogni regola e soprattutto oltre ogni definizione. Ed è forte nell’animo e nel
braccio, nel temperamento e nella dignità. È per questo binomio, che fa del
personaggio l’archetipo letterario e biologico dell’androgino qui stemperato da
una moderna fragilità, che negli anni l’eroina e il manga di cui è protagonista
sono stati considerati un contributo all’affermazione di una nuova condizione
della donna. Una sorta di manifesto femminista a fumetti. È stata la stessa
autrice Riyoko Ikeda a puntare l’attenzione su questa interpretazione e sui
limiti nei quali erano costrette le donne non solo nel Settecento
pre-rivoluzionario francese ma anche all’epoca della realizzazione del manga, a
partire dalla sua stessa sfida di volersi fare mangaka e non più semplicemente,
come avrebbe voluto la tradizione di genere, servizievole sposa. Lady Oscar è
dunque un manga femminista, per vocazione e progetto, pensato per dare voce alle
donne, regalando loro un’eroina da prendere a modello. Anzi da superare. Ma è,
per proiezione e inconscia metabolizzazione, soprattutto un manga di denuncia
“sociale”. A essere portata sotto i riflettori dall’autrice, infatti, è la
schiavitù – di costumi, società, pregiudizi – che di fatto diventa protagonista
nel suo essere ostacolo all’alterità della donna. Per rappresentare la
costrizione violenta dei costumi e dare alla sua eroina ancora più rilievo, la
Ikeda sceglie un antagonista “ambientale”, diffuso, definito per epoca ma esteso
tra tempo e spazio, nel suo essersi fatto tradizione e regola. Ed è proprio
l’antagonista la vera sorpresa della storia, nella lucidità della visione, nella
subliminalità dell’impatto. Oscar non è la donna che prende le armi per
liberarsi da regole e limiti imposti al proprio sesso, né per contrastare le
prevaricazioni degli uomini, no, Oscar prende le armi per seguire altre regole e
altri limiti. Non cambia lo schema di gioco, cambia la prospettiva. Il suo
eroismo non è quello di una suffragetta in lotta per il diritto all’esistenza e
alla parità, bensì quello di matrice epica classica che porta l’eroe tragico ad
accettare il suo destino senza tentare di contrastarlo. Nata femmina, è
costretta a crescere come un maschio per rispettare la schiavitù della
discendenza che lega la progenie maschile all’onore della famiglia di
appartenenza. Oscar non può scegliere cosa essere perché la sua coscienza matura
a decisione già presa e vita avviata, quando diventare qualcosa di nuovo
significherebbe in realtà tornare indietro. Non è interessata al genere che deve
portare in scena ma alla perfezione come unico vero obiettivo di vita. La sua
vocazione è essere l’idea che è stata costruita per lei, più ancora l’ideale in
cui e per cui è stata cresciuta. E se Oscar è costretta nel suo ruolo, i
personaggi che la affiancano non sono meno vincolati. Andrè non può che restare
al fianco dell’amata, inizialmente bandito dal suo cuore per nascita più che per
sentimento. E non può neppure concedersi le lacrime che, invece, Rosalie, donna
e a sorpresa di sangue nobile, può versare per il suo stesso amore. Andrè è
travestito quanto Oscar: non ha bisogno di indossare altri panni per essere
vincolato alla maschera dell’attendente prima e del compagno d’armi poi. Maria
Antonietta non può vivere la sua gioventù per una politica molto più grande di
lei e diventa merce di scambio, suggello di un patto. E non può conoscere la
passione, se non nella versione idealizzata e disperata di un batticuore
furtivo, cui dovrà rinunciare per mantenere salda non la sua corona, ma quella
di ben due Stati, che per un suo sguardo di troppo finirebbero per dichiararsi
guerra. La Corte sa la passione che lega la regina a Fersen e non la condanna
per ciò che prova ma per ciò che mostra. Le lacrime di Maria Antonietta
denunciano la colpa della sua ricerca di felicità. Versailles potrebbe accettare
il Conte come suo amante, non può tollerarlo come amato. È una questione di
ruoli, regole, costumi. Maschere. Il “travestimento” di quell’amore vincola pure
Fersen, che non può amarla che alla distanza, di quella stessa responsabilità
politica schiavo. Perfino Luigi XVI non è libero, schiavo di quell’amore
combinato che improvvisamente è diventato sincero e tanto profondo da accecarlo.
Il sovrano sa, intuisce, non ignora il pettegolezzo ma deve mascherare la
consapevolezza per non essere costretto ad agire da re. La trappola della Corte
fa il resto, trasformando in burattini proprio i suoi primi attori. Andando al
di là della volontà dell’autrice, nel sentimento della storia, Lady Oscar è la
storia corale di mille e una schiavitù che caratterizzano la Vita, attimo dopo
attimo, per paradosso, nelle regole che l’uomo le ha imposto. La “rivoluzione”
di Oscar è consentita nel gioco di Versailles, dove il lusso aristocratico rende
più elastici i costumi e la morale, tollerando vezzi e vizi, soprattutto
fantasie, perfino quella snaturante di un padre sulla figlia. È accolta in seno
alla cultura di una Francia libertina, che si fa bella dei suoi dongiovanni e di
De Sade, cercando nuovi svaghi e azzardi alla noia del quotidiano, fosse anche
solo quello di fantasticare sull’ambiguità di un Capitano-fanciulla in abiti non
suoi. Ma quella stessa rivoluzione non è tollerata nel Giappone anni Settanta
della Ikeda. Quindi, sì, Lady Oscar è femminista nella misura in cui sottolinea
come alla donna sia negato essere diversa da ciò che ci si aspetta che sia, pena
la solitudine, il dubbio, la morte. È femminista perché parla di schiavitù nei
toni diretti di un dialogo di genere. Ma è anche maschilista, nella prima e
ultima parola che all’uomo riconosce come diritto, al di là del “gioco” delle
parti. È maschilista nella consapevolezza che le Giovanna d’Arco della storia
muoiono bruciate per “liberare” il mondo dalla difficoltà di trovare loro un
posto nel quotidiano. Testo estratto da “Lady Oscar. L’eroina rivoluzionaria di
Riyoko Ikeda” di Valeria Arnaldi, Edizioni Ultra. © 2015 Lit Edizioni s.a.s. Per
gentile concessione
Dagospia il 29 gennaio 2021. Da “la Zanzara –
Radio24”. “Tra 17 provvedimenti di Biden ce ne sono tre che riguardano i trans.
Dunque per dire: io sono questa cosa qui politicamente. Il primo è la nomina del
viceministro della Sanità, metto uno che sostiene che cambiare sesso è una cosa
normale. Fino a due anni fa l’Oms sosteneva che la transessualità era un
disordine mentale. Un problema dunque c’è. Il secondo è dire sì ai trans
nell’esercito, il terzo è la possibilità di far gareggiare i transessuali con le
donne”. Lo dice Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia a La Zanzara su
Radio 24. “Esiste una lobby ultra potente di gay che riesce a influire sul
maggior centro di maggior potere nel mondo, cioè la presidenza Usa. Ed è una
lobby estremamente pericolosa”, dice Adinolfi. “Mettere un trans alla Sanità –
prosegue ò- è una scelta politica. E io non manderei mai i miei figli da una
pediatra transessuale. Mai. Non è normale che guidino le polemiche sulla sanità
le persone che erano considerate dei disturbati mentali fino a poco tempo fa. E’
una pazzia, ed è una pazzia mettere a correre una trans con una struttura
maschile con una donna”. “Il trans può fare quello che vuole- dice Adinolfi – ma
io ho il diritto a non mandare mio figlio da un pediatra trans. Levine è un
uomo con la parrucca. Quando fa il pediatra è sempre un uomo con la parrucca. E
tu mandi i tuoi bambini lì tranquillamente. E ricordiamo che secondo gli studi
dell’Oms un transessuale ha l’istinto di suicidio otto volte maggiori rispetto
agli altri”.
Federico Boni per gay.it il 29 gennaio 2021. Un
mese e mezzo dopo aver insultato Elliot Page (“Uno è uomo o donna, punto, questa
mica s’è messa il cazzo“), su Radio24 durante La Zanzara Giuseppe Cruciani è
tornato a diffondere via etere transfobia a buon mercato, ospitando il
solitamente ‘cordiale’ Mario Adinolfi per parlare di Joe Biden e della comunità
transgender. Pronti, via e Cruciani ha immediatamente dettato la strada da
seguire. Parliamo di transessuali un secondo, perché c’è una roba che mi ha
fatto incazzare. Biden ha dato il via libera al fatto che i transessuali possano
gareggiare con le donne. Secondo te è possibile che un trans possa gareggiare
con le donne? Quello è un uomo. Quellè un uomo! Chiaro che diventa una follia.
Una roba impari. Imboccato dal presentatore, Mario Adinolfi c’è andato a nozze,
sottolineando i provvedimenti presi da Biden nei primi giorni da Presidente
degli Stati Uniti d’America. Vedi la nomina a sottosegretario della salute della
dottoressa trans Rachel Levine, la cancellazione del divieto alle persone trans
nell’esercito e la possibilità di assegnare borse di studio ad atlete
transgender. “Questa è una follia!“, ha risposto Giuseppe Cruciani. “Il Governo
Biden è un governo transessuale?“, ha domandato in modo del tutto insensato il
conduttore de La Zanzara, ancora una volta tornato su argomenti legati alla
comunità LGBT con parole becere e discussioni indegne di una diretta radio
nazionale, soprattutto se cavalcate al fianco di Mario Adinolfi, che deve la
propria esistenza politica alla sua conclamata omotransfobia. “Secondo me esiste
una lobby ultra potente che riesce ad influire sul centro di potere del Pianeta
indicando quelle come politiche caratterizzanti. Esiste una lobby gay molto
forte negli Stati Uniti estremamente pericolosa“, ha insistito Adinolfi, con
Cruciani a rintuzzarlo come al suo solito, alla disperata ricerca della solita
ridicola polemica mascherata da politicamente scorretto. “Assolutamente mai
manderei i miei figli da un medico transessuale, mai!“, ha tuonato il leader del
Popolo della Famiglia, scatenando l’ira di David Parenzo, che pochi mesi fa
definì “melati mentali” chi andava a letto con le persone trans. “Quando guardi
quel viceministro alla salute“, ha proseguito Adinolfi in riferimento a Rachel
Levine, “vedi evidentemente un uomo con la parrucca. Non affiderei mai la
politica di un Paese a quel medico lì perchè potrebbe orientarla in una
direzione molto precisa. Se noi diciamo che è normale, anzi che devono guidare
le politiche pubbliche della sanità coloro che fino a due anni fa erano compresi
nella tabella dei disturbati mentali dico che c’è qualcosa che ha a che fare con
la pazzia “. Tutto ciò, duole ricordarlo, al cospetto di 2.357.000 ascoltatori
medi quotidiani per Radio24.
·
Gli
Omosessuali.
Marco Leardi per ilgiornale.it il 2 dicembre 2021.
"Basta con questo vittimismo!". Il tema dei diritti Lgbt e dell'imposizione
delle quote arcobaleno anche nel mondo dello spettacolo ha infiammato il
confronto. Al Maurizio Costanzo Show in onda ieri sera su Canale5, il tema ha
acceso un duro botta e risposta tra Mauro Coruzzi, alias Platinette, e
l'influencer Tommaso Zorzi. Alle insistenze di quest'ultimo, che denunciava un
fantomatico "sistema eterocentrico", ha replicato con veemenza il conduttore
radiofonico, anch'egli omosessuale ma contrario alle categorizzazioni forzate di
genere. La discussione tra i due era stata inizialmente innescata dal commento
su uno spot tv norvegese che rappresenta un Babbo Natale gay. Coruzzi ha da
subito criticato quella rappresentazione, stigmatizzando la volontà di
"ritrasformare a immagine e somiglianza di un orientamento sessuale delle
categorie che di per sé non richiamano al sesso". Poi ha allargato il discorso e
si è lanciato in un'osservazione polemica di carattere generale. "Non mi piace
che adesso il mondo cosiddetto Lgbt sia diventato un mercato come tutti gli
altri. Nelle piattaforme tu trovi la striscia Lgbt, tutto ciò per dire che
ognuno ha dei propri orientamenti sessuali, ma il proprio non deve prevalere su
quello altrui. Io non grido tutti i giorni 'non sono omosessuale, sono
eterosessuale' ma 'sono un essere umano' punto. Basta con le categorie!", ha
esclamato Platinette. Una presa di posizione decisa, che ha riscosso un applauso
del pubblico in sala. Le parole del conduttore radiofonico non sono però
piaciute a Tommaso Zorzi, che attualmente su Discovery+ presenta un programma
sulle drag queen. L'influencer ha iniziato a scuotere la testa e non si è piu
trattenuto quando Platinette ha ripreso il suo discorso, citando il fatto che
oggi molte pubblicità vengano appositamente ritrasformate "con coppie
omosessuali che si baciano". "Noi per anni siamo stati, tra virgolette, vittime
di un sistema eterocentrico, se per una volta uno vuole sbandierare la bandiera
Lgbt lasciateglielo fare! Ma che fastidio ti dà", ha commentato Zorzi,
affermando invece la necessità di ribadire l'identità omosessuale in un contesto
ritenuto ostile. Un'argomentazione che ha fatto spazientire Platinette. "Ma se
la televisione è piena di fr*ci! Ma cosa dici eterocentrica! Basta con questo
vittimismo! Siamo ovunque!", ha sbottato Coruzzi. Per placare gli animi è dovuto
intervenire lo stesso Maurizio Costanzo. Non era la prima volta che Platinette e
Zorzi si scontravano davanti alle telecamere, anche a distanza, peraltro sempre
sul tema dei diritti Lgbt.
"Lezioni di sesso gay alla
fiera della Caritas". Bufera sull'Arcigay.
Francesca Galici il 14
Novembre 2021 su Il Giornale. Brochure esplicite su sesso orale e tra uomini
sono state esposte in bella vista (senza filtri) sui banchetti dell'Arcigay alla
Fiera del volontariato a Bolzano. Quanto accaduto alla Fiera del volontariato a
Bolzano ha dell'incredibile: volantini espliciti su sesso orale, preservativi e
pratiche edonistiche omosessuali. La denuncia arriva da Alessandro Urzì,
consigliere regionale e provinciale, che su Facebook ha portato alla luce i
contenuti dello stand dell'associazione Centaurus Arcigay dell'Alto Adige.
L'esponente di Fratelli d'Italia ha fatto notare che l'Arcigay "ha sfruttato la
tribuna offerta dalla fiera del volontariato organizzata da una collaborazione
fra l'Ufficio provinciale #Anziani e distretti sociali (sì, proprio la
Provincia), Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone (sì proprio la Caritas
diocesana), la Federazione per il Sociale e la Sanità, il Comune di #Bolzano (sì
proprio quello di Caramaschi) e l’Associazione Provinciale di Soccorso Croce
Bianca" per esporre argomenti non adatti a un pubblico di famiglie. La Fiera del
volontariato, infatti, è un evento che richiama un pubblico trasversale, che
comprende anche famiglie con bambini e persone anziane. Una platea variegata per
la quale è necessario adottare un linguaggio che sia consono e fruibile da
tutti, ciò che non ha fatto l'Arcigay che, come denuncia Urzì, "ha dimostrato la
solita incontinenza comunicativa usando l’opportunità della fiera del
volontariato (aperta a famiglie e bambini) per farne una esibizione di messaggi
diretti e senza censura". Sul banco allestito dall'associazione, infatti,
facevano bella mostra di sé opuscoli informativi che trattano l'educazione al
corretto sesso orale, ma anche brochure che insegnano le posizioni da assumere
per il miglior amplesso da persone di sesso maschile e che spiegano come
inserire nel modo giusto il preservativo. Non sarebbe nemmeno questione di
censura ma di buon gusto, che sarebbe stato richiesto anche se si fosse trattato
di un'associazione non Lgbtq. Infatti, Alessandro Urzì ha precisato:
"Attenzione: per quanto mi riguarda nessuna pruderie o imbarazzo. Non è questo a
fare arrossire me o chiunque sia persona all’altezza dei tempi che viviamo. Ma
la domanda è un’altra: è normale che sia la Provincia a organizzare assieme a
Caritas diocesana e altre meritorie organizzazioni la tribuna in cui presentare
il 'corso per immagini' a scena aperta per grandi e piccini di 'pompino' e
persone adulte dello stesso sesso? Attenzione: il giudizio sarebbe stato lo
stesso, almeno da parte mia, se si fosse offerta una rassegna di Kamasutra
eterosessuale. Non per pruderie ma per contesto: si può auspicare che una fiera
del volontariato nella cornice della Biolife, la fiera del benessere, possa
offrire una comunicazione sobria, adatta a tutto il pubblico (maggiorenne e
minorenne) e non una sceneggiatura hardcore?". Come sottolineato dall'esponente
di Fratelli d'Italia, inoltre, "può essere lodevole il carattere educativo, per
gli interessati, della rassegna su come esercitare in sicurezza pratiche
sessuali. Ma questo non giustifica che la scuola di sesso sicuro sia offerta
senza filtri a tutto il pubblico di una intera fiera". In chiusura del suo
intervento, Urzì rende noto che "con una interrogazione chiederemo quale sia in
Provincia l’assessorato che finanzia Centaurus, che ha messo piede anche nelle
scuole attraverso il progetto Young Queer Generation, considerato che lo stesso
viene presentato 'di formazione' per il corpo insegnante".
Francesca Galici. Giornalista
per lavoro e per passione. Sono una sarda trapiantata in Lombardia. Amo il
silenzio.
Salvatore Dama per “Libero quotidiano” il 14
novembre 2021. Magari i meno pratici hanno pensato si trattasse di un'altra
cosa. Tipo un manuale per utilizzare quell'affare che serve a gonfiare le gomme
della bicicletta. E invece no. Era proprio quella roba lì: un opuscolo per
eseguire «il pompino perfetto». Ed era esposto nello stand del circolo Centaurus
Arcigay Alto Adige, all'interno della Fiera del volontariato Biolife di Bolzano,
organizzata, tra gli altri, dall'Ufficio Provinciale Anziani, dalla Caritas
diocesana e dal Comune. L'evento si è svolto alcuni giorni fa. Gli avventori-
famiglie, bambini e vecchietti - hanno avuto a loro disposizione una agile
brochure contenente le migliori tecniche per offrire (e ricevere) una fellatio
soddisfacente. Corredata da illustrazioni esplicative. Non si sa se qualcuno ne
abbia usufruito. Ma il caso è stato comunque sollevato da Fratelli d'Italia, in
particolare dal consigliere regionale Alessandro Urzì, che ha voluto mettere
bocca sull'accaduto. Dichiarandosi preoccupato dal fatto che il Bignami della
pompa potesse finire nelle mani sbagliate. In effetti, anche nelle foto postate
dal circolo Centaurus Arcigay su Facebook, il dizionario del sesso orale fa
bella mostra di sé su un banchetto, insieme a un utile campionario di gadget e
altra narrativa tematica. C'è una ciotola con preservativi colorati e
aromatizzati. E c'è un'altra mini guida su come utilizzare i goldoni e il
lubrificante appena prima di consumare un rapporto intimo. Ma che c'è scritto
nel prontuario della fellatio? Sostanzialmente una serie di utili consigli per
prepararsi all'esame orale. Il testo è focalizzato sulla pratica al maschile,
tra persone dello stesso sesso, però - dopo uno sguardo fugace - è plausibile
che le dritte possano essere applicate universalmente.
Tipo: non usare i denti; avere una corretta igiene
intima; in che posizione mettersi (inginocchiati, sul letto, sessantanove,
etc.); come e se coinvolgere i testicoli nell'operazione; quando baciare,
leccare ed (eventualmente) ingoiare; come stimolare il "punto L", che poi
sarebbe il corrispettivo maschile del punto G femminile. Ecco, tutta questa roba
era messa lì, a disposizione di anziani e famiglie, in una fiera organizzata
dalla Caritas. E a qualcuno, probabilmente, deve essere venuto il dubbio che,
parlando di cappelle, il manuale non si stesse riferendo a dei luoghi di culto.
Urzì, per esempio. L'esponente di FdI se la prende con l'Arcigay altoatesina:
«Ha dimostrato la solita incontinenza comunicativa usando l'opportunità della
fiera del volontariato (aperta a famiglie e bambini) per farne una esibizione di
messaggi diretti e senza censura. Come si fanno i "pompini", ma anche che
posizione assumere «per l'uso corretto del preservativo e dei lubrificanti in
rapporti fra persone di sesso maschile". Il consigliere regionale non ne fa una
questione bacchettona. Ma si domanda se la fiera, «organizzata dalla Provincia,
insieme alla Caritas diocesana e altre meritorie organizzazioni» fosse la
tribuna più opportuna dove «presentare il "corso per immagini" a scena aperta
per grandi e piccini di "pompino" e persone adulte dello stesso sesso». Urzì
precisa che l'omofobia non c'entra: «Il giudizio sarebbe stato lo stesso, almeno
da parte mia, se si fosse offerta una rassegna di kamasutra eterosessuale. Non
per pruderie, ma per il contesto: si può auspicare che una fiera del
volontariato nella cornice della Biolife, la fiera del benessere, possa offrire
una comunicazione sobria, adatta a tutto il pubblico (maggiorenne e minorenne) e
non una sceneggiatura hardcore?». L'esponente della destra si domanda se la
Diocesi sapesse e, infine, annuncia una interrogazione alla Provincia e al
Comune: «Si dovrà rendere conto delle scelte operate a favore di una
organizzazione come Centaurus Arcigay Alto Adige che dimostra, pur beneficiaria
di abbondanti fondi pubblici, di non avere rispetto e senso delle regole e della
misura». Il caso non finisce qui. Anzi, rischia di essere pompato.
Riccardo Conti
per harpersbazaar.com il 19 ottobre 2021. Per tutti coloro che si sono
avvicinati anche solo occasionalmente alla storia della queer culture italiana,
la rivista FUORI! rappresenta uno dei nuclei pulsanti di quella stagione
militante e rivoluzionaria cominciata simbolicamente nel 1971 come risposta alla
pubblicazione di un infelice articolo sul quotidiano La Stampa nel quale lo
psicologo Andrea Romeo, allora primario di neurologia dell’ospedale Mauriziani
di Torino, dissertava sulla cronica infelicità dell’omosessuale, e sui rimedi
che la psicanalisi poteva offrire per curare quella che evidentemente ancora per
molti era da considerarsi una malattia. La reazione da parte della comunità
omosessuale di Torino non tardò a manifestarsi e fu così che nacque la prima
associazione di liberazione omosessuale italiana: il collettivo F.U.O.R.I.
acronimo di Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano. La Torino degli
anni di Piombo ma anche dell'Arte Povera fu quindi il centro delle prime vere
proteste, di un movimento gay organizzato con manifesti, striscioni e cortei,
capitanate dal libraio Angelo Pezzana, proprietario dichiaratamente omosessuale
della storica libreria Luxemburg. Parallelamente nacque l’esigenza di ordinare
le idee e comunicare attraverso il formato della rivista, ed è così che venne
alla luce il numero zero di Fuori! – mensile di liberazione sessuale, che
proprio nel 2021 compie cinquant’anni. Per questa occasione il giornalista e art
director Carlo Antonelli e la coppia curatoriale Francesco Urbano Ragazzi hanno
messo insieme per la casa editrice NERO un grande volume dove, oltre a
ripubblicare tutte le rare pagine della rivista, hanno messo in prospettiva i
temi e il lascito culturale del magazine, amplificandone se possibile il culto:
FUORI!!! 1971-1974 appunto, ma questa volta con tre punti esclamativi. Il duo di
curatori così racconta l’idea di portare nuovamente alle stampe il magazine
insieme ad Antonelli e in partnership con Levi's: "Carlo con il suo eclettismo è
un messia assoluto della ‘fuoranza’ contemporanea. FUORI!!! è a tutti gli
effetti frutto del nostro incontro con lui. Insieme avevamo già lavorato
sull'archivio del FUORI! tra il 2011 e il 2012 in occasione di una mostra che si
intitolava Io Tu Lui Lei e che rifletteva sull'eredità artistica dei movimenti
di liberazione omosessuale. Per qualche strana congiuntura astrale e grazie
all'Osservatorio Queer del Comune di Venezia, la mostra si tenne alla Fondazione
Bevilacqua La Masa con il sostegno del Ministero delle Pari Opportunità, allora
capitanato da una Mara Carfagna ormai redenta dopo una serie di dichiarazioni
infelici. In una parte della mostra esponemmo tutti i numeri del FUORI! che
catturarono immediatamente l'attenzione del pubblico. Carlo conosceva molto bene
quella storia e vedendo il catalogo di Io Tu Lui Lei, che riprendeva il formato
del FUORI!, si accese immediatamente. Il suo genio editoriale lo portò a pensare
subito che il FUORI! andava riportato alla luce. Tra il 2015 e il 2019 ci siamo
trovati a parlarne più volte, incontrando i fondatori della rivista a Torino,
fino a quando, due estati fa, non abbiamo deciso di chiamare Valerio Mannucci di
NERO e di iniziare questa avventura". Risfogliare oppure scoprire oggi FUORI!,
che i curatori del nuovo volume descrivono convintamente come “patrimonio
dell'umanità” significa anche confrontarsi con mezzo secolo di storia, di
cultura queer, di lotte e di vite: "Sfogliando le pagine del libro ci si renderà
immediatamente conto che il lessico a disposizione all'inizio degli anni
Settanta era limitato e che la parola omosessuale riuniva in sé tutta una serie
di spettri identitari che nella società del tempo restavano inespressi e
indicibili. Ma a furia di ripeterla, quella parola, è uscita dalla cronaca nera
e dal torbido, e si è lentamente imposta all'opinione pubblica per poi iniziare
ad articolarsi in numerose altre parole e specificazioni. Se oggi possiamo
definirci gay, non binari, queer, transgender, asessuali o in qualsiasi altro
modo lo dobbiamo certamente ai militanti del FUORI! che ci hanno permesso di
accedere ad un ordine del discorso altrimenti negato. Al contempo, vedremo come
la mancanza di terminologie e modelli a cui il Fronte Unitario Omosessuale
Rivoluzionario Italiano doveva far fronte rende quella stagione di lotta
estremamente generativa. Da questo punto di vista FUORI!!! diventa come
un'esortazione al disorientamento permanente". Il libro, anche per il suo
generoso formato appare oggi come un sorta di monumentale archivio che
circoscrive e rende accessibile un intero giacimento di idee, uno spazio in cui
stabilire nessi comparativi tra il nostro modo di vivere e quello testimoniato
dalle pagine raccolte. Il volume non è dedicato soltanto a chi si riconosce a
vario titolo nella galassia sessuale alternativa, ma è anche un documento che
evidenza il solco profondo che i membri di questa comunità hanno lasciato e
continuano ad imprimere nelle varie produzioni culturali, così come fanno notare
i Francesco Urbano Ragazzi: "Negli ultimi vent'anni è emerso in maniera
incontrovertibile quanto il consumo culturale sia una prerogativa LGBTQI+.
Parliamo non solo dei consumatori, ma anche dei trend-setter. Questo ha reso
improvvisamente desiderabile lo stile di vita di coloro che socialmente erano
stati relegati a una condizione minoritaria, se non deficitaria o anormale. Non
c'è dubbio alcuno che si tratti di un'enorme conquista: una vittoria estetica
che è anche politica, sebbene il legame con la politica ufficiale si sia forse
allentato. Dall'altro lato la forza scardinante della nostra comunità sta nel
non aderire alle dinamiche del mercato, rifiutando categoricamente la
categorizzazione e delegittimando la norma. Insomma, non vogliamo il
queernorm!". Ed è assai evidente quanto le tematiche di genere siano centrali
nel dibattito e nei linguaggi del contemporaneo finanche e sfiorare
l’exploitation in operazioni artistiche o di vero e proprio rainbow washing
funzionale al marketing e alla comunicazione: "Per molte ragioni," spiegano i
curatori, "quella stagione di lotta sta riecheggiando in vari canali di
comunicazione e questo ci sembra il segno di uno zeitgeist retroattivo che va
abbracciato e compreso. Dal nostro punto di vista però FUORI! non può diventare
un pretesto, come spesso avviene quando l'industria creativa -o presunta tale-
cerca profondità in una sigla o in una citazione. Certo i nostri tempi non si
prestano all'esegesi, ma parassitare o sublimare questo tipo di storie vuol dire
partecipare colpevolmente al loro fraintendimento. É per questo che FUORI!!!
1971-1974 è un readymade che ricalca alla lettera il testo originale, e lascia
ai lettori la possibilità e la libertà di studiare e disegnare nuove
associazioni con il presente". Ma FUORI! è stato soprattutto ed è, anche in
questa nuova reincarnazione XXL un oggetto straordinario, capace di esprimere e
inventare linguaggi. Carlo Antonelli, a sua volta geniale inventore di progetti
editoriali così ne restituisce le peculiarità: "è inutile dire che l’importanza
di FUORI! sta nel fatto di essere una rivista seriamente incredibile per l’epoca
e non solo per l’Italia; se uno va all’archivio di Torino trova forse la più
bella collezione di magazine gay che esiste in Europa perché il collettivo
studiò attentamente tutto ciò che veniva pubblicato, guardando anche alla
cultura sociale americana dell’epoca, sia in formati ufficiali che nell’ambito
dell’underground e tutto questo viene riassunto in FUORI! con un linguaggio che
in parte è mutuato dalle riviste politiche della sinistra extra-parlamentare del
tempo, unite però a un senso dello humor che era unico e all’ora completamente
inedito, esprimendo anche una capacità di prendendosi in giro che nella sinistra
emergerà solo successivamente, nel ‘77 ad esempio, con esperienze come Falce e
Mirtillo, lo humor che emerge attraverso le vignette di FUORI! è straordinario,
capovolgendo ad esempio il luogo comune dell’insulto in quello che abbiamo
definito come ‘Marxismo scheccante’". Dove scovare oggi la stessa intensità
rivoluzionaria erotica e ironica? Sempre per Carlo Antonelli lo spirito di
FUORI! non è da ritrovarsi più in un oggetto editoriale ma "in tutta quella
straordinaria emersione che sta venendo fuori dalla stand-up comedy di trentenni
italiani e di performer che stanno letteralmente cambiando le arti performative
in senso largo, anche nel pop nostrano e che hanno in comune quell’intelligenza
tagliente che distingueva la rivista" e inaspettatamente sotto forme
completamente nuove; "in quell’enorme universo della nuova idea di bellezza che
da tempo si è attivata attraverso le innumerevoli possibilità offerte dai filtri
digitali fatti di trucchi, metamorfosi, mutazioni e ‘fuoranza’ in genere che si
racconta dal punto di vista estetico in una sorta di iridescenza e impossibilità
di appartenenza a un unico genere sessuale che fortunatamente la cosmetica
avanzata sa esprimere".
FUORI!I 50 anni del primo
movimento omosessuale italiano.
Francesco Lepore su L'Inkiesta
il 20 Ottobre 2021. Fino al 24 ottobre sarà visitabile presso la Galleria delle
Immagini di Palazzo San Celso (Torino) la mostra dedicata all’organizzazione che
ha segnato le prime, storiche, lotte per i diritti Lgbtq+. Oggi è più che mai
importante ripercorrere una storia che continua ad avere ricadute positive e a
mantenere tratti di attualità. Il significato di un anniversario, per usare le
parole di un celebre discorso del filosofo Adriano Bausola, sta non solo nel
recupero della memoria storica ma anche nella riflessione attualizzante di
quanto si ricorda e celebra. È quanto sta avvenendo a Torino, dove fino al 24
ottobre sarà visitabile presso la Galleria delle Immagini di Palazzo San Celso
la mostra “FUORI! 1971 – 2021. 50 anni dalla fondazione del primo movimento
omosessuale in Italia”. Titolo, questo, anche del libro-catalogo, che è stato
edito nei giorni scorsi dalla Hopefulmonster a cura di Roberto Mastroianni e
Chiara Miranda. Organizzato dal Museo Diffuso della Resistenza, dal Polo del
‘900 e dalla Fondazione Sandro Penna, il percorso espositivo, di cui la
pubblicazione con saggi e interventi di varia importanza ne è completamento e
ideale prolungamento, ripercorre per immagini e documenti d’archivio le
principali tappe di quello che è stato il primo movimento nazionale per i
diritti delle persone omosessuali e che può riguardarsi quale inizio del
contemporaneo movimento Lgbt+ in Italia. Ne è stato fondatore, appunto 50 anni
fa, Angelo Pezzana, stimato libraio all’epoca proprietario dell’Hellas, in
reazione alla recensione del “Diario di un omosessuale” dello psicoterapeuta
cattolico Giacomo Dacquino. Comparso su La Stampa del 15 aprile 1971 col titolo
“L’infelice che ama la propria immagine” e scritto dal neurologo Andrea Romero,
l’articolo valutativo, condensato di stereotipi sull’omosessualità, ne rimarcava
il carattere patologico e la possibilità di guarigione attraverso «cure
cliniche». È l’autentica goccia che fa traboccare il vaso, tanto più che il
quotidiano torinese non aveva voluto pubblicare la richiesta di rettifica
redatta dallo stesso Pezzana. Questi decide allora di creare, insieme con amici
e amiche, una realtà militante esemplata sul modello di coevi movimenti d’area
europea come, ad esempio, il G.L.F. britannico o il F.H.A.R. francese. Tutti, in
ogni caso, ispirati e susseguenti al Gay Liberation Front statunitense, che era
nato immediatamente dopo i moti di Stonewall (28 giugno – 3 luglio 1969). Il
nome F.U.O.R.I – cui si sarebbe spesso sovrapposto con valore sinonimico quello
di FUORI!, titolo della specifica rivista edita per la prima volta nel dicembre
1971 – è ideato dal milanese Luigi Cannillo: ci si voleva richiamare sia al
“come out of the closet”, il grido di rivendicazione e d’orgoglio dei movimenti
di liberazione omosessuale, sia a quanto fatto in Francia dal F.H.A.R. o Front
homosexuel d’action révolutionnaire. L’acronimo F.U.O.R.I. significava infatti
Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano. Scritta, questa, che
compare su muri al centro di Torino già nel maggio-giugno di quell’anno a
testimonianza della prima azione di strada del movimento. Ma a far conoscere il
Fuori! a livello nazionale sarebbe stata la protesta inscenata, il 5 aprile
1972, davanti al Casinò di Sanremo, mentre è in corso il Congresso
internazionale di sessuologia. A manifestare, tra gli altri, Alfredo Cohen,
l’ecofemminista Françoise d’Eaubonne in rappresentanza del F.H.A.R. e Mario
Mieli, giunto da Londra a nome del Gay Liberation Front, mentre Angelo Pezzana e
Carlo Sismondi, sotto le mentite spoglie di psichiatri, seguono all’interno i
lavori congressuali per poi reagire pubblicamente contro la visione
patologizzante dell’omosessualità. In quel 1972 il FUORI! inizia anche a
espandersi in tutta Italia con l’apertura di sedi a Bologna, Ancona, Venezia,
Napoli, Brescia. Contemporaneamente l’omonima rivista s’impone sempre più come
mezzo d’informazione sulla lotta contro le discriminazioni e la tutela dei
diritti di persone gay e lesbiche grazie anche al contributo di nomi dal calibro
di Fernanda Pivano, Mario Mieli, Mariasilvia Spolato, Alfredo Cohen, Anna
Cuculo, Myriam Cristallo e di tanti altri insieme con lo stesso Pezzana. È la
linea di quest’ultimo a imporsi al Congresso nazionale del ’74, dove si decide
la federazione del movimento al Partito Radicale. La reazione non si fa
attendere con la formazione del gruppo Fuori! Autonomo di Milano, la conseguente
uscita dal FUORI! e la trasformazione, all’inizio del 1976, nei Collettivi
omosessuali milanesi o Com a opera di Mario Mieli. Di collettivi autonomi, così
chiamati perché non federati al Partito radicale e gravitanti a sinistra, ne
sarebbero poi nati in tutta Italia nella seconda metà degli anni Settanta. Mieli
sarebbe però rimasto profondamente legato al libraio piemontese, come
testimoniano due lettere inedite del 7 marzo 1983 (esposte alla mostra e ora
riprodotte nel libro-catalogo), nella prima delle quali il celebre autore degli
“Elementi di critica omosessuale”, cinque giorni prima di suicidarsi, esaltava i
«bei tempi del FUORI! – intendo prima della federazione col Partito Radicale», e
sottolineava la competenza di Pezzana in quanto «mai permise che un mio articolo
venisse stampato senza la dovuta cura». Nella seconda, invece, rilevando che «il
professor Rugafiori dell’Einaudi s’è comportato con me in maniera indegna, ho
mandato a Giulio Einaudi una lettera d’insulti e il contratto del “Risveglio dei
Faraoni” stracciato». Come noto, il controverso romanzo autobiografico, un vero
e proprio j’accuse nei riguardi della famiglia Mieli, sarebbe comparso postumo
solo nel 1994. Nella seconda metà degli anni ’70 l’attività del FUORI! è
soprattutto caratterizzata dal ruolo co-fondantivo dell’organismo internazionale
IGA, oggi ILGA, e dall’azione di attivisti come Enzo Francone, Bruno Di Donato,
Enzo Cucco. Pezzana, invece, che s’era imposto all’attenzione generale
manifestando nel novembre 1977 a Mosca per la liberazione del regista
omosessuale Sergej Iosifovič Paradžanov, vive anche la breve esperienza di
deputato radicale, da cui si dimise il 14 febbraio 1979 a otto giorni dalla
proclamazione. Ma è anche il periodo in cui fa parlare ampiamente di sé il
FUORI! di Palermo grazie all’operato di Piero Montana e, soprattutto, di
Giuseppe Di Salvo, che ne sono i fondatori nel 1976. Sono loro a ideare quel
breve corteo d’orgoglio rivendicativo, che, tenutosi nel capoluogo siciliano il
14 gennaio 1977, può considerarsi di fatto come il primo Pride italiano. Sono
soprattutto loro ad animare, insieme con Enzo Francone, Bruno Di Donato e altri
militanti palermitani, il convegno “Omosessualità. Orgoglio e pregiudizio”, che
ha luogo a Giarre poco dopo l’uccisione dei due “ziti” (fidanzati in dialetto
siciliano) Giorgio Agatino Giammona e Toni Galatola. Convegno, questo, preparato
da un manifesto di denuncia, che, composto dal brillante Di Salvo ed esemplato
sul profetico articolo di Pier Paolo Pasolini “Cos’è questo golpe? Io so”, è, in
uno dei pochi esemplari superstiti, anch’esso esposto a Torino per l’importante
valore testimoniale. Poco più di un mese dopo da quell’evento, cui aveva
partecipato anche un giovanissimo Francesco Rutelli, sarebbe sorto proprio a
Palermo – su proposta di don Marco Bisceglia e col coinvolgimento anche di
alcuni militanti del FUORI! locale – il primo Collettivo omosessuale dell’Arci,
divenuto il 22 maggio 1981 Arci-Gay e nazionalizzato nel 1985 da Franco Grillini
con assetto centralizzato e il nuovo nome di Arcigay. Il FUORI! si era già
disciolto coi lavori congressuali di Vico Equense nel gennaio 1982, non senza
aver precorso ancora una volta i tempi. Nell’ambito del VII Congresso nazionale,
tenutosi a Torino dal 3 al 5 ottobre 1980, il movimento fondato da Pezzana aveva
infatti avviato il primo confronto in assoluto su «matrimonio e convivenza
omosessuale e lesbica». Il voto sarebbe stato in realtà a favore di un
riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso e non già di
matrimonio secondo quello che era l’indirizzo di Pannella e dell’intero Partito
Radicale. A distanza di decenni, la terminata stagione FUORI! continua ad avere
ricadute positive e a mantenere tratti di attualità. Soprattutto per Angelo
Pezzana che, in una lunga intervista rilasciata al produttore Giorgio Bozzo e
pubblicata nel libro-catalogo, ha dichiarato: «Oggi tutti riconoscono
l’importanza del movimento omosessuale. Tutti riconoscono che fosse necessario e
per me è una bella soddisfazione. Però, non riesco a relegare questa cosa nel
passato: è ancora nel mio presente, è vivissima».
LA DESTRA, GLI OMOSESSUALI
E QUELLE RELAZIONI PERICOLOSE.
Mario Baudino per “La Stampa”
il 15 agosto 2021. «Non sono dell'AfD nonostante sia lesbica. Lo sono perché
sono lesbica»: la dichiarazione potrebbe suonare sorprendente, considerato che
viene da Alice Elisabeth Weidel, leader un partito di estrema destra come
l'Alternative fr Deutschland, sovranista, antieuropeo e fortemente sospetto di
neonazismo. In realtà un atteggiamento del genere fa intuire una nuova
condizione degli omosessuali di destra, che sono sempre esistititi anche se le
loro scelte politiche (spesso sciagurate) sono state motivate nel tempo
ricorrendo ad altri schemi ideologici. La politica delle destre, e in
particolare delle destre estreme, è sempre stata ferocemente omofoba: nel caso
del nazismo da un certo punto in poi addirittura sterminatrice, coi gay
rinchiusi nei lager e segnati col triangolo rosa, in quello che è stato definito
l'Omocausto. Per quanto riguarda la nostra contemporaneità, le leggi repressive
di Ungheria e Polonia che hanno suscitato la reazione dell'Unione Europea
sembrerebbero inoltre confermare una totale incompatibilità fra persone
omosessuali e scelte politiche reazionarie. Invece non è così. Marco Fraquelli,
studioso della cultura di destra, ci spiega che la situazione, sia dal punto di
vista storico sia da quello politico, è più sfaccettata. E' appena uscito presso
l'editore Oaks il suo A destra di Sodoma, con prefazione di Franco Grillini. Si
tratta dell'edizione aggiornata di un testo uscito nel 2007 (col titolo
Omosessuali di destra): un utile work in progress, anche perché gli ultimi
quindici anni sono stati significativi al proposito. Sul passato, ormai,
sappiamo tutto. Dalle figure più note ad altre in apparenza secondarie, la
galleria dei gay di destra è da tempo aperta al pubblico: basti pensare a
Mishima, grande scrittore che, dopo aver creato un suo piccolo esercito di
studenti per opporsi (anche se non con le armi) alla democrazia giapponese in
nome della sacralità della tradizione imperiale, fa irruzione in una caserma di
Tokyo - il 25 novembre 1970 - e si suicida come un samurai. O a Ernst Rohm, fra
i primissimi compagni di Hitler, creatore delle SA, l'apparato paramilitare che
consentì l'ascesa del nazismo: venne eliminato a Bad Wiesse, stazione termale
bavarese, insieme al suo stato maggiore. Fu la «notte dei lunghi coltelli»
(giugno 1934), e non andò proprio come nella scena celeberrima della Caduta
degli dei, il film di Visconti. Le SA dormivano tranquillamente al momento delle
irruzioni delle SS, guidate dallo stesso Hitler, e non vennero sorpresi durante
un'orgia (solo uno di loro era effettivamente a letto con un giovanotto). Furono
arrestati e solo successivamente uccisi. Hitler eliminò così un antagonista che
diventava pericoloso, non forse in quanto omosessuale. E' vero però che Heinrich
Himmler bandì di lì a poco una crociata contro i gay, considerandoli una
minaccia alla forza e alla coesione nazionale. Fino ad allora l'omosessuale di
destra era un aristocratico che aveva come punto di riferimento l'idea greca di
pederastia, incarnata nel mito del «Battaglione sacro» di Tebe, formato da
centocinquanta coppie di amanti adulti e di amati adolescenti. Da quel momento
gli si aprirono le porte di lager come Dachau. Ciò non impedì tuttavia che in
Europa, ad esempio in Francia, fossero moltissimi i collaborazionisti
omosessuali (Sartre li definì «un covo di zie», e se ne scandalizzò a tal punto
che ebbe per anni grandi difficoltà a prendere in considerazione i diritti delle
comunità LGBT). Fra molti nomi a noi poco famigliari, il più noto è ovviamente
Robert Brasillach, scrittore assai popolare nella Francia occupata, cantore
dell'amicizia adolescenziale e di un'Europa hitleriana, fucilato nel '45; ma c'è
anche Henri de Montherlant, che si sciolse in lodi per l'esercito tedesco
invasore - e salvò la pelle. Va detto che nessuno dei due ebbe a proclamarsi
apertamente gay, ma la cosa era di dominio pubblico, come del resto sarebbe
avvenuto per Mishima. Il contesto direttamente o indirettamente guerriero non è
però il solo, anzi probabilmente appartiene ormai al passato. Nella sua ampia
indagine sul tema, Fraquelli sembra intercettare segnali di mutamento, al di là
di eredi tra il bizzarro e l'inquietante come certi skinheads russi che nel loro
manifesto proclamano di combattere contro ebrei ed eterosessuali (aggiungendo
per soprammercato che anche Hitler era gay). Ma la leader dell'AfD che abbiamo
citato all'inizio intercetta un atteggiamento più complesso: quello che spinge
molti omosessuali a votare «pragmaticamente» (per esempio per sentirsi più
tutelati rispetto agli islamici, anche rinunciando a certi diritti, come
sostiene Didier Lestrade in un libro del 2012 uscito per il Seuil, Pourquoi les
gays sont passes à droite). Sta nascendo una sorta di amicizia ancora una volta
pericolosa e dalle motivazioni piuttosto contraddittorie, considerata la
politica delle destre? In Italia esiste da tempo un'associazione, Gaylib, creata
nel 1997, che ora aderisce a Fratelli d'Italia. Si sentono un fattore di stimolo
e sensibilizzazione, e sostengono anche che il fascismo non è omofobo, perché
non emanò leggi al proposito. Vero: ma solo perché l'esistenza di omosessuali
nell'Italia del Duce era considerata inammissibile. Citarli sarebbe stato un
riconoscimento della loro esistenza. Come nel film di Scola, Una giornata
particolare, finivano nel caso, silenziosamente, arbitrariamente, al confino.
Da blitzquotidiano.it il 5
maggio 2021. Barbara Gallavotti ospite a DiMartedì parla dei gay e
dell’omosessualità spiegando che non c’è niente di contronatura e che, anzi,
l’omosessualità è prevista sia dalla natura sia dall’evoluzione. Barbara
Gallavotti è una biologa, accademica, autrice televisiva e divulgatrice
scientifica, ed è anche una delle ospiti fisse nel programma condotto da
Giovanni Floris.
Barbara Gallavotti e i gay. “I
gay sono contronatura?”, le chiede Floris. Barbara Gallavotti risponde: “A parte
che io ho un problema a pensare che gli esseri umani devono adeguare il proprio
comportamento a quello che fanno le altre specie. Noi stiamo facendo qualcosa di
terribilmente contronatura. Non ho mai visto altre specie fare dirette
televisive. Però nel caso dell’omosessualità il problema non c’è perché è
prevista dalla natura e dall’evoluzione, tant’è che estremamente diffusa”.
Gay e altre specie. A questo
punto Barbara Gallavotti prosegue: “Ci sono qualcosa come 1500 specie diverse
nelle quali si sono visti comportamenti omosessuali. Dai mammiferi al moscerino
della frutta. Coppie stabili, coppie temporanee, coppie che si formano per
allevare una prole ottenuta con l’aiuto di qualche altra specie. Ci sono anche
animali che cambiano sesso nel corso della vita. Magari trascorrono la prima
parte della loro esistenza come maschi e la finiscono come femmine. Quindi, se
ci appelliamo alla natura possiamo considerarci massimamente liberi. Resta da
capire se vogliamo basare i nostri diritti fondamentali su quello che fanno i
moscerini della frutta, perché ci resta di girare intorno alle mele marce e poco
altro”.
Dagotraduzione da Nbc News il 22 aprile 2021.
Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, il tasso di suicidi
globale è aumentato negli ultimi anni, e i giovani gay o bisessuali hanno quasi
cinque volte più probabilità di togliersi la vita rispetto ai loro coetanei
etero. I ricercatori del Williams Institute, un think tank sull'orientamento
sessuale e l'identità di genere presso la UCLA School of Law, hanno scoperto che
il 30% degli intervistati lesbiche, gay e bisessuali di età compresa tra 18 e 25
anni ha tentato almeno una volta il suicidio. Ma più sale l'età, più diminuisce
la percentuale: nella fascia 34-41 anni sono stati il 24%, in quella 52-29 il
21%. Lo studio, pubblicato il mese scorso sulla rivista PLOS One, ha anche
rivelato che questi i giovani vivono livelli più elevati di repressione, disagio
psicologico e omofobia rispetto alle generazioni più anziane. «Ci aspettavamo
davvero che sarebbe stato meglio per il gruppo più giovane», ha detto l'autore
principale Ilan H. Meyer, un illustre studioso senior di politiche pubbliche
presso l'istituto. «Ma allo stesso tempo, sapevamo che i dati di altri studi
hanno dimostrato che i giovani LGB fanno molta più fatica dei giovani
eterosessuali - oggi più che in passato». Meyer e i suoi colleghi hanno
intervistato 1.518 persone che si sono identificate come lesbiche, gay o
bisessuali (i trans sono stati inclusi in uno studio separato). I partecipanti
sono stati divisi in tre categorie: la generazione "Pride", i nati dal 1956 al
1963; la generazione "Visibility", nata dal 1974 al 1981; e la generazione
"Equality", nata dal 1990 al 1997. Utilizzando la scala Kessler, una misura
clinica del disagio psicologico, hanno scoperto che i membri della generazione
Equality riportavano quasi il doppio dei sintomi di ansia e depressione rispetto
alla generazione Pride. Molti fattori hanno influenzato i dati, ha detto Meyer,
incluso il fatto che le persone stanno andando via di casa sempre prima. «Questo
può essere positivo, ovviamente», ha detto. «Ma può anche ritorcersi contro e
esporti a molte molestie e persecuzioni. Potresti non essere preparato per le
conseguenze». I membri della generazione Equality hanno riferito di aver fatto
coming out con un membro della famiglia in media all'età di 16 anni, rispetto ai
22 per la generazione Visibility e ai 26 per la generazione Pride. Il rischio è
quello dei sentirsi rigettati in un momento in cui i ragazzi fanno più
affidamento sulla famiglia per il supporto emotivo e finanziario, ha spiegato
Amy Green, vicepresidente della ricerca per The Trevor Project,
un'organizzazione di prevenzione dei suicidi e di intervento per le crisi
giovanili LGBTQ. Secondo un sondaggio condotto dall'organizzazione lo scorso
anno, il 40% dei giovani LGBTQ di età compresa tra 13 e 24 anni aveva seriamente
considerato di tentare il suicidio nei 12 mesi precedenti. «Non è che il mondo
non stia facendo progressi per le persone LGBTQ, è che i recenti progressi hanno
portato a una straordinaria comunità di giovani che capiscono chi sono ma vivono
ancora in un mondo in cui gli altri potrebbero essere scortesi con loro,
rifiutarli, maltrattarli o discriminarli», ha detto Green in una e-mail. «E
sappiamo che queste esperienze di repressione possono aggravare e produrre esiti
negativi per la salute mentale». L'avvento dei social media e di Internet ha
anche influenzato notevolmente il senso di identità. «Quando abbiamo chiesto
loro le reazioni di altre persone nella comunità, le risposte del gruppo più
giovane erano sempre riferite - sempre - ai social media, mai agli incontri
nella vita reale», ha detto Meyer. «Le persone sono molto crudeli online, che si
tratti di Twitter o Grindr». Meyer ha anche detto si aspettava di leggere, nelle
interviste, giovani adolescenti e ventenni presentare «un modo diverso di essere
gay». Invece «uno dei primi racconti che ho ascoltato è stato quello di un
18enne latinoamericano di San Francisco. La sua storia era la stessa delle
generazioni passate: omofobia, esclusione, vergogna. L'evoluzione [nei diritti
LGBTQ] non ha avuto alcun impatto sulla sua vita». I ragazzi della generazione
più giovane hanno mostrato una maggiore persecuzione anti-LGBTQ rispetto alle
loro controparti più anziane, ha detto Meyer. Quasi 3 su 4 (72%) hanno
dichiarato di essere stati insultati verbalmente sulla propria identità e quasi
la metà (46%) ha dichiarato di essere stata minacciata di violenza. Più di un
terzo (37%) ha riferito di essere stato aggredito fisicamente o aggredito
sessualmente. «Credo nel potere delle istituzioni e delle strutture sociali che
cambiano. Lo credo davvero», ha detto Meyer. «Ma penso che il vero progresso
richieda più tempo di quanto pensiamo. Solo perché stiamo assistendo a un
cambiamento non significa che i genitori di ogni bambino gay lo accettino o che
i loro amici li stiano abbracciando».
DAGONEWS il 20 aprile 2021.
Malika Chalhy è finita al centro della scena mediatica perché insultata dai
genitori, cacciata di casa dopo aver rivelato di essere lesbica. In diversi
programmi, da Le Iene al Maurizio Costanzo Show, ha raccontato la sua storia che
ha suscitato parecchia indignazione, è stata avviata anche una raccolta fondi
che ha già raggiunto ben 130 mila euro. Una domanda sorge spontanea: che
rapporti ha la ragazza toscana con la Match Picture, agenzia di management e
ufficio stampa che fa capo a Giuseppe Carriere (storico amico del giornalista e
autore Gabriele Parpiglia)? Malika li tagga per l'ospitata al Maurizio Costanzo
Show, la pagina a sua volta rilancia articoli su di lei o il servizio de Le Iene
che la vede protagonista. Stando alle nostre fonti le ospitate della Chalhy per
ora hanno previsto solo un rimborso spese e non un vero cachet.
Chi è Malika Chalhy, la 22enne cacciata
di casa dai genitori perché lesbica. Elisabetta
Panico su Il Riformista il 15 Aprile 2021. La 22enne Malika Chalhy, originaria
di Castelfiorentino, in provincia di Firenze, è diventata protagonista di un
caso doloroso che sta avendo enorme attenzione mediatica. E’ stata brutalmente
cacciata di casa dai propri genitori, con i quali ha sempre avuto un buon
rapporto. Almeno fino al suo coming out: Malika è lesbica. Lo scorso gennaio i
suoi genitori non le hanno più aperto la porta di casa. A suo favore si sono
esposti anche personaggi noti del mondo dello spettacolo. Malika si è innamorata
di una ragazza e a “causa” di questo amore da gennaio ormai non ha più un tetto
sotto il quale dormire. I genitori si sono rifiutati di ridarle anche i vestiti
lasciandola completamente sola, senza neanche una maglietta di ricambio. Nel
tentativo disperato di ottenere qualcosa da indossare, Malika si è presentata
sotto casa scortata dalle forze dell’ordine. Ma una volta bussato alla porta di
casa, la mamma si è affacciata alla finestra e ha esclamato davanti al
carabiniere: “Io non conosco questa persona“. Malika si descrive come una
ragazza sensibile e caparbia, attaccata molto alla famiglia. Da sempre ha avuto
un ottimo rapporto con i genitori, specialmente con la mamma e non si aspettava
assolutamente una reazione del genere da parte della famiglia che, come ha detto
alle telecamere de Le Iene, si è sempre fatta in quattro per
lei. Malika, durante l’adolescenza, è stata anche fidanzata con un ragazzo, ma
durante una festa ha incontrato quella che oggi è la sua attuale ragazza. Da
subito ha capito di provare un sentimento diverso. Le due sono fidanzate dalla
notte del 27 agosto, quando su una panchina si sono dichiarate il loro amore.
Essendo ormai una coppia di fatto, era arrivato il momento per Malika di
rivelare a tutti i suoi affetti di essersi innamorata di un’altra ragazza. La
prima persona con la quale ha fatto coming out è la sua migliore amica Gaia, che
la sta aiutando soprattutto ora che non ha neanche un letto. Anche quest’ultima
e ha tentato di parlare con la mamma di Malika, che le ha detto che non si
dovevano mai più far vedere, per nessun motivo al mondo. Per Malika, il momento
di parlare con i suoi genitori per dire di essere gay, è arrivato dopo diversi
tentativi sempre rimandati al “giorno dopo”. Poiché terrorizzata di parlare con
i propri genitori, la ragazza ha scelto di fare coming out con una lettera nella
quale chiedeva di starle accanto. Dunque ha scritto la lettera e l’ha lasciata
nel cassetto della mamma, la mattina prima di uscire per andare a lavoro. Una
volta tornata da lavoro però i genitori non le hanno aperto più la porta di
casa. Da quel momento non ha più visto gli occhi della mamma né tantomeno ha
avuto un abbraccio. Tra le tante note audio la mamma ha minacciato la figlia e
la fidanzata, augurandole il cancro. Ora Malika è spaventata e non sa più come
chiedere aiuto. La sua storia fortunatamente ha avuto un riscontro mediatico
enorme e Malika, abbandonata dalla propria famiglia, sta trovando la forza di
andare avanti grazie all’affetto che moltissime persone le stanno dimostrando.
Ha ricevuto solidarietà anche da grandi personaggi, come Fedez, Elodie, Mhamood,
Alessia Marcuzzi o Tommaso Zorzi. E’ stata ospite del Maurizio Costanzo Show. La
cugina ha avviato una raccolta fondi su Go Found Me per aiutarla che ha già
raggiunto una somma di oltre 120 mila euro. La ragazza ha fatto sapere che parte
del ricavato lo donerà a diverse strutture che hanno bisogno d’aiuto proprio
come lei.
Elisabetta Panico. Laureata in relazioni
internazionali e politica globale al The American University of Rome nel 2018
con un master in Sistemi e tecnologie Elettroniche per la sicurezza la difesa e
l'intelligence all'Università degli studi di roma "Tor Vergata". Appassionata di
politica internazionale e tecnologia.
La raccolta fondi per la ragazza di
Castelfiorentino. Il caso di Malika Chalhy, raccolti oltre 120mila euro per la
22enne cacciata di casa perché gay. Elisabetta
Panico su Il Riformista il 15 Aprile 2021. Dopo esser stata cacciata di
casa, Malika Chalhy, 22enne, di Castelfiorentino, in provincia di Firenze, è
rimasta senza vestiti né un tetto sotto il quale dormire. Con i pochi soldi che
guadagna dal lavoro è riuscita a comprare due tute e un paio di scarpe. La sua
storia è divenuta celebre in tutta Italia: è stata cacciata dai genitori perché
è lesbica, e quindi per il suo rapporto con la sua fidanzata. Una raccolta fondi
per aiutarla ha raggiunto oltre 120mila euro. Per fortuna Malika non è sola,
come ha raccontato in un’intervista a Le Iene. Sta andando a dormire o dalla sua
migliore amica o dalla sua attuale fidanzata. Nello stesso servizio, andato in
onda il 12 aprile, Malika ha fatto ascoltare le note audio ricevute dalla mamma.
Parole dure, troppo forti, soprattutto se dette da madre a una figlia. Malika ha
raccontato di aver sempre avuto un ottimo rapporto con la madre, almeno fino al
giorno del coming out. “Fai schifo, sei morta, meglio una figlia drogata che
lesbica“, e ancora molte altre, urlate con odio. Dopo il vano tentativo
dell’inviata del programma di parlare con i genitori di Malika, la giornalista
ha ricevuto una chiamata del fratello della ragazza che ha aggiunto un’altra
notizia, sconosciuta anche alla stessa protagonista della vicenda. I genitori
hanno iniziato la pratica per il disconoscimento. La storia di Malika ha quindi
avuto un riscontro mediatico enorme. Sono state innumerevoli le testate
giornalistiche che hanno raccontato il caso e la ragazza ha ricevuto solidarietà
anche da grandi personaggi, come Fedez, Elodie, Mhamood, Alessia Marcuzzi
o Tommaso Zorzi. E’ stata invitata anche da Maurizio Costanzo, al suo programma
serale Maurizio Costanzo Show. Lo stesso conduttore ha preso le difese della
ragazza dicendo che lui “sarà sempre dalla parte di chi viene picchiato perché
si bacia con un uomo o di una donna che viene cacciata di casa perché ama
un’altra donna. Non è tollerabile che nel 2021 ancora devono succedere queste
cose. A me dispiace molto per lei, ha solo 22 anni e spero che abbia la forza di
reagire e vivere“. La ragazza ha lanciato un appello alla famiglia dicendo:
“Fatevi aiutare, chiedete aiuto“. Per aiutare Malika, ormai rimasta senza
neanche una maglietta di ricambio, la cugina ha creato una raccolta fondi su Go
Found Me con la quale ha già raggiunto una somma di oltre 120 mila euro. La
ragazza sottolinea che parte del ricavato lo donerà a diverse strutture che
hanno bisogno d’aiuto proprio come lei.
Elisabetta Panico. Laureata in relazioni
internazionali e politica globale al The American University of Rome nel 2018
con un master in Sistemi e tecnologie Elettroniche per la sicurezza la difesa e
l'intelligence all'Università degli studi di roma "Tor Vergata". Appassionata di
politica internazionale e tecnologia.
La vicenda. Chi è Malika Chalhy, la
22enne cacciata di casa dai genitori perché lesbica.
Elisabetta Panico su Il Riformista il 15 Aprile 2021. La 22enne Malika Chalhy,
originaria di Castelfiorentino, in provincia di Firenze, è diventata
protagonista di un caso doloroso che sta avendo enorme attenzione mediatica. E’
stata brutalmente cacciata di casa dai propri genitori, con i quali ha sempre
avuto un buon rapporto. Almeno fino al suo coming out: Malika è lesbica. Lo
scorso gennaio i suoi genitori non le hanno più aperto la porta di casa. A suo
favore si sono esposti anche personaggi noti del mondo dello spettacolo.
Malika si è innamorata di una ragazza e a “causa” di questo amore da gennaio
ormai non ha più un tetto sotto il quale dormire. I genitori si sono rifiutati
di ridarle anche i vestiti lasciandola completamente sola, senza neanche una
maglietta di ricambio. Nel tentativo disperato di ottenere qualcosa da
indossare, Malika si è presentata sotto casa scortata dalle forze dell’ordine.
Ma una volta bussato alla porta di casa, la mamma si è affacciata alla finestra
e ha esclamato davanti al carabiniere: “Io non conosco questa persona“.
Malika si descrive come una ragazza sensibile e caparbia, attaccata molto alla
famiglia. Da sempre ha avuto un ottimo rapporto con i genitori, specialmente con
la mamma e non si aspettava assolutamente una reazione del genere da parte della
famiglia che, come ha detto alle telecamere de Le Iene, si è sempre fatta in
quattro per lei. Malika, durante l’adolescenza, è stata anche fidanzata con un
ragazzo, ma durante una festa ha incontrato quella che oggi è la sua attuale
ragazza. Da subito ha capito di provare un sentimento diverso. Le due sono
fidanzate dalla notte del 27 agosto, quando su una panchina si sono dichiarate
il loro amore. Essendo ormai una coppia di fatto, era arrivato il momento
per Malika di rivelare a tutti i suoi affetti di essersi innamorata di un’altra
ragazza. La prima persona con la quale ha fatto coming out è la sua migliore
amica Gaia, che la sta aiutando soprattutto ora che non ha neanche un letto.
Anche quest’ultima e ha tentato di parlare con la mamma di Malika, che le ha
detto che non si dovevano mai più far vedere, per nessun motivo al mondo.
Per Malika, il momento di parlare con i suoi genitori per dire di essere gay, è
arrivato dopo diversi tentativi sempre rimandati al “giorno dopo”. Poiché
terrorizzata di parlare con i propri genitori, la ragazza ha scelto di
fare coming out con una lettera nella quale chiedeva di starle accanto. Dunque
ha scritto la lettera e l’ha lasciata nel cassetto della mamma, la mattina prima
di uscire per andare a lavoro. Una volta tornata da lavoro però i genitori non
le hanno aperto più la porta di casa. Da quel momento non ha più visto gli occhi
della mamma né tantomeno ha avuto un abbraccio. Tra le tante note audio la mamma
ha minacciato la figlia e la fidanzata, augurandole il cancro. Ora Malika è
spaventata e non sa più come chiedere aiuto. La sua storia fortunatamente ha
avuto un riscontro mediatico enorme e Malika, abbandonata dalla propria
famiglia, sta trovando la forza di andare avanti grazie all’affetto che
moltissime persone le stanno dimostrando. Ha ricevuto solidarietà anche da
grandi personaggi, come Fedez, Elodie, Mhamood, Alessia Marcuzzi o Tommaso
Zorzi. E’ stata ospite del Maurizio Costanzo Show. La cugina ha avviato una
raccolta fondi su Go Found Me per aiutarla che ha già raggiunto una somma di
oltre 120 mila euro. La ragazza ha fatto sapere che parte del ricavato lo donerà
a diverse strutture che hanno bisogno d’aiuto proprio come lei.
Elisabetta Panico. Laureata in relazioni
internazionali e politica globale al The American University of Rome nel 2018
con un master in Sistemi e tecnologie Elettroniche per la sicurezza la difesa e
l'intelligence all'Università degli studi di roma "Tor Vergata". Appassionata di
politica internazionale e tecnologia.
Giovanni Sallusti per "Libero quotidiano" il 15
aprile 2021. La cronaca non esiste più, esiste solo la propaganda, in questa
versione peggiorativa dell' incubo orwelliano che sono i tempi in cui ci è dato
vivere. Non è che il Media Unico politicamente corretto deformi la realtà, siamo
oltre: non esiste nessuna realtà, se non quella che conferma i tic, le pose, l'
ideologia perbene e pettinata del suddetto Media Unico. Prendete la storiaccia
di Malika Chalhy, la ventiduenne di Castelfiorentino cacciata di casa perché
lesbica. Insultata, minacciata di morte, diseredata. Tra il campionario offerto
dai famigliari gentiluomini: «Se torni ti ammazziamo, meglio 50 anni di carcere
che una figlia lesbica» (i genitori); «ti taglio la gola» (il fratello); «io non
so chi sia questa persona» (la madre, dopo che la ragazza è tornata a casa in
compagnia dei Carabinieri per ritirare almeno qualche effetto personale). Grande
e sacrosanto baccano mediatico attorno a Malika, giustamente presentata a
testate unificate come vittima di un'omofobia cieca, fanatica, bestiale. Scatta
una gara di solidarietà tra i vip arcobaleno, la cantante Elodie lancia una
raccolta fondi in sostegno della giovane che ha già superato i 30mila euro
(applausi), Vladimir Luxuria definisce, con tutte le ragioni, «contronatura» i
genitori che bandiscono la figlia, i sostenitori della legge Zan ne approfittano
per inondare le agenzie di dichiarazioni sulla retriva e patriarcale
inclinazione italica all' omofobia. Chi non resiste a buttarla direttamente in
politica è Fedez, che nella veste di opinionista riesce a essere perfino più
mediocre che in quella canora, e se la prende con «i vari Pillon, associazioni
cattolico-estremiste, antiabortisti» (la colpa è di senatori leghisti e Chiesa
cattolica, in sintesi). Tutto bene, anzi no, perché nessuno cita un lievissimo,
infinitesimale dettaglio, quello per cui i famigliari di Malika, gli odiatori
contro il diritto e perfino contro il proprio stesso sangue, sono di cultura
islamica. Lo ha ricordato il portale FeministPost, non esattamente un covo di
fascio-sovranisti. Che racconta come il padre si chiami Aberrazak e sia di
origine marocchina, il fratello si chiami Samir, e soprattutto sul profilo
Facebook del primo circolino foto di tutta la famiglia con le donne velate. Come
riporta lo stesso sito, è impossibile stabilire il livello di ortodossia
religiosa di quella casa, ma quel che è certo è che la tragedia di Malika ha
come sfondo un contesto (pseudo)culturale musulmano. Spiace, editorialisti e
musicanti che vi retwittate a vicenda, ma in questa storia inascoltabile non c'
entra l' associazionismo cattolico, non c' entra nemmeno la tessera della Lega,
c' entra invece quella che la grande scrittrice e dissidente somala Ayaan Hirsi
Ali ha definito «la più pericolosa forma di omofobia ai giorni nostri»: quella
«islamica». Del resto, per quanto non sia mai un tema gettonato negli appelli
filo-gender della buona società nostrana, i gay vengono decapitati nella sunnita
Arabia Saudita, impiccati nello sciita Iran, gettati dai tetti nei territori
ancora controllati dall' Isis. Dove c' è Islam, spesso c' è persecuzione omicida
e fondata teocraticamente delle persone omosessuali. Una lunga scia di odio, che
può prolungarsi anche fino a un piccolo borgo sui colli fiorentini. Ma, statene
certi, non arriverà mai sulle prime pagine dei giornaloni.
Dagospia il 16 aprile 2021. Da La Zanzara -
radio24.ilsole24ore.com. Intervista bomba a La Zanzara su Radio 24 di Samir
Chalhy fratello di Malika, la ragazza ventiduenne di Castelfiorentino cacciata
di casa perché lesbica.Samir smentisce tutto quello che è stato detto finora e
attacca la sorella: “Ha sputtanato la famiglia davanti a tutta la nazione per
quattro note audio, non voglio rivederla”. “Non la voglio più vedere perché è
un’infame, non perché è lesbica”. “La raccolta fondi l’ha organizzata lei prima
di mettere il video, ha fatto tutto per soldi. Ha tradito la famiglia per
denaro”. “Minacciata da mamma? Ma che dite? E’ uno sfogo di cinque secondi, mia
madre non l’avrebbe mai toccata, non le avrebbe fatto niente, in 22 anni le
abbiamo fatto solo del bene”. “Due giorni dopo il coming out ha chiamato le Iene
e le portate sul posto di lavoro di mio padre, ha messo benzina sul fuoco, non
ha dato tempo ai miei genitori di assimilare la cosa”. “Io non approvo, sarei
stato più contento se fosse arrivata a casa con un ragazzo. Non è una dittatura.
Ma le ho scritto: ti appoggio in ogni scelta, in ogni cosa”. “Sono libero di
pensare e dire a mia sorella: non approvo, essere lesbica sarà una vita più
tortuosa”. “Mia madre ha reagito male, quelle cose non si dicono, ma non
l’avrebbe mai toccata. Certe cose si dicono anche per fare del male”. “Tagliare
la gola? L’ho detto a Malika quando ha minacciato di venire a casa coi
carabinieri e gli avvocati. Allora ho risposto: venite e vi taglio la gola, ma
sono conversazioni tra fratello e sorella”. “Ho sempre detto e scritto a mia
sorella che ero il suo bastone, che poteva contare su di me”. “Diffondere gli
audio è la cosa più orribile che si possa fare” “Nessuno l’ha cacciata perché
lesbica, è uscita una mattina per andare a lavorare e non è più tornata, ha
cavalcato l’onda delle note audio di mia madre per raccogliere soldi. Non sono
omofobo, stanno istigando all’odio contro di noi. I miei non l’hanno mai
cacciata di casa, è una balla che ha detto lei”. “Mia madre spesso mi ha detto:
come ti ho fatto ti disfò, come ti ho fatto ti disfò. E’ fatta così, ma non le
avrebbe mai fatto nulla”. “Ha cavalcato le note audio di mia madre per
intenerire la gente, è una furba, una viscida. Ma l’ha spiazzata su Italia 1 per
farla infamare da un popolo intero”. “Non abbiamo nulla contro il fatto che è
lesbica, puoi dirlo forte, ci siamo rimasti male, ma le cose sarebbero andate
come per le altre lesbiche o gay, sarebbero andate bene. Ma uno non va via da
casa, non chiama i carabinieri, le telecamere, aggrappandosi a quattro note
audio”. “Noi islamici? Macchè, mangiamo anche i morti, la religione non c’entra
nulla. manco mio padre è islamico”. "Per me è normale se lei è lesbica, è chiaro
che ci vuole tempo per accettarlo. Se portava un ragazzo a casa ero contento al
cento per cento". "Amore? Si è seduta sulla panchina con questa ragazzina, si
sono guardate e le ha detto: sono innamorata di te. L'amore è altro". "Stanno
istigando all'odio dandoci degli omofobi". “Lesbica? Due anni fa ha conosciuto
un ragazzo e dopo dieci giorni voleva lasciare lavoro e famiglia. E’ fatta
così”. “Siamo talmente violenti che mio padre dopo la tv si è sentito male, è
svenuto. L’omofobia non c’entra nulla, il problema è una ragazza che registra la
voce della mamma e la mette in diretta nazionale”. "Le denunce? Non mi importa,
so quello che ho fatto e quello che ho detto". "Malika ha voluto speculare su
questa cosa qui, voglio vedere quanto darà in beneficenza. A casa non ha mai
tirato fuori un euro, servita e riverita, la conosco bene la mia sorella". "Ha
sputtanato i miei genitori in tutta Italia per quattro messaggi".
Il Doge per Dagospia il 5
aprile 2021. Milano è un porno d'autore. Uno di quelli dalla sceneggiatura
essenziale. Rigorosamente senza colonna sonora. Senza suoni che non siano quelli
dei lascivi gemiti della carne che esulta. Carne sopra carne. Erezione della
truce, e a volte trucida, meraviglia e conflitto del piacere. È un po' come
l'idea di "arte" per gli esistenzialisti crucchi: "apertura di un nuovo mondo di
verità". E la verità è la piu' piccolo borghese delle pause: quella del post
orgasmo. Quella con la sigaretta in bocca. E una gran fetta di Milano, questa
terza ondata del feroce virus la sta vivendo corrompendo le soste. Sta forzando
le sue erezioni. Amplificando i suoi amplessi. Mettendo a rischio se stessa.
Annaspando e nuotando in gioie di "contrabbando". Milano proprio non ce la fa a
rinunciare al suo lato B. Un città che gira intorno all’ano, anche in tempo di
Covid. Qualsiasi colore i governanti le mettano addosso. E da quando puttane,
escort, trans e pusher hanno non pascolano più sotto la Madonnina, riducendo
all'osso le feste chem-sex o "pan-sex", i milanesi cosiddetti "etero" fanno di
necessità virtù. Dagospia si è imbattuto in Francesco B., uomo gay di 43 anni
con un po' di panza e un filo di barba, che ci ha raccontato la sua storia.
Francesco ha affittato per 5 giorni una stanza in un Bed & breakfast vicino
piazzale Loreto. E ha postato su un sito di incontri il suo annuncio, corredato
dalle seguenti foto: "Vanessa trav insospettabile ospita gratis h24. Cercasi
solo attivi dominanti. Sono Vanessa TRAV insospettabile di 42 anni amante dei
gingilli larghi e pieni. Ospito GRATIS ora in Loreto uomini italiani e non, che
vogliono essere soddisfatti da me. Cerco ora e non domani. Contatto telefonico
immediato e veloce. No perditempo”. Francesco, meglio specificarlo, ha indossato
solo una parrucca in testa e un paio di orrende scarpe in plastica rosa lucido e
tacco 12. Ha conservato fiero la sua barbetta e il suo villoso e rigonfio
addome. Come è andata? In quattro giorni e tre notti si sono presentati ben 103
uomini, di età compresa tra i 19 ai 55 anni. Le categorie professionali? Le più
disparate. Di notte tassisti, camionisti, conducenti di autobus, tre infermieri,
addetti alla metro e dipendenti Auttogrill. Il 90% sposati o fidanzati. Poi
quattro guardie giurate, due vestiti da militari (che volevano farlo in tre).
Tre addetti alla sicurezza. Hanno risposto all’appello anche molti corrieri
Amazon e "pizza boys". Anche due postini e uno che guidava un camion con
idrante. Ben rappresentata anche la categoria dei liberi professionisti:
consulenti finanziari, un paio di novelli avvocati e una cinquina di agenti
immobiliari. Dieci studenti, tra i 19 e i 26 anni, di buona famiglia e ben
vestiti. Non potevano mancare gli operai e ragazzoni col reddito di cittadinanza
in attesa di occupazione. Quasi tutti italiani. Cosa chiedeva la stragrande
maggioranza? Un rapporto versatile, bi-curious: possedere ed essere posseduto.
Molti i feticisti dei piedi e del tacco 12. E il rischio covid? A nessuno è
sembrato importare granché. Ps: ha risposto all’annuncio anche uno dei
protagonisti del programma "Matrimonio a prima vista". Ha chiesto di poter
raggiungere l'orgasmo con la antica e complessa tecnica del fisting…Di chi si
tratta? A quale edizione ha partecipato? Ah, saperlo...
Luca Beatrice per mowmag.com
il 6 marzo 2021. “Outing e coming-out? È stato un atto liberatorio, ma è
diventato una moda”. “Gender Fluid? Pericoloso, e comunque un atteggiamento
figlio della superficialità del tempo”. A sostenere tali posizioni non è un
conservatore, un reazionario, uno che non vuol capire che stiamo vivendo nel
terzo millennio, ma un omosessuale autenticamente rivoluzionario che esattamente
cinquant’anni fa fondò il FUORI, acronimo che sta per Fronte Unitario
Omosessuale Rivoluzionario Italiano. Sto parlando di Angelo Pezzana, oggi
ottantenne, un simbolo non solo per Torino (la città in cui il movimento prese
il via) ma per tutta quella parte d’Italia, omo o etero, che ha sempre amato la
libertà propria e altrui. Di professione libraio indipendente, ha fondato la
Hellas nel 1963 e anni dopo la Luxemburg, considerata ancora oggi tra le dieci
librerie più belle in Europa, promotore della scintilla che accese il Salone del
Libro, Angelo appartiene al mondo della cultura, di certo meno discriminante di
altri sulla questione omosessuale eppure non scevro da certa ipocrisia di fondo.
Amo e stimo profondamente quest’uomo (lui non se lo ricorda, ma da ragazzino
passavo interi pomeriggi a scartabellare da Hellas le riviste internazionali,
unica a venderle in città) perché non si lamenta mai, non si lagna, non
piagnucola sull’ingiustizia del mondo. Ma quale gay? Angelo è un frocio cazzuto
con un dna tostissimo e coraggioso, che non significa il coraggio superficiale
dell’ostentazione - negli anni 70 indossava camicie rosa e lo guardavano male ma
detesta i ragazzini con le unghie smaltate e i capelli colorati - ma quello di
assumere rischi e pericoli, come manifestare da solo a Mosca nel 1977 per
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prigionia del regista Sergiej
Paradzanov, incarcerato dal regime sovietico perché omosessuale. Va bene che in
Italia la sinistra nei tardi anni 80 ha preso le distanze dall’URSS, però Angelo
Pezzana è convinto (e lo sono anche io) che il PCI e i suoi eredi non abbiano
mascherato del tutto di derivare da una cultura fondamentalmente chiusa e
burocratica. “Per quelli di destra eravamo degli sporcaccioni, per i cattolici
dei peccatori da redimere, per i comunisti comunque un problema”. Ci è voluto
Marco Pannella e il Partito Radicale per un’altra idea di sinistra in Italia,
moderna, vicina al mondo liberale e post-ideologica quando ancora le ideologie
esistevano e facevano danni. Ma questa è un’altra storia. Da un’eresia a
un’altra, Angelo ne combina diverse: collabora per Il Giornale e per Libero,
perché Vittorio Feltri gli lascia lo spazio che desidera senza censure, sposa la
questione israeliana e la sua politica governativa. È proprio il caso di dire…
altri cazzi, ma d’altra parte un rivoluzionario non si appisola su posizioni
scontate e banali, ha bisogno di spazi liberi, di decidere di testa propria, di
andar controcorrente, da solo e mai nel branco. Non c’è tragedia né tristezza
nell’omosessualità come la racconta Pezzana. Gli piaceva scopare, come a me,
come a noi, solo che invece delle donne preferiva i ragazzi. Negli anni ’70,
dopo che Torino era già passata dal ’68, i posti per incontrarsi erano i
gabinetti pubblici, le ultime file dei cinema di terza visione, magari le serate
svoltavano bene, alla fine si conoscevano tutti e cominciarono a diffondere il
numero zero di FUORI, giornale-manifesto nato sulla scorta dell’esperienza
francese e per reazione a un articolo uscito su La Stampa che recensiva il libro
di uno psicanalista convinto di riuscire a “guarire” gli omossessuali e farli
tornare “normali”. Perché ho voluto raccontare questa storia ai lettori di Mow?
Per ribadire un concetto cui tengo molto: ci sono persone che rivendicano sempre
e comunque la propria libertà, muoversi, andare, venire, far sesso, bere,
mangiare, divertirsi, andare in moto, prendere posizioni impopolari e fare
scelte sbagliate. Angelo ritiene #metoo una vera e propria aberrazione e neppure
gli piace Black Lives Matter, o quantomeno gli desta qualche sospetto di
conformismo. E sulle ultime mode del momento ha risposto: "Achille Lauro? Non so
chi sia". Quando gli diciamo che imita un po' Bowie un po' Renato Zero aggiunge:
"Già Renato Zero non mi piace, ha sempre fatto finta e detesto l'ipocrisia...".
Capite allora che razza di personaggio è Angelo Pezzana?
Stefano Semeraro per “La Stampa” l'1 marzo 2021.
Joy Neville è una pioniera abituata alle sfide, non solo sul campo di rugby. Nel
2013 ha capitanato la prima Nazionale irlandese vincitrice nel Sei Nazioni
femminile, poi è stata la prima donna ad arbitrare campionati maschili in
Italia, Irlanda e Galles e la prima a gestire il Tmo (la Var del rugby) in un
incontro maschile internazionale. Oggi aspetta un figlio insieme con sua moglie
di origini italiane, Simona Coppola, sposata nel 2015 quando nella molto
cattolica Irlanda il referendum che riconosceva i matrimoni fra persone dello
stesso sesso passò con il 62 per cento di voti.
Mrs Neville, come è stata accolta dai colleghi
quando ha iniziato ad arbitrare?
«A braccia aperte, con un sincero desiderio di
rendersi utile. Sono stata fortunata, perché in Irlanda ho colleghi di grande
livello».
I giocatori come si sono comportati?
«All'inizio non è stato sempre facile. I membri
più anziani, vestiti con i colori del loro club, mi chiedevano: "Oh, sei qui ad
arbitrare la terza squadra?". E quando rispondevo che ero lì per il match più
importante, si preoccupavano: "Sei sicura di saper reggere il ritmo di gioco?".
Ci vuole tempo per assorbire il cambiamento. Per rispondere alla sua domanda:
molto dipende dai primi minuti di gara. Se sei attenta e precisa, poi non ci
sono problemi».
Ha subito contestazioni?
«C'è sempre una minoranza che fa attenzione alle
questioni di genere. È una motivazione in più, so che se non arbitro bene ci
sarà qualcuno pronto a dire: "È solo una donna". Mi spinge a prepararmi sempre
al meglio. Voglio però che passi questo messaggio: non si tratta di genere, di
sessualità o colore della pelle; ma solo di quanto sei brava a svolgere il tuo
lavoro».
Conosce Stephanie Frappart, la prima donna che ha
arbitrato nella Champions League del calcio?
«Non di persona, ma ci siamo messaggiate. Sta
facendo cose molto importanti per le giovani. Vederla in grado di arbitrare così
bene ad alto livello può incoraggiare chi altrimenti non ci proverebbe nemmeno».
È più facile arbitrare una partita al maschile o
al femminile?
«Un match femminile. Non per una questione di
livello di gioco, ma perché le donne sono più oneste».
Anche Nigel Owens, l'arbitro di rugby più famoso
al mondo, è apertamente gay. Possiamo dire che il rugby in questo è avanti
rispetto ad altri sport, come il calcio?
«C'è bisogno di un salto culturale. Oggi solo chi
ha un carattere forte è disposto a parlarne apertamente. È un cambiamento che
deve venire dalle giovani generazioni. Gli sportivi che hanno fatto coming out
li conti sulle dita di una mano, difficile pensare che non siano di più. Penso
che il rugby in questo sia meglio del calcio, specie a livello femminile. Fra i
maschi si può migliorare molto, sui gay c'è una sorta di stigma. In generale,
più si parla della questione, più la gente non avrà paura di dichiarare le
proprie inclinazioni sessuali, nello sport come nella società».
Laura Berlinghieri per “La Stampa” il 29 gennaio
2021. «La cosa che mi ha fatto più male? Leggere le offese rivolte a mia figlia,
nel tentativo di ferire me. C'è chi l'ha chiamata ragazzina sintetica e chi ha
scritto che non può essere considerata una bambina, perché frutto di un atto
contro natura». Sono le parole del 34enne trevigiano Manuel Zardetto, eletto
"papà più bello d'Italia" a seguito di un concorso sul portale Starpeoplenews.
Una nomina che ha scatenato una vergognosa pioggia di insulti sui social, perché
Manuel, papà di una bimba di sei anni e mezzo, è omosessuale. «Mia figlia non è
nata da un atto sessuale tradizionale, ma con l'inseminazione artificiale. È il
frutto dell'amore di un uomo omosessuale e di una donna single, che avevano un
grandissimo desiderio di creare una famiglia, senza andare contro la rispettiva
natura. La mia bimba ha due genitori e, da un anno e mezzo, un secondo papà, il
mio compagno, che presenta con orgoglio alle amichette». Una situazione che la
bambina vive con la massima naturalezza. Le tante fotografie sui social la
ritraggono, sorridente, vicino al padre, mentre indossa una corona di cartone,
va a scuola, è truccata per Carnevale, mangia il gelato. Una felicità nella
quale un nutrito gruppo di sconosciuti ha sentito l'esigenza e il diritto di
insinuarsi, con le parole più becere: «È un rapporto malato. Questa non è una
bambina. I figli hanno una mamma e un papà». Parole di fronte alle quali
Zardetto risponde con il silenzio: «Preferisco non direi niente, perché non
riuscirei a essere molto diplomatico». Manuel ora vive a Milano, dove lavora nel
settore del commercio dei cavalli. La figlia trascorre alcuni giorni a casa sua
e altri dalla madre. «Ho una vita bellissima, che non cambierei per nulla al
mondo, e un rapporto splendido con la mamma della mia bambina. Mia figlia ha
sempre vissuto con normalità questa situazione. Non so come sarà la sua
generazione, ma la immagino aperta e "fluida", anche grazie alla grande campagna
di sensibilizzazione che si sta portando avanti. La cattiveria è nelle parole
degli adulti». Una cattiveria che Zardetto ha cercato di codificare: «Credo che
a incidere sia soprattutto l'ignoranza. Gli insulti, a cui non ho risposto, sono
arrivati da persone che vomitano odio a ruota libera, ragionando per stereotipi:
"Quello che hai fatto è il male, è contro natura. Tua figlia nascerà in maniera
sbagliata". Non riesco a capire perché gente che non mi conosce debba entrare
nella mia vita». Dopo la conquista del titolo di papà più bello d'Italia, Manuel
è diventato una sorta di punto di riferimento per tanti genitori gay, che
faticano a vivere serenamente la propria omosessualità. «Ci sono padri di
famiglia che mi scrivono, chiedendomi un consiglio su come aprirsi con i figli.
C'è ancora tanta paura. Qualche tempo fa, mi ha contattato un uomo dicendomi
che, leggendo la mia storia, aveva trovato il coraggio di dichiararsi
omosessuale. Ne sono stato veramente felice». Nonostante lo tsunami che lo ha
travolto, Zardetto rivendica le sue scelte, sostenendo che, anche prevedendo
cosa sarebbe successo, avrebbe comunque partecipato al concorso che gli ha dato
tanta visibilità. «Avevo messo in conto che sarebbe potuto accadere. Non
sopporto che venga offesa mia figlia, perché è sintomo di una bassezza infinita,
che mi provoca molta rabbia. Pensare che i genitori possano essere solo quelli
che mettono al mondo un bambino è inconcepibile, nel 2021». Manuel è nato in
Paraguay 34 anni fa, ma ha dovuto percorrere più di 10 mila chilometri per
conoscere quella che sarebbe stata la sua famiglia, venendo adottato da una
coppia di Vittorio Veneto, nel Trevigiano. «Sono l'esempio vivente del fatto che
non sia l'atto sessuale a identificare due persone come genitori. Mio padre e
mia madre sono l'uomo e la donna di 76 anni che per quasi metà della loro vita
si sono sbattuti, impartendomi un'educazione. Mia figlia è felice vicino a me,
che sono il suo papà, vicino alla sua mamma e vicino al suo secondo papà. È
questo il mio "schiaffo" agli omofobi».
Maria Novella De Luca per "la Repubblica" il 28
gennaio 2021. Luca ha perso uno dei suoi due papà quando aveva soltanto cinque
anni. Giulio, dirigente d' azienda, è morto d' infarto a 40 anni, nel 2015, e
Luca, nato con gestazione di supporto negli Stati Uniti nel 2010, è stato
cresciuto a Milano da Corrado, l'altro suo papà. Corrado è il genitore
biologico, mentre suo marito Giulio era "l' altro genitore", il "padre
intenzionale" che la legge italiana ancora stenta a riconoscere. Luca, da ieri,
è il primo bambino in Italia a cui l' Inps dovrà riconoscere la pensione di
reversibilità del "padre intenzionale", ossia del padre non biologico e per lo
stato italiano inesistente. Un fantasma. Alla vigilia dell' udienza di oggi
della Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi sull' ancora troppo incerto
destino dei figli delle coppie omosessuali, con la sentenza numero 803 del 2020,
la Corte d' Appello di Milano ha condannato l' Inps a garantire a Corrado e a
Luca la pensione di reversibilità di Giulio. Morto, purtroppo, prima che in
Italia arrivassero le unioni civili e le adozioni speciali per i figli delle
coppie gay. Grazie alla battaglia portata avanti e vinta in appello dall'
avvocato Alexander Schuster, l' Inps dovrà garantire a Luca la pensione di un
padre che per la legge italiana non esiste. Tutti i nomi di questo storia sono
naturalmente di fantasia, mentre la felicità di Corrado e di suo figlio Luca
sono reali e palpabili. A differenza dei due casi che oggi la Corte
Costituzionale dovrà analizzare, nei quali il "genitore intenzionale" è stato
cancellato dai tribunali, questa è invece una storia di riconoscimenti e
successi. Racconta Schuster: «Luca nasce negli Stati Uniti nel 2010 da una madre
surrogata e dall' amore di Corrado e Giulio, che si sposano sempre negli States
nel 2013. Vivono vicino a Milano. Giulio muore a causa di un infarto fulminante
nel 2015, senza aver potuto ancora riconoscere in Italia il piccolo Luca. Con un
lungo lavoro burocratico e giuridico, grazie anche all' intelligenza di una
funzionaria di anagrafe, nel 2017 siamo riusciti a far trascrivere, post mortem,
il certificato di matrimonio americano di Giulio e Corrado. E il certificato di
nascita di Luca che negli States risultava con due papà». Quindi la battaglia
per ottenere la reversibiità della pensione. Già ottenuta in altri casi dal
coniuge sopravvissuto di coppie unite civilmente, ma mai da un figlio "non
biologico". «È una sentenza storica in una situazione che mette il diritto
spalle al muro di fronte ad un dramma. La Corte di appello di Milano fa
giustizia e condanna l' Inps a riconoscere a questa famiglia gli stessi diritti
che riconosce ad ogni altra famiglia. Le famiglie arcobaleno non vivono solo la
gioia e le emozioni della genitorialità. Esse vivono anche dolorosi conflitti di
coppia. Esse vivono i drammi di una morte inattesa e prematura». Ed è questo il
riferimento ai casi che oggi saranno discussi dalla Consulta. La vicenda di
Valentina, che dopo la rottura con la sua compagna, è stata esclusa dalla vita
delle sue due figlie. Bambine concepite con fecondazione eterologa all' estero e
che lei, madre non biologica, non aveva potuto riconoscere alla nascita. Dunque
oggi Valentina non ha alcun diritto legale sulle sue figlie. Se l' Italia
riconoscesse che il consenso dato da Valentina alla fecondazione eterologa della
sua compagna all' estero valesse, così prevede la legge 40 per le coppie etero,
come riconoscimento del figlio, Valentina potrebbe legalmente a riabbracciare le
sue bambine. E anche nel secondo caso in discussione oggi davanti alla Corte, il
tema è la "cancellazione" di un genitore. Un bambino nato in Canada con
gestazione di supporto, lì riconosciuto come figlio di due papà, nella
trascrizione italiana del certificato di nascita, ne ha "perso" uno, restando
figlio solo del genitore biologico.
·
Le Lesbiche.
Michela Proietti per corriere.it il 15 dicembre
2021. Sapessi come è strano parlare di fluidità a Milano: anzi no, perché la
capitale morale ha per prima azzerato le differenze di genere, promosso le
unioni civili e animato il dibattito culturale sulla diversity. Anche per questo
Eliana Miglio, attrice, modella e autrice, ha ritenuto giunto il momento per
ripubblicare un suo scritto, «La grande invasione delle rane» (Il Prato), che
affronta il tema della identità sessuale, proprio nel momento in cui questa si
forma, dunque nel passaggio dall'età infantile a quella adulta. «Quella stagione
della vita in cui si è ibridi come «tutti questi girini nello stagno»-come
scrive Silvia Ronchey, bizantinista e amica della scrittrice - Sono passati
quindici anni da quando è stato pubblicato per la prima volta, e oggi il tema
che lo assilla e il soggetto corale che lo anima sono diventati dominanti non
solo nel nostro cinema e nella nostra letteratura, ma nell'evoluzione della
nostra società e dunque anche della politica». A presentare questa riedizione,
allo SpazioBigSantaMarta con l'autrice è intervenuta la giornalista Giulia
Cerasoli, la scrittrice Sibyl von der Schulenburg con la lettura di Federica
Simonelli, attrice e doppiatrice. A fine presentazione è stato offerto un
cocktail che ha consentito agli ospiti di ammirare la nuova mostra di pittura
allestita nello spazio con artisti dal `400 al `goo tra cui una meravigliosa
tela rossa di Lucio Fontana. Alla presentazione sono intervenuti personaggi di
spicco della «milanesità», come Paola e Guido Pennisi, della gioielleria di
monili antichi di via Manzoni. «Sono cresciuta in un paese di provincia, a
Luino, sul Lago Maggiore, dove i piccoli tumulti del cuore e della sessualità
erano identici a quelli che si vivono oggi - spiega la Miglio-: eravamo anche
noi «figli» di David Bowie. Una fase di passaggio vissuta con le stesse
indecisioni e gli identici turbamenti dei ragazzi di oggi». Dopo la fortunata
presentazione milanese, c'è stata quella romana, al Cinema Farnese. Eliana
Miglio si divide anche nella vita privata tra Roma e Milano. «Agnese e Anna sono
due sorelle adolescenti in fasi di maturazione diverse, ma per entrambe si
profilano rischi che in qualche modo le accomunano alle rane nella loro
evoluzione e trasmigrazione riproduttiva». «Non è di rane che parla questo libro
ovviamente, ma di un importante e doloroso viaggio interiore che compiono
Agnese, Anna, Clara e Luca i principali protagonisti di questa vicenda», ha
scritto nella prefazione Francesco Patierno. Figlia di padre milanese e di madre
tedesca, è terzogenita dopo un fratello ed una sorella: ha vissuto tra i cinque
e i quindici anni di età sulle rive del lago Maggiore, a Luino, dove a 12 anni
ha lavorato come dj nell'emittente locale Radio Stereo 4. Sempre a Luino ha
frequentato il primo e parte del secondo anno scolastico, per poi andare a
vivere in Germania e successivamente in collegio a Cortina d'Ampezzo.
Dagospia il 3 dicembre 2021. Capitolo tratto
da "La grande invasione delle rane", di Eliana Miglio (Il Prato edizioni). Sono
le sei di sera. Sono tre giorni che piove ed è tornato il freddo. La casa di
Clara è un po’ umida. Mi stringo nel pullover norvegese mentre prendiamo un te’
dentro delle tazze scompagnate. Clara sta sistemando i bagagli coi suoi vestiti.
In un angolo c’è una vecchia valigia ammaccata. “Era di mia nonna”, dice. “Io ho
vissuto con lei. Dentro c’è tutto quello che mi ha lasciato”. Ha una voce chiara
come quella di una bambina.
Mi fa tenerezza e corro da lei, sedendomi sul
bracciolo della poltrona dove è accocolata.
“Piccola!” le dico mentre la stringo dolcemente.
Mentre ridiamo le scivolo in grembo, per attirarla
a me e baciarla. “Non sono mai stata cosi felice” mi sussurra all’orecchio. Le
succhio il seno attraverso la camicetta. I capezzoli le diventano duri. “Ho
voglia di te”, le dico prendendola per mano.
Con lei mi sento sicura. So quello che devo fare.
Lei mi segue baciandomi il collo. Ci tuffiamo sul letto e le slaccio
frettolosamente i pantaloni. Le cosce di Clara sono sottili con piccoli peli
biondi fini. La pelle profuma di borotalco, a dispetto del profumo che usa, che
non c’entra nulla con lei. Paco Rabanne un profumo da uomo.
Accarezzo la pelle lievemente ambrata, il pube
scuro e poi di nuovo la pancia piatta, sensuale. Le bacio un piccolo neo sopra
l’ombelico.
Le ossa dei fianchi sporgono lievemente, ma sono
arrotondate. Ha un sedere piccolo, ben fatto. Senza muscoli. Ha le spalle
dritte, le braccia magre. Anche le sue mani mi piacciono molto, anche se le sue
unghie lunghe, troppo curate, mi sembrano finte.
Mentre mi accarezza disinvoltamente, mi chiedo:
Quante volte l’ha già fatto? Con chi? Dove ha imparato?
Divento gelosissima e mi tuffo dentro di lei.
Vorrei fare l’amore facendole un po’ male. Penso che le mie dita potrebbero non
bastarle. La bacio a lungo. Ha un sapore salato. Le infilo la lingua. La sento
ansimare sotto di me. Allungo la mano fino al suo seno sinistro e stringo forte
il capezzolo. “Ti amo”, le esce.
Mi stacco, il tempo di dirle “Anch’io”. Poi
continuo fino a che la sento respirare sempre piu’ forte, al ritmo dei baci.
Le infilo fino in fondo insieme alla lingua anche
un dito, l’indice. E’ molto bagnata, ma voglio di più. Quando sono stanca
appoggio la testa al suo ventre accarezzandola. “Ti amo”, sospiro.
L’ho detto altre volte, ma questa volta sento che
è davvero cosi.
“Non sono mai stata cosi bene con nessuno”, dice
lei.
Ridiamo.
Dagospia il 3 dicembre 2021. Capitolo tratto
da "La grande invasione delle rane", di Eliana Miglio (Il Prato edizioni). Un
roll-on all'arancio, boccettine di vetro con scritto Metadone, tabacco Drum,
cartine da sigarette e un mazzo di chiavi con un piccolo serpente di pelle nera
con gli occhi che brillano. «Bello, vero? L'ho preso a Londra.» «Sei stato a
Londra?» «Sì, l'estate scorsa, in vacanza... veramente sono scappato di casa.»
Pensavo: Ma se è minorenne come ha fatto a passare il confine? Ma, per non
contraddirlo, gli ho chiesto: «Parli inglese?» «Sì, l'ho imparato dalle
canzoni.» Mi è simpatico Luca. Mi è familiare e mi piace che abbia sempre il
sorriso sulle labbra. Trovo curioso il suo modo di gesticolare con la mano
destra, mettendo in mostra le unghie un po' lunghe, ma curate. In lui stona
soltanto la risata. t come se avesse dentro uno gnomo che ride per lui. Ho
voglia di andare a casa. Mi metto a cercare Anna. In giardino non c'è. Entro in
casa e salgo al piano superiore. Tutto tace. Mi si stringe il cuore. «Anna!
Anna, dove sei?» «Che c'è, Agnese?» Entro nella stanza e la vedo nuda, coi
capelli spettinati che le coprono il seno mentre un raggio di sole le illumina
una spalla e metà del viso. Si siede. Clara ride sotto al lenzuolo. Anna si
copre svogliatamente, raccogliendo i vestiti sparsi per terra. Guardo la
bottiglia di bianco mezza vuota e il bicchiere sporco sul comodino. Sento che
bisogna parlarle piano, dolcemente. «Vorrei andare a casa...» «Adesso, adesso
andiamo... stavo riposando un po'.» «Ti aspetto giù.»
Daniela Mastromattei
per "Libero quotidiano" il 21 settembre 2021. Non ci si può nemmeno candidare in
pace a Miss Mondo. Il giudizio lapidario (non richiesto) di chi sosta giorno e
notte sui social è arrivato prima di quello della giuria del concorso. A
dimostrare che non basta più la bellezza, una pioggia di battute sarcastiche dai
toni aggressivi ha travolto nelle ultime ore due aspiranti Miss. Motivo? Non si
accetta che tra le finaliste ci sia una (presunta) simpatizzante di Matteo
Salvini e una candidata che a un fidanzato preferisce una fidanzata. I
frequentatori di Facebook e dintorni sanno essere assai spietati. A 'sto giro si
sono scagliati prima contro Claudia Motta, 21 anni. Lei è al terzo anno di
Giurisprudenza a Roma e sogna di diventare magistrato. Un'aspirante paladina
della legge che, per il suo fisico statuario, i capelli biondo oro e il nasino
alla francese, ha sconfitto le altre 20 concorrenti e ora può volare, insieme ad
altre nove, alla finale nazionale di Gallipoli, in Puglia il 26 settembre, a
rappresentare il Lazio. La giovane, originaria di Velletri, è già nota al grande
pubblico della televisione per avere fatto l'"angelo custode" di Piero
Chiambretti in Tiki Taka. E fin qui tutto bene. Ma secondo i professorini del
web, Claudia avrebbe commesso un errore, scegliendo di mettere sul suo profilo
Instagram il motto Memento Audere Semper/1922, ("ricorda di osare sempre"),
locuzione in latino coniata dallo scrittore e poeta Gabriele D'Annunzio e dunque
considerata "di destra", citata anche in alcune occasioni da Matteo Salvini, per
rendere omaggio al Motoscafo armato silurante, acronimo Mas, un'imbarcazione
bellica usata sul finire della Prima Guerra Mondiale. Lo stesso D'Annunzio
partecipò alla prima battaglia in cui fu utilizzato il Mas, quella che divenne
nota come la Beffa di Buccari. Viene contestata Claudia anche per i suoi
riferimenti politici su Facebook; si nota per esempio che segue Giorgio Greci,
capogruppo della Lega-Salvini premier di Velletri, e Luigi Grossi, portavoce di
Fratelli di Italia nel Comune di Pico. E allora? Niente: giù raffiche di
insulti. Come quelli arrivati anche alla piemontese Erika Mattina, "colpevole"
di amare una donna. E di averlo dichiarato pubblicamente. Adesso ha passato le
varie selezioni per Miss Mondo Italia ed è arrivata anche lei in finale: è tra
le 25 che si contenderanno la fascia. Una gioia per la bella ragazza di Arona
(provincia di Novara) subito offuscata dalle offese omofobe su Instagram.
L'accusa più ricorrente? «È passata solo perché lesbica», scrivono sui social.
Diversi messaggi sul web hanno più o meno lo stesso significato. «Oramai il
ghieismo è ovunque e vince sempre». E ancora. «Come fa una omosessuale
dichiarata a fare le selezioni per Miss Mondo? Assurdo dove stiamo arrivando».
Tutti commenti pubblicati sull'account della pagina Instagram che condivide con
Martina Tammaro (la sua fidanzata). Non hanno fatto in tempo neanche a
festeggiare il piccolo successo che sono state aggredite in modo davvero
spiacevole. E forse non tanto perché Erika ha superato le semifinali, ma perché
le due ragazze sui social hanno reso pubblica la loro scelta di vita, immagini
dove appaiono belle e sorridenti. Felici. Non sarà stata invece proprio quella
gioia a far uscire allo scoperto gli invidiosi (è pieno il mondo) che si sono
accaniti sulla coppia? Erika va avanti nonostante gli insulti. «Tu sai quanto
vali - le dice Martina- e sai che hai e avrai sempre un sacco di persone dalla
tua parte». Ma non ce l'hanno una vita coloro che passano il tempo a spiare,
nascosti dietro a un monitor, e soprattutto a criticare quella degli altri? A
quanto pare no. Ricordano quei personaggi di memoria fantozziana, leoni con i
deboli e inginocchiati davanti al capo.
Giusi Fasano per il "Corriere
della Sera" il 21 settembre 2021.
Come sta?
«Bene, dai. Adesso va un po'
meglio. Ci diamo del tu?»
Certo. Un po' meglio rispetto
a quando?
«Rispetto alle prime ore.
Quando arriva l'ondata è sempre difficile, ti agiti e ci rimani male anche se
sei abituata».
Abituata a...
«A insulti di ogni genere,
ogni giorno, a messaggi che hanno più parolacce che spazi, a cattiverie, a
minacce di morte. Cose tipo: se vi becco per strada vi ammazzo, prego per farvi
morire... Stavolta però non me lo aspettavo».
Perché no?
«Perché in questo momento non
sto facendo la lesbica attivista. Sto facendo una cosa per me, sono qui da sola
e sto vivendo una gioia per essere arrivata alla finale di Miss Mondo Italia,
non sto scrivendo un post sul ddl Zan. Non giustificherei gli haters nemmeno per
il ddl Zan ma tirare in ballo l'orientamento sessuale per un concorso di
bellezza... Sono più dispiaciuta che arrabbiata».
Ti rovinano la festa?
«Ci provano ma non ci
riusciranno. Però che fatica avere a che fare di continuo con gente frustrata
che usa i social per sfogarsi...».
Stiamo parlando con Erika
Mattina, 24 anni, fidanzata da quasi cinque con Martina Tammaro, 26. Tutte e due
attiviste lgbt e antiomofobia, via Facebook ma soprattutto via Instagram, dove
gestiscono un profilo da 120 mila follower che si chiama leperledegliomofobi.
Cos' è successo in questi
ultimi due giorni?
«Che i soliti leoni da
tastiera se la sono presa con me perché sono fra le 25 finaliste di Miss Mondo.
A parte gli insulti l'accusa è: sei passata perché lesbica. Fortuna che Martina,
lontano, sta gestendo tutto in modo impeccabile per non farmelo pesare».
Lo staff del concorso si è
detto «basito» da questi attacchi «da voltastomaco».
«Mi sono tutti molto vicini e
qui (a Gallipoli per la finale del 26, ndr ) nessuno è interessato alla mia
omosessualità».
Davvero gli odiatori sono così
presenti nella vita tua e di Martina?
«Mi piacerebbe dire che non è
così ma non posso. Ci tartassano da mattina a sera». Denunce?
«Non so più quante volte siamo
andate dalla polizia. Abbiamo denunciato una settantina di profili, e sono solo
i post più gravi e minacciosi».
E quindi sono arrivati ai
responsabili.
«Alcuni sono profili fake,
altri non sono rintracciabili, altri ancora spargono odio e poi vengono
eliminati. Sono risaliti solo a due identità. Due uomini, un adulto e un
ragazzo. L'adulto aveva incitato al bullismo contro di noi da un profilo con
nome e cognome vero. Non lo abbiamo mai visto ma durante la causa civile (vinta)
lui ha consegnato al nostro avvocato un foglio con scritte le scuse per quello
che aveva detto».
Scuse accettate?
«Beh, diciamo che le scuse
sono già qualcosa, un piccolo traguardo. Il foglietto lo abbiamo incorniciato».
E invece il ragazzo?
«È ancora tutto in corso».
Vi è capitato di incontrare
fisicamente qualcuno che vi aveva insultato via social?
«No, perché sono codardi alla
fine. Fanno i leoni da tastiera finché restano anonimi e protetti dietro uno
schermo. Però ci sono capitate situazioni in cui qualcuno se l'è presa con noi
per un abbraccio o un bacio. Anche lì: insulti, risatine, una volta un papà ha
coperto gli occhi di un bambino perché avevo dato un bacio "a stampo" a
Martina».
Se avessi davanti una delle
persone che vi ha scritto cattiverie che gli diresti? «Dipenderebbe da quel che
ha scritto. Se fosse solo un commento cattivo proverei a ragionare e a capire
perché prendersi la briga di venire sul mio profilo a insultarmi. Davanti a
minacce di morte sarei meno diplomatica».
I vostri genitori saranno
preoccupati.
«Molto. Mia madre mi dice che
spesso non riesce a dormire, soprattutto se legge minacce di morte, appunto».
Il coming out?
«Dopo sei mesi che stavo con
Martina. Non è stato facile. Ho perso molti amici, giovani ma pieni di
pregiudizi. Confido nelle nuove generazioni. Anche in famiglia non è stato
facile. I genitori di Martina l'hanno presa bene, i miei hanno fatto più fatica,
ma alla fine oggi amano Martina. Le cose possono cambiare. A chi crede di non
farcela dico: abbiate fiducia».
Da grande vuoi fare...
«Mi piacerebbe entrare in
polizia».
Valentina Sarmenghi per "la
Stampa" il 20 settembre 2021. Quando Erika Mattina è stata selezionata tra le 25
finaliste di Miss Mondo Italia, la fidanzata Martina Tammaro ha condiviso la
gioia di questo traguardo con un post sui social, dove le due ragazze di Arona
sono molto attive. Ma gli haters non si sono fatti attendere. «Come fa una
lesbica dichiarata a fare le selezioni per Miss Mondo? Assurdo», «È passata solo
perché è gay», «Sono più tutelati i ghiei (sì, proprio scritto così, ndr) che le
persone normali (...) Ormai il ghieismo è ovunque e vince sempre». Questo il
tenore di diversi commenti omofobi al post. «Gli attacchi contro di noi si
ripetono a cadenza regolare ma questa volta trovo la situazione ancora più
assurda - dice Martina, che con Erika ha aperto sui social la pagina "Le perle
degli omofobi" proprio per sensibilizzare sul tema dei diritti Lgbtq+ -. Si
tratta di una competizione alla quale partecipa solo Erika, non c'entra la
nostra coppia e lei è arrivata a questo risultato superando selezioni molto
rigorose». La prima online durante il primo lockdown un anno e mezzo fa, poi in
presenza ha ottenuto in Lombardia la fascia di Miss del Web. E così è partita
con altre 200 ragazze per Gallipoli, dove si trova ora, e dove ha superato anche
l'ultimo step per essere tra le 25 che si sfideranno per il titolo il 26
settembre. «Hanno messo in mezzo l'orientamento sessuale ma non ha nessun senso
- continua Martina - Erika è arrivata tra le finaliste perché se l'è meritato e
basta. Io sono molto orgogliosa di lei e volevo condividere questo bel momento.
Spero solo che possa vivere questa esperienza in modo sereno nonostante questi
stupidi commenti. Io anche se siamo lontane le do tutto il supporto che posso».
Ci sono anche numerosi commenti di solidarietà: «L'amore con tutte le sue
sfaccettature, ecco il mondo come dovrebbe essere, fatto di solo amore. Brava!
Anzi brave!», oppure «Complimenti Erika , siete veramente mitiche ragazze!» sono
solo due esempi. «Siamo fortunate - conclude Martina - perché oltre alle nostre
famiglie che ci sostengono abbiamo tanti follower meravigliosi che ci
incoraggiano ad andare per la nostra strada, ed è proprio ciò che faremo».
Oramai il ghieismo è
ovunque e vince sempre”.
Chi è Erika Mattina, la 23enne finalista di Miss Mondo insultata
perché lesbica. Vito Califano su Il Riformista il 20 Settembre 2021. Erika
Mattina è stata bersagliata da insulti e offese perché è rientrata tra le 25
finaliste per le selezioni di Miss Mondo. E perché è lesbica, che sarebbe poi lo
stesso motivo per il quale l’hanno offesa. “Carina, niente di che. È passata
solo perché è lesbica”, uno dei commenti sui social. “Se non fossi lesbica non
passeresti neanche le selezioni per miss Paese”. Oppure: “Oramai il ghieismo è
ovunque e vince sempre”. E ancora: “Come fa una omosessuale dichiarata a fare le
selezioni per Miss Mondo? Assurdo dove stiamo arrivando”. La finale del concorso
si terrà domenica 26 settembre. Le finaliste dovranno affrontare una serie di
prove e accumulare il punteggio più alto per vincere. Ed Erika Mattina ci sarà
nonostante gli insulti e le minacce. Tutto è cominciato quando la compagna di
Mattina, Martina Tammaro, sui social ha pubblicato un post dando praticamente la
notizia: “Non potete capire la felicità che ho provato ieri quando Erika mi ha
chiamata, con le lacrime agli occhi, e mi ha detto ‘sono passata’. Erika è
ufficialmente una delle 25 finaliste di Miss Mondo Italia. Sono 25 in tutta
Italia. Sono così fiera di lei. In una maniera indescrivibile. Complimenti amore
mio, ti amo”. Mattina, classe 1997, ha 24 anni. È nata a Brugherio, provincia di
Monza e Brianza. È laureata alla triennale in Scienze dei Servizi Giuridici a
Milano. “Non è stato facile dirlo ai miei”, ha raccontato in merito al suo
outing a 19 anni. “La cosa positiva, comunque, è che ho Martina. È con lei che
passerò il resto della mia vita. Poi più in là se ci sarà modo di far capire
alla gente che questa è una cosa normale, altrimenti amen, la vita è la mia”. Ha
fatto da figurante nella trasmissione televisiva Furore, dove ha conosciuto la
sua fidanzata, Tammaro. La coppia vive ad Arona, provincia di Novara, ha
raccontato la sua storia anche a Forum, Striscia la notizia e Dritto e rovescio.
E ha pubblicato un libro, Le perle degli omofobi, un titolo che è diventato
anche una pagina Instagram (da 119mila follower) sulla quale raccontano, anche
con leggerezza, discriminazioni e offese per il loro orientamento sessuale. E
sul quale hanno pubblicato gli screenshot con le offese e gli insulti. Mattina
ha partecipato anche al reality-show di Rai 2 La Caserma. Tammaro ha pubblicato
un altro post sui social, condiviso anche dalla pagina “Le perle degli omofobi”,
dopo le offese: “Nonostante gli insulti e le critiche insensate che stai
ricevendo in queste ore, io invece ci tengo a dirti quanto io sia fiera di te.
Eri una ragazza timida e introversa, e sei diventata una donna incredibilmente
coraggiosa e forte. Non hai paura di esporti, e lo fai sempre rimanendo fedele a
te stessa. Non rinunceresti mai ai tuoi ideali. Sei semplicemente una leonessa.
E hai raggiunto uno degli obiettivi più belli di sempre. Vorrei essere al tuo
fianco mentre vivi questi giorni da finalista, ma sai che è come se fossi
lì. Non ascoltare la gente che dice cavolate, lo sai che hanno sempre voglia di
dare aria alla bocca. Tu sai quanto vali e sai che hai e avrai sempre un sacco
di persone dalla tua parte. Facciamo tutti il tifo per te”.
Vito Califano. Giornalista. Ha
studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive
principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di
televisione e teatro.
·
Gli
Agender – “Non Binari”.
Da fanpage.it il 29 ottobre 2021. Gli Stati Uniti
hanno emesso oggi il primo passaporto con la X per indicare il terzo genere, un
passo storico per le persone che non si riconoscono nella categoria binaria
maschio o femmina, "una pietra miliare" per i diritti dei soggetti intersessuali
e non conformi al genere, come ha scritto la stampa locale. L'opzione sarà
disponibile normalmente dall'inizio del 2022, sia sui passaporti che sui
certificati di nascita degli americani all'estero. «Voglio ribadire, in
occasione dell'emissione di questo passaporto, l'impegno del dipartimento di
stato a promuovere la libertà, la dignità e l'eguaglianza di tutte le persone,
comprese quelle della comunità Lgbtqi», ha detto il portavoce Ned Pric. Il
dipartimento di Stati Usa aveva annunciato a giugno che avrebbe aggiornato le
sue procedure per consentire ai cittadini di selezionare autonomamente il
proprio "sex marker" per i passaporti e che «non sarebbe stata più necessaria la
certificazione medica» qualora il genere autoselezionato non corrispondesse al
sesso elencato sui documenti di identità ufficiali, come il certificato di
nascita. Per questioni di privacy, non è stato reso noto chi sia il destinatario
del primo nuovo passaporto. Ad accelerare il cambiamento però, come si legge
su Cnbc, è stato il caso di Dana Zzyym, residente intersessuale del Colorado,
che dal 2015 ha combattuto in un’aspra battaglia legale con le istituzioni, dopo
che le è stato negato il documento di viaggio – necessario per recarsi alla
riunione dell'Organizzazione Intersex International in Messico – per non aver
sbarrato sulla domanda né la casella "maschio", né quella "femmina". Gli Stati
Uniti si uniscono così a Canada, Australia, Nuova Zelanda e altri paesi che
hanno politiche simili sui passaporti con il genere X. La notizia della svolta
storica arriva nel giorno in cui invece in Italia il Senato ha affossato il ddl
Zan contro l’omotransfobia. Per la legge, con l’approvazione della cosiddetta
"tagliola" che ha impedito di passare all’analisi dei singoli articoli del ddl,
di fatto suona uno stop definitivo, almeno in questa legislatura.
Gianluca Veneziani
per "Libero quotidiano" il 30 settembre 2021. Scordatevi i baci romantici del
Tempo delle Mele e scordatevi l'immagine dei giovani come esperti animali
sessuali che hanno i primi rapporti nella prima adolescenza e arrivano alla
maturità già ben formati dal punto di vista erotico. La verità è che i ragazzi
oggi baciano pochissimo e ancora meno fanno sesso, sono una generazione di
kissless virgin, vergini che non hanno mai dato un bacio. È il ritratto
impietoso che viene fuori dal libro di Brando Barbieri, Kissless. Generazioni in
gabbia (Salani): l'autore, classe 1996, con grande finezza intellettuale e
capacità di analisi svolge un'indagine nel cuore di tre generazioni, quella X (i
nati trail 1965 e il 1980), quella Y (nati tra 1981 e il il 1995) e la Z (nati
tra il 1996 e il 2010), cogliendone le fragilità, le crisi, i tic, la privazione
di radici e orizzonti. E facendone emergere le mancanze erotico-affettive, la
cosiddetta «anoressia emotiva». Lo scenario che vien fuori è desolante: nelle
faccende di amore affiora uno stuolo di giovani onanisti e impotenti odi
individui impauriti che temono perfino di lasciarsi andare al primo bacio per
evitare il giudizio del potenziale partner. Eccoli allora riuniti, questi
sfigati e frustrati sessualmente, nel girone infernale dei nuovi negazionisti, i
No Kiss e i No Sex. Nella fase del primo (mancato) approccio trovi gli orbiter,
gli «orbitanti», perlopiù maschi che ruotano attorno a una donna con la quale
non hanno alcuna chance. Molti di costoro sono anche incel, involontariamente
celibi: essi non hanno rapporti sentimentali con l'altro sesso per la paura di
essere rifiutati o per il timore di andare "sotto", e cioè di diventare la parte
debole della relazione. Altri finiscono tra gli zerbini, «schiavetti o giullari»
che servono la «padrona», senza averne contraccambi erotico-sentimentali, ma
vendendo scaricati in area «friendzone», versione postmoderna del «Ti vedo più
come un amico». E questo mentre molte ragazze acquistano autorità nel vedersi
circondate di «servitori maschi» e godono nel respingerli, credendo che fare
sesso con un uomo significhi dargli troppo potere. Queste dinamiche si acuiscono
nella fase della mancata intimità fisica. Cresce, nota Barbieri, il fenomeno di
giovani che hanno paura di fare sesso per non essere giudicati per la
prestazione, per non poter controllare a pieno la situazione o perché si nutrono
dubbi sul fatto che il o la partner sia meritevole di entrare a contatto con i
propri genitali. La «paura di scopare» si traduce in un desiderio di scappare.
Cinquant' anni dopo, la rivoluzione sessuale si è rovesciata in sessuofobia.
Aumenta così in modo impressionante il numero degli «erbivori» che non hanno
alcuna attività erotica: in Giappone l'83,5% dei ventenni è vergine e in
Occidente il numero di persone tra i 20 e i 24 anni che non hanno mai fatto
sesso è raddoppiato rispetto agli anni '60. Crescono anche le coppie bianche,
relazioni d'amore trasformate in amicizie nelle quali la sessualità viene meno:
oggi in Italia le coppie bianche sono una su tre e molte di queste sono
giovani. Anche quando persiste, il desiderio sessuale trova altre forme per
esprimersi: c'è chi si accontenta del cybersex via cam o chat, un «sesso a bassa
intensità» in cui vengono utilizzati solo due sensi su cinque, vista e udito,
«2/5 di un coito». Chi non ha questa possibilità ricorre al porno, il cui
consumo cresce in modo esponenziale: nel 2019 Pornhub ha registrato 8,7 milioni
di visite in più rispetto al 2018 e l'Italia ha raggiunto il settimo posto nella
classifica dei maggiori fruitori di pornografia online. In questa dinamica a
farla da padroni sono i giovani, ridotti a «masturbatori compulsivi». Il dramma
però è che molti di costoro non riescono neppure a reggere le performance
sessuali fai-da-te: un under 40 su tre soffre di disfunzione erettile e la
percentuale di giovanissimi che fa uso di Viagra oggi tocca punte del 35%,
laddove era del 2% nel 2002. Tutto questo si somma a vite che oscillano tra la
Noia e l'Ansia, caratterizzate dall'aumento del consumo di psicofarmaci e dei
casi di depressione e suicidi. E in cui, anche per il venir meno di Dio, patria
e ideologie, i giovani si sentono privati di un’origine e un destino. «Il
terreno è arido», riflette Barbieri, «perché, dopo aver estirpato piante vecchie
e malate, non è stato piantato niente che avesse radici abbastanza forti».
Questa ricerca insoddisfatta di senso si risolve spesso in una sterile caccia al
consenso (social). Ma è solo un palliativo per lenire le dilaganti solitudini
esistenziali. Resta infatti inevasa la domanda di pienezza che può trovare
risposta solo in una persona amata, in «quei capelli, quelle forme, quel
profumo, quell'ammasso di cellule che il cervello ha identificato
indissolubilmente con la parola 'felicità'». E invece oggi il Bacio è diventato
un apostrofo grigio tra le parole Ho Paura.
Dagotraduzione dal DailyMail il 6 maggio 2021. Una
modella britannico-australiana è diventata la prima star agender a posare per la
copertina di Elle Uk. «Dopo aver disprezzato per anni il corpo in cui sono nata,
incapace di relazionarmi con il genere che mi è stato assegnato alla nascita, ho
finalmente trovato un modo di esistere che per me ha senso. «Non mi sono mai
sentita una femmina, ma neanche un maschio. Se ci fosse una linea sottile a
collegare i due sessi, sarei un punto che fluttua da qualche parte tra gli
estremi, ma non per forza legata ad essa. È l'unico modo in cui posso descrivere
come mi sento». «Non avevo mai davvero avuto la possibilità di considerare che
il genere potesse essere qualcosa che potevo controllare se lo volevo». «Una
volta che mi sono trasferita in città, tutto è cambiato. La mia mente si è
aperta ed è stata inondata di luce: c'era questa comunità queer, non avevo idea
che esistesse». Eley, che è cresciuta in Australia, ha anche spiegato perché ha
scelto di non avere una mastectomia ma di legarsi il petto. «Ci sono
innumerevoli interventi chirurgici a cui alcune persone trans scelgono di
sottoporsi per sentirsi più a loro agio; ma io mi sento così scollegata da
qualsiasi genere che nessun corpo sarà mai perfetto», ha ammesso. «Preferivo
avere la possibilità di legarmi il petto, ma le dimensioni del mio torace non mi
permettevano di farlo in modo efficace. Per questo ho deciso per una riduzione,
in modo da avere il controllo del mio aspetto. Adesso comprimo il petto non
perché mi vergogno del mio corpo ma perché poterlo fare mi fa sentire al
sicuro». «Ho accettato di essere una persona non binaria che vive in un mondo
binario che vorrei interrompere», ha aggiunto.
Da open.online il 21 maggio
2021. La cantante Demi Lovato ha annunciato sul suo profilo Twitter di essere
“non binaria” e che da oggi il pronome con cui vuole essere riconosciuta sarà
“they”, che nella traduzione italiana non sta per “loro”, ma si riferisce al
“they singolare” presente nella lingua inglese. Lovato ha detto quindi di non
sentirsi né donna, e né uomo. «Demi Lovato vuole le sia dato del loro, come il
Mago Otelma», ha commentato ironicamente su Twitter la comica Michela Giraud,
tra gli ospiti anche della prima stagione di LOL. Una battuta che però ha
portato a un fiume di polemiche. La comica ha deciso quindi di rimuovere il
tweet dopo le molte critiche ricevute. «Mai mi sarebbe passato per la mente di
doverlo fare ma cancello il tweet, a maggior ragione del fatto che è in uscita
un film che affronta le tematiche LGBTQ sul quale mi è stato dato un testo che
evidentemente devo ancora studiare. Invito alla calma e stare sereni», ha
scritto in un tweet di risposta successivo. Il film cui fa riferimento la comica
romana è Maschile Singolare, in uscita su Amazon Prime il prossimo 4 giugno.
Nella pellicola si racconterà la storia di un amore omosessuale. «Chiaramente è
una lezione per la vita, e non per il film in uscita. La lezione è studiare e
aprire gli allegati che spiegano il mondo Lgbtq perché se ti dicono di studiarlo
martedì deve essere studiato martedì, e non giovedì, che potrebbe essere troppo
tardi», ha chiosato Giraud.
Da open.online il 21 maggio
2021. Il comico Saverio Raimondo solidarizza su Twitter con la collega Michela
Giraud, costretta dalle critiche a cancellare una battuta sulla cantante Demi
Lovato, che ha annunciato di essere «non binaria» e di voler essere chiamata con
il pronome they, che è traducibile in italiano come loro, pur riferendosi al
they singolare presente nella lingua inglese. Proprio dal pronome è partito
Raimondo, che si è lanciato in una citazione cinematografica. Il tweet non è
sfuggito a Giraud, che d’altra parte è stata esplicitamente menzionata da
Raimondo. E la comica, apprezzando la solidarietà, ha risposto con un cuoricino.
Sul caso è intervenuto anche il fidanzato di Michela Giraud, Riccardo
Cotumaccio, di professione speaker radiofonico, che ha twittato: «L’era della
suscettibilità che costringe attori e comici a dover spiegare una battuta – che
resta tale – come fosse un manuale di storia contemporanea o un corso di
educazione civica. Anni complessi che domani valuteremo meglio, con il dito meno
puntato e qualche neurone in più».
Gianluca Veneziani per “Libero
quotidiano” il 21 maggio 2021. Gentilissim* , come diavolo potremo chiamarVi, o
meglio chiamare Loro, adesso che Voi, cioè Loro, hanno rifiutato i pronomi di
Lui e Lei e si sono dichiarat* di genere non binario, oltre le identità ormai
desuete di maschi* e femmin*? È doveroso chiederselo (anche se si fa una fatica
immensa a scriverlo) dopo che una serie di vip, o presunti tali, hanno fatto
coming out, ammettendo di non sentirsi né uomini né donne. Cosa che, in tempi di
fluidità di genere, non sarebbe neppure una notizia, se non fosse che essi hanno
anche rivendicato il diritto a non essere più considerati una singolarità,
quanto una molteplicità concentrata in uno stesso Io. Ragion per cui, al fine di
indicare ciascuno di questi vip "fluidi", bisognerà ricorrere al pronome inglese
They, cioè Loro, anziché He o She, e quindi Lui o Lei. La follia politicamente
corretta ha Loro in bocca. A portare avanti questa ennesima crociata della
demenza culturale e linguistica sono alcuni personaggi anglosassoni del mondo
dello spettacolo, gente nota ma non troppo che evidentemente cerca ulteriore
visibilità anche così. Il premio per l' idiozia dell' anno va alla cantautrice
statunitense Demi Lovato che in questi giorni sui social ha annunciato
fieramente «Sono una persona non binaria. Chiedo che sia usato il pronome "loro"
di qui in avanti». Poco prima di lei sul tema si era espresso l' artista
britannico Kae Tempest, vincitore del Leone d' Argento della Biennale Teatro,
che aveva «affermato con fierezza la propria identità plurale, chiedendo l' uso
del pronome they/them, "loro"», come si poteva leggere su ll Venerdì di
Repubblica. L' aspetto paradossale è che, e lo faceva notare lo stesso
settimanale, il pronome "loro" non può che essere tradotto in italiano con il
molto più familiare "voi". Cosicché, di fatto, per definire questi artisti
fluidi e non-binari, nuove icone del mondo Lgbt, si finisce per ricorrere al
"voi" fascista. A Voi! Cioè, a Loro! Chissà se ne è consapevole anche Elliot
Page, al secolo Ellen, attrice già interprete del film anti-abortista Juno, e
poi divenuta emblema della transizione sessuale, senza mai essere approdata a
un' identità certa, neppure a livello di pronomi, al punto da aver comunicato
qualche mese fa: «Voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono
lui/loro e il mio nome è Elliot». Persone che si sentono molteplici, che credono
di poter vivere più vite in una, di superare il limite dell' Io, contenendo e
coltivando moltitudini. È il sogno mitico di Proteo, dell' Infinito cangiante,
della perpetua mutazione e moltiplicazione, oltre ogni identità fissa. Ma, a ben
vedere, questa pluralità corrisponde a un' espropriazione, non a un
arricchimento ma a un annullamento del Sé. Sei Loro, ma non sei più Io. Il
delirio di onnipotenza della multi-identità si traduce in un annichilimento. Non
sei più Uno, e neppure Centomila. Finisci per essere solo Nessuno. E questo
anonimato, questa perdita del nome e del pronome, è evidente anche nel mancato
uso delle desinenze per definirli. Al posto delle vocali a/o, anch' esse
giudicate discriminatorie perché imprigionerebbero la loro persona in una
sessualità binaria, o maschile o femminile, si ricorre in Italia (ma non solo,
anche in Germania) agli asterischi. E così si partoriscono mostri linguistici,
di raro e involontario effetto comico, come quelli che si possono leggere nell'
intervista a Kae Tempest: «Vi sentite più seren* oggi?». «Mi sento più onest*
verso il mondo, verso me stess*». Le star ridotte ad asterischi. Abbiamo perso
la vocale, oltre alla testa.
·
Il DDL Zan: la storia di una Ipocrisia. Cioè: “una presa per il
culo”.
ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE.
Da “Libero Quotidiano” il 10
novembre 2021. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha istituito la figura
dell'inviato speciale del ministero degli Affari esteri per i diritti umani
delle persone Lgbtiq+. A svolgere questo ruolo sarà il diplomatico Fabrizio
Petri, attuale presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani
(Cidu), designato oggi dal segretario generale della Farnesina, ambasciatore
Ettore Francesco Sequi. Petri sarà chiamato a coordinare l'azione della
Farnesina per la tutela e promozione dei diritti delle persone Lgbtiq+,
favorendo la più ampia decriminalizzazione dell'omosessualità nel mondo.
Michela Bompani per “Il
Venerdì di Repubblica” il 16 novembre 2021. A destra l'ha chiamato un "Ddl Zan
mascherato" che punta a introdurre, nuovamente, il concetto di "identità di
genere". Così a Palazzo Madama, il 4 novembre, il dl Infrastrutture, Trasporti e
Mobilità ha scatenato la bagarre. Tanto che il governo ha dovuto mettere la
fiducia, intascando un risultato tondo: 190 sì e 34 no. Le polemiche che ne sono
seguite hanno però "nascosto" il varo di un provvedimento importante: quello che
vieta i manifesti sessisti, discriminatori e violenti lungo le strade o negli
spazi pubblicitari sui mezzi pubblici. Ed è solo l'inizio, perché si sta
preparando un testo analogo, per vincolare i contenuti audio-televisivi,
intervenendo sulla Legge Gasparri. Si attendeva da tempo una norma che facesse
argine ai messaggi promozionali che sfruttano il corpo delle donne. A rimediare
ci hanno pensato la presidente della Commissione Trasporti alla Camera,
Raffaella Paita, Iv, e quella della Commissione Ambiente alla Camera, Alessia
Rotta, Pd, che hanno proposto un emendamento ad hoc. «Troppo spesso le
pubblicità utilizzano messaggi che mortificano le donne o sono discriminatori»
dice Rotta. «È il momento di dire basta e di promuovere una cultura del rispetto
di tutti gli individui». Nella sezione che modifica il Codice della Strada,
infatti, si introduce «il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, su strade e
veicoli, avente contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei
diritti civili, del credo religioso e dell'appartenenza etnica ovvero
discriminatorio». Per chi sgarra sono previste la revoca dell'autorizzazione
della pubblicità e la rimozione. «Abbiamo introdotto un vincolo normativo a
tutta la categoria della cartellonistica fissa e mobile» spiega Paita. «È stata
definita anche la responsabilità di chi gestisce gli spazi stradali: la
Provincia, il Comune, il concessionario autostradale o Rfi». Da oggi, quindi, i
Comuni possono contare su una norma nazionale e non più su singoli provvedimenti
autonomi, spesso vanificati da ricorsi vari. Per l'entrata in vigore del divieto
di pubblicità sessiste servirà un decreto attuativo del governo. Lo sta
preparando, per vararlo entro dicembre, la ministra delle Pari Opportunità,
Elena Bonetti.
Daniele Priori, Segretario
nazionale GayLib, per “Libero Quotidiano” il 10 novembre 2021. Gay e
missionario. Il M5S che ha in testa Vincenzo Spadafora, già sottosegretario alle
Pari Opportunità nel governo pentaleghista e poi ministro dello Sport
nell'esecutivo pentapiddino, sposa con spirito critico e una dialettica intensa
il «campo progressista» nel quale lui in persona e a mezzo stampa (anzi libro
più tv) si lancia e autopromuove con coraggio e entusiasmo come profeta del
politicamente corretto, indiscusso e a tutti i costi. Lo fa attraverso le pagine
della sua nuovissima fatica letteraria: Senza riserve, appena edito da
Solferino. Come cassa di risonanza non casuale sceglie uno dei templi televisivi
del politically correct: la messa laica domenicale di Fabio Fazio su Rai 3. Un
campo nel quale, sulle orme di altre celebri profetesse - dalla Boldrini alla
Boschi - essere, ovvero identificarsi (meglio se in una minoranza), vale
decisamente come valore aggiunto, a tal punto da poter mettere tra parentesi
anche le capacità o le conoscenze. In fondo fu proprio Spadafora, lasciando
l'incarico ministeriale, a dichiarare di aver conosciuto davvero l'ambito e le
dinamiche sportive solo facendo il viceministro, tornando poi ripetutamente pure
a spiegare il senso di tale affermazione, a suo dire giustificativa di una
pretesa terzietà, tesa a favorire di fatto l'autonomia di pensiero del ministro
stesso. (Sic!) Oggi, però, il vento dev'essere evidentemente cambiato e, in
barba alla terzietà, la missione "omosessualista" la capisce, la racconta e la
usa in prima persona come arma di scontro politico, proprio perché lui per primo
la vive dal di dentro. Commozione e applausi. In questo caso, dunque, tertium
non datur. Perché il brusio alle spalle di un omosessuale velato o anche solo
mezzo dichiarato, peggio se pure parlamentare, a un certo punto diventa
insopportabile. E poco importa, dunque, se il ddl Zan è stato affossato proprio
in quello stesso campo progressista-buonista-politically correct. L'icona da
seguire in materia di diritti (più editoriali che civili) è proprio il relatore
del testo di legge contro l'omotransfobia, Alessandro Zan, che ha scelto di
affiancare, anche lui, alla sua battaglia politica pure una bella tournée di
presentazioni in libreria tendenzialmente autobiografiche. Missionari loro. Gay
impegnati che, legittimamente, si preparano ormai a una prossima rielezione...
ovviamente in quota gay. Zan nel Pd che lo rende suo malgrado martire. Spadafora
nel M5S, gruppo che nel 2016, animato dal sacro fuoco del purismo pro adozioni
gay, non votò il testo finale della legge Cirinnà sulle unioni civili,
portatrici, quelle sì, di diritti civili veri a tante coppie omo-normali, anche
non famose. Roba da far rimpiangere il primogenito gay grillino per eccellenza,
l'ex gieffino Rocco Casalino che almeno il suo coming out l'ha fatto, ma almeno
senza la coperta di Linus dell'impegno politico-frocio-progressista. Di Rocco
semmai divennero ben più famose le video-gaffe grossolane sugli afrori tre volte
diversi degli omosessuali «poveri e rumeni dal profumo agrodolce». E chissà
quanto è casuale, allora, anche il fatto che, a finire nel mirino finto-buonista
di Spadafora, c'è proprio la comunicazione del M5S, il cui vate, fino a prova
contraria, nell'era pre-Draghi è stato proprio Casalino. La guerra nel M5S si fa
cupa e anche gli arcobaleni, a fronte del loro altro ruolo pacifista, diventano
armi contundenti. E mentre al povero Giggino Di Maio è toccato difendersi,
ospite di Lilli Gruber, dall'accusa di dichiarata eterosessualità, al nuovo
leader M5S, Giuseppe Conte, non resterà che chiamare a raccolta le sue fan più
indefesse: le famose bimbe di Conte, possibilmente armate di borsette aguzze da
utilizzare in difesa della virilità del maschio grillino eterosessuale, non più
così di moda da quelle parti.
Mentalità e leggi. I
diritti Lgbtq in Italia dal delitto di Giarre a oggi (passando per il ddl Zan).
Linkiesta
il 13 novembre 2021. Sul palco de Linkiesta Festival si confrontano Francesco
Lepore, autore de “Il delitto di Giarre” (Rizzoli) e il deputato e
sottosegretario Ivan Scalfarotto, moderati da Simonetta Sciandivasci. Dal 1980 a
oggi, dal delitto di Giarre fino al ddl Zan. Il percorso dei diritti Lgbtq e la
lotta per rivendicarli è stato lungo, accidentato e – va detto – imperfetto. Ma
qualcosa è avvenuto, anche se ancora molto è da fare. L’importante è capire la
prospettiva – e la strategia – migliore da adottare. Ne hanno parlato dal palco
di Linkiesta Festival il giornalista Francesco Lepore, autore del libro “Il
delitto di Giarre” (Rizzoli) e l’onorevole Ivan Scalfarotto, moderati dalla
giornalista Simonetta Sciandivasci. Tutto comincia dall’inizio, cioè dal caso
dell’uccisione di Toni e Giorgio. I due ragazzini gay trovati assassinati – è il
1980 – nella provincia di Palermo. È una storia importante perché, per la prima
volta, viene trattata dalla stampa «non come un episodio sordido di ambienti
loschi, ma come un delitto omofobo». In reazione al caso viene fondato Arcigay a
Palermo e comincia la stagione delle battaglie per i diritti degli omosessuali.
È un momento fondante, insomma. «Il libro nasce da un articolo che ho scritto su
Linkiesta», spiega Lepore. «Per scriverlo ho compulsato i documenti e gli
articoli del tempo», ma è anche andato sui luoghi, ha sentito i parenti e le
persone coinvolte nella storia. «La versione ufficiale fu quella di un omicidio
compiuto da un infraquattordicenne, il cuginetto di uno dei due fidanzatini, che
li avrebbe uccisi su loro richiesta perché non riuscivano a sostenere la loro
condizione». La realtà è diversa: «Dopo molta fatica, la sorella di Toni mi ha
spiegato che i veri assassini erano dei familiari. Ora morti. Per cui si può
dire che si era trattato di un delitto d’onore, fatto per lavare l’onta» di una
cosa vergognosa. Il fascicolo del processo è andato perduto, e «le indagini
erano durate soltanto tre giorni». Insomma, «Lotta Continua aveva scritto che
“Toni e Giorgio” erano rimasti senza giustizia. Io spero di aver reso loro
giustizia». Il pensiero non può non andare – e viene portato da Simonetta
Sciandivasci – al presente e al recente fallimento della ddl Zan. Sul tema c’è
Scalfarotto, finito nel mirino delle contestazioni perché Italia Viva viene
considerata, a torto o a ragione, tra i responsabili del naufragio della legge.
«Una delle cose più interessanti del libro di Lepore – spiega Scalfarotto – è
l’affresco di un’Italia e di una Sicilia che, per fortuna, non è più quella
attuale. Il Paese in 40 non è più lo stesso. È diventato più corretto, più
educato. Io ho un marito e lo posso presentare ai commensali di una cena, senza
problemi. Nel 1975 il nuovo diritto di famiglia stabilisce la parità tra i
coniugi, avendo rivoluzionato secoli di idee e abitudini». Tutto questo,
sottolinea «è il frutto dell’approccio del riformismo. Dei piccoli passi verso
l’obiettivo. Ti carichi il peso di un cambiamento, accettando leggi imperfette,
in vista di un miglioramento progressivo continuo». Non viene fatta la
rivoluzione (servirebbe?) ma viene migliorata la società per tutti. Il principio
è quello del compromesso. «Voi rinuncereste a una legge solo perché è
imperfetta? Io mai». Sul punto specifico del ddl Zan: «Italia Viva non ha
cambiato idea», dice Scalfarotto. Ma non si può ragionare solo sui principi,
serve farlo anche sulla strategia. «I numeri alla Camera e al Senato sono
diversi. Servono tattiche diverse». La legge era andata avanti in Commissione
solo grazie a un voto. Viene portata in aula con una forzatura, le destre
chiedono di riportarla in Commissione e la proposta non passa – a voto palese –
solo per un voto. «Questo vuol dire che a scrutinio segreto va sotto di 40, è
una cosa che sa chiunque sia stato anche solo una settimana in Parlamento».
Scegliere di farlo, insomma, è una scelta suicida «che rivela non la volontà di
far passare una legge, ma di cercare una battaglia». Un’operazione «cinica,
fatta da chi aveva un pelo sullo stomaco che ci si possono fare le trecce»,
spiega Scalfarotto. «I militanti Lgbt fanno benissimo ad avere l’asticella alta,
e mi aiutano per rappresentarli nelle battaglie che faccio da parlamentare». Ma
quando serve un compromesso, occorre avere spazio di manovra. Altrimenti non fai
il parlamentare ma fai il militante: «Il problema è che chi ha gestito questa
legge ha fatto militanza. Monica Cirinnà lo ha detto: “andremo in aula a cercare
la bella morte”». Resta il fatto che le leggi sono una cosa, la realtà un’altra,
e l’orizzonte della politica un’altra ancora. «È vero che non siamo più nel
1980», concede Lepore, «ma la mentalità stereotipica, violenta contro gli
omosessuali (e non solo) c’è ancora. I casi continuano a essere riportati, sono
in aumento. Nel caso specifico del delitto di Giarre, le famiglie continuano a
parlarne come se i ragazzi non fossero omosessuali. Il parroco del paese, che
voleva fare un funerale congiunto – cosa che venne rifiutata perché i familiari
non erano d’accordo – è lo stesso che sosteneva che, in fondo, i gay cercano
comunque di adescare gli altri. Questa convinzione la si ritrova, anche oggi, in
ambienti di destra che pensano di poter “rieducare” i gay, di guarirli. La
mentalità c’è ancora». Sul caso Zan «tutti hanno avuto colpe». Ma per Lepore
l’accusa più ingiusta e fastidiosa l’accusa che fosse una legge che non
estendeva diritti, ma stabilva pene. «A parte l’infelice articolo iniziale
definitorio», c’era solo un articolo penale. Tutti gli altri, anche piccoli,
erano diritti. Qui si arriva insomma al punto, come lo riprende Sciandivasci: le
leggi hanno importanza sul piano culturale? Lei stessa ha ammesso di aver
cambiato idea sul tema del femminicidio, definizione che all’inizio le appariva
superflua e pretestuosa (perché distinguere l’uccisione di una donna rispetto a
quella di un uomo?). Dietro alla legge c’è un pensiero, la volontà di cambiare
mentalità. Vale anche per il ddl Zan. «Io penso che sia importante fare coming
out. In Parlamento sono raddoppiati i gay dichiarati: da 3 a 5», ricorda con
sarcasmo. Che mi risulti io sono l’unico a essere entrato al governo già da gay
dichiarato». Ma la lotta per i diritti passa anche per i provvedimenti che
aiutino le persone, per i modelli d chi è più o meno svantaggiato (come ha fatto
Spadafora), non solo per le leggi. I temi sono tanti: non può non toccare il
tema del femminismo (classico vs intersezionale), una divisione che è nata
discutendo proprio sul ddl Zan e la possibilità di autodefinire la propria
sessualità, né si omette la questione dei transessuali. Si fa il punto dello
stato dei diritti in Italia, insomma, e se ne discutono le direzioni. A 40 anni
dal delitto di Giarre qualcosa è cambiato, molti passi sono stati fatti, tanti
altri servono ancora. La battaglia continua, insomma. E il libro di Lepore
(andrà nelle scuole?) è uno dei tanti passaggi di questa storia.
Flavia Amabile per "La Stampa"
il 5 novembre 2021. Identità di genere. Sono tre semplici parole ma hanno il
potere di creare tempeste. La destra le detesta. Se potessero i cattolici più
conservatori e i movimenti per la vita le cancellerebbero da ogni documento
ufficiale. Con loro enorme sconcerto sono riapparse in un provvedimento
diventato legge. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha approvato in via
definitiva il decreto Infrastrutture e Trasporti nonostante Lega, Fratelli
d'Italia e le associazioni per la vita da giorni stessero provando a attirare
l'attenzione su un punto del provvedimento, dal loro punto di vista una
pericolosa minaccia. È il comma 4 bis dell'articolo 1 introdotto con un
emendamento approvato alla Camera, che stabilisce il divieto con affissione
sulle strade ma anche su mezzi pubblici o su mezzi privati di pubblicità che
abbiano contenuti con «messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere
offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti
civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure
discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere
o alle abilità fisiche e psichiche». Sono lì le tre discusse parole che la
destra non tollera, in un emendamento firmato dalle deputate Raffaella Paita di
Italia Viva e Alessia Rotta del Pd, approvato dalla Camera senza alcun problema
e poi in Senato con un voto di fiducia. Un paradosso se si pensa che una
settimana fa Italia Viva e Pd si sono divise in Senato sul ddl Zan e
sull'identità di genere contenuta nel provvedimento, come non mancano di far
notare da destra. «Come è possibile - chiede Lucio Malan, senatore di Fratelli
d'Italia - che in un decreto riguardante gli investimenti e la sicurezza delle
infrastrutture, trasporti e circolazione stradale, sia stata inserita una norma
ideologica, volta a limitare la libertà di espressione, con il pretesto che
l'esercizio di questa libertà non può avvenire sulle strade e sui veicoli? Una
cosa assolutamente inaccettabile, introdotta di soppiatto». «Sarà ancora
possibile affermare in una pubblicità che i bambini sono maschi è le bambine
sono femmine? Che un bambino nasce da una mamma e un papà?», chiede Antonio
Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia. «L'identità di genere non è entrata
con il cavallo di Troia del ddl Zan e ora surrettiziamente il Governo ci riprova
inserendola in questa norma sotto la foglia di fico, come al solito, delle
discriminazioni» aggiunge Jacopo Coghe, vicepresidente della Onlus. Polemiche a
cui Raffella Paita risponde con decisione. «L'emendamento è il frutto di un
lungo lavoro trasversale che permette di dare un valore sociale a questi temi»,
spiega. E accetta solo in parte il riferimento al ddl Zan. «In quel caso
l'identità di genere era declinata in varie forme al contrario di quanto accade
nel nostro emendamento. Aver proposto e fatto approvare la modifica però è la
dimostrazione che la forza politica che esprimo cerca di dare una mano sul tema
dei diritti civili e che le battaglie in solitudine frenano il progresso.
Bisogna lavorare con una logica di tessitura per aiutare chi subisce
discriminazioni».
L'ideologia di pochi sull'omofobia.
Karen Rubin il 31 Ottobre 2021 su Il Giornale. La
sconfitta sul disegno di legge Zan dovrebbe insegnare alla sinistra non soltanto
la necessità di un confronto tra i suoi parlamentari ma soprattutto quello con
la realtà culturale degli italiani che vorrebbe rappresentare. La sconfitta sul
disegno di legge Zan dovrebbe insegnare alla sinistra non soltanto la necessità
di un confronto tra i suoi parlamentari ma soprattutto quello con la realtà
culturale degli italiani che vorrebbe rappresentare. Il relatore e i suoi
supporter hanno sostenuto si trattasse di una legge a tutela delle persone che
subiscono discriminazione omotransfobica, accusando i detrattori di essere
contrari alla difesa di omosessuali e transessuali. Pensavano che agli avversari
sarebbe sfuggita la portata dei significati contenuti nell'articolo 1 che
definisce l'identità di genere come l'identificazione percepita e manifestata di
sé, anche se non corrispondente al sesso biologico. La disputa in corso riguarda
l'eliminazione o la conservazione di un modello binario, culturalmente diffuso,
che prevede l'associazione tra sesso anatomico e identità sessuale. Finanche una
parte della stessa sinistra non ha visto civilizzazione ma caos nella spinta
alla liquidità sessuale verso cui vorrebbe andare, anche attraverso Zan.
Normalizzare la possibilità di vivere in società nei panni del sesso opposto
perché ci si percepisce soggettivamente così, senza una diagnosi di disforia di
genere e un supporto medico e psicologico crea confusione identitaria e
favorisce l'instabilità delle persone, soprattutto degli adolescenti che ancora
sono alla ricerca della loro identità. Con il disegno Zan la sinistra ha fatto
lo stesso tentativo già provato con la legge sulle unioni civili, che
comprendendo la stepchild adoption, poi stralciata, apriva le porte all'utero in
affitto, nel nostro paese illegale. Se avessero stralciato l'articolo 1 con
molta probabilità la legge Zan sarebbe stata approvata e invece prepotentemente
e in contraddizione con i valori ancora prevalenti nella società voleva imporre
una visione di un gruppo sparuto di potere, che questo potere si è dimostrato
non possedere. La legge deve ispirarsi all'insieme di valori, tradizioni e
costumi di una società, ai suoi modelli etici e alle regole di comportamento
caratteristiche dei luoghi in cui si legifera. Quando gli italiani hanno voluto
le leggi sul divorzio e sull'aborto le hanno ottenute nonostante i veti
religiosi ma ora a quanti di loro alletta l'idea di eliminare i simbolici madre
e padre per trasformarli in genitori asessuati da chiamare uno e due? Quanti
sono ad approvare l'utero in affitto per creare in laboratorio un bambino da
vendere al miglior offerente anche se sarà un uomo che lo priverà della madre?
Le leggi che riguardano gli archetipi dell'umanità devono tener conto di strati
ampi di popolazione e non delle ideologie di pochi usate strumentalmente a scopi
elettorali. Karen Rubin
Gli
omofobi Rossi.
Fausto
Carioti per "Libero quotidiano" l'1 novembre 2021. L'odio di Fidel Castro per
gli omosessuali è cosa nota. Lui stesso ammise le proprie colpe nel 2010, quando
era troppo tardi e mille testimonianze lo avevano già condannato. Tra queste c'è
il libro di Felix Luis Viera, Il lavoro vi farà uomini, che racconta la vita
nelle Umap, i gulag cubani nei quali, a decine di migliaia, maricones ed
effeminati sono passati assieme a dissidenti, seminaristi cattolici e altre
«piaghe sociali» non tollerate dal regime. Soprattutto, c'è il racconto che
Valerio Riva, lì presente, ha fatto della conversazione che il compagno Fidel
ebbe a Cuba nel marzo del 1965 con Giangiacomo Feltrinelli. Una sera, a cena,
l'editore gli chiese perché perseguitasse gli omosessuali. Tra i commensali calò
il gelo. Castro, racconta Riva, «disse qualcosa come "è un bello sfacciato
questo Giangiacomo!", accese un sigaro e prese lentamente a dire che all'origine
c'erano stati problemi in certe scuole, che dei genitori avevano protestato, che
in fondo bisognava capirli, l'idea di mandare un figlio a scuola e vederselo
tornare frocio non garberà a nessuno. Disse che lui non aveva proprio niente
personalmente contro gli omosessuali, purché non pretendessero di far proseliti.
Se gli tirava il culo, problemi loro... Lo Stato, la Rivoluzione non poteva
certo permettere la corruzione di minorenni...». C'è però un'altra vicenda,
molto meno conosciuta, che ha per protagonisti Pier Paolo Pasolini, Alberto
Moravia e Dacia Maraini. È emersa solo di recente, grazie a Paragone, raffinata
rivista fiorentina di arte e letteratura fondata da Roberto Longhi. È la "vera"
storia del viaggio di Moravia a Cuba. O comunque "un'altra" storia, diversa che
da quella che si sapeva.
LA VERSIONE UFFICIALE...
Sinora, c'è stata solo la versione di Moravia. Ad Alain Elkann che lo
intervistava (Vita di Moravia, 1990), la raccontò così: «Fui invitato a Cuba nel
1966 alla Conferenza tricontinentale e ci andai con Dacia Maraini. La conferenza
si occupava principalmente, almeno per quanto mi sembrò di capire, di questioni
politico-militari. Era cioè una conferenza che lasciava indovinare nelle grandi
linee quello che sarebbe stato l'intervento armato di Cuba in tante parti del
mondo del futuro». Lui e la Maraini ebbero due incontri con Castro, uno pubblico
e uno privato, «brevissimo». Quanto basta perché Moravia s' invaghisse del
dittatore, «un ottimo oratore, pieno di calma e ragionevole autorità». «Come con
Arafat e con Tito», rivelò a Elkann, «ho avuto simpatia per lui, perché ho
sentito in lui l'uomo d'azione. Anzi, in quel momento lui rappresentava l'uomo
d'azione per eccellenza, in quanto la rivoluzione culturale capovolgeva la
credenza "veteromarxista" che il pensiero deve precedere l'azione. (...) Il fare
cambia il mondo. La parola, se non diventa a sua volta fatto, non cambia nulla».
Non una parola né un fatto, però, vennero da Moravia sugli aspetti più infami di
Castro e della sua dittatura. Eppure, l'autore de Gli indifferenti questi
aspetti li conosceva molto bene. Perché pochi giorni prima, a pagarne il prezzo,
era stato il suo amico Pasolini. Il «pervertito» Pasolini. È qui che le pagine
di Paragone scritte da Francesco Rognoni gettano una luce diversa su Moravia e
sul suo resoconto di quei giorni all'Avana. La rivista pubblica un assaggio del
carteggio che lo scrittore "irregolare" Nicola Chiaromonte, socialista
libertario, ebbe con la scrittrice statunitense Mary McCarthy, alla quale era
legato. Chiaromonte era molto amico di Moravia e della Maraini, e in una lettera
che inviò alla McCarthy nel febbraio del 1966 le riporta questo aneddoto,
stranamente sfuggito a tutti i biografi: «Ti racconto una storia divertente.
Quella del viaggio di Moravia a Cuba. A dicembre, Moravia voleva farsi una
vacanza con Dacia in Marocco. E dato che, per ragioni sue, sembra non sia capace
di viaggiare senza Pasolini, gli ha chiesto di unirsi a loro. Pasolini ha detto
che no, lui andava a Cuba. A Moravia l'idea di Cuba non piaceva per niente:
voleva solo farsi una vacanza, e andare a Cuba era un gesto politico, dato che
non ci si può andare se non in qualità di ospiti del Governo innanzitutto.
Quindi ha provato a far ragionare Pasolini. Niente da fare. O Cuba o niente.
Moravia, che è un bravo ragazzo, alla fine si è arreso ed è andato
all'ambasciata di Cuba a chiedere il visto. Che, naturalmente, gli hanno servito
su un piatto d'argento. Così si è preparato al viaggio. Ma da parte di Pasolini,
silenzio. Alla fine Moravia l'ha chiamato per chiedergli se era pronto anche
lui. Pasolini ha detto "No", gli avevano negato il visto perché notoriamente
omosessuale: a Cuba l'omosessualità è un reato penale. Moravia si è arrabbiato
doppiamente, è tornato all'ambasciata cubana a protestare, a chieder anche lui
il visto per Pasolini ("Dopo tutto, è un grande scrittore, eccetera..."). Niente
da fare. Impossibile lasciar entrare a Cuba un notorio pervertito. E così
Moravia è andato a Cuba (dove mi si dice che il 15% della popolazione sia
omosessuale, a cominciare da Castro) solo con Dacia. Dove è stato accolto
benissimo, e oltretutto non ha dovuto spendere un centesimo. Ma Pasolini è
rimasto a Roma (o forse è andato in Marocco, non so)». ...
E L'ALTRA Secondo la versione
di Chiaromonte, dunque, Moravia non era stato «invitato» dal regime ad assistere
alla Conferenza tricontinentale, che si era tenuta all'Avana dal 3 al 16 gennaio
del 1966. L'idea di andare sull'isola era stata di Pasolini, e Moravia aveva
chiesto il visto con l'intento, meravigliosamente borghese, di farsi una vacanza
al sole dei Caraibi assieme alla Maraini. Ma il poeta e regista bolognese era
stato umiliato dal governo di Castro, che gli aveva negato l'accesso in quanto
«pervertito». E quando Moravia capì che le proteste con l'ambasciata cubana non
avrebbero rimosso quel veto vergognoso, anziché denunciare la vicenda (per
difendere almeno il suo amico, se non l'intera categoria degli omosessuali), o
comunque cambiare meta sdegnato, lui, il più influente degli intellettuali
italiani, scelse il silenzio e l'aereo che lo portò all'Avana. Dove, assieme
alla sua compagna, fu accolto con tutti gli onori e non dovette «spendere un
centesimo», ospite di Castro. E da dove tornò colmo di pensieri buoni per il
líder máximo. Del tutto indifferente- è il caso di dirlo- al modo in cui costui
aveva trattato il povero Pasolini e calpestava i diritti dei «pervertiti». E un
giorno, chissà, magari sapremo pure se le voci sull'omosessualità nascosta del
macho Castro, riferite dal serissimo Chiaromonte («Austero cavaliere», lo
chiamava la McCarthy), fossero calunnie o verità.
DDL ZAN: MARCUCCI, BENE
PRODI, ANCH'IO NON VOLEVO INCIDENTE.
(ANSA l'1 novembre 2021) -
"Condivido in pieno le parole che ha usato ieri sera Romano Prodi da Fabio Fazio
sul ddl Zan. È esattamente la mia posizione, io volevo in tutti i modi la legge
e volevo evitare l'incidente". Lo afferma il senatore del Pd, Andrea Marcucci.
LA STRIGLIATA DI PRODI A
LETTA: «IL DDL ZAN? SI POTEVA SALVARE: HANNO CERCATO L’INCIDENTE».
Giovanni Ruggiero
per open.online l'1 novembre 2021. Tra i responsabili dell’affossamento del Ddl
Zan secondo Romano Prodi c’è anche il Pd di Enrico Letta. Perché spiega l’ex
premier sarebbe stato: «molto facile fare piccole modifiche, anche verbali – ha
detto ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa – ma si è voluto strumentalizzare
il tutto». Dal fondatore dell’Ulivo a cui lo stesso Letta dice di ispirarsi
arriva insomma una ferma bocciatura su come la trattativa sia stata gestita, con
il Pd fino all’ultimo irremovibile su ogni tipo di modifica, e infine la
famigerata «tagliola» finita con l’affossamento appunto dopo il voto segreto:
«Se uno vuole riformare quei piccoli aspetti della legge su cui si discuteva,
bisognava andare caso per caso – ha detto Prodi – e si trova l’accordo». Una
volontà che lui stesso sospetta non deve esserci mai stata: «Col voto segreto si
voleva creare “l’incidente” e l’incidente c’è stato». Soprattutto con i renziani
di Italia viva, additati come i principali franchi tiratori del disegno di
legge. Alla fine, in quella: «prova di forza ha vinto la destra» ha aggiunto
Prodi che ha criticato anche il comportamento di Forza Italia e Silvio
Berlusconi: «che su queso tema si è un po’ appiattito». Per quanto, ha ammesso
ancora Prodi, il Cav ha preferito tutelare gli equilibri interni nella sua
coalizione: «Un comportamento razionale».
Sabrina Cottone per "il Giornale" il 3 magio 2021.
«Come mi sono sentito? Stupito e arrabbiato, preso di mira di fronte a milioni
di italiani mentre guardavo la tv con mia moglie e i miei figli» ricorda Jacopo
Coghe, vicepresidente di Pro Vita e famiglia, uno dei bersagli di Fedez, reo di
essere «ultracattolico e antiabortista» oltre che contrario al ddl Zan. Un'
infinità di follower, un milione e mezzo di spettatori del Concertone.
Altri sarebbero stati contenti di essere citati.
«Francamente no, non era un encomio e le modalità
mi hanno fatto arrabbiare. Non è la prima volta. Su Instagram mi aveva deriso
con una foto con sopracciglia arcobaleno, scatenando gli haters. Fedez non è
responsabile del singolo ma i suoi followers hanno scritto che starei bene
appeso a testa in giù. Chi si comporta così può sembrare un bullo».
Che cosa si aspetta da Fedez e dalla Rai?
«Di avere la possibilità di rispondere a Fedez e
di confrontarmi con lui. Ritengo gravissimo che abbia fatto un discorso politico
in diretta, su una tv pubblica, pagata da tutti noi contribuenti, senza
contraddittorio. Dopo le blasfemie di Sanremo penso che la Rai ci debba
spiegazioni e che la maggioranza degli italiani siano stanchi».
In verità chiedono le dimissioni dei vertici per
aver tentato di censurare Fedez. Non vede anche questo rischio?
«Ha travalicato con i toni. La sostanza è che per
la Festa del lavoro un rapper milionario che fa le pubblicità per Amazon non ha
parlato delle difficilissime condizioni dei lavoratori e del dramma per le
famiglie causato dalla pandemia, ma si è messo a promuovere il ddl Zan come uno
smalto collezionando dichiarazioni che non c' entrano con la legge. Così si
denigra l' avversario e se la pensi diversamente non hai diritto di parola».
Vuol dire che siete una sparuta minoranza? Eppure
avete testimonial come la Rowling.
«No, siamo una maggioranza silenziosa, anzi
silenziata, perché il mainstream la pensa diversamente. Quando la Rowling si è
espressa è stata massacrata. Al ddl Zan si sono detti contrari il mondo
femminista con Marina Terragni, i Verdi, Marco Rizzo di Comunisti italiani,
liberali come Cruciani, tutte persone non assimilabili a noi. Se c'è un parterre
contrario di persone di diversi mondi qualcosa va discusso».
Lei si definisce un ultracattolico come ha detto
Fedez?
«Credo di essere un semplice cattolico. Anche il
Papa ha parlato più volte del gender come uno «sbaglio della mente umana» e
nell' articolo 1 si parla di identità di genere».
Fedez l'ha definita anche antiabortista.
«Con le loro ecografie, Fedez e la moglie hanno
seguito passo passo la gravidanza dei loro bambini. Come si fa poi a definirli
un grumo di cellule?».
Che cosa vorreste cancellare del ddl Zan?
«Per noi non è emendabile. Il succo è che se mi
percepisco donna devo avere tutti i diritti: entrare in un bagno delle donne,
gareggiare nello sport con le donne. L'autopercezione dell'identità di genere
del sé sostituisce il sesso biologico. E poi spetta ai genitori il diritto di
priorità educativa e la Giornata contro l'omofobia fa entrare il gender nelle
scuole di ogni ordine e grado».
Ma se tante persone chiedono maggiore tutela
legislativa, un motivo ci sarà. Non pensa che le aggressioni siano frequenti?
«Le leggi già esistenti sono sufficienti:
giustamente hanno garantito e garantiscono pene molto alte».
Da "il Giornale" il 3 magio 2021. Il ddl Zan (già
approvato alla Camera) ha come obiettivo «prevenzione e contrasto della
discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'
orientamento sessuale, sull' identità di genere e sulla disabilità». Introduce
il carcere fino a 18 mesi o multa fino a 6.000 euro per chi istiga a commettere
o commette tali atti di discriminazione; il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi
istiga a commettere o commette violenza per gli stessi motivi; la reclusione da
6 mesi a 4 anni per chi partecipa o aiuta organizzazioni aventi tra i propri
scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza. Istituisce centri
antiviolenza. Vediamo i principali punti contestati, a partire dal timore che
siano a rischio libertà di pensiero, educazione e religione. All' articolo 1,
tra le definizioni, il punto d (l'identità di genere), distinguendosi dagli
altri tre, andrebbe a coincidere con l'ideologia gender. Nella legge si
distinguono quattro concetti: «a) per sesso si intende il sesso biologico o
anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una
persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al
sesso; c) per orientamento sessuale si intende l' attrazione sessuale o
affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di
entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l' identificazione
percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non
corrispondente al sesso, indipendentemente dall' aver concluso un percorso di
transizione». L' articolo 7 istituisce la Giornata nazionale contro l'omofobia e
coinvolge tutte le scuole di ogni ordine e grado in iniziative per contrastare
pregiudizi e discriminazioni. Il timore è che sia un mezzo per introdurre l'
deologia gender nelle scuole.
Che cosa c’entrano i diritti civili con
l’identità di genere? Esercitare un diritto è
l’espressione libera delle proprie attitudini sessuali in un quadro di tutele
contro violenza e discriminazione. Giuliano Cazzola su Il Quotidiano del Sud il
3 novembre 2021. La metempsicosi è “la reincarnazione delle anime, secondo la
credenza professata da alcune dottrine religiose’’. Se facessimo una ricerca in
proposito troveremmo certamente intere biblioteche che trattano l’argomento.
Immagino, però, che se trovassimo scritto in un articolo di legge che nei
programmi scolastici si devono dedicare ore di insegnamento a questa dottrina,
forse ci porremmo delle domande. Nel libro ‘’Sottomissione’’ Michel Houellebecq
ipotizzava un futuro abbastanza prossimo dove, in Francia, un partito mussulmano
(le conversioni erano all’ordine del giorno anche per questioni di potere)
diventava determinante per formare un’alleanza di governo. Così si cominciava a
programmare l’introduzione della poligamia nel novero dei nuovi diritti civili.
Poi, visto che la cancel culture si preoccupa solo delle opere dei grandi
filosofi greci, ma non dell’attitudine alla pedofilia, per quale ragione
vietarne la pratica, se in un Paese nordeuropeo è consentito persino avere
rapporti sessuali con animali a condizione che non si provochi loro sofferenze?
È chiaro che ci stiamo ponendo interrogativi che possono sembrare paradossali ad
un interlocutore del nostro tempo, ma quando sono le leggi ovvero il diritto
positivo a riconoscere diritti che hanno perduto ogni rapporto valoriale con il
diritto naturale, possiamo aspettarci di tutto. Chi scrive è contrario al ddl
Zan e non si sente un oscurantista né un bigotto, tanto meno un fascista. Uno
della mia generazione – se riflette onestamente sull’educazione ricevuta – è in
grado di comprendere le sofferenze e i torti subiti dalle persone omosessuali
(specie se nati maschi). Nessuno lo ricorda. Ma c’erano anche loro nei campi di
sterminio con la stella rosa sulla divisa a righe ora abusata dai no vax. Per
decenni sono stati costretti a nascondere le loro attitudini sessuali. Nel
dialetto della mia città si diceva: “l’è mej un fiol lader che un fiol buson”.
Ovvero «è meglio avere un figlio ladro che ‘’busone’’» come venivano definiti i
gay. In sostanza, perfino le famiglie si vergognavano di loro. Fin dalla scuola
chi fosse – come si diceva allora ‘’effeminato’’ era oggetto di un bullismo
violento, persino ammesso dalla comunità in considerazione dell’abnormità della
‘’deviazione’’. È facile comprendere come si dovesse sentire un ‘’diverso’’ in
quel contesto sociale e (sub)culturale. La commedia all’italiana – anche quella
di grande qualità – ha prosperato sullo stereotipo dell’omosessuale, con
definizioni che variavano a seconda delle realtà territoriali ma che facevano
parte del linguaggio consueto. Tutto questo non si riferisce a tempi lontani e
neppure recenti, ma è presenta ancora in mezzo a noi, anche se si sono compiuti
importanti passi avanti nel costume e nell’ordinamento giuridico. Il ddl Zan si
proponeva di contrastare con sanzioni più severe una discriminazione ormai
ritenuta inaccettabile? Qualcuno ha sostenuto con argomenti che si sarebbe
trattato di un eccesso di tutela rispetto alla legislazione ordinaria e che
sarebbe stato un errore prevedere delle fattispecie di protezione per figure
troppo specifiche, con il rischio di escluderne altre (tanto che nel disegno di
legge si è reso necessario introdurre i disabili che nulla hanno da spartire con
le discriminazioni basate sul sesso o come si dice adesso sul genere). Si
riteneva tuttavia – come è stato detto – mandare un segnale più forte,
attraverso un regime sanzionatorio più robusto? Nessuna forza politica avrebbe
potuto chiamarsi fuori (ancor meno che nel caso delle unioni civili). Perché
allora, col pretesto di assicurare una maggiore tutela agli omotransessuali il
ddl voleva insinuare (articoli 1, 4 e 7) nell’ordinamento giuridico, con il
riconoscimento del concetto di ‘’identità di genere’’, una visione ideologica,
priva di qualunque riscontro scientifico. Il sesso – che è l’unico dato reale
ed evidente – era relegato ad un tratto di penna dell’anagrafe e considerato un
adempimento burocratico che avrebbe imprigionato il corpo alla natura degli
organi genitali. Mentre l’espressione del diritto civile avrebbe dovuto
consentire di bypassare l’esistenza di differenze (visibili e intuitive) che da
miliardi di anni distinguono in tutti gli esseri viventi il maschio dalla
femmina. E sono le differenze che permettono la procreazione e la riproduzione
sociale. Da questo vincolo non si sfugge, nonostante tutti i surrogati e le
diavolerie che una scienza, un po’ disumana e mercificata, ha inventato per
sottrarre il concepimento alle leggi della Natura. Che cosa c’entrano i diritti
civili (spesso evocati a sproposito) con l’identità di genere? Esercitare un
diritto significa poter dare espressione libera alle proprie attitudini sessuali
in un quadro di tutele contro la violenza, la discriminazione, la repressione;
significa poter dare – come è stato fatto – a queste unioni un riconoscimento
giuridico con i relativi diritti e doveri. L’identità sessuale di un individuo,
secondo le teorie a cui il ddl si ispirava, non veniva stabilita dalla natura e
dall’incontrovertibile dato biologico ma unicamente dalla soggettiva
percezione di ciascuno che sarebbe stato libero di assegnarsi il genere
percepito, “orientando” la propria sessualità secondo i propri istinti e le
proprie pulsioni. Era il genere, secondo questa dottrina, che stabiliva, in
ultima analisi, l’identità sessuale di un individuo. Non si è uomini e donne
perché nati con certe identità fisiche, ma lo si è solo se ci si riconosce come
tali. Non ci sono maschi e femmine ma ci sono semplicemente esseri umani, liberi
di assegnarsi autonomamente il genere che percepiscono al di là dell’incomodo
del loro sesso naturale le cui tradizionali specie diventano così delle
categorie mentali superate, inadatte a rappresentare la complessità sociale
moderna e che per questo vanno rimosse per “decostruire”, ossia, cancellare la
natura, con l’obiettivo di smantellare pezzo per pezzo, un sistema di pensiero
considerato obsoleto e persino reazionario, alla stregua dei peggiori disvalori.
Così si è arrivati al punto che persino quelle manifestazioni di entusiasmo che
ogni opposizione attua da sempre e ovunque quando sconfigge la maggioranza in
una votazione importante, viene pubblicamente stigmatizzata alla stregua di una
gazzarra oscurantista, perché espletata ai danni di un ‘’diritto civile’’. Ma se
l’orientamento sessuale viene difeso dalla legge, non vi è alcun motivo – e
nessuno è autorizzato a rivendicare un diritto in tal senso – per consentire
alla teoria dell’identità di genere (ovvero «l’identificazione percepita e
manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso,
indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione») di trovare
posto, in modo arbitrario e truffaldino, nell’ordinamento giuridico alla stregua
di un valore comune. Determinando così una vistosa contraddizione: quanto viene
percepito diventerebbe reale a norma di legge, mentre ciò che è platealmente
reale (il sesso) si trasformerebbe in un’opinione, magari un po’ retrò e a
rischio di essere ritenuta una prevaricazione di diritti creati in vitro dal
legislatore. C’era la possibilità di approvare il ddl con una larghissima
maggioranza stralciando gli articoli inquinati da un’ideologia sconosciuta come
il covid-19. Ma proprio su questi articoli si è voluto dare battaglia mettendo a
rischio tutto il resto; peraltro la definizione identità di genere era inclusa
in tutti gli articoli come se fosse un ‘’amen’’ da recitare dopo ogni preghiera
(per inciso, negli Usa, per non fare discriminazioni dopo ‘’amen’’ dicono pure
“awomen”). Si vede che in fondo erano questi gli articoli giudicati più
importanti della nuova metempsicosi. Un tempo la sinistra si preoccupava
dell’identità di classe; adesso è passata all’identità di genere. E questo
cambiamento di valori viene oggi definito evoluzione, modernità, capacità di
interpretare i cambiamenti della società.
Storia di una legge che ha acceso il
dibattito. Che cos’è la legge Zan contro omotransfobia e cosa prevede.
Rossella Grasso su Il Riformista il 2 Maggio 2021. La legge Zan è una proposta
di norma contro l’omotransfobia e la misoginia. Punta a estendere le norme di
tutela attualmente in vigore per le etnie e l’orientamento religioso previste
dalla legge Mancino del 1993 anche all’orientamento sessuale. Propone infatti di
punire con aggravante chi commette violenza o incita a commettere violenza nei
confronti di un’altra persona sulla base dell’orientamento sessuale. La proposta
prende il nome del deputato del Pd Alessandro Zan che ha presentato il disegno
di legge avviandone così il tortuoso iter legislativo. Il testo si propone
di contrastare le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, identità
di genere e disabilità, per porre un freno ai numerosi episodi di violenza che
sempre più accendono le cronache. Amplia l’ambito di applicazione dei delitti
contro l’eguaglianza previsti dal Codice penale agli articoli 604 bis e 604 ter,
aggiungendo al novero delle fattispecie condannate i comportamenti
discriminatori contro disabili, omosessuali, transessuali, e qualsiasi altro
atto persecutorio motivato dall’orientamento sessuale. È una legge che non solo
tutela i diritti della comunità LGBT ma punisce anche il sessismo e la
misoginia. Le donne sono infatti le più colpite da episodi di discriminazione,
violenza, emarginazione e demansionamento sul lavoro.
Le misure e le pene proposte nella legge Zan. Il
testo prevede praticamente un’aggiunta all’articolo 604 bis che punisce le
discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, aggiungendo le
condotte discriminatorie fondate su “sul sesso, sul genere, sull’orientamento
sessuale e sull’identità di genere”. Le misure consistono nella reclusione fino
ad 1 anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro per chi istiga a commettere o
commette atti di discriminazione nei confronti delle categorie indicate. Poi la
reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi istiga a commettere o commette violenza o
atti di provocazione alla violenza per motivi discriminatori. E infine la
reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque partecipa o presta assistenza ad
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi
l’incitamento alla discriminazione o alla violenza verso le categorie
discriminate. Invece la modifica all’articolo 604 ter prevede una circostanza
aggravante – quindi una pena più severa – per i reati commessi con finalità
discriminatoria, odio etnico-razziale, religioso o per agevolare organizzazioni,
gruppi, movimenti fondati su principi discriminatori. Per questi soggetti la
pena è aumentata fino alla metà.
A che punto è la legge Zan. Il disegno di legge è
stato approvato alla Camera a novembre. Ma da allora è ferma per l’approvazione
in senato. Per questo motivo è partita la mobilitazione di attivisti e
personaggi del mondo dello spettacolo che chiedono a gran voce che si riprenda
l’iter legislativo per l’approvazione della legge che reputano fondamentale. Ma
parte del governo ha ritenuto non prioritaria la discussione sulla legge Zan. A
chiedere da tempo la sua discussione Pd, M5s, Leu e Italia Viva mentre tutto il
centrodestra si è sempre espresso contrario. Poi finalmente è
stato calendarizzato in senato. Ma le polemiche non sono finite: sarà proprio il
presidente della commissione Giustizia del Senato, il leghista Andrea
Ostellari, il relatore del provvedimento. Una mossa, quella di autonominarsi
relatore, definita da Zan “l’ennesima forzatura di chi vuole affossare una legge
voluta dalla maggioranza del #Senato. Ancora una volta dimostra di gestire la
Commissione Giustizia come fosse di sua proprietà. Le istituzioni si
rispettano”. Ostellari in quanto presidente della commissione ha la funzione di
relatore di ogni disegno di legge. Si tratta di una facoltà che in realtà
potrebbe essere delegata ad altri commissari: “Poiché sono stato confermato
presidente, grazie al voto della maggioranza dei componenti della commissione,
per garantire chi è favorevole al ddl e chi non lo è, tratterrò questa delega”,
ha spiegato Ostallari che è lo stesso senatore che pochi giorni fa, in una
intervista a Radio 24 al programma ‘La Zanzara’, disse che “dire frocio a un gay
non è sempre offensivo, dipende dal contesto”.
La posizione della Cei sulla legge Zan. Dopo la
notizia della calendarizzazione sono arrivate le parole della Cei, che
attraverso la sua presidenza auspica che “anche la voce dei cattolici italiani
possa contribuire alla edificazione di una società più giusta e solidale”. “La
Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi lunedì 26 aprile,
coerentemente a quanto già espresso nel comunicato del 10 giugno 2020, nel
quadro della visione cristiana della persona umana, ribadisce il sostegno a ogni
sforzo teso al riconoscimento dell’originalità di ogni essere umano e del
primato della sua coscienza. Tuttavia, una legge che intende combattere la
discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza,
mettendo in questione la realtà della differenza tra uomo e donna”, si legge
nella nota della Conferenza Episcopale. “In questi mesi sono affiorati diversi
dubbi sul testo del ddl Zan in materia di violenza e discriminazione per motivi
di orientamento sessuale o identità di genere, condivisi da persone di diversi
orizzonti politici e culturali. È necessario che un testo così importante cresca
con il dialogo e non sia uno strumento che fornisca ambiguità
interpretative”, spiega ancora la Cei che poi aggiunge: “Auspichiamo che si
possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo aperto e non pregiudiziale”.
Rossella Grasso. Giornalista professionista e
videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali
occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di
Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha
collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di
stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana,
si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo
Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al
Napoli Film Festival.
Virginia Piccolillo per il
"Corriere della Sera" il 7 aprile 2021. Lo scontro finale sulla legge contro
l'omotransfobia approda nell'ufficio di presidenza della commissione Giustizia
del Senato. Pd, Cinque Stelle, Leu e Iv tenteranno di superare il «no» della
Lega che con Andrea Ostellari si oppone alla calendarizzazione del disegno di
legge Zan. Franco Mirabelli (Pd) è convinto: «Supereremo quel veto». E domani
potrebbe essere incardinato. Ma il leghista Claudio Borghi avverte: «Il governo
nazionale è nato per il sostegno all'economia e il Recovery plan, non rompete le
scatole con cannabis e legge Zan». Lo scontro si accende su alcuni punti in
particolare. Il ddl parte dalla legge Mancino, che già punisce reati e discorsi
d'odio fondati su nazionalità, etnia e religione, e vi aggiunge una tutela per
la galassia Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transgender cui si aggiungono i
queer, che si interrogano sulla propria sessualità, e gli intersessuali). Ma non
li cita. E rende punibile la discriminazione fondata «sul genere e
sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere». Espressioni più elastiche
della definizione biologica di sesso. Cristina Gramolini, di Arcilesbica, lanciò
su Sette l'allarme: «Così le donne rischiano di perdere le poche garanzie
conquistate come le quote in politica». Invitando il legislatore a sostituire
«identità di genere» con «gay, trans e stereotipi di genere». Ma il punto più
contestato è l'articolo 4. Il sospetto che promuovere l'unione uomo-donna
diventi punibile ha già fatto gridare i vescovi: «Attenti a derive liberticide».
Nel timore che si vada oltre Papa Francesco e il suo: «Nessuna persona deve
essere discriminata sulla base del proprio orientamento sessuale». E si arrivi
all'eccesso dell'inchiesta in Spagna sull'Arcivescovo di Pamplona, «colpevole»
di aver dichiarato che in una relazione omosessuale è preclusa la finalità della
procreazione. Critiche condivise da Lega e FdI, una parte di Forza Italia e
centristi. Il dem Stefano Ceccanti rassicura: «Il lavoro proficuo svolto ha
consentito di superare riserve iniziali sulla libertà di espressione. Non sono
punite generiche opinioni, discutibili o spiacevoli, ma quelle che determinano
il concreto pericolo del compimento di atti violenti». Infine lo scontro sulla
campagna di sensibilizzazione da 4 milioni di euro. Come evitare, si chiedono
nel centrodestra, che si trasformi in propaganda contro le unioni eterosessuali?
Zan: “La mia legge non è liberticida,
tutela la dignità delle persone”. In Italia esiste un
enorme fenomeno di under-reporting sui reati a sfondo omotransfobico, proprio
perché non esiste fattispecie di reato ad hoc. Alessandro Zan su Il Dubbio il 3
maggio 2021. Il valore che le madri e i padri costituenti hanno impresso nella
Costituzione non è solo quello di atto fondamentale per tutta la struttura
normativa su cui si basano le nostre vite, ma anche di manifesto programmatico,
che tutte le sensibilità politiche condivisero, per creare una società realmente
democratica e plurale, dopo gli anni del totalitarismo e della catastrofe.In
particolare, all’articolo 3 la Costituzione affida alla Repubblica, e quindi al
legislatore, il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana”. Dunque anche la tutela di tutte le
condizioni e i caratteri insiti in ogni essere umano, in quanto tale. Proprio
seguendo il percorso indicato dalla Costituzione, la legge Reale-Mancino già
contrasta i crimini d’odio per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.
Tuttavia negli ultimi anni i maggiori osservatori europei per i diritti umani
hanno relegato l’Italia agli ultimi posti delle loro classifiche per inclusione
sociale della comunità lgbt+. Hanno disegnato una vera e propria mappa
dell’odio, che ci consegna una situazione critica e d’emergenza: i crimini
d’odio e le discriminazioni colpiscono in particolare le donne, le persone lgbt+
e le persone con disabilità. Ovvero individui colpiti per il loro sesso, per il
loro genere, per il loro orientamento sessuale, per la loro identità di genere o
per la loro disabilità. Ed è esattamente utilizzando questi termini che il ddl,
di cui sono stato relatore alla Camera, intende emendare la legge Reale-Mancino,
estendendo anche a queste categorie (che sono pure condizioni ascritte
all’essere umano, come l’etnia o la nazionalità) l’efficacia della norma. Una
volta emendati, gli articoli 604 bis e ter del codice penale – che hanno
codificato la legge citata poco fa – diverrebbero dunque non solo uno strumento
in più di denuncia da parte delle vittime, ma anche un aiuto alle forze
dell’ordine per perseguire e prevenire questi crimini. Come è stato più volte
sottolineato anche da dirigenti OSCAD (Osservatorio della Polizia di Stato
contro le discriminazioni) in Italia esiste un enorme fenomeno di
under-reporting sui reati a sfondo omotransfobico, proprio perché non esiste
fattispecie di reato ad hoc, dunque i dati in nostro possesso sono decisamente
parziali e arrivano tutti dai casi che finiscono sulla stampa o sui social
media, perché denunciati pubblicamente dalle vittime.Dunque, da un punto di
vista tecnico-giuridico, la nostra volontà (nostra per indicare l’ampia volontà
comune di tutte quelle forze politiche che hanno contribuito alla formulazione e
all’approvazione alla Camera del testo) è quella di estendere una legge che
esiste da più di 40 anni, con una giurisprudenza – anche costituzionale –
consolidata, che ne ha chiarito ogni aspetto potenzialmente critico. Mi
riferisco agli attacchi pretestuosi e infondati di chi definiscequesto
provvedimento “liberticida”, e che ha creato nell’ultimo anno massicce campagne
di fake news. Questa è una proposta di legge che poggia sul bilanciamento tra la
libertà di espressione e la tutela della dignità delle persone. Il Presidente
della Repubblica stesso, in occasione dell’ultima giornata internazionale contro
l’omofobia, ha chiarito che “le discriminazioni basate sull’orientamento
sessuale costituiscono una violazione del principio di eguaglianza e ledono i
diritti umani necessari a un pieno sviluppo della personalità umana”. Insomma la
libertà di espressione non può mai degenerare in discriminazione o incitamento
all’odio. Per essere chiari, un esempio: un prete in Chiesa sarà sempre libero
di affermare che l’unica famiglia possibile può essere tra un uomo o una donna.
È ovviamente una libera opinione, che non condivido, ma che deve essere
tutelata. Ma una persona non può liberamente augurare il rogo alle persone
omosessuali o auspicare che si riaprano i forni crematori per le persone trans,
come purtroppo spesso accade soprattutto sui social. Uno stato che si definisce
civile deve contrastare con tutta la sua forza questi fenomeni. C’è inoltre un
ulteriore aspetto che mi preme sottolineare. Più volte nel corso di questi mesi
mi è stato chiesto chi ha paura di questo ddl, e perché spesso chi si oppone
ricorre a bufale, in totale malafede. Sono convinto che l’approvazione di questo
provvedimento sancirebbe il posizionamento dell’Italia nell’Europa dei diritti,
della libertà e della democrazia, tra Paesi come Francia, Germania, Belgio,
Spagna, rompendo definitivamente ogni ammiccamento a derive sovraniste come
quelle di Ungheria e Polonia. Lega e Fratelli d’Italia guardano ancora a quei
modelli, che hanno creato profonde fratture all’interno dell’Unione Europea e
che tutt’ora conducono campagne d’odio istituzionalizzate contro la comunità
lgbt+ e contro i diritti delle donne. Questa non può diventare una battaglia
ideologica o di parte, ma una battaglia per un patrimonio comune. In Francia fu
la destra di Chirac ad approvare una norma contro l’omotransfobia nel 2004.
Infatti non ci può essere alcun europeismo dove esiste esitazione o, peggio,
opposizione ai diritti, ed è tempo per il nostro Paese di definire il suo
modello di futuro, di definire la sua collocazione in un contesto europeo che
proprio su questi temi si sta dividendo tra paesi avanzati e paesi arretrati.
Dopo ben cinque tentativi falliti dal 1996, l’Italia non può più permettersi di
perdere questa occasione di civiltà e tutelare ogni sua cittadina e suo
cittadino semplicemente per chi è.
Da “La Zanzara – Radio24” il 6 maggio 2021.
“L’omofobia è come l'antisemitismo, per questo la legge Zan va approvata. La
differenza tra civiltà e inciviltà passa attraverso il rispetto di ogni singola
minoranza. Oggi a causa delle campagne della destra social Liliana Segre va in
giro con la scorta e ci sono dei ragazzi gay che si buttano dalla finestra
perché vengono rifiutati dalla famiglia o bullizzati a scuola. Quello che è
successo agli ebrei è inenarrabile, ma tutte le minoranze vanno rispettate”. Lo
dice a la Zanzara su Radio 24 Alessandro Cecchi Paone. Dire che due gay sono
contro natura è incitazione all’odio? “Sì”, risponde Cecchi Paone. E se dici che
l’unica famiglia è quella tra uomo e donna?: “Sì, perché crei infelicità negli
esseri umani, inciti all’odio. Se tu dici che i froci non possono unirsi in
matrimonio per me sei perseguibile”.
Da adnkronos.com l'8 maggio 2021. "Se avessi
condotto io il Concertone del Primo Maggio avrei spento le telecamere a Fedez
durante il suo discorso. Per querelarlo è troppo tardi, equivarrebbe solo fargli
il doppio della pubblicità". La vede così Pippo Baudo che all'Adnkronos spiega:
"Fedez ha esagerato. Poteva fare spettacolo, mentre fa ogni cosa per essere
protagonista. E ha sbagliato a fare quel discorso in una sede che non era sua.
L’errore che ha commesso la Rai - scandisce Baudo - è stato quello di non dire
semplicemente che quel palcoscenico era il suo e a lei competeva
l’autorizzazione. Chiedere il testo dell’intervento di Fedez è stato senza
dubbio corretto. Se tu vieni a casa mia e io ti ricevo nel mio salotto, io
voglio sapere cosa ci vieni a fare. E poi gli argomenti che Fedez ha toccato
sono complicati e non si può utilizzare il mezzo pubblico in maniera così
indiscriminata. Bisogna stare attenti perché si ripercuote sulla società in modo
divisivo". E ancora: "Quanto si prefigge il Ddl Zan è già previsto dalla nostra
Costituzione nei primi 12 articoli, quelli fondamentali. Lì si legge
chiaramente, al primo comma dell’articolo 3, che tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, oltre che di condizioni
personali e sociali. Il Ddl Zan è un raddoppio" dice Baudo, conversando con
l'Adnkronos e soffermandosi sul disegno di legge che sta facendo discutere da
tempo politici e personaggi pubblici, vieppiù dopo il discorso di Fedez sul
palco del Concertone del Primo Maggio. "Abbiamo fra le più belle carte
costituzionali del mondo - rimarca Baudo -. E' inutile aggiungere un’altra legge
che confonde le cose. La nostra Costituzione è perfetta ed è garantista al
massimo. Il Ddl Zan è la complicazione delle cose semplici. La vita che facciamo
e, in particolare, la vita che conduciamo in Italia, ci ha dato tutte le marce
che ci servono per vivere tutti insieme con tutte le diversità e le mentalità
che si possono avere".
Redazione Blitz il 10 maggio
2021. Dj Ringo, noto conduttore radiofonico, attuale direttore creativo di
Virgin Radio, ha commentato su MOW Magazine le polemiche circa il concerto del
Primo Maggio e l’intervento sul palco di Fedez: “Non è più musica. Lui si
presenta come fenomeno mediatico”.
Ringo e le scuse di Fedez per
i testi vecchi. Perché, secondo il disc-jockey, “ha numeri altissimi nei social,
la cosa incredibile è che nessuno lo invita come rapper”. Ringo ha infatti
sottolineato l’ammenda pubblica di Fedez sui testi contenuti nelle proprie hit
musicali: “perché ha chiesto scusa anni dopo aver scritto quei testi? Solo
perché è venuto fuori questo casino? Le scuse doveva farle tempo fa, le offese a
Tiziano Ferro erano pesanti”.
Ringo: “Dietro Fedez penso ci
sia la moglie”. Dj Ringo ha però evidenziato che “quando mesi fa raccolse i
soldi e aprì con la moglie il reparto anticovid sono stato il primo a fargli i
complimenti, merita davvero rispetto. Io non voglio attaccarlo, sto solo
analizzando. Lui fa delle cose giustissime e ha il potere per farlo”.
Concludendo con un’analisi strategica circa la facile polemica mediatica: “Io
penso che dietro ci sia la moglie, non si offenda, non sto dicendo nulla di
male. Lei gli avrà chiesto di cambiare registro, sono sposati, hanno una
famiglia. Il Ringo buono, la mia parte angelica, pensa che sia cresciuto e abbia
ascoltato i consigli della moglie. Il Ringo perfido dall’anima diabolica pensa
che sta sfruttando questi momenti per avere clic. La risposta la sa solo Fedez
ma è chiaro che da fuori può sembrare che lui – come altri personaggi – a volte
usi queste faccende importanti per cavalcare l’onda. E avere più like e più
Nike. Ma questo vale anche per me, è un sistema in cui siamo tutti coinvolti”.
Dj Ringo, Fedez e la politica.
Infine circa il sostegno e l’abbraccio da parte della politica: “Per me lui si
sta preparando la carriera per entrare in politica. Diventerà un politico, dopo
Zingaretti-Letta il prossimo leader sarà Fedez”. E, circa l’eventualità di un
futuro voto, Dj Ringo aggiunge: “No, io ho altre idee. Una cosa che non capisco
è che in Italia quando dici di non essere di sinistra automaticamente sei un
nazista. È terribile”.
Dagoreport by Dago il 10
maggio 2021. Tutti uguali questi ragazzi-prodigio. Partono a razzo, vanno fuori
di testa poi finiscono fuori orario, fuori binario, come quella cima di rap di
Fedez, nato Federico Lucia, di professione idolo dei teenager, ma ormai così
inquieto e pretenzioso che è finito sul materasso del conformismo web, del
velleitarismo politicante, dell'estremismo retorico oggi tanto di moda. Sembrava
che studiasse per diventare un Battisti da discoteca, è diventato uno di questi
sirenetti del "vuoto sincronizzato", tromboneggiante le consuete opinioni
generosamente generiche, ingenuamente ideologiche, ovviamente sentenziose che ci
aspettiamo, che temiamo. Con quell'aria pentita, il tatuaggio da incazzato,
l'occhio infelice, la maglietta stagionata e la braga espansa, che è la divisa
di ordinanza dei rivoluzionari del rap, il portaborsetta di Chiara Ferragni si è
messo a fare grandi discorsi, travolto da un'inarrestabile voglia di dire la
sua, di dividere il mondo in buoni e cattivi, di improvvisarsi intermediario tra
i giovani disorientati e una politica che ha perso la bussola. Secondo Francesco
Merlo "il pensiero spelacchiato è un vecchio genere di successo in evoluzione (o
involuzione). Ma Celentano è un grande cantante, Fedez per ora è un grande
marito". Ma forse la formula più esatta per definire l’insostenibile birignao di
Fedez è la parabola di Jovanotti. Ricordate? Dopo aver seppellito
proditoriamente il funambolico digei degli anni Ottanta, il jovanottismo
spensierato di "E' qui la festa?", "Un, due, tre, casino!", "Gimme five",
sbandierando che "Il disimpegno è acqua passata" l'ex "profeta del cretinismo
integrale" (definizione di Michele Serra) conquista le colonne dei settimanali
d'opinione, discettando di Dio, Marx e Berlusconi. Senza troppo sottilizzare,
frusta i governanti, canzona i politicanti, denuncia la mafia, spiegando a tutti
come dovrebbero andare le cose nel nostro benedettissimo Paese. In "Penso
positivo", brano-manifesto della sua opera-compact, l'ex "giovane scemo"
concretizza così la sua ansia da singhiozzo: "Io credo che a questo mondo esista
solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa,
passando da Malcom X attraverso Gandhi e San Patrignano, passando da un prete in
periferia che va avanti nonostante il Vaticano". Bastava aggiungere una tappa al
Mulino Bianco, ed era tombola. Poveri ragazzi. Dai e dai, a forza di tracimare
in campi a loro sconosciuti (la palude italiana, la politica internazionale,
l'ecologia, l'ecumenismo espanso; ultima uscita: l’omofobia e l’identità di
genere), si è trasformato in una macchietta. Essì: Fedez, che pur stonando anche
quando dorme, soffre della stessa candida sindrome del Savonarola che ha colpito
negli anni passati i vari Dalla, Battiato, De Gregori, Venditti, Piero Pelù.
Non pare che abbiano lasciato luminose tracce nella nostra legislazione. Ecco:
il grande "errore" di Fedez, bardato da "opinionista" militante, è proprio un
equivoco di forma: credere che sia sufficiente il buon impegno per opporsi ai
problemacci della vita. La musica pop è una fabbrica per la normalizzazione
dell'insolito; per il portarossetto della Ferragni è invece una gabbietta dorata
in cui rinchiudersi a fare il pappagallo della banalità.
Quello che Fedez non vi dice sul ddl Zan.
Giuseppe De Lorenzo l'8 Maggio 2021 su Il Giornale. Le
attività Lgbt nelle scuole e i veri scopi ideologici: tutte le ombre del ddl
Zan. Abbiamo già provato a dare a Federico Lucia, in arte Fedez, una breve
lezione di democrazia sul rispetto delle opinioni altrui. Dunque partiamo dal
presupposto che il cantante e i suoi paladini abbiano riguardo del nostro
dissenso, e che dunque si possa ragionare un po’ sul ddl Zan. In maniera più
approfondita di quanto non abbia fatto il n° 2 dei Ferragnez dal palco del primo
maggio. Il testo del disegno di legge, già approvato alla Camera, non è né lungo
né di complessa lettura. Eppure per la scaltrezza con cui è stato scritto si
presta a interpretazioni e storture che giustificano in larga parte le
preoccupazioni di cattolici, conservatori, femministe e pure delle lesbiche.
Prendete l’articolo 1, che poi è una sorta di glossario dell’ideologia gender.
Pensate che al mondo esistano i maschi e le femmine? E che al massimo qualcuno
tenta una transizione da una sponda all’altra? Beh, siete dei retrogradi. Perché
il ddl Zan sentenzia per legge altre definizioni antropologiche di dubbia
natura. Tipo: per “genere” si intende una “manifestazione esteriore conforme o
contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso” (e che vuol dire?); e
addirittura arriva a disciplinare qualcosa di ancor più fumoso, “l’identità di
genere”, ovvero “l’identificazione percepita e manifesta di sé in relazione al
genere, anche se non corrisponde al sesso”. Oggi mi sveglio maschio, domani
femmina, dopodomani chissà. Ora, è legittimo portare avanti le proprie
battaglie. Pure quelle più strampalate. Ma non si dica che questo glossario
arcobaleno non ha finalità ideologiche. Lasciate perdere la fregnaccia del
“serve per difendere gli omosessuali”. Non è così. L’obiettivo sotteso, spiega
il politologo Alessandro Campi, è quello di “lasciarsi alle spalle le differenze
tra i sessi naturalisticamente definite a favore delle identità sessuali e di
genere soggettivamente percepite e autocertificate”. Si tratta insomma un
intento politico-culturale, intrapreso mettendo in vetrina quelle belle parole
sulla lotta all’omofobia. Va bene, siete liberi di perseguire lo scopo. Ma
almeno ditelo chiaramente. Chiaro, Fedez? Anche perché se l'intento fosse solo
quello di combattere le violenze, le sinistre fedeziane avrebbero potuto
banalmente accettare il testo scritto dai colleghi di maggioranza
di Lega e Forza Italia. Senza strani passaggi gender né pilatesche Giornate
nazionali per la lotta all’omofobia, la proposta del centrodestra puntava solo a
riconoscere l’aggravante dei reati omofobi. Punto e basta. Ma Pd e M5S hanno
preferito forzare la mano sul ddl Zan. Lo sa Federico Lucia che il 17 maggio di
ogni benedetto anno i suoi figli a scuola saranno sottoposti a “cerimonie e
incontri” obbligatori, ovviamente appannaggio delle associazioni Lgbt di varia
natura? Direte: cosa c’è di strano? Lo ha spiegato bene Michela Murgia in tv:
"Il punto è cominciare a modificare la cultura”. Modificare la cultura, chiaro?
Ci è permesso non condividere? Ultimo appunto sulla libertà di espressione. I
tifosi del ddl Zan ritengono i timori liberticidi eccessivi, perché l’articolo 4
contiene la cosiddetta clausola sul pluralismo delle idee. Già il fatto che una
norma debba prevedere una “clausola di libertà”, teoricamente garantita dalla
Costituzione, dimostra la pericolosità di quanto contenuto nel testo. E poi è
previsto un limite: si può cioè dire e pensare ciò che si vuole purché le idee
non siano “idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti”. Bene. E chi decide quando le opinioni determinano un
effettivo pericolo? Spiega Campi: “Ci vuole poco a capire quali margini di
discrezionalità, con una magistratura politicizzata in molte sue frange come
quella italiana, lascia aperta una simile formulazione”. Ad esempio: come
potremo essere liberi di dire che “l’identità di genere” è una frottola
astrofisica? E come potremo sostenere che non si può scegliere la mattina
davanti allo specchio se sentirsi maschietto o femminuccia, se questo principio
viene sancito dalla legge? Potremo ancora affermare che le coppie omosessuali
non debbono adottare bambini? O che l’utero in affitto è un mercimonio orrendo e
un crimine contro le donne? Potranno i cattolici dirsi contrari al matrimonio
gay? È evidente che l’incertezza giuridica del testo produrrà denunce temerarie
contro chiunque si opponga all’ortodossia arcobaleno. Lo dimostra quanto detto
ieri da Alessandro Cecchi Paone a La Zanzara: ritenere che l’unica famiglia sia
quella tra uomo e donna sarebbe incitamento all’odio perché “crea infelicità
negli esseri umani", quindi sarebbe "perseguibile". Abbiamo il diritto di
dissentire?
Nessun attacco alla libertà
d'opinione. Perché il ddl Zan è utile e necessario, basta bufale.
Salvatore Curreri su Il
Riformista il 15 Maggio 2021. Il disegno di legge “Zan” è inutile, repressivo e
ambiguo, come sostengono i suoi detrattori? Oppure è opportuno, come
autorevolmente affermato l’altro ieri dal presidente della Corte
costituzionale Coraggio (nomen omen)? Per rispondere a questa domanda occorre
approfondire il tema sotto un profilo strettamente giuridico. Operazione non
facile e magari noiosa per il rischio di cadere in sottigliezze ai più
incomprensibili. Eppure analizzare il testo della proposta, concentrarsi sui
suoi singoli termini – che nel diritto non sono mai spesi a caso anche in forza
del significato che loro deriva da consolidate tradizioni interpretative
giurisprudenziali – mi sembra l’unico modo per fare ordine su un disegno di
legge certo perfettibile ma che sicuramente non merita le accuse, inesatte e
semplificatorie, veicolate in modo facile e strumentale da una certa propaganda
politica. Ci provo. 1. Si dice: il ddl Zan è inutile perché le disposizioni per
punire comportamenti violenti o discriminatori già esistono. Vero, perché è
ovvio che menare un gay è già reato. Ma il ddl Zan non tratta di questo. Tratta
di chi istiga a commettere tali reati. Certo, la repressione sessuale non si
supera con la repressione penale. Ed è per questo (e solo in questo senso) che
il ddl Zan punta a un’attività educativa da svolgere anche nelle scuole per
prevenire le discriminazioni. Ma è indubbio che il legislatore deve intervenire
di fronte a un fenomeno che, proprio in assenza di specifiche fattispecie di
reato, è statisticamente sottostimato (come confermato dall’Osservatorio della
Polizia di Stato contro le discriminazioni) e specialmente presente nei social
network dove, per malinteso senso di impunità, è più reale e concreto il
pericolo che – per così dire – le parole si trasformino in pietre. Mai
dimenticare McLuhan: il mezzo è parte integrante del messaggio. 2. Le parole,
giustappunto. Per i contrari il ddl Zan è un testo ideologico, lesivo della
libertà di espressione garantita dall’articolo 21 della Costituzione, perché non
definisce, con la determinatezza propria della legge penale, quali siano gli
atti discriminatori e, di conseguenza, quali opinioni vanno considerate reato
perché idonee a determinare il concreto pericolo di loro compimento. Falso.
Innanzi tutto il ddl Zan non introduce una nuova fattispecie di reato. Piuttosto
estende i delitti già previsti contro l’eguaglianza, aggiungendo ai già
previsti motivi “razziali, etnici, nazionali e religiosi”, quelli per sesso,
genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità. Quindi quanti
sostengono che si tratti di una proposta di legge repressiva della libertà di
espressione dovrebbero per coerenza estendere la loro accusa
d’incostituzionalità all’intera disciplina in materia (la c.d. legge
Reale-Mancino oggi trasfusa nell’art. 604-bis) e, dunque, invocare sempre e
comunque libertà di parola anche in materia razziale, etnica, nazionale o
religiosa. Non lo fanno perché (forse) sanno – come vedremo – di avere contro
tutta la giurisprudenza. In secondo luogo ad essere sanzionata per i nuovi
motivi che si vorrebbe introdurre (sesso, genere, ecc.) non è la propaganda di
idee ma l’istigazione a commettere atti discriminatori. Tra i due concetti c’è,
giuridicamente parlando, un abisso. Non deve trattarsi di semplici opinioni ma
di parole che, per portata istigativa, rischiano di tradursi o si sono tradotte
in concreto in azioni discriminatorie, secondo uno stretto, diretto,
conseguenziale nesso di causalità. Insomma verrebbe punito il dicere diretto a
tradursi (o già tradottosi) in facere. Insomma, è e rimarrà pienamente legittimo
affermare (magari durante un’omelia) l’eterosessualità del matrimonio o
criticare le adozioni omosessuali e l’utero in affitto (già vietati), mentre non
sarà più possibile aizzare (magari davanti a un noto luogo di ritrovo degli
omosessuali) contro di loro l’odio dell’opinione pubblica per i loro
comportamenti ritenuti contrari al buon costume. Per fugare ogni dubbio in
merito, in prima lettura alla Camera è stato approvato un emendamento cosiddetto
salva idee (presentato dal deputato di Azione Enrico Costa) in base al quale «ai
fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di
convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al
pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a
determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o
violenti». Si continua ad obiettare: tale articolo non risolve nulla perché
rimane incerto quali siano gli atti discriminatori e, di conseguenze, le
opinioni da vietare perché in grado di determinare il concreto pericolo di loro
compimento. Alla fine quindi sarebbe sempre il giudice a distinguere tra
opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e quelle istigatrici all’odio e
alla violenza. Ora, premesso che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire e
che sembra pretendersi dal legislatore un tasso di specificità che contrasta con
la connaturata generalità ed astrattezza di ogni disposizione normativa – penale
inclusa –, è proprio la consolidatissima giurisprudenza costituzionale e
ordinaria sui cosiddetti reati di opinione a dimostrare quanto simili
preoccupazioni siano infondate. Anzi, proprio la definizione di pericolo
concreto affidata alla valutazione del giudice, entro i marcati confini
tracciati da tale giurisprudenza, è di gran lunga più garantista rispetto ad un
pericolo astratto predeterminato dal legislatore. Tali reati di opinione, tra
l’altro ormai in gran parte abrogati o depenalizzati, non contrastano con la
libertà d’espressione nella misura in cui l’autore vuole andare oltre la
critica, sempre legittima ancorché radicale, per tradursi in un «comportamento
concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti» (Corte cost.,
65/1970; v. anche 126/1975). È quello che la Corte suprema Usa definisce
“pericolo chiaro ed imminente” (“clear and present danger”). Per questo occorre
sempre «valutare la concreta ed intrinseca capacità della condotta a determinare
altri a compiere un’azione violenta con riferimento al contesto specifico e alle
modalità del fatto» (Cass., I pen. 42727/2015). Ad essere puniti per motivi
discriminatori non sono stati mai i sentimenti di generica antipatia,
insofferenza o rifiuto, tutelati dalla libertà d’espressione ex art.
21 della Costituzione, quanto le opinioni idonee «a determinare il concreto
pericolo di comportamenti discriminatori» (Cass., III pen. 36906/2015) perché
esprimono una manifesta volontà d’incitamento all’odio dirette a creare in un
vasto pubblico, come nel caso della diffusione ed amplificazione veicolata dai
social network, il concreto pericolo del compimento di atti d’odio e di violenza
(Cass., VI pen. 33414/2020). I reati d’istigazione a compiere atti
discriminatori non si pongono, dunque, in contrasto con la libertà d’espressione
perché «l’incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta,
quanto meno intesa come comportamento generale, e realizza un quid pluris
rispetto ad una manifestazione di opinioni, ragionamenti o convincimenti
personali» (Cass., V pen. 31655/2001). Il lettore spero mi perdonerà questa
sfilza di citazioni giurisprudenziali, ma credo sia l’unico modo, argomentato e
convincente, per dimostrare quanto giuridicamente infondati siano, almeno sotto
questo profilo, i timori espressi contro il ddl Zan. 3. Infine l’ultima accusa:
l’ambiguità perché il ddl Zan introdurrebbe un concetto – l’identità di genere –
cioè la percezione che si ha del proprio sesso anche se non corrispondente a
quello biologico o anagrafico – sconosciuta al nostro ordinamento. Falso anche
in questo caso. In base a una legge del 1982 (!) ciascuno, in nome del proprio
diritto alla salute psico-fisica e all’autodeterminazione della propria identità
sessuale, può cambiare anagraficamente sesso, senza che oggi occorra più
modificare chirurgicamente i propri connotati sessuali (il soma). Ciò a seguito
di un iter giudiziale in cui la semplice dichiarazione del soggetto di
appartenere psicologicamente ad un sesso diverso (self-id) non deve avere di per
sé rilievo esclusivo o prioritario (così Corte cost. n. 180/2017, ma v. anche la
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 10.3.2015, Y.Y. c. Turchia).
L’identità di genere è quindi già riconosciuta nel nostro ordinamento e chi
ritiene che basti proclamarsi di un sesso diverso per esserlo dimostra ancora
una volta non solo la propria ignoranza giuridica ma di avere una visione
strumentale e caricaturale di temi e percorsi esistenziali senz’altro meritevoli
di maggiore rispetto. Salvatore Curreri
Francesco Borgonovo per “la Verità” il 14 maggio
2021. Michele Ainis è uno dei più conosciuti e stimati giuristi italiani.
Costituzionalista, docente universitario, è molto noto come editorialista di
Repubblica e l'Espresso, oltre che come scrittore. Il suo ultimo libro -
pubblicato da La Nave di Teseo - è un romanzo intitolato Disordini: un titolo
che sembra avere molto a che fare con l'attuale dibattito politico. Ainis non si
può certo considerare un pericoloso sovranista, e anche per questo ha suscitato
molto dibattito un suo articolo (uscito su Repubblica) che metteva in luce
alcuni problemi del ddl Zan. «Penso che il problema sia che noi non riusciamo
più pensare per categorie generali e allora ci impicchiamo alle
microdefinizioni», spiega il professore. «C' è la preoccupazione di dimenticarsi
qualche categoria, e allora si elencano tutte, anche se poi dimenticarsi
comunque qualcuno è fatale. Negli anni Settanta, i giuristi tedeschi e inglesi
hanno stilato delle linee guida, le checklist, per i testi legislativi. Quando
ne si esamina uno, la prima domanda da farsi è: questo testo è davvero utile o
una legge così esiste già, magari sommersa da mille altre?».
E di frequente si producono norme su questioni di
cui i codici già si occupano.
«Succede talmente spesso che quando si fa una
nuova legge si specifica che abroga le norme in contraddizione, anche se non
sarebbe necessario. Il fatto che si scriva dimostra che spesso chi fa le leggi
non sa se ne esistano altre dello stesso genere, e certifica la proliferazione
di norme che abbiamo. Purtroppo non è un problema nuovo, ma negli ultimi tempi
si è acuito. Le leggi devono essere generali, se ti metti a fare gli elenchi
dimentichi sempre qualcuno».
Quindi, per quanto riguarda il ddl Zan, lei dice
che basterebbe la legge Mancino.
«Sinceramente penso che la stessa legge Mancino
fosse inutile. Anche la più ampia tutela della libertà di pensiero e di parola è
cosa diversa dalle azioni violente, lo insegna Popper. Significa che l'
istigazione a delinquere è reato e rimane reato, su questo non ci possono essere
dubbi. Il ddl Zan vuole aggiungere alle categorie già contemplate dalla Mancino
il sesso e il genere? Torniamo al punto precedente: una buona legge deve essere
generale. Oggi esiste un problema con le categorie generali. E questa tendenza
ad elencare è segno di un cattivo rapporto tra il legislatore e i giudici».
In che senso?
«Nel senso che si scrive il più possibile nel
testo delle leggi per elidere gli spazi di libertà del giudice. In realtà si
ottiene sempre l'effetto opposto. Più scrivi, più gli spazi di indeterminatezza
e di libertà del giudice aumentano».
Zan e i suoi sostenitori insistono sulla necessità
di introdurre aggravanti per alcuni reati. Queste aggravanti secondo lei
esistono già?
«Esistono le aggravanti per motivi futili o
abietti che aumentano la pena fino a un terzo, e non è poco. Certo, si tratta di
una aggravante formulata in termini generali, poi sta al giudice decidere. Ma la
possibilità di darle c' è. Esiste poi un ulteriore problema».
Quale?
«Abbiamo in circolo 35.000 fattispecie di reato.
Sono tantissime. Ogni volta che si fa una legge si aggiungono 2 o 3 norme
penali. Ma un conto sono i delitti naturali: tutti sappiamo che è sbagliato, che
so, uccidere la suocera. Un altro conto sono i delitti di pura creazione
legislativa, i quali spesso si rivelano trappole».
E perché?
«Perché i cittadini rischiano di commettere reati
senza rendersene conto. In generale questa proliferazione del diritto penale
rende infido l'ordinamento giuridico e concede al giudice un potere superiore a
quello che gli si vorrebbe togliere. Con 35.000 reati, se io volessi prendermela
con lei, mi sarebbe più facile dire: andiamo a cercare il reato che posso
contestargli al supermercato dei reati».
Se ci sono già leggi per punire i cosiddetti
«crimini di odio» ed esistono pure le aggravanti, mi viene da pensare che il
vero cuore di questa legge sia altrove. Ad esempio nell' introduzione dell'
identità di genere che si può autodeterminare.
«Anche in questo caso abbiamo un riflesso della
"cultura dei diritti" in cui viviamo.
Continuiamo ad aggiungere diritti, i quali altro
non sono se non desideri che si trasformano in norme giuridiche. E in questo
modo spesso si alimentano gli egoismi individuali. Sull' identità di genere mi
viene da dire che noi siamo individui fatti di corpi, di carne. Invece qui mi
sembra che si alimenti la dematerializzazione ormai imperante. Non possiamo
prescindere dal fatto di avere carne e ossa. Infatti le femministe - alcune, non
tutte - si sono accorte che l' identità di genere significherebbe cancellazione
del corpo femminile (perché questo vuol dire) e dicono che sarebbe un
arretramento».
C'è poi la questione della libertà di espressione
e dei suoi limiti.
«In questo periodo si ragiona molto sulla libertà
di parola e l' hate speech. Gli americani, che hanno il culto della libertà di
espressione, hanno anche una grande tolleranza nei confronti degli intolleranti.
Quella sì che ha un valore pedagogico».
Sul serio?
«John Stuart Mill diceva che ha maggior impatto la
rappresentazione dell' errore rispetto a un bel sermone. Si impara di più dal
cattivo esempio. Se sento qualcuno dire che gli omosessuali sono una sciagura,
il moto di esecrazione che scaturisce rafforza le convinzioni positive. La
circolazione delle idee, anche le più aberranti, rafforza i valori della
cittadinanza. Le opinioni si combattono con altre opinioni: vietarne alcune per
legge le santifica».
Secondo lei il ddl Zan rischia in qualche modo di
«ghettizzare» le persone Lgbt?
«Anche qui dobbiamo tornare al dibattito
statunitense. Con Kennedy prima o poi con Johnson si sviluppò la cosiddetta
affirmative action, con il sistema delle quote che conosciamo. Ad esempio, se si
voleva promuovere l' ingresso dei neri nelle università o in certi luoghi di
lavoro, li si favoriva attribuendo punti in più nelle graduatorie. Sappiamo però
che questo modo di agire ha prodotto l' effetto opposto a quello che si voleva
ottenere. Io in realtà sono anche abbastanza favorevole ad azioni positive, ma
non all' azione penale».
Giancarlo Coraggio, presidente della Consulta, ha
detto ieri che sui «nuovi diritti» anche la corte Costituzionale deve
intervenire se la politica non provvede a garantirli. Ma non si rischia così di
scavalcare il Parlamento?
«Il punto è che se lasci una sedia vuota prima o
poi qualcuno la occupa. Se la politica non interviene, allora scatta l' azione
di supplenza da parte dei giudici costituzionali e pure dei giudici comuni. Ad
esempio sulla stepchild adoption esistono varie sentenze. Emblematico in questo
senso è il caso che ha riguardato Marco Cappato. È un effetto a catena. In
Parlamento c' è un proliferare di commissioni i cui poteri sono quelli dell'
autorità giudiziaria. Mentre il legislatore si occupa di azioni giudiziarie, l'
autorità giudiziaria si occupa di legiferare».
Curioso cortocircuito. In conclusione, mi pare di
capire che secondo lei il ddl Zan non sia necessario.
«Io credo che, in generale, ci sia bisogno di
sottrarre, non di aggiungere; di usare la gomma e non la matita. E non vale solo
per le leggi».
Verissimo, la confessione
dolorosa di Alessandro Zan: "Non avevo neanche cinque euro".
Libero Quotidiano il 06
novembre 2021. Ospite di Verissimo Alessandro Zan. Dopo aver incassato in Senato
la sconfitta del suo ddl contro l'omotransfobia, l'esponente del Partito
democratico ha promesso a Silvia Toffanin che la battaglia continua. "Ho
conosciuto la paura quando mi sono reso conto che essere gay non era un’opzione
possibile nella società in cui vivevo - ha confidato per poi lasciarsi andare a
dichiarazioni ben più personali -. In famiglia non era accettato e i miei
compagni di classe facevano battute omofobe. L’unica possibilità che avevo era
nascondermi". Zan ha raccontato di aver capito da piccolo di essere omosessuale
e questo lo ha reso oggetto di atti discriminatori. La libertà Zan l'ha trovata
in Inghilterra. Da quel momento il deputato ha deciso di aprirsi con la madre:
"Quando sono tornato ho parlato con mia mamma. Con mio padre, però, è stato una
tragedia: si è messo le mani in faccia e ha detto ‘io non capisco più niente’ e
da lì non ci siamo più parlati. Allora ho deciso di andarmene di casa. Studiavo
e lavoravo, ero arrivato a non avere neanche cinque euro in tasca". Un momento
difficilissimo, superato, però, visto che il padre ha poi deciso di accettarlo:
"Mi ha detto ‘quando ti sposi con un uomo?’ e lì ho capito che lo aveva
accettato. Si è anche impegnato nella mia campagna elettorale".
Chi è il deputato che vuole imporci
la dottrina arcobaleno. Giuseppe De Lorenzo il 7
Maggio 2021 su Il Giornale. Alessandro Zan, omosessuale e attivista Lgbt+, ex
Sel ed ex renziano, è il primo firmatario del ddl sull'omofobia. È il deputato
del momento, il cognome che tutti usano e pochi comprendono. Alessandro Zan,
onorevole Pd, paladino dei diritti Lgbt. Prima che il disegno di legge
sull’omofobia di cui è firmatario diventasse terreno di scontro politico, non è
che fosse davvero noto al grande pubblico di stirpe non veneta. Sul sito dei
deputati Pd, in teoria vetrina ufficiale per gli onorevoli eletti sotto le
insegne dem, la sua pagina è praticamente bianca. Inoltre non ha un sito
ufficiale e di ritratti lui dedicati ne esistono ben pochi. Chi volesse
conoscerlo un po’ deve spulciare su Google per trovare una vecchia pagina del
sito del gruppo parlamentare Pd. Nella foto Alessandro è senza barba, quella che
ora invece lo identifica insieme al capello tirato all’indietro. Dicono sia un
bell’uomo. Tanto che sotto la foto profilo di Facebook, un follower apprezza e
scrive: “Comprendo perché è nato il gruppo a sostegno chiamato ‘Le bimbe di
Zan’”. Si tratta probabilmente di una boutade (non ce n'è traccia), anche perché
sarebbe un controsenso: Alessandro è omosessuale dichiarato, anzi fiero. Nel
2016 un suo intervento alla Camera fece spellare le mani ai colleghi di partito
quando raccontò di come i genitori abbiano accettato e sostenuto il
suo outing senza problemi. Nato a Padova, classe 1973, la militanza politica
inizia sin dalle superiori. Prima si avvicina ai movimenti per la pace, poi
sposa la bandiera arcobaleno per le battaglie Lgbt. Organizza manifestazioni per
i diritti civili, va in piazza, si fa sentire. Ma soprattutto nei primi anni
Duemila s’inventail “Kiss2Pacs”, una sorta di gaia slinguazzata collettiva in
piazza, e i cosiddetti “pacs alla padovana”, il primo registro anagrafico per le
coppie di fatto aperto ai gay. Negli anni è stato presidente dell’Arcigay
Veneto e ancora oggi risulta tra i soci benemeriti del circolo Tralaltro Arcigay
di Padova. Inoltre non nasconde di essere tra i fondatori dell’enorme Padova
Pride Village, il tempio della cultura e del divertimento Lgbt+, una
manifestazione estiva vietata agli omofobi (ma ce l’hanno scritto in faccia?)
che dura da giugno a settembre e che - dicono i politici locali - “ha
surclassato tutte le altre manifestazioni gay”. Zan non è solo ancora oggi un
fervido sostenitore del “più grande evento Lgbt+ d’Italia”, ma risulta essere
anche azionista di maggioranza al 52% della Be Proud srl, cioè la società che si
occupa di organizzarne i dibattiti. Lui all’Espresso ha assicurato di non aver
“alcun ritorno economico” né compensi per il ruolo di amministratore unico di
una società “che non fa alcun tipo di utile”. Ma certo essere a capo di un
evento da 200mila visitatori all’anno non è roba da poco, anche in termini di
ritorno elettorale. Eletto per la prima volta consigliere comunale nel 2004
nelle liste dei Ds, a Padova è stato anche assessore al lavoro, all’ambiente e
alla cooperazione internazionale in quota Sel, il partito di quel Nichi
Vendola che 1996 provò a far passare una legge simile all'attuale ddl. Di quegli
anni, dal 2009 al 2013, Zan ricorda lo sforzo fatto per installare pannelli
fotovoltaici in città (ammazza) e per aver incrementato il flusso di racconta
differenziata (arrabbiete). La prima volta alla Camera risale al 2013, dove
entra subito dopo essersi dimesso dall’assessorato. Eletto nella lista di Sel,
uscirà poco dopo dal partito per finire nel gruppo Misto e appoggiare la salita
a Palazzo Chigi di Matteo Renzi. I suoi avversari lo definiscono un “renziano
che, appena l’ex premier è andato in vacca, ha smesso di essere renziano”. Nel
novembre del 2014 confluisce nel Pd, dove ancora oggi risiede senza più travasi
partitici. Pochi mesi prima, secondo quanto racconta una fonte padovana, “aveva
partecipato alle primarie di coalizione di sinistra per la scelta del sindaco,
d’accordo con l’uomo scelto dal Pd, Ivo Rossi, al solo scopo di portare via voti
al vero avversario di Rossi, tale Roberto Fiore, esponente dell’area riferibile
a coalizione civica”. Questo suo “gesto di lealtà verso il Pd”, sostengono i
detrattori, “è stato ovviamente premiato” con l’accoglienza nel partito e “con
la successiva ricandidatura in Parlamento”. Solo malelingue?
La collega Alessia Rotta lo definisce un “grande
lavoratore”, “attento”, “empatico”, “garbato” e “generoso”. Uno che in
Parlamento si è “sempre occupato del tema dei diritti omosessuali” e che ora col
ddl Zan “mantiene un cammino coerente”. Parole smielate, e ci saremmo sorpresi
del contrario. Anche perché oggi dalle fila piddine Zan muove la sua battaglia
politica contro la Lega per approvare il “suo” disegno di legge e tutti i
colleghi gli danno corda. E poco importa se sull’argomento la maggioranza è
spaccata, quasi a rischio tracollo; poco importa se la Cei e i cattolici
chiedano di rivedere il testo, spaventati dal rischio che possa essere il
cavallo di Troia del gender e dell’utero in affitto nelle scuole; poco importa
se anche giuristi, politologi, femministe e arcilesbiche siano contrari
all’introduzione per legge del concetto di “identità di genere”. Lui è “molto
determinato” e “convinto delle proprie ragioni”. E infatti l’idea di mettere
mano al suo testo non lo entusiasma: “La politica decida, o approvare questo
testo oppure presentare migliaia di emendamenti per affossarla”, dice
perentoreo. Il compromesso ci sarà? Difficile immaginarlo, viste le ultime
dichiarazioni. Nei giorni scorsi, per dire, Zan ha affermato che in Italia “i
gay dalla destra sono ancora visti come persone diverse, da curare”, quando
esistono esponenti omosessuali (e pure elettori) che militano in Lega e FdI. Non
proprio il miglior modo per trovare una mediazione.
Il relatore del disegno di legge si
racconta. Alessandro Zan, dall’outing al Ddl: “Mio
padre non la prese bene, la militanza nata in Erasmus”. Antonio Lamorte su Il
Riformista il 26 Maggio 2021. Alessandro Zan era un deputato del Partito
Democratico pressoché sconosciuto. Almeno prima del Ddl che ha preso il suo
nome, perché relatore del disegno di legge alla Camera. Ddl per “la prevenzione
e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul
sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla
disabilità”. È uno dei temi del momento. Si discute e si dibatte e si litiga
tutti i giorni sul Ddl. Zan, padovano, già nell’amministrazione comunale della
giunta del sindaco Flavio Zanonato, laureato in ingegneria delle
telecomunicazioni, in Parlamento dal 2013 prima con Sinistra e Libertà e quindi
con il Pd, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere del Veneto.
“Prima di fare coming out, ero agitato e impaurito, perché ovviamente il
giudizio dei genitori è importante per ogni figlio. Appena mi sono dichiarato,
mia madre è stata molto tenera e comprensiva, mentre mio padre non l’ha presa
bene. Poi però ha fatto un suo percorso personale, perché anche i genitori
devono fare un percorso di accettazione dei propri figli, e alla fine è
diventato un mio grande sostenitore”, ha raccontato. Si è formato all’Arcigay di
Padova, ha organizzato il Gay Pride del 2002 nella sua città. I Democratici di
Sinistra (Ds) il primo partito cui è stato iscritto. Nessuna violenza
nell’infanzia e nell’adolescenza per il suo orientamento sessuale. Battute,
offese, epiteti quelli sì. “Lo scherno verbale contro la comunità Lgbt+ era ed è
ancora frequentissimo. Anche se, con le nuove generazioni, questo atteggiamento
sta cambiando radicalmente”. A portarlo all’impegno politico l’esperienza
dell’Erasmus in Inghilterra. “Quei mesi mi hanno fatto capire che la società
italiana era, ed è, ancora fortemente machista e patriarcale, mentre
l’esperienza vissuta in Gran Bretagna mi ha fatto capire che un’alternativa è
possibile. Una volta tornato, ho iniziato la mia militanza”. Barricate intanto
in Parlamento di Pd, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali che accusano la Lega
di ostruzionismo. Si sono detti pronti a portare il testo in aula senza
relatore. “Questa legge non sta dividendo l’Italia, piuttosto sta portando allo
scoperto coloro che vogliono un Paese proiettato verso l’Europa sovranista di
Orban e Duda, anziché l’Europa della democrazia e dei diritti”. A Padova, alle
prossime comunali, potrebbe candidarsi Andrea Ostellari, l’onorevole della Lega
che ha frenato il ddl e che ha presentato ieri 170 audizioni. Il Carroccio vuole
modificare il disegno in maniera sostanziale. Non solo la destra, anche parte
del movimento femminista è contrario al Ddl. CHE COS’E’ IL DDL – Il Ddl Zan è un
disegno di legge per “la prevenzione e il contrasto della discriminazione e
della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento
sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”. È stato approvato alla
Camera il 4 novembre e ora è all’esame della commissione Giustizia al Senato.
Accorpa più progetti di legge e integra la Legge Mancino del 1993 contro le
discriminazioni e le violenze per motivi razziali, etnici, religiosi o
nazionali. Non introduce pene nuove ma amplia quelle già esistenti. Gli articoli
sono 10. Il primo articolo definisce i termini per descrivere le categorie
oggetto del disegno. La novità sta nell’identità di genere, che indica
“l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche
se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso
di transizione”. La nozione non modifica la legge sul cambio di genere del 1982
che prevede la modifica del sesso all’anagrafe solo dopo un lungo processo. Il
secondo articolo aggiorna l’articolo 604-bis del codice pensale e punisce
con reclusione da un anno a sei mesi e multa da seimila euro “chi propaganda
idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a
commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi” e con la reclusione da sei mesi a quattro anni
chi “istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Lo stesso articolo
vieta l’organizzazione di movimenti volti alla discriminazione e alla violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il Ddl Zan integra
l’articolo con motivi “fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento
sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”. Il Ddl punisce
l’istigazione e non la propaganda. L’istigazione è considerata un “reato di
pericolo concreto”. L’articolo 4 riguarda la libertà di espressione ed è
definito la “clausola salva-idee”: “Ai fini della presente legge, sono fatte
salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte
legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte,
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti
discriminatori o violenti”. L’articolo 5 si coordina con la legge Mancino. Il 5
applica le norme previste per le “vittime particolarmente vulnerabili”.
L’articolo 7 istituisce la Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia,
la bifobia e la transfobia. L’articolo 8 del Ddl Zan stabilisce altri compiti
all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. L’articolo 9 chiarisce chi
può usufruire delle case accoglienza o dei centri contro le
discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere; centri
già istituiti dal decreto legge 34 del 2020, poi convertito in legge,
finalizzati a proteggere e sostenere le vittime lgbt+ di violenza, anche
domestica. E quindi gli adolescenti malmenati perché gay, lesbiche, bisessuali o
transgender oppure coloro che per gli stessi motivi vengono allontanati o
minacciati dalla famiglia. L’articolo 10 affida all’Istituto nazionale di
statistica e all’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori di
raccogliere dati sulle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
Antonio Lamorte. Giornalista professionista. Ha
frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di
Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di
stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.
Alessandro Zuin per il Corriere del Veneto il 26
maggio 2021. Sarà che ha un cognome di appena tre lettere, così facile da
memorizzare e con un suono quasi onomatopeico, fatto sta che, per essere un
soldato semplice del Parlamento italiano, di questi tempi lo conoscono davvero
in tantissimi: «Ddl Zan» – cioè il disegno di legge contro l’omotransfobia, che
mira a rendere punibile ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sul
genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità –
è diventata una di quelle formule che entrano nel linguaggio comune e, almeno
fino a quando l’argomento continuerà a scaldare gli animi, sono destinate a
rimanerci per un pezzo. Il rapper Fedez, attaccando frontalmente dal palco del
concertone del Primo Maggio la Lega - che osteggia l’approvazione del disegno di
legge, come gran parte del centrodestra - e la Rai, accusata di fare censura
preventiva sull’argomento, gli hanno dato un’eco potentissima, innescando una
colata lavica di reazioni e polemiche. Persino la presidenza della Cei - la
Conferenza episcopale italiana - ha sentito il bisogno, pochi giorni fa, di
prendere posizione sul «Ddl Zan», esprimendosi con un salomonico «modificare,
non affossare». Ma chi è e da dove viene Alessandro Zan, l’esponente padovano
del Pd che, in quanto relatore del provvedimento alla Camera (dove è già stato
approvato, mentre ora si è impantanato al Senato), ha finito per identificare
con il proprio nome la proposta di legge? Nella città del Santo, dove in passato
ha fatto parte dell’amministrazione comunale nella giunta del sindaco Flavio
Zanonato, lo ricordano soprattutto per avere promosso e ottenuto - era la fine
del 2006 - l’istituzione del primo registro anagrafico italiano delle coppie di
fatto, aperto anche alle coppie omosessuali. Ancora prima, nel 2002, era stato
in prima fila nell’organizzazione del Gay Pride nazionale a Padova. Classe ‘73,
una laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, dal 2013 siede in Parlamento,
prima per Sel e poi per il Pd. I colleghi alla Camera lo descrivono come un gran
lavoratore, attento ed empatico verso il prossimo. Da qualche anno, porta
fieramente la barba.
Deputato Zan, avrebbe mai immaginato di dare il
suo nome a una proposta di legge capace di dividere trasversalmente l’Italia?
«Questo ddl porta il mio cognome perché sono stato
nominato relatore alla Camera, ma è una legge di tutti quei colleghi
parlamentari che, da un anno e mezzo, si battono e si impegnano per portarla a
casa. Questa legge non sta dividendo l’Italia, piuttosto sta portando allo
scoperto coloro che vogliono un Paese proiettato verso l’Europa sovranista di
Orban e Duda, anziché l’Europa della democrazia e dei diritti».
Partiamo dalla sua esperienza personale: le è mai
capitato di essere bullizzato da ragazzo o discriminato per il suo orientamento
sessuale?
«Sono stato fortunato: nessuna violenza fisica
pesante, come oggi ancora troppo spesso accade. Ma ho spesso ricevuto battute,
scherzi omofobi, qualche danno alla bicicletta. Devo anche ammettere che la mia
mente li aveva rimossi, poi, in questi ultimi mesi, ascoltando tante storie di
discriminazione, ho ripercorso anch’io quegli anni e ho focalizzato quanto mi
era accaduto».
Nella Padova della sua adolescenza (anni Ottanta)
immaginiamo che certi epiteti rivolti agli omosessuali non fossero così
infrequenti: le è capitato di riceverne?
«Sì, certo. Lo scherno verbale contro la comunità
Lgbt+ era ed è ancora frequentissimo. Anche se, con le nuove generazioni, questo
atteggiamento sta cambiando radicalmente».
C’è stato un momento o un episodio precisi in cui
ha capito che avrebbe dovuto combattere per i suoi diritti e la sua identità?
«L’Erasmus in Inghilterra. Quei mesi mi hanno
fatto capire che la società italiana era - ed è - ancora fortemente machista e
patriarcale, mentre l’esperienza vissuta in Gran Bretagna mi ha fatto capire che
un’alternativa è possibile. Una volta tornato, ho iniziato la mia militanza».
La sua scuola politica qual è stata?
«Ho cominciato nell’Arcigay di Padova, dove ho
capito quanto sia importante l’associazionismo, esperienza culminata con il
Pride nazionale del 2002: Padova fu invasa da decine di migliaia di persone, fu
veramente incredibile. Mentre i DS furono il primo partito a cui mi iscrissi,
un’esperienza politica a cui devo moltissimo e un’ottima scuola».
L’esperienza del Pride Village padovano quanto è
stata importante?
«Ho un grande orgoglio per il Padova Pride
Village: dal 2008 a oggi è stata fatta tantissima strada, ormai è un tutt’uno
con la città. I padovani aspettano con gioia questo evento ogni estate. Siamo
riusciti a coniugare positivamente momenti di approfondimento culturale e
politico con il divertimento. Inoltre, ora è il festival lgbt+ più importante
d’Italia, un vero baluardo dei diritti».
Come si è rivelato ai suoi genitori e all’ambiente
familiare in genere?
«Prima di fare coming out, ero agitato e
impaurito, perché ovviamente il giudizio dei genitori è importante per ogni
figlio. Appena mi sono dichiarato, mia madre è stata molto tenera e comprensiva,
mentre mio padre non la prese bene. Poi però fece un suo percorso personale,
perché anche i genitori devono fare un percorso di accettazione dei propri
figli, e alla fine diventò un mio grande sostenitore. È mancato quattro anni
fa».
È uno sportivo praticante? Esiste una squadra del
cuore?
«Sì, amo fare attività fisica, penso sia
fondamentale, cerco sempre di ritagliarmi del tempo per lo sport. Tuttavia non
seguo nessuno sport in particolare, né tifo per una squadra di calcio».
Ha letto che il leghista Andrea Ostellari, che in
Senato sta frenando con grande applicazione il cammino del «ddl Zan», potrebbe
essere il candidato sindaco del centrodestra nella sua Padova?
«Chiunque sia il candidato del centrodestra, sono
convinto che Sergio Giordani, che sta facendo un ottimo lavoro, sarà
riconfermato sindaco di Padova, una città che sta cambiando ed evolvendo, e che
deve guardare all’Europa, non certo a ottuse ricette sovraniste».
Quanti omosessuali «nascosti» ci sono nelle forze
politiche che osteggiano la sua legge?
«Non ne ho idea. Quello che so è che noi stiamo
facendo questa battaglia di civiltà anche per loro, affinché non ci sia più
nessuno costretto a nascondersi. Questa legge è per tutta la società, non per
una minoranza».
Quando Zan chiese alla Rai di censurare i
cattolici in tv. Stefano Zurlo il 6 Maggio 2021 su Il
Giornale. Il cantore della libertà con il bavaglio fra le mani. Un post del 2013
pescato dal battagliero periodico Tempi accende i riflettori su Alessandro Zan.
Il cantore della libertà con il bavaglio fra le mani. Un post del 2013 pescato
dal battagliero periodico Tempi accende i riflettori su Alessandro Zan, il
politico del momento, autore del ddl sull'omotransfobia al centro delle
polemiche, ancora di più dopo l'esplosione del caso Fedez. Oggi Zan dà lezioni
di galateo e buone maniere politically correct, ma all'epoca sparava al
bersaglio grosso: «Possibile che in Rai se si parla di gay bisogna ricorrere per
forza ad ospiti ultra cattolici e omofobi?». Per la cronaca l'ultrà segnalato da
Zan era l'avvocato Giancarlo Cerrelli, non proprio un passante ma il
vicepresidente dell'Unione giuristi cattolici italiani: l'avevano invitato in
Rai, a Uno Mattina, per discutere del ddl contro l'omofobia presentato da un
altro deputato del Pd, Ivan Scalfarotto, antesignano di quello targato Zan.
Allora la presenza di Cerrelli, contrario alla proposta Scalfarotto, suscitò un
vespaio di polemiche e la componente lbgt dei 5 Stelle si rivolse al
neopresidente della Commissione di vigilanza Rai Roberto Fico per spingerlo a
fare pressioni sui vertici Rai, così da avere ospiti più «accomodanti». Insomma,
la stessa censura denunciata da Fedez, ma otto anni prima e in forma quasi
conclamata, non strisciante ma quasi esibita in nome della lotta ad ogni forma
di prevaricazione verbale. Solo che a farne le spese erano i tradizionalisti,
quelli che nel linguaggio double face di molti politici e opinionisti sono
chiamati gli «oscurantisti» solo perché la pensano diversamente. La libertà è
sempre un esercizio difficile e le opinioni non possono calpestare l'altrui
dignità. Su questo tema Zan ha scritto una lettera al Foglio dai toni
rassicuranti, spiegando che la nuova norma non calpesterà la possibilità di
avere idee in contrasto con il pensiero alla moda: «Un prete in chiesa potrà
sempre dire che l'unica unione è fra un uomo e una donna, come un politico
durante un comizio potrà sempre dire che è contrario alla stepchild adoption».
Ci mancherebbe. Zan aggiunge che verranno perseguite invece le espressioni
offensive, crudeli, insultanti, per esempio contro i gay. Concetti che sfiorano
l'ovvio ma che convincono fino a un certo punto perché i ragionamenti
controcorrente potrebbero essere incasellati come l'anticamera di posizioni
discriminanti e scorrette. Vedremo. Nel 2013 però Zan andava all'attacco di
Cerrelli con quel post a forma di spillo: «Chiederò l'intervento della
Commissione di vigilanza. È impensabile che il servizio pubblico si faccia
megafono di tesi, teorie e personaggi che esprimono opinioni discriminanti e che
si scagliano contro la discussione in corso in Parlamento, senza alcun
contraddittorio politico». Parole allarmanti che suscitano dubbi e retropensieri
listati a lutto sulla capacità di far convivere e rispettare scuole di pensiero
differenti. Certo che non c'è solo la censura gridata da Fedez ma ci sono forme
sottili di emarginazione delle idee che non piacciono agli artisti di successo,
agli intellettuali che stanno sempre dalla parte giusta, ai leader che cavalcano
l'indignazione facile e ai collezionisti di like. Insomma, una specie di censura
al contrario, talvolta strisciante, qualche volta esplicita. Cerrelli fu
invitato ancora da Mara Venier nel salotto di Domenica in ma poi fu congedato
senza tanti complimenti. Una coincidenza? Chissà. L'inappuntabile Zan, che oggi
ringrazia Fedez e gli porta la sua solidarietà, aggiungeva a proposito del
solito Cerrelli: «Per caso quando si parla di questioni legate al cattolicesimo
la Rai invita rappresentanti delle comunità gay per esprimere un'opinione?». Una
domandina suggestiva che, se si riflette, chiude a doppia mandata la complessità
e la ricchezza dell'evento cristiano dentro il ghetto di una speciosissima
questione di genere. Peggio di una discriminazione.
Ddl Zan, smontiamo le bufale della destra
una per una. Simone Alliva su L'Espresso il 3 maggio
2021. “È una norma che non serve”, “Sono gli eterossessuali quelli da
difendere”, “scompariranno la mamma e il Natale”, “ti arrestano se sei contrario
all’utero in affitto”. Tutte falsità della propaganda di destra. Ecco cosa
prevede davvero la norma contro l’odio omotransfobico, punto per punto.
Distratti dal dibattito scatenato dalle parole del rapper Fedez al Concertone
del Primo Maggio, la legge Zan rimane per molti un oggetto distorto. La
confusione sul suo contenuto è grande e porta spesso fuoristrada. Alcune
dichiarazioni arrivate da politici ed esponenti del centrodestra sono pure e
semplici bufale: la cancellazione del Natale, l’accesso all’utero in affitto,
l’ideologia gender nelle scuole. La maggior parte di queste fake-news sono
intenzionali. Lo scopo è quello di intorbidire le acque e avvelenare il
dibattito. Ma la verità dei fatti sull’oggetto, cioè sulla luna (la legge Zan) e
non il dito (Fedez), è proprio nel disegno di legge approvato alla Camera il 4
novembre 2020 e attualmente fermo in commissione giustizia. È un documento di 12
pagine che riporta dieci articoli.
Cosa c’è dentro la legge Zan? La legge mette sullo
stesso piano la discriminazione per orientamento sessuale, identità di genere,
genere, sesso, disabilità a quella razziale, etnica e religiosa. Interviene su
due punti del codice penale e attraverso un'aggiunta alla già esistente legge
Mancino-Reale (del 1992), mira a sanzionare gesti e azioni violenti. Oltre a
reprimere i crimini d’odio misogino, omotransfobico e abilista prevede una serie
di azioni positive che puntano a prevenirli. Di una legge contro l’omotransfobia
nel nostro paese se ne parla esattamente da 25 anni. Analizziamo le più diffuse
fake-news:
“Il nostro ordinamento giuridico già punisce le
aggressioni omotransfobiche”
Falso. Oggi il Codice penale non colpisce le
condotte motivate da omotransfobia ma si può solo sperare - laddove il diritto
dovrebbe dare, nei limiti del possibile, certezze - che venga contestata e
applicata l’aggravante dei “motivi abietti e futili”. Cosa che non avviene
sempre. Inoltre, i reati previsti con formule generali vengono ad assumere un
aspetto diverso e peculiare sotto il profilo criminologico quando colpiscono una
minoranza, arrivando a qualificarsi come "crimini d'odio". L'articolo 3 della
legge Mancino-Reale prevede reati commessi per odio etnico, nazionale, razziale
o religioso. La legge Zan estende questi reati anche alle persone Lgbt, alle
donne e alle persone con disabilità. Il reato d’odio si rivolge proprio contro
quell’individuo e contro la sua differenza allo scopo di annullarla. Dare uno
schiaffo a una persona nell’ambito di una lite non è la stessa cosa che
picchiare una persona perché ebrea. Proprio per questo non si ritiene
sufficiente l’applicazione dell’aggravante dei “motivi abietti e futili”: perché
nel caso dei delitti d’odio non vi è solo una motivazione riprovevole ma un
diverso e ulteriore bene giuridico tutelato. Colpendo una persona in quanto
minoranza, il reo ottiene l’effetto che tutte le persone appartenenti alla
minoranza (esempio: neri, Lgbt, ebrei, persone con disabilità) si sentano
minacciate e abbiano paura. Entra in discussione il diritto alla tranquillità,
alla sicurezza, alla libertà di circolazione di più soggetti. Proprio per questo
si giustifica una reazione dello Stato.
“La legge Zan minaccia la libertà di opinione”
Falso. La proposta di legge Zan punisce solo
l’istigazione e il compimento di atti discriminatori e violenti. L’articolo 4
della proposta di legge chiarisce che sono fatte salve le opinioni che non siano
idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori
o violenti.
È vero che la legge Zan estende la legge
Mancino-Reale, ma non la estende al reato di "propaganda di idee fondate
sull’odio etnico e razziale” (art. 604 bis c.p.). Facciamo un esempio: il
giudice potrebbe applicare l’aggravante Zan a un’associazione che pubblicando la
foto di un attivista gay invita i suoi seguaci a linciarlo. Non a un cittadino
che potrà ancora liberamente dire: “Le persone omosessuali sono malate”,
“l'utero in affitto è un abominio”, “il matrimonio omosessuale è sbagliato”.
Giuridicamente si rispetta quel confine sottile tra determinatezza e
indeterminatezza, quello che caratterizza il reato di diffamazione per
intenderci, e riserva dunque ai gruppi anti-Lgbt quella libertà di pensiero
presente anche nell’articolo 21 della nostra Costituzione. Determinare un
soggetto, metterlo all'indice e invitare alla discriminazione è un reato già
ampiamente condannato dal già citato reato di diffamazione. Con la legge Zan,
potrebbe diventare "aggravato" in caso di soggetti vulnerabili come le persone
Lgbt, le persone con disabilità, le donne.
Questo perché la proposta sui diversi reati,
previsti dallo stesso articolo 604 bis, di “istigazione a commettere atti
discriminatori o violenti” e sul “compimento” di quei medesimi atti, si
estendono al caso di condotte motivate da genere, orientamento sessuale, sesso,
disabilità e identità di genere. La condotta istigatoria è quella suscettibile
di determinare il “concreto pericolo” del compimento di quegli atti. Dunque, non
ogni opinione sarà oggetto della norma penale, ma solo l’opinione istigatoria
che – determinando un concreto pericolo di compimento di atti discriminatori o
violenti – leda l’identità personale altrui, in relazione al genere,
all’orientamento sessuale o all’identità di genere.
I nostri giudici sono particolarmente chiari sul
punto: il diritto di esprimere il proprio pensiero non è assoluto ma può essere
limitato per proteggere “i diritti e le libertà altrui”. Insomma, anche nel caso
di critica politica - che pur rende ammissibile una maggiore asprezza nei toni e
nelle parole - devono essere pienamente rispettati i limiti della “verità” e
“dell’interesse sociale” (come riportato negli articoli 9 e 10 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre del 1950).
Il bilanciamento deve dunque essere effettuato tra
la libertà di esprimere il proprio pensiero, da un lato e la necessità di
garantire comunque il rispetto della dignità umana e dell’uguaglianza di tutti i
cittadini a prescindere dalle caratteristiche personali e sociali. Un giusto
equilibrio tra libertà e dignità, tra libertà e persona. In questo senso,
spiegano i nostri giudici, le norme in tema di discriminazione razziale
costituiscono anche l’applicazione del fondamentale principio di uguaglianza
(indicato nell’articolo 3 della Costituzione), sicché è ampiamente giustificato
il sacrificio del diritto di libera manifestazione del pensiero.
Insomma, tutti possiamo esprimere la nostra
opinione, purché nel limite del rispetto degli altri e in ossequio a un
principio che dovrebbe ispirare sempre l’azione politica di chi occupa posti di
potere, la guida è nell’articolo 3 della Costituzione che è una garanzia di
tutela dall’odio.
“La legge Zan introduce l’ideologia gender nelle
scuole”
Falso. La legge Zan prevede la strategia Nazionale
attivata dall'UNAR, l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali del
dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei
ministri. Sono già presenti oggi interventi anti-discriminazioni negli ambiti
dell’educazione e dell’istruzione, del lavoro, della sicurezza e delle carceri.
Spesso vanno sotto il nome di “corsi di educazione al rispetto”. La legge Zan
punta sulla cultura, quella che serve veramente per arginare il fenomeno
dell'omotransfobia. Un lavoro in sinergia con le associazioni
anti-discriminazioni già rodato da anni. Arcigay, ad esempio, a Siena, organizza
‘Orientiamoci alle differenze’, progetto di formazione per operatori di
sportello specializzati in tematiche Lgbt. Ma anche ‘Prof Presente’ corso
gratuito per gli insegnanti che offre strumenti per prevenire o affrontare il
bullismo omotransfobico. Nessuna ideologia gender, solo educazione al rispetto.
I corsi sono già riconosciuti dalle alte istituzioni da più di vent’anni. Nel
2011 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano conferì ad
Arcigay-Trieste una medaglia di bronzo per il progetto “A Scuola per
conoscerci”, realizzato in Friuli-Venezia Giulia. Dopo dieci anni di impegno
contro il bullismo la giunta guidata dal leghista Massimiliano Fedriga ha dato
lo stop al progetto.
“L’identità di genere introdotta dalla legge Zan
cancellerà le donne”
Falso. Basti pensare che tra le caratteristiche
personali che possono determinare discorsi e crimini d’odio nella legge Zan è
stato aggiunto, accanto al genere, proprio il sesso, per nominare anche tale
componente dell’identità personale. Il concetto di identità di genere non è
astratto ma già presente nella giurisprudenza, lo si trova nell’ordinamento
penitenziario ( articolo 1, legge 354/1975. Articolo 14, ultimo comma). Lo si
riscontra nell’articolo 8 (comma 1, lett. d) del decreto legislativo n.
251/2007 in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, a proposito
della nozione di gruppo sociale perseguitato. Più recentemente possiamo leggere
il termine “identità di genere” nella sentenza n 221/2015 della Corte
Costituzionale, a proposito della legge n. 164/1982, in materia di
rettificazione dell’attribuzione di sesso. E ancora anche nei trattati
internazionali (su tutti, la Convenzione di Istanbul) o nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’identità di genere non è dunque
un’invenzione della proposta di legge Zan, ma è un concetto ampiamente presente
nel nostro ordinamento. Il suo riconoscimento riporta alla “necessità di un
accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell’intento, ma anche
dell’intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere emersa nel
percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza
l’intento così manifestato” (è ancora la Corte costituzionale, sent. n.
180/2017). Il termine viene ripreso dalla proposta di legge Zan per proteggere
le persone trans oggetto di comportamenti discriminatori e violenti fondati
sull’odio verso la loro condizione personale. La definizione di identità di
genere contenuta all’articolo 1 della proposta di legge Zan è coerente con la
nozione di identità di genere propria dell’ordinamento vigente: si parla,
infatti, di: “identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al
genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver
concluso un percorso di transizione”. Spesso a questa obiezione si aggiunge
quella che la legge Zan nominando “l’identità di genere” possa consentire alle
persone transessuali, transgender e non binarie di scardinare il vigente sistema
di rettificazione anagrafica del sesso. Non è così. La proposta Zan riguarda il
contrasto della discriminazione e della violenza, contiene disposizioni penali
che devono essere formulate nel modo più preciso possibile e, soprattutto,
essere adatte a colpire discorsi e crimini d’odio lì dove si manifestano,
riconoscendo il motivo specifico per il quale si manifestano. E l’identità di
genere è uno di questi motivi, le persone transgender del resto, sono il 70%
delle persone aggredite.
La legge Zan assimila le donne a una minoranza da
proteggere, quando invece sono la maggioranza
Falso. La proposta di legge Zan non tutela
minoranze, ma dimensioni dell’identità personale, compresi il sesso e il genere,
rispetto a discriminazioni, violenza e odio.
Sul piano penale, non considera (o aggrava) reati,
sulla base di chi ne sia vittima: colpisce il movente d’odio, e dunque le
specifiche ragioni di una condotta, dovute alle condizioni personali della
vittima.
“La legge Zan discrimina le persone eterosessuali.
Serve una legge contro l’eterofobia”
Falso. La proposta Zan è già una legge contro le
vittime di eterofobia. Cioè quegli etero aggrediti da persone Lgbt (le cronache
sono asciutte di questi crimini d’odio ma l’obiezione viene dal leader leghista
Matteo Salvini). La proposta Zan tutela le vittime per “orientamento sessuale” e
questa espressione include tutti gli orientamenti, compreso quello
eterosessuale.
“La Legge Zan cancellerà la festa della mamma, i
presepi, il natale, i canti”
Falso. La legge Zan prevede l'istituzione della
giornata mondiale contro l'omotransfobia il 17 Maggio. Si celebra nel mondo dal
2004. Il 17 maggio 1990 è stata una giornata di svolta nella storia della
civiltà: l'Organizzazione mondiale della Sanità, cioè l'organismo a cui la
comunità internazionale affida il compito di stabilire le conoscenze cardine
sulla salute della popolazione planetaria, ha depennato l'omosessualità
dall'elenco delle malattie mentali. In Italia, ogni anno, il Presidente della
Repubblica, il Presidente del Consiglio e i Presidenti di Camera e Senato
rilasciano dichiarazioni a riguardo. La legge Zan prevede che, in occasione
della Giornata mondiale contro l’omotransfobia, le scuole organizzino attività
di sensibilizzazione per «contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le
violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere». Quindi
prevenire atti di bullismo e discriminazioni. Non avrà carattere di festività e
le iniziative si svolgeranno nel rispetto dell'autonomia scolastica della
corresponsabilità educativa con le famiglie.
“La legge Zan introduce l’utero in affitto”
Falso. Questa è una legge sulle aggressioni.
Inoltre, in Italia la “gestazione per altri”, definita da altri “utero in
affitto”, non è legale.
"No all'identità
di genere", "Urgente": il ddl Zan divide tutti.
Francesco Curridori il 6
Maggio 2021 su Il Giornale. Per la rubrica Il bianco e il nero abbiamo sentito
le opinioni di Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay, e della giornalista
Marina Terragni. Il ddl Zan continua a far discutere, anche all'interno del
campo della sinistra. A tal proposito, per la rubrica Il bianco e il
nero abbiamo sentito le opinioni di Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay
per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale, e della scrittrice e
giornalista Marina Terragni.
Cosa pensa del ddl Zan?
Marrazzo: "La legge contro
l’omotransfobia, è una legge che affronta temi urgenti e che ha recepito istanze
importanti e riprende molti articoli suggeriti anche da me, elaborati sulla base
dell'esperienza maturata nei molti anni passati nel mondo dell'associazionismo
LGBT, è utile ma deve marciare nella giusta direzione. Infatti, presenta
criticità che vanno risolte per non risultare controproducenti, come l'art.4 che
consente di definire malati ed inferiori le persone LGBT e l'art.7 che di fatto
blocca le attività formative contro l'omotransfobia nelle scuole. Sappiamo bene
che la Lega di Salvini è contraria alla legge, ma PD, M5S, IV e LEU hanno la
maggioranza in commissione ed al Senato. Quindi, chiediamo che non venga
utilizzata la proposta della Lega come alibi per far passare emendamenti
peggiorativi, anzi i sostenitori dichiarati migliorino la legge, come da noi
indicato rendendola più simile a quella contro il razzismo, eliminando cosi
articoli pericolosi".
Terragni: "Penso che il testo
vada modificato. Ci sono delle cose che non vanno bene, in particolare la
misoginia perché vengono coinvolte le donne che non sono una minoranza e
l'identità di genere perché comporta un impatto molto pesante sulle società dove
viene riconosciuta".
Perché il termine 'identità di
genere' divide?
Marrazzo: "Non direi che è
così. L'identità di genere non é un tema su cui ci si può dividere: ogni
individuo esprime la propria soggettività identificandosi anche in un genere
diverso dal sesso biologico. Secondo me ci sono alcune attiviste che hanno un
atteggiamento un pò ingeneroso e con un fondo di pregiudizio nei riguardi delle
persone trans. È una piccola barriera che supereranno da sole, tutto qui, non
drammatizzerei un fenomeno abbastanza circoscritto".
Terragni: "Divide perché è il
portone d'ingresso al cosiddetto post-umanesimo. Non viene chiarito che
l'identità di genere è il concetto centrale della legge e che si impedisca ogni
forma di discussione pubblica perché riguarda la sessuazione umana, cioè il
fatto che nasciamo con due generi diversi. Si lascia, dunque, libero accesso a
qualunque genere con semplici atti amministrativi. Mi sembra una questione che
vada discussa ampiamente".
Ci possono essere dei rischi
per la parità tra uomo e donna, se passa questa legge?
Marrazzo: "Quale parità'? Oggi
purtroppo non c'è. La legge è fatta per difendere anche le donne vittime di
discriminazione, anzi paradossalmente un uomo potrà usufruire della legge se
discriminato o oggetto di violenza di genere! Ma non capita spesso".
Terragni: "Non è in questione
la parità. Ci sono dei rischi perché il fatto che ognuno possa decidere
liberamente decidere di essere uomo o donna tocca la radice dell'umano e non può
essere approvato in fretta e furia e clandestinamente".
Si potrebbe migliorare il ddl
Zan? E, se sì, come?
Marrazzo: "Certo, ci possono
essere molte migliorie, ma come appena detto, bisognerebbe almeno eliminare
l'art.4 perché è superfluo ed ambiguo, con ipocrite circonlocuzioni per
inzuccherare la pillola. La libertà di pensiero è garantita dall'art.21 della
Costituzione. Ma non è prevista la licenza di offendere. Considerare inferiore
un popolo rispetto ad un altro è razzismo, considerare le donne inferiori
rispetto agli uomini è maschilismo, ma disprezzare gli LGBT, che è
omo-bi-transfobia, secondo l'art.4 si puo', basta non provocare reazioni
concrete di odio riconducibili a tali affermazioni. Ossia cosa quasi impossibile
da provare, perché se uno dice una frase discriminatoria, poi qualcuno dovrà
provare che una persona che lo ha sentito compie contestualmente una
discriminazione, come si fa? Si devo pedinare per giorni tutti coloro che lo
hanno sentito?. Quindi, a causa di questo articolo, di noi LGBT si può anche
dire che siamo malati, come se la definizione di malattia o normalità fosse
un'opinione personale e non una condizione definita dalla scienza. La quale ha
stabilito tramite L'O.M.S. nel 1990 che l'omosessualità non è una malattia e nel
2018 che anche la transessualità non lo è. Anche l'art. 7 è mal impostato per la
parte che riguarda la scuola. Infatti rispetto ad oggi rende più difficili
interventi educativi sia organici che estemporanei. Contro il bullismo
omotransfobico dilagante ci vorrebbe un'educazione al rispetto verso le
differenze, ma ci vengono a dire che con questa scusa vogliamo introdurre la
fantomatica ed assurda teoria gender, che semplicemente non esiste, è una truffa
culturale. Nelle scuole va solo fatto capire che le persone LGBT non vanno
discriminate, ma accolte. Lo dovrebbe fare l’educazione civica. Invece, per
l’art. 7 se succede un episodio di discriminazione o di bullismo non si potrà
intervenire subito nella scuola, perché servirà un progetto che entri nel piano
triennale e sia approvato da tutti i genitori! Mentre oggi basta solo
l’approvazione del consiglio di istituto che rappresenta già genitori, studenti
e docenti".
Terragni: "Si deve levare ogni
riferimento alla misoginia e all'identità di genere e si devono consentire corsi
Lgbt che sono già presenti nelle scuole lasciando la libertà ai genitori di
decidere se mandare i propri figli a questi corsi oppure no".
Teme che le femministe
contrarie al ddl Zan possano fare il gioco degli ultracattolici?
Marrazzo: "Lo stanno già
facendo, spero che se ne accorgano. Concludo: nonostante la società civile
accetti, comprenda e rispetti il pluralismo culturale, razziale, sociale, ecc,
permane in certe persone un retaggio dei pregiudizi tradizionali difficile da
estirpare perché spesso inconscio. Non solo sugli LGBT ma anche su donne,
migranti e non solo. Quante volte ci sentiamo dire: 'io non sono razzista
ma....'. 'Io ho tanti amici gay ma...'. Finché non cambia questa mentalità, un
minimo di rispetto dell'altro deve essere imposto per legge e, in mancanza,
sanzionato. Come il codice della strada, per poter circolare tutti senza troppi
incidenti. O come il "Politically Correct", che è una forma di tutela sociale
non violenta".
Terragni: "Noi non facciamo il
gioco di nessuno. Noi ascoltiamo la nostra coscienza e conosciamo bene il
concetto dell'identità di genere che in altri Paesi, come la Gb, è già stato
abolito. La destra farà la sua battaglia, noi faremo la nostra. La differenza è
che la destra non vuole la legge tout-court, mentre noi vogliamo la legge ma
senza il riferimento all'identità di genere come in Spagna, in Germania e in
altri Paesi".
Ddl Zan, la Lega chiama come “esperti”
periti agrari, curatori di gay e sacerdoti. Ma anche
Platinette, il presidente di Pro Vita e l’infettivologa che vedeva nelle unioni
civili la causa dell’Hiv. Ecco chi sono i 170 chiamati dal presidente della
Commissione Giustizia Andrea Ostellari a esprimersi sulla legge contro
l’omostransfobia. Simone Alliva su L'Espresso il 25 maggio 2021. C’è la
negazionista, il curatore, il gay in astinenza. La drag queen leghista, il
figlio del leader di Forza Nuova e il perito agrario. È destinata a far
discutere la lista dei 170 “esperti” presentata dal Presidente della Commissione
Giustizia, Andrea Ostellari, che dovranno pronunciare un parere “tecnico”
sul ddl Zan contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. “Casa
Ostellari”, l’ha definita Monica Cirinnà riferendosi al numero altissimo di
auditi che rischia di allungare i tempi di una discussione che ha subito freni e
contraccolpi. Una mossa che “ha come unica finalità quella di affossare la
legge” commenta Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico e capogruppo
in Commissione Giustizia. A scorrere la lista però il colpo d’occhio è da
baraccone ambulante per via dei nomi che poco hanno a che fare con l’esperienza
tecnica-scientifica richiesta per esprimersi su un provvedimento di legge. Da
Platinette (alias Mauro Coruzzi) a Nino Spirlì, presidente facente funzioni
della Calabria ("Dirò negro e frocio fino alla fine dei miei giorni, la lobby
frocia vuole toglierci le parole”). Tra i nomi spicca quello di Giorgio Ponte,
richiesto dal centro-destra in quanto “scrittore”. Ponte è noto alle cronache
per una lettera pubblicata dal settimanale Tempi nel 2015, l'uomo si era
definito omosessuale e felice di non avere gli stessi diritti di tutti gli
altri, affermando che la sua «condizione» avesse «cause psicologiche» e che
necessariamente dovesse essere modificata o ignorata attraversare la totale
astinenza. Ci sarà spazio anche per ascoltare Chiara Atzori, professione
infettivologa, il centro-destra chiede dunque un parere su una legge di
contrasto ai crimini d’odio a alla dottoressa che nel 2008 scatenò un mare di
polemiche quando, dai microfoni di Radio Maria, sostenne che
la “normalizzazione” dell’omosessualità (ovvero unioni civili e matrimoni
egualitari) fosse la causa dell’aumento delle infezioni da HIV”. Chiara Atzori
ha curato la prefazione del libro “Omosessualità maschile: un nuovo approccio”
testo dell’americano Joseph Nicolosi, il padre di tutte le terapie riparative, e
collabora con il gruppo Chaire, un gruppo di cristiani che vuole “confutare gli
argomenti dei propagandisti dell’ideologia gay” e che dicono di poter rendere
eterosessuali i gay. Dall’universo anti-Lgbt del Family Day non manca nessuno:
c’è Toni Brandi, presidente di Pro-Vita e Famiglia. C’è Marina Casini per Il
Movimento per La Vita. E ancora Jacopo Coghe sempre di Pro-Vita, Rachele Ruiu,
di Generazione Famiglia. Immancabile Massimo Gandolfini, audito come
neuro-chirurgo ma noto come portavoce del Family Day, nel 2015 offrì la sua
soluzione al suicidio di moltissimi giovani gay a causa dell’omofobia:
“Spingiamoli all’eterosessualità”. L’omosessualità non è più ritenuta una
malattia da 31 anni, in Aula al Senato tuttavia è prevista anche l’audizione
di Tonino Cantelmi, psichiatra di area cattolica e vicino alle istanze del
Family day e dei movimenti anti-gay italiani. Nel 2013 in un documento
pubblicato sul sito dell’onorevole Paola Binetti, in merito al ddl sull’omofobia
allora in discussione alla Camera dei Deputati (contro cui prese posizione), in
un suo articolo dichiarava: «Nella sua attuale formulazione, questa legge
potrebbe impedire un approccio clinico-terapeutico, ledendo la libertà di cura
del medico e dello psicologo (fatte salve le prescrizioni già previste
nell’ordinamento deontologico delle professioni interessate), e soprattutto del
paziente stesso». Cantelmi, in seguito alla pubblicazione dell’articolo ha
inviato a L’Espresso una nota in cui precisa: «All’epoca (2013, ndr) la mia
preoccupazione era circa l’impatto che la formulazione di allora avrebbe potuto
avere sulla libertà di ricerca clinica. In effetti successivi emendamenti e
cambiamenti hanno accolto le mie osservazioni e attualmente, tranne alcune
problematiche terminologiche (identità di genere), non ho grandi riserve
sull’attuale formulazione del DDL Zan». Riccardo Cascioli, audito in qualità di
semplice “giornalista” è in realtà direttore responsabile de “La Nuova Bussola”,
sito ultracattolico che miscela complottismi gender e teorie no-vax. Alessandro
Fiore, si presenterà in qualità di giurista. In realtà è militante di Pro-vita,
figlio del più noto Roberto Fiore, leader di Forza Nuova. In questo girone di
cariche omesse c’è anche la co-fondatrice delle “Sentinelle in Piedi”, Raffaella
Frullone presentata nella lista come “giornalista esperta”. Gaetano Montante,
infine si presenta a nome dell’ “Assemblea di Dio in Italia” sul proprio sito
raccoglie video di presunti "ex-gay" prodotti da organizzazioni americane
commerciali come la PPfox. Immancabili sono anche i vari link che rimandano ad
articoli del Narth (National Association for Research and Therapy of
Homosexuality) di Joseph Nicolosi al fine di sostenere che «l’omosessualità è un
disturbo dell’identità Sessuale. Un disordine che può essere rimesso in ordine
se l’individuo decide di riordinare la propria vita secondo il disegno del
Creatore». Massimo Polledri è invece ex deputato leghista. Viene presentato per
le sue esperienze in psichiatria e neuropsichiatria con l’onlus “Umanitaria
Padana”: “L'omosessualità può essere una condizione di infelicità che può anche
essere reversibile” aveva sostenuto ai microfoni di Radio 24 nel 2012. Il 31
marzo 2011 in aula alla collega con disabilità Ilaria Argentin del PD urlò:
“Stai zitta handicappata del cazzo”. E il 23 giugno 2011 sussurrò in diretta
radiofonica a Pina Picierno, deputata del Pd, “Se ci caliamo le braghe noi, può
esserci una bella sorpresa per te”. La lista continua, presente l’area
femminista radicale rappresentata da Marina Terragni e Monica Sargetini. Il
leghista Alberto Zelger, consigliere comunale leghista di Verona diventato noto
per le dichiarazioni riportate dal rapper Fedez, sul palco del primo maggio: “Le
unioni civili sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della
specie”. Andrea Williams, capo della Chiesa Cristiana Evangelica d’Inghilterra
noto per le sue posizioni conservatrici e omofobe. E c’è spazio anche per un
perito agrario: Daniele Zampolini, presidente dell’associazione non proprio nota
“Famiglia nel cuore”, che su Facebook conta 235 like.
Non era mai successo prima. Vaticano
contro il ddl Zan, una "nota verbale" per fermare la legge: “Viola il
Concordato”. Carmine Di Niro su Il Riformista il 22 Giugno
2021. Il Vaticano interviene ‘a gamba tesa’ nel già complicato dibattito
italiano sul ddl Zan, disegno di legge contro l’omotransfobia che prende il nome
dal deputato Dem Alessandro Zan, attualmente fermo in commissione Giustizia del
Senato. Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli
Stati della Santa Sede, ha chiesto formalmente al governo italiano di modificare
il ddl Zan poiché “viola il Concordato”. Una mossa che stupisce, quella del
Vaticano: è la prima volta infatti che la Chiesa interviene durante l’iter di
approvazione di una legge, esercitando le facoltà previste nei Patti
Lateranensi. Come riporta il Corriere della Sera Gallagher, di fatto il
‘ministro degli Esteri’ di Papa Francesco, si è presentato lo scorso 17 giugno
presso l’ambasciata italiana in Vaticano consegnando una “nota verbale”, ovvero
una comunicazione formale preparata in terza persona e non firmata, nelle mani
del primo consigliere. Nel testo si legge che “alcuni contenuti attuali della
proposta legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà garantita
alla Chiesa Cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del
Concordato”. Cosa vuol dire? Il riferimento è quei commi del Concordato tra
Santa Sede e Vaticano dl 1984 che assicurano alla Chiesa la “libertà di
organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del
ministero episcopale”, come recita il comma 1, e che garantiscono “ai cattolici
e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di
manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione” col comma 2. L’accusa che arriva dal Vaticano è, pur con un
linguaggio ‘sobrio’, di quelle pesanti: secondo la nota verbale il ddl Zan
attenterebbe alla “libertà di pensiero” della comunità cattolica, oltre alla
“libertà di organizzazione”. Per quest’ultimo caso l’esempio sarebbe l’articolo
7 del ddl Zan, che non esclude le scuole private dall’organizzare attività in
occasione della costituenda Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia
e la transfobia. La mossa del Vaticano, pur straordinaria perché mai prima d’ora
la Chiesa era intervenuta nell’iter di approvazione di una legge italiana, in
parte non sorprende. La Cei, Conferenza episcopale italiana, già due volte è
intervenuta ufficialmente per bocciare il disegno di legge, mosse però
“politiche” e mai arrivate con l’uso ufficiale della diplomazia.
Carmine Di Niro. Romano di nascita ma trapiantato
da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia
Giovanni Viafora per corriere.it il 22 giugno
2021. Il Vaticano ha attivato i propri canali diplomatici per chiedere
formalmente al governo italiano di modificare il «ddl Zan», ovvero il disegno di
legge contro l’omotransfobia. Secondo la Segreteria di Stato, la proposta ora
all’esame della Commissione Giustizia del Senato (dopo una prima approvazione
del testo alla Camera, lo scorso 4 novembre), violerebbe in «alcuni contenuti
l’accordo di revisione del Concordato». Si tratta di un atto senza precedenti
nella storia del rapporto tra i due Stati — o almeno, senza precedenti pubblici
—, destinato a sollevare polemiche e interrogativi. Mai, infatti, la Chiesa era
intervenuta nell’iter di approvazione di una legge italiana, esercitando le
facoltà previste dai Patti Lateranensi (e dalle loro successive modificazioni,
come in questo caso).
La «nota verbale». A muoversi è stato monsignor
Paul Richard Gallagher, inglese, segretario per i Rapporti con gli Stati della
Segreteria di Stato. In sostanza, il ministro degli Esteri di papa Francesco. Lo
scorso 17 giugno l’alto prelato si è presentato all’ambasciata italiana presso
la Santa Sede e ha consegnato nelle mani del primo consigliere una cosiddetta
«nota verbale», che, nel lessico della diplomazia, è una comunicazione formale
preparata in terza persona e non firmata. Nel documento — pur redatto in modo
«sobrio» e «in punta di diritto» — le preoccupazioni della Santa Sede: «Alcuni
contenuti attuali della proposta legislativa in esame presso il Senato — recita
il testo — riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall’articolo 2,
commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato».
I commi. Questi commi sono proprio quelli che,
nella modificazione dell’accordo tra Italia e Santa Sede del 1984, da un lato
assicurano alla Chiesa «libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di
culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale» (è il comma 1); e,
dall’altro garantiscono «ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni
la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione» (il comma 2). E sono i veri nodi della
questione.
«Libertà a rischio». Secondo il Vaticano, infatti,
alcuni passaggi del ddl Zan non solo metterebbero in discussione la sopracitata
«libertà di organizzazione» — sotto accusa ci sarebbe, per esempio, l’articolo 7
del disegno di legge, che non esenterebbe le scuole private dall’organizzare
attività in occasione della costituenda Giornata nazionale contro l’omofobia, la
lesbofobia e la transfobia —; ma addirittura attenterebbero, in senso più
generale, alla «libertà di pensiero» della comunità dei cattolici. Nella nota si
manifesta proprio una preoccupazione delle condotte discriminatorie, con il
timore che l’approvazione della legge possa arrivare persino a comportare rischi
di natura giudiziaria. «Chiediamo che siano accolte le nostre preoccupazioni», è
infatti la conclusione del documento consegnato al governo italiano.
Cosa succede. Il giorno stesso, a quanto risulta
al Corriere, la nota sarebbe stata consegnata dai consiglieri dell’ambasciata
italiana presso la Santa Sede al Gabinetto del ministero degli Esteri di Luigi
Di Maio e all’Ufficio relazioni con il Parlamento della Farnesina. E ora si
attende che venga portata all’attenzione del premier Mario Draghi e del
Parlamento. Ma cosa potrebbe succedere adesso? In teoria, stando al Concordato,
potremmo essere davanti anche all’ipotesi in cui, di fronte ad un problema di
corretta applicazione del Patto, si arrivi all’attivazione della cosiddetta
«commissione paritetica» (prevista dall’articolo 14). Ma è presto per trarre
conclusioni. L’unica cosa certa è che siamo oltre ad una semplice moral suasion.
Il salto di qualità. Il punto, come detto,
riguarda proprio il «livello» su cui la Santa Sede ha deciso, questa volta, di
giocare la partita. Le critiche della Chiesa al «ddl Zan» non sono certo nuove.
Sul tema la Cei è già intervenuta ufficialmente due volte: la prima nel giugno
del 2020 («Esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni
comportamento violento o persecutorio», dissero all’epoca i vescovi); e la
seconda non più tardi di un mese e mezzo fa («Una legge che intende combattere
la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con
l’intolleranza», era stata la nota del presidente Gualtiero Bassetti). Per non
parlare delle singole prese di posizione («È un attacco teologico ai pilastri
della dottrina cattolica», ha affermato di recente, per esempio, il vescovo di
Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta»). Ma si è sempre trattato di pur legittime
prese di posizione «esterne», «politiche». Come le tante, dirette e indirette,
cioè mediate dai partiti di riferimento, registrate negli anni (nel 2005 il
cardinal Ruini arrivò a schierarsi pubblicamente a favore dell’astensionismo nel
voto referendario sulla fecondazione assistita). Ma mai si era attivata la
diplomazia. Mai lo Stato Vaticano era andato a bussare alla porta dello Stato
Italiano chiedendo conto, direttamente, di una legge.
Omofobia: Letta, sosteniamo ddl, pronti a
dialogo su nodi. (ANSA il 22 giugno 2021) "Noi
sosteniamo la legge Zan e, naturalmente, siamo disponibili al dialogo. Siamo
pronti a guardare i nodi giuridici ma sosteniamo l'impianto della legge che è
una legge di civiltà". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a "Radio
anch'io" su Radio Rai 1 a proposito della notizia riportata dal Corriere della
Sera di una iniziativa della Santa Sede contro il disegno di legge Zan contro
l'omotransfobia in quanto violerebbe il Concordato.
Giovanni Viafora per il "Corriere della Sera" il
22 giugno 2021. Il Vaticano ha attivato i propri canali diplomatici per chiedere
formalmente al governo italiano di modificare il «ddl Zan», ovvero il disegno di
legge contro l'omotransfobia. Secondo la Segreteria di Stato, la proposta ora
all' esame della Commissione Giustizia del Senato (dopo una prima approvazione
del testo alla Camera, lo scorso 4 novembre), violerebbe in «alcuni contenuti
l'accordo di revisione del Concordato». Si tratta di un atto senza precedenti
nella storia del rapporto tra i due Stati - o almeno, senza precedenti pubblici
-, destinato a sollevare polemiche e interrogativi. Mai, infatti, la Chiesa era
intervenuta nell' iter di approvazione di una legge italiana, esercitando le
facoltà previste dai Patti Lateranensi (e dalle loro successive modificazioni,
come in questo caso). A muoversi è stato monsignor Paul Richard Gallagher,
inglese, segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. In
sostanza, il ministro degli Esteri di papa Francesco. Lo scorso 17 giugno l'alto
prelato si è presentato all' ambasciata italiana presso la Santa Sede e ha
consegnato nelle mani del primo consigliere una cosiddetta «nota verbale», che,
nel lessico della diplomazia, è una comunicazione formale preparata in terza
persona e non firmata. Nel documento - pur redatto in modo «sobrio» e «in punta
di diritto» - le preoccupazioni della Santa Sede: «Alcuni contenuti attuali
della proposta legislativa in esame presso il Senato - recita il testo -
riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall' articolo 2, commi 1 e
3 dell'accordo di revisione del Concordato». Un passaggio delicatissimo. Questi
commi sono proprio quelli che, nella modificazione dell'accordo tra Italia e
Santa Sede del 1984, da un lato assicurano alla Chiesa «libertà di
organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del
ministero episcopale» (è il comma 1); e, dall' altro garantiscono «ai cattolici
e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di
manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione» (il comma 2). E sono i veri nodi della questione. Secondo il
Vaticano, infatti, alcuni passaggi del ddl Zan non solo metterebbero in
discussione la sopracitata «libertà di organizzazione» - sotto accusa ci
sarebbe, per esempio, l'articolo 7 del disegno di legge, che non esenterebbe le
scuole private dall' organizzare attività in occasione della costituenda
Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia e la transfobia -; ma
addirittura attenterebbero, in senso più generale, alla «libertà di pensiero»
della comunità dei cattolici. Nella nota si manifesta proprio una preoccupazione
delle condotte discriminatorie, con il timore che l'approvazione della legge
possa arrivare persino a comportare rischi di natura giudiziaria. «Chiediamo che
siano accolte le nostre preoccupazioni», è infatti la conclusione del documento
consegnato al governo italiano. Il giorno stesso, a quanto risulta al Corriere,
la nota sarebbe stata consegnata dai consiglieri dell'ambasciata italiana presso
la Santa Sede al Gabinetto del ministero degli Esteri di Luigi Di Maio e all'
Ufficio relazioni con il Parlamento della Farnesina. E ora si attende che venga
portata all' attenzione del premier Mario Draghi e del Parlamento. Ma cosa
potrebbe succedere adesso? In teoria, stando al Concordato, potremmo essere
davanti anche all' ipotesi in cui, di fronte ad un problema di corretta
applicazione del Patto, si arrivi all' attivazione della cosiddetta «commissione
paritetica» (prevista dall' articolo 14). Ma è presto per trarre conclusioni. L'
unica cosa certa è che siamo oltre ad una semplice moral suasion. Il punto, come
detto, riguarda proprio il «livello» su cui la Santa Sede ha deciso, questa
volta, di giocare la partita. Le critiche della Chiesa al «ddl Zan» non sono
certo nuove. Sul tema la Cei è già intervenuta ufficialmente due volte: la prima
nel giugno del 2020 («Esistono già adeguati presidi con cui prevenire e
reprimere ogni comportamento violento o persecutorio», dissero all' epoca i
vescovi); e la seconda non più tardi di un mese e mezzo fa («Una legge che
intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l'obiettivo
con l'intolleranza», era stata la nota del presidente Gualtiero Bassetti). Per
non parlare delle singole prese di posizione («È un attacco teologico ai
pilastri della dottrina cattolica», ha affermato di recente, per esempio, il
vescovo di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta). Ma si è sempre trattato di pur
legittime prese di posizione «esterne», «politiche». Come le tante, dirette e
indirette, cioè mediate dai partiti di riferimento, registrate negli anni (nel
2005 il cardinal Ruini arrivò a schierarsi pubblicamente a favore
dell'astensionismo nel voto referendario sulla fecondazione assistita). Ma mai
si era attivata la diplomazia. Mai lo Stato Vaticano era andato a bussare alla
porta dello Stato Italiano chiedendo conto, direttamente, di una legge.
Il colpo "segreto" che ha
paralizzato i Dem.
Francesco Boezi l'11 Luglio 2021 su Il Giornale. Una singola nota
verbale del Vaticano ha mandato in confusione democratici e laicisti non solo
sul Ddl Zan, ma su tutta la narrazione ultra-progressista. Un colpo ben
assestato. Una mossa capace di animare il dibattito, rendendo in salita
l'approvazione del Ddl Zan: se l'intenzione del Vaticano era quella di
complicare l'iter del disegno di legge più discusso del momento, quel proposito
ha avuto un seguito di tutto rispetto. Dalla nota diplomatica in poi, la
politica ha avuto un bel da fare. Con una postilla: la Santa Sede ha
dichiarato di non essere contraria alla legge. Il Vaticano ha, al massimo,
domandato modifiche per tutelare la libertà d'espressione prevista anche
nell'ambito del Concordato, che è un trattato internazionale che l'Italia ha il
dovere di rispettare. Lo ha ribadito anche il cardinale Gualtiero Bassetti,
presidente Cei, in un'intervista rilasciata a Repubblica: è stata chiesta una
rivisitazione, non uno stralcio. E poi quella nota, stando alle intenzioni delle
mura leonine, tutto doveva essere tranne che pubblica. Il Partito Democratico è
rimasto comunque spiazzato. Il segretario Enrico Letta ha reagito, erigendo una
barriera contro cui il Ddl Zan potrebbe schiantarsi. Al Nazareno sono in
difficoltà palese. Che i Sacri Palazzi siano maestri di tattica non è mistero.
Che certa politica non spicchi per capacità strategica anche. Il clamore che ha
accompagna questa fase è indicativo: lo scombussolamento riguarda le stesse
certezze su quel provvedimento. Quelle che i Dem non hanno più. Se il Partito
Democratico avesse deciso di mediare, oggi racconteremmo un'altra storia. Ma
tant'è. Martedì è la giornata clou: quella in cui dovrebbe chiarirsi il destino
di una legge che è divenuta il simbolo dello scontro ideologico contemporaneo.
Una discussione politica più elastica avrebbe fatto del Ddl Zan un argomento
magari perfettibile, ma comunque realizzabile. Il Pd ha deciso che questa
possibilità non c'è. Così, la bioetica e i suoi dintorni sono stati elevati a
terreno di scontro. Come accade nel quadro polarizzato degli States, dove quasi
non si parla d'altro, con tutto quello che ne consegue sul clima. In questa
storia, c'è almeno un fraintendimento: Papa Francesco è sempre stato
cristallino in materia. Chi pensava che il pontefice fosse un sostenitore della
cosiddetta "teoria gender" legge poco o sbaglia i calcoli. Inoltre, la
segretezza di quel documento avrebbe dovuto garantire un volo a bassa quota.
Qualcuno (c'è chi parla di "manina") ha optato per la pubblicazione: il resto è
cronaca. Il Vaticano non voleva irrompere sulla scena - come pensano gli
anticlericali - , bensì sollevare alcune questioni, con strumenti appropriati e
in punta di penna. Tanto è bastato a mandare in confusione i teorici del "Papa
progressista". Gli stessi che sono stati smentiti dai fatti. E che ora non
vogliono sentire ragione. I laicisti - dicevamo - hanno replicato con un coro
condito dalle consuete punte di anticlericalismo. Il Vaticano ha posto questioni
giuridiche e di compatibilità tra un'eventuale legge dello Stato ed il
Concordato. Fedez si è domandato "chi ha concordato il Concordato". Sono due
metodi diversi: uno, legittimo, che ha alzato il livello dialettico; l'altro,
sempre legittimo, ma semplicistico, che fa del furore ideologico il suo
substrato. La Santa Sede non sembra temere l'approvazione di una legge che
contrasti e sanzioni l'omotransfobia, anzi. Semmai a preoccupare gli ambienti
ecclesiastici è proprio il terriccio culturale entro cui si muovono i promotori
del Ddl Zan, con le possibili evoluzioni illiberali a fare da sfondo. Una
singola nota diplomatica ha mandato in tilt un intero universo ideologico.
Diventa legittimo chiedersi, come qualcuno si aspettava, cosa sarebbe accaduto
se Papa Francesco avesse manifestato aperto disappunto, affacciandosi su piazza
San Pietro.
Francesco Boezi. Sono nato a
Roma il 30 ottobre del 1989, ma sono cresciuto ad Alatri, in Ciociaria. Oggi
vivo in Lombardia. Sono laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
presso la Sapienza di Roma. A ilGiornale.it dal gennaio del 2017, mi occupo e
scrivo soprattutto di Vaticano, ma tento spesso delle sortite sulle pagine di
politica interna. Per InsideOver seguo per lo più le competizioni elettorali
estere e la vita dei partiti fuori dall'Italia. Per la collana "Fuori dal Coro"
de IlGiornale ho scritto due pamphlet: "Benedetti populisti" e "Ratzinger, il
rivoluzionario incompreso". Per la casa editrice La Vela, invece, ho pubblicato
un libro - interviste intitolato "Ratzinger, la rivoluzione interrotta". Nel
2020, per le edizioni Gondolin, ho pubblicato "Fenomeno Meloni, viaggio nella
Generazione Atreju". Sono giornalista pubblicista.
La nota, gli incontri e il Papa: ecco
cosa è successo in Vaticano. Francesco Boezi il 23
Giugno 2021 su Il Giornale. Il Vaticano reagisce al Ddl Zan. Con l'atto formale
emerso ieri, la Santa Sede rivendica libertà. Ecco cosa si muove in queste ore
tra le mura leonine. Molti si stupiscono perché non se lo sarebbero mai
aspettato. Ma l'atto formale con cui il Vaticano è intervenuto sul Ddl Zan,
oltre a essere legittimo, è in linea con quanto scritto e detto in materia
bioetica (e non solo su quella) durante questo pontificato. La nota verbale di
cui si parla in queste ore è un atto formale. Se la Conferenza episcopale
italiana avesse espresso un parere non sarebbe stato lo stesso, e non avrebbe
fatto il medesimo rumore. Ecco perché, con buone probabilità, la protagonista di
questa vicenda è la Segreteria di Stato. Non solo: visto che l'oggetto della
discussione è divenuto il Concordato, è normale che a intervenire sia il
dicastero presieduto dal cardinale Pietro Parolin. Diviene un discorso di
competenze, cosa che Oltretevere è ancora molto sentita.
La scelta dei tempi. Le tempistiche sono un
fattore da non sottovalutare in questa storia. Sarebbe stata una "interferenza",
come vanno denunciando adesso certi ambienti progressisti, se l'iter
parlamentare fosse appena iniziato. Ma il Ddl Zan è già in discussione, e ad
oggi più di qualche esponente politico di spessore ha già rimarcato la necessità
di approvarlo così com'è. Poi c'è chi come il segretario del Pd Enrico
Letta sembra aver cambiato idea in maniera repentina. Il timing dei sacri
palazzi, insomma, sembra tenere conto pure della politica e dei suoi tempi.
Perché siamo in una fase avanzata.
Quegli incontri nei Sacri Palazzi. Fonti
qualificate hanno riferito a ilGiornale.it di incontri che sarebbero avvenuti
nei giorni scorsi, in particolare di meeting tra la segreteria di Stato ed
esponenti del mondo conservatore. Insomma, qualcuno dotato di un certo peso
politico avrebbe insistito con il "ministero degli Esteri" della Santa Sede con
motivazioni tagliate sulle criticità del Ddl in oggetto. Altre fonti sostengono
che la segreteria di Stato avesse già deciso di agire attraverso una mossa
ufficiale, che si sarebbe declinata nelle asserzioni che vengono accostate a
monsignor Paul Richard Gallagher. Se ne dicono tante. Certo è un evento raro. E
questo forse perché quasi mai una norma aveva messo in discussione il Concordato
nella sua stessa impostazione. Almeno stando ai contenuti della nota che sono
rimbalzati ieri di quotidiano in quotidiano. L'alto ecclesiastico originario di
Liverpool, del resto, avrebbe posto proprio la questione del rispetto del
Concordato, che è un architrave della storia diplomatica italiana e vaticana:
"Alcuni contenuti attuali della proposta legislativa in esame presso il Senato
riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall'articolo 2, commi 1 e 3
dell'accordo di revisione del Concordato". Tra le frasi che abbiamo avuto modo
di leggere, quella sulla libertà garantita alla Chiesa cattolica; è di sicuro
tra le più rilevanti. Roma ne fa pure una battaglia di libertà, quindi.
I protagonisti della vicenda e il ruolo del Papa.
I protagonisti di questa vicenda sono almeno tre. Il primo è il cardinale Pietro
Parolin, teorico e pratico del multilateralismo diplomatico e figura chiave di
questo pontificato. Il secondo è monsignor Paul Richard Gallagher, che sarebbe
l'autore della nota e dunque il consacrato preposto, pure per via del suo status
di segretario per i Rapporti con gli Stati, ad occuparsi in prima persona della
faccenda. Infine, Papa Francesco, che molti associano al progressismo
ideologizzato (quindi indirettamente ad un presunto riguardo verso qualunque
provvedimento provenga da parte progressista), ma che non può non aver letto i
contenuti della nota verbale. Questa storia secondo cui il pontefice argentino
non verrebbe messo al corrente di alcune prese di posizione ufficiali
provenienti dalle mura leonine (o che non le condividerebbe) è ormai
un leitmotiv. In termini di procedure tipiche nelle stanze vaticane, però, è
sostanzialmente impossibile che un atto del genere venga inoltrato senza la
previa visione ed approvazione del pontefice. Vale pure per le benedizioni alle
coppie omosessuali che certi ambienti tedeschi vorrebbero approvare. Jorge Mario
Bergoglio, sin da quando si è seduto sul soglio di Pietro, ha identificato la
cosiddetta "teoria gender" - quella che per i conservatori sarebbe alla base del
Ddl Zan - con qualcosa che andrebbe "contro il progetto di Dio". Ipotizzare che
Francesco la pensi in un modo e la segreteria di Stato in un altro, dunque,
risulta un po' forzato, per usare un eufemismo. Possibile che la Curia viva una
fase di scontro interno? Pensare che all'interno del Vaticano esistano sia
ecclesiastici favorevoli al Dll Zan sia elementi contrari è del tutto naturale.
La Chiesa cattolica, durante questi ultimi decenni, è stata animata da un
pluralismo che coinvolgerà in via indiretta anche certi scossoni legislativi che
la politica avrebbe intenzione di dare. Questo però non può significare che la
segreteria di Stato agisca senza badare al pensiero e alla pastorale del sovrano
pontefice.
Francesco Boezi. Sono nato a Roma il 30 ottobre
del 1989, ma sono cresciuto ad Alatri, in Ciociaria. Oggi vivo in Lombardia.
Sono laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso la Sapienza
di Roma. A ilGiornale.it dal gennaio del 2017, mi occupo e scrivo soprattutto di
Vaticano, ma tento spesso delle sortite sulle pagine di politica interna. Per
InsideOver seguo per lo più le competizioni elettorali estere e la vita dei
partiti fuori dall'Italia. Per la collana "Fuori dal Coro" de IlGiornale ho
scritto due pamphlet: "Benedetti populisti" e "Ratzinger, il rivoluzionario
incompreso". Per la casa editrice La Vela, invece, ho pubblicato un libro -
interviste intitolato "Ratzinger, la rivoluzione interrotta". Nel 2020, per le
edizioni Gondolin, ho pubblicato "Fenomeno Meloni, via...
Paul Richard Gallagher, il diplomatico
vaticano dietro la missiva contro il ddl Zan. Roberto
Vivaldelli il 23 Giugno 2021 su Il Giornale. L'arcivescovo di Liverpool,
nominato da Papa Francesco Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa
Sede, è il firmatario della nota contro il Ddl Zan che sta facendo discutere la
politica italiana. Paul Richard Gallagher, 67 anni, è il responsabile della
diplomazia del Vaticano, Segretario per i rapporti con gli Stati nominato da
Papa Francesco nel 2014. Com'è emerso nelle ultime ore grazie a uno scoop
del Corriere della Sera, con un atto senza precedenti nella storia dei rapporti
tra Vaticano e lo stato italiano, l'arcivescono Gallagher ha firmato la
nota consegnata il 17 giugno scorso nella quale chiede formalmente al governo
italiano di modificare il "ddl Zan", ovvero il disegno di legge contro
l’omotransfobia. Secondo la Santa Sede, infatti, "alcuni contenuti attuali della
proposta legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà garantita
alla Chiesa Cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del
Concordato". Posizione che ha scatenato il dibattito politico italiano e le
prese di posizione dei vari partiti che compongono la maggioranza. Ma chi è Paul
Richard Gallagher? Nato a Liverpool il 23 gennaio 1954, frequenta in gioventù il
collegio "San Francesco Saverio" di Woolton.
Dal 2014 Gallagher è responsabile della diplomazia
vaticana. Dopo il servizio prestato presso l'arcidiocesi di Liverpool, Gallagher
si iscrive alla Pontificia accademia ecclesiastica a Roma, la scuola che forma i
diplomatici della Santa Sede. Dal 1º maggio 1984 diventa ufficialmente membro
della diplomazia della Santa Sede e ricopre incarichi diplomatici per conto del
Vaticano in Tanzania, Uruguay e Filippine. Nel 2000 il grande salto di qualità
nella sua carriera, quando viene nominato da Papa Giovanni Paolo II inviato
speciale con funzioni di Osservatore permanente della Santa Sede presso il
Consiglio d'Europa. Dopo un'esperienza in Australia come nunzio apostolico nel
2012, nel 2014 diventa Segretario per i rapporti con gli Stati per volontà
dell'attuale Pontefice. Come sottolinea il Corriere della Sera, l'arcivescono
inglese è "cordiale, simpatico in privato ma blindato in pubblico, pragmatico,
molto inglese". Sulla politica estera della Santa Sede ha però le idee
chiarissime. Come ricorda proprio il Corriere della Sera, nel recente passato
Gallagher si è schierato contro il ritorno del nazionalismo nel mondo:
"I nazionalismi scatenati hanno la tendenza ad escludere e il Papa ci invita a
fare attenzione ai pericoli insiti nei sovranismi". La Chiesa, sottolineò, "non
ha visioni nazionalistiche, apprezza molto l’amor di patria ma questo deve
essere condito da un senso di apertura verso gli altri". In Vaticano, è uno dei
principali promotori dell'apertura diplomatica alla Cina. Nel febbraio
2020 incontrò, nella cornice importante a margine della Conferenza sulla
sicurezza di Monaco 2020, Munich Security Conferente 2020, Wang Yi, ministro
degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese. "Nel corso del colloquio"
riportava il comunicato della Sala Stampa della Santa Sede "sono stati evocati i
contatti fra le due Parti, sviluppatisi positivamente nel tempo". In
particolare, si è evidenziata l’importanza dell’Accordo Provvisorio sulla nomina
dei Vescovi, firmato il 22 settembre 2018, rinnovando la volontà di proseguire
il dialogo istituzionale a livello bilaterale per favorire la vita della Chiesa
cattolica e il bene del Popolo cinese". Una svolta diplomatica fondamentale,
della quale l'arcivescovo inglese è stato assoluto protagonista. Ora la nota
dell'arcivescovo resa nota dal Corriere della Sera sta facendo discutere la
politica italiana, tutta. E non c'è alcun dubbio che - piaccia o meno - le
parole del responsabile della diplomazia vaticana peseranno come un macigno
nella discussione del Ddl Zan, come dimostra peraltro l'apertura al dialogo da
parte del segretario del Pd, Enrico Letta.
Roberto Vivaldelli. Roberto Vivaldelli (1989) è
giornalista dal 2014 e collabora con IlGiornale.it, Gli Occhi della Guerra e il
quotidiano L'Adige. Esperto di comunicazione e relazioni internazionali, è
autore del saggio Fake News. Manipolazione e propaganda mediatica dalla guerra
in Siria al...
L'arcivescovo e la polemica sul disegno
di legge. Chi è Paul Richard Gallagher, il Segretario di Stato del Vaticano
della nota contro il ddl Zan. Vito Califano su Il
Riformista il 22 Giugno 2021. Paul Richard Gallagher è arcivescovo e segretario
per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Sarebbe stato lui a
muoversi, secondo lo scoop de Il Corriere della Sera, con un documento
consegnato all’ambasciata italiana in Vaticano e quindi al ministro degli
Esteri, per sollevare le preoccupazioni della Santa Sede in merito al disegno di
legge Zan, in esame al Senato, contro discriminazioni e violenze per
orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo. Il compito
ricoperto da Gallagher è quello di una sorta di ministro degli Esteri della
Santa Sede. Parla correntemente l’italiano, il francese e lo spagnolo, oltre che
all’inglese naturalmente. Gallagher infatti è nato a Liverpool nel 1954. È
cresciuto al collegio San Francesco Saverio di Woolton. È stato ordinato
sacerdote nel 1977 e ha conseguito il dottorato in medicina presso la Pontificia
accademia ecclesiastica a Roma. È membro diplomatico della Santa Sede dal 1984,
presso la quale ha cominciato la sua attività in Tanzania, Uruguay e nelle
Filippine. È stato membro della diplomazia della Santa Sede presso il Consiglio
d’Europa, nominato da Papa Giovanni Paolo II; quindi nunzio apostolico in
Burundi, in Guatemala, in Australia. È stato nominato arcivescovo titolare di
Holdelm nel 2004. Dal 2014 è Segretario per i Rapporti con gli Stati, nominato
da Papa Francesco. Gallagher si sarebbe presentato lo scorso 17 giugno
all’ambasciata italiana presso la Santa Sede e al Primo Consigliere avrebbe
consigliato una cosiddetta nota “non verbale”. Lo scoop de Il Corriere della
Sera, se confermato, configurerà un gesto emblematico, senza precedenti: la
prima volta che viene impugnato la revisione del Concordato tra Stato e Chiesa
del 1984. O almeno pubblicamente impugnato. Per la Santa Sede il ddl potrebbe
mettere in discussione l’articolo 2 dell’accordo, e in particolare il comma 1
che assicura alla Chiesa “libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di
culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale”; e il comma 2 che
garantisce “ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena
libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione”. Altro punto di discordia: l’articolo 7 del
disegno di legge che prevede l’istituzione della Giornata nazionale contro
l’omofobia, la lesbofobia e la transfobia che metterebbe in difficoltà le scuole
cattoliche e che gli oppositori del ddl hanno strumentalizzato facendola passare
come un’occasione di propaganda per la Comunità Lgbtq+. Contro il disegno di
legge si era esposta anche la Cei, la Conferenza Episcopale dei Vescovi
Italiani, senza arrivare al livello del dibattito configurato dalla “nota non
verbale” qualora fosse confermata. Immediata la reazione dei promotori e
sostenitori del ddl: la libertà di espressione non viene messa in discussione
dal disegno, hanno spiegato, a differenza di chi si rende protagonista di
episodi che possano incitare alle molestie e alla violenza. Il ddl mantiene
insomma separate la propaganda dall’istigazione, punendo la seconda a differenza
della prima.
Vito Califano. Giornalista. Ha studiato Scienze
della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di
cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e
teatro.
Il ddl Zan mette a nudo la definitiva
debolezza della Chiesa. Carlo Tecce su L'Espresso il
22 giugno 2021. Il Vaticano che impugna il concordato contro il disegno di legge
è un atto contro la storia che umilia la Conferenza episcopale e i presunti
cattolici in politica. Come è successo in passato, anche stavolta perderà. Il
Vaticano che impugna il concordato con lo Stato per chiedere all’Italia
di modificare il disegno di legge contro le discriminazioni di genere, più noto
come ddl Zan, compie un atto di inedita e ormai definitiva debolezza. Com’è
accaduto nell’ultimo mezzo secolo, appena la Repubblica è diventata matura e la
società ha cominciato a rimuovere la cappa di oppressione civile con i
referendum su divorzio e aborto, anche stavolta la Chiesa è destinata a perdere.
Non con l’Italia: con la storia. Il documento ufficiale che il monsignor Paul
Richard Gallagher, il ministro degli Esteri di papa Francesco, ha consegnato
all’ambasciatore italiano presso la Santa Sede per protestare formalmente, come
ha ricostruito nei dettagli il Corriere della Sera, è un doppio messaggio che si
rivolge all’interno più che all’esterno della Chiesa: sancisce il fallimento
politico della Conferenza episcopale italiana, sin dal principio del pontificato
di Jorge Mario Bergoglio delegata a esercitare la sua influenza (o ingerenza)
sui governi e sui partiti; risolve l’equivoco di un Papa troppo progressista (o
secolarizzato) che rischia di provocare uno scisma. Francesco si pone come il
capo di una organizzazione religiosa che si apre al dialogo col mondo, il mondo
nuovo, ma non deroga ai suoi princìpi, ai suoi dogmi, ai suoi scritti. Già sette
anni fa, mentre ancora si scopriva il pontefice argentino che scelse il nome di
Francesco e una croce di ferro, era palese l’approccio diverso rispetto a
Benedetto XVI o Giovanni Paolo II, lo spirito conciliare, il ricordo di Paolo
VI. Però Bergoglio non è il liquidatore di ciò che rappresenta il cattolicesimo:
“Il pensiero dominante – disse – propone una falsa compassione. Quello che si
ritiene sia un aiuto alla donna favorire l’aborto, un gesto di dignità procurare
l’eutanasia, una conquista scientifica produrre un figlio considerato come un
diritto invece di accoglierlo come dono. Aborto, eutanasia e fecondazione: sono
risultati di una falsa compassione, come anche lo è usare vite umane come cavie
di laboratorio per salvarne presumibilmente altre”. Bergoglio intervenne dopo la
sentenza della Consulta che autorizzava la fecondazione eterologa. Da allora si
stima siano nati circa 10.000 bambini.
Quando l’Italia reclamò maggiori diritti, per
esempio con il divorzio, la Chiesa schierò la Democrazia cristiana e il
segretario Amintore Fanfani che, nel comizio conclusivo della campagna
elettorale, si spese con il celebre anatema: “Vostra moglie andrà con la serva”.
Dopo il concordato col governo di Bettino Craxi e il lento crollo della prima
Repubblica e di uno schema consolidato, ci fu il lungo regno del cardinale
Camillo Ruini alla Cei che professò il trasversalismo: non c’erano più un
partit0 di riferimento, ma dei politici di riferimento, sparsi ovunque e capaci
di muoversi quando serve. Fu così che il Pdl trasformò il caso di Eluana
Englaro e l’eutanasia in una profonda e violenta bandiera del centrodestra che
ebbe il suo apice quando l’onorevole Gaetano Quagliariello, fra i banchi di
Montecitorio, gridò all’omicidio. Il 14 dicembre del 2017, l’Italia si è data
una legge, non esaustiva, ma una legge: il testamento biologico, approvato in
Senato dal centrosinistra e dagli odierni alleati dei Cinque Stelle. La Chiesa
ha scarsa aderenza nei partiti se si va oltre le dichiarazioni alle agenzie di
stampa. La Conferenza episcopale italiana ha tentato anche di promuovere un
movimento politico cattolico nel mentre condannava Matteo Salvini baciatore di
santini e corone. Divisa dalle correnti e lontana dalla realtà, monsignor
Gallagher certifica la confusione di una Chiesa che non insegue fedeli, ma
fantasmi.
Il Vaticano contro il ddl Zan. Letta apre
al dialogo, ma il Pd blinda la legge. Dem sulle
barricate per difendere la norma voluta dal deputato Alessandro Zan contro
l'omotransfobia. Quello del Vaticano, che fa ricorso a facoltà previste dai
Patti Lateranensi, è di un atto senza precedenti. Simona Musco su Il Dubbio il
22 giugno 2021. Il Vaticano interviene a gamba tesa nel dibattito politico
italiano, chiedendo di «rimodulare» il ddl Zan «in modo che la Chiesa possa
continuare a svolgere la sua azione pastorale, educativa e sociale liberamente».
Un intervento invocato attraverso una nota verbale informale, consegnata da
monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della
Segreteria di Stato Vaticana, all’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede il
17 giugno 2021, in quanto il testo violerebbe, in alcuni punti, «l’accordo di
revisione del Concordato», come riportato ieri dal Corriere della Sera. Una
richiesta che, dunque, ha riacceso il dibattito politico, con il Pd sulle
barricate a difendere la norma voluta dal deputato Alessandro Zan per punire
violenza e discriminazione contro la comunità Lgbti+ e la Lega che spinge
affinché si ridiscuta il testo, a lungo osteggiato in Aula. E in mezzo c’è anche
il giallo della “correzione” fatta dalla base del Pd alle parole del segretario
Enrico Letta, che si era detto disponibile al confronto. Si tratta di un atto
senza precedenti, compiuto dal Vaticano facendo ricorso a facoltà previste dai
Patti Lateranensi. «Alcuni contenuti attuali della proposta legislativa in esame
presso il Senato — si legge nella nota — riducono la libertà garantita alla
Chiesa Cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del
Concordato». Tali commi prevedono che l’Italia assicuri alla Chiesa «libertà di
organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e
del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica».
Inoltre, garantisce ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni «la
piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione». La norma, secondo il Vaticano,
metterebbero in discussione la «libertà di organizzazione», attentando, più in
generale, alla «libertà di pensiero» della comunità dei cattolici. Sotto accusa,
in particolare, l’articolo 7 del disegno di legge, «che non esenterebbe le
scuole private dall’organizzare attività in occasione della costituenda Giornata
nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la trasnfobia e attenterebbe alla
libertà di pensiero della comunità dei cattolici». In un primo intervento a
Radio Anch’Io, il segretario del Pd, Enrico Letta, si è detto aperto «al
confronto in Parlamento», dicendosi disponibile a guardare «con il massimo
spirito di apertura ai nodi giuridici, pur mantenendo un favore sull’impianto
perché la norma è di civiltà per il nostro Paese». Parole alle quali hanno
subito replicato il presidente della Commissione Giustizia al Senato Andrea
Ostellari e il leader del suo partito, Matteo Salvini. «La mia proposta è sempre
valida – ha evidenziato Ostellari -. Riuniamo i presidenti dei gruppi del Senato
e i capigruppo in commissione e sediamoci a un tavolo. Le audizioni si possono
ridurre. Inauguriamo, finalmente, una fase di confronto, leale e costruttivo».
Per il segretario della Lega, l’intervento del Vaticano è di «buon senso»: «Del
Ddl Zan – ha sottolineato Salvini – abbiamo sempre contestato il fatto che fosse
un bavaglio nei confronti della libertà di opinione, quindi se c’è la volontà di
ragionare insieme su un testo che non cancelli la libertà di opinione, ma che
tuteli da aggressioni e discriminazioni, noi siamo assolutamente d’accordo». Ma
respinge ogni accusa l’autore del ddl, il dem Zan. «Alla Camera sono sempre
state ascoltate con grande attenzione tutte le preoccupazioni e, come anche
confermato dal Servizio studi Senato, il testo non limita in alcun modo la
libertà di espressione, così come quella religiosa. E rispetta l’autonomia di
tutte le scuole. L’iter non si è ancora concluso. Vanno ascoltate tutte le
preoccupazioni e fugati tutti i dubbi, ma non ci può essere alcuna ingerenza
estera nelle prerogative di un parlamento sovrano», ha affermato. Attorno a lui
si è stretto subito il Pd, che ha manifestato il proprio sostegno convinto al
ddl. «Naturalmente vogliamo leggere con attenzione le carte sui nodi giuridici,
che al momento sono solo in un articolo di giornale», affermano fonti del
Nazareno, specificando la posizione del segretario Letta. Precisazione che non è
passata inosservata tra i leghisti: «Letta parla, e subito dopo fonti del
Nazareno correggono le sue parole sulla legge Zan. Già una volta il Pd aveva
sfiduciato clamorosamente Letta, quando era a Palazzo Chigi, e recentemente
buona parte del partito l’ha smentito sulla tassa di successione come fatto
anche dal presidente Draghi. Ora il Partito democratico si prepara a cacciare
Letta dalla segreteria?». Contro la presa di posizione del Vaticano si è
schierato, invece, il Partito Radicale: «Pur essendo convinti che la repressione
sessuale si superi con la liberazione sessuale e non con la repressione penale o
con una imposizione culturale di Stato, le ragioni della Santa Sede per chiedere
il rispetto del Concordato sono pretestuose – si legge in una nota -. La Santa
Sede è preoccupata di dover parlare nelle proprie scuole della Giornata
nazionale contro l’omofobia. Ma questo problema non esiste a meno che le scuole
private godano di finanziamenti pubblici (da poco raddoppiati!). È difficile
rinunciare ai denari pubblici in nome dei propri convincimenti ma è la stessa
Chiesa cattolica che insegna che non si può servire Dio e Mammona. E non si
capisce perché, se la Santa Sede brandisce il Concordato, come suo diritto, non
lo abbia mai fatto lo Stato, come sarebbe stato suo dovere, nei confronti della
Santa sede per le politiche dello Ior o per quelle sulla pedofilia», si conclude
la nota.
Zan, la bomba di Fico:
"Nessuna ingerenza".
Francesca Galici il 23 Giugno 2021 su Il Giornale. Alle
preoccupazioni sulla contrazione delle libertà di pensiero derivanti dal ddl Zan
del Vaticano ha risposto Roberto Fico, ospite di Agorà. La nota verbale della
Santa sede allo Stato italiano in cui si manifesta preoccupazione per la
limitazione della libertà di pensiero nel caso in cui il ddl Zan venisse
approvato nella sua attuale stesura sta facendo molto discutere a tutti i
livelli. Dopo le dichiarazioni a favore di social da parte di Fedez e di Elodie,
eletti maître à penser del pensiero unico (ma solo su certi temi) si è fatta
sentire la voce istituzionale, quella di Roberto Fico. Il presidente della
Camera dei deputati è intervenuto nel programma Agorà su Rai3 per difendere il
ddl Zan, chiedendo al Vaticano un passo indietro nelle questioni dello Stato
italiano. "Come rispondere alla richiesta del Vaticano di modificare il ddl Zan?
È molto semplice, il Parlamento è assolutamente sovrano, i parlamentari decidono
in modo indipendente quello che vogliono o non vogliono votare", ha dichiarato
Roberto Fico. Il presidente della Camera, quindi, ha proseguito: "Il ddl Zan è
già passato alla Camera ed è stato votato, frutto di discussione e dibattito
nelle commissioni e in Aula, adesso è al Senato e quindi fa la procedura
parlamentare normale. Noi come Parlamento non accettiamo ingerenze, il
Parlamento è sovrano e tale rimane sempre". Lo Stato Vaticano ha chiesto
maggiore attenzione all'Italia sulla base dell'articolo 7
della Costituzione italiana, che dice: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono
regolati dai Patti Lateranensi". Il Concordato tra Stato e Chiesa è considerato
alla stregua di un trattato internazionale, che regola i rapporti tra i due
Stati. Ma a differenza dei normali trattati internazionali, essendo i Patti
inseriti nella Costituzione, questi non possono essere modificati
unilateralmente senza modificare la Costituzione, ma solo in caso di accordo
bilaterale. Infatti, come si specifica nel terzo comma dell'articolo 7 della
Costituzione, "le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale". Lo Stato Vaticano si è
limitato a ricordare all'Italia l'esistenza del Concordato e, in base a quello,
è stato chiesto di verificarne l'accordanza con il ddl Zan. Ma prima di Roberto
Fico, è stato Alessandro Zan, primo firmatario della legge che porta il suo
nome, parlare di ingerenze dal suo profilo Twitter: "Vanno ascoltate tutte le
preoccupazioni e fugati tutti i dubbi, ma non ci può essere alcuna ingerenza
estera nelle prerogative di un parlamento sovrano".
Francesca Galici. Giornalista
per lavoro e per passione. Sono una sarda trapiantata in Lombardia. Amo il
silenzio.
Da lastampa.it il 23 giugno
2021. Draghi ha iniziato a rispondere alle richieste dei senatori. Tra le tante
domande, la risposta più attesa è quella annunciata ieri sul caso del concordato
tra Italia e Vaticano: «Mi preme ricordare che il nostro è uno stato laico, non
è confessionale, quindi il parlamento ha tutto il diritto di discutere e
legiferare. Il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie per verificare che
le nostre leggi rispettino sempre i principi costituzionali e gli impegni
internazionali, tra cui il Concordato con la Chiesa». Specificando come «la
laicità non è indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso. La
laicità è tutela del pluralismo e delle diversità culturali». Poi ribadisce
brevemente la posizione del governo italiano sulla situazione dell’Ungheria e la
legge contro l’omosessualità: «Ieri l'Italia ha sottoscritto con 16 Paesi
europei in cui si esprime preoccupazione per gli articoli di legge in Ungheria
in base a cui si discrimina l'orientamento sessuale». E ha esaurito la risposta
alle polemiche tornando sul Ddl Zan: «Senza entrare nel merito della discussione
parlamentare, che il governo sta seguendo, questo è il momento del Parlamento,
non è il momento del governo».
Ddl Zan, il giurista del
Concordato: «Nessuna violazione». Ma Draghi non la pensa così.
Chiara Pizzimenti su Vanityfair.it il 24/6/2021. «Il nostro è uno Stato laico,
non confessionale. Il Parlamento è libero di discutere e legiferare e il nostro
ordinamento è in grado di dare tutte le garanzie verificare che le nostre leggi
rispettino sempre i principi costituzionali e gli impegni internazionali, tra
cui il Concordato con la Chiesa». Mario Draghi alla fine è intervenuto sulla
questione Ddl Zan-Vaticano ribadendo la laicità dello stato italiano. Una
risposta che probabilmente nemmeno serviva per Francesco Margiotta Broglio,
giurista fra i più importanti in Italia, a capo della commissione paritetica sul
Concordato fra lo Stato italiani e la Santa Sede dal 1984 al 2014. Secondo
Margiotta «non c’è alcuna violazione». La nota consegnata da monsignor Gallagher
all’ambasciatore Sebastiani dice il Ddl Zan violerebbe l’articolo 2 del
Concordato quello in cui si dice che la Repubblica italiana riconosce alla
Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale,
educativa e caritativa. «Nel Ddl Zan», spiega il professore a Repubblica, «non
c’è ingerenza negli affari della Chiesa. Uno dei punti del contendere, da parte
dei vescovi, è l’articolo 7 del disegno di legge in cui si prevede l’istituzione
della Giornata nazionale contro omofobia e transfobia, con le scuole invitate ad
organizzare incontri, attività sul tema. Se è evidente che non si possono
obbligare le scuole private “confessionali” a festeggiare questa giornata, è
altrettanto evidente che la Chiesa non può certo chiedere allo Stato di non fare
leggi che essa, la Chiesa, ritiene contrarie alla propria dottrina cattolica».
Al professore pare che il Vaticano ripeta la via e l’esperienza dei referendum
su divorzio e aborto, superando i confini degli accordi, non il contrario, e
mostrando con questo agire debolezza. «La Chiesa fece fuoco e fiamme prima
contro il divorzio e poi contro l’aborto, minacciando la rottura dei patti. Non
è successo ed entrambe sono poi diventate leggi dello Stato. Così sarà per il
disegno di legge Zan che oltretutto, vorrei ricordare, vieta anche ogni
discriminazione fondata su motivi razziali o religiosi».
Fedez e Cappato guidano la crociata
contro Papa Francesco e le ingerenze del Vaticano sul Ddl Zan.
Piero de Cindio su Il Riformista il 22 Giugno 2021. Papa
Francesco è stato esautorato dalla base della Chiesa e scoppia la polemica
social sul Ddl Zan. A margine della richiesta formale al Governo Italiano
attraverso il Segretario per i rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard
Gallagher. Di “rivedere il decreto a contro l’omotransfobia e le disabilità”
perché in conflitto con il concordato. L’atto consegnato il 17 giugno ed emerso
all’attenzione della cronaca dopo meno di una settimana, ha fatto esplodere
migliaia di commenti sulla rete che hanno inveito contro la scelta dello Stato
Vaticano di esporsi contro una riforma in itinere nel Parlamento Italiano. Il
dibattito derivato dalla discussione di questa notizia ha in poche ore generato
su Twitter la bellezza di 12.269 tweets, 209.876 mi piace, 30.960 condivisioni,
10.693 commenti e 5.245 citazioni. “Un dato impressionante che ha rappresentato
un colpo molto duro all’immagine della chiesa – dichiara al Riformista Livio
Varriale, autore della ricerca – non ci sono commenti positivi nei confronti del
Vaticano e questo fa in modo che si oscuri la narrazione delle motivazioni poste
in essere dallo Sato comandato da Papa Francesco”. HASHTAGS – Le parole chiave
per individuare tali discussioni sui social sono state, oltre a Vaticano, ddlzan
e concordato “la maggior parte delle persone non sapeva manco che esistesse il
concordato come strumento giuridico di relazione tra Stato e Chiesa Vaticana –
spiega Varriale – bene però che questa polemica abbia insegnato qualcosa di
nuovo alla massa. Oltre all’hashtag LGBT e Chiesa, rimbalza all’occhio quello di
Emanuela Orlandi e questo dimostra che il livello di aggressività e di
strumentalizzazione nei confronti del clero abbia avuto anche toni accesi che
fanno riferimento ad una delle peggiori pagine della storia Vaticana”.
LIKES – Ad avere la meglio in termini di like e
condivisione, il marito di Chiara Ferragni, Fedez, che ha incalzato quanto
lasciato dopo le polemiche del primo maggio dove fece un endorsement
pubblicamente contro coloro che ostacolavano il percorso di approvazione del
Decreto. Marco Cappato, attivista per l’eutanasia in Italia, quest’ultima
osteggiata proprio dal Vaticano, ha raccolto consensi posizionandosi al secondo
posto. Al terzo c’è invece Vladimir Luxuria, rappresentante del mondo LGBT in
Italia, insieme all’avvocato attivista per i diritti della categoria Cathy la
Torre ed allo stesso Alessandro Zan.
MENZIONI – “Dalle menzioni è possibile capire
quali sono stati i personaggi inghiottiti dalla polemica indipendentemente dalla
parte assunta” Spiega Varriale “Il Corriere ha fornito la notizia di
riferimento, seguito dalla Repubblica e Fatto Quotidiano mentre Fedez per la
seconda volta coglie un’occasione ghiotta per rappresentare i suoi interessi
anticlericali più volte predicati. Boldrini e Papa Francesco sono le figure
politiche più coinvolte, seguiti dal duo del Pd Letta e Zan. Per quanto riguarda
la Lega, il trio Salvini, Borghi e Pillon si conferma il bersaglio preferito
dalla massa su questioni afferenti le tematiche LGBT, mentre chiude la
classifica dei top 20 il pro vita Mario Adinolfi che ha avuto posizioni sempre
molto nette contro Ddl Zan”.
Piero de Cindio. Esperto di social media, mi
occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format
"Fedez ha detto fesserie.
Il Vaticano paga le tasse, ecco le cifre".
Fabio Marchese Ragona il 24
Giugno 2021 su Il Giornale. Il presidente dell'Apsa smentisce il rapper: "È
disinformato, nel 2020 oltre 5 milioni di Imu". Nella polemica sul Concordato
tra Italia e Santa Sede, con il Vaticano che ha chiesto al Governo la
rimodulazione del testo Zan, si è inserito anche il rapper Fedez che da tempo
sostiene pubblicamente il ddl. Il re del tormentone estivo, ha lanciato dal suo
profilo Instagram, che conta 12,6 milioni di followers, accuse al Vaticano sul
tema degli immobili. «Amici», ha chiesto con ironia il cantante ai suoi seguaci,
«voi avevate concordato qualcosa? Non avevamo concordato, amici del Vaticano,
che ci davate delle tasse arretrate sugli immobili e che l'Unione Europea ha
stimato in cinque miliardini o forse di più? In realtà non si sa, perché avete
perso il conto degli immobili, ne avete troppi». Affermazioni che non vanno giù
a monsignor Nunzio Galantino, presidente dell'Apsa, l'Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica che gestisce gli immobili della Santa Sede.
Monsignor Galantino che cosa
risponde a Fedez?
«L'unica risposta che si può
dare a una persona disinformata sono le carte, i fatti. Non so se lo faccia per
ignoranza o per malafede. Non ci sono alternative. A fronte di affermazioni che
lui non può documentare, io posso invece documentare che il Dicastero che
presiedo paga».
Avete pagato?
«Nel 2020 l'Amministrazione
del Patrimonio della Sede Apostolica ha pagato 5,95 milioni di euro per l'Imu e
2,88 milioni di euro per l'Ires. A queste vanno aggiunte le imposte pagate da
Governatorato, Propaganda Fide, Vicariato di Roma, Conferenza Episcopale
italiana e singoli enti religiosi. Nel 2019 abbiamo pagato oltre 9 milioni e 300
mila euro. Ed è tutto documentato! Poi se si vuole andare in processione con
Fedez, si vada pure. Il problema è che qualcuno, pur sapendo queste cose,
continua a dire che la Chiesa non paga...»
Fedez parla di miliardi di
euro di arretrati...
«Chi dice che il Vaticano ha
evaso 5 miliardi di Imu allo Stato non offre nessun dato che permetta di
verificare questa affermazione. Da chi denuncia la rilevante somma che il
Vaticano avrebbe evaso bisognerebbe farsi dire: in base a quale legge, su quali
immobili e in riferimento a quale periodo è stato quantificato il debito del
Vaticano? Bisogna ribadire che sugli immobili dati in affitto quelli che rendono
davvero da sempre le imposte vengono pagate senza sconti o riduzioni. In
passato, le polemiche furono alimentate perché l'Ici prevedeva l'esenzione per
gli immobili degli enti senza scopo di lucro, integralmente utilizzati per
finalità socialmente rilevanti (come scuole, mense per i poveri o centri
culturali). È da sapere che l'esenzione non riguarda solo la Chiesa, ma tutte le
Confessioni religiose, i partiti, i sindacati ecc. Ho persino chiesto a coloro
che fossero a conoscenza di evasione da parte di enti ecclesiastici, di
denunciarli subito alle competenti autorità, assicurando il mio appoggio».
Perché secondo lei Fedez ha
fatto queste affermazioni?
«Bisognerebbe chiedere a lui,
è difficile dare spiegazioni, io non lo conosco nemmeno, non so chi sia, lui può
fare quello che vuole, ma chi lo ascolta deve sapere che almeno su questo
argomento ha detto cose che, nella migliore delle ipotesi, non conosce. Perché a
fronte delle mie parole ci sono dei fatti e ho le prove per smentirlo. La gente
decida se vale più un documento o la parola di Fedez...»
La questione degli immobili
vaticani è terreno fertile per chi vuol fare polemica...
«A metà luglio pubblicheremo
il bilancio dove ci sarà elencato il numero degli immobili, in Italia,
all'estero, ecc. e così saranno serviti anche questi benpensanti».
Forse il problema è che in
passato la Chiesa non rendeva tutto pubblico?
«La responsabilità è anche
nostra che talvolta, all'epoca, non abbiamo fatto buona o sufficiente
comunicazione...».
Adesso con Papa Francesco le
cose son cambiate?
«Dobbiamo riconoscerlo, oggi
posso dire tu hai detto una fesseria e parli di cose che non conosci. O lo fai
in malafede o perché lo ignori. Io ti aiuto a superare la tua ignoranza, se lo
accetti o non lo accetti sono problemi tuoi. Grazie a Dio, il tempo del silenzio
è finito!». Fabio Marchese Ragona
Ddl Zan, la vergogna di
Fedez: se non la pensi come lui ti insulta, sfregio e insulti alla Chiesa.
Francesco
Specchia su Libero Quotidiano il 23 giugno 2021. Per il ddl Zan, finché c'è
Fedez c'è speranza. C'è sempre un innegabile tempismo nel rapper Federico Lucia,
quando si tratta di cavalcare l'onda arcobaleno. Prendete il suo ultimo j'
accuse su Twitter. È bastato che il Vaticano, attraverso il cardinale Paul
Gallagher ministro degli Esteri del Papa, levasse gli scudi diplomatici per
chiedere formalmente al governo italiano di modificare il disegno di legge
contro l'omotransfobia in quanto violatore dei Patti Lateranensi, che subito
Fedez il templare delle minoranze chiassose, insorgesse. E che, armato di tweet
e telecamera, muovesse contro i preti a testa bassa: «Il Vaticano che ha un
debito stimato di 5 miliardi di euro su tasse immobiliari mai pagate dal 2005 ad
oggi per le strutture a fini commerciali dice all'Italia 'guarda che con il Ddl
Zan stai violando il concordato». Aggiungendo, inoltre: «E comunque, siamo uno
Stato laico. Un'altra cosa, voi potete mettere becco sulle leggi italiane però
perchè quando in Italia viene sgamato un pretino pedofilino, il pretino non
viene processato dalla giustizia italiana?». A far da eco a Fedez contro il
Concordato si alzano voci dal web e quelle di Paola Turci ed Elodie («Ringrazio
i miei per non avermi battezzata») in una furiosa giostra anticattolica. Ora,
l'intervento della diplomazia vaticana che -rivela il Corriere della sera-
esprime "preoccupazione" per una legge dello Stato italiano e che va oltre la
semplice moral suasion, è tanta roba. E, nella visione di uno stato laico, c'è
poco da confutare nella reazione di Fedez. La Chiesa ha i suoi problemi con
immobili e pedofili. Ma il problema è che con quel documento squisitamente
giuridico del Vaticano depositato all'ambasciata italiana, il Fedez-pensiero
c'entra come i cavoli a merenda. È parlare due lingue diverse, è come chiedere
un giudizio sul Recovery e sentirsi rispondere sui gol di Insigne. Tra i
commenti che plaudono al rapper ne estraggo due controcorrente: «Attenzione a
parlare del Concordato, perché è citato nella nostra Costituzione all'art 7
(Patti lateranensi). Ti supporto in tante battaglie, compreso il ddl Zan, ma
parlare del Concordato vuol dire parlare della Costituzione. Occhio a non fare
il passo più lungo della gamba». E ancora: «Non condivido la posizione del
Vaticano, questo accostamento non ha molto senso. Che la Chiesa cattolica sia
portavoce di una grande fetta della popolazione italiana è un dato di fatto, la
democrazia è anche questo». Sono due giudizi emblematici. È esattamente questo
il senso: il rispetto dell'opinione altrui e il tracciato della democrazia da
cui Fedez tende a deviare pericolosamente. Tra l'altro, se proprio non si sente
minoranza e vuol fare il figo con la forza dei suoi 12 milioni e rotti di
followers, la lotta con 1,32 miliardi dei seguaci della Chiesa cattolica sarebbe
impari. In realtà la faccenda è tecnica. Per la Santa Sede l'art.7 del ddl Zan
non esenterebbe le scuole private dall'organizzare attività in occasione della
costituenda Giornata nazionale contro omofobia, lesbofobia e transfobia,
violando la "libertà di organizzazione" al comma 1 e 3 dell'art.2-; e
attenterebbe alla «libertà di pensiero» dei cattolici. Il che, in punta di
diritto, è impeccabile. Suggerisce Gennaro Acquaviva revisore con Craxi del
Concordato dell'84: la Chiesa non ha torto, se la libertà e l'autonomia della
scuola cattolica vengono messe a rischio nel momento in cui la stessa scuola
«viene obbligata a fare qualcosa che va contro la propria coscienza e i propri
principi». Qui, la disputa è tra Stati sovrani. Credo che Fedez ne sappia quanto
io della discografia di Guè Pequeno o di Fabri Fibra.
Dagoreport il 23 giugno 2021.
"La Chiesa non è contro il Ddl Zan e non lo contesta né sul piano teologico né
nel merito. Si chiede solo la rimodulazione di due punti caratterizzati da una
criticità tecnica affinché siano più facilmente interpretabili". Don Filippo Di
Giacomo, giornalista e canonista, interviene sulla ridda di polemiche scatenate
dalla pubblicazione della "nota verbale" con cui il Vaticano segnalava al
governo le sue perplessità sul Ddl Zan. "Il primo equivoco della vicenda -
precisa Di Giacomo - è legato alla natura del documento in questione. Si tratta
di una "nota verbale", ovvero il modo usuale con cui le diplomazie si parlano,
si confrontano e scambiano osservazioni. Enfatizzarlo come una 'lettera
ufficiale' è pura idiozia, anche perché siamo in una fase interlocutoria del
dialogo tra due parti, lo Stato italiano e la Chiesa, i cui rapporti sono
regolati dall'articolo 7 della Costituzione. Il confronto verte sulla difesa di
quegli spazi di libertà religiosa che riguardano non solo i cattolici ma anche
ebrei, musulmani e i seguaci di altre confessioni". Gli attacchi di Fedez alla
Santa Sede? Il cantante ha berciato: "Il Vaticano non paga le tasse immobiliari
e dice che l'Italia sta violando il Concordato". Notizia mezza tarocca visto
che, nel 2020, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha pagato
5,95 milioni di euro di IMU, 2,88 milioni per l'Ires senza contare le imposte
pagate da Governatorato, Propaganda fide, Vicariato di Roma, Conferenza
Episcopale italiana e singoli enti religiosi… "Evidentemente il cantante si
considera uno specchio di virtù - ironizza Di Giacomo - In Italia è diffusa
un'idea di laicità che fa ridere: della serie, se parla un prete bisogna
metterlo a tacere. E' una "laicità" in chiave anti-cattolica. Uno stato laico
non interviene, non si intromette e non ha pregiudizi. Negli ultimi mesi,
invece, una quindicina di funzioni religiose sono state interrotte mentre si
stava pregando per i malati o per le persone bisognose. Alcuni parroci sono
stati denunciati solo perché nel bollettino parrocchiale ricordavano, sui temi
della sessualità, quel che c'è scritto nel catechismo…". "Si parte sempre dal
preconcetto - prosegue Di Giacomo - che ogni volta che parla un prete, stia
esprimendo un "no". Mentre sul caso del Ddl Zan si sta solo manifestando, nel
rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, una perplessità su due articoli
(tra cui quello legato alle sanzioni) non chiari e, dunque, non idonei a
garantire la piena libertà di coscienza. D'altronde quel che la Chiesa chiede,
cioè una rimodulazione di due passaggi del testo per una più facile
interpretazione e una più serena osservazione della legge, è stato espresso
anche dagli esperti, tra cui ex presidenti della Corte costituzionale, sentiti
dalla Commissione parlamentare". Di Giacomo piccona anche l'apparente monolite
di consenso intorno al controverso disegno di legge: "Dieci giorni fa c'è stato
un convegno, organizzato da un'associazione Lgbt, dal titolo "Per salvare il Ddl
Zan, cambiamo il Ddl Zan". Siamo sicuri che il mondo Lgbt, nella sua totalità,
aderisca senza riserve alla proposta?". Resta una questione "politica", tutta
interna al Vaticano, sulla diffusione della "nota verbale": chi l'ha data alla
stampa? Di Giacomo non ha dubbi: "E' uno sgarbo al Papa. La diplomazia non è un
oggetto rococò da mettere in salotto e si muove a un livello in cui la
discrezione è sovrana. Come diceva l'arcivescovo Marcinkus 'il Vaticano è un
paese abitato da 500 lavandaie'. Quel che va precisato è che chiunque abbia
deciso di dare il documento ai giornalisti non è certo estraneo alla gestione
Bergoglio. Nella Santa Sede vige uno spoil system totale: da quando è stato
eletto, otto anni fa, il Papa ha nominato molte persone, ne ha sostituite altre.
E oggi chi ricopre un incarico di responsabilità Oltretevere, è stato scelto da
lui…"
Ddl Zan, il paradosso di
una legge che va contro la Costituzione: pena aumentata se l'aggressore fosse di
colore? Iuri
Maria Prado su Libero Quotidiano il 01 giugno 2021. «L'odio si combatte con i
fatti», dice l'onorevole Alessandro Zan, che è il relatore del disegno di legge
che porta il suo nome e inventa aggravanti nel caso di atti violenti e di
discriminazione «fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale,
sull'identità di genere o sulla disabilità». E quali sarebbero i fatti con cui
si combatte l'odio è presto detto: galera, galera e galera, perché è questo il
presidio progressista a tutela delle vittime di quei comportamenti odiosi, la
galera e ancora la galera. Non conta che la Costituzione indichi il sesso tra le
condizioni che la legge non può considerare per attribuire o revocare diritti, e
non conta che un atto violento contro un omosessuale, un transessuale, un
sessualmente orientato di qui o di là, o l'istigazione a commetterlo, siano oggi
perfettamente punibili: niente da fare, ci vuole questa legge perché la cronaca
riporta casi di aggressione ai danni di quelle categorie (brutta parola: ma sono
i sostenitori di questa ignominia legislativa a dividere la società in
corporazioni sessiste). E così la coppia gay picchiata a Palermo, la lesbica
presa a testate a Catanzaro o le bottigliate all'omosessuale pugliese diventano
riprove che è indifferibile creare un diritto speciale perché altrimenti quei
delitti rimangono impuniti: una bugia bella e buona, confezionata mentre il
legislatore ordinario si incarica di spiegare che non intende intervenire sulla
libertà di manifestazione del pensiero e sulle «condotte legittime», stabilendo
lui, il legislatore ordinario, le ragioni di compatibilità del proprio lavoro
con la Costituzione. Per capirsi: domani un'altra maggioranza chiude un giornale
scomodo e spiega che però non è mica intervenuta sulla libertà di stampa. Ma
facciamo un esempio più scottante. Si ipotizzi che qualcuno denunci un alto
tasso di criminalità tra quelli con la pelle scura, e sulla base di questo
rilievo proponga un aggravamento di pena per il responsabile del delitto che
appartenga a quella categoria: e immaginiamo che nel mettere in legge questa
trovata spieghi che la norma non vuole interferire col precetto costituzionale.
Bene: cosa fa se non applicare in altra direzione lo stesso criterio del ddl
Zan? Alcuni (pochissimi) hanno tentato di spiegare queste cose ai tanti (pochi
soltanto ignoranti, moltissimi in malafede) per i quali l'approvazione di questa
legge costituisce l'avvenimento capitale del nostro progresso civile, ma non ci
sono santi: chi rema contro sotto sotto si compiace della violenza omofoba. Ed è
bestemmia l'idea che la contestazione di questo ddl sia sorretta da ragioni
altrettanto degne rispetto a quelle agitate da chi ne sostiene
l'indispensabilità: ragioni sistematiche e liberali, le prime, che esigono un
po' di studio e qualche consuetudine con la prassi democratica, roba antipatica
presso i cultori del modello Greta-Fedez-Zan.
Dalla Boldrini a Luxuria, in campo il
fronte anti Vaticano. Luca Sablone il 22 Giugno 2021
su Il Giornale. La sinistra sulle barricate contro la Santa Sede dopo le
critiche al ddl Zan: "Inaccettabile intromissione della Chiesa, ora acceleriamo
ancora di più e aboliamo il Concordato". Non potevano ovviamente mancare
infiniti comunicati stampa da parte di esponenti della sinistra, fortemente
indignati per la presa di posizione del Vaticano sul ddl Zan. Al governo
italiano è stato chiesto di accogliere le preoccupazioni avanzate soprattutto
perché si ritiene che siano minacciate la libertà di organizzazione e di
pensiero della comunità dei cattolici. A guidare il fronte rosso contro la mossa
della Santa Sede è Laura Boldrini, secondo cui l'approvazione del ddl Zan resta
assolutamente prioritario: "È una legge di civiltà. Punisce i crimini d'odio per
omolesbobitransfobia, misoginia, abilismo e promuove il rispetto. Non c'è
rischio per la libertà di pensiero poiché esclude la propaganda di idee". La
deputata del Partito democratico si è detta sì disponibile ad ascoltare il
Vaticano, ma ha tenuto a ribadire che la decisione finale spetterà al
Parlamento: "Ascoltiamo anche il Vaticano, ma il Parlamento è sovrano".
Il Pd non molla. In mattinata Enrico Letta ha
provato a blindare di nuovo il testo del ddl Zan: "Noi siamo sempre stati
favorevoli a norme molto forti contro l'omotransfobia. Rimaniamo favorevoli a
queste norme e al ddl Zan". Ma alla posizione del Vaticano è seguita una
sostanziale sottolineatura non indifferente: il segretario del Pd ha aperto a
possibili modifiche. "Siamo pronti a guardare i nodi giuridici pur mantenendo un
favore sull'impianto perché la norma è di civiltà per il nostro Paese. Il nostro
è sempre stato un atteggiamento di apertura", ha dichiarato. Fonti del Partito
democratico però tengono comunque a far passare un messaggio piuttosto chiaro:
"Il Pd sostiene convintamente il ddl Zan. Naturalmente vogliamo leggere con
attenzione le carte sui nodi giuridici, che al momento sono solo in un articolo
di giornale". Non molla neanche il senatore dem Andrea Marcucci, che non vuole
perdere ulteriore tempo e chiede arrivare rapidamente a una decisione finale: "È
sempre tempo di libera Chiesa in libero Stato, non di guerre di religione. Il
ddl Zan vada al più presto in Aula, il Parlamento decida autonomamente".
Il fronte rosso anti-Vaticano. Non solo dal Pd. Le
dure risposte al Vaticano arrivano in generale dall'area di centrosinistra. Ad
esempio per Chiara Appendino, sindaco di Torino, questa è addirittura
l'occasione per imprimere una forte accelerata: "Una posizione senza precedenti,
il Parlamento è stato votato dal popolo, legittimato giustamente a legiferare e
il mio auspicio è che, alla luce di quello che è accaduto con questa lettera, si
vada avanti ancora di più rapidamente con tutte le forze politiche che hanno
deciso di sostenerlo". Polemiche le parole di Vladimir Luxuria, secondo cui la
Santa Sede - intervenendo come legislatore e suggerendo quali sono i punti da
modificare - ha compiuto un "enorme passo indietro". Ritiene che sia "una grande
bufala" pensare che una scuola privata cattolica debba sentirsi obbligata a
parlare di omofobia il 17 maggio, che potrebbe diventare la Giornata nazionale
contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Dunque Luxuria
invita a proseguire la battaglia per arrivare all'ok definitivo al ddl Zan:
"Questo è un banco di prova sul rispetto di un principio costituzionale. Abbiamo
fatto grandi battaglie come quella sull'aborto e sul divorzio. Teniamo duro
anche su questa". "Uno Stato laico non può subire simili ingerenze e
intromissioni", lamenta a gran voce Riccardo Magi. Il deputato di +Europa si è
espresso duramente su Facebook dopo la tesi del Vaticano per cui il ddl Zan
violerebbe - in alcuni contenuti - l'accordo di revisione del Concordato: "Una
cosa mai successa prima, un fatto di una gravità inaudita nel rapporto mai
davvero limpido tra l'Italia e il Vaticano. "Ama il prossimo tuo", ma solo se
rispetta le loro norme. Noi lo diciamo da decenni e ora lo ribadiamo: aboliamo
il Concordato!".
Luca Sablone. Classe 2000, nato a Chieti.
Fieramente abruzzese nel sangue e nei fatti. Estrema passione per il calcio,
prima giocato e poi raccontato: sono passato dai guantoni da portiere alla
tastiera del computer. Diplomato in informatica "per caso", aspirante
giornalista per natura. Provo a raccontare tutto nei minimi dettagli,
possibilmente prima degli altri. Cerco di essere un attento osservatore in d...
Da "corriere.it" il 22 giugno 2021. «Oggi un
ringraziamento speciale va ai miei genitori che non mi hanno battezzata.
Grazie». Elodie, con una story su Instagram, prende una posizione chiara in
relazione alla vicenda del ddl Zan, dopo le notizie secondo cui il Vaticano ha
chiesto di modificare il provvedimento. La cantante, già in passato, aveva
manifestato in maniera eloquente le proprie opinioni sul tema. Sui social,
davanti al no della Chiesa alle unioni omosessuali, aveva affermato: «Per
fortuna la gente continuerà ad amarsi pur non avendo la "benedizione" del
Vaticano».
"Grazie ai miei non
sono battezzata". Ma Elodie scorda un particolare.
Francesca Galici il 23 Giugno
2021 su Il Giornale. Non tutti i sostenitori del ddl Zan si sentono
rappresentati da Elodie, che rivendica di non essere stata battezzata con la
croce tatuata sul braccio. Da ieri il discorso sul ddl Zan è tornato
prepotentemente alla ribalta per la nota con la quale il Vaticano ha chiesto
allo Stato italiano maggiore attenzione perché, così com'è scritto, violerebbe
il Concordato. La Santa sede ha manifestato seria preoccupazione per la libertà
di pensiero dei cattolici ed è divampata la polemica da parte dei sostenitori
del disegno di legge a firma di Alessandro Zan, che hanno chiesto meno ingerenza
della Chiesa nel processo decisionale dello Stato italiano. Tra loro anche Fedez
ed Elodie, i due cantanti sempre pronti a schierarsi dalla parte delle battaglie
più social che hanno già ampia eco mediatica e non di quelle che, per esempio,
avrebbero bisogno di maggiore visibilità. Il populismo permea i discorsi dei due
cantanti, probabilmente all'oscuro dell'articolo 7 della Costituzione, nel quale
si specifica che, tra Stato e Chiesa, i "rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi". E, proprio in virtù del Concordato, il Vaticano ha chiesto
all'Italia di verificare che il ddl Zan non vada a ledere la libertà e
l'autonomia delle scuole cattoliche. Che Elodie si presenti in video con una
storia nella quale, con orgoglio, dice "oggi un ringraziamento speciale va ai
miei genitori che non mi hanno battezzata", è avulso dal senso del discorso. E
lo è al pari di Fedez che chiede alla Chiesa di pagare "5 miliardi di tasse
immobiliari". Il battesimo è un percorso personale che non dovrebbe essere
utilizzato a fini propagandistici. Le parole di Elodie, che sembra porsi in
posizione moralmente superiore rispetto a chi, invece, ha ricevuto il battesimo,
hanno indignato molti. E c'è chi ha fatto notare alla cantante la supponenza
delle sue parole: "Elodie non è stata battezza, il che la pone al di sopra di
ogni battezzato. Cara Elodie, facciamo che se tu sia battezzata o meno ce ne
frega poco e niente ma facciamo anche che come vuoi che gli altri rispettino il
tuo pensiero tu debba rispettare quello degli altri". Un presupposto che spesso
manca in chi sostiene il ddl Zan, soprattutto sui social. Ma è un altro
l'elemento che maggiormente stride con il "ringrazio che non mi hanno
battezzata". Sul braccio sinistro di Elodie spicca una grande croce, simbolo di
cristianità. Appare quanto meno contraddittoria la sua presenza sul corpo di chi
rivendica con onore di non aver ricevuto il sacramento del battesimo. E infatti
non manca chi glielo fa notare. Uno dei tanti che ha sottolineato questa
ipocrisia, dopo aver riportato le sue parole ha aggiunto: "E ha una croce
tatuata sul braccio. Dal club degli illuminati de sinistra è tutto, a voi
studio". Ma c'è di più, perché anche tra chi spinge affinché venga approvato il
ddl Zan c'è chi critica il modo di porsi dei due cantanti: "Si può essere
favorevoli al ddl Zan e, allo stesso tempo, non sentirsi rappresentati da Fedez
ed Elodie? Rendiamo più maturo il dibattito, please!". Una richiesta più che
legittima da parte di chi si è stancato delle strumentalizzazioni social e vuol
portare il discorso a un livello più alto, che prescinde dalla smania del
consenso.
Francesca Galici. Giornalista
per lavoro e per passione. Sono una sarda trapiantata in Lombardia. Amo il
silenzio.
Tagadà, Antonio Padellaro e il
pesantissimo sospetto su Papa Francesco: "Cosa succede lì dentro?". Vaticano e
ddl Zan, una bomba. Libero Quotidiano il 22 giugno
2021. Antonio Padellaro ha commentato la notizia della richiesta del Vaticano di
modificare il DdlZan, richiesta inviata con una missiva al governo. Un caso
enorme, rivelato dal Corriere della Sera: "Interferenza pesante, che pensa Papa
Francesco, cosa succede lì dentro?", si chiede il direttore del Fatto
Quotidiano, ospite di Tagadà in onda su La7 condotto da Tiziana Panella. Il
Vaticano infatti ha chiesto al governo italiano di modificare il ddl Zan, il
disegno di legge contro l'omotransfobia ora in commissione Giustizia del Senato,
perché "violerebbe in alcuni contenuti l'accordo di revisione del Concordato".
Secondo il Vaticano, infatti, alcuni passaggi del ddl Zan non solo metterebbero
in discussione la "libertà di organizzazione", ma in senso più generale, alla
"libertà di pensiero" della comunità dei cattolici. L'intervento della Santa
Sede sul governo italiano ha l'obiettivo "non di bloccare" il ddl Zan ma di
"rimodularlo in modo che la Chiesa possa continuare a svolgere la sua azione
pastorale, educativa e sociale liberamente", spiegano fonti vaticane. Questo
però ha dato molto fastidio a Padellaro che ci vede una grossa ingerenza del
Vaticano nella politica italiana. Il giornalista chiede così il parere del Papa.
Nel frattempo al Vaticano ha subito risposto l'autore del disegno di legge: "Il
ddl Zan è stato approvato da un ramo del Parlamento a larga maggioranza, e
l'iter non si è ancora concluso. Vanno ascoltate tutte le preoccupazioni e
fugati tutti i dubbi, ma non ci può essere alcuna ingerenza estera nelle
prerogative di un parlamento sovrano". Così Alessandro Zan del Pd su twitter.
«Così la Santa sede mette in discussione
la laicità dello Stato». Il Vaticano contro il ddl
Zan, parla la senatrice dem Monica Cirinnà: «Siamo di fronte a una presa di
posizione molto netta in una materia che è affidata al Parlamento». Simona Musco
su Il Dubbio il 23 giugno 2021. Nessun pericolo per la libertà di opinione –
«che è resta distinta da una inesistente “libertà” di istigare alla
discriminazione o alla violenza» – e nessun pericolo per l’autonomia scolastica.
A dirlo è la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, tra le più
agguerrite sostenitrici della legge presa di mira dal Vaticano. Legge alla
quale, a nome dell’intero partito, ribadisce oggi il più incondizionato
appoggio. «Sicuramente ci sono dei profili molto delicati di tenuta del
principio di laicità dello Stato – dice al Dubbio -. Mi auguro non si arrivi ad
una crisi diplomatica».
Come giudica l’intervento del Vaticano sul ddl
Zan?
Mi fa riflettere molto, come cittadina e come
rappresentante delle istituzioni repubblicane, che la Santa sede senta la
necessità di pronunciarsi in modo così duro su una legge che ha il solo
obiettivo di proteggere le persone da discriminazione e violenza.
L’autonomia legislativa e la laicità dello
Stato sono messe in discussione?
Siamo di fronte a una presa di posizione molto
netta in una materia che, al momento, è affidata al Parlamento, avvenuta in
forme inedite e con un’intensità senza precedenti nella storia della Repubblica.
Come tale deve essere valutata, alla luce del principio costituzionale di
laicità e della lettera dell’articolo 7 della Costituzione. Sarà necessario
riflettere su quanto accaduto, anche al di là degli stretti profili di merito
legati al ddl Zan.
Come risponde alle obiezioni sollevate da
Monsignor Gallagher?
La nota vaticana riprende obiezioni largamente
diffuse nel dibattito sul ddl Zan. Posso solo rispondere ribadendo che a queste
obiezioni è stato dato ascolto e risposta già alla Camera, in sede di
discussione e approvazione del testo. Non ci sono pericoli per la libertà di
opinione – che è resta distinta da una inesistente “libertà” di istigare alla
discriminazione o alla violenza – e non ci sono pericoli per l’autonomia
scolastica.
Secondo l’arcigay si tratta di un “attentato
alla Costituzione” e di un tentativo di aprire una crisi diplomatica. Secondo
lei è davvero così?
Sicuramente ci sono dei profili molto delicati di
tenuta del principio di laicità dello Stato. Non so se si arriverà a una crisi
diplomatica e sicuramente non me lo auguro. Quel che è certo è che la politica
deve essere in grado di dare una risposta equilibrata ma netta, rivendicando il
proprio ruolo nel quadro dei principi sanciti dalla Costituzione.
Per coloro che da sempre si sono opposti a questa
norma una delle note dolenti è quella che riguarda la scuola. Ci sono margini di
trattativa su questioni come questa?
L’articolo 7 del ddl – quello che istituisce la
Giornata contro l’omolesbobitransfobia prevedendo anche che possano svolgersi
iniziative nelle scuole – è stato modificato alla Camera proprio per ribadire il
pieno rispetto del principio di autonomia scolastica. Non ci sono pericoli di
sorta. Concentriamoci sull’importanza di prevenire discriminazioni e violenza a
partire dalla formazione e dalla cultura, piuttosto che agitare fantasmi
inesistenti.
Come influirà questa vicenda sui lavori
parlamentari?
La posizione del Partito democratico non muta. È
necessario porre fine all’ostruzionismo di queste settimane, portando al più
presto il ddl in Aula. È l’ostruzionismo a impedire il confronto democratico sui
contenuti, non altro.
Alessio Poeta per “Chi” il 22 giugno 2021.
Alessandra Mussolini, negli anni, ha capito che la coerenza appartiene solo a
chi non ha idee. Ha abbandonato la politica, ha trovato il suo equilibrio, si è
interrogata spesso sul senso della vita e per questo ha scelto di supportare il
Ddl Zan. «Non la chiamerei conversione, né redenzione. Sarebbe riduttivo. Io non
faccio altro che analizzare le situazioni, senza barriere e senza essere
condizionata, in alcun modo, dalle etichette. Eppure, ciononostante, viviamo una
realtà così particolare dove la tolleranza non vale per tutti, ma solo per
alcuni».
Domanda. La foto pubblicata sui suoi social con
scritto Ddl Zan, sul palmo della mano sinistra, ha scatenato il putiferio e
fatto il giro del mondo.
Risposta. «Ho aderito a una campagna per una
battaglia che considero più che giusta. Niente di straordinario, tra l’altro,
visto che è sempre stato il leitmotiv della mia esistenza. Oggi più che mai
bisogna combattere tutti assieme le tante discriminazioni che, purtroppo,
esistono ancora».
D. C’è chi sostiene che questa sia una legge che
limiti, in qualche modo, la libertà d’espressione.
R. «Sono dell’idea che, in questo caso specifico,
la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri».
D. A sposare certe lotte, non ha paura di deludere
i suoi sostenitori?
R. «La verità? No! Chi ha apprezzato e condiviso
il mio spirito libero e liberale, nonché le tante battaglie fatte, sono sicura
che continuerà a farlo. E poi, io, parlo per me in quanto cittadina. Non
rappresento, né voglio condizionare nessuno».
D. L’Italia e gli italiani sono pronti?
R. «Occorre iniziare oggi per le generazioni
future. Ogni rivoluzione culturale necessita di tempi molto lunghi e su questo
dissento da chi vorrebbe cambiare sempre tutto e subito. Se si pensa che ancora
oggi la donna viene accompagnata all’altare, dal padre, e viene consegnata al
futuro marito...».
D. Fa strano sentirla parlare così visto che, nel
2006 ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, urlò a Vladimir Luxuria: «Meglio
fascista che fr***o».
R. «Usai quell’espressione in risposta a una
violenta provocazione sul mio cognome. Non volevo offendere, ma porre fine a una
spiacevole discussione».
D. Ha mai chiesto scusa?
R. «Le basti pensare che io e Vladimir, oramai,
siamo amiche. Ci troviamo spesso come ospiti nelle stesse trasmissioni
televisive e non rinunciamo mai a due risate assieme».
D. Sarebbe favorevole alle adozioni per le coppie
dello stesso sesso?
R. «I bambini abbandonati negli istituti sono la
peggiore sconfitta di ogni società. L’amore deve prevalere su tutto».
D. I detrattori delle battaglie arcobaleno usano
la Gpa (gestazione per altri, volgarmente chiamata utero in affitto) per
seminare dubbi.
R. «Non le nascondo che anche io, su questo
argomento spinoso e delicato, nutro molte perplessità. Figuriamoci quando si
parla di sfruttamento della donna dietro questa pratica».
D. Se uno dei suoi tre figli, un domani le
rivelasse la propria omosessualità?
R. «Per me conta, oggi più che mai, solo ed
esclusivamente la loro felicità».
D. E si è mai chiesta del perché molte famiglie
siano così reticenti nell’accettare la sessualità dei propri figli?
R. «Perché, nonostante tutto, la nostra società
non è così aperta come sembra, tanto che talvolta l’omosessualità di un figlio
diventa un’onta per tutta la famiglia. Quando poi la sessualità non è
nient’altro che la più intima condizione di ogni individuo sulla quale nessuno
dovrebbe discutere. Invece oggi mi sembra ci sia una vera e propria ossessione».
D. Quando Platinette dichiara che “inserire
l’identità di genere nei programmi scolastici è una violenza”, che cosa pensa?
R. «Mi torna in mente il mio disagio quando da
bambina sulla pagella c’era scritto: “Firma del padre o di chi ne fa le veci”. I
miei genitori erano divorziati e firmava sempre mia madre e questo non ha idea
di quanto mi facesse soffrire».
D. È più importante l’educazione in casa o nelle
scuole?
R. «Senza alcun dubbio quella dei genitori».
D. Questo è il mese dell’orgoglio gay. Ritiene sia
ancora utile marciare, tra carri e colori, sulle note di I will survive?
R. «Trovo che musica e colori siano la migliore
cura dopo un periodo buio e triste come quello dal quale stiamo faticosamente
tentando di uscire. Mi auguro che questo spirito si riversi in ogni
manifestazione, politica e non».
D. Se venisse invitata come madrina?
R. «Madrina? Semmai padrina!».
D. Il politicamente corretto e quest’attenzione
maniacale alle desinenze affinché finiscano con la “a”, porterà a qualcosa?
R. «Trovo inutile e anche un po’ ridicolo cambiare
al femminile un termine maschile. Non sarà mai questo a eliminare le disparità
esistenti. E non è certo per questo che un sindaco, un notaio, un avvocato donna
si sentono meno rappresentative della categoria».
D. Ha mai ricevuto avance da parte di una donna?
R. «No, sempre e solo “disavance”». (Ride).
D. Sono stati più gli uomini o le donne, negli
anni, a entrare in competizione con lei?
R. «In modo anche piuttosto preponderante gli
uomini e, talvolta, usando anche mezzi abbastanza sleali, ma le dirò: meglio
guardare avanti».
D. E se le chiedessi di guardare al futuro?
R. «Mi fermerei al presente. La pandemia mi ha
insegnato a vivere giorno per giorno».
D. E io che pensavo rispondesse, dopo questa
intervista, “un ritorno in politica con il Pd”.
R. «Allora, come temevo, la strada che porta
all’accettazione dell’altrui pensiero è ancora lunga. Molto lunga». (Sorride).
D. Quando si guarda allo specchio, oggi, chi vede?
R. «Una donna soddisfatta di ciò che ha realizzato
e che, con fatica, cerca di mantenere un atteggiamento di ottimismo nonostante
quello che stiamo vivendo da oltre un anno».
D. Si piace?
R. «A fasi alterne».
D. E se tornasse indietro poserebbe ancora per
Playboy?
R. «Certo, a patto che venisse fatto un servizio
anche per... Playgirl!».
«Ma io, giurista cattolico, dico: quello
del Vaticano non è un atto di guerra». Scontro sul ddl
Zan, parla l'ex presidente della Consulta Cesare Mirabelli: «Siamo all'interno
di un rapporto tra due soggetti di diritto internazionale che hanno stipulato un
accordo». Valentina Stella su Il Dubbio il 23 giugno 2021. Il professor Cesare
Mirabelli, giurista, ex presidente della Corte Costituzionale, è stato
Segretario della Commissione per l’attuazione dell’Accordo di revisione del
Concordato e per le intese con le altre confessioni religiose. In merito alla
nota della Santa Sede inviata al nostro Governo per lanciare un allarme sul Ddl
Zan che potrebbe determinare una violazione del Concordato del 1984, Mirabelli
dice: «Gli articoli 4 e 7 lasciano troppo margine interpretativo. La Chiesa non
può rischiare sanzioni penali se decide di non benedire unioni omosessuali o se
una associazione cattolica è formata da persone di un unico sesso».
Presidente in base a quale principio la Santa
Sede ha inviato una richiesta formale al nostro Governo di modifica del Ddl Zan?
Non la qualificherei come una richiesta formale di
modifica del Ddl Zan. Siamo all’interno di un rapporto tra due soggetti di
diritto internazionale che hanno stipulato un accordo e uno dei due segnala
all’altro che esiste il rischio che quell’accordo sia violato. Non si tratta di
un atto di protesta o di contestazione ma di un gesto di cooperazione. Le pongo
una domanda: è intrusivo segnalare il rischio che un patto sia violato? Oppure
bisogna aspettare che sia violato per poi contestarlo e aprire un contenzioso?
Le note verbali rappresentano uno strumento usuale di comunicazione, di
segnalazione di problemi, di formalizzazione di osservazioni o richieste di
chiarimenti. Non è una dichiarazione di guerra, ma un tentativo di prevenire un
contenzioso. Una reazione diplomatica dopo la presunta violazione sarebbe stata
certamente più grave e avrebbe irrigidito di più i rapporti tra i due Stati.
In che cosa potrebbe consistere un contenzioso?
Tutto quello che riguarda la violazione di un
accordo di tipo internazionale. Può darsi che lo Stato italiano ritenga che
l’accordo non sia violato e allora nascerebbe un conflitto che dovrebbe
pervenire ad una composizione amichevole della controversia.
Secondo la Santa Sede il Ddl Zan violerebbe
l’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato del 1984. Può
spiegare in che termini?
L’articolo 2 sostanzialmente riafferma sul piano
bilaterale delle garanzie di libertà che la Costituzione già riconosce: quella
religiosa nella forma dell’esercizio del magistero ecclesiastico,
dell’insegnamento, della libertà della Chiesa di avere una sua visione
antropologica e di manifestarla. E poi anche la garanzia per i cattolici, ma non
solo evidentemente per loro, di piena libertà di manifestazione del pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
E allora quali sarebbero gli elementi critici?
Soprattutto gli articoli 4 e 7 del Ddl Zan
dovrebbero fornire delle garanzie per la libertà di pensiero e religiosa ma in
realtà lasciano un ampio margine interpretativo sulle eventuali conseguenze
penali. Si può sanzionare una opinione manifestata, una convinzione, una scelta
di idee se non è diretta intenzionalmente a determinare atti di violenza? Oppure
non si può manifestare una idea che sia difforme da un sentire diverso? Il
disegno di legge cerca di garantire la libertà delle scelte e il pluralismo
delle idee ma lo fa in una maniera ritenuta non adeguata e non appropriata che
mette a rischio penale determinate espressioni, indipendentemente dalla volontà
della parte di scatenerà della violenza. Si tratta di un rischio per i cattolici
ma anche per tutti gli altri cittadini. È discriminazione, ad esempio, non
consentire da parte della Chiesa la benedizione di unioni omosessuali? Questo
rientra nella libertà della Chiesa che va garantita. Non ci può essere il
rischio di denuncia penale per queste situazioni. Trattandosi di reati occorre
davvero la massima chiarezza. L’altro punto sul quale mi pare la nota della
Santa Sede faccia delle osservazioni concerne la libertà della scuola
culturalmente orientata. Le scuole cattoliche non sarebbero esentate
dall’organizzazione della futura Giornata nazionale contro l’omofobia, la
lesbofobia e la transfobia. Inoltre, nella scuola pubblica va rispettato
l’indirizzo educativo dei genitori. La scuola deve essere un luogo di educazione
alla tolleranza e di rispetto della dignità di ogni persona. In generale il
rapporto temporale e di contesto tra una posizione culturale e religiosa
espressa e l’eventuale successivo atto violento o discriminatorio è
assolutamente vago. Addirittura le associazioni cattoliche potrebbero essere
perseguite per i ruoli differenti al loro interno tra uomini e donne: immagini
che ci sia una associazione che per statuto è formata solo da donne o solo da
uomini. È una discriminazione non tollerabile? Può costituire un elemento che
sprona alla violenza? Voglio ricordare una cosa.
Prego…
Tempo addietro un giornale ha pubblicato
l’opinione di una giurista la quale si riservava di denunciare una università,
non appena il Ddl Zan fosse stato approvato, perché un libro di bioetica usato
nel corso degli studi aveva posizioni antropologiche rispetto agli omosessuali
non conformi alla linea che la legge segue. Fin quando rimangono opinioni o
insegnamento vanno contrastati con opinioni ed insegnamenti, non con sanzioni
penali. Perciò va garantita la libertà di espressione. Ma mi preme sottolineare
un’altra cosa.
Mi dica.
Questo non toglie nulla all’esigenza di assicurare
il pieno rispetto delle persone quale che sia la loro condizione o la loro
scelta di vita. Non è in gioco la dignità della persona, che deve essere
garantita in modo assoluto.
Assodato che la nota della Santa Sede sia
legittima, Lei ritiene che sia anche opportuna? Molti l’hanno letta come una
ingerenza del Vaticano nei nostri affari.
Non la riterrei una ingerenza se si tratta di una
enunciazione rispetto ad un accordo che vincola le parti. Il Parlamento potrà –
e a mio giudizio dovrebbe – tenere in considerazione le osservazioni della Santa
Sede per valutare il merito delle questioni. Tra l’altro si tratta di temi
dibattuti anche nell’ambito dello Stato.
Ci sono dei precedenti come questa nota, non
divenuti pubblici?
Non possiamo saperlo ma comunque si tratta di
strumento diffuso quello delle note verbali in cui si condensa in un piccolo
scritto quello che direi al mio interlocutore.
Ci sono spazi per un’ulteriore revisione del
concordato dopo quella del 1984 che, come nel 1946, raccolse il favore sia della
maggioranza che dell’opposizione?
Mi pare che il concordato del 1984 abbia
funzionato e che ci sia stato un clima di cooperazione come quello attuale che
permane tra lo Stato e la Chiesa. Il principio alla base è quello della
collaborazione nella distinzione delle competenze.
Concordato Vaticano Italia del 1984,
cos’è e perché, secondo la Chiesa, il Dl Zan lo viola.
Giampiero Casoni il 22/06/2021 su Notizie.it. Concordato
Vaticano-Italia, perché secondo la chiesa il Dl Zan lo viola: la nota consegnata
da monsignor Gallagher allo Stato italiano solleva un vespaio.
Concordato Vaticano-Italia, ricordare cos’è e perché secondo la chiesa il ddl
Zan lo violerebbe è improvvisamente diventato faccenda cruciale. Lo è nella
misura in cui in questi giorni il Vaticano ha formalmente chiesto al governo
italiano di modificare il disegno di legge contro l’omotransfobia approvato
dalla Camera il 4 novembre del 2020. Ma innanzitutto: perché il Vaticano ha il
diritto, non la facoltà, si badi, ma il diritto, di chiedere allo Stato italiano
di modificare una sua legge? La risposta sta proprio nella natura del Concordato
che si intende violato con il Dl Zan, almeno secondo la dichiarazione ufficiale
consegnata dal segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa
Sede, monsignor Gallagher, all’ambasciata italiana e arrivata fresca e venefica
sul tavolo del ministro Di Maio.
Concordato Vaticano-Italia, il Dl Zan viola un
“contratto” che risale al 1929. I Patti Lateranensi che si sostanziarono nel
Concordato risalgono al 1929, quando il Regno d’Italia decise di porre fine
alla “Questione romana” postasi anni prima con il culmine del Risorgimento. Con
la presa di Roma resa iconica dall’episodio della Breccia di Porta Pia l’Italia
pose fine al potere temporale dei papi, che per mezzo del loro rappresentante di
allora, Pio IX, reagirono malissimo e vietarono ai cattolici di partecipare alla
politica italiana. L’allora capo del governo Mussolini però aveva (ancora)
bisogno di legittimare il fascismo in punto di diritto e consenso, soprattutto
per accedere al serbatoio delle associazioni cattoliche giovanili e farne un
“balillificio”. Perciò promosse e stipulò i Patti del Concordato con cui Chiesa
e Regno d’Italia mettevano a contratto i reciproci rapporti.
Concordato Vaticano-Italia, il Dl Zan e la
revisione del 1984. Il Concordato venne poi sottoposto a conferma e revisione
nel 1984, quando Bettino Craxi e il cardinale Casaroli rinnovarono l’impegno e
ne modellarono l’impalcatura alle mutate circostanze storiche. Insomma, il sunto
spiccio è che ci sono cose in cui per legge e non per velleità “invasive” la
Chiesa può mettere il naso nelle faccende dello Stato. E perché questa facoltà è
stata esercitata a proposito del Dl Zan? Qui la faccenda si fa complicata e in
aiuto arriva una “rinfrescata” su cosa disciplina il disegno di legge contro
l’omotransfobia. Il Ddl voluto dal dem Alessandro Zan prevede la reclusione fino
a 18 mesi o una multa fino a seimila euro nei confronti di chi commette o istiga
ad atti di discriminazione. Inoltre prevede anche il carcere da 6 mesi a 4
anni nei confronti di chi istiga o commette violenza: poi, e qui lo snodo
giuridico cruciale, prevede l’esercizio dell’azione penale per chi partecipa a
organizzazioni che incitano a discriminazione o violenza. Il testo annovera
dieci articoli con l’estensione dei cosiddetti reati d’odio per discriminazione
razziale, etnica o religiosa a chi compia discriminazioni verso omosessuali,
donne, disabili.
Concordato Vaticano-Italia, il Dl Zan viola il
“diritto di discriminare”. In buona sostanza e per metterla giù bruta il
Vaticano ritiene che il Dl Zan “discrimini il suo diritto a discriminare”, e
siccome quel diritto è sancito da una legge precedente e prevalente (Il
Concordato) quella successiva (Il Dl Zan) scardinerebbe spirito e legiferato del
‘29 e la conferma dell’84. Ma in quali punti si sostanzierebbe questo peloso
paradosso giuridico? Nell’articolo 2 ed ai commi 1 e 3 della versione
revisionata del Concordato del 1984. Leggiamo: “La Repubblica italiana riconosce
alla Chiesa la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e
caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata
alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di
esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in
materia ecclesiastica”.
Concordato Vaticano-Italia, quali commi viola il
Dl Zan. Poi il comma 3 che garantisce “ai cattolici e alle loro associazioni e
organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Ora, dato per assunto
che per sua impalcatura etica (discutibile) e per Diritto di Stato
Sovrano (inattaccabile) il Vaticano fa un punto di orgoglio ed azione normativa
manifestare il pensiero, per singole o associate istanze, secondo criteri che
non sono proprio aderenti ed afferenti con la condanna dell’omotransfobia, una
legge che vieta la manifestazione di quei sentimenti in realtà vieta al Vaticano
di esercitare un diritto sancito da una legge, quella scaturita dall’accordo
di Villa Madama, quando Stato e Chiesa “rinnovarono i voti” della pace fatta nel
1929.
Concordato Vaticano-Italia, il Dl Zan, le scuole e
la Giornata Nazionale contro l’Omotransfobia. E sulla scorta di questo principio
il Vaticano critica anche un altro effetto del Dl Zan: quello per cui le scuole
private non sono esentate dal partecipare alla istituita Giornata Nazionale
contro l’Omotransfobia. Le scuole cattoliche sono private e il Vaticano non
vuole che i suoi spot didattici celebrino una cosa che proprio in forza della
sua mistica didattica ritiene che non sia affatto faccenda da festeggiare.
Perché è impossibile abolire il
Concordato. Andrea Muratore su Inside Over il 23
giugno 2021. Il Vaticano è entrato in gamba tesa nel dibattito pubblico italiano
pronunciandosi ufficialmente sul Ddl Zan-Scalfarotto, il discusso e controverso
disegno di legge sull’omotransfobia che violerebbe l’accordo di revisione del
Concordato siglato nel 1984 dalle autorità d’Oltretevere e dal governo italiano
di Bettino Craxi. Secondo la Santa Sede, infatti, il Ddl sull’omotransfobia
andrebbe rivisto (non eliminato, come erroneamente riportato) laddove violerebbe
la libertà garantita alla Chiesa cattolica dall’articolo 2, commi 1-3
dell’accordo di revisione del Concordato che assicurano alla Chiesa Cattolica
in Italia “libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di
esercizio del magistero e del ministero episcopale” e garanzie “ai cattolici e
alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di
manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione”. “Chi ha concordato il Concordato?” è stato il commento del
principale alfiere del Ddl Zan nel dibattito
pubblico italiano, Fedez, che assieme a diversi esponenti della sinistra
progressista ha alzato le barricate contro il Vaticano in una giornata, quella
del 22 giugno, che dopo le esclusive rivelate dal Corriere della Sera è stata
caratterizzata da un forte tam-tam mediatico e social attorno all’ipotesi
radicale di abolizione del Concordato. La nostra società odierna vive
chiaramente in una fase contraddistinta dalla fine del mito dei competenti, e
questo è palesemente sotto gli occhi di tutti, ma il mondo dei social, degli
influencer e dell’immediatezza ha prodotto un fenomeno decisamente inverso, una
diffusione generalizzata e spesso dannosa di opinioni
semplicistiche, raffazzonate e fuorvianti, molto spesso promosse proprio da
coloro che hanno i seguiti più vasti di follower e contatti. Riccardo Magi,
deputato di +Europa, è stato il primo esponente delle istituzioni a portare nel
dibattito il tema dell’abolizione del Concordato in ritorsione alla mossa senza
precedenti della Santa Sede. Una posizione che, come vedremo, è semplicemente
inattuabile. In primo luogo perché il Concordato fondato sui Patti
Lateranensi del 1929 e sugli Accordi di Villa Madama del 1984, sottoscritto da
Italia e Santa Sede, ha un surplus di profondità giuridica e politica,
stabilendo di fatto la costituzione della Città del Vaticano come Stato sovrano
ed indipendente e trovandosi ad essere un ibrido tra un trattato internazionale
e un accordo tra un’istituzione politica e una confessione religiosa come molti
stipulati in precedenza dai Papi sin dai tempi di Napoleone. In secondo luogo,
perché la Costituzione italiana, all’Articolo 7 (dunque nel pieno dei principi
fondamentali dello Stato), tutela con forma speciale l’intesa siglata dal nostro
Paese con la Chiesa cattolica e le sue istituzioni. Il fatto che l’Articolo
affermi che “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani” segnala per che motivo la nota vaticana si sia
concentrata sulle questioni di merito del Ddl Zan e non sia stata strutturata
come un’entrata in gamba tesa rischiosa. Nel 1948 la Costituzione entrò in
vigore anche grazie alla mediazione che la Democrazia Cristiana e il Partito
Comunista riuscirono a trovare sull’inserimento del Concordato nella suprema
carta, accettato con lungimiranza da Palmiro Togliatti. In sostanza, nota Il
Sussidiario, “la Costituzione italiana ha tutelato la realtà considerata parte
integrante del sistema di valori civili, morali, politici e religiosi – ovvero
la Chiesa: se questo dovesse cambiare in futuro, non è dato saperlo ad ora e di
certo non dovrebbe essere il punto di discussione all’interno di un disegno di
legge in tema di diritti civili-libertà di opinione”. Infine, vi è una questione
d’ordine politico di cui tenere conto. Il Vaticano non ha fatto, in fin dei
conti, che esplicitare in termini chiari e precisi quanto già sottolineato
dalla Conferenza episcopale italiana, che nelle scorse settimane non aveva
chiuso unilateralmente al Ddl Zan ma chiesto solo, semplicemente, che i punti
più controversi venissero chiariti e sanati. La nota con l’appello al Concordato
è sicuramente dura, ma in sostanza dà applicazione a quanto aveva espresso nelle
scorse settimane il cardinale Bassetti, presidente della Cei, che rispetto al
ddl Zan contro l’omofobia aveva dichiarato che ci fosse ancora tempo per un
“dialogo aperto” per arrivare a una soluzione priva di “ambiguità e di forzature
legislative”. E la reazione aperturista di Enrico Letta, segretario di quel
Partito Democratico che è il primo propugnatore della nuova legge, alla nota
vaticana fa capire che proprio questo è l’obiettivo politico dell’Oltretevere.
Il punto, dunque, è sulla lettera del Concordato, sui suoi articoli espliciti, e
non sulla ratio di fondo che ne ha giustificato la promozione e la stipulazione.
Ogni dibattito da social sugli inviti al governo italiano a recedere
unilateralmente da un accordo che regola i rapporti con la principale
confessione religiosa del Paese e determina l’indipendenza di uno Stato sovrano
per le questioni del Ddl Zan è semplicemente malposto o fuorviante. Sarà
la mediazione politica a dover sanare ogni effettivo punto di attrito.
Il sospetto di Bizzarri
che asfalta la sinistra: "Ddl Zan scritto male?".
Francesca Galici il 23 Giugno
2021 su Il Giornale. Luca Bizzarri si espone domandando se, forse, il ddl Zan
non avesse problemi di stesura e contro di lui si è scatenato il fuoco amico. Se
anche a sinistra iniziano a esserci dubbi sul ddl Zan, forse un problema
effettivamente esiste. E Luca Bizzarri ci ha provato a farlo notare su Twitter
con una lucidità invidiabile, la stessa con la quale si è poi dovuto difendere
dai kompagni per aver azzardato una critica al disegno di legge di Alessandro
Zan, che da ieri è tornato al centro dell'attenzione per l'appunto fatto dal
Vaticano sulla possibilità che nella sua attuale stesura violi il Concordato.
"Però, dopo mesi, dopo che viene attaccata da destra (evabè, ci sta) da una
parte di sinistra, dalle femministe, e ora pure dai preti… Non è che questa
legge Zan è, semplicemente, scritta male? Perché a volte i pasticci e
gli slogan fanno più danni degli omofobi, temo", ha scritto l'attore sollevando
un legittimo dubbio. La legittimità del dubbio e il diritto di critica, però,
non fanno parte del mondo radical chic, al quale comunque Bizzarri appartiene.
Infatti sono bastati pochi minuti all'attore per ricevere centinaia di commenti,
molti dei quali infarciti di populismo spiccio e di poca conoscenza
dell'argomento. Diversi anche i personaggi noti che hanno contraddetto Luca
Bizzarri, che ha semplicemente espresso un suo libero pensiero in merito al ddl
Zan sul quale, forse, i kompagni vorrebbero non ci fosse critica in nome di un
concetto democratico molto particolare. A Luca Bizzarri, per esempio, ha
risposto Luca Viotti, ex europarlamentare del Partito democratico: "No, caro
Luca. Sul #ddlzan decine di giuristi hanno scritto opinioni favorevoli e
contrarie. Puoi leggerli, farti un’idea e sostenerla pubblicamente. Fare una
domanda su twitter sai bene che non risolverà il tuo dubbio ma, ripeto, creerà
polemiche e avvelenerà i pozzi". Quindi Twitter va bene solo per fare propaganda
pro ddl Zan per i dem, non per sollevare dubbi? E infatti Luca Bizzarri ha
replicato: "Scusa ma sei tu che dici che decine di giuristi hanno scritto
opinioni favorevoli E CONTRARIE. Visto che le ho lette, mi chiedo se non sia
migliorabile. O quei giuristi con idee contrarie sono tutti dei pericolosi
omofobi? Ma perché ogni volta che mi dai torto poi mi dai ragione?". Messo con
le spalle al muro, Viotti ha risposto: "Se hai letto quelle opinioni ti sarai
già fatto un’idea: la legge va bene o non va bene. Dì liberamente quel che pensi
e se pensi che sia 'migliorabile' aiuta il dibattito dicendoci cosa va
modificato, quali parti". E Luca Bizzarri ci ha provato a dire la sua sul modo
di migliorare il ddl Zan: "Per esempio vorrei sapere se nella legge viene
trattato il caso in cui qualcuno possa dirti: 'Puoi partecipare al dibattito ma
solo nei modi e nei termini che dico io'". Ma dopo questa domanda, di Viotti, si
sono perse le tracce. Luca Bizzarri ha avuto modo di scontrarsi anche con un
giornalista che, per aver espresso un dubbio sul ddl Zan, ha accusato l'attore
di sostenere le fake news. E la reazione di Bizzarri non si è fatta attendere:
"Ma cosa sostengo? Ma quali fake news? Lo ripeto, la reazione pavloviana di
quelli come te che se uno non urla immediatamente 'bravo, giusto!' ma si pone
semplicemente delle domande sulla soluzione (sul problema siamo tutti d’accordo,
spero) sarebbe esilarante, non fosse tragica".
Francesca Galici. Giornalista
per lavoro e per passione. Sono una sarda trapiantata in Lombardia. Amo il
silenzio.
Ma l'ingerenza è un
autogol.
Marco Zucchetti il 23 Giugno 2021 su Il Giornale. Per anni, chi in Italia ha
difeso la sacrosanta libertà di parola e pensiero delle gerarchie ecclesiastiche
sui temi etici della politica italiana, ha usato un argomento semplice: la
Chiesa fa la Chiesa. Per anni, chi in Italia ha difeso la sacrosanta libertà di
parola e pensiero delle gerarchie ecclesiastiche sui temi etici della politica
italiana, ha usato un argomento semplice: la Chiesa fa la Chiesa. Ovvero tutela
legittimamente il suo magistero, la sua dottrina, anche i suoi interessi. Ma se
appelli, prediche e moral suasion sono un diritto, l'atto formale con cui il
Vaticano chiede al governo italiano «non di bloccare, ma di rimodulare» il
disegno legge Zan è qualcos'altro. Non una discussione fra due istituzioni (e
Nazioni, giova ricordarlo), ma una battaglia di carte bollate su una norma,
peraltro non ancora promulgata. È il segno che la Chiesa, oltre a fare la
Chiesa, torna a sentire l'impulso - covato dai tempi di San Pietro e messo in
soffitta dalla breccia di Porta Pia e dal Non expedit - di fare anche lo Stato.
Su questo Giornale lo abbiamo scritto molte volte: il disegno di legge Zan
contro l'omotransfobia è divisivo, pasticciato e presenta più di un nodo sulla
salvaguardia della libertà di pensiero e sulla propaganda fra i minori a scuola.
Posto che queste criticità sono state espresse da un ventaglio molto eterogeneo
di categorie, dai comunisti ai vescovi, dalle femministe ai conservatori,
davvero serviva al dibattito questa specie di anatema? L'intervento della Santa
Sede sposta il centro del discorso. Perché ora non si discetta più di una legge
buona o cattiva, ma di chi deve decidere se lo è. E la sensazione è che anche
quei liberali che osteggiano il provvedimento siano infastiditi da un'ingerenza
così pesante. Gli italiani meritano di essere rappresentati da una classe
politica che si prenda la responsabilità di decidere se il ddl Zan fa schifo, è
ottimo o è da modificare, senza essere imbeccata o commissariata da un'autorità
esterna. Invece lo spettacolo dei partiti in queste ore è penoso. La sinistra
degli ultrà arcobaleno che ha fatto muro in Parlamento ora si affretta a dire
che è giusto dialogare. I sovranisti che tuonavano contro il «ce lo chiede
l'Europa», ora esultano se le richieste arrivano da Oltretevere. Pochi che
ricordino un semplice punto: compito degli eletti, a cui spetta il potere
legislativo da Costituzione, è ascoltare tutti (dunque anche una Chiesa
cristiana cattolica su cui si fonda la cultura nazionale) e poi legiferare in
autonomia, salvo assumersi le responsabilità davanti agli elettori delle proprie
scempiaggini. E sull'eventuale incompatibilità con i trattati internazionali è
la Consulta a doversi esprimere. Fine della querelle dallo stantio sapore
Risorgimentale. Invece questa scomposta entrata a gamba tesa senza precedenti
polarizza le posizioni, rinfocola le solite accuse da bar alla Chiesa che non
paga le tasse e difende i pedofili e riesce nel miracolo di trasformare un
provvedimento discutibile nella bandiera dell'indiscutibile primato dello Stato
laico. Così che - invece di salvaguardare «la libertà garantita ai cattolici
dall'articolo 2 del Concordato» - il Parlamento finirà per approvare la legge
per ripicca, e per dimostrare un'orgogliosa autonomia (presunta). Con il
risultato che la legge passerà e limiterà la libertà di tutti, non solo dei
cattolici. In punta di diritto starà ai giuristi decidere se la protesta è
fondata. Ma politicamente è un autogol goffo, ostile e anche un po' fastidioso.
Viene da dire che per fortuna chi amministra il Vaticano non viene eletto a
suffragio universale: difficilmente verrebbe rieletto. Marco Zucchetti
La nota, gli incontri e il
Papa: ecco cosa è successo in Vaticano.
Francesco Boezi il 23 Giugno
2021 su Il Giornale. Il Vaticano reagisce al Ddl Zan. Con l'atto formale emerso
ieri, la Santa Sede rivendica libertà. Ecco cosa si muove in queste ore tra le
mura leonine. Molti si stupiscono perché non se lo sarebbero mai aspettato. Ma
l'atto formale con cui il Vaticano è intervenuto sul Ddl Zan, oltre a essere
legittimo, è in linea con quanto scritto e detto in materia bioetica (e non solo
su quella) durante questo pontificato. La nota verbale di cui si parla in queste
ore è un atto formale. Se la Conferenza episcopale italiana avesse espresso un
parere non sarebbe stato lo stesso, e non avrebbe fatto il medesimo rumore. Ecco
perché, con buone probabilità, la protagonista di questa vicenda è la Segreteria
di Stato. Non solo: visto che l'oggetto della discussione è divenuto il
Concordato, è normale che a intervenire sia il dicastero presieduto dal
cardinale Pietro Parolin. Diviene un discorso di competenze, cosa che
Oltretevere è ancora molto sentita.
La scelta dei tempi. Le
tempistiche sono un fattore da non sottovalutare in questa storia. Sarebbe stata
una "interferenza", come vanno denunciando adesso certi ambienti progressisti,
se l'iter parlamentare fosse appena iniziato. Ma il Ddl Zan è già in
discussione, e ad oggi più di qualche esponente politico di spessore ha già
rimarcato la necessità di approvarlo così com'è. Poi c'è chi come il segretario
del Pd Enrico Letta sembra aver cambiato idea in maniera repentina. Il timing
dei sacri palazzi, insomma, sembra tenere conto pure della politica e dei suoi
tempi. Perché siamo in una fase avanzata.
Quegli incontri nei Sacri
Palazzi. Fonti qualificate hanno riferito a ilGiornale.it di incontri che
sarebbero avvenuti nei giorni scorsi, in particolare di meeting tra la
segreteria di Stato ed esponenti del mondo conservatore. Insomma, qualcuno
dotato di un certo peso politico avrebbe insistito con il "ministero degli
Esteri" della Santa Sede con motivazioni tagliate sulle criticità del Ddl in
oggetto. Altre fonti sostengono che la segreteria di Stato avesse già deciso di
agire attraverso una mossa ufficiale, che si sarebbe declinata nelle asserzioni
che vengono accostate a monsignor Paul Richard Gallagher. Se ne dicono tante.
Certo è un evento raro. E questo forse perché quasi mai una norma aveva messo in
discussione il Concordato nella sua stessa impostazione. Almeno stando ai
contenuti della nota che sono rimbalzati ieri di quotidiano in quotidiano.
L'alto ecclesiastico originario di Liverpool, del resto, avrebbe posto proprio
la questione del rispetto del Concordato, che è un architrave della storia
diplomatica italiana e vaticana:"Alcuni contenuti attuali della proposta
legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà garantita alla Chiesa
Cattolica dall'articolo 2, commi 1 e 3 dell'accordo di revisione del
Concordato". Tra le frasi che abbiamo avuto modo di leggere, quella sulla
libertà garantita alla Chiesa cattolica; è di sicuro tra le più rilevanti. Roma
ne fa pure una battaglia di libertà, quindi.
I protagonisti della vicenda e
il ruolo del Papa. I protagonisti di questa vicenda sono almeno tre. Il primo è
il cardinale Pietro Parolin, teorico e pratico del multilateralismo diplomatico
e figura chiave di questo pontificato. Il secondo è monsignor Paul Richard
Gallagher, che sarebbe l'autore della nota e dunque il consacrato preposto, pure
per via del suo status di segretario per i Rapporti con gli Stati, ad occuparsi
in prima persona della faccenda. Infine, Papa Francesco, che molti associano al
progressismo ideologizzato (quindi indirettamente ad un presunto riguardo verso
qualunque provvedimento provenga da parte progressista), ma che non può non aver
letto i contenuti della nota verbale. Questa storia secondo cui il pontefice
argentino non verrebbe messo al corrente di alcune prese di posizione ufficiali
provenienti dalle mura leonine ( o che non le condividerebbe) è ormai
un leitmotiv. In termini di procedure tipiche nelle stanze vaticane, però, è
sostanzialmente impossibile che un atto del genere venga inoltrato senza la
previa visione ed approvazione del pontefice. Vale pure per le benedizioni alle
coppie omosessuali che certi ambienti tedeschi vorrebbero approvare. Jorge Mario
Bergoglio, sin da quando si è seduto sul soglio di Pietro, ha identificato la
cosiddetta "teoria gender" - quella che per i conservatori sarebbe alla base del
Ddl Zan - con qualcosa che andrebbe "contro il progetto di Dio". Ipotizzare che
Francesco la pensi in un modo e la segreteria di Stato in un altro, dunque,
risulta un po' forzato, per usare un eufemismo. Possibile che la Curia viva una
fase di scontro interno? Pensare che all'interno del Vaticano esistano sia
ecclesiastici favorevoli al Dll Zan sia elementi contrari è del tutto naturale.
La Chiesa cattolica, durante questi ultimi decenni, è stata animata da un
pluralismo che coinvolgerà in via indiretta anche certi scossoni legislativi che
la politica avrebbe intenzione di dare. Questo però non può significare che la
segreteria di Stato agisca senza badare al pensiero e alla pastorale del sovrano
pontefice.
Francesco Boezi. Sono nato a
Roma il 30 ottobre del 1989, ma sono cresciuto ad Alatri, in Ciociaria. Oggi
vivo in Lombardia. Sono laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
presso la Sapienza di Roma. A ilGiornale.it dal gennaio del 2017, mi occupo e
scrivo soprattutto di Vaticano, ma tento spesso delle sortite sulle pagine di
politica interna. Per InsideOver seguo per lo più le competizioni elettorali
estere e la vita dei partiti fuori dall'Italia. Per la collana "Fuori dal Coro"
de IlGiornale ho scritto due pamphlet: "Benedetti populisti" e "Ratzinger, il
rivoluzionario
Il risveglio della Chiesa.
Felice Manti
il 23 Giugno 2021 su Il Giornale. Eppur si muove. La Chiesa tuona contro le
storture del ddl Zan che vincola la libertà di pensiero. Di tutti, non solo dei
cattolici. Eppur si muove. La Chiesa tuona contro le storture del ddl Zan che
vincola la libertà di pensiero. Di tutti, non solo dei cattolici. Lo fa a
sorpresa, senza troppe liturgie, con un atto inusuale che i detrattori del Papa
ammantano di fragilità per svilirne la potenza, ovattarne il fragore. E invece è
un sussulto d'orgoglio che fa tremare chi pensava di poter addomesticare un
pensiero che sopravvive immutato da migliaia di anni. E che risveglia un senso
di appartenenza un po' sfiorito sotto i colpi della secolarizzazione, ammonendo
tutti che la liquidazione dei cattolici è ancora di là da venire. È come negli
anni Settanta, osserva qualcuno, quando la Chiesa ha scommesso contro l'aborto e
il divorzio. Ha perso una battaglia, certo. Ma non la sua identità. Con questa
nuova scommessa il Vaticano rivendica il suo bottino, la supremazia dei suoi
valori non negoziabili, striglia una classe politica imbelle, le ricorda che non
si possono mescolare diritti e desideri e superare indenni la traversata del
Tevere. Certo, passata la paura per la scossa che ha terremotato il Parlamento,
l'armata Brancaleone del ddl Zan ha schierato i suoi cavalli e i suoi alfieri a
difesa della laicità dello Stato. Ex sacerdoti sposati con uomini, cantanti
convintamente mai battezzati, laici di professione, tutti insieme
appassionatamente a sperticarsi di esegesi biblica, a interpretare la parola di
Dio al Vaticano e alla Cei, ad ammonire i cattolici, a vagheggiare di una Chiesa
profondamente divisa. Come se uno juventino volesse spiegare il tremendismo
granata al Grande Torino, e fa già ridere così. Anziché entrare nel merito del
ddl Zan e della sua deriva ideologica si ritira fuori il solito distillato
anticlericale, «pénsino ai preti pedofili», «e allora l'Imu», «aboliamo il
Concordato». Chi lodava il Bergoglio pro immigrazione ora ne reclama
l'interferenza, smascherando la sua sulfurea ipocrisia. Puoi parlare finché
reciti a memoria il pensiero unico. Ma non praevalebunt, non prevarranno. Non
questa volta. La ferita al Paese aperta negli anni Settanta brucia ancora. Per
spezzare «in nome del popolo sovrano» un legame deciso a tavolino, senza
sentimenti e pieno di violenza, abbiamo svuotato i legami familiari, abusandone
fino a codificarli in mediocri contratti. Per togliere al padre padrone
qualsiasi diritto sul corpo della donna abbiamo spento la luce a milioni di
creature la cui unica colpa è non avere parola, figurarsi diritto di voto. Oggi
la risposta è una famiglia frammentata, l'utero che si voleva proteggere si
svende al mercato della genetica. Il nuovo, comodo alibi si chiama «omotransfobia»,
lo spauracchio è la violenza contro gli omosessuali. Fenomeno spregevole, già
ampiamente normato e lontano dall'essere un'emergenza, a meno di una difficile
alchimia statistica. Lo dice un costituzionalista «laico» come Michele Ainis:
«Il ddl Zan è superfluo perché le fattispecie che enumera sono tutte già nel
nostro codice penale». Imporre una giornata sulle teorie gender alle scuole
elementari, cattoliche o meno, è un abominio. Si vuole manipolare la chimica, la
biologia e financo l'italiano per rivendicare una presunta molteplicità di
identità di genere, rendere eguali nelle officine dell'ipocrisia le diversità,
imbrigliare l'intimità e renderla mutevole in base a una «percezione»,
indipendentemente da un «percorso di transizione sessuale». Una fictio juris,
che inventa una realtà che non esiste. Come sempre la Chiesa, che mette al
centro la persona, non i suoi desideri, rivendica una verità cristallina.
Eppure, in questi tempi è un atto rivoluzionario, il peso di una croce che solo
la Chiesa può sollevare senza il timore di soccombere. Felice Manti
DAGONEWS il 23 giugno 2021.
Come riportato nel suo articolo di oggi sul “Corriere della Sera” da Massimo
Franco, la diffusione della nota verbale del Vaticano sul DDL Zan è uno
sgambetto che colpisce il Papa, ma principalmente indirizzato al Cardinal
Bassetti, segretario della Conferenza Episcopale Italiana. A far circolare il
documento è stato “il partito di Ruini”, che ha voluto mandare un segnale contro
la timidezza e l’immobilismo delle gerarchie ecclesiastiche sul disegno di
legge. Tra le mura leonine si vocifera di un messaggio fatto recapitare da
Bergoglio direttamente a “Mariopio” Draghi: “Pace con l’Italia”. Un segnale di
via libera al DDL Zan che passerà con piccoli ma sostanziali aggiustamenti.
Massimo Franco per
il "Corriere della Sera" il 23 giugno 2021. «Se non fossimo intervenuti,
rischiavamo un pronunciamento della Cei simile a quella su Joe Biden dei vescovi
americani contrari a dare la comunione ai politici che sostengono il diritto
all' aborto». La lettura che nel cuore del potere vaticano si dà dello strappo
della Santa Sede sulla legge Zan in materia di omofobia rimanda agli equilibri
precari nel mondo cattolico; al rapporto complicato tra il papato di Francesco e
l'episcopato italiano; e all' insoddisfazione nei confronti del presidente, il
cardinale Gualtiero Bassetti, e della stampa di area cattolica, accusati
sottovoce di eccessiva timidezza. Le rimostranze contro governo e Parlamento
dove è in discussione una legge contestata e divisiva vanno filtrate con lenti
che non riguardano soltanto le relazioni con Palazzo Chigi, il M5S e una parte
consistente della sinistra. La nota di protesta della quale ha dato notizia il
Corriere, con l'accusa di violare alcune norme del Concordato, è in primo luogo
un modo per ricompattare un'unità in bilico. E riflette la preoccupazione della
Chiesa italiana di ritrovarsi con una legislazione che farebbe finire «nel
tritacarne delle accuse di discriminazione e omofobia» qualunque sacerdote. D'
altronde, erano mesi che cresceva la pressione di alcuni settori dell'episcopato
su Bassetti. Si voleva una presa di posizione netta, dura: anche a costo di
essere accusati di un'ingerenza di altri tempi. Ma si è aspettato a causa
dell'epidemia del coronavirus, e dell'esigenza di non esasperare una
contrapposizione sgradita al Papa e scivolosa per le implicazioni politiche. «La
Cei aveva parlato due volte, ma con toni troppo accomodanti», si spiega. «Un
segnale di debolezza». Esponenti come l'ex presidente della Cei, Camillo Ruini,
hanno dato voce a chi voleva un atteggiamento di netta contrarietà. Ai vescovi
che lo hanno interpellato, Ruini ha detto che occorreva «battersi nella certezza
di avere ragione». Secondo il cardinale, «sarebbe una follia se con la legge Zan
si pretendesse di chiuderci la bocca, di non farci insegnare il catechismo. È
una legge che non può essere applicata così com' è». La svolta vaticana si è
avuta dopo che il 17 giugno scorso l'ambasciatore d' Italia presso la Santa
Sede, Pietro Sebastiani, ha ricevuto la nota dalle mani del «ministro degli
esteri», l'inglese monsignor Richard Gallagher. Alla fine ha prevalso l'esigenza
di battere un colpo, per quanto clamoroso e senza escludere l'eventualità di un
irrigidimento delle forze politiche. Nell' iniziativa vaticana si avverte un
calcolo: quello di dividere partiti e schieramenti meno granitici nel sostegno
alla legge di quanto appaia ufficialmente. La legge Zan è considerata figlia di
una fase di governo cementata lungo l'«asse radicaleggiante», viene definito
così, tra l'allora premier grillino Giuseppe Conte e l'allora segretario del Pd,
Nicola Zingaretti. Sotto voce, esponenti dei Cinque Stelle e del Pd ammettono
che qualche ragione il Vaticano può accamparla. È noto, ad esempio, che in
questi mesi si sono consolidati i rapporti tra monsignor Gallagher e il ministro
degli Esteri grillino, Luigi Di Maio. Ma si tratta di posizioni che appaiono
minoritarie. Anche perché non mancano nemmeno vescovi perplessi dall' iniziativa
presa da Gallagher per conto della segreteria di Stato e avallata da Francesco.
Il timore è che ridia fiato a chi invoca una disdetta del Concordato; a chi
chiede alla Chiesa di pagare gli arretrati sui suoi immobili; e punta il dito
contro la pedofilia dei sacerdoti. A caldo qualcuno ha tentato perfino di
accreditare la nota della Santa Sede come «uno sgambetto a Bassetti e un
dispetto al Papa»: tesi grottesca e insultante nei confronti del pontefice. La
realtà è che l’asse giallorosso M5S-Pd ha avuto a lungo sponde potenti nelle
gerarchie cattoliche. La confusione delle reazioni che l'iniziativa sta
provocando testimonia quanto la mossa arrivata da Oltretevere spiazzi posizioni
date per scontate. Al vertice del Pd, che un Ruini defilato definisce in privato
«una pagliuzza», il segretario Enrico Letta ha parlato subito della possibilità
di ridiscutere alcuni aspetti giuridici del disegno di legge, pur difendendone
l'impianto. Il problema è che voci anonime filtrate dal partito hanno ribadito
una linea di chiusura totale. Il Vaticano ora fa sapere che l'obiettivo è
«rimodulare, non bloccare la legge Zan». Il leader della Lega, Matteo Salvini,
schierato con la Cei col resto del centrodestra, con toni moderati ha chiesto di
vedere Letta per trovare una mediazione. Ma non sarà facile, con un sistema
politico e un mondo cattolico divisi e sfibrati. Forse è un caso ma è in uscita
un libro di intellettuali cattolici, tra cui Giuseppe De Rita, Andrea Riccardi e
Romano Prodi, ma anche la regista Liliana Cavani, sul declino della Chiesa
italiana. Titolo: «Il gregge smarrito».
Fiorenza Sarzanini e Francesco
Verderami per "il Corriere della Sera" il 23 giugno 2021. La segreteria di Stato
vaticana «auspica che la parte italiana possa tenere in debita considerazione le
argomentazioni e trovare così una diversa modulazione del testo continuando a
garantire il rispetto dei Patti lateranensi». Eccolo il passaggio chiave della
nota verbale consegnata dal cardinale Paul Richard Gallagher il 17 giugno e
subito tramessa dall' ambasciatore italiano presso la Santa Sede Pietro
Sebastiani al ministero degli Esteri, a Palazzo Chigi e al Quirinale. Ecco la
frase che impegna il governo - la «parte italiana» - a trattare. La
comunicazione è giunta per via diplomatica, ma non c' è dubbio che il premier
fosse già stato informalmente messo a parte dalla Sante Sede del disagio per la
possibile approvazione della legge, se è vero - come sottolinea un ministro -
che «le note verbali sono elementi abituali, sempre frutto di precedenti
incontri». Numerose fonti di governo lo confermano, spiegando come sia
«impensabile che il Vaticano abbia formalizzato una posizione così netta senza
alcuna avvisaglia precedente. Il tema viene valutato con grande attenzione». E
già oggi in Parlamento Mario Draghi dirà che «dovranno essere valutati gli
aspetti segnalati da uno Stato con cui abbiamo rapporti diplomatici». Un modo
per rispondere alle sollecitazioni vaticane in attesa di trovare - grazie anche
al lavoro degli esperti - una soluzione che non appare facile. Il disegno di
legge Zan è infatti già stato approvato dalla Camera e l'esecutivo dovrà
scegliere la strada per inserirsi nel percorso parlamentare senza «interferire».
Secondo la Santa Sede «alcuni contenuti della proposta legislativa avrebbero
l'effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa e ai
suoi fedeli». La norma contestata riguarda la mancata esenzione delle scuole
cattoliche dalle attività previste nella Giornata nazionale contro l'omofobia,
la lesbofobia e la transfobia. In particolare si stigmatizza «il riferimento
alla criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi fondati sul
sesso». Nella nota verbale c' è un passaggio in cui si sottolinea che «ci sono
espressioni della sacra scrittura e della tradizione ecclesiale del magistero
autentico del Papa e dei vescovi, che considerano la differenza sessuale secondo
una prospettiva antropologica che la Chiesa cattolica non ritiene disponibile
perché derivata dalla stessa rivelazione divina». Proprio sulla base di questa
considerazione si sollecita la revisione del ddl Zan. Da qui si dovrà adesso
ripartire per sbrogliare la matassa di una legge che aveva già evidenziato
profonde divisioni tra i partiti della maggioranza. Una moral suasion da portare
avanti con estrema cautela, ma anche con la determinazione di non mettere in
discussione gli accordi tra l'Italia e lo Stato Vaticano. La reazione del
premier Draghi nel corso della conferenza stampa convocata dopo l'incontro con
la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, a chi gli chiedeva che
cosa farà il governo, dimostra quanto spinosa sia la questione. «È una domanda
importante», ha sottolineato evidenziando la necessità di «rispondere in maniera
strutturata». E così confermando l'esigenza di garantire i rapporti con la Santa
Sede, di salvaguardare l'indipendenza del Parlamento ma anche di accompagnare
l'approvazione di norme che proteggano le libertà. Per questo viene letto come
un segnale importante la scelta del ministro per gli Affari europei Vincenzo
Amendola di firmare - insieme ad altri 13 Stati membri dell'Unione - una
«richiesta di chiarimenti» avanzata nei riguardi dell'Ungheria su alcune leggi
approvate in quel Paese che «producono discriminazioni in base all' orientamento
sessuale». E finora «non sono arrivati chiarimenti soddisfacenti». Intervenendo
oggi in Parlamento, Draghi fornirà chiarimenti lasciando probabilmente intendere
che la soluzione non è comunque imminente. Servirà una riflessione approfondita,
e il tempo verrà usato per far decantare il clamore. Magari consentendo ai
gruppi della larga maggioranza di lavorare a un compromesso su un testo che è
diventato terreno di scontro politico. E che peraltro non avrebbe i numeri per
essere definitivamente approvato. Si vedrà se la mossa del Vaticano spingerà i
partiti verso un accordo.
l "non possumus" sui
diritti scatena la rissa tra partiti. Cosa sono i Patti Lateranensi e cosa
c’entrano con il Ddl Zan.
Fabrizio Mastrofini su Il Riformista il 23 Giugno 2021. È un
fatto senza precedenti (almeno quelli noti) la richiesta del Vaticano al governo
italiano di modificare il ddl Zan, il disegno di legge contro l’omofobia.
Dalla Segreteria di stato – secondo quanto ha rivelato ieri il Corriere della
Sera – è partita una nota a firma del segretario vaticano per i Rapporti con gli
stati, mons. Paul Richard Gallagher. Nel documento, prontamente inoltrato al
governo dall’Ambasciatore italiano presso la Santa Sede – che l’ha ricevuto il
17 giugno – si sottolinea che alcuni passaggi del decreto legge
Zan violerebbero “l’accordo di revisione del Concordato” del 1984. Secondo
quanto è trapelato la Nota rileva che «alcuni contenuti della proposta
legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà garantita alla Chiesa
cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del
Concordato». Di che si tratta esattamente? Il comma 1 dice: “La Repubblica
italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua
missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di
santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di
organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e
del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”.
Il comma 3 stabilisce invece che «è garantita ai cattolici e alle loro
associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione
del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Il
costituzionalista Cesare Mirabelli ha spiegato quali siano le questioni
problematiche in una lunga conversazione con VaticanNews, la testata informativa
italiana del Dicastero per la Comunicazione. «Non si tratta di contestare o di
contrastare la protezione particolare che vuole essere assicurata a determinate
categorie di persone», ha spiegato Mirabelli. Gli aspetti rischiosi hanno a che
fare con la tutela «della libera espressione di convinzioni che possono essere
legate a valutazioni antropologiche su alcuni aspetti. È particolarmente
rischioso se la previsione di norme penali possano limitare la libertà di
espressione e di manifestazione del pensiero. Sotto questo aspetto la nota
verbale della Santa Sede è una comunicazione che viene fatta, una segnalazione
di attenzione per il rischio di ferire alcuni aspetti di libertà che l’accordo
di revisione del Concordato assicura. Non si chiedono quindi privilegi». In
maniera ancora più specifica il costituzionalista ha notato: «Si deve evitare
che ci sia un rischio di sanzionare penalmente espressioni o comportamenti che
sono riconducibili a convincimenti, ma che non sono né di aggressione, né di
violenza, né di incitazione all’odio, anche se possono altri su queste opinioni
fondare le loro condotte». Inoltre un “punto critico” riguarda la libertà della
scuola e la libertà educativa dei genitori. «Se varata (la legge Zan, ndr),
questo tipo di garanzie, che la legge vuole introdurre, diventa una presenza non
allineata con l’impostazione educativa dei genitori o l’orientamento, ad
esempio, di istituzioni che possono essere cattoliche, ma anche di altro
orientamento culturale, che hanno una diversa identità». Tra le questioni
sollevate c’è il fatto che le scuole cattoliche non sarebbero esentate
dall’organizzazione della futura Giornata nazionale contro l’omofobia, ma si
evidenziano anche timori più generali per la “libertà di pensiero” dei cattolici
e anche delle possibili conseguenze giudiziarie nell’espressione delle proprie
idee. Sollecitata in proposito, la Sala stampa vaticana ha confermato
all’agenzia Ansa l’intervento sul ddl Zan, spiegando che ha l’obiettivo “non di
bloccare” il ddl Zan ma di «rimodularlo in modo che la Chiesa possa continuare a
svolgere la sua azione pastorale, educativa e sociale liberamente». Tra i
capi-dicastero della Santa Sede, è toccata una domanda, nella conferenza stampa
di ieri su tutt’altro tema, al cardinale Kevin Joseph Farrell, Prefetto del
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Il porporato ha spiegato
genericamente che «certamente c’è la preoccupazione della Santa Sede e di
ciascuno di noi». Sul piano politico, dopo le anticipazioni del Corriere della
Sera, sono fioccate le dichiarazioni dei partiti. Il deputato Pd Alessandro
Zan non ha dubbi: «Il testo non limita in alcun modo la libertà di espressione,
così come quella religiosa. E rispetta l’autonomia di tutte le scuole». Il
segretario del Pd Enrico Letta, su Twitter, ha scritto: «Attendiamo quindi di
vedere i contenuti della Nota della Santa Sede lì preannunciata. Ma abbiamo
fortemente voluto il ddl Zan, norma di civiltà contro reati di odio e
omotransfobia e confermiamo il nostro impegno a farla approvare». «Sul ddl
Zan io sono pronto a incontrare Letta, anche domani, per garantire diritti e
punire discriminazioni e violenze, senza cedere a ideologie o censure, e senza
invadere il campo di famiglie e scuole», ha sottolineato il leader della
Lega, Matteo Salvini, sempre su Twitter. Il senatore leghista Andrea
Ostellari ha precisato che dopo aver sentito la presidente del Senato «ho fatto
richiesta formale di acquisire il testo della rilevante nota che lo
Stato Vaticano ha inviato alla Farnesina. Ai fini del lavoro che sta compiendo
la commissione Giustizia del Senato, è fondamentale conoscere e valutare i
rilievi sollevati dalla Santa Sede». Gabriele Piazzoni, segretario generale
di Arcigay, dal canto suo rileva che «l’attivazione della diplomazia Vaticana
con l’utilizzo del Concordato per cercare di bloccare l’iter della legge Zan al
Senato è un qualcosa senza precedenti nelle relazioni tra la Repubblica Italiana
e la Santa Sede, il tentativo esplicito e brutale è quello di sottrarre al
Parlamento il dibattito sulla Legge e trasformare la questione in una crisi
diplomatica, mettendola nella mani del Governo Draghi per far si che tutto venga
congelato». Per Antonio Tajani di FI «non siamo una caserma e ci sarà qualcuno
che può pensarla in maniera diversa». Per la ministra della Famiglia Elena
Bonetti «c’è un dibattito in Parlamento e Italia Viva porta avanti un’idea di
ricomposizione della politica. Per dotare il Paese di una legge che condanni
l’omotransfobia va usato il metodo del dialogo tra i partiti, non del dibattito
ideologico». Barricadero Nicola Fratojanni, segretario nazionale di Sinistra
Italiana: «Occorre che governo e Parlamento reagiscano in modo deciso. E voglio
dire al Vaticano che, se vede minacciato il Concordato, allora quel Concordato
lo possiamo anche ridiscutere».
La Conferenza episcopale
italiana è intervenuta due volte, il 10 giugno 2020 ed il 28 aprile 2021, per
ribadire che non serve una nuova legge rispetto alle norme attualmente esistenti
che puniscono l’omofobia. Il presidente dei vescovi italiani, cardinale
Bassetti, il 17 maggio, sempre al Corriere della Sera, diceva che «se si ritiene
utile una legge specifica contro l’omofobia, va bene», ma occorre “la
chiarezza”: perché «così com’è ora è un testo che si presta a essere
interpretato in varie maniere e può sfociare in altre tematiche che nulla hanno
a che vedere con l’omofobia, gli insulti o le violenze». Ma l’ultima parola
spetterà a Mario Draghi. «Domani io sono in Parlamento e risponderò in maniera
ben più struttura di quanto possa fare oggi», ha detto il premier a margine
della conferenza stampa con Ursula von der Leyen.
Fabrizio Mastrofini.
Giornalista e saggista specializzato su temi etici, politici, religiosi, vive e
lavora a Roma. Ha pubblicato, tra l’altro, Geopolitica della Chiesa cattolica
(Laterza 2006), Ratzinger per non credenti (Laterza 2007), Preti sul lettino
(Giunti, 2010), 7 Regole per una parrocchia felice (Edb 2016).
Vittorio Feltri e la follia
del ddl Zan: "Vietato dire onora il padre e la madre", i Dieci Comandamenti da
stracciare.
Libero Quotidiano il 23 giugno 2021. “Occhio. Se passa la legge Zan bisogna
correggere i dieci comandamenti: non si potrà dire onora il padre e la madre, ma
onora il genitore uno e il genitore due. Divertente”. Così Vittorio Feltri in un
commento su Twitter ha scatenato la sua proverbiale ironia, centrando però un
punto importante. Sul ddl Zan la discussione si è infiammata nuovamente dopo che
il Vaticano ha chiesto formalmente di modificare alcuni passaggi che
violerebbero il Concordato. Ovviamente si è scatenata una feroce polemica
politica, anche se Pd e M5s si sono poi tirati indietro alla Camera, non ponendo
la questione a Mario Draghi, che pure aveva fatto sapere di aver preparato una
risposta articolata. Si confida che al Senato qualcuno si faccia avanti, anche
perché gli italiani pretendono giustamente risposte. Nel frattempo Feltri nel
suo editoriale odierno ha espresso il suo punto di vista: “Il Vaticano c’è. È
uno Stato che con l’Italia ha firmato un concordato che fissa le regole di buon
vicinato. E queste regole vanno rispettate in forma bilaterale”. “Pertanto - ha
aggiunto - è da fessi prendersela col monsignor Gallagher, ministro degli Esteri
del Papa, soltanto perché dichiara apertis verbis che la legge Zan, di cui si
discute da tempo, non è conforme ai patti sottoscritti tra la chiesa e il nostro
nevrotico paese. Attaccare i preti, come sta avvenendo, poiché la pensano
diversamente dai progressisti è una operazione scorretta sotto ogni punto di
vista”.
Ddl Zan, Vittorio Feltri
denuncia la vergogna della sinistra: i compagni che vogliono imbavagliare la
Chiesa.
Vittorio Feltri su Libero Quotidiano il 23 giugno 2021. Il Vaticano c'è. È uno
Stato che con l'Italia ha firmato un concordato che fissa le regole di buon
vicinato. E queste regole vanno rispettate in forma bilaterale. Pertanto è da
fessi prendersela col monsignor Gallagher, ministro degli Esteri del Papa,
soltanto perché dichiara apertis verbis che la legge Zan, di cui si discute da
tempo, non è conforme ai patti sottoscritti tra la Chiesa e il nostro nevrotico
Paese. Attaccare i preti, come sta avvenendo, poiché la pensano diversamente dai
progressisti è una operazione scorretta sotto ogni punto di vista. La libertà
di opinione è sacra e inviolabile, ed è garantita tra l'altro dalla nostra
Costituzione. Quindi le gerarchie ecclesiastiche non possono essere zittite
perché esprimono le loro idee circa l'omofobia. Esse, secondo le norme vigenti,
sono autorizzate a intervenire sulle questioni etiche senza subire ritorsioni di
alcun genere. È assurdo impedire a vescovi e cardinali di osteggiare una
leggediscutibile. Personalmente non sono credente e neppure omofobo. Delle
abitudini sessuali dei miei simili non mi importa un accidente. Dirò di più, non
ho mai conosciuto una persona che detesti gli omosessuali e li combatta come
nemici dell'umanità. Non capisco il motivo per cui si debba varare una regola
per puni rechi non abbia in simpatia gli omosex, i quali se vengono aggrediti da
qualcuno ovvio siano tutelati dal codice penale, come qualsiasi connazionale. Ma
è assurdo che menare un invertito sia più grave, e meriti sanzioni più pesanti,
che non menare altri cittadini. Gli uomini e le donne sono tutti uguali e
meritano lo stesso rispetto. Creare distinzioni tra chi ama i maschi ole femmine
è fuori da ogni logica, ciascuno faccia ciò che desidera, non c'è bisogno di
creare una graduatoria per stabilire se sia peggio dare un cazzotto a un
omosessuale che a un etero. In certe nazioni islamiche si arriva al punto di
impiccare quelli che il popolo definisce froci, il che ci ripugna. Ciononostante
non si può neppure considerare, come ci accingiamo a fare noi, che gli omofili
costituiscano una razza eletta degna di maggior rispetto. Tra l'altro alcuni
giorni fa la scrittrice Murgia ha manife stato il suo disgusto nei confronti di
Figliuolo, quello dei vaccini, in quanto indossa la divisa militare. E nessuno
l'ha rimproverata. Ergo. Gli alpini se ti stanno sulle scatole è una cosa
normale, se non apprezzi i trans devi essere condannato. Siamo alla follia.
Adesso tocca al Vaticano essere messo sotto accusa perché critica, usando
argomenti che non è importante condividere, la legge Zan. Ormai la censura è
scatenata e colpisce chiunque non si adegui al conformismo più bieco. Non si
tiene neanche conto che gli italiani e gli europei sono tutti pervasi dalla
cultura cristiana, la quale abbiamo assimilato in famiglia e a scuola. Come
diceva Benedetto Croce: non possiamo non dirci cristiani.
Ddl Zan, la clamorosa frase
"rubata" a Papa Francesco: "Ora me li chiedono tutti", terrorizzato da Sergio
Mattarella.
Libero Quotidiano il 23 giugno 2021. Un caso deflagrato con lo scoop
del Corriere della Sera. Si parla della lettera inviata dal Vaticano alla
Farnesina, ossia al governo, in cui viene avanzata la richiesta di fermarsi sul
ddl Zan, il contestatissimo disegno di legge sulla omotransfobia contro il
quale, ora, piove il veto anche della Santa Sede. Una missiva, quella del
Vaticano, che sarebbe dovuta rimanere segreta: risale infatti a giorni fa.
Eppure è diventata di dominio pubblico. E, forse, alla Santa Sede era proprio
l'obiettivo che volevano raggiungere. Il dibattito, ovviamente, si è infiammato:
che ne sarà del disegno di legge tanto voluto dal Pd e tanto osteggiato dal
centrodestra, Silvio Berlusconi compreso? E nel frattempo fioccano
indiscrezioni, retroscena, illazioni. Papa Francesco sapeva? Il Pontefice
condivide? Probabilmente sì, dato che la missiva è vergata dal ministro degli
Esteri vaticano, fedelissimo di Bergoglio. E ancora, si legge di spaccature
profondissime alla Santa Sede dopo quanto accaduto. Un contesto esplosivo,
insomma, nel quale entra a gamba tesa l'irresistibile Osho, ovviamente sulla
prima pagina de Il Tempo, il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis,
nell'edizione di oggi, mercoledì 23 maggio. In prima pagina, ecco il titolo: "Il
Vaticano non fa Zan Zan. No alla legge sull'omofobia". E in calce l'ironia di
Osho. Una foto di Papa Francesco, alle sue spalle Sergio Mattarella, e quella
frase "rubata" al Pontefice: "Mò questi me chiedono tutti l'arretrati Ici...
guarda eh". Insomma, Osho, a modo suo, svela il vero e inconfessabile timore del
Papa.
Vaticano contro il ddl Zan,
Antonio Socci: Papa Francesco divorzia dalla sinistra, "le vere ragioni dello
strappo".
Antonio Socci su Libero Quotidiano il 23 giugno 2021. Il fatto che la Santa
Sede sia stata costretta a fare un passo diplomatico formale per segnalare
al Governo italiano che il disegno di legge Zan, attualmente sotto esame
parlamentare, violerebbe il Concordato fra Stato italiano e Chiesa Cattolica sul
tema della libertà (attenzione: non si sta parlando di un "privilegio" della
Chiesa, ma delle libertà di tutti gli italiani) è un evento eccezionale, che è
accaduto raramente e che dovrebbe far suonare un campanello d'allarme. Infatti
in questa occasione la Chiesa non entra nel merito di questa o quell'opinione su
omosessualità, genere o famiglia, temi su cui ci sono molte idee diverse (di
sicuro sotto l'attuale pontificato non sono mai state intraprese particolari
"battaglie culturali" in proposito). Ma la Santa Sede ha preso questa iniziativa
eccezionale proprio in difesa delle tante sensibilità diverse, cioè in difesa
del diritto di libertà che, in Italia, dovrebbe accomunare tutti in base al
dettato costituzionale che è recepito nella revisione del Concordato del 1984
fra Stato italiano e Chiesa Cattolica. È curioso che quella Sinistra che
applaude il papa ogni volta che interviene su temi politici riguardanti altri
stati, non di diretta competenza della Santa Sede, come l'emigrazione, si irriti
se la stessa Santa Sede interviene su temi che attengono al Concordato che ha
sottoscritto con lo Stato italiano. In particolare la nota diplomatica vaticana
richiama l'attenzione del Governo sull'articolo 2, commi 1 e 3, del Concordato.
Il comma 1 recita: "La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la
piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di
evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la
libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del
magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia
ecclesiastica". E il comma 3: "È garantita ai cattolici e alle loro associazioni
e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". La Santa Sede ha
voluto porre formalmente all'attenzione del Governo il problema della libertà
religiosa, della libertà educativa e della libertà d'opinione a proposito del
Ddl Zan - scrive il vaticanista Giuseppe Rusconi - in particolare per gli
articoli 1 (identità di genere), 4 (libertà d'opinione), 7 (istituzione della
Giornata nazionale sui temi Lgbt) e 8 (la "strategia della Corte Costituzionale,
ieri ha ricordato alcuni problemi posti da questa legge che preoccupano la Santa
Sede: «Addirittura le associazioni cattoliche potrebbero essere perseguite per i
ruoli differenti al loro interno tra uomini e donne. Ancora: un'università
cattolica potrebbe essere denunciata penalmente per l'adozione di testi di
bioetica, come già c'è chi preannuncia di fare, non ap pena il Ddl Zan sarà
approvato». Carlo Giovanardi, già ministro per la famiglia, esulta per
l'iniziativa vaticana: «Da mesi stiamo spiegando come quel testo, già approvato
dalla Camera, non riguarda affatto violenze o discriminazioni, ma si prefigge
l'obiettivo di colpire penalmente chi vuole essere libero di esprimere una
opinione e di indottrinare i bambini sin dalle elementari alla ideologia Lgbt».
Ma oltre ai politici cattolici e a giuristi come Alfredo Mantovano, autore del
libro "Legge omofobia perché non va" (Can tagalli), anche un costituzionalista
come Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Consulta ed ex ministro di
Grazia e Giustizia, si è espresso per la modifica del Ddl Zan. Perfino un
giurista laico come Michele Ainis, editorialista di Re pubblica e L'Espresso, ha
sotto lineato le grosse criticità dique sta legge. Probabilmente in Vaticano
hanno sperato fino all'ultimo di evitare il passo diplomatico. In questi mesi
hanno sperato che il Pd (in particolare il suo segretario, Letta) accettasse il
dialogo per concordare con tutti una legge contro l'intolleranza, senza ledere
diritti di libertà. Era intervenuta anche la Cei, chiedendo di evitare «derive
liberticide» e più recentemente è arrivata a dire che non era necessario
cancellare tutta la legge, ma solo correggerla. Ma le Sinistre (Pd, M5S, Leu) -
ricorda Giovanardi - «hanno innalzato un muro, opponendosi con arroganza e
sicumera ad ogni tipo di confronto, non soltanto con la opposizione parlamentare
e la società civile, ma anche con le femministe, che attraverso l'imposizione
del gender vedono messe a rischio storiche battaglie per la emancipazione delle
donne». Enrico Letta, di fronte alle critiche di alcuni dirigenti Pd, aveva
indicato di approvare il Ddl Zan «così com' è». Perché? Si ritiene che - con il
crollo del governo giallorosso - il Pd lettiano, smarrito e confuso per l'arrivo
del governo Draghi, abbia cercato una qualche vittoria politica per dare un
segno di vitalità. Forse fiutando la strumentalizzazione, Italia viva si era
dissociata, aprendo alle modifiche del testo della legge. È chiaro perciò che
ora l'iniziativa vaticana sia sentita da Letta come una pesante bocciatura per
sé. Ma è anche un segnale forte per certi settori "rivoluzionari" del mondo
cattolico. Il Pontefice, soprattutto nelle ultime settimane, sembra voler
smentire chi finora ha auspicato (o temuto) che volesse ribaltare la Chiesa.
Pare che siano in corso - in queste ore - sottili "pressioni" perché il Papa
sconfessi la sua Segreteria di Stato. Ma - come dice il professor Mirabelli -
«non si può immaginare che un passo di questo genere sia avvenuto senza
l'assenso esplicito di Papa Francesco». Tutto può essere, ma una smentita
delegittimerebbe lo stesso Pontefice e demolirebbe la Segreteria distato, cioè
il governo della Chiesa. A chi ha parlato della nota vaticana come «un dispetto
della Curia contro il Papa», ha replicato il sito Il Sismografo (molto vicino
alla Segreteria di Stato vaticana e di idee bergogliane) scrivendo: «Una certa
stampa che dice di rispettare i cattolici dovrebbe per primo rispettare il Papa
e non usarlo per i suoi giochi di potere». Far credere che certe iniziative
«accadano alle spalle del Pontefice, non è accettabile» ha aggiunto, «questa
narrazione danneggia enormemente il prestigio e la credibilità di Papa Francesco
poiché lo fa percepire come un pastore poco lineare, non trasparente,
manipolatore del vero e del falso». Invece, per capire il suo pontificato, c'è
chi ricorda il magistero di questi anni di Francesco sulla libertà dei popoli,
per esempio gli interventi in cui ha messo in guardia dalle «colonizzazioni
culturali». Come questa sua omelia: «Si toglie la libertà, si decostruisce la
storia, la memoria del popolo e si impone un sistema educativo ai giovani».
Vaticano contro ddl Zan,
Pietro Senaldi: "Il Pd? Convinto che Papa Francesco debba comportarsi come
loro".
Libero Quotidiano il 23 giugno 2021. Il condirettore di Libero Pietro
Senaldi sul Ddl Zan e la reazione del Pd: "Il Pd si è perso il Papa, perché al
Ddl Zan il Vaticano si è opposto: in base a questa legge noi del Vaticano
potremmo essere accusati di essere omofobi e razzisti. Ovviamente, i
progressisti, convinti che il Papa tifasse per loro si sono indignati. Direi che
siamo al cortocircuito: la sinistra quando qualcuno sostiene qualcosa che gli fa
comodo diventa un idolo, sennò diventa un poveretto. Questa è la stessa sinistra
che si inginocchia di fronte a Binden, all'Europa, a Macron, quella pronta a
cedere la sovranità all'Europa su tutto. I nodi stanno arrivando al pettine: si
vuole imporre il proprio pensiero per legge vietando agli altri di esporre le
proprie idee. Siamo alle soglie di una dittatura politico-mediatica".
Otto e Mezzo,
delirio-Michela Murgia sul ddl Zan: "Se uno viene pestato?". Per lei chi dice
"no" vuole nascondere le violenze.
Libero Quotidiano il 24 giugno
2021. Nel salottino di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, nella puntata in onda su La7
mercoledì 23 giugno, tiene banco il ddl Zan. Il tutto al termine della giornata
in cui in Parlamento, dopo l'intervento del Vaticano contro il disegno di
legge, Mario Draghi ha ribadito la laicità dello Stato aggiungendo però che
toccherà alle aule decidere sul testo in questione. Insomma, da parte del
premier non sembra esserci la volontà di tirare dritto su un provvedimento
troppo divisivo per la sua maggioranza. Ed ecco che in studio dalla Gruber
campeggia Michela Murgia, la scrittrice rossa e fierissima sostenitrice del ddl
Zan, la quale argomenta: "Il termine è nella natura della legge, che istituisce
quella omofobica e transfobica, oltre che quella verso i disabili e le donne,
come una discriminazione. Quello che non si vuole che venga scritto nero su
bianco è che queste categorie subiscono una discriminazione", la spara. "Se uno
viene picchiato per strada, si dice che viene picchiato da un balordo e non
perché omosessuale o in quanto donna. Nel momento in cui si nega il fenomeno,
non si vuole una legge che il fenomeno lo certifica. Quando dicono che vogliono
modificare il testo, significa che vuole fermare il testo", sentenzia la Murgia.
Insomma, secondo lei l'obiettivo di chi è contrario al ddl Zan è imboscare
violenze e discriminazioni. Non, semmai, tutelare la libertà d'espressione che
in alcune circostanze sembra essere seriamente minacciata. La Murgia, per
inciso, si è distinta nelle ultime ore anche per un intervento su La Stampa, in
cui ha messo nero su bianco come, a suo giudizio, la contrarietà del Vaticano al
ddl Zan sarebbe dovuta alla paura di "dover insegnare il rispetto delle persone
nelle scuole paritarie". Frasi che danno la cifra del personaggio in
questione...
Ddl Zan, Michela Murgia
contro il Vaticano: "La paura di rispettare le persone" (e quella balla sui
licenziamenti).
Libero Quotidiano il 23 giugno 2021. Parla di una "entrata a
gamba tesa" che non si vedeva "dai tempi non rimpianti della presidenza Cei del
cardinal Ruini" del Vaticano sul ddl Zan Michela Murgia. Che in un articolo
su La Stampa scrive. Addirittura l'attacco viene, sottolinea la scrittrice dalla
"segreteria di stato vaticana, l'equivalente del ministero degli esteri, con una
nota a firma del segretario per i rapporti con gli stati". Insomma, prosegue la
Murgia. "la percezione è che il ddl zan sia solo l'ennesima arma della guerra
che va consumandosi nelle stanze vaticane, dove c'è da mesi la corsa a chi più
mette in imbarazzo papa Francesco allo scopo di delegittimarne l'autorevolezza
esterna, visto che quella interna è compromessa da tempo". Quindi la scrittrice
sinistra lancia una frecciata a Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "La parte più
retriva dello scenario politico, quella che si fa i selfie con Orban, è già
pronta a sfruttare questa lotta intestina, ma il timore fondato è che tutta la
politica italiana, sempre intimorita dallo spauracchio curiale, possa
essere incline a dar retta alla richiesta di rivedere un disegno di legge che è
già frutto di mille compromessi". Ma, attacca la Murgia, "la principale
preoccupazione vaticana è che, se la legge viene approvata, le scuole cattoliche
non saranno esentate dal dover insegnare il rispetto per le persone, quale che
sia la loro condizione e il loro orientamento. Ma perché mai dovrebbe essere
diversamente? Perché per una parte del sistema scolastico finanziato dallo stato
dovrebbero valere leggi diverse da quelle che valgono per tutti gli altri? Se le
scuole cattoliche rivendicano la qualifica di paritarie, sarebbe ora che lo
fossero in tutto, non solo quando si tratta di ricevere i fondi pubblici". E
conclude durissima: "Purtroppo, anche senza aspettare il ddl Zan, la realtà è
che le scuole cosiddette paritarie la discriminazione la praticano già. Se
divorzia o va a convivere, chi vi insegna corre già il rischio di poter essere
licenziato, nonostante sia anche con le sue tasse che viene garantita
l'esistenza degli istituti cattolici all'interno del sistema educativo
pubblico". Anche se non è esattamente così.
Da ansa.it il 24 giugno 2021.
Il presidente della commissione Giustizia del Senato, il leghista Ostellari, ha
convocato per mercoledì un tavolo di confronto della maggioranza sul ddl Zan
contro la omotransfobia. un passo verso la trattativa dopo la tensione con il
Vaticano. “Lo Stato italiano è laico, non confessionale. Concordo pienamente con
il presidente del Consiglio Draghi sulla laicità dello Stato e sulla sovranità
del Parlamento italiano”, ha detto anche il Segretario di Stato vaticano
Parolin, aggiungendo che la Santa Sede non vuole bloccare la legge ma esprime
una preoccupazione su possibili interpretazioni. Il card. Parolin spiega la
genesi dell'iniziativa della Santa Sede: "Avevo approvato la Nota Verbale
trasmessa all'ambasciatore italiano e certamente avevo pensato che potevano
esserci reazioni. Si trattava, però, di un documento interno, scambiato tra
amministrazioni governative per via diplomatica. Un testo scritto e pensato per
comunicare alcune preoccupazioni e non certo per essere pubblicato". Il
Segretario di Stato vaticano rileva poi che "l'intervento è stato preventivo
proprio per fare presenti i problemi prima che sia troppo tardi. Il disegno di
legge è stato già approvato, peraltro, da un ramo del Parlamento. Un intervento
solo successivo, una volta cioè che la legge fosse stata adottata, sarebbe stato
tardivo. Alla Santa Sede si sarebbe potuto imputare un colpevole silenzio,
soprattutto quando la materia riguarda aspetti che sono oggetto di un accordo".
Infine spiega perché sia intervenuto il Vaticano e non la Cei: ""La Conferenza
episcopale italiana - dice Parolin a Vatican News - ha fatto tutto il possibile
per far presenti le obiezioni al disegno di legge. Ci sono state due
dichiarazioni in proposito e il quotidiano dei cattolici italiani, Avvenire, ha
seguito con molta attenzione il dibattito. Anche la Cei, con la quale c'è piena
continuità di vedute e di azione, non ha chiesto di bloccare la legge, ma ha
suggerito delle modifiche. Le preoccupazioni della Santa Sede sul ddl Zan sono
legate al fatto che "il concetto di discriminazione resta di contenuto troppo
vago. In assenza di una specificazione adeguata corre il rischio di mettere
insieme le condotte più diverse e rendere pertanto punibile ogni possibile
distinzione tra uomo e donna, con delle conseguenze che possono rivelarsi
paradossali e che a nostro avviso vanno evitate, finché si è in tempo.
L'esigenza di definizione è particolarmente importante perché la normativa si
muove in un ambito di rilevanza penale dove, com'è noto, deve essere ben
determinato ciò che è consentito e ciò che è vietato fare". Le preoccupazioni
della Santa Sede sul ddl Zan sono legate al fatto che "il concetto di
discriminazione resta di contenuto troppo vago. In assenza di una specificazione
adeguata corre il rischio di mettere insieme le condotte più diverse e rendere
pertanto punibile ogni possibile distinzione tra uomo e donna, con delle
conseguenze che possono rivelarsi paradossali e che a nostro avviso vanno
evitate, finché si è in tempo. L'esigenza di definizione è particolarmente
importante perché la normativa si muove in un ambito di rilevanza penale dove,
com'è noto, deve essere ben determinato ciò che è consentito e ciò che è vietato
fare".
Ddl Zan, il cardinale
Pietro Parolin: "Mario Draghi ha ragione, lo Stato è laico".
Libero quotidiano il 24 giugno
2021. Ora, dice la sua il cardinal Pietro Parolin. Si parla ovviamente del ddl
Zan, della lettera del Vaticano e di quanto detto alla vigilia in aula alla
Camera da Mario Draghi. "Non è stato in alcun modo chiesto di bloccare il ddl
Zan. Siamo contro qualsiasi atteggiamento o gesto di intolleranza o di odio
verso le persone a motivo del loro orientamento sessuale, come pure della loro
appartenenza etnica o del loro credo. La nostra preoccupazione riguarda i
problemi interpretativi che potrebbero derivare nel caso fosse adottato un testo
con contenuti vaghi e incerti, che finirebbe per spostare al momento giudiziario
la definizione di ciò che è reato e ciò che non lo è", ha rimarcato il
porporato. Uno schiaffo alla sinistra, insomma, che ha puntato il dito
affermando che la sovranità del Parlamento fosse in pericolo. Quella sovranità
che, spiega Parolin, nessuno ha voluto mettere in discussione. Il
sottosegretario di Stato in Vaticano, interpellato da Vatican News, aggiunge
di condividere le parole di Draghi al Senato: "Lo Stato italiano è laico, non è
uno Stato confessionale, come ha ribadito il presidente del Consiglio. Concordo
pienamente con il presidente Draghi sulla laicità dello Stato e sulla sovranità
del Parlamento italiano. Per questo si è scelto lo strumento della Nota Verbale,
che è il mezzo proprio del dialogo nelle relazioni internazionali", puntualizza.
Tutto chiaro: il Vaticano chiede semplicemente di modificare il ddl Zan poiché
violerebbe il Concordato. Parolin, successivamente, si spende nello spiegare le
principali preoccupazioni della Chiesa, che sono legate al fatto che "il
concetto di discriminazione resta di contenuto troppo vago. In assenza di una
specificazione adeguata corre il rischio di mettere insieme le condotte più
diverse e rendere pertanto punibile ogni possibile distinzione tra uomo e donna,
con delle conseguenze che possono rivelarsi paradossali e che a nostro avviso
vanno evitate, finché si è in tempo - rimarca Parolin -. L'esigenza di
definizione è particolarmente importante perché la normativa si muove in un
ambito di rilevanza penale dove, com'è noto, deve essere ben determinato ciò che
è consentito e ciò che è vietato fare", conclude il sottosegretario di Stato.
Chi è Pietro Parolin, lo
stratega di papa Francesco.
Emanuel Pietrobon su Inside
Over il 25 giugno 2021. Dietro ogni grande statista aleggia l’ombra di abili
diplomatici e strateghi lungimiranti, novelli cardinali Richelieu che alla luce
dei riflettori del palcoscenico internazionale preferiscono l’anonimato e il
buio garantiti dal dietro le quinte, il luogo in cui si decide il film e in cui
vengono scritti i copioni degli attori. Nel caso della Chiesa cattolica, unica
nell’essere una potenza di cielo, nell’avere un’agenda innatamente votata
all’universalità, nel possedere un esercito armato di croci e nell’operare su un
orizzonte temporale orientato alla Fine dei tempi, colui che sta suggerendo
all’orecchio dell’attuale sovrano di Roma, Francesco, risponde al nome di Pietro
Parolin.
Una vita dedicata alla Chiesa.
Pietro Parolin nasce il 17 gennaio 1955 nel micro-comune vicentino di Schiavon.
Di umili origini – la madre insegnava alle scuole elementari, il padre era
ferramenta –, Parolin sperimenta il dolore del lutto a soli dieci anni, perdendo
il padre in un incidente stradale. Quattro anni più tardi, nel 1969, all’età di
soli quattordici anni, il giovane Parolin riceve la “chiamata” ed entra nel
seminario vescovile di Vicenza: sarà l’inizio di una lunga ed ascendentale
carriera all’interno della Chiesa cattolica. Dopo aver ricevuto l’ordinazione
sacerdotale nel 1980, cioè undici anni dopo l’entrata in seminario, Parolin
trascorre i primi tre anni da chierico presso la diocesi di Vicenza. In lui,
però, i superiori vedono qualcosa; perciò lo inviano a Roma. Una volta qui,
nella capitale d’Italia e nel cuore della Cristianità occidentale, Parolin si
iscrive alla Pontificia università gregoriana e viene ammesso alla Pontificia
accademia ecclesiastica – è il 1983 –, ovvero la storica scuola di formazione
della diplomazia vaticana. Nel 1986, dopo aver conseguito una laurea in diritto
canonico presso la Gregoriana, parte alla volta della Nigeria per servire nella
nunziatura apostolica ivi operante. Rimarrà a Lagos tre anni, cioè fino al 1989,
per poi essere trasferito in Messico. E sarà precisamente qui, a Città del
Messico, che il promettente Parolin riuscirà a far sì che il suo nome venga
conosciuto a San Pietro, negoziando con il governo messicano il riconoscimento
giuridico della Chiesa cattolica e l’apertura di relazioni diplomatiche
ufficiali con la Santa Sede – due fascicoli congelati da sessant’anni, ovvero
dalla sanguinosa guerra cristera degli anni Venti e Trenta. Raggiunto l’accordo
con Città del Messico, Parolin viene richiamato a Roma: per lui c’è un posto
all’interno della Segreteria di Stato, l’equivalente vaticano di un ministero
degli Esteri, che, naturalmente accettato, ricoprirà fino al 2000.
La scalata ai vertici della
piramide pietrina. La guerra fredda è finita e la Chiesa cattolica può e deve
trarne vantaggio per espandersi in nuovi territori, evangelizzando laddove, fino
ai primi anni Novanta, era stato tanto impossibile quanto impensabile – come
la Cina –; questa era l’idea che accomunava Giovanni Paolo II, il
futuro Benedetto XVI e anche gli strateghi Tarcisio Bertone e Parolin.
Quest’ultimo, mostrando una predilezione per l’Oriente, dopo essere stato
investito dal papa polacco del ruolo di sottosegretario agli Esteri della
Segreteria di Stato – è il 2002 –, comincia a viaggiare in Asia, gettando le
basi per la svolta cinese del Vaticano. Nel 2009 viene nominato nunzio
apostolico in Venezuela dall’allora Benedetto XVI. L’obiettivo del pontefice è
chiaro: delegare all’abile Parolin la gestione dello spinoso fascicolo Hugo
Chavez, con il quale la Chiesa venezuelana è ai ferri corti sin dagli albori del
bolivarismo per una serie di ragioni, in primis per le accuse di interferenza
negli affari interni del Paese. I rapporti, pur continuando ad essere tesi, con
il tempo miglioreranno progressivamente: un altro successo per il Parolin, che,
non a caso, lo stesso anno della nomina a nunzio apostolico, verrà consacrato
arcivescovo.
Al servizio di papa Francesco.
Profondo conoscitore dell’America Latina – Parolin parla fluentemente spagnolo
–, nella quale ha aiutato la Chiesa a prosperare dal Messico al Venezuela, ma
anche abile negoziatore, nonché lungimirante stratega – a lui si deve la posa
della prima pietra nei rapporti con Pechino, visitata per la prima volta nel
2005 –, l’arcivescovo viene eletto segretario di Stato da papa Francesco nel
2013. Fatto cardinale l’anno successivo alla nomina a segretario di Stato,
Parolin si mette subitaneamente a lavoro per dare concretezza a quelli che sono
i sogni propri e del nuovo vescovo di Roma: la costruzione di una “Chiesa in
uscita” – uscita definitiva dall’Occidente ed ingresso più marcato nelle
“periferie del mondo” –, la formulazione di un corso d’azione equilibrato
nell’ambito nella cosiddetta “terza guerra mondiale a pezzi” e la trasformazione
del Vaticano in una forza catalizzatrice della transizione multipolare. A
Parolin si devono, tra le altre cose, il raggiungimento della dichiarazione di
L’Avana del 2016 con la Chiesa ortodossa e l’accordo sulla nomina dei vescovi
cinesi; due avvenimenti storici che hanno condotto il Vaticano ad
avvicinarsi rispettivamente alla Russia e alla Cina, ossia i due principali
rivali dell’Occidente nel contesto della nuova guerra fredda, inimicandosi gli
Stati Uniti e, a latere, l’intera internazionale sovranista. E a lui si deve
anche, ad esempio, l’accordo di pace tra il governo colombiano e le Farc del
2016 – mediato dal Vaticano. Descritto da alcuni vaticanisti come un vincitore
della “guerra civile vaticana” che ha dilaniato San Pietro negli anni della
transizione dall’era Ratzinger all’era Bergoglio, Parolin, oggi, può essere
ritenuto a tutti gli effetti il secondo uomo più potente della Chiesa cattolica
e l’artefice del grande ritorno del Vaticano nell’arena internazionale. E, nello
stesso modo in cui Agostino Casaroli è ricordato dai contemporanei per aver
aiutato Giovanni Paolo II ad abbattere l’impero sovietico, Parolin, forse,
potrebbe essere celebrato dai posteri come colui che ha facilitato la
transizione multipolare e che, soprattutto, ha saputo traghettare la Chiesa
dall’anziano, poststorico e postcristiano Occidente alle giovani e vibranti
periferie del mondo, riconfermandone la natura unica di catéchon impegnato a
lavorare per il bene e per la pace in un mondo afflitto dal male e dalle guerre.
Massimo Franco per
il "Corriere della Sera" il 25 giugno 2021. «Mario Draghi non poteva che dire
quanto ha detto in Parlamento. Sa che il Vaticano vuole una mediazione, e credo
sia la stessa intenzione del governo...». Il messaggio che arriva dai vertici
della Santa Sede è di chi ritiene di avere compiuto una mossa obbligata, e di
avere ricevuto una risposta. E adesso si prepara a una trattativa lunga e
difficile, avendo di fronte non Palazzo Chigi ma un Parlamento percorso da
fremiti ideologici che al momento sembrano non dare spazio al dialogo; e
soprattutto mostrano uno schieramento che va dal M5S al Pd, aggrappato in
apparenza alla bandiera della legge Zan sull' omofobia così com' è, quasi fosse
una sorta di confine invalicabile tra progresso e reazione. L' ostacolo più
serio sono «le due tifoserie che si combattono a colpi di ideologia», impedendo
qualunque passo avanti. Il primo effetto è che si incrina la collaborazione
stretta, perfino la subalternità della Chiesa cattolica allo Stato italiano nei
mesi della pandemia. E la paura è che questo faccia riemergere un fronte ostile
al Concordato. Il paradosso politico è che a difendere il Vaticano sono Lega,
Fratelli d' Italia e Forza Italia: partiti considerati non in sintonia con
l'attuale pontificato su temi dirimenti come l'immigrazione, il sovranismo, e il
modo di intendere l'identità e i valori cristiani. L' imbarazzo delle gerarchie
ecclesiastiche è palpabile. Da leader come Matteo Salvini «ci divide un alfabeto
culturale diverso», spiega un alto prelato. Il problema è che il lessico della
Santa Sede fatica a fare breccia nell' intero arco politico. Colpisce la
mancanza di partiti considerati sponde affidabili. «Al massimo ci sono individui
in grado di dare voce alle nostre ragioni», si spiega. «Ma sono troppi e insieme
troppo deboli». Trasuda l'irritazione nei riguardi del vertice del Pd,
oscillante tra aperture e chiusure: viene ritenuto condizionato dalla componente
ex comunista e vittima di una «deriva radicale». Quanto al grillismo,
l'atteggiamento è stato sempre di profonda diffidenza: sebbene sia emersa a
intermittenza la tentazione di utilizzare esponenti che ricoprono ruoli
istituzionali. Ma la questione è drammatizzata dalle divisioni che attraversano
lo stesso mondo cattolico. Intorno alla nota ufficiale consegnata il 17 giugno
all' ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani, fioriscono
le voci più curiose: indiscrezioni che segnalano confusione e tensioni nelle
gerarchie ecclesiastiche. Ma il fatto che sia stata la Santa Sede a compiere il
passo ribadisce un principio: è il Vaticano come Stato a chiedere il rispetto
del Concordato con l'Italia. I vescovi hanno un ruolo diverso: anche se la
pressione è arrivata da lì. Il modo in cui ieri il cardinale Pietro Parolin,
«primo ministro» di Francesco, ha rivendicato con Vatican News l'iniziativa,
conferma la divisione dei compiti con una Cei accusata di eccessiva timidezza.
L' idea di un Papa defilato, quasi neutrale, è goffa e strumentale; e riceve
smentite a tutto tondo. «Il principio è che di tutto quello che si fa si
informano sempre i superiori», ha detto Parolin. E a ribadire al Messaggero la
sintonia sull' iniziativa tra Francesco e il segretario di Stato è anche
Giovanbattista Re, decano del Collegio cardinalizio. L' obiettivo primario è
disarmare chi parla di ingerenza: si vedrà con quale esito. Parolin afferma di
concordare «pienamente con il presidente Draghi sulla laicità dello Stato e
sulla sovranità del Parlamento italiano. Per questo si è scelto lo strumento
della Nota verbale, che è il mezzo proprio del dialogo nelle relazioni
internazionali». Aggiunge che si trattava di «un documento interno, scambiato
tra amministrazioni governative per via diplomatica». Sono toni difensivi che
tradiscono un disagio. Cercano di giustificare una mossa che, sebbene definita
un «mezzo proprio», rimarca l'assenza di dialogo tra le due sponde del Tevere e
la preoccupazione per il testo del deputato del Pd, Alessandro Zan, in
discussione in Parlamento. Difensivo è anche il modo in cui Parolin assicura di
non voler chiedere «in alcun modo di bloccare la legge»; e di essere «contro
qualsiasi atteggiamento o gesto di intolleranza o di odio verso le persone a
motivo del loro orientamento sessuale». Il tema, semmai, è come la legge può
essere interpretata, con il rischio di «spostare al momento giudiziario la
definizione di ciò che è reato e ciò che non lo è». Traduzione: il Vaticano teme
che la magistratura possa usare la legge contro i sacerdoti, e «rendere punibile
ogni possibile distinzione tra uomo e donna». Per questo si chiede che venga
cambiata in alcuni punti «prima che sia troppo tardi» e si imputi alla Santa
Sede «un colpevole silenzio». Da chi? Evidentemente, dall'interno dello stesso
mondo cattolico. La parolina magica è «modulazione». Ma trasferirla in un testo
che radicalizza e agita il Parlamento non sarà facile: a meno che alla fine il
governo o qualcun altro, con gradualità e cautela, abbandoni la sua «terzietà» e
offra un consiglio per uscire da una situazione al momento senza sbocchi.
Legge Zan, il paradosso del
Vaticano: in campo contro i pasdaran clericali.
Paolo Pombeni su Il Quotidiano
del Sud il 24 Giugno 2021. E’ DIFFICILE gestire qualsiasi cosa in un paese in
cui ormai si parla a ruota libera anche a livelli molto alti. La vicenda delle
reazioni alla nota verbale vaticana su quanto prevederebbe il ddl Zan se
diventasse legge (il che per il momento ancora non è) porta a considerazioni
poco consolanti. Iniziamo dall’aspetto più banale: la canea sulla presunta
violazione della sovranità del parlamento perché il Vaticano ha reso noto, nei
termini più soft possibili fra quelli ovviamente che restano agli atti (questo
non avviene con telefonate, incontri informali, ecc.), che a suo giudizio alcune
limitate norme ledevano diritti che il Concordato aveva riconosciuto alla
Chiesa. Banalmente tutti dovrebbero sapere, anche al vertice della Camera, che
un trattato internazionale è di suo uno strumento che nei limiti previsti limita
la sovranità di entrambe le parti. Tanto per capirci, ricordiamo un episodio
emblematico. Quando nel febbraio 1998 un aereo dei marines Usa volando troppo
basso rispetto alle normative tranciò i cavi della funivia del Cermis in
Trentino provocando la morte di 20 persone, in base ad un trattato
internazionale quei militari non poterono essere sottoposti alla giustizia
italiana, perché c’era una riserva di giurisdizione per quella americana (che,
sia detto per inciso, vergognosamente non punì poi gli avventati militari). Il
fatto era gravissimo, ma purtroppo un trattato legava le mani e non ci fu nulla
da fare. Il Concordato del 1984 sottoscritto fra l’Italia e la Santa Sede è un
trattato internazionale ed è stato approvato dal parlamento italiano, dunque è
un atto che promana anche dalla sovranità italiana. Se il Vaticano chiede il
rispetto di quel testo si muove nel suo buon diritto e l’Italia farebbe una
pessima figura a livello internazionale se ritenesse che i patti che sottoscrive
sono carta straccia se così viene deciso da una quota di opinione pubblica
eccitata. Ovviamente si può discutere del merito dei rilievi della Santa Sede,
dimostrando che non sono fondati, perché non ci sarebbe nessuna violazione degli
accordi. Questo è un punto molto delicato e meriterebbe considerazioni diverse
dal far rivivere scontri fra clericali e anti clericali, scontri del tutto fuori
luogo oltre che fuori tempo. Si viene così ad affrontare il secondo punto della
questione, che è ancora una volta la resa a trasformare in legge pulsioni
demagogiche con scarsa attenzione alla porta generale delle norme. Nel caso
specifico non si tratta dell’approvazione di una legge che sanzioni in modo
adeguato quelli che sono crimini d’odio e di intolleranza verso persone con
orientamenti sessuali che in passato sono stati ingiustamente e infondatamente
ritenuti aberranti. Fin qui sono tutti d’accordo, inclusa la Santa Sede. Si
tratta invece del fatto che si è esagerato nel perseguimento dell’obiettivo, non
solo proponendo di definire per legge un aspetto delicato e privato delle
relazioni sessuali fino ad arrivare a codificare delle teorie sul “genere” la
cui determinazione non è compito dello stato laico (giustamente si respinge che
lo facciano gli stati che sono organizzati su base religiosa), ma arrivando ad
imporre che la novità sia insegnata nelle scuole con apposite giornate dedicate.
Con molta ironia ci verrebbe da dire che se si dovessero dedicare specifiche
giornate a discutere di tutte quelle che i diversi gruppi definiscono storture,
alla scuola non resterebbe tempo per insegnare altro (e già abbiamo deficit di
apprendimento nei ragazzi). Più seriamente sappiamo bene in cosa si
tramuterebbero le giornate scolastiche contro l’omotransfobia: occasioni perché
docenti più militanti si mettessero a far concioni ideologiche sul tema
aumentando la confusione già esistente, mentre per la maggior parte diventerebbe
occasione per uno svolgimento burocratico e annoiato di quanto prescritto coi
ragazzi ben felici di un giorno senza interrogazioni, compiti e obblighi di
studio. E’ triste pensare che per portare un po’ di ragionevolezza in questa
impennata di radicalismo alla moda sia dovuta intervenire la Santa Sede. Come è
stato già messo in evidenza da più parti, l’ha fatto per evitare che risorgesse
uno spazio per il clericalismo arrabbiato a cui strizzano l’occhio i partiti di
destra che si sono riscoperti cristiani. Con ciò ha reso un servizio ad un paese
che impegnato com’è su temi assai rilevanti per il nostro futuro non ha proprio
bisogno di queste crociate all’amatriciana a cui si è pronti da destra e da
sinistra. C’è da sperare che i partiti prendano al volo l’occasione e senza
farsi condizionare dai nuovi pasdaran del radicalismo da social trovino modo di
fare una buona legge che giustamente colpisca in maniera efficace i crimini e le
discriminazioni ispirati da preclusioni verso gli orientamenti sessuali delle
persone (che sono e devono rimanere nella sfera privata intangibile dallo
stato). Si può farlo senza cadere nell’imposizione di una sorta di
religione-ideologia di stato, contribuendo invece a far progredire la cultura
diffusa del paese sulla via del rispetto per le persone e per le loro legittime
scelte di vita. Sarebbe stato meglio che a queste conclusioni la politica
italiana fosse giunta da sola senza bisogno di esservi costretta da un
intervento esterno. Purtroppo in questi tempi dominati dalla simpatia per leggi
che “spazzano” di qui e di lì, di su e di giù, la buona cultura
giuridico-istituzionale sta diventando un optional non molto richiesto.
DAGONEWS il 25 giugno 2021.
Quante cose si scoprono spippolando sui social. Può capitare, ad esempio, di
imbattersi nell'account twitter di Padre Antonio Spadaro, direttore della
rivista "La Civiltà Cattolica". Il gesuita giornalista, penna anche del "Fatto",
posta un tweet in cui annuncia: "Saluti da Anagni. A Fiuggi con i ministri
Carfagna, Brunetta, Patuanelli, Garavaglia, il Presidente Zingaretti, il
Segretario Generale della Farnesina Sequi, il sindaco di Firenze Nardella e
altri a raccontare l’Italia che verrà". Ah, beato lui che ha tempo da perdere a
disegnare scenari nei convegni! In ogni caso, a corredo dell'annuncio, c'è il
faccione di Spadaro e sullo sfondo il campanile della cattedrale di Santa Maria
ad Anagni. Una torre di 30 metri che si erge in tutta la sua svettante potenza.
Pochi minuti dopo, su un altro social (Instagram) e su un altro account, quello
di Francesco Sechi, appare una foto praticamente identica. L'ex autore di
"Mattino 5" viene fotografato ad Anagni, con lo sfondo della cattedrale, stesso
cielo grigio. Nulla di male, ovviamente. Soprattutto perché Francesco Sechi, ex
segretario di Marcello Dell'Utri, è l'assistente di Padre Spadaro. Insieme hanno
anche pubblicato su "La Civiltà Cattolica" una lunga intervista a Mogol. Sechi
ha un profilo facebook molto seguito (427 mila follower) che inonda di meme,
opinioni pret-à-porter e scemenze raccattate in rete. A volte tuona contro la
proroga dello stato d'emergenza ("E' un colpo di stato"), si schiera con il
poliziotto che alla stazione Termini ha sparato al migrante svalvolato armato di
coltello, snocciola tutti i suoi dubbi sulle vaccinazioni e fa battute sugli
elettori del M5s. In un'intervista di novembre 2016 concessa alla rivista
"Slide", Sechi viene definito "professionista della comunicazione", "spin doctor
per personaggi illustri" (ma di chi?). Sostiene di aver "affiancato 'grandi''" e
di avere nel curriculum "oltre agli studi all'Università anche la laurea
nell'università della strada". Il 40enne sardo spargeva umiltà a fiotti: "Ho
appreso tanto quanto da un pastore del mio paese quanto da un ministro, tanto da
un muratore quanto da un presidente del Consiglio" (ma quali ministri e
presidenti ha frequentato?). Confessa che "la mamma è il suo primo amore" e
altre banalità un tanto al chilo che è possibile leggere qui su issuu.com. Sul
suo account instagram, Sechi posta la foto con papa Francesco, la benedizione da
lui ricevuta, un selfie con San Pietro sullo sfondo ma anche immagini più
"intime". Una mentre fa la doccia (chissà chi c'era a fotografarlo…), un'altra
mentre si allena con deltoide in bella vista, un'altra ancora con camicia aperta
e petto in mostra. C'è persino una foto cui imbraccia un bel kalashnikov, a
evocare forse l'ispirazione della sua carità cristiana: porgi l'altra guancia e
poi spara. Padre Spadaro, da sempre molto sensibile alle tematiche Lgbt (tanto
da intervenire a favore dell'approvazione del Ddl Zan: "Occorre appoggiare norme
che hanno senso difensivo di persone vulnerabili e non abbiano senso offensivo
di legittime idee"), sbertucciato da "la Verità" che maliziosamente lo ha
definito esponente della "Chiesa arcobaleno", ha avuto modo di fare una
ricognizione dei social del suo amico e collaboratore? Ha tastato con mano e
verificato il misterioso quanto roboante curriculum di Sechi? Ah, saperlo…
Lorenzo Bertocchi per "la
Verità" il 25 giugno 2021. C'era una volta l'uso politico della religione
secondo padre Antonio Spadaro. Il direttore de La Civiltà Cattolica, solo una
settimana fa, dalle colonne del New York Times, richiamava alla pia devozione i
vescovi statunitensi, rei di «usare l'accesso all' eucaristia come arma
politica». Del Vangelo secondo Spadaro però 168 vescovi americani non hanno
saputo che farsene, probabilmente ritenendolo apocrifo, visto che hanno deciso a
larga maggioranza che il documento sulla coerenza eucaristica s' ha da redigere,
anche per quei politici cattolici (vedi il presidente Joe Biden) che si dicono
tali e poi sostengono politiche contrarie all' insegnamento della Chiesa. È una
questione di libertà religiosa. Ancora ieri, nel giorno della grande sberla sul
ddl Zan, il gesuita americaneggiava su Twitter: «"Quando il cristianesimo è
ridotto a costume, a norme morali, a rituali sociali, allora perde la sua
vitalità e il suo interesse esistenziale per gli uomini e le donne del nostro
tempo" (monsignor Christophe Pierre, Nunzio apostolico negli Usa)». Sulla legge
anti omofobia, la dottrina Spadaro ha fatto un po' il controcanto ai vescovi
italiani che, almeno nel comunicato del 10 giugno 2020, scrivevano di non
riscontrare alcun vuoto normativo. «Occorre appoggiare norme», cinguettava,
invece, uno Spadaro un po' criptico, «che hanno senso difensivo di persone
vulnerabili e non abbiano senso offensivo di legittime idee». Probabilmente
l'intento del consigliere del Papa era sempre quello di evitare l'uso politico
della religione e aprire il mondo cattolico all' inclusione, un po' come il
quotidiano dei vescovi, Avvenire. Nel giugno 2020, infatti, la penna d' elezione
per questioni Lgbt, Luciano Moia, intervistava lo stesso Alessandro Zan,
esattamente il giorno dopo che era stata pubblicata la già citata nota Cei.
Ovviamente l'intervista appare oggi un po' in ginocchio, visto che faceva
risaltare le parole del relatore sul fatto che «non sarà una legge bavaglio, né
una legge liberticida». Talmente poco liberticida che, infatti, il 17 giugno la
Segreteria di Stato vaticana ha fatto pervenire al governo italiano una «nota
verbale» in cui si chiede di fare attenzione al testo del ddl Zan in quanto c' è
il rischio di veder ridotta la «libertà garantita alla Chiesa cattolica dall'
articolo 2, commi 1 e 3 dell'accordo di revisione del Concordato». Qui, di uso
politico della religione, a ben vedere, c' è pochissimo, perché la Santa Sede
gioca in «punta di diritto», che, potrà anche non piacere, ma è una posizione
laica. Certo, il direttore del quotidiano dei vescovi, Marco Tarquinio, lo
scorso 15 aprile, rispondendo proprio a una lettera di Alessandro Zan,
sottolineava che il testo ha subito «un'evoluzione indubbia anche se non
sufficientemente chiara e ancora insidiosa», in ossequio al diktat che il testo
va fatto, sebbene «rimodulato». Ma l'inclusione del quotidiano dei vescovi non
dava troppo spazio a quel manipolo di prelati coraggiosi che, invece, sul ddl
Zan le parole chiare le hanno dette. Innanzitutto il vescovo di
Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, che in una lettera del giugno
2020 scriveva che «non si può accettare che una legge, perseguendo un obiettivo
"ideologico", metta a rischio la possibilità di annunciare con libertà la verità
dell'uomo, sia pur con l'obiettivo di prevenire forme di discriminazione contro
le quali, come già ricordato, è sufficiente applicare le disposizioni già in
vigore». E ieri lo stesso Suetta ha ribadito che quello del Vaticano, con
riferimento al Concordato, è un «atto opportuno fatto da chi ha competenza per
farlo». Ma tanti altri si sono seduti sulla comoda posizione di dare un colpo
alla botte e uno al cerchio, nel nome dell'inclusione e del rispetto della
dignità di tutti. Un po' per convinzione, un po' per pavidità. Bisogna però
riflettere che l'atto posto dallo Stato del Vaticano nei confronti dello Stato
italiano è un fatto storico e in un certo senso unico che cambia le carte in
tavola. Il livello su cui si è spostato il contendere è ben altro di quello dei
comunicati o delle lettere pastorali, delle articolesse o dei cinguettii, qui la
preoccupazione della Santa Sede è formale e riguarda una materia delicatissima e
fondamentale come la libertà religiosa, declinata in questo caso nella libertà
di predicazione e di educazione. Tutti coloro che fino a ieri martellavano sui
ponti da gettare, e sui cui spesso trascinavano anche oltre la sua volontà il
Papa, dovranno fare i conti con questa laicissima presa di posizione a cui
Francesco ha dato il suo placet. Ricordiamo che tra le cose che urtano la
libertà di predicazione e educazione ci sono anche passaggi del Catechismo o
delle Scritture o atti del Magistero che forse qualcuno all' interno della
Chiesa mal digerisce, ma su cui lo Stato del Vaticano ha chiesto conto al
governo italiano affinché venga rispettata la libertà religiosa. La pastorale,
per quanto inclusiva e dialogante con tutti, vede tracciarsi davanti una sottile
linea rossa invalicabile. Da ieri, quelli che avendo da eccepire sulle derive
liberticide del ddl Zan venivano trattati da cripto-omofobi, impresentabili,
hanno un paio di alleati in più per sostenere le loro idee. Per quanto la linea
del «troncare e sopire» ora venga messa in atto dalle regie mediatico-curiali,
con ampio utilizzo del «non affossare», ma «rimodulare», il ddl Zan, se non è
morto, è gravemente ferito.
«L’attacco del Vaticano al
ddl Zan sembra un dispetto della Curia contro il Papa. Di cui non si sentiva il
bisogno». Lo
sconcerto di padre Alberto Maggi. «Ma guardando alla storia non è una novità: la
Chiesa da sempre si è opposta al progresso». Simone Alliva su L'Espresso il 22
giugno 2021. “Un dispetto al Papa”. Sconcertato Padre Alberto Maggi, sacerdote e
biblista, frate dell'Ordine dei Servi di Maria che a Montefano ha fondato il
Centro studi biblici " Vannucci" commenta la nota della Segreteria di Stato del
Vaticano secondo cui il ddl Zan violerebbe "l'accordo di revisione del
Concordato". Padre Maggi che già quarant’anni fa dava la comunione agli
omosessuali cattolici ben conoscendo le loro sofferenze per l’esclusione della
Chiesa si dice attonito: «Sembra tutto così surreale. Non so se è stata
un’iniziativa dall’alto oppure se è stata una mossa. Certo è sorprendente ma non
se ne sentiva il bisogno».
Ha detto “una mossa”. Forse
per colpire la presunta apertura di Papa Francesco alle questioni Lgbt?
«Mi sembra chiaro che Papa
Francesco abbia i bastoni tra le ruote e questi non vengono dagli esterni ma
dall’interno della Chiesa. Quelli che non tollerano questa sua apertura. Ma è
sempre stato così. Le Curie sono sempre state la palla al piede dei Papi. Non
apertamente, il tentativo però è stato quello di rallentare o affossare. Tanto i
Papi passano ma la Curia resiste a sé stessa. Può darsi che sia un dispetto al
Papa. Può darsi. Ma guardando alla storia non è una novità: la Chiesa da sempre
si è opposta al progresso. Eppure alla fine ci deve arrivare. Pensi che c’è
stato un Papa contrario anche all’uso della bicicletta e scomunicava i preti che
la usavano. Papa Giuseppe Sarto. Ma si rende conto? La bicicletta era una novità
scandalosa».
Lei crede che sui diritti
civili i fedeli siano più avanti di questa Chiesa?
«Non lo penso io. Il Cardinale
Carlo Maria Martini disse che la Chiesa era indietro di duecento anni. Ma
Martini era stato generoso. La Chiesa è molto più indietro. Come preti abbiamo
una garanzia: lo Spirito del signore che ci apre gli occhi di fronte ai nuovi
bisogni della società. La società non è statica ma cambia. Il rischio è quando
di fronte a nuove situazioni, come questa, restiamo impauriti o incapaci e
quindi diamo vecchie risposte. Sa, quando diamo vecchie risposte la gente non ci
ascolta e fa bene, va avanti. La garanzia della Chiesa è essere capaci di dare
nuove risposte e vedere il bene dell’uomo come valore assoluto».
Ascoltandola direi che lei è
favorevole al ddl Zan. Nella Chiesa siete in pochi a dirlo apertamente.
«Il cardinal Bassetti aveva
parlato di miglioramenti. L’apertura c’è. Ma certo nessuna legge è perfetta. Ci
saranno sempre dei punti che vanno migliorati. Ma appunto il Cardinal Bassetti
non l’ha bocciata. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Poi però la Chiesa si
muove un passo avanti e due indietro ma la società va sempre avanti. Questa di
oggi e molte altre sono pietre di inciampo della Chiesa. Pensi che oggi,
parlando della legislazione ecclesiastica, se lei divorzia non può accedere alla
comunione. Se ammazza sua moglie basta confessarsi. Possibile che sia più grave
il peccato del divorzio che quello dell’omicidio? Oggi per la Chiesa è così.
Distruggere un amore, che pensiero inaccettabile. Il buon senso della gente ha
lo stesso valore dello Spirito Santo. La chiesa deve imparare ad ascoltare».
Lei disse: si benedicono le
case, gli animali, gli oggetti, ma due persone che si vogliono bene no.
«Sì è incredibile. Il peccato
è il male che fai agli altri. Cosa c’è di male nelle persone che si vogliono
bene? È una novità? No, nei secoli passati queste persone erano semplicemente
nascoste. Oggi parlano di degenerazione dei tempi ma non è vero. Sono sempre
esistite solo che prima venivano lasciate ai margini, si nascondevano
nell’oscurità mentre oggi, per fortuna, vivono alla luce del sole. Per vedere il
male in due persone che si vogliono bene quanta perversione bisogna avere in
testa?»
Il ddl Zan riguarda anche il
futuro. Gli studenti, i giovani lgbt. Lei è diventato un punto di riferimento
per moltissimi giovani cattolici lgbt.
«Io non sono esperto di
morale. La mia piccolissima competenza sono i vangeli. I gruppi omosessuali
hanno sentito nel mio messaggio un tono diverso e mi hanno coinvolto. Una volta
partecipai a programma televisivo (Uno Mattina, ndr ) per parlare di
omosessualità e Vangelo. Sa, da quella volta non mi hanno chiamato più.
Comunque, tre giorni dopo ho ricevuto la lettera di un ragazzo di Lugano. Quella
mattina questo ragazzo di 30 anni aveva tentato il suicidio, dopo una notte
passata a piangere. Decise di arrampicarsi sul tetto, per non farsi sentire
accese il televisore a tutto volume. Era sintonizzato su Rai1. Mi scrisse:
“ascoltai le sue parole scoppiai in un pianto. Padre Maggi qualsiasi cosa accada
sappia che lei ha salvato una vita, la mia” Pensi a quanta gente ha sofferto, si
tolgono la vita, la mortificano perché? Per quale motivo?»
Salvare vite e difendere i più
deboli dovrebbe essere la missione cardine della Chiesa
«La buona notizia è per tutti.
Il peccato nei Vangeli è il male che si fa agli altri. Gesù ci ha avvertito:
attenti, perché voi ponete dei pesi sulle spalle delle persone e non le
risollevate neanche con un dito. Oggi per gli omosessuali l’unica soluzione è
vivere casti. Io sono frate da 50 anni e ho scelto questo celibato e so quanto
sia difficile. Ma non posso imporlo agli altri, non posso dire devi essere
celibe, non devi avere una famiglia così facendo metto dei pesi sulle spalle di
queste persone. Comunque andiamo avanti sereni. Queste uscite sono cose che non
andrebbero neanche considerate, l’umanità va avanti. Ecco perché il Papa dice
spesso: pregate per me. Preghiamo per il Papa e sosteniamolo».
Piergiorgio Odifreddi per “La
Stampa” il 24 giugno 2021. Rispondendo all'intervento del Vaticano sulla legge
Zan, il presidente del Consiglio ha dichiarato che «lo stato Italiano è laico e
il Parlamento è libero», e i parroci di strada hanno accusato una manina di aver
agito all'insaputa del papa. In realtà, il Vaticano ha semplicemente sollevato
un dubbio di incostituzionalità, com' è nel suo pieno diritto, confermato
implicitamente da Draghi. L'articolo 7 della Costituzione stabilisce infatti che
i rapporti fra Stato e Chiesa siano regolati dal Concordato ereditato dal
fascismo. Non bisogna dunque prendersela con il Vaticano che rivendica
l'attuazione di quei patti, ma con coloro che dapprima li hanno voluti, da
Mussolini a Togliatti, e in seguito li hanno mantenuti. Cioè, con tutti i nostri
leader politici, nessuno dei quali ha mai chiesto una revisione costituzionale o
una denuncia unilaterale di quell'anacronismo: meno che mai gli ex democristiani
come Renzi e Letta, o gli ex allievi dei preti come Conte e Draghi. Quanto al
papa, solo gli ingenui e i disinformati possono non sapere che il suo
"progressismo" è una leggenda mediatica, e che quand'era in Argentina intervenne
ben più pesantemente di ora contro i matrimoni civili, con toni definiti allora
"medievali e inquisitori". Il Vaticano si preoccupa che la legge Zan possa
obbligare le scuole a insegnare l'identità di genere, e paradossalmente non ha
tutti i torti: quest' ultima, infatti, viene definita nell'Articolo 1 della
legge come "l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al
genere, anche se non corrispondente al sesso". La legge decreterebbe in tal modo
una cesura tra la percezione psicologica di un individuo e la sua realtà
fisiologica: la prima dev' essere naturalmente tutelata e difesa, perché
ciascuno ha diritto di avere le opinioni e i sentimenti che desidera, ma la
seconda non può semplicemente essere negata o rimossa, perché anche i fatti
hanno i loro diritti. Per fare un altro esempio, di cui si può forse parlare più
serenamente, tutti conoscono il detto di Thomas Mann nei Buddenbrook: "si ha
l'età che si sente di avere". Ora, nessuno si sogna di negare a un ottantenne il
diritto di sentirsi un ventenne, o viceversa, ma questo non significa che allora
dobbiamo tutti dire, o addirittura insegnare nelle scuole, che non esistono
l'età biologica o il tempo, e che non possiamo misurarli. Eppure, è proprio
questo che i post-moderni predicano da decenni, all'insegna del motto di
Nietzsche: "non ci sono fatti, solo interpretazioni". E non è un caso che gli
scienziati si secchino, perché sanno che invece i fatti ci sono eccome, e che le
interpretazioni non vanno affatto tutte bene, se li negano o li rimuovono. E'
singolare che a cercare di introdurre l'ircocervo dell'identità di genere nella
legislazione italiana sia un decreto che porta la firma di un ingegnere come
Zan, invece che di un filosofo del pensiero debole come Vattimo. Ma è proprio
l'accoppiamento della sacrosanta difesa del diritto alle scelte sessuali e
affettive, da un lato, con la condannabile introduzione dell'identità di genere,
dall'altro, che rischia di affossare l'uno e l'altra. Ora, sono più importanti i
fatti, e in particolare la necessità di tutelare le scelte di vita individuali,
e di difenderle dalle vessazioni e dalle violenze, o le interpretazioni, e cioè
le ideologie sociologiche post-moderne? Non sarebbe meglio riconoscere che anche
da sinistra si sono sollevate perplessità di vario "genere" su queste ideologie,
che rischiano di far buttare nel lavandino il bambino insieme all'acqua sporca?
A proposito di sinistra, ammesso che la parola abbia ancora un significato qui e
oggi, non sarebbe meglio migliorare la legge anche dal punto di vista dei
diritti sessuali e affettivi? Ad esempio, si parla sempre di "coppie",
dimenticando questa volta il detto di Alexandre Dumas figlio: "le catene del
matrimonio sono così pesanti che a volte bisogna essere in tre per portarle". La
vera liberazione non è il riconoscimento delle coppie di fatto, ma dei triangoli
e degli altri poligoni. Ecco, parlare di legalizzazione della poligamia sarebbe
sicuramente un argomento interessante e di sinistra, e forse quello sì che
potrebbe finalmente far saltare il banco con il Vaticano!
L'intervento del Vaticano
per fermare i diritti. Preti in cella per il ddl Zan, una tesi che sfiora il
ridicolo.
Salvatore Curreri su Il Riformista il 28 Giugno 2021. Quando uno Stato può dirsi
laico? Certo, quando non c’è una religione di Stato. Ma non basta, e le reazioni
di segno opposto alla nota verbale della Santa Sede sul ddl Zan lo dimostra. C’è
chi, soprattutto tra i non credenti, la considera un’inaccettabile ingerenza
perché considera la laicità innanzi tutto come separazione istituzionale tra
Stato e Chiese. E chi, all’opposto, soprattutto tra i credenti, l’ha apprezzata
perché considera la laicità soprattutto come libertà d’esercizio del magistero
pastorale. In realtà, benché la laicità presupponga e richieda ovunque la
distinzione tra dimensione temporale e dimensione spirituale, il modo in cui si
realizza varia storicamente nel tempo e nello spazio. Così abbiamo Stati
laici che s’ingeriscono negli affari della Chiesa nazionale (giurisdizionalismo)
fino al punto che il Sovrano ne è a capo (Gran Bretagna); Stati che considerano
la religione il collante sociale che fonda la loro identità (God Bless
America…); Stati che considerano la laicità in senso negativo (per sottrazione)
come assoluta neutralità delle istituzioni pubbliche nei confronti del fenomeno
religioso, visto come fattore di potenziale divisione sociale (Francia, dove ad
esempio per questo motivo è vietata l’ostensione di simboli religiosi). Stati,
infine – come il nostro – che intendono la laicità in senso inclusivo (per
addizione) perché considerano la religione non solo come un’esperienza
spirituale privata, ma anche un fattore di rilievo sociale al quale lo Stato
deve guardare con favore perché espressione della personalità di ciascuno (Corte
cost., sentenza n. 334/1996). Per questo, l’art. 19 della
nostra Costituzione precisa che “tutti hanno diritto di professare liberamente
la propria fede religiosa” non solo “in qualsiasi forma, individuale o
associata” ma anche “di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. E per
questo lo Stato regola la dimensione pubblica del fenomeno religioso, stipulando
accordi bilaterali con la Chiesa cattolica (Concordato) e con le confessioni
acattoliche (intese) per soddisfare loro esigenze specifiche, concedere loro
particolari vantaggi o imporre particolari limiti, dare rilievo giuridico a loro
atti (come nel caso del matrimonio), disciplinare infine materie di comune
interesse. Bene dunque ha fatto il presidente del Consiglio
Draghi in Parlamento a non limitarsi a ribadire l’ovvia laicità del nostro
Stato, aggiungendo piuttosto che essa non equivale a “indifferenza dello Stato
dinanzi alle religioni” ma si traduce nella “garanzia dello Stato per la
salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e
culturale” (Corte costituzionale, sentenza n. 203/1989). Questo spiega perché,
nel nostro Paese, è sancito, ad esempio, il diritto d’obiezione di coscienza per
motivi religiosi; il diritto all’assistenza religiosa nei luoghi pubblici (i
ricoverati negli ospedali, i detenuti nelle carceri, i militari nelle caserme,
gli studenti che vogliono frequentare l’ora di religione); il diritto di non
lavorare per onorare determinate festività religiose; i finanziamenti pubblici
per costruire edifici destinati al culto. Alla luce di una concezione inclusiva,
in cui Stato e Chiesa cattolica sono chiamati nei loro rapporti “alla reciproca
collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese” (art. 1
Concordato), la suddetta nota verbale esprime legittimamente le preoccupazioni
della Santa Sede sulla possibilità che il ddl Zan incida negativamente sulla
libertà della Chiesa cattolica di svolgere la sua missione pastorale e di quella
dei fedeli di esercitare i loro diritti politici (riunione, associazione,
espressione). Libertà garantite dal Concordato (v. rispettivamente artt. 2.1 e
2.3) e per questo che potevano essere oggetto d’intervento solo da parte della
Santa Sede e non della Conferenza Episcopale Italiana, alla quale l’art.
14.2 del Concordato lascia solo la regolazione tramite intese di “ulteriori
materie”. Ma, ancor prima, libertà garantite dalla Costituzione(artt. 17-21) per
cui, sotto questo profilo, il richiamo al Concordato non aggiunge nulla agli
argomenti a sostegno della pretesa natura liberticida del ddl Zan (dovendosi
ovviamente escludere che la Chiesa si sia mossa per esservi esentata,
rivendicando la propria libertà a essere omofoba…). Ciò chiarito, continuo a
ritenere infondate le preoccupazioni espresse sul ddl Zan. Così come contro il
referendum sul Trattato costituzionale dell’Ue i francesi nel 2004 furono
terrorizzati dall’arrivo degli idraulici polacchi che gli avrebbero tolto il
posto di lavoro, ora l’argomento principe della propaganda contro il ddl Zan è
quella del povero prete che verrebbe arrestato dai gendarmi (con i pennacchi,
con i pennacchi…) al termine della sua omelia a favore del matrimonio solo tra
uomo e donna, oppure contro le adozioni delle coppie omosessuali o la maternità
surrogata. Argomento d’indubbia presa ma giuridicamente infondato. Come ho già
cercato di argomentare su queste colonne (v. il mio intervento dello scorso 15
maggio) a essere colpito è soltanto il pensiero che istiga a compiere atti
discriminatori e violenti. Si continua a obiettare: come si fa a stabilirlo? Non
si lascerebbe così troppa discrezionalità al magistrato di turno, magari
anticlericale? E a nulla varrebbe scrivere nella proposta di legge (art. 4) che
«sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le
condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle
scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di
atti discriminatori o violenti», perché, secondo tali critici, tale articolo
finirebbe per ammettere la fondatezza del pericolo segnalato (strano argomento,
invero: quando non c’era tale precisazione, la si richiedeva; ora che è scritta,
la si ritiene un’auto-accusa: insomma, come fai sbagli…). Tutte queste obiezioni
hanno un difetto: considerano il ddl Zan come se introducesse per la prima volta
i reati contro l’eguaglianza quando invece essi già esistono. Il ddl Zan,
infatti, si limita ad estendere i delitti già previsti contro l’eguaglianza,
aggiungendo alle discriminazioni per motivi “razziali, etnici, nazionali o
religiosi” quelle fondate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di
genere o disabilità. Quanti sostengono, quindi, che si tratti di una proposta di
legge repressiva della libertà d’espressione e lesiva dei principi di
tassatività e determinatezza della fattispecie penale, a causa della fumosità
dei concetti di “istigazione” e “atto discriminatorio” dovrebbero per coerenza
estendere la loro accusa d’incostituzionalità all’intera legge
Reale-Mancino (oggi trasfusa nell’art. 604-bis c.p.) e, dunque, temere per la
loro libertà di parola anche in materia razziale, etnica, nazionale o religiosa.
Se non l’hanno mai fatto prima e non lo fanno è perché sanno che hanno contro
tutta la giurisprudenza che, pronunciandosi sulle fattispecie oggi previste, ha
chiarito da tempo che l’istigazione a compiere atti discriminatori è punita
perché «realizza un quid pluris rispetto ad una manifestazione di opinioni,
ragionamenti o convincimenti personali». Difatti, «l’incitamento ha un contenuto
fattivo di istigazione ad una condotta, quanto meno intesa come comportamento
generale» (Cass., V pen. 31655/2001). Ad essere punito per tali motivi non è,
dunque, la propalazione di un sentimento di generica antipatia, insofferenza o
rifiuto, o le mere manifestazioni di ostile disprezzo nei confronti di una
persona, tutti rientranti sotto la tutela della libertà d’espressione ex art. 21
Cost., bensì le opinioni che, per il contesto in cui vengono espresse, sono per
stretta consequenzialità idonee «a determinare il concreto pericolo di
comportamenti discriminatori» (Cass., III pen. 36906/2015) nei confronti di un
soggetto non per quel che fa ma per quel che è da parte di chi la considera
deviante dall’unico modello ritenuto ammissibile (Cass., VI pen. 33414/2020).
L’istigazione esprime quindi una manifesta volontà diretta a creare in un vasto
pubblico, come nel caso della diffusione ed amplificazione veicolata dai social
network, il concreto pericolo del compimento di atti d’odio e di violenza fisica
e morale. L’ha ricordato di recente anche la Corte europea dei diritti dell’uomo
nel caso Beizaras e Levickas c. Lituania condannata per non aver previsto
sanzioni penali nei confronti di utenti di Facebook che avevano postato auguri
di morte a due omosessuali fotografati mentre si baciavano. Forse quando si
lamenta la violazione della libertà d’espressione i critici del ddl
Zan farebbero bene a guardare altrove. All’Ungheria? Esatto. Salvatore Curreri
Ddl Zan, Augusta Montaruli
a Omnibus: "Finiremo tutti alla sbarra", il più pericoloso degli errori nel
testo della legge.
Libero quotidiano il 24 giugno 2021. Si parla del ddl Zan e della
reazione del Vaticano da Gaia Tortora a Omnibus nella puntata di oggi 24 giugno
e Augusta Montaruli, di Fratelli d'Italia, spiega perché il suo partito è
contrario. "Non ci piace perché non è scritto bene", dice in collegamento: "Un
provvedimento scritto male su temi fondamentali come la libertà di vivere la
propria sessualità e la libertà di espressione debba invitare tutti a fare una
riflessione aggiuntiva", attacca la Montaruli. "Affrontiamo il tema ma
scriviamolo bene". Ma oltre a un problema di forma, c'è un problema di sostanza.
Secondo la Montaruli, infatti, "nel merito ci sono aspetti che sono un'ombra.
Non si discute il diritto sacrosanto di vivere la propria libertà sessuale. Ma
dove finisce questa libertà? Nella libertà di espressione come il ddl Zan?", si
chiede la meloniana. Che sottolinea un altro aspetto fondamentale: "Non si
specifica quali siano gli 'atti discriminatori'. Cosa si intende per 'atti
discriminatori'? Tutto verrà rimesso nelle mani della magistratura". E ancora,
"tutto è soggetto all'interpretazione". Quindi c'è il tema per esempio
dell'utero in affitto e quello delle adozioni per le coppie omosessuali. La
Montaruli si riferisce al fatto che con "atti discriminatori" potrebbe poi per
esempio rientrare l'adozione per le coppie gay, la registrazione di coppie
monogenitoriali eccetera e soprattutto si pone con essa un'altra questione: "Un
sindaco può diventare imputato se per esempio si rifiuta di iscrivere una coppia
monogenitoriale". Insomma, il rischio che tutto finisca in mano ai magistrati e
alla loro libera interpretazione c'è tutto.
Ddl
Zan, Concordato e le polemiche. Anche il Vaticano teme i Pm, la legge crea
arbitrio.
Alberto Cisterna su Il Riformista il 28 Giugno 2021. Per carità,
siamo tutti d’accordo. Chi volete che in questo Paese, vocazionalmente
conformista, si accodi a Orban o a suoi consimili a proposito dell’omofobia?
Salvo qualche aspirante alla lapidazione mediatica, o qualche grullo che non
manca mai, è impossibile o quasi che si trovi qualcuno sano di mente che ritenga
siano ammissibili atti di discriminazione o peggio ancora di violenza «fondati
sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e
sulla disabilità», come recita il titolo del disegno di legge Zan. Il tema,
però, non è se una legge sia opportuna per prevenire e contrastare simili
comportamenti, ma quale legge si debba approvare senza che, per tutelare anche
la più minuta diversità sessuale e identitaria, sia messa in pericolo la libertà
di manifestazione del pensiero, la libertà religiosa, la libertà di insegnamento
di tanti. Si è ricordato nelle polemiche recenti che la Repubblica è uno Stato
laico. Ce lo dicono autorevoli e recenti asseverazioni che certo ci
tranquillizzano, ma questo non vuol dire che si possa sostituire alla
confessionalità di un credo o di una fede, una inflessibile religione della
tolleranza assoluta che, a ben guardare, non rinviene spazio e legittimazione in
alcuna norma della Costituzione. Benché una generica e bonaria tolleranza sia
largamente predicata e invocata come la nuova religione del Terzo millennio, in
verità i Costituenti la tennero fuori dalle porte della Carta. Non la
menzionarono affatto nei suoi articoli, preoccupati com’erano dal possibile
incedere di un relativismo che poteva minare l’etica repubblicana la quale,
invece, si fonda su valori non negoziabili né suscettibili di mediazioni al
ribasso. Relativismo e tolleranza non sono sinonimi, né si equivalgono poiché la
comprensione e anche la difesa delle altrui convinzioni non può comportarne
l’equivalenza con le proprie le quali, in una coscienza rettamente orientata,
prevalgono sulle altre per il solo fatto di essere profondamente accettate e
vissute da ciascun individuo. Dopo il 1750 la Francia fu inondata da scritti
sulla tolleranza, tra i quali il famoso Trattato sulla
tolleranza di Voltaire che riassumeva, si badi bene, la tolleranza nella regola
aurea del «non fare agli altri ciò che non si vorrebbe fatto a sé stessi». Roba
scontata si potrebbe dire, ma che con il relativismo ha poco a che vedere. È
scontato, è vero, ma a patto che, nel momento in cui si mette mano alla pistola
del codice penale, si sia sufficientemente chiari su cosa si intenda sanzionare
e su quali condotte si intenda punire. Ed è su questo crinale che la Chiesa
italiana sembra aver inteso reagire. Invero a muoversi è stata la Segreteria di
Stato, ossia il ministero degli Esteri del Vaticano, uno Stato estero che ha in
piedi un Concordato con la Repubblica, ossia un patto che pone vincoli precisi
al Parlamento il quale – invece che baloccarsi nella retorica dell’assoluta
sovranità legislativa (che non esiste in Costituzione) – dovrebbe ricordare che
ha il preciso dovere di far fronte agli obblighi internazionali assunti verso
la Santa Sede. È noioso e didascalico, ma piuttosto che accodarsi al coro di
quanti strepitano senza aprire un codice, è bene intendersi almeno su alcuni
degli obblighi che la Repubblica ha assunto con il Vaticano in favore
della Chiesa italiana e dei cattolici, intesi come singoli. Tra questi spiccano
«la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di
svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione
e di santificazione. In particolare, è assicurata alla Chiesa la libertà di
organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e
del ministero spirituale» (articolo 2, comma 1) e poi «è garantita ai cattolici
e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di
manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione». In altre parole, i cattolici presenti nel Paese – siano essi o meno
cittadini italiani – usufruiscono formalmente di una tutela rafforzata della
propria libertà di manifestazione del pensiero e finanche della propria libertà
educativa (articolo 9) che ha fondamento insieme nella Costituzione e
nel Concordato. Da questo punto di vista si deve comprendere che il Vaticano non
può arretrare neanche di un millimetro su questo crinale e che il Soglio di
Pietro opera non a proprio vantaggio, quale Stato straniero, ma in favore della
comunità dei cattolici residenti in Italia, della Chiesa che la Repubblica
riconosce, nel suo ordine, come indipendente e sovrana (articolo 1). Roba da
sbadiglio è chiaro. Mentre hanno causato una mezza insurrezione alcune
autorevoli dichiarazioni che al rispetto di questi patti si sono
richiamati. Monsignor Nunzio Galantino, uomo di primo piano delle gerarchie
ecclesiastiche italiane, ha detto: «Non è mia competenza, ma penso che si debba
stare attenti a non usare formulazioni che nelle mani, e nelle teste, di
malintenzionati diventino strumenti di intolleranza». Poi, il cardinale Pietro
Parolin, segretario di Stato della Santa Sede: «La nostra preoccupazione
riguarda i problemi interpretativi che potrebbero derivare nel caso fosse
adottato un testo con contenuti vaghi e incerti, che finirebbe per spostare al
momento giudiziario la definizione di ciò che è reato e ciò che non lo è».
Qualcuno ha pensato che il cardinale, convenendo sul dato della laicità
dello Stato, abbia inteso fare una sorta di marcia indietro, laddove è chiaro
che proprio quella laicità impedisce derive verso una sorta di religione neutra
della tolleranza che con quella posizione è palesemente incompatibile. Ma non è
questo il punto. Entrambi hanno manifestato la preoccupazione che si rimetta ai
tribunali il compito di stabilire cosa sia discriminatorio e cosa non lo sia.
Una magistratura cui la Santa Chiesa, e non da sola di questi tempi, guarda con
circospezione e con un certo sospetto almeno a partire dalla guerra dei
crocifissi nelle aule scolastiche che venne vissuta come il segnale di
un’intolleranza laicista verso ogni fede religiosa. Al di là dei tecnicismi che
possono riguardare le singole norme penali, manca nella legge Zan una nozione
chiara di atti discriminatori e, ad esempio, non è evidente se il rifiuto di una
scuola confessionale di iscrivere i figli di coppie omogenitoriali possa o meno
essere sanzionato penalmente o civilmente. Non è in discussione se sia un
comportamento giusto o ingiusto, condivisibile o deplorevole, quel che conta è
se possa portare o meno a un processo. E basta leggere l’articolo 4 per capire
che un po’ di cautela non guasterebbe affatto: «Ai fini della presente legge,
sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le
condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle
scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di
atti discriminatori o violenti». A parte il fatto che, per fortuna, quella
libertà è «fatta salva» dalla Costituzione e non dalla legge Zan, è davvero
singolare che «condotte legittime» sono tollerate alla condizione però che non
determinino «il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o
violenti». È chiaro che si è fuori da ogni tipicità e che così si affidi ai
tribunali un compito immane e preoccupante, ossia quello di stabilire ex post e
sulla base di opinioni in gran parte opinabili cosa sia consentito o cosa
vietato. Battaglia dura e oltre Tevere hanno il patema di chi sa bene che la
fede affonda la propria storia in un processo ingiusto celebrato in una piazza
di esagitati. Alberto Cisterna
Ddl
Zan, Giulia Bongiorno: "Paradossale, chi vuole difendere l'uguaglianza pone
limiti alle nostre libertà".
Libero Quotidiano il 28 giugno
2021. "Sta facendo un ottimo lavoro, non ha bisogno di consigli". Un elogio
quello indirizzato a Marta Cartabia arrivato direttamente da Giulia
Bongiorno. L'avvocato, nonché senatrice della Lega, non ha potuto fare a meno di
spendere belle parole per il ministro della Giustizia: "Trovare una sintesi è
complicato, perché sul tema giustizia si agitano sensibilità molto diverse: per
esempio, c'è chi pensa che il garantismo sia un esercizio di vuota retorica,
dimenticando che è un principio inserito nella nostra Costituzione".
Soddisfazione da parte del Carroccio sulla riforma del processo penale: "Sono
molto soddisfatta della proposta del Ministro di superare il testo Bonafede
sulla prescrizione, che è stato oggetto di un duro confronto tra la Lega e i
Cinque Stelle quando eravamo al governo". Non mancano comunque piccole
divergenze su appello e Cassazione. Per la Bongiorno si tratta di una fase
particolarmente delicata, dove la magistratura è in crisi, "frutto delle
distorsioni di un correntismo esasperato". Da qui l'appello rivolto dalle
colonne de La Stampa affinché "non possiamo limitare i controlli sulle
sentenze". Una richiesta non per forza legata alla sfiducia nei giudici, ma
"essere innocenti - spiega la leghista a chi si presenta da lei - potrebbe non
bastare per essere assolti. Sui piatti della bilancia, simbolo della giustizia,
temo che a volte potrebbero non esserci solo le prove. È grave, ma è così".
L'esempio è dietro l'angolo e conferma quanto denunciato dall'ex membro del
Consiglio superiore della magistratura, Luca Palamara: "Se ci si imbatte in un
giudice ambizioso e il pm di quel processo appartiene a una corrente che
potrebbe incidere su una promozione, è lecito avere dei dubbi sulla sua
imparzialità? Le impugnazioni sono forme di controllo degli errori dei giudici
precedenti e a questa garanzia non si può rinunciare". È proprio questo
l'obiettivo dei referendum proposti in tandem con i Radicali: l'indipendenza
della magistratura. Non meno schiette le posizioni sul disegno di legge Zan. La
proposta tutta piddina contro l'omotransfobia ha trovato un forte avversario,
oltre che nel centrodestra, anche nel Vaticano. Eppure non c'è da stupirsi,
visti i pericoli giuridici che si verrebbero a creare. Quali? Presto detto: "Si
usano definizioni normative che paiono contrastare con la difesa del pluralismo.
Si deve tener conto della libertà di religione, di insegnamento e di
espressione. È paradossale che una legge volta a tutelare l'uguaglianza si
presenti come un limite alla libertà altrui. Nessuno vuole affossare il ddl Zan,
ma servono alcune correzioni per raggiungere una condivisione tra tutte le forze
politiche su un tema delicato".
Alessandro Sallusti,
magistrati e verginelli della politica mi fanno più paura del Vaticano.
Alessandro
Sallusti su Libero Quotidiano il 25 giugno 2021. Tutti a dire che "il parlamento
è sovrano" e che di conseguenza la nota di protesta sulla legge Zan in
discussione al Senato inviata dallo stato Vaticano al governo italiano è
irricevibile in quanto costituisce una indebita interferenza. Non so, a me
risulta che i rapporti tra Stati, soprattutto se tra due Stati intercorrono
trattati vincolanti, siano regolati anche da pressioni più o meno
debite, altrimenti dovremmo abolire la diplomazia sia nelle sue forme
sotterranee che esplicite. E mi sembra altrettanto chiaro che comunque nessuno,
tantomeno il Vaticano, abbia mai pensato che il nostro parlamento non sia
sovrano. Esattamente come facciamo noi a parti opposte: il fatto che l'Egitto
sia uno stato sovrano non ci impedisce di protestare con Il Cairo per l'arresto
dello studente Patrick Zaky, il giovane attivista egiziano che studiava
all'università di Bologna. Ma soprattutto mi piacerebbe che altrettanta fermezza
nei confronti dell'autonomia del parlamento venisse esibita anche in campi
diversi dalla legge Zan, per esempio per quanto riguarda la riforma della
giustizia. I minacciosi comunicati dell'Associazione nazionale magistrati, le
esternazioni altrettanto dure di singoli magistrati verso qualsiasi tentativo
della politica di riordinare il sistema giudiziario costituiscono o no una
"indebita ingerenza" di un potere nei confronti dell'autonomia di deputati e
senatori? Su questo il presidente della Camera Fico e la sinistra tutta non
hanno nulla da obiettare? Quelli che fanno i verginelli sono una delle categorie
peggiori della politica, mi preoccupano più loro del Vaticano. Solitamente
accade che le "pressioni" sono accolte se provengono da ambienti amici tipo
appunto i magistrati, denunciate e respinte con sdegno se intralciano i propri
piani. La laicità dello Stato va ribadita contro ogni fede invasiva, compresa
quella dei giustizialisti che in quanto a violazione dei diritti e dogmatismo
cieco sono assai più pericolosi di cardinali e vescovi.
L'Ungheria sfida la Ue. Referendum sulla
legge che discrimina i gay. Gaia Cesare il 22 Luglio
2021 su Il Giornale. Il premier Orbán: "Dite No ai cinque quesiti".
L'opposizione: "Boicottiamolo come nel 2016". Come fece nel 2016, per rigettare
le quote di ripartizione dei migranti decise dall'Unione europea, Viktor Orbán
alza l'asticella dello scontro con Bruxelles e chiama a raccolta il popolo
d'Ungheria. Stavolta c'è di mezzo lo scontro con la Ue sulla legge per la
«tutela dei minori» che regola le informazioni sulla comunità Lgbtqia (lesbiche,
gay, bisex, trans, intersessuali, queer, asessuali). Armato del suo
ultranazionalismo, marchio di fabbrica dell'esecutivo di Budapest, Orbán
annuncia il referendum: «Quando la pressione contro la nostra patria è così
forte, solo la volontà comune del popolo può difendere l'Ungheria». Entrata in
vigore l'8 luglio, la norma rende illegale mostrare o promuovere, a scuola e nei
media, contenuti che rappresentino «deviazioni dall'identità corrispondente al
proprio sesso assegnato alla nascita» se i destinatari sono minori, mettendo di
fatto sullo stesso piano omosessualità e pedofilia. Il provvedimento,
considerato discriminatorio dalle Ue, è stato definito «una vergogna» dalla
presidente della Commissione europea Ursula von Der Leyen tanto che Bruxelles ha
aperto una procedura d'infrazione contro l'Ungheria, ha rinviato l'approvazione
del Recovery Fund (7,2 miliardi) destinato a Budapest e medita l'introduzione di
sanzioni dopo che l'Europarlamento ha votato una risoluzione che esorta l'Unione
ad avviare un'azione legale contro il Paese, già condannato per «evidente
rischio di violazione grave dei valori» europei. Governata dalla maggioranza
assoluta di Fidesz, il partito nazionalista e ultraconservatore sospeso dal Ppe
nel 2019 e poi uscito per sua scelta a marzo di quest'anno, l'Ungheria
sovranista spaventa l'Europa ma non intende arretrare. E allora referendum sarà.
Composto da cinque quesiti. Uno: «Sostieni che i minori dovrebbero frequentare
le lezioni scolastiche sul tema degli orientamenti sessuali senza il consenso
dei genitori?». Due: «Sostieni la promozione di trattamenti per il cambiamento
di genere tra i minori?» Tre: «Sostieni che la chirurgia di riassegnazione del
sesso debba essere disponibile per i minori?». Quattro: «Sostieni che i
contenuti dei media che influenzano lo sviluppo sessuale dovrebbero essere
presentati ai minori senza restrizioni?». Quinto e ultimo: «Sostieni che i
contenuti multimediali che descrivono il cambiamento di genere debbano essere
mostrati ai minori?». L'invito del premier è a votare sempre «No». «È
un'iniziativa per distogliere l'attenzione dai guai del governo ungherese»,
attacca l'opposizione citando lo scandalo Pegasus: migliaia di politici,
oppositori e giornalisti spiati anche dall'Ungheria, sulla quale la Ue ha
avviato anche un'indagine per spionaggio. L'invito della minoranza è a
boicottare il referendum, che vuole «mettere gli ungheresi gli uni contro gli
altri» e usa i minori per «vili fini di propaganda». Nel 2016 finì male per
Orbán: il referendum non raggiunse il quorum (votò il 43,2%) ma il primo
ministro si convinse di aver dato comunque un segnale politico forte. Il 98%
degli ungheresi che si recò alle urne disse «No», non vogliamo che la Ue
«imponga a ogni paese membro quote di ripartizioni di migranti, senza consultare
governo e Parlamento nazionali e sovrani magiari». Il portavoce del partito
Coalizione democratica (DK), Barkóczi Balázs, è convinto che anche stavolta
finirà come allora, con il referendum nullo. «Come conseguenza della sua
disperazione, Orbán fa la solita cosa, inventa un'ennesima guerra con la Ue».
Gaia Cesare
Si stringe il cerchio dei
Paesi Ue contro Orban sulla legge anti-Lgbt.
Roberto Vivaldelli su Inside
Over il 24 giugno 2021. È massima la pressione politico-mediatica contro il
governo ungherese, promotore di una legge che vieta la propaganda Lgbt rivolta
ai minori nelle scuole e sui media. Da una parte, come abbiamo già osservato
sulle colonne di questa testata, ci sono gli europei e il calcio, sfruttato come
arma politica dagli avversari del governo magiaro per fomentare e sensibilizzare
l’opinione pubblica: dall’altra si muovono le cancellerie europee e l’Unione
europea stessa, mentre i leader dell’Ue si trovano a Bruxelles per il consiglio
europeo. “Questa legge ungherese è una vergogna. Ho incaricato i commissari
responsabili di inviare una lettera per esprimere le nostre preoccupazioni
legali prima che il disegno di legge entri in vigore. Discrimina chiaramente le
persone in base al loro orientamento sessuale. Va contro i valori fondamentali
dell’Unione europea: dignità umana, uguaglianza e rispetto dei diritti umani.
Non scenderemo a compromessi su questi principi”, ha affermato la presidente
della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, durante la presentazione del Pnrr
belga, in una presa di posizione piuttosto inusuale e inconsueta per il vertice
della Commissione, che di prassi non dovrebbe intervenire nel dibattito interno
dei Paesi membri dell’Ue. Nella giornata di ieri, come riporta
l’agenzia LaPresse, il presidente ungherese, Janos Ader, ha firmato la tanto
discussa legge anti-Lgbt. Secondo Ader, la legge non contiene alcuna
disposizione che determini come deve vivere una persona maggiorenne e non lede
il diritto al rispetto della vita privata, determinato dalla Costituzione. Come
spiega l’Huffpost, la normativa, presentata la scorsa settimana da Fidesz, mira
principalmente a combattere la pedofilia, ma include anche emendamenti che
vietano altre forme di rappresentazione di orientamento sessuale oltre
all’eterosessualità, nei programmi di educazione sessuale nelle scuole, nei film
e nelle pubblicità rivolte agli under 18. Di fatto, Con la nuova legge sarà
possibile vietare o censurare libri per ragazzi che parlano apertamente di
omosessualità e non sarà permessa la diffusione di campagne pubblicitarie
pro-Lgbt rivolte ai minori. I Paesi Ue la vedono come una forma di
discriminazione, a differenza di Budapest. Secondo la Cancelliera tedesca Angela
Merkel, la legge approvata dal Parlamento ungherese che mira a impedire la
“promozione” dell’omosessualità e della comunità Lgbt è “sbagliata”. “La legge
ungherese è una vergogna. Userò tutti i poteri che abbiamo per bloccarla e
garantire i diritti dei cittadini. Brava Von der Leyen. Questa è l’Unione
Europea che vogliamo” ha osservato su Twitter il segretario del Pd, Enrico
Letta. “L’Italia – ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi –
ha sottoscritto con altri 16 Paesi europei una dichiarazione comune in cui si
esprime preoccupazione sugli articoli di legge in Ungheria che discriminano in
base all’orientamento sessuale”. I Paesi firmatari (al momento) sono: Belgio,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lituania,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Lettonia, Italia, Grecia, Austria e
Cipro. Nella dichiarazione, gli stati Ue esprimono “profonda preoccupazione per
l’adozione da parte del Parlamento ungherese di emendamenti che discriminano le
persone Lgbtiq e violano il diritto alla libertà di espressione con il pretesto
di proteggere i bambini”. Contro la legge del governo magiaro si è mosso
anche David Sassoli che, come riporta Italpress, ha scritto alla presidente
della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo alla Commissione di
adempiere agli obblighi previsti dai trattati dell’Ue per garantire il rispetto
dello stato di diritto in tutti gli Stati membri. “Come indicato dalla nostra
risoluzione del 10 giugno 2021, ho scritto alla Presidente della Commissione, a
nome del Parlamento europeo e sulla base dell’articolo 265 del TFUE, per
invitare la Commissione ad adempiere ai suoi obblighi di custode dei trattati e
a garantire la piena e immediata applicazione del regolamento relativo alla
condizionalità sul rispetto dello Stato di diritto”, ha ricordato Sassoli in
apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles. Contro il
governo ungherese si è espresso anche il Partito popolare europeo, attraverso le
parole di capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber: “L’Europa è
sinonimo di libertà e tolleranza. Costituiscono la base del nostro stile di vita
e del nostro successo. Per proteggerlo non c’è posto per leggi che vanno contro
le libertà fondamentali delle persone. Supportiamo pienamente la presidente von
der Leyen per sostenere fermamente questi valori e le nostre leggi ovunque in
Europa”. Mentre i capi di Stato e di governo dell’Unione europea si riuniscono
oggi da Bruxelles per un Consiglio europeo che avrà come temi centrali i flussi
migratori, la ripresa economica e le relazioni esterne, con particolare
attenzione ai rapporti con la Turchia e la Russia, Budapest replica alle
dichiarazioni di Ursula von der Leyen, definendole senza mezzi termini “una
vergogna”. Affermazioni vergognose perché basate su “accuse false”. La legge
oggetto del contendere “protegge i diritti dei bambini, garantisce i diritti dei
genitori e non si applica ai diritti di orientamento sessuale di coloro che
hanno più di 18 anni”, ragione per la quale non è discriminatoria, sottolinea in
una nota il governo magiaro. Per l’opinionista statunitense Rod Dreher,
prestigiosa firma della rivista the American Conservative, von der Leyen avrebbe
spudoratamente mentito nella sua offensiva contro Budapest. La presidente della
Commissione Ue, nota Dreher, “derubrica la legge come contraria a un’Unione
europea dove sei libero di essere chi vuoi essere e dove sei libero di amare chi
vuoi. Ma la legge ungherese non vieta l’omosessualità o l’essere transgender”.
Al contrario, vieta la propaganda Lgbt rivolta ai minori. “Von Der Leyen afferma
che difendere la Blue’s Clues Pride Parade e Drag Queen Story Hour è una
questione di “diritti umani fondamentali” – ma non il diritto dei genitori a
proteggere i propri figli da queste parate. Che il presidente della Commissione
europea scelga di inquadrare il conflitto in questo modo la dice lunga su come
la burocrazia europea consideri la famiglia tradizionale”. Da Bruxelles, il
premier magiaro Viktor Orban è intervenuto per difendere la legge da poco
approvata dal parlamento di Budapest. Sotto il comunismo in Ungheria
l’omosessualità era punita per legge, e “io sono un combattente per la libertà,
ho difeso i diritti degli omosessuali” ha spiegato, come riportato
dall’agenzia Adnkronos. Le leggi approvate dal Parlamento ungherese “non
riguardano l’omosessualità”, bensì “la difesa dei diritti dei bambini e dei
genitori”. Rispondendo alle domande sulle norme riguardanti i contenuti per i
minori dei pochi cronisti ammessi ai doorstep del Consiglio Europeo a
Bruxelles., Orban ha poi aggiunto che “è sempre meglio prima leggere e poi
parlare – continua Orban -. Le leggi riguardano il modo in cui i genitori
vogliono educare i figli”. La legge ungherese sui contenuti destinati ai
minorenni “non è nell’agenda” del Consiglio Europeo, osserva, ma “sono a
disposizione di chiunque” voglia chiarimenti. In ogni caso, precisa, “la legge è
fatta e funziona”.
L’ultimatum dei Paesi
membri contro l’Ungheria. Diritti gay, Draghi stoppa Orban: “Ritiri la legge”.
Claudia
Fusani su Il Riformista il 26 Giugno 2021. A Bruxelles una ventina di paesi
dell’Unione hanno dato l’ultimatum a Viktor Orban perché ritiri quella legge che
vieta di parlare di genere, identità sessuale e omosessualità nelle scuole fino
a 18 anni di età. In Italia si apre il Tavolo per trovare una sintesi
parlamentare sul ddl Zan, contro l’omotransfobia, con Salvini nei panni del
“mediatore”, Alessandro Zan, il deputato Pd che della legge è l’ideatore, che lo
avverte: «giù le mani dalla mia legge, volete solo svuotarla» e il segretario
dem Letta che chiarisce: «La legge non si tocca». Fino a mercoledì primo luglio,
giorno di convocazione del Tavolo con i capigruppo al Senato, si andrà avanti
così. Lavorando a una mediazione che a oggi non sembra possibile. Poi ci sarà la
conta in aula. Come se non bastasse Giorgia Meloni, presidente del gruppo
conservatore Ecr, in missione a Bruxelles scatta selfie con Orban e si schiera
col presidente ungherese: «Chi critica quella legge non l’ha letta». Facendo
come minimo andare di traverso la giornata a Salvini che con Orban è in
trattativa per farci un gruppo parlamentare europeo e in Italia a questo punto
non può più “perdere” la battaglia sul ddl Zan. Per non parlare della Uefa che
in pieno campionato europeo ha avviato un’indagine sulla
partita Ungheria-Germania dove tifosi ungheresi avrebbero fatto cori e alzato il
dito medio contro la Germania, “paladina dell’omosessualità”. Il premier
Draghi pensava, sperava, di essersela cavata con “l’Italia è uno stato laico e
il Parlamento sovrano” per tornare così a occuparsi di quello che
preferisce, Pnrr, riforme, ripresa economica e dossier immigrazione. Nella
conferenza stampa di fine Consiglio europeo neppure nomina il caso diritti lgbt,
lo strappo dell’Ungheria e la lettera del Vaticano che martedì scorso ha
scatenato il dibattito anche in Italia. Nel comunicato finale dell’EuCo la
questione non è neppure citata perché non era all’ordine del giorno. Ma è sempre
così, i dossier scomodi tenuti fuori dalla porta hanno la prerogativa di saper
rientrare sempre dalla finestra. E nonostante pandemia («il virus non è
sconfitto, la varianti sono aggressive ed è necessario accelerare sulle
vaccinazioni»), Russia (il vertice con Putin resta congelato)
e immigrazione («il dossier è tornato in agenda dopo tre anni, i ricollocamenti
non erano l’obiettivo del vertice che invece si è concentrato sugli interventi
europei nei paesi africani di partenza e transito»), tutte notizie di
cui Draghi rivendica gli aspetti “utili e positivi, è il dossier diritti quello
che tiene banco nella due giorni al Palazzo Europa, sede del Consiglio
Europeo. E nelle dichiarazioni post Consiglio. Con Orban si sfiora la
rottura. Macron, Merkel, Rutte, Kurz, lo stessa von der Leyen, il
presidente Sassoli e Michel, tutti i principali leader europei usano toni
ultimativi. «La questione dei valori è fondamentale per l’Europa», dice Macron.
«C’è un aumento dell’illiberalismo nelle società che si sono battute contro il
comunismo e che oggi sono attirate da modelli politici che sono contrari ai
nostri valori» ha aggiunto denunciando “due blocchi europei”, quello dei paesi
dell’Ovest e dei paesi dell’Est. Macron non vuole usare l’articolo 50 (recesso
unilaterale di un paese dall’Unione, ndr) però invoca “procedure efficaci per
isolare queste derive”. Che sono simili a quelle dei paesi di Visegrad contrari
agli accordi sui flussi migratori. Il premier austriaco Kurz dice che “tocca
alla Commissione Ue agire”. Draghi ha ricordato che l’articolo 2 del Trattato
Ue – quello relativo ai diritti umani – è legato alla storia di oppressione dei
diritti umani vissuta in Europa. «Il Trattato, sottoscritto anche
dall’Ungheria, è lo stesso che nomina la Commissione guardiana del trattato
stesso» ha detto rivolto a Orban. Spetta quindi alla Commissione «stabilire se
l’Ungheria viola o no il Trattato». Angela Merkel, al suo ultimo consiglio Ue
con pieni poteri (in ottobre si vota in Germania), non ricorda di «aver mai
avuto in tanti anni una discussione di questa profondità e certamente non
armoniosa. Con l’Ungheria restano problemi molto seri che vanno
affrontati». Ursula von der Leyen congela al momento la faccenda denunciando
«grande preoccupazione per una legge, quella ungherese, che viola i principi
fondamentali dell’Unione». Tra Rutte e Orban si è arrivati quasi “alle mani” sui
social. «Vattene», ha detto l’olandese… «Porta più rispetto agli ungheresi», ha
replicato l’ungherese. Quello sui diritti è un incendio che va bloccato in
fretta. Potrebbe diventare alibi per atti di odio e intolleranza come si sono
visti negli stadi di Euro2020 con una Uefa impreparata a gestire questi fenomeni
che pure sono frequenti negli stadi ormai da anni. In Italia è cominciata la
conta su chi al Senato il prossimo 6 luglio potrebbe votare la calendarizzazione
della legge così com’è a partire dal 13 luglio. Le posizioni non si avvicinano.
Il Pd con Italia viva, 5 Stelle (chi, come e quanti ad oggi nessuno lo può
dire), Leu sembrano granitici: la Nota diplomatica della Santa Sede ha
accelerato l’iter del ddl Zan che la Lega tiene impantanato in commissione
Giustizia da novembre scorso con l’alibi di 170 audizioni, l’equivalente di una
tonnellata di cemento. Tutto il centrodestra chiede invece di correggere il
testo Zan con le indicazioni arrivate dalla Santa Sede. «Importante è punire i
violenti, la strada l’ha indicata la Santa Sede, ma togliamo dal tavolo il
gender nelle scuole e i reati d’opinione. Ho scritto a Letta ma avrà molto da
fare e non mi risponde». S’è fatto sentire anche Berlusconi che, a ridosso del
semestre bianco, annusa aria di pretesto per disturbare il manovratore,
cioè Draghi. «Abbiamo un governo di emergenza – ha detto il Cavaliere – che deve
andare avanti per il tempo necessario per uscire dalla crisi sanitaria ed
economica e realizzare grandi riforme come quella del fisco, della burocrazia e
della giustizia. Non certo per occuparsi di argomenti divisivi come il ddl Zan».
Il cui torto principale, par di capire, è di introdurre (articolo 1) i concerti
di sesso, genere, identità di genere e orientamento sessuale. Concetti “non
nella nostra disponibilità” ha scritto la Santa Sede.
Claudia Fusani. Giornalista
originaria di Firenze laureata in letteratura italiana con 110 e lode. Vent'anni
a Repubblica, nove a L'Unità.
Ultimatum europeo a Orban: "Cambi la
legge o passiamo ai fatti". Lorenzo Vita il 7 Luglio
2021 su Il Giornale. La legge approvata in Ungheria infiamma il dibattito. L'Ue
chiede che Orban modifichi la normativa che limita i materiali Lgbt. E qualcuno
mette in dubbio l'approvazione del piano per il Recovery Fund. Si infiamma lo
scontro tra Unione europea e Ungheria sui diritti Lgbt e nel mirino c'è
ovviamente Viktor Orban. La legge approvata da Budapest, che limita la visione
di materiale Lgbt ai minori, è considerata contraria ai valori dell'Ue, e
Bruxelles chiede che sia modificata prima di passare direttamente alla procedura
di infrazione. La sfida si è allargata anche alla Polonia, altro Paese del
Gruppo Visegrad che da tempo è al centro del dibattito per la sua legislazione
sui diritti Lgbtq. La presidente della Commissione europea, Ursula von der
Leyen, è scesa in campo con affermazioni che fanno intendere tutta la
contrarierà dell'Unione europea alle ultime mosse di Orban. "Questa legge non
serve alla protezione dei bambini, viene utilizzata la protezione dei bambini
come pretesto per discriminare l'orientamento delle persone, questa legge è
vergognosa", ha detto von der Leyen in sessione plenaria. Il capo della
Commissione ha poi ribadito che la norma approvata in Ungheria "contraddice
profondamente i valori fondamentali dell'Ue" minacciando di usare tutti gli
strumenti a disposizione per "difendere questi valori". Il rischio è che in
questo meccanismo di controllo e di procedure di infrazione rientri anche il
piano per il Recovery Fund proposto dall'Ungheria. L'ipotesi era stata paventata
dal capogruppo di Renew Europe, Dacian Ciolos, che aveva soprattutto posto
l'accento sulla mancanza di trasparenza da parte di Orban. Per adesso l'ipotesi
non sembra trovare conferme né in sede Ue né in sede magiara. I vertici
dell'Unione hanno parlato di procedure di infrazioni, ma non hanno ancora
menzionato in modo definitivo la possibilità di intaccare il piano sull'utilizzo
dei fondi europei. "La Commissione Ue sta proseguendo la sua valutazione
approfondita del piano ungherese di risanamento e resilienza rispetto agli
undici criteri stabiliti nel regolamento Rrf", ha spiegato un portavoce
dell'organo europeo. "Gli undici criteri richiedono in particolare una
valutazione del fatto che le misure affrontino le sfide individuate nelle
raccomandazioni specifiche per paese o un sottoinsieme significativo di esse e
se i piani forniscono un adeguato meccanismo di controllo e verifica. Poiché la
valutazione approfondita è in corso, non forniremo alcuna valutazione
preliminare". Un discorso simile l'ha fatto Paolo Gentiloni, che ai giornalisti
ha chiarito come i l'approvazione del piano di resilienza ungherese si basi
sugli undici criteri definiti dall'Europa. Gentiloni ha confermato l'ipotesi di
"strumenti paralleli" per convincere l'Ungheria a modificare la legge, ma sulla
questione del piano lascia le porte aperte. Da Budapest, invece, ha parlato la
ministra della giustizia ungherese, Judit Varga, che in un tweet ha smentito la
voce rilanciate dall'agenzia tedesca Dpa e ha confermato che Bruxelles non ha
respinto in alcun modo il piano ungherese. Segno che anche nel governo guidato
da Orban si vogliano distinguere i due piani di azione.
Lorenzo Vita. Nato a Roma il 2 febbraio 1991, mi
sono laureato in giurisprudenza nel 2016 con una tesi in diritto
internazionale. Dopo la laurea, ho conseguito un master in geopolitica e ho
seguito corsi sul terrorismo internazionale. Lavoro per ilGiornale.it dal 2017 e
seguo in particolare Gli Occhi della Guerra. Da settembre 2018 mi sono
trasferito a Milano e lavoro nella redazione del sito. Mi occupo prevalentemente
di Esteri, con un occhio..
Ursula Von der Leyen minaccia Orban: "Legge
vergognosa, cambiatela o passiamo ai fatti". L'Europa sanziona l'Ungheria?
Libero Quotidiano il 07 luglio 2021. "Se
l'Ungheria non aggiusterà il tiro la Commissione Ue userà i poteri ad essa
conferiti in qualità di garante dei trattati. Noi ricorriamo a questi poteri a
prescindere dallo Stato membro". Così Ursula von der Leyen la Commissione non
solo si appresta ad aprire una procedura d'infrazione per la legge anti-Lgbt che
Budapest non vuole cambiare, ma sarebbe anche pronta a bloccare il suo Recovery
plan. La legge anti Lgbt adottata in Ungheria, ha precisato la von der Leyen nel
suo intervento alla plenaria sulle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo, "è
vergognosa". La legge ungherese, ha affermato ancora, "dice che pubblicazioni
con rappresentazioni di giovani Lgbt non possono essere più mostrate ai minori:
praticamente l'omosessualità e la transessualità vengono poste allo stesso
livello della pornografia. Questa legge non serve alla protezione dei bambini,
viene utilizzata la protezione dei bambini come pretesto per discriminare
l'orientamento delle persone, questa legge è vergognosa", spiega la von der
Leyen. La legge, ha proseguito von der Leyen, "contraddice profondamente i
valori fondamentali dell'Ue. Userò tutti gli strumenti che sono a disposizione
della Commissione per difendere questi valori. Non lasceremo che una parte della
società sia stigmatizzata. Dall'inizio del mio mandato abbiamo aperto circa 40
procedure di infrazione legate al rispetto dello stato di diritto e se
necessario apriremo altre procedure", ha proseguito, spiegando che "non possiamo
rimanere a guardare quando ci sono regioni che si dichiarano liberate da persone
Lgbt. Non lasceremo che una parte della nostra società sia stigmatizzata, quando
difendiamo parti delle nostre società noi difendiamo la libertà di tutta la
nostra società", ha concluso la von der Leyen.
Omofobia, Ue senza vergogna: affida il
“processo” a Orban a un condannato per revenge porn.
Sveva Ferri giovedì 8 Luglio 2021 su Il Secolo d'Italia. È atteso per oggi il
voto del Parlamento europeo sulla risoluzione contro l’Ungheria, per
costringerla a modificare la legge a tutela dei bambini che dispone, tra
l’altro, di non coinvolgerli nella propaganda Lgbt. Una legge “omofoba” secondo
gli apparati di potere Ue, che in questa battaglia contro il governo Orban sono
rappresentati da un uomo, il laburista maltese Cyrus Engerer, condannato in
passato per revenge porn nei confronti dell’ex fidanzato.
Il «ricatto» Ue a Orban: a rischio i fondi del
Recovery. Engerer è, infatti, l’estensore della risoluzione che chiede alla
Commissione di intervenire contro Orban e che è parte di un più
ampio «processo», ormai in atto da tempo, nei confronti di uno «Stato membro
colpevole di non omologarsi al pensiero unico di Bruxelles», come ha commentato
il copresidente del gruppo Ecr-FdI, Raffaele Fitto, al termine del «dibattito
surreale» di ieri sul tema. La presidente della Commissione, Ursula Von der
Leyen, del resto, sempre ieri ha già fatto sapere che «userà tutti i suoi poteri
in qualità di guardiano dei Trattati». In ballo ci sono anche i 7,2 miliardi di
euro del Recovery. «Utilizzare le nuove regole sulla condizionalità di bilancio
come strumento per fare pressione sui governi non allineati con Bruxelles è un
ricatto inaccettabile», ha commentato il capodelegazione di FdI a
Bruxelles, Carlo Fidanza.
La risposta ungherese all’offensiva di Bruxelles.
Dunque, tutta la faccenda prende i connotati di un vero e proprio «ricatto», che
per altro rappresenta un precedente gravissimo rispetto alle ingerenze che l’Ue
è pronta a esercitare sugli Stati membri e sui suoi governi legittimamente in
carica. «Bruxelles non può rimuovere per nessun motivo politico ciò per cui gli
ungheresi hanno lavorato», ha avvertito il ministro della Giustizia ungherese
Judit Varga, ribadendo la posizione di un esecutivo che è pronto a ribattere
colpo su colpo. Sempre Varga ha chiarito che Budapest promuoverà una campagna di
informazione presso governi e istituzioni Ue per smontare le fake news contro
una legge «mal interpretata». Intanto, ha lanciato la bomba: «Quanto è
credibile il relatore dell’Europarlamento che contesta la legge sulla protezione
dell’infanzia dopo essere stato condannato per un crimine sessuale?», sono state
le sue parole, riportate da La Verità.
Il grande accusatore di Orban condannato per
revenge porn. I fatti cui si riferisce Varga sono pubblici e se ne trova ampia
conferma sul Times of Malta dell’epoca. Vi si legge che Engerer nel 2014
ricevette una condanna a due anni di carcere per aver «distribuito foto
pornografiche del suo ex fidanzato nel tentativo di screditarlo». Un caso da
manuale di «revenge porn», come lo definisce senza mezzi termini anche il Times
of Malta: Engerer e l’ex fidanzato si lasciano; l’attuale europarlamentare
spedisce foto intime al datore di lavoro dell’ex; l’ex sporge denuncia e parte
un processo che, alla fine, porta alla condanna del laburista, che però ha
ottenuto la sospensione della pena e, in virtù delle leggi maltesi, ha potuto
comunque candidarsi, conquistando poi il seggio all’Europarlamento.
E poi parlano di odio…Con questo pregresso,
dunque, Engerer si presenta come capofila del fronte parlamentare anti Orban,
che ha l’appoggio incondizionato della Commissione. «L’Ue non è posto per la
politica dell’odio», tuona oggi Engerer, aggiungendo che «il fatto che Orbán
abbia introdotto una legge omofoba in stile russo nel quadro legislativo dell’Ue
deve essere condannato e punito». Ancora La Verità ricorda come del caso di
revenge porn in capo a Engerer si occupò anche la giornalista Daphne Caruana
Galizia, uccisa in un attentato nel 2017.
Dalle sue cronache emergono ulteriori dettagli sul
comportamento dell’attuale eurodeputato. Engerer, ricostruì Galizia, entrò in
casa dell’ex senza permesso e rubò le foto dal suo computer, usandole poi «per
ferirlo agli occhi del suo datore di lavoro e dei colleghi, sperando che
perdesse il lavoro o almeno il loro rispetto». «Se non riuscite a capire che si
tratta di un crimine grave, allora – concludeva la giornalista – dovreste
mettere in discussione i vostri valori».
Ddl Zan, la Garante dell’Infanzia della
Regione Umbria: “Legittima rapporti con animali e cose”.
Giampiero Casoni il 07/07/2021 su Notizie.it. Ddl Zan, la Garante
dell’Infanzia: “Legittima rapporti anche con animali o cose. Ogni desiderio sarà
considerato un bisogno e il bisogno un diritto”. Ddl Zan e iperboli
interpretative, iperboli come quella della Garante dell’Infanzia della Regione
Umbria per cui le legge concepita così com’è legittimerebbe “rapporti anche con
animali o cose” e incentiverebbe incesti, poligamie e gang banghismo con i
mobili di casa. Insomma, fra le tante decorose ragioni in punto di dialettica
democratica per esprimere perplessità su alcune parti del Ddl Zan Maria Rita
Castellani, garante dei diritti dell’Infanzia per la Regione Umbria, è andata ad
elaborarne una che ha il pregio dell’iperbole da sodomia biblica, che è però
pregio solo in letteratura fetish. In buona sostanza e con piena coscienza del
suo ruolo istituzionale che le fa divieto di buttarla troppa massa critica la
signora ha detto perché a suo parere bisogna dire di no alla legge che sanziona
l’omotransfobia. E la risposta è certa, granitica e senza tema di equivoco
perché le cose equivoche le fanno solo quelli là: perché approvarla
legittimerebbe il sesso con i bambini o con gli animali. Dove sta il nodo
cruciale a parare della Garante? Nella definizione ondivaga e soggettiva del
concetto di identità di genere. Insomma, l’equazione è, o sarebbe “se io
attribuisco in punto di libertà individuale al genere una natura diversa da ciò
che natura ed anagrafe in quel momento significano in esteriorità allora potrò
avere rapporti con chiunque perché non esiste più legame fra ciò che si è
davvero e ciò che si appare”. Con chiunque e qualunque cosa a questo punto,
perché a seguire il ragionamento della dottoressa Castellani, amica
dell’ortodosso Simone Pillon, un comodino non è detto che sia tale e potrebbe
coltivare sogni identitari precisi e divergenti dalla sua natura di coso su cui
poggiare gli occhiali la sera. Fuor di celia e di iperbole (ma ha cominciato
lei) le affermazioni della Garante umbra per l’Infanzia hanno sollevato un
vespaio grosso come quel Palazzo Madama che il 13 luglio si appresta a diventare
ring per Pd e Lega, divisi sul tema come Totò e Peppino a Berlino e con Matteo
Renzi a fare da Check Point Charlie. È stata depositata anche una formale
richiesta da parte di associazioni e partiti di opposizione che chiedono la
testa della Castellani. Ecco in polpa le sue affermazioni sul tema: “Il concetto
d’identità cambia, non è più quello antropologico che conosciamo da sempre e che
distingue persona da persona a ragione di evidenze biologiche, ma diventerà
qualcosa che io, cittadino, posso decidere arbitrariamente secondo la percezione
del momento”. E ancora: “Di conseguenza ogni desiderio sarà considerato un
bisogno e il bisogno un diritto. Si potrà scegliere l’orientamento
sessuale verso cose, animali, e/o persone di ogni genere e, perché no, anche di
ogni età, fino al punto che la poligamia come l’incesto non saranno più un
tabù”. Messa al sicuro la nonna dalle scalmane del pappagallo di casa e del
ferro da stiro resta il dato storico per cui le affermazioni della garante sono
finite dritte in una lettera indirizzata alla governatrice Donatella Tesei. Lo
scopo? Manco a dirlo, sempre la testa della Castellani che con tre frasi tre è
riuscita a superare in appeal di periglio pure Billy The Kid. La richiesta porta
in calce la firma di associazioni Lgbt, partiti, sindacati, studenti, medici,
psicologi e marmitte catalitiche in crisi di identità. Ecco cosa dice in
stralcio lo scritto: “Castellani ha realizzato un’acrobazia pericolosa in bilico
fra propri convincimenti personali e pregiudizi inqualificabili,
dimostrando un’ignoranza colpevole per chi ricopre il suo ruolo, acrobazia che
rappresenta una realtà fantascientifica, inesistente nel mondo delle cose
concrete e non scritta nel Ddl Zan”. Nessun problema per le chiocciole della
mail list: loro sono ermafrodite.
Assedio a Orban per una
legge che non parla di omofobia ma di pedofilia. Meloni: quanti l’hanno letta?
Adele
Sirocchi sabato 26 Giugno 2021 su Il Secolo d'Italia. Viktor Orban, l’Europa è
in pressing contro il premier ungherese per la legge che vieta la propaganda
gender ai minori. Orban non cede di un millimetro ma intanto la retorica
anti-Ungheria si fa sempre più asfissiante e va dalle tirate d’orecchio di
Ursula von der Leyen al documento dei 17 paesi in difesa dei diritti sconfinando
nei campi di calcio tinti di arcobaleno.
La legge parla di minori e non
dell’omosessualità. Orban intanto replica attaccando: «L’omosessualità non
c’entra con questa legge. Si parla dei minori e dei loro genitori, tutto qui».
Con lui si è schierato l’omologo sloveno Janez Jansa. E Judit Varga, ministro
ungherese della Giustizia, si infuria: «L’orientamento sessuale e l’identità di
genere rientrano pienamente nelle tutele della Costituzione ungherese». E
sostiene che nel suo Paese «tutti sono liberi di esprimere la loro identità
sessuale come ritengono». In pratica si attacca una legge di cui nessuno vuole
conoscere il contenuto. Un appunto che anche Giorgia Meloni fa proprio. Ieri ha
dichiarato in proposito: “Io la legge l’ho letta e le cose sono distanti da come
vengono raccontate. La legge è scritta con toni che non mi piacciono. Ma è una
legge che vieta la propaganda gender nelle scuole da parte di organizzazioni che
non appartengono al sistema di istruzione ungherese”.
Cosa contiene la legge
ungherese. Oggi solo Libero e la Verità si preoccupano di informare i lettori
su cosa contiene la contestata legge ungherese, il cui titolo è «Sull’adozione
di misure più severe contro i pedofili e sulla modifica di alcune leggi per la
protezione dei bambini». Il primo titolo – scrive la Verità – prevede un
emendamento alla legge sulla protezione dei bambini e l’amministrazione della
tutela. Il nuovo articolo recita: «Per garantire la realizzazione degli
obiettivi stabiliti nella presente legge e l’attuazione dei diritti dei minori,
è vietato rendere accessibile alle persone che non hanno raggiunto l’età di 18
anni un contenuto pornografico o che rappresenta la sessualità in modo gratuito
o che diffonde o ritrae la divergenza dall’identità corrispondente al sesso alla
nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità».
Le norme e i divieti della
legge di Orban. Il terzo titolo – scrive ancora La Verità – riguarda la
modificazione della legge sulla pubblicità. La nuova norma recita: «È vietato
rendere accessibile alle persone che non hanno raggiunto l’età di 18 anni la
pubblicità che ritrae la sessualità in modo gratuito o che diffonda o ritragga
la divergenza dall’autoidentità corrispondente al sesso alla nascita, il
cambiamento di sesso o l’omosessualità». Vi è poi il titolo 5, che prevede una
stretta sui programmi classificati come «non adatti a un pubblico di età
inferiore ai 18 anni», cioè quelli in cui elemento centrale è «la violenza, la
diffusione o la rappresentazione della divergenza dall’identità personale
corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o
dell’omosessualità o la rappresentazione diretta, semplicistica o gratuita della
sessualità». In pratica, la legge censura i contenuti che ritiene impropri e
legati a tutta la sfera della sessualità e non solo a quella dell’orientamento
sessuale Lgbt. Si può discutere se sia opportuno “proteggere” i minori in questo
modo ma non è certo corretto presentarla come una normativa anti-gay.
La leader di Fdi dice la
sua. Roma Pride 2021, Meloni: “Cristo lgbt è irrispettoso”.
Riccardo Annibali su Il
Riformista il 26 Giugno 2021. Il corteo Roma Pride 2021 è arrivato a piazza
della Repubblica e la manifestazione si è conclusa. Ad aprirsi invece ora sono
le polemiche, e a farlo è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Leggo
che il corteo del Roma Pride è aperto da un ragazzo travestito da ‘Cristo Lgbt’,
con stimmate colorate e bandiera arcobaleno. Per quanto mi interroghi, non
riesco a trovare una risposta a questa domanda: che bisogno c’è di mancare di
rispetto a milioni di fedeli per sostenere le proprie tesi? E aggiungo: come si
concilia la lotta alle discriminazioni, alla violenza e all’odio con i cori di
insulti e minacce contro chi non è d’accordo con il ddl Zan? Se sei convinto
delle tue idee e delle tue posizioni, non hai bisogno di insultare nessuno. Io
la penso così. Qualcun altro evidentemente no”, conclude così il suo pensiero
affidato alla pagina Facebook. Il corteo del Roma Pride 2021 ha raggiunto piazza
della Repubblica. Sono partiti in migliaia, dall’Esquilino senza i tradizionali
carri. I sostenitori Lgbti+ hanno sfilato in modo pacifico e senza scontri di
sorta, sventolando bandiere arcobaleno e cartelli in favore del ddl Zan. Si sono
sentiti cori di Bella Ciao e le canzoni di Raffaella Carrà. L’organizzazione del
Pride è stata a cura del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli che ha
curato anche lo striscione di apertura del corteo che recitava: “Orgoglio e
Ostentazione”. Alle sue spalle, in riferimento alle ultime dichiarazioni del
Vaticano in merito al ddl Zan: “Per la laicità dello Stato aboliamo il
concordato”. Riccardo Annibali
L'ira della Meloni:
"Guardate questo cristo Lgbt..."
Federico Garau il 26 Giugno 2021 su Il Giornale. Al corteo arcobaleno di Roma
compare anche il "Cristo Lgbt". Meloni: "Se sei convinto delle tue idee e delle
tue posizioni, non hai bisogno di insultare nessuno". Mentre si continua a
discutere in merito al Ddl Zan, sale la tensione per le strade italiane, dove
proprio oggi hanno sfilato cortei a favore dei diritti Lgbt. Almeno sei le città
dello stivale coivolte, da Milano a Roma, fino ad arrivare ad Ancona, L'Aquila,
Faenza e Martina Franca, in provincia di Taranto. Nel corso delle sfilate, anche
manifestazioni di insofferenza: al gay pride di Bologna, nella giornata di
apertura, impronte rosa sono state volutamente impresse sui volti di alcuni
famosi politici appartenenti alla destra, come Matteo Salvini, Giorgia Meloni,
Simone Pillon, Mario Adinolfi, Viktor Orbàn e Donald Trump. Ma le provocazioni
del popolo arcobaleno non sono finite, come mostrato dalla leader di Fratelli
d'Italia sulla propria pagina Facebook.
Il "Cristo Lgbt". A guidare il
corteo del Roma Pride di oggi, infatti, c'era un ragazzo travestito da "Cristo
Lgbt". Un'immagine difficile da accettare per chi ha a cuore certi simboli
religiosi. "Leggo che il corteo del Roma Pride è aperto da un ragazzo travestito
da 'Cristo Lgbt', con stimmate colorate e bandiera arcobaleno", ha dichiarato
Giorgia Meloni, postando la foto della sfilata. "Per quanto mi interroghi, non
riesco a trovare una risposta a questa domanda: che bisogno c'è di mancare di
rispetto a milioni di fedeli per sostenere le proprie tesi?", si è domandata la
presidente di FdI. E ancora: "Aggiungo: come si concilia la lotta alle
discriminazioni, alla violenza e all'odio con i cori di insulti e minacce contro
chi non è d'accordo con il ddl Zan? Se sei convinto delle tue idee e delle tue
posizioni, non hai bisogno di insultare nessuno. Io la penso così. Qualcun altro
evidentemente no". Con il loro atteggiamento intransigente nei confronti di chi
non la pensa come loro, i sostenitori del Ddl Zan stanno mostrando proprio quel
comportamento discriminatorio che tanto condannano.
"La Chiesa mi vuole morto".
Fra i manifestanti, del resto, c'è anche chi non ha rispetto per le istituzioni
religiose, e arriva addirittura a condannarle. "La Chiesa perseguita le persone
Lgbt da 2000 anni. Di fronte a un ddl che può provare ad arginare i fenomeni di
odio dovrebbe almeno rispettare l'autonomia del Parlamento italiano invece di
appellarsi a un concordato vecchio di 90 anni", ha apertamente dichiarato
all'AdnKronos un manifestante del corteo di Roma, che sfilava con un cartello
recante la scritta 'Sono gay e la Chiesa cattolica mi vuole morto'. In realtà le
intenzioni della Chiesa con la sua richiesta di rimodulazione del decreto di
legge erano ben altre, come dichiarato dal Segretario di Stato Pietro Parolin,
ma evidentemente il messaggio non è passato.
Federico Garau. Sardo,
profondamente innamorato della mia terra. Mi sono laureato in Scienze dei Beni
Culturali e da sempre ho una passione per l'archeologia. I miei altri grandi
interessi sono la fotografia ed ogni genere di sport, in particolar modo il
tennis (sono accanito tifoso di King Roger).
Il gay pride blasfemo fa esplodere le
polemiche. Federico Garau il 27 Giugno 2021 su Il
Giornale. Non è piaciuta la provocazione del mondo Lgbt, in tanti ad insorgere
sui social. Dopo le parole della Meloni, arriva la condanna di Salvini: "Una
schifezza, un’offesa e una sgradevole mancanza di rispetto". È scoppiata
un'autentica bufera in seguito ai cortei arcobaleno che ieri hanno sfilato per
le strade dello Stivale al fine di riaffermare i diritti del popolo Lgbt e
sostenere con forza il Ddl Zan: da Milano a Roma, fino ad arrivare a Martina
Franca (Taranto), tante le immagini delle sfilate, dove non sono mancate
provocazioni nei confronti della Chiesa, rea di aver chiesto una rimodulazione
del disegno di legge. Fra queste, a fare scalpore è stata di sicuro quella del
"Cristo gay" impersonato da un giovane agghindato ad arte, con tanto di stimmate
colorate. Una foto che ha fatto il giro dei social, scatenando l'ovvia reazione
dei religiosi. La prima a far sentire la propria voce è stata la leader di
Fratelli d'Italia, che postando sui propri account social l'immagine del "Cristo
gay" ha commentato: "Per quanto mi interroghi, non riesco a trovare una risposta
a questa domanda: che bisogno c'è di mancare di rispetto a milioni di fedeli per
sostenere le proprie tesi? Aggiungo: come si concilia la lotta alle
discriminazioni, alla violenza e all'odio con i cori di insulti e minacce contro
chi non è d'accordo con il ddl Zan? Se sei convinto delle tue idee e delle tue
posizioni, non hai bisogno di insultare nessuno. Io la penso così. Qualcun altro
evidentemente no". Parole che hanno poi provocato la reazione dell'ex deputato
grillino passato al gruppo misto Giorgio Trizzino: "Che Giorgia Meloni si erga a
difensore della Cristianità rivendicando che al Roma Pride non possa mostrarsi
un ragazzo travestito da Gesù Cristo, mi fa molto pensare. Mi chiedo come mai la
patriottica Giorgia si ricordi di essere cattolica e praticante solo in queste
circostanze, mentre mostra gravissimi vuoti di fede quando urla che bisogna
respingere al mittente quei poveri migranti che cercano un po' di vita
approdando sulle nostre coste". A replicare alla frecciata del deputato Trizzino
è stato il rappresentante di FdI Andrea Delmastro. "Si atteggia ad ayatollah
della cristianità e lancia una laica scomunica a Giorgia Meloni, rea di aver
stigmatizzato il disgustoso Cristo Lgbt", ha commentato Delmastro, riferendosi
all'ex pentastellato. "Meloni ha, con equilibrio e pacatezza, difeso il
sentimento di cristianità, offeso e vilipeso dalla manifestazione Lgbt
chiedendosi perché l'affermazione di presunti diritti debba passare per la
denigrazione di Cristo". In realtà sono in molti a non aver affatto gradito le
provocazioni del popolo arcobaleno, che avrebbe potuto tranquillamente
manifestare ed esprimere le proprie idee senza attaccare quei simboli ritenuti
preziosi non soltanto dai cristiani praticanti, ma anche da coloro che nutrono
un forte rispetto nei confronti delle tradizioni religiose del Paese. Durante le
manifestazioni di ieri si è visto di tutto, non solo il "Cristo gay", ma anche
un papa Francesco mascherato e striscioni ed insulti rivolti contro il Vaticano
("Per la laicità dello Stato aboliamo il Concordato", o "Vaticano vaff...", solo
per citarne alcuni). "Nel 2021 è chiaro a tutti quanto la comunicazione conti. E
che nessuno si permetta di fare lo splendido con la figura di Maometto perché lì
si tratta di “rispetto”, o paura. Allora mi chiedo il senso di sputare in faccia
ai cristiani. Accorcia le distanze?", ha sbottato la senatrice di FdI Daniela
Santanchè. Ad unirsi agli indignati, anche il giornalista e scrittore del Popolo
della Famiglia Mario Adinolfi: "Ieri il Gay Pride di Roma è stato aperto da uno
striscione antivaticano con un tizio che irrideva la figura di Gesù, nudo con
corona di spine, stimmate e drappo arcobaleno", ha commentato. "Ho invidiato i
musulmani che riescono a far rispettare Maometto, inculcando in quei 4 cialtroni
la paura". Parole pesantissime che hanno naturalmente scatenato un autentico
putiferio sui social network. A far discutere anche il pride di Milano, dove non
sono mancati gli slogan contro la Chiesa. A postare le immagini del corteo, dove
è apparsa una "seconda versione" del Cristo gay, è stato un indignato Matteo
Salvini. "Ieri in piazza a Milano..." ha scritto il leader della Lega. "Secondo
me raffigurare Gesù Cristo con minigonna e tacchi a spillo non è una simpatica
provocazione, è una schifezza, un’offesa e una sgradevole mancanza di rispetto".
Federico Garau. Sardo, profondamente innamorato
della mia terra. Mi sono laureato in Scienze dei Beni Culturali e da sempre ho
una passione per l'archeologia. I miei altri grandi interessi sono la fotografia
ed ogni genere di sport, in particolar modo il tennis (sono accanito tifoso di
King Roger). Dal 2018 collaboro con IlGiornale.it, dove mi occupo soprattutto di
cronaca.
Felice Manti per "il
Giornale" il 28 giugno 2021. Orgoglio e pregiudizio. No, Jane Austen non
c'entra, anche se nella comunità Lgbt lei è un'icona perché si favoleggia fosse
lesbica. Balle. L'orgoglio è quello andato in scena ieri ai Gay Pride, da Milano
a Roma, il pregiudizio è il solito: siccome «la Chiesa perseguita i gay da 2mila
anni» (altra balla) allora perché non trasformare anche Gesù in un'icona gender,
mettergli dei tacchi a spillo, imbrattare la sua croce con un simbolo fallico e
guadagnarsi una foto sui giornali? Un attivista l'ha fatto, e il risultato l'ha
ottenuto. «Secondo me raffigurare Gesù Cristo con minigonna e tacchi a spillo
non è una simpatica provocazione, è una schifezza, un'offesa e una sgradevole
mancanza di rispetto», twitta Matteo Salvini. «Che bisogno c'è di mancare di
rispetto a milioni di fedeli per sostenere le proprie tesi?», aveva detto già
l'altro giorno la leader Fdi Giorgia Meloni. Se oggi qualcuno volesse sostenere
che questo attivista gay ha insultato una religione nel cui nome, nel 2020, sono
morte 4.761 persone, potrebbe farlo senza timore di smentita. D'altronde, i dati
parlano chiaro: l'anno scorso 340 milioni di persone sono state perseguitate
perché credono che un ragazzo di 33 anni morto in croce fosse il figlio di Dio.
Ma con il ddl Zan sarà ancora possibile difendere il proprio credo da una
bestemmia arcobaleno? Sarà ancora possibile dire che un bambino ha diritto a una
mamma e a un papà senza finire davanti a un giudice? Secondo il Vaticano e molti
esperti, no. La Chiesa è un facile bersaglio, soprattutto se rivendica la
propria libertà di culto prevista nel Concordato. Ma, come dice padre Laurent
Cabantous, «la libertas ecclesiae è il cuore di ogni altra libertà, e la Chiesa
nel proteggere i suoi diritti difende la libertà di tutti». Nessuno nel
centrodestra vuole giustificare i reati di omotransfobia, tanto che Lega, Fdi e
Forza Italia hanno presentato una proposta di legge, molto più ragionevole e
meno ideologica, per venire incontro alle istanze della comunità Lgbt. Eppure il
tema resta lo stesso: il ddl Zan serve perché copre un vuoto normativo o è solo
un cavallo di Troia per imbavagliare i cattolici? La Pd Monica Cirinnà ha
gettato la maschera: «Va approvato così com'è - ha detto a margine del Gay Pride
di Roma - se dovesse essere modificato meglio non avere nessuna legge». Segno
che il problema non è combattere veramente l'omotransfobia, ma approfittare di
un clima favorevole per mettere fuori gioco chi si ostina ad opporsi al pensiero
unico che predica amore vero ma razzola di utero in affitto, fluidità di genere
e ideologia gender nelle scuole. «Se non ci sarà una legge perché la parte
oltranzista del Parlamento non si siederà con la volontà di approvare una norma
buona e condivisa, ai cittadini sarà chiaro chi stava realmente dalla parte dei
diritti e delle libertà e chi, invece, faceva solo finta», dice Licia Ronzulli
di Forza Italia. Intanto ieri un ragazzo, Orlando Merenda, si è gettato sotto un
treno a 18 anni, i pm indagano per bullismo e omofobia, altro segno che una
nuova legge non serve. Il ragazzo sui social aveva scritto «il problema delle
menti chiuse è che hanno la bocca aperta», qualcuno ha replicato «morte ai gay».
Non è puntando il dito contro il nemico, che sia un prete o un militante Lgbt,
che si risolve il problema dell'omofobia. Non è spaccando il Paese mettendo
all'indice cattolici e moderati che si insegna la tolleranza per chi percepisce
il proprio corpo come qualcosa di estraneo. È anche per questo che Papa
Francesco lunedì scorso ha scritto (a mano e in spagnolo) al padre gesuita James
Martin, considerato un difensore dei diritti Lgbt, dicendo che «il cuore di Dio
è aperto a tutti, si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli». Perché il
rispetto prevede altrettanto rispetto, l'odio semina odio, e nessuna legge potrà
impedirlo. Qualcuno, duemila anni fa, è morto per amore di tutti. Anche di
Orlando.
Pride, così la piazza ha
scatenato d'odio: parlano d'amore ma vogliono annientare chi non la pensa come
loro. Renato
Farina su Libero Quotidiano il 28 giugno 2021. Gay pride, sabato scorso. Si può
discuterne senza essere appesi per i piedi? Provando a disobbedire all'obbligo
dell'inginocchiatoio dinanzi a questa colonna marciante del pensiero unico? Ci
provo. Il corteo di Roma per la difesa dei diritti omosessuali è stato un lungo
ululato di odio, che resta tale anche se fluisce circondato dai dolci colori
dell'arcobaleno. Lo scopo della marcia è la divisione dell'umanità in due razze.
Da una parte quella superiore, che esige l'approvazione sic et simpliciter del
disegno di legge Zan. L'altra, tipicamente sub -umana, che chiede se ne discuta,
si provi almeno a prendere sul serio le ragioni chi ne intravede un uso
intimidatorio verso i dissenzienti. L'allegro serpentone è stato preceduto da un
tale che rappresentava Gesù Cristo, reso idoneo a partecipare al carnevale
Lgbtqi+. Che cos'è se non cosciente cristianofobia? Maledizioni non solo contro
chi osi citare la Bibbia sulla condanna della sodomia, ma anche contro chi
vorrebbe che il ddl Zan lasciasse la libertà di dar ragione al catechismo senza
la prospettiva di finire in tribunale. In questo quadro il vaffa al Vaticano è
quanto di più mite si sia scandito. Queste cose si possono dire anche oggi?
Anche dinanzi all'orrore di un ragazzino suicida a Torino travolto- dicono gli
amici - dai bulli omofobi, che possano sprofondare?
Il consenso dei media. Si è
soliti udire una critica da parte degli omosessuali più seri ai vari gay pride
che suona così: è una pagliacciata, non mi ritrovo in una manifestazione di
cattivo gusto così esibito. D'accordo. Ma non è questo il punto. Chiunque abbia
un minimo di coscienza di sé, senza bisogno di essere omo o bio transessuale, sa
che la cifra sessuale della vita intima e sociale di ciascuno è comunque un
dramma, perché i rapporti con l'altro/a di qualsiasi genere e tipo sono
attraversati da questo essere maschio o femmina. Ma guai a ridurre la questione
a scontro tra etero e i diversi (o, detta altrimenti, tra Lgbt e i diversi),
come se fosse una lotta di classe, al termine della quale saremo tutti felici
come predicava il comunismo. Balle. Nei Paesi come la Svezia dove la questione è
risolta pienamente, e i diritti a qualsiasi amore e al loro riconoscimento
sociale sono pienamente sanciti, la tragedia incombe comunque (si veda su
Netflix il film Dancing Queen). La volontà di potere e di mercificazione del
prossimo (concupiscenza come la definisce san Tommaso o sfruttamento
-alienazione, vedi Marx, Nietzsche e Freud) è un demone a cui ciascuno è
chiamato a mettere le catene per far prevalere l'amore come dono di sé. Dunque
mettersi le piume o indossare la tiara colorandola di arcobaleno e andare in
piazza sui carriaggi come al carnevale butta la questione un po' troppo sul
ridicolo. Del resto esiste il diritto umano ad essere farseschi. Il problema è
che ogni anno di più questi spettacoli pubblici di orgoglio Lgbt, mano a mano
che cresce intorno ad essi il consenso, e il Tg1 ne parla con la stessa
devozione della messa di Natale, acquisiscono la tracotanza dell'intolleranza e
dell'odio. Ma qualcuno ha letto davvero i cartelli, ascoltato i canti, osservato
i travestimenti che ufficialmente sarebbero satirici? Altro che partito
dell'amore, queste sono pure sceneggiate di odio in maschera, con la complicità
condiscendente dei media. È vero. L'odio è un sentimento, e cometa le non è un
reato. Eppure il primo esercizio di libertà è di chiamare le cose con il loro
nome. Accettando il parere di chi dà un altro nome, ma nel rispetto
dell'interlocutore. Tutto questo è impossibile. Chi contraddice il tema del "si
può amare chi si vuole come si vuole" (un famoso maître à penser ha aggiunto
"anche i cani") è perciò stesso infilato tra gli omofobi, e perciò, prima ancora
che messo nelle mani dei magistrati, sottoposto a scorticatura dell'anima. Altro
che "chi sono io per giudicare?". Sei impalato al volo.
Diritti fasulli. Ecco, in
questo senso il clima da gay pride che sta trionfando oggi (e che l'intervento
della Santa Sede ha cercato di riportare sui binari della pacata razionalità) è
pericoloso. Non perché da quei cortei rischino di partire pattuglie di
omo-black-bloc, solo un cretino potrebbe pensarlo. Il fatto è che esistono i
manganellatori del pensiero e delle coscienze. E i gay pride si basano su un
dogma che è impossibile mettere in discussione senza essere scomunicati dai
sacerdoti dell'amore libero e sbattuti fuori dal recinto della civiltà. Un po'
come il movimento Black Lives Matter. Tutti in ginocchio. Chi non si inginocchia
appartiene al mondo delle bestie, com' è sfuggito con un mirabile lapsus a
Chiellini, passa per un nazista, vuole l'Auschwitz per i neri e in questo caso
per le persone di orientamento omosessuale, con le varianti che mano a mano si
aggiungono con una letterina ed oramai con il + per sottolineare che sono
infinite quanto i pareri di ciascuno. Ecco, chiederei che in quelle categorie di
diversi da rispettare, comprendendoli misericordiosamente in quel +, ci siano
anche coloro che ieri il gay pride ha schernito, assoldando all'uopo anche un
finto Gesù Cristo. P.S. Per intenderci, so per certo citando Pier Paolo Pasolini
a proposito della Dc e delle stragi -, so, sono sicuro, ma non ho le prove, che
le poche migliaia che si esercitano al gay pride sono le arcobaleniche
avanguardie di poteri assai meno vezzosamente piumati, il cui scopo da decenni è
di sciogliere ciò che resta delle radici giudaico cristiane nell'acido dei
diritti fasulli. Qualcosa però resiste nella memoria nebbiosa dei popoli.
Alessandro Sallusti contro il ddl Zan: i
fascisti di oggi cantano Bella Ciao. Alessandro
Sallusti su Libero Quotidiano il 27 giugno 2021. Tranquilli, dicono a sinistra
che la legge Zan non limiterà le libertà di pensiero e opinione. È la stessa
sinistra che in queste ore, con un appello firmato da 150 pseudo illustri
economisti d'area, chiede la rimozione di due autorevoli consulenti del
governo, Riccardo Puglisi e Carlo Stagnaro non perché giudicati incapaci, non
perché pregiudicati e neppure perché raccomandati, ma in quanto pensatori
liberisti. Parità di genere quindi per i trans, ma non parità di pensiero per i
liberali: un economista che crede nel libero mercato non ha diritto di parola e
di rappresentanza, tanto meno di accesso alle stanze del potere. Ieri il
fascismo, oggi il liberismo, presto se passa il decreto Zan così come è - il
cattolicesimo. Mai l'offensiva per eliminare il pensiero non di sinistra è stata
così violenta e diffusa. La parola d'ordine è "omologarsi" e non mi stupirei se
il Pd iniziasse a emanare liste di proscrizione di professori, giornalisti e
pensatori da cacciare da università, mezzi di comunicazione e uffici pubblici.
Il precedente c'è: 1938, quando in concomitanza con la sciagurata firma delle
leggi razziali furono espulsi dagli atenei italiani 96 docenti, ben il 7%, oltre
a circa 200 altri ricercatori e liberi insegnanti per il solo fatto che erano
ebrei. Oggi i fascisti non portano la camicia nera, cantano Bella Ciao e hanno
in tasca la tessera del Pd o di uno dei tanti partitini d'area. Professori che
pensano di poter imporre alle scuole cattoliche cosa insegnare, agli economisti
cosa pensare, a noi come scrivere (alcune parole sono già state messe al bando e
usarle comporta andare in seri guai professionali). E chi non si adegua? Ora
cacciato, punito, deriso, messo all'indice, un domani - perché no? - un bel
campo di rieducazione come pena alternativa al carcere. Chiedere la testa di due
economisti in quanto liberisti è un fatto gravissimo. Che a farlo siano 150
professori e non un gruppo di invasati sui social spazzatura rende la cosa assai
pericolosa. E dà la misura di che cosa sia e in che mani sia finita l'università
italiana (sulla immoralità della sinistra non abbiamo mai nutrito dubbi).
Lo sfregio al Gay Pride:
calpestati i volti dei leader di destra.
Francesca Bernasconi il 26
Giugno 2021 su Il Giornale. A Bologna inizia la settimana transfemminista. Per
la performance di apertura, le impronte rosa imbrattano volti noti. In testa una
mitra rosa, il tradizionale copricapo del vescovo, e in mano cartelloni e
bandane dello stesso colore. Lasciano impronte (anche queste rosa) sui volti di
personaggi noti, come Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Simone Pillon, Mario
Adinolfi, Viktor Orbàn, Donald Trump e Papa Francesco. La chiamano
"performance", ma è l'ennesima manifestazione violenta del popolo arcobaleno. È
andata in scena in piazza Nettuno a Bologna per lanciare la settimana
transfemminista e transnazionale che, da oggi fino al 3 luglio coinvolgerà
diverse realtà del territorio bolognese. La trovata non distende certo gli animi
in un momento dove la politica si sta già profondamente dividendo sul ddl Zan.
Il popolo arcobaleno
all'attacco. "Da oggi fino al 3 luglio invaderemo lo spazio pubblico con i
nostri corpi - spiegano le femministe al microfono e nei post pubblicati sui
social -la nostra rabbia e la nostra gioia contro i continui attacchi misogini e
omolesbobitransfobici". Gli attacchi di cui parlano i fautori della
manifestazione hanno assunto una dimensione transnazionale: "L'uscita dalla
convenzione di Istanbul voluta da Erdogan ha come base la stessa retorica degli
attacchi alla legge Zan in Italia", spiegano nel post, citando anche la
posizione del Vaticano in merito al Ddl Zan. "Questi attacchi familisti e
ultraconservatori di fatto legittimano la violenza che subiamo quotidianamente e
sono la reazione eterocispatriarcale alla nostra rivendicazione di
autodeterminazione". I collettivi, le associazioni Lgbtqia+ di Bologna e il nodo
locale di Non Una Di Menosi scagliano contro i sostenitori della famiglia
nucleare e intendono rispondere agli"Stati Generali della Natalità, dove il
primo ministro sfila davanti al Papa additando le donne di rifiutarsi di
accogliere il dono della maternità per questioni individualistiche" con
gli "Stati GENDERali", che si terranno per tutta la prossima settimana. Due i
principali appuntamenti lanciati dalle associazioni. Giovedì prossimo, "data
ufficiale di uscita della Turchia dalla Convenzione di Istanbul" alle 18 sfilerà
in piazza dellUnità un corteo transfemminista e transnazionale, che si unirà a
quello lanciato "dai movimenti delle donne e persone Lgbt*qia+ in Turchia e
della rete EAST (Essential Autonomous Struggles Transnational), in connessione
con le mobilitazioni femministe e transfemministe contro la violenza maschile e
di Stato in America Latina, per dire chiaramente che non accetteremo di pagare
le conseguenze delle sindemia sui nostri corpi". Il secondo appuntamento si
terrà invece il 3 luglio, giorno della Rivolta Pride, l'appuntamento annuale del
movimento Lgbtqia+, che quest'anno "assume connotati molto più radicali".
Infatti, spiegano le diverse realtà, "quest'anno il Pride sarà Rivolta Pride.
Prendiamo parola per rivendicare molto più di Zan, perché una misura repressiva
non ci basta. Non abbassiamo la testa e non rimaniamo in silenzio".
Lo sfregio alla
manifestazione. I volti degli avversari calpestati. Sulle loro foto
spuntano impronte rosa, che mirano a coprire e cancellare le facce di uomini e
donne, politici di tutto il mondo e non solo, stampate su fogli di carta con cui
è stata tappezzato qualche metro della piazza. È lo sfregio messo in atto dai
manifestanti che a Bologna hanno lanciato la settimana transfemminista e
transnazionale. Lo hanno fatto ballando a suon di musica, come mostra il video
postato da Non una di meno, sulle foto di chi non la pensa al loro stesso modo.
"L’Ansa ci informa che il Gay Pride unitario di Bologna, che prende il nome di
Rivolta Pride, sarà 'molto più radicale'- ha commentato Mario Adinolfi, tra i
protagonisti (suo malgrado) della distesa di stampe di volti noti, comparse in
piazza a Bologna-e prevede una performance in cui esponenti Lgbt indossando una
mitra vescovile e armati di vernice rossastra calpestano i volti tra gli altri
del sottoscritto e di Papa Francesco. È un onore. E vedasi il mio post
antecedente a questo". Tra gli altri, sono stati calpestati i volti di Matteo
Salvini, Donald Trump e persino Papa Francesco: "Chiunque dissenta, per
qualsiasi ragione, deve sparire nel sangue rappresentato dalla vernice
rossastra", commenta Adinolfi. E si chiede: "Ma se avessimo mai organizzato noi
una performance in cui calpestavamo i volti di Luxuria e Cecchi Paone, più
cancellandoli con vernice rossastra, che ci avrebbero fatto?".
Francesca Bernasconi. Nata nel
1991 a Varese, vivo tra il Varesotto e Rozzano. Mi sono laureata in lettere
moderne e in scienze della comunicazione. Arrivata al Giornale.it nel 2018, mi
occupo soprattutto di cronaca, ma mi interesso di un po' di tutto: da politica e
esteri, a tecnologia e scienza. Scrivo ascoltando Vasco Rossi.
Malika, polemica sulla
raccolta fondi: "Mi sono comprata una bella macchina".
Andrea Vivaldi su La
Repubblica il 30 giugno 2021. Il caso sollevato dopo una intervista firmata
dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. La giovane era stata cacciata di casa
dalla sua famiglia quando aveva rivelato di amare una donna: dalla Toscana ora
vive a Milano. "Ho 22 anni e volevo togliermi uno sfizio, mi sono comprata una
bella macchina, potevo comprarmi un'utilitaria e non l'ho fatto". A innescare il
caso attorno a Malika Chalhy, la ragazza di Castelfiorentino (Firenze) cacciata
di casa dai genitori perché lesbica, una intervista rilasciata a Selvaggia
Lucarelli per TPI (The Post Internazionale). La giovane che adesso vive a Milano
con la compagna ha rivelato, in un modo un po' confuso, di aver utilizzato una
parte dei soldi ricevuti dalle raccolte fondi per acquistare un'auto nuova. "Ho
preso la casa in affitto a Milano, abbiamo dato un anno di affitto più duemila
euro di caparra. Poi ho pagato dentista, avvocato, ho comprato dei vestiti. Non
avevo niente, era rimasto tutto a casa dei miei - riferisce la giovane
nell'intervista - Adesso ho avuto delle spese per la macchina". Una vettura che
le sarebbe costata intorno ai "17mila euro", aggiunge durante la telefonata
Roberta, agente e sua portavoce. Per Malika erano state lanciate due raccolte
fondi tramite la piattaforma gofundme, ricevendo da tutta Italia circa 150 mila
euro. La 22enne avrebbe venduto la vecchia auto per poi sostituirla con la
Mercedes nuova. La notizia ha sollevato subito numerose reazioni polemiche sui
social. Emergono anche un paio di foto da Instagram, in cui Malika è stata
fotografata alla guida dell'auto e taggata da Gaia Zorzi, sorella di Tommaso
Zorzi, il vincitore del Grande Fratello VIP 2020. "Perché quando giorni fa ti è
stato chiesto privatamente da altre persone di chi fosse la Mercedes che
guidavi, hai detto che era dei genitori della tua fidanzata?",
incalza Lucarelli. E Malika ammette: "Sì ho detto una bugia. Mi scuso. Mi è
stato chiesto che ero sotto pressione". La ragazza attraversa, spiega chi le sta
intorno, una fase di fragilità. Nell'intervista viene chiesto alla 22enne a chi
avesse deciso di destinare le donazioni, visto che in passato più volte aveva
annunciato di elargire quei soldi in beneficenza. La ragazza in un primo momento
risponde di non aver ancora deciso. Poi l'agente Roberta prova a spiegare la
motivazione: "La ragione è che insieme alla Boldrini avevamo deciso di fondare
un'associazione per le vittime di discriminazioni. Abbiamo cercato - dice la
portavoce - di coinvolgerla ma lei non sta bene e la cosa si è allungata un po'.
Siamo in una fase in cui non sappiamo ancora bene, mettiamo dei paletti. Malika
però non sta bruciando i soldi". Pubblicata l'intervista, è arriva però la
precisazione della deputata: "Tengo a precisare che mai è stata discussa con me
o con alcun collaboratore o alcuna collaboratrice del mio staff l'ipotesi di
costituire una associazione per le vittime di discriminazione tanto meno di una
raccolta fondi - spiega Laura Boldrini, smentendo quanto dichiarato dall'agente
di Malika -. Si tratta perciò di una vera e propria fake news. Il mio nome
quindi viene tirato in ballo in maniera totalmente impropria".
Da "corriere.it" l'1 luglio
2021. Una storia di Instagram della sorella di Tommaso Zorzi, vincitore del
Grande Fratello VIP 2020, ha colto Malika Chalhy, la ragazza di Castelfiorentino
cacciata da casa dalla propria famiglia perché lesbica, alla guida di una
Mercedes. Questa storia postata sui social ha generato alcune perplessità: si
può vedere Malika alla guida di una Mercedes appena uscita dal concessionario.
Fin qui nulla di male se non fosse che per permettere alla ragazza di farsi una
nuova vita lontano da una famiglia che non la voleva più, erano state lanciate
due raccolte fondi che avevano racimolato complessivamente 140 mila euro. Soldi
che le erano serviti per trovare una casa a Milano, dove ha deciso di
trasferirsi, e, a quanto pare, di comprarsi un’automobile. Una macchina costata,
in offerta, 17 mila euro, come ha confessato la stessa Malika in un’intervista a
Tpi.it. «Ho 22 anni e volevo togliermi uno sfizio, mi sono comprata una bella
macchina, potevo comprarmi un’utilitaria e non l’ho fatto», così Malika ha
risposto a Selvaggia Lucarelli per TPI (The Post Internazionale). «Ho preso la
casa in affitto a Milano, abbiamo dato un anno di affitto più duemila euro di
caparra. Poi ho pagato dentista, avvocato, ho comprato dei vestiti. Non avevo
niente, era rimasto tutto a casa dei miei - racconta ancora la giovane
nell’intervista - Adesso ho avuto delle spese per la macchina». «Perché quando
giorni fa ti è stato chiesto privatamente da altre persone di chi fosse la
Mercedes che guidavi, hai detto che era dei genitori della tua fidanzata?»,
chiede Lucarelli. E Malika: «Sì ho detto una bugia. Mi scuso. Mi è stato chiesto
quando ero sotto pressione». «Ha venduto la sua macchina vecchia, è andata in
una concessionaria, le serviva una macchina per essere una persona libera e si è
comprata una macchina nuova», afferma Roberta, agente e portavoce della ragazza
di Castelfiorentino incalzata dalle domande. A questo punto l’acquisto della
Mercedes ha spinto molte persone a chiedersi se le donazioni siano state
destinate alla risoluzione dei problemi finanziari dovuti a un violento cambio
di vita, o se servano solo per togliersi degli sfizi. Nell’intervista la
Lucarelli chiede alle 22enne a chi avesse deciso di destinare le donazioni,
visto che più volte aveva annunciato di dare quei soldi in beneficenza e lei
risponde di non aver ancora deciso ma che ci sono stati contatti anche con Laura
Boldrini. Che ha poi smentito completamente la notizia.
Malika, non solo la
Mercedes ma anche un cane da 2500 euro. Altro schiaffo ai buonisti.
Redazione giovedì 1
Luglio 2021 su Il Secolo d'Italia. Non solo la Mercedes, ma anche un bulldog
francese. Costo: 2500 euro. Si amplia il caso di Malika Chalhy, la giovane di
Castelfiorentino cacciata da casa dalla propria famiglia perché lesbica. Dopo
che la sua disavventura è venuta alla luce è partita una raccolta fondi per
aiutarla, che ha raggiunto la cifra considerevole di 150mila euro. La scoperta
dell’uso che la giovane ha fatto dei soldi ricevuti in segno di solidarietà in
quanto vittima di omofobia ha suscitato non poche perplessità dando il via sui
social a una sequela di critiche, soprattutto dopo che la ragazza in
un’intervista con Selvaggia Lucarelli su The Post Internazionale ha ammesso con
un certo imbarazzo di avere usato quei soldi per un bene di lusso come la
Mercedes. E ciò dopo avere promesso che li avrebbe dati in beneficenza. E
l’acquisto della Mercedes non è stato l’unico “sfizio” per Malika. E’ sempre
Selvaggia Lucarelli a pubblicare la notizia che la ragazza ha comprato anche un
cane. Lucarelli rintraccia l’allevatore, Simone, che le ha venduto il bulldog
francese: “Malika? Non l’avevo riconosciuta quando è venuta in allevamento, ma
poi ho capito. Ha comprato il cane più caro”. “Le chiedo – scrive Lucarelli –
come mai abbia comprato un cane da 2.500 euro. “Perché mi piaceva la razza, devo
giustificarmi perché spendo i miei soldi come voglio?”. Le rispondo che se le
persone donano perché lei si ricostruisca una vita, perché paghi avvocati o
supporto psicologico o perché faccia beneficenza, forse qualche spiegazione la
deve”. E la conversazione che Selvaggia Lucarelli riporta va avanti così: ““Il
cane è un bene di prima necessità, ok?”, insiste. “Potevi prenderti un
trovatello”. “Avrei potuto ma sono cavoli miei. Il cane è un supporto
psicologico”. “Il bulldog da 2500 euro?”. “Sono amante di questa razza, e ho
preso un bulldog. La Mercedes e il bulldog sono beni necessari”. “Ma quando
rispondi così pensi che non ti arriverà altra merda addosso?”, le dico
sinceramente incredula. “Mi arriverà, chi se ne frega. Ciaooo!”. E mi attacca il
telefono in faccia. Per la cronaca, mi aveva telefonato lei”. Malika, eroina
delle schiere progressiste, aveva partecipato a Milano alla manifestazione in
favore della celere approvazione del ddl Zan. E nelle molte interviste
rilasciate aveva anche annunciato che si sarebbe data da fare per aiutare le
vittime di violenza e bullismo.
Malika Chalhy “assolta” da
GoFundMe, la direttrice: “La Mercedes e il cane? Spese legittime”.
Alessandro Artuso
il 02/07/2021 su Notizie.it. La direttrice di GoFundMe in Europa è intervenuto
in merito alla donazione di Malika Chalhy: le sue parole. Continuano le polmiche
sulla raccolta fondi destinata a Malika Chalhy, la ragazza di Castelfiorentino
tolta di casa dai genitori perché lesbica. Gli organizzatori hanno avviato la
raccolta con lo scopo di permettere alla giovane di rifarsi una vita. Sulla
questione ha parlato ai microfoni di Fanpage.it Elisa Liberatori Finocchiaro in
qualità di direttrice di GoFundMe in Europa. Su GoFundMe sono partite due
diverse campagne per aiutare la giovane della provincia di Firenze. La polemica
è nata nel momento in cui la giovane ha parlato di aver utilizzato parte dei
fondi per acquistare una nuova auto, precisamente una Mercedes, insiema ad
un cane di quasi 3mila euro. “Nel caso della campagna di raccolta fondi che sta
facendo tanto rumore, quella per Malika, i due organizzatori delle raccolte –
commenta la direttrice Liberatori Finocchiaro – che hanno impostato i fondi a
suo beneficio, hanno chiarito che i fondi sarebbero serviti a permettere alla
ragazza di rifarsi una vita. La direttrice ha parlato anche di
una clausola indicata come una sorta di garanzia per chi dona su GoFundMe. “Chi
ha donato lo ha fatto consapevole del fatto che quel denaro sarebbe servito a
Malika a comprare quello di cui ritenesse avere bisogno. Inoltre l’obiettivo era
impostato a 10mila euro ma nonostante questo le persone hanno continuato a
donare.
donatori su GoFundMe sono
protetti dalla cosiddetta garanzia GoFundMe. Se le finalità della campagna non
vengono rispettate tutti i donatori avranno la possibilità di chiedere e
ottenere il rimborso”. Malika Chalky è salita alle cronache nel mese di aprile
del 2021, quando era stata cacciata dalla casa con cui abitava con i genitori
perché lesbica. In suo favore venne istituita una raccolta fondi. Adesso si
scopre che i soldi donati sono stati usati da Malika per comprarsi una Mercedes
e per un costoso cane di circa 3mila euro. GoFundMe ha comunque assicurato che
ogni tipo di illegittimità viene scoperta nel momento in cui le verifiche con il
beneficiario dichiarato non vanno a buon fine. In questo caso, infatti, la
campagna viene annullata e gli eventuali donatori rimborsati.
Massimo Gramellini per il
“Corriere della Sera” il 2 luglio 2021. Più che le istituzioni, gli italiani
preferiscono finanziare le storie. E Malika era la storia perfetta: una ragazza
cacciata di casa dalla mattina alla sera perché aveva detto ai genitori di
essere lesbica. In un batter di ciglia umide, furono raccolti centoquarantamila
euro. Nella testa di chi glieli metteva a disposizione, dovevano servire a
Malika per costruirsi un futuro, ma adesso si scopre che li ha usati per godersi
il presente: ha comprato una Mercedes e un cane di razza. Così l'onda di
commozione le si è rovesciata contro, tramutata in indignazione. I finanziatori
hanno peccato d'ingenuità. Che cosa immaginavano che facesse, una ragazza di
vent'anni appena arrivata a Milano, di tutti quei soldi che le piovevano addosso
di colpo e senza fatica? Pensavano che li avrebbe accantonati per pagarsi gli
studi e sottoscrivere fondi-pensione, e che nel frattempo si sarebbe
accontentata di viaggiare in utilitaria e di portare al parco un trovatello del
canile, come forse avrebbe fatto un adulto giudizioso? Gli eroi sono tali finché
restano confinati nella dimensione aerea del racconto, ma appena toccano terra,
dietro il mito spunta inesorabilmente l'essere umano con i suoi limiti, i suoi
vezzi e i suoi vizi. Se era esagerato esaltare l'eroina, lo è adesso
colpevolizzare la ragazza per non essere stata all'altezza dell'immagine
artefatta che (con il suo aiuto) molti le avevano cucito addosso per pagarsi
l'iscrizione al partito dei buoni.
Candida Morvillo per il
“Corriere della Sera” il 2 luglio 2021. Questo è ancora il Paese in cui due
genitori, quando scoprono che la figlia di vent'anni è lesbica, la cacciano di
casa. Questo è anche il Paese in cui, per quella giovane rimasta senza un soldo
e senza nemmeno un cambio di biancheria, scatta una gara di solidarietà che
raccoglie ben 140 mila euro. Fin qui, per ciascuna coscienza è facile sentire da
che parte stare. Le cose si complicano quando la ragazza, Malika, di
Castelfiorentino, usa parte dei soldi per comprarsi una Mercedes, sebbene Classe
A, la più economica, sebbene d'occasione, a 17mila euro. Adesso, sui social, c'è
chi le augura di andarci a sbattere contro un albero, con quell'auto. Lei dice
al Corriere: «La gogna me la prendo tutta, ma chi mi ci mette non è migliore di
me. A 22 anni nessuno ha fatto uno sbaglio?». Chiedi qual è lo sbaglio e lei:
«Ho fatto una scelta affrettata. Magari dovevo trovarmi prima un lavoro». L'ha
capito tardivamente e dopo un'uscita infelice: a Selvaggia Lucarelli che la
intervistava su Tpi, aveva detto «mi sono tolta uno sfizio». Ora, Malika
ritratta: «Sono stata travisata». Travisata come? Ha detto «sfizio» o no? Lei:
«Io penso che le persone mi hanno donato dei soldi per la mia serenità».
Insomma, la linea è quella dei pochi supporter che, sui social, dicono che la
donazione non era fatta con la condizionale. Ma l'Italia che per Malika aveva
messo mano al portafogli, si è sentita tradita perché lei aveva promesso di
usare le donazioni per rifarsi una vita e fare beneficenza. La Mercedes non era
contemplata. Peggio di tutto è stata la bugia: in principio, Malika aveva
giurato che l'auto era dei genitori della fidanzata. Poi, si è scusata per la
bugia: «Ero sotto pressione». La pressione era, in effetti, comprensibile. La
storia di Malika, operaia in fabbrica ma in cassa integrazione, inizia a
gennaio, quando scrive ai suoi confessando di amare una ragazza. La madre le
invia trenta messaggi vocali di insulti. «Mi fai schifo, schifo, schifo!», le
urla. E anche «spero ti venga un tumore, se ti vedo, t'ammazzo». Madre e padre
le fanno trovare la serratura di casa cambiata. Lei, per cercare di recuperare
le sue cose, va dai carabinieri. È così che la Procura di Firenze apre
un'inchiesta per violenza privata. Arrivano, quindi, su Gofundme, le donazioni.
Malika si trasferisce a Milano, va in tv da Bianca Berlinguer e da Maurizio
Costanzo. Si fa amici vip. Il video alla guida della Mercedes compare
sull'Instagram di Gaia, sorella di tale Tommaso Zorzi, uno diventato famoso
facendo sciabolate di champagne in un docureality sui figli di papà intitolato
#Riccanza. Questo è il Paese in cui per accedere al mondo dei vip o sei molto
ricco e molto esibizionista o basta una sciagura qualsiasi, e in cui per
rimanerci non puoi guidare una 500 usata. Non puoi avere per cane neanche un
trovatello: l'ultima è che Malika ha comprato un French Bulldog da 2.500 euro.
«Era un bene di prima necessità», ha detto sempre a Tpi. «Sono stata travisata»,
giura ora. Di nuovo. «Ho detto che il cane era un supporto psicologico. E poi:
se i soldi mi sono stati donati, perché non vi va bene niente di quello che
faccio?». Insomma, nella vita dell'operaia, ora, tutto è nuovo e anche le
«pressioni» non sono più quelle di una volta. Non stupisce, si fa per dire,
scoprire che, nel frattempo, si è procurata un agente e persino una portavoce.
Poi, la portavoce, per mettere una pezza alla storia della Mercedes, combina un
pasticcio peggiore: annuncia contatti con l'onorevole Laura Boldrini per la
lotta contro le discriminazioni; ma Boldrini smentisce. Intanto, al Corriere,
l'agente rivela di aver abbandonato l'incarico già prima del patatrac. Non vuole
essere citato, ma è amareggiato: racconta d'aver aiutato Malika pro bono, che
lei gli aveva fatto credere di volersi impegnare nel sociale. La Mercedes
l'aveva insospettito, ma lei gli aveva giurato che non era sua. Sembrava una
brutta, bella, storia di violenza, discriminazione e riscatto. Lei ancora la
rivendica: «Sono una ragazza che ha perso i punti di riferimento e che qualcuno
voleva mandare al Grande Fratello, ma ha detto no. Io voglio lottare per delle
buone cause e, in Panda o in Mercedes, lo farò». Il tempo dirà se invece era il
solito abbaglio da luccichio dei social, successo facile, riccanza.
Malika Chalhy, "cosa fece nel giugno
2019": sbugiardata pure dal fratello. Per lei ora si mette davvero male.
Libero Quotidiano il 03 luglio 2021. Continua a tenere banco
il caso di Malika Chalhy, che tra Mercedes, cane di lusso e telefonate con
Selvaggia Lucarelli si è praticamente sbugiardata da sola. Cacciata di casa
perché lesbica, la ragazza avrebbe marciato su questo aspetto ottenendo 140mila
euro tramite una raccolta fondi organizzata per permetterle di “rifarsi una
vita” e di pagare le spese di avvocati e psicologo. Invece Malika ha finora
speso i soldi per soddisfare il proprio benessere: ha sbagliato dal punto di
vista etico e morale, ma la colpa è di chi l’ha assecondata. Mentre la bufera
social imperversa su di lei, il fratello Samir ha parlato a La Nazione e ha
spiegato che non parla con la sorella da mesi. Però ci ha tenuto a condannare
gli insulti e le offese che stanno piovendo su sua sorella: “Sono assolutamente
sbagliati. Le persone dovrebbero stare zitte e invece giudicano senza sapere
come stanno le cose. Questa vicenda doveva rimanere in famiglia fin dall’inizio.
Non è stato giusto giudicare prima e non lo è nemmeno adesso”. Però parlando
della Mercedes e del french bulldog, Samir ha ammesso che “tutto questo non mi
stupisce, ho sempre pensato che Malika avesse usato gli audio di mia mamma per
avere notorietà. Quegli audio con insulti erano e restano sbagliati - ha
precisato - ma lei avrebbe potuto evitare di andare a vivere a Milano, la città
più cara d’Italia per gli affitti. Ha sempre sognato la bella vita e i soldi,
non a caso nel giugno 2019 fece dei provini per entrare a Uomini e Donne”.
Malika Chalhy, "truffa aggravata". Chi la
porta in tribunale: i soldi della beneficenza per Mercedes e cagnolino, la
rovinano. Libero Quotidiano il 03 luglio 2021. Si
mette male per Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa perché lesbica e
aiutata attraverso due raccolte fondi, i cui soldi sono stati utilizzati per
acquistare un'auto di lusso e un cane. A denunciare l'accaduto era stata per
prima Selvaggia Lucarelli. Ora però si muove anche il Codacons, che annuncia di
aver fatto un esposto alla magistratura "per la possibile fattispecie di truffa
aggravata". Secondo l'associazione "la vicenda di Malika dimostra ancora una
volta come nel settore regni l'anarchia: chiunque può chiedere soldi ai
cittadini attraverso piattaforme come Gofundme, ma poi non c'è alcun controllo
sulla reale destinazione dei soldi raccolti, e le stesse società che ospitano le
campagne di solidarietà declinano qualsiasi responsabilità per eventuali usi non
conformi dei fondi donati dai cittadini. Pertanto - si legge ancora - sul caso
di Malika Chalhy abbiamo deciso di presentare un esposto alle Procure della
Repubblica di Milano e Firenze, affinché avviino una indagine sulla vicenda alla
luce della possibile fattispecie di truffa aggravata, accertando i fatti e le
relative responsabilità anche nei confronti dei gestori delle piattaforme che
ospitano le raccolte fondi, per omissione di controllo e concorso in eventuali
reati che saranno ravvisati". A nulla sembrano essere serviti i tentativi di
difesa della ragazza. Proprio nella giornata del 2 luglio, dopo la bufera
sollevata, la giovane ha reso pubblici su Instagram i bonifici fatti a varie
associazioni. Non solo, perché ha spiegato che l'auto fa parte "della
ricostruzione della mia vita", mentre per lei il cane (un bulldog
francese pagato 2.500 euro) altro non era che "un bene di prima utilità".
Rimangono però ancora molti dubbi, uno dei quali sulla manager che ha affiancato
la ragazza dopo il servizio de Le Iene e le varie apparizioni, da Maurizio
Costanzo a Bianca Berlinguer.
DA adnkronos.com il 2 luglio
2021. "La Malika che cercate non sono io". Malika Ayane su Twitter deve mostrare
la propria carta d'identità virtuale alle persone che hanno preso d'assalto i
suoi profili e la sua mail. La cantante è stata scambiata per Malika Chalhy: la
giovane toscana è al centro di grosse polemiche per aver lanciato una raccolta
fondi dopo aver detto di essere stata cacciata di casa in quanto omosessuale, ed
aver invece speso i soldi ricevuti per acquistare una Mercedes e altri beni non
di prima necessità. "Cari #fulminidiguerra che mi intasate la mail e i social
con insulti o espressioni di solidarietà, ho una notizia per voi: la Malika che
cercate non sono io. Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso
nome, eh? Che poi, se volete mandare messaggi d’amore siete i benvenuti -se
d’odio un po’ meno ma avrete le vostre ragioni- purché siano per me stessa
medesima. #sipuofare", scrive Malika Ayane.
Lo schianto
dei buonisti beffati dall'idolo arcobaleno.
Andrea Indini il 2 Luglio 2021
su Il Giornale. La sinistra cavalca la cronaca per imporci le sue crociate. Ma
le polemiche sulla giovane cacciata di casa perché lesbica mettono ancora una
volta in ombra la narrazione buonista. Lo scorso aprile, in pieno fermento
pro ddl Zan, i buonisti crearono l'ennesimo simulacro per piegare l'opinione
pubblica alla causa Lgbtqi+: Malika Chalhy. La 22enne di Castelfiorentino,
cacciata dalla famiglia (musulmana più o meno praticante) dopo il coming out,
divenne in breve tempo un altro simbolo della lotta all'omofobia. Le accuse
mosse contro i genitori (rilanciate in tv dalle Iene) monopolizzarono il
dibattito per qualche giorno nonostante il fratello Samir si sgolasse a dire che
l'intero teatrino fosse stato messo in piedi "solo per soldi". Allora nessuno
gli dava retta. In molti si fiondarono a sottoscrivere la donazione
su Gofundme per "aiutarla a ricostruirsi una vita". Ora, però, sono tutti
infuriati perché Malika ha usato parte dei 140mila euro raccolti per affittare
un appartamento a Milano (e fin qui nessun problema) e togliersi
qualche "sfizio" (come si è giustificata lei), ovvero una Mercedes nuova di
zecca (una fiammante classe A), un bulldog da 2.500 euro e un po' di vestiti. E
qui, di problemi, ce n'è più di uno. Oggi i buonisti sono tutti inorriditi. Si
sentono presi in giro: hanno abboccato alla campagna di liberazione e sono
finiti per schiantarsi contro i capricci di una 22enne a cui "piacciono i
motori". A farli sbarellare è stato, tra le tante cose, anche il teatrino sui
soldi da dare in beneficenza scoperchiato nei giorni scorsi da Selvaggia
Lucarelli su Tpi. Prima ha detto che le sarebbe piaciuto
fondare "un’associazione con la Boldrini, solo che la cosa va per le lunghe, lei
non è stata bene". Peccato che non appena l'ex presidente della Camera è venuta
a saperlo si è fiondata a smentire tutto: "Si tratta di una vera e propria fake
news". Messa con le spalle al muro, Malika ha prima tirato in ballo la
Fondazione Nadia Toffa, poi denunciato imprecisate "persone" che volevano
costringerla "a donare al gruppo ospedaliero San Donato". Il commento di Matteo
Salvini è stato lapidario: "Vergogna ne abbiamo?". La risposta alla domanda del
leader del leghista oggi appare scontata. E probabilmente se la sta ponendo
anche la sinistra che nelle scorse settimane ha innalzato Malika a nuovo idolo
della battaglia arcobaleno. A metà maggio, in occasione della Giornata
internazionale contro le discriminazioni di genere, c'era anche lei in piazza a
Firenze accanto alle sigle che pretendevano (e pretendono tuttora) che "il ddl
Zan venga immediatamente calendarizzato e approvato in Senato". "Amare una
persona dello stesso sesso non è una malattia", diceva. Qualche giorno
prima aveva presenziato pure alla manifestazione organizzata dai Sentinelli a
Milano dove, tra i tanti, era accorso pure il piddino Alessandro Zan. "La
famiglia tradizionale non ha colori, non ha orientamento sessuale - ha
detto parlando dal palco - quindi approvate questo disegno di legge perché io
come tante altre persone sono stata vittima di violenza verbale". Ad ogni uscita
pubblica seguiva immancabilmente una copertura mediatica che fa invidia alle
migliori influencer. Tanto che, come svelato alla Lucarelli, la 22enne è corsa a
farsi affiancare da una ragazza che le fa da portavoce e da un agente che tratta
i rimborsi quando va in tv. Una vera e propria star, insomma. Oggi la stella di
Malika è in fase di spegnimento. Non è il primo idolo della sinistra a fare
questa fine. Nelle settimane scorse (prima ancora che Enrico Letta imponesse
agli Azzurri di inginocchiarsi a inizio partita) abbiamo assistito allo stesso
schianto della fondatrice di Black Lives Matter, Patrisse Cullors, quando si è
venuto a sapere che si era comprata una villa da 1,4 milioni di dollari in un
quartiere di Los Angeles composto per l'88% da bianchi. I buonisti dovrebbero
smetterla di cercare simulacri da sbattere sui giornali per far valere le
proprie ragioni. Tranvate in questo senso le hanno prese sia quando hanno
tentato di spacciare Seid Visin come vittima del razzismo italiano per
promuovere lo ius soli sia quando hanno cavalcato il suicidio di Orlando
Merenda per accelerare il via libera al ddl Zan. Già un paio di "incidenti" del
genere avrebbero dovuto farli riflettere. Ma a quanto pare i buonisti non
imparano mai la lezione.
Andrea Indini. Sono nato a
Milano il 23 maggio 1980. E milanese sono per stile, carattere e abitudini.
Giornalista professionista con una (sincera) vocazione: raccontare i fatti come
attento osservatore della realtà. Provo a farlo con quanta più obiettività
possibile. Dal 2008 al sito web del Giornale, ne sono il responsabile dal 2014.
Con ilGiornale.it ho pubblicato Il partito senza leader (2011), ebook sulla
crisi di leadership nel Pd, e i saggi Isis segreto (2015) e Sangue occidentale
(2016), entrambi scritti con Matteo Carnieletto. Nel 2020, poi, è stata la volta
de Il libro nero del coronavirus (Historica Edizioni), un'inchiesta fatta con
Giuseppe De Lorenzo sui segreti della pandemia che ha sconvo…
Malika Chalhy dimostra che
non basta essere vittima per diventare portabandiera di una battaglia.
Flavia Piccinni
l'01/07/2021 su Notizie.it. L'acquisto di una Mercedes e di un cane trasformano
la vittima di omofobia in una delusione per chi l'ha trasformata nella
portabandiera di una battaglia. Comprare una Mercedes (da 17mila euro). Comprare
un cane (da quasi 2500 euro). Prendere una casa in affitto a Milano. Spendere i
soldi ricevuti attraverso una raccolta fondi – dove si spiegava che sarebbero
stati donati anche in beneficienza – non solo per ricostruirsi, ma per
compiacersi. Permettersi dei lussi attraverso delle donazioni, esponendosi alle
critiche, ma anche svilendo una battaglia (quella contro l’omofobia), deludendo
chi ha partecipato alla raccolta fondi (esercitata attraverso due piattaforme
online, e arrivata alla cifra affatto trascurabile di 150mila euro) e in qualche
modo sprofondare da vittima in carnefice (di se stessi). Potrebbe essere questa
la sintesi della parabola di Malika Chalhy, 22 anni, fiorentina. Prima vittima
degli atteggiamenti omofobi dei genitori, dunque cacciata di casa dopo aver
dichiarato il suo amore per un’altra ragazza, infine eletta a transitoria eroina
contro l’omofobia. La recente primavera, la giovane si è infatti imposta
all’attenzione dei media per la sua struggente storia, divenendo rapidamente
simbolo dello sgomento italiano di fronte all’ennesimo esempio di violenza
omofoba. Intervistata in molte trasmissioni, protagonista di numerosi show
televisivi, ha raccontato il suo difficile vissuto, ha prestato la voce per
cause simili e altrettanto dolorose, si è accompagnata ad agenti dello show
business che evidentemente hanno provato a metterla a sistema come si fa con una
starlette. Poteva essere una storia a lieto fine – la giovane sfortunata che
riesce a ricostruirsi e a rimettersi in piedi – invece è diventata una storia
sulla pochezza dei nostri tempi. A distanza di tre mesi dal primo interesse
mediatico, la storia di Malika Chalhy ha infatti gloriosamente dimostrato due
assunti elementari. Il primo è che entrare nel ciclone mediatico è un terremoto
che in pochi sanno superare indenni. Il secondo, forse più elementare, è che
vivere un’esperienza straordinaria – essere vittima di una storia infelice, o di
quella storia essere carnefice – non ti trasforma necessariamente in un
portabandiera. Per essere dei portabandiera, non è sufficiente aver sofferto.
Per essere degli attivisti serve anche – soprattutto? – studiare, prepararsi,
tenere un rigore reale. Anche quando la telecamera si spegne. Anche quando il
tuo manager ti fa sembrare che non sia così. E ti salta in mente che forse, dopo
aver tanto sofferto, puoi anche toglierti uno sfizio. Una macchina. Una casa
nuova. Un cane che costa quasi il doppio del tuo vecchio stipendio. Dovremmo
saperlo, però ci sorprendiamo ogni volta. Eppure quotidianamente ormai
assistiamo alla nascita di mostri. Personaggi che vengono sbalzati dalle loro
vite – più o meno semplici – alla ribalta nazionale, increduli per quello che
stia accadendo loro (e, naturalmente, del tutto inadeguati a comprendere le
conseguenze delle loro azioni). Negli anni la cronaca nera, esattamente come il
gossip, hanno partorito diversi esempi di questo straordinario fenomeno di
“ista-celebrity”, ovvero persone qualsiasi travolte da una popolarità repentina.
Abbiamo assistito – forse all’inizio cinicamente divertiti, dunque spaesati,
infine piuttosto disturbati – all’apoteosi di personaggi inadeguati che,
assediati dai giornalisti, venivano invitati a parlare in diretta nazionale con
la stessa frequenza con cui prima siedevano per chiacchierare al bar, erano
scelti come testimoni di cause, dotati di manager televisivi in grado di
gestirne l’immagine. Il fine era unico: trasformarli in piccoli eroi del
quotidiano. La verità è che viviamo tempi di eroi ed eroine necessarie e
fulminee, chiamate alla ribalta per ruoli molto più ingombranti e impegnativi di
quelli che potrebbero sopportare. Nella lunga lista di eroine all’arrembaggio –
dopo l’apoteosi di Asia Argento, da paladina del #metoo a presunta violentatrice
– la storia di Malika Chalhy è solo l’ennesimo esempio, purtroppo, di una
cultura vampirizzatrice e molesta. L’intervista di Selvaggia Lucarelli su TPI è
la fotografia di un malessere più grande di quello che possiamo immaginare.
Malika Chalhy traballa su molte verità – spiega di aver mentito sui proprietari
dell’auto, definisce bene di prima necessità un cane di razza -, dunque corre ai
ripari facendo dei bonifici per delle associazioni benefiche e postandone su
Instagram le foto (dove le cifre sono nascoste), rilascia un’intervista a
Fanpage in cui spiega: “in tutto io ho speso 55mila euro dei 140mila della
raccolta fondi, e 14mila li ho dati in beneficenza (Fanpage ha visionato alcune
ricevute di bonifico datate oggi, ndr)”. Quarantunomila euro in una manciata di
mesi non è male, ed è naturale venire sommersi da critiche perché quei soldi
avevano uno scopo ben lontano da togliersi degli “sfizi”. In ogni caso, la
giovane cade in diverse contraddizioni, forse è consigliata male, alla fine
decide – come sempre più accade in questo tempo in cui la comunicazione avviene
su più livelli – di confidarsi su Instagram, dove la seguono quasi 100mila
persone. Utilizza un linguaggio sempre più frequente sui social network, si
rivolge al “suo pubblico” definendolo la sua “famiglia” che in quanto
tale “merita tutta la trasparenza del mondo”, dice “vi voglio bene” e sottolinea
come “da oggi voglio mostrarvi la persona che sono senza filtri mediatici, e
quindi vi invito a chiedermi qualsiasi cosa”. Speriamo solo che questa
storiaccia non incida sulla buona fede dei donatori, e resti per quello che è:
l’immagine dolente di una ragazza giustamente immatura – considerata l’età -, e
l’eccessiva necessità dei nostri tempi di cercare portabandiera in chicchessia.
Almeno per quindici minuti di popolarità.
Filippo Facci per “Libero
quotidiano” il 30 giugno 2021. Da ogni fatto di cronaca, ogni volta, dobbiamo
aspettare che si diradino le nebbie preventive dell'omofobia, del razzismo e
della discriminazione: salvo scoprire che, una volta dissolte queste nebbie, la
cronaca e il fatto nudo perdono interesse da parte del gregge massmediatico: non
sono più rilevanti, manca il link con lo spirito del tempo, insomma chi se ne
frega. Se non c' è discriminazione, in altre parole, la realtà viene
discriminata. L' ultimo caso è quello del suicidio di un ragazzino omosessuale,
che subito, di riflesso, è diventato un suicidio in quanto omosessuale, perché
discriminato. Da chi? Boh, «qualcuno», «forse». Cioè: dei singoli suicidi non
bisognerebbe neppure scrivere, non si contano le ricerche che dimostrano come le
notizie dei suicidi, più di altre, possano essere fonte di emulazione; troppe
persone hanno tratto linfa dal gesto altrui - di una celebrità come di uno
sconosciuto - per compiere il proprio. È la ragione per cui sui giornali si
tende a non parlarne (i suicidi sono migliaia ogni anno, e nelle grandi città la
media è quasi due al giorno). Ma ecco che diventa eccezione il caso del povero
Orlando Merenda, un diciottenne che domenica 20 giugno, a Torino, si è ammazzato
gettandosi sotto un treno. Che cosa sappiamo, di certo? Che frequentava una
scuola professionale (Engim) al pari di un bar in corso Vittorio Emanuele II,
Cristalife. Che era un ragazzo tranquillo ma a tratti ansioso, come potremmo
dire quasi di chiunque. Che, a domanda su come stesse, ha risposto «oggi sono un
po' così». In questi casi, l' elenco degli aggettivi spesi dai testimoni si
somigliano tutti: Orlando «riservato», «persona seria», «puntale e preciso», «un
ragazzo splendido», «perfettamente a suo agio nell' ambiente scolastico», «i
suoi compagni sono profondamente turbati», poi il corredo della solidarietà, e
all' ingresso della scuola palloncini bianchi a forma di cuore legati stretti
con un fiocco nero ai selfie scattati durante l' anno scolastico», e «fiori e
striscioni che invadono il parapetto del cavalca -ferrovia dal quale si è
gettato». Perché ne parliamo? Perché ne scriviamo? Perché Orlando Merenda ha
fatto eccezione alla regola? Non c' è risposta: se non nel linguaggio
giornalistico più ambiguo, il rapporto con il padre «conflittuale, con un
genitore severo, poco incline a certi argomenti», l'omosessualità come
«malessere interiore che non è più riuscito a dominare», al di là di quelle
«menti chiuse che hanno la bocca aperta», come scriveva su Instagram.
Apprendiamo che «Orlando non si sentiva completamente accettato», che «qualcuno
gli rinfacciava la sua omosessualità», «altri potrebbero essersi approfittati
delle sue fragilità quando ancora era minorenne», «aveva paura di qualcuno».
Qualcuno. Potrebbero. «La polizia», si legge sul Corriere, «sta scandagliando la
vita del ragazzo». Poveretto. «In un primo momento gli accertamenti si sono
concentrati su omofobia e bullismo, ora si lavora su altre piste». Quindi ne
esistono altre. Si parlicchia di un ricatto sessuale, addirittura di un
fascicolo aperto per «istigazione al suicidio»: sta di fatto che le ragioni per
cui il suicidio è sfuggito al citato e giustificato riserbo sono già cadute,
forse non sono mai esistite, forse sono state solo il riflesso condizionato di
una stampa idiota: come se la mente di un suicida non resti l'insondabile e
l'imprendibile, come se fosse solo materiale all' ingrosso per alimentare le
fobie della propria epoca. Povero ragazzo, povero amico e compagno, circondato
da quella cricca impietosa chiamata genere umano. All'inizio del mese c'era
stato il suicidio di un ragazzino nero, Seid Visin, a Nocera inferiore: e, pure,
era subito diventato un suicidio in quanto nero, perché discriminato. L'
orgoglioso distinguo di suo padre («Il razzismo non c' entra: basta speculare
sul dolore di nostro figlio») spesso era stato impaginato a margine degli stessi
articoli in cui il razzismo veniva appunto fatto entrare a forza, dove appunto
si speculava sulla morte di un ragazzo. Perché non puoi fermare la macchina.
Tutto si sfrutta. Tutto si tiene.
Ddl Zan, “quelli di
Bibbiano” rispuntano a Sassuolo: ora di gender in un liceo. L’ira di FdI.
Redazione giovedì 1
Luglio 2021 su Il Secolo d'Italia. Dopo quelli di Bibbiano, questi di Sassuolo.
Gira e rigira, la rossa Emilia si conferma laboratorio di ingegneria sociale.
Ieri a Bibbiano attraverso una rete di assistenti sociali e
psichiatri specializzati nel sottrarre bambini alle famiglie di origine per
affidarle a coppie amiche, meglio ancora se omosessuali. Oggi a Sassuolo,
schiudendo le porte del liceo Formiggini all’ideologia gender infiocchettata
sotto forma del controverso ddl Zan. Peccato per loro che se ne sia
accorto Marco Lisei, capogruppo di FdI in Consiglio regionale. Reca la sua
firma, oltre a quella di Michele Barcaiuolo, l’interrogazione rivolta
alla giunta Bonaccini, sebbene la competenza primaria sia in realtà
del ministero. I firmatari, infatti, si sono limitati a chiedere al governo
regionale «se non si ritenga sbagliato l’indottrinamento a scuola su un tema
d’attualità come il ddl Zan». Tanto più, hanno sottolineato, che la
“spiegazione” sull’argomento non ha registrato la presenza «di una controparte».
In pratica, il solito confronto per solisti così caro alla sinistra soprattutto
quando ha torto marcio nel merito del provvedimento. Eppure, e Lisei lo ha
ricordato, esiste una norma della legge sulla cosiddetta “Buona scuola” che
fissa il perimetro entro il quale è possibile per un istituto scolastico
affrontare temi quali la «pari opportunità, la prevenzione della violenza di
genere e le discriminazioni». C’è anche una nota del Miur del 2015 che vieta
espressamente la promozione di «pensieri o azioni ispirati a ideologie di
qualsivoglia natura». Altra cosa, infatti, è illustrare avendo cura di tener
conto di tutte le voci. A Sassuolo è invece accaduto che un singolo docente
organizzasse l’ora di indottrinamento su un argomento – il gender –
espressamente escluso dal novero delle materie su cui confrontarsi. E, per
giunta, senza neppure avvertire le famiglie. «In Gran Bretagna, a settembre – ha
ricordato Lisei -, il dipartimento per l’Educazione ha bandito dalle scuole
statali ogni tipo di insegnamento sull’identità di genere (vero punto fermo del
ddl Zan, ndr) poiché pericolosa per i minori». In Italia invece le spalanchiamo
le porte prima ancora che diventi obbligo di legge.
Francesco Grignetti per "la
Stampa" il 6 luglio 2021. Due soltanto sono i punti fermi. Primo, oggi il
presidente della commissione Giustizia, il leghista Andrea Ostellari, presenterà
una sua riscrittura del ddl Zan sulla base degli emendamenti di Italia viva,
Forza Italia e Lega; proporrà di ripartire da lì, per verificare se questa nuova
versione (sostanzialmente ha cassato il riferimento all' identità di genere,
tanto contestata; cancellata ogni ipotesi di reato d' opinione; e smussato l'
obbligo per le scuole, statali o parificate, di organizzare iniziative contro la
cultura dell' odio omofobo e transfobo) può avere una più larga maggioranza. In
teoria potrebbe votarlo pure Giorgia Meloni. Da parte del Pd, M5S e Leu però gli
verrà risposto che il testo non si tocca e che secondo loro bisogna andare
avanti con il ddl Zan come approvato già alla Camera. Secondo punto, concatenato
al primo: subito dopo la questione Ostellari, la maggioranza sarà chiamata a
votare in Aula il calendario delle prossime sedute, e i partiti di cui sopra
insisteranno che il 13 luglio si deve iniziare l'esame del ddl Zan; questo
calendario sarà votato anche da Iv, non dalla Lega, e di conseguenza martedì
prossimo al Senato si parte. Tutto il resto è puro caos. Matteo Renzi e i
renziani insistono che nel muro contro muro sarà impossibile approvare alcunché.
Per questo motivo si sono fatti protagonisti di una mediazione. Ma i toni si
sono infiammati. E a sinistra si grida al tradimento. Peggio, alla collusione
con Salvini. «Sulla vicenda Zan - replica Renzi - sta accadendo la stessa cosa
di sei mesi fa sul Conte-Draghi: i social ci massacrano senza sapere di che cosa
stanno parlando. Chi va ControCorrente (citando il suo libro in uscita, ndr) fa
politica e ottiene risultati. A distanza di mesi, ci stanno dando ragione su
Draghi. Ma anche su molto altro». E comunque il clima si è fatto pesante. «Sto
ricevendo - dice ancora Renzi - insulti, minacce, auguri di morte. Questo in
nome della tolleranza. La tolleranza degli intolleranti, per recuperare un
concetto di Pasolini. Io ho firmato la legge sulle Unioni Civili, mettendo la
fiducia dopo che gli altri avevano solo fatto convegni e progetti a vuoto. Non
prendo lezioni da chi usa i diritti come bandierine, senza ottenere risultati:
io i diritti li allargo, davvero. Ma servono le riforme, non i tweet». Gli
«altri» a cui accenna, sono forse Enrico Letta e i dirigenti attuali del Pd? Il
rapporto tra i due è tornato ai minimi. Dice Letta, ospite di Concita De
Gregorio e David Parenzo su La 7: «Si dice che queste battaglie identitarie non
portano consenso? Ma se facessi le cose perché voglio lo 0,2% nei sondaggi del
pomeriggio, farei uno sbaglio. Gli italiani daranno un giudizio alla fine,
quando si voterà, sulla serietà. Per esempio, sul fare dell'Italia un Paese
completamente europeo quanto al rispetto e tolleranza, che punisce severamente i
reati d' odio. Ripeto: il giudizio si vedrà alla fine, e la coerenza sarà molto
importante». Matteo Salvini a questo punto fiuta ormai il successo: «Spero che
non si ostinino a andare fino in fondo. Se la legge viene affossata, il signor
Letta se ne prende la responsabilità». E insiste: «Quello che non va nel ddl Zan
- dice il leghista, intervistato a Radio Radio - è la parte ideologica. Che è
contestata non solo da Salvini, ma dal Santo Padre, da associazioni di
femministe, di gay e lesbiche, da costituzionalisti. Un' ideologia che prevede
reati di opinione e carcere per chi ha una certa idea di famiglia, che non
pretendo sia quella giusta, ma che deve avere la libertà di confrontarsi con
altri». Ripete invece Letta: «Salvini non vuole questa legge; l' ha sempre
detto. Il suo alleato principale in Europa è Orban, e lo stanno sanzionando per
i passi indietro su questo tema. Ma la Lega è stata coerente. Non capisco la
posizione di Italia viva: alla Camera hanno fatto un lavoro importantissimo, e
poi improvvisamente hanno cambiato posizione. Nel momento in cui Renzi si sfila
e si copre dietro il problema del voto segreto, io dico: il Pd non chiederà mai
il voto segreto».
Ddl Zan, Pietro Senaldi
contro Enrico Letta: "Robe che neanche Orban, perché è lui il vero nemico degli
omosessuali".
Libero Quotidiano il 05 luglio 2021. Secondo Pietro Senaldi,
condirettore di Libero, il vero nemico degli omosessuali è Enrico Letta. Nel suo
video editoriale di oggi spiega che "il Partito democratico ha questo progetto
di legge contro l'omotransfobia, ma la maggior parte degli italiani e del
parlamento ritiene che, più che difendere gli omosessuali, la legge Zan limiti
la libertà d'espressione. E così da destra e da sinistra sono piovuti
emendamenti o progetti di legge alternativi per modificarli. Sono tutti
disponibili a fare una legge che dia una stretta a chi insulta o usa violenza
contro i gay, ma la maggioranza del parlamento non vuole la legge Zan". "La
posizione di Enrico Letta e del Pd", prosegue Senaldi, "è: o legge Zan o non se
ne fa nulla". "Siamo ancora in democrazia e il parlamento si preoccupa di fare
leggi che tutelino le minoranze", tuona il direttore, "ma le leggi della
democrazia impongono che ci sia una maggioranza parlamentare per fare queste
leggi. Letta se ne frega, pensa che con il suo 18% può disporre e fare leggi
etiche, cosa che non fa neanche Orban. Alla fine", conclude Senaldi, "dopo tanto
strepitare in favore degli omosessuali, il vero ostacolo a una legge che limiti
le violenze contro di loro e punisca severamente chi le fa è il Pd di Enrico
Letta".
La controversa
interpretazione del concetto di identità di genere nel ddl Zan.
Giuliano Cazzola il 6
luglio 2021 su L'Inkiesta. Il testo contro l’omotransfobia presentato dal
deputato del Partito democratico rende a norma di legge ciò che viene percepito,
ovvero l’orientamento sessuale, mentre ciò che è platealmente reale, il sesso
della persona, si trasformerebbe in un’opinione soggetta a prevaricazioni e
definizioni fuorvianti. Non vedo sostanziali differenze tra il gender e il
terrapiattismo. Anzi; poiché ambedue i casi si basano sulla percezione mi sembra
più comprensibile ritenere che Terra sia piatta (l’umanità lo ha creduto per
secoli), piuttosto che non riconoscere le differenze (visibili e intuitive) che
da miliardi di anni distinguono in tutti gli esseri viventi il maschio dalla
femmina. E sono le differenze che consentono di procreare. Da questo vincolo non
si sfugge, nonostante tutti i surrogati e le diavolerie che una scienza, un po’
disumana e mercificata, ha incentrato per sottrarre il concepimento alla Natura.
È lontano il tempo in cui, agli studiosi di diritto costituzionale comparato,
veniva spiegato che il Parlamento del Regno Unito poteva legiferare in tutti i
campi, ma non gli era consentito di trasformare l’uomo in donna e viceversa.
Tuttavia, come dicevano i versi di una vecchia canzone: «Cambian con la moda gli
usi e le tradizion». In quell’Europa in cui si aggirava, nel XIX secolo, il
fantasma del comunismo, oggi siamo chiamati a fare i conti con una nuova visione
della biologia e dell’evoluzione, assolutamente priva di basi scientifiche.
Almeno Darwin aveva concepito le sue teorie, non conformi al libro della Genesi,
osservando i fenomeni naturali delle Isole Galapagos; mentre William King aveva
individuato il lungo processo evolutivo che in milioni di anni risaliva
dall’Uomo di Neanderthal all’Homo sapiens (non abbiamo approfondito la questione
del cosiddetto anello mancante), basando le sue teorie su dati reali come la
forma degli oggetti e i disegni sulle pareti delle caverne. Ma su che cosa si
basa, invece, il concetto di gender? I suoi sostenitori – va loro riconosciuto –
rifiutano i concetti di dottrina e di teoria; inoltre chi volesse documentarsi
deve sapere che nel corso degli anni, si sono sviluppati diversi approcci,
elaborazioni e studi sul genere, ognuno dei quali ha approfondito un aspetto
dell’intera questione: è quindi plausibile che non esista in realtà un pensiero
organico sul gender (come dicono al di là della Manica) che possa assurgere a
teoria o a dottrina. Certo, come quel personaggio di Molière che all’improvviso
si accorge «di aver fatto sempre della prosa», alcuni possono formulare dottrine
e teorie a loro insaputa. Ma è nostra intenzione evitare una guerra di parole.
Poiché da noi – la Patria del diritto – è in discussione al Senato, dopo una
prima lettura della Camera, un disegno di legge noto col nome di Alessandro Zan
del Partito democratico, suo primo firmatario (in realtà si tratta di un testo
che ne ha unificati altri) attingiamo da lì le definizioni che potrebbero
esserci imposte con il potere della legge. Non è necessario impegnarsi
nell’interpretazione dei 10 articoli che compongono il ddl, anche perché sono
tante le spiegazioni dei sostenitori come se parlassero a nome dei giudici che
saranno chiamati a sanzionare le violazioni. Basta citare l’articolo 1 dal
titolo indicativo di “Definizioni” che ci autorizza a usare questo termine anche
per il gender.
1. Ai fini della presente
legge: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si
intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o
contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento
sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone
di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di
genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione
al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver
concluso un percorso di transizione.
Sulla base di queste
coordinate, il ddl Zan è presentato come un deterrente all’omotransfobia (è un
obiettivo sicuramente encomiabile) e come un ampliamento dei diritti civili.
Premesso – ma non è questo il caso – che per un certo «dirittismo» (copyright di
Alessandro Barbero) ricorda spesso un verso di Dante (libito fé licito in sua
legge), è sicuramente un diritto civile esprimere il proprio orientamento
sessuale anche attraverso il riconoscimento di rapporti giuridici più solidi di
quelli attualmente previsti, pur continuando ad appartenere al sesso biologico
denunciato all’anagrafe (a meno che non si segua la procedura molto più
complessa della trasmigrazione sessuale) che non toglie o aggiunge nulla al
diritto di provare, in piena libertà, «attrazione sessuale o affettiva nei
confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i
sessi». Che omosessuale è una persona, creata uomo, che per andare a letto con
un’altra dello stesso sesso deve percepirsi come donna? Se l’orientamento
sessuale viene difeso dalla legge, per quale motivo la teoria dell’identità di
genere (ovvero «l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al
genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver
concluso un percorso di transizione») deve trovare posto, in modo arbitrario e
truffaldino, nell’ordinamento giuridico alla stregua di un valore comune?
Determinando così una vistosa contraddizione: quanto viene percepito
diventerebbe reale a norma di legge, mentre ciò che è platealmente reale (il
sesso) si trasformerebbe in un’opinione, magari un po’ retrò e a rischio di
essere ritenuta una prevaricazione.
Alessandro Rico per "la
Verità" il 5 luglio 2021. Storica, professoressa di storia contemporanea all'
Università La Sapienza di Roma, Lucetta Scaraffia è membro del Comitato
nazionale di bioetica. Da anni scuote l'establishment accademico e culturale per
le sue posizioni tanto acute, quanto refrattarie ai dogmi del pensiero unico.
Femminista, ma anche cattolica, risoluta oppositrice di certe derive
dell'ideologia arcobaleno. Qualche giorno fa, ha suscitato vivo interesse un suo
editoriale sul Quotidiano Nazionale, in cui difendeva il diritto della Chiesa
d'intervenire sulla delicata e divisiva questione del ddl Zan.
Professoressa, erano anni che
non si sentivano più lamentele sull'«ingerenza» del Vaticano negli affari
politici italiani. Crede che la nota verbale sulla legge contro l'omotransfobia
fosse legittima?
«Sì, perché era una nota di
tipo giuridico e diplomatico. E aveva a che fare solo ed esclusivamente con il
rapporto tra due Stati. Qualcuno, invece, l'ha erroneamente scambiata per una
nota di tipo morale».
È un problema il fatto che si
stia cercando di conferire sanzione normativa a una concezione filosofica e
antropologica - l'identità di genere?
«Sì, secondo me è un problema.
Soprattutto se poi vengono puniti quelli che non condividono quest' ideologia.
Perché, semmai, è proprio la libertà di pensiero ed espressione a costituire la
base di tutti i diritti».
Esiste, quindi, il pericolo
che, in virtù del ddl Zan, si sottopongano le opinioni a una sorta di scrutinio
giudiziario?
«A mio avviso, sì. Questo
pericolo esiste».
In una recente intervista, lo
stesso Alessandro Zan, nel tentativo di sottrarre la legge a questa obiezione,
ha praticamente dettato al sacerdote ciò che può dire e non può dire durante
un'omelia.
«Non ricordo questo episodio
in particolare, ma è una cosa che non mi meraviglia».
No?
«Nell' articolo 4 del ddl Zan,
c' è una clausola che ribadisce la punibilità delle opinioni che integrerebbero
il "concreto pericolo" che si compiano discriminazioni o violenze».
Quindi?
«Decidere cos' è che incita
alla violenza e cosa no rimane una prerogativa del magistrato. E questo è molto
pericoloso».
Sembra che, nonostante le
forti resistenze del Pd di Enrico Letta, si stia aprendo uno spiraglio di
mediazione politica. Italia viva, ad esempio, propone di convergere su un testo
che elimini i riferimenti all' identità di genere, cassi l'articolo 4 e, quanto
alla giornata sull'omotransfobia, che andrebbe celebrata nelle scuole, ribadisca
l'autonomia degli istituti.
Crede sia un compromesso
accettabile?
«Mi sembra di sì, perché si
eliminerebbero i rischi più gravi. Dopodiché, io ho proprio una posizione
diversa».
Cioè?
«Ho un'idea antica: penso che
ai bambini si debba insegnare il rispetto dell'altro in generale: di ogni
persona, di ogni essere umano».
E invece, cosa si cerca di
fare?
«Qualcuno è convinto che si
debba insegnare il rispetto per categorie: i disabili, gli omosessuali... Alcune
categorie sono protette e vanno rispettate. E gli altri? La trovo un'idea
profondamente sbagliata».
I critici vanno oltre:
sostengono che sia in atto un tentativo di manipolare i bambini e di conculcare
la libertà educativa delle famiglie. Sono ansie giustificate?
«Guardi, tutto sommato credo
che nella realtà quotidiana queste cose non succedano così di frequente. Quelle
sono posizioni ideologiche che, per fortuna, hanno poco a che fare con la realtà
delle scuole».
Esiste l'ideologia gender? Chi
ne propugna i principi, al contempo, lo nega.
«Esistono tante forme di
questa ideologia. E alcune sono anche forme positive di attenzione
all'appartenenza a un genere sessuale».
Ad esempio?
«Io sono una storica. Una
volta si faceva storia senza distinguere gli uomini dalle donne.
Adesso, oltre che studiare gli
avvenimenti di cui erano protagonisti gli uomini, ci si deve interrogare anche
su quale fosse la condizione femminile in quel dato periodo. Mi sembra buono e
giusto».
La «diversità» è diventata una
specie di dogma. A ben vedere, però, promuovere l'annullamento delle differenze
sessuali significa scivolare proprio dalla «diversità» alla «fluidità». Non sono
due concetti antitetici?
«Sì, sono due cose diverse. Ma
anche in questo caso, ho la sensazione che siano elaborazioni teoriche che nella
realtà della vita non hanno alcuna presa. Sono posizioni ideologiche a cui
nessuno presta veramente attenzione».
Nel suo editoriale sul Qn
difendeva - cito - «una verità che è sotto gli occhi di tutti», ovvero, «che i
desideri trovano un limite nella realtà». Intende dire che siamo esposti a una
specie di dittatura del desiderio?
«Senz'altro: ne sono
convinta».
E da cosa scaturisce?
«È una forma tipica del nostro
tempo. I desideri sono sollecitati continuamente per via del consumismo. E
questa continua sollecitazione ci convince che abbiamo diritto a tutto».
È da questo paradigma
filosofico che originano anche pratiche come l' utero in affitto?
«Sì. Tra l' altro, io sono una
delle più impegnate contestatrici dell' utero in affitto. E ci ho scritto un
libro contro, La fine della madre».
Riflettiamoci su un secondo. I
gay pride invocano il libero accesso a tutte le tecnologie riproduttive. In
Francia è stata appena approvata una legge che consente la fecondazione
eterologa a coppie lesbiche e donne single.
In Spagna, la ley trans ha
ridotto mamma e papà a persona «incinta» e individuo «non gravido». Non le pare
sia in atto una rimozione della figura del padre?
«Al contrario: a me sembra che
si tratti piuttosto di una cancellazione della figura della madre».
Perché?
«Quello della madre diventa
una specie di lavoro pagato, con uno spezzettamento tra la donna che vende gli
ovuli, quella che vende l'utero e quella che paga per avere il bambino. È
soprattutto una distruzione della figura della mamma».
Ma chi è che spinge per quello
che, a questo punto, è un vero e proprio sconvolgimento della natura umana? E
perché?
«La logica sottesa è sempre
quella: la pretesa di avere tutto ciò che si desidera, anche quando non si è
donne. È la volontà di appropriarsi della specificità delle donne: il loro
potere generativo. E poi c' è un altro aspetto».
Quale?
«Mi sembra che l'obiettivo
finale sia quello di distruggere le identità sessuali».
In che modo?
«Siccome l'identità femminile
si fonda sulla maternità, se uno fa a pezzi la maternità, distrugge anche la
femminilità».
Si può trovare un punto di
equilibrio tra l'ascolto del disagio di chi non si identifica con il proprio
genere sessuale biologico e la necessità di difendere, in ogni caso,
un'elementare verità antropologica, cioè che esistono uomini e donne?
«Si può trovare benissimo.
Basterebbe lasciare ogni persona libera di scegliere il comportamento sessuale
che preferisce, senza che questo debba avere a che vedere con la sua identità
sessuale. Al netto di quei casi patologici di confusione dell'identità sessuale,
che sono rarissimi».
Un'altra questione dibattuta è
la transessualità infantile. Siamo su una china pericolosa?
«Come sa, faccio parte del
Comitato nazionale di bioetica e abbiamo scritto un documento proprio su questo
tema: le cure ormonali sui ragazzi giovani che percepiscono un'incertezza quanto
alla loro identità sessuale».
Chiedete prudenza nei loro
confronti?
«Di più: fino alla maggiore
età siamo contrari a queste terapie. Ma io stessa, nella mia esperienza
personale, ho notato che c'è una preoccupante tendenza a intervenire molto
precocemente con cure ormonali che possono danneggiare gravemente il loro
sviluppo e la loro personalità».
Ci sono commentatrici
femministe secondo le quali il mondo Lgbt è misogino. È vero?
«Credo di sì».
Perché?
«Be', in fondo, quella intorno
alla maternità è una lotta per il potere, che è sempre costata molto alle donne
- è costata l'oppressione. Chi non ha la capacità di generare la vita, cerca di
toglierla anche a chi ce l'ha».
Le persone Lgbt hanno
sicuramente patito discriminazioni. Oggi, però, si stanno trasformando in
soggetti prevaricatori, peraltro con l'appoggio del cosiddetto woke capitalism,
del potere politico e dei media?
«Questo è successo sempre
nella storia. Non mi stupisce per niente».
Le due cose, però, sono in
contraddizione: se è perseguitata, una minoranza non può avere dalla sua il
capitale, il potere politico e il mainstream mediatico.
«Il fatto è che questi gruppi
non accettano che la mentalità delle persone abbia bisogno di tempi lunghi per
cambiare. La gente non cambia a comando. Se costoro usano quelle leve per
forzare i cambiamenti, è perché non riescono a tollerare che per ottenerli serva
del tempo».
“Il dogma gender non si discute”. Gli
esperti rossi in audizione in Parlamento fanno muro.
Carlo Marini giovedì 8 Luglio 2021 su Il Secolo d'Italia. Arrivano tristi
conferme dall’audizione (in videoconferenza alla Commissione Infanzia della
Camera) sulle pratiche della transizione di genere dei soggetti minori di età.
Il dogma gender regna anche tra gli addetti ai lavori. Ne scrive oggi il
quotidiano La Verità, citando la seduta della commissione parlamentare per
l’Infanzia presieduta dal leghista Simone Pillon, convocata per far luce su
quelle linee guida che avevano suscitato clamore sia per l’impostazione –
favorevole al «cambio di sesso» dei minori con disforia di genere -, sia per le
prese di distanza da parte della Regione e dell’Azienda ospedaliera San Camillo
Forlanini di Roma. Il quotidiano riporta a mo’ di esempio, l’intervento del
dottor Luca Chianura. Il responsabile di Psicologia clinica presso il SAIFIP
(Servizio di adeguamento tra identità fisica ed identità psichica) del San
Camillo Forlanini di Roma. «Mi trovo un po’ a disagio, non capisco qual è il
senso di questa audizione», ha detto il dottor Chianura. Mistero fitto anche sul
rapporto, avviato dal 2005, tra il Saifip e il Tavistock, l’ospedale britannico
che ha seguito centinaia di «cambi di sesso» di minori. Tutto questo prima di
finire al centro di uno scandalo giudiziario. Sono diverse le denunce di ex
medici e di ex pazienti, che hanno denunciato d’essere stati prematuramente
avviati all’iter di riassegnazione sessuale. Lo stesso Chianura da una parte ha
preso le distanze dalla struttura britannica («noi abbiamo un protocollo
diverso»), ma dall’altra al Tavistock ha riservato parole d’encomio: «È ancora
oggi il punto di riferimento per tutti i servizi dell’età evolutiva del mondo».
Si è alzato un muro di gomma anche quando i commissari hanno chiesti ragguagli
sulla collaborazione del Saifip con lo psichiatra Domenico Di Ceglie, che del
Gids è stato direttore e che risulta vicino al gruppo autore delle linee guida
laziali. Linee che vorrebbero imporre il ddl Zan di fatto. «Di Ceglie è uno dei
massimi esperti della sua disciplina», ha minimizzato la psicoterapeuta
Maddalena Mosconi, responsabile “Area Minori” del SAIFIP presso l’A.O. San
Camillo Forlanini di Roma. Un buco nell’acqua anche quando i membri della
Commissione Infanzia hanno citato il caso di Keira Bell, trans pentita, che ha
citato i medici inglesi per danni. “Un caso isolato”, hanno tagliato corto gli
esperti. Guai a mettere in discussione il dogma gender.
Maria Teresa Martinengo per "la Stampa" l'8 luglio
2021. Il primo caso è arrivato nel 2005, il secondo nel 2007, un altro due anni
dopo. Poi sempre di più, fino a contarne 37 nel triennio 2019 - 2021 e 162 in
totale. È la crescita esponenziale delle famiglie con bambini, bambine, ragazzi
o ragazze con disforia di genere che si sono rivolte ai servizi torinesi
dedicati, quelli che possono aiutarle nell' accompagnare i loro figli e figlie a
comprendersi e a seguire il percorso che in una minoranza di casi, nella
maggiore età, può portare al cambiamento di sesso. Chi vive questa condizione
non percepisce la sua identità di genere come corrispondente all' assegnazione
avvenuta alla nascita. Le prime famiglie si sono rivolte al Cidigem, il Centro
Interdipartimentale Disturbi Identità di Genere dell'ospedale Molinette, mentre
dal 2009 è entrato in funzione l'ambulatorio Varianza di Genere dell'ospedale
infantile Regina Margherita, entrambi appartenenti alla Città della Salute e
della Scienza di Torino, i cui medici e psicologi collaborano e si confrontano.
Di questi tempi molto si discute di «identità di genere», ma rispetto ai minori
la questione emerge soprattutto attraverso vicende drammatiche. L'ultima, poche
settimane fa, dolorosissima, è stata quella di Orlando Merenda, diciottenne
torinese, morto suicida sotto un treno. «La domanda di aiuto da parte delle
famiglie oggi è diventata molto più frequente che in passato, e i centri, con le
forze che hanno, sono sommersi», racconta Damiana Massara, psicologa,
coordinatrice del Gruppo di lavoro minorenni del Cidigem (che accoglie dai 16
anni) e coordinatrice della Commissione Minorenni dell'Osservatorio Nazionale
sull' Identità di genere a cui fanno riferimento quasi tutti i centri italiani
dove è possibile effettuare l'intervento chirurgico. «L' osservazione dei 162
casi dice qualcosa: 100 sono minori "assegnate femmine alla nascita", 62 sono
"assegnati maschi". Un tempo si diceva maschi o femmine "biologici". Quando
abbiamo cominciato - prosegue Massara - era il contrario, arrivavano più maschi.
Le famiglie erano spaventate, si preoccupavano per loro, la condizione delle
femmine aveva meno risonanza. Nel tempo è cresciuta la sensibilità e oggi
arrivano le femmine». In questo momento sono 16 le famiglie che attendono un
primo colloquio al Regina Margherita. Per la dottoressa Massara non ci sono
cause «sociali» per questo aumento. «I casi sono tanti perché il servizio è
conosciuto dai pediatri, dagli psicologi, dalle stesse famiglie. Noi ne parliamo
in tutti i corsi che teniamo. Il problema è sempre esistito - osserva la
psicologa - ma ora viene affrontato e chiamato col suo nome. Cambiamento
significa riconoscimento della dignità, del rispetto. Tanti bambini e ragazzi
che non si sentono "nella norma" si isolano, non vanno più a scuola, hanno paura
di essere evitati, temono il bullismo. Il punto è riconoscere il loro travaglio,
assicurare loro lo spazio nella società, nella scuola». La neuropsichiatra
infantile Chiara Baietto, che coordina l'ambulatorio del Regina Margherita,
parla di «un percorso decisamente lungo, che per qualche bambino può
incominciare a 2-5 cinque anni, ma l'età media è 14-15 anni, ed è differente da
caso a caso. Le famiglie ci presentano il problema di un figlio che non si sente
di appartenere al sesso assegnato e chiedono una consulenza. Sono famiglie
attente, non liquidano la cosa proibendo comportamenti, ma cercano di capire».
Con i più piccoli lavoriamo per eliminare le paure in loro e nella famiglia,
facciamo prevenzione delle psicopatologie. Naturalmente, più i bambini e i
ragazzi crescono in un ambiente sereno, meno cadono in ansia, depressione, meno
mettono in atto tentativi di suicidio o forme di autolesionismo, molto comuni in
questi casi». La dottoressa Baietto spiega che «spesso il bambino o la bambina,
il ragazzo o la ragazza si sentono "strani". Per questo il percorso per
comprendere è molto lungo, capita che i ragazzi non sappiamo inquadrare il loro
problema e vadano per tentativi, vedono magari una persona transgender su
internet e dicono "forse sono così". Arrivando poi alla pubertà, solo un terzo
conferma la disforia di genere». Ancora: «La pubertà è il momento spartiacque.
Se dopo l'inizio l'adolescente si vive male si può intervenire con i farmaci
bloccanti, per dare ancora tempo al ragazzo o alla ragazza per considerare cosa
è meglio per lui o lei. Dai 16 anni si può avviare la terapia con ormoni che
inducono il sesso desiderato. La transizione non è certamente una scelta facile.
Tutto il percorso è molto complesso, comunque si risolva. Per questo in tutta
Italia i servizi dovrebbero essere più strutturati e numerosi».
Da "liberoquotidiano.it" il 10
luglio 2021. Tutta la follia gender riassunta dalla storia di Keira Bell, trans
inglese che ha cambiato sesso a soli 23 anni. Nata femmina, è diventata maschio
e oggi, a 23 anni, ha fatto causa alla clinica Tavistock and Portman NHS Trust
di Manchester, dove è stata operata perché a suo dire i medici non le avrebbero
spiegato nel dettaglio tutte le implicazioni e le ripercussioni di una scelta
così radicale, maturata da adolescente. Keira ha raccontato al sua storia al
seguitissimo show mattutino Good morning Britain del canale Itv: "Non si possono
prendere decisioni simili a 16 anni, così in fretta. I ragazzi a quell’età
devono essere ascoltati e non immediatamente assecondati. Io ne ho pagato le
conseguenze, con gravi danni fisici. Ma così non va bene, servono cambiamenti
seri". "Era il percorso sbagliato", ammette ora la ragazza diventata ragazzo.
"Ero molto depressa da ragazzina, non mi sentivo a mio agio nel mio corpo da
donna e così ho sviluppato presto una disforia di genere", riconosce la 23enne,
che accusa poi le autorità sanitarie: "Non c’è stato un vero esame psichiatrico
nei miei confronti, è stato tutto così rapido e basato sul mio passato. Non c’è
mai stata una vera discussione: i miei sentimenti dovevano essere scandagliati e
non semplicemente accettati per quello che erano. Perché quando inizi il
percorso, poi è molto complicato tornare indietro". Con buona pace di chi crede
che la vita si possa decidere già quando si è ancora bambini, come fosse
semplicemente una scuola da cambiare nel caso non andasse come sperato.
Si fa presto a
dire Zan, la clinica inglese dei gender riconosce: “Certi cambi di sesso
affrettati”. Luisa Perri mercoledì 7 Luglio 2021
su Il Secolo d'Italia. Sul palmo della mano al posto del Ddl Zan dovrebbero
scrivere Keira Bell. E’ il nome della trans pentita, che a 16 anni fu indotta a
cambiare sesso. E che ora ha fatto causa alla clinica britannica Tavistock,
considerata la Mecca dei minorenni gender.
Il caso di Keira Bell, trans “pentita”. Keira,
nata biologicamente di sesso femminile, da bambina si è sentita uomo. Così, ad
appena 16 anni, ha deciso di cambiare sesso. La clinica a cui si è rivolta, la
Tavistock and Portman NHS Trust, ha approvato abbastanza velocemente la sua
decisione di intraprendere il suo percorso transgender. Ora, però, Keira, che
nel frattempo di anni ne ha 23, si è pentita della scelta fatta, accusando le
autorità mediche di aver “acconsentito troppo presto al desiderio di cambio di
identità e di genere”. “Ero troppo giovane per decidere, non dovevano
assecondarmi. Non si possono prendere decisioni simili a 16 anni, e così in
fretta. I ragazzi a quell’età devono essere ascoltati, e non immediatamente
assecondati”, ha dichiarato Keira a Good Morning Britain su Itv.
Le dichiarazioni allarmanti dalla clinica di
Londra. Per il trattamento dei casi della cosiddetta disforia di genere la
clinica di Londra è un punto di riferimento in Europa. In questo centro bambini
e ragazzi, in un’età compresa fra i 24 mesi e i 17 anni, vengono sottoposti a
terapie per cambiare sesso. Dal 2014 al 2019, sono stati 2.500 tra bambini e
adolescenti e il fenomeno è in aumento. Uno psicologo che ha lavorato presso la
stessa clinica Tavistock, ha confidato al Times dei suoi timori che la clinica
stesse eseguendo una “terapia di conversione per bambini gay”. Il dottor Matt
Bristow ha affermato di temere che la clinica Tavistock e Portman NHS stesse
ignorando la possibilità che i ragazzi e le ragazze che hanno affermato di voler
cambiare sesso possano essere semplicemente gay. L’affermazione di Bristow è
emersa nelle dichiarazioni dei testimoni per Sonia Appleby, una psicoterapeuta
responsabile della salvaguardia dei bambini presso la clinica per l’identità di
genere, che sta facendo causa alla fiducia. La scorsa settimana ha detto a un
tribunale del lavoro di essere stata “denigrata” per aver sollevato
preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini sottoposti a trattamento, che
includeva la clinica che segnalava bambini di appena 12 anni per farmaci che
bloccavano la pubertà. Come riferisce Panorama, un’indagine interna, voluta dal
dottor Dinesh Sinha, a capo del Tavistock and Portman Nhs Trust ha raccolto
“decine di testimonianze di medici e infermieri, tutti dubbiosi sull’effettiva
moralità dei trattamenti ormonali per bambini e bambine affetti da presunta
disforia di genere. Bambini magari depressi, anoressici o autistici o
semplicemente incerti, incoraggiati a una transizione senza ritorno. Il tutto in
nome di una tendenza, di una propaganda. Anzi, forse di una moda”. E mentre in
Gran Bretagna si riconoscono gli errori qui, con le lezioni di transomofobia
imposte con la legge Zan, si vorrebbe fare lo stesso.
La Ferragni parla del Ddl Zan, ma sa di che cosa
parla? Il caso di Keira non è l’unico, in merito ai danni fisici procurati dagli
ormoni bloccanti. Come riporta il sito Provita e famiglia, l’endocrinologo
Michael Laidlaw, ha pubblicato sui Social i dati sulla fascia d’età dei giovani
transgender, ai quali erano stati somministrati i farmaci, in età compresa tra i
di 12 e i 15 anni. Lo studio in questione, come spiega Laidlaw, avrebbe
confermato una “massiccia diminuzione della densità ossea di questi pazienti
rispetto ai loro coetanei”, tramite un grafico che ne mostrava la diminuzione
graduale nel tempo, soprattutto sulla spina dorsale. Quello che la Ferragni di
turno non dice è che si fa presto a scrivere “Ddl Zan” sul palmo della mano.
Tornare indietro, per molti bambini e ragazzi, sarebbe troppo tardi.
Fratoianni e Fassina compagni contro. Ma
sul Ddl Zan ha torto il primo e ragione il secondo.
Francesca De Ambra mercoledì 7 Luglio 2021 su Il Secolo d'Italia. Nicola
Fratoianni non riesce a farsene una ragione. Ha letto dei seri dubbi di Stefano
Fassina circa la costituzionalità del ddl Zan e l’ha presa quasi come un fatto
personale. Leggere, per conferma, quel che ha scritto sull’Huffington Post. Più
che un ragionata disamina, la sua è una raffica di anatemi all’indirizzo di
chiunque osi dissentire dal testo sull’omotransfobia all’esame del Senato. Passi
per la destra, che «ha sempre paura di ogni libertà», e transeat pure per Renzi,
da cui «viene il solito opportunismo di purezza», ma non per Fassina. Qui il
tono di Fratoianni, da ironico e leggero si fa accorato e ferito. Bolla come
«confuse e infondate» le sue parole per poi inerpicarsi lungo un sentiero irto
di spigolature giuridiche che il leader di Sinistra Italiana avrebbe fatto
meglio a scansare che ad affrontare. E sì, perché lui è uno di quelli per i
quali la legge è un’insieme di concetti moralistici incollati da più o meno
belle parole. E quella magica, per lui come per tanti compagni della sua
parrocchietta, è “diritti“. E perciò non si capacita del come del perché a
Fassina sia saltato in mente di definire l’identità di genere, così come
formulata nell’articolo del ddl Zan, cioè accostata all’orientamento sessuale,
«un veicolo per un progetto ideologico». Orrore. «È piuttosto il contrario»,
sentenzia Fratoianni con l’aria di chi la sa lunga. Per lui, infatti, chi vuole
rimuovere l’identità di genere lasciando nel testo il sesso, il genere e
l’orientamento sessuale «sta tentando di affermare il valore generale e
universale di un punto di vista da cui in tanti non si riconoscono sentendosi
quindi esclusi e discriminati».
Il nodo dell’identità di genere. E siamo al punto.
Già, perché la lettera d) dell’articolo 1 definisce l’identità di genere come
«la manifestazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere». E
questo anche quando non corrisponde al sesso e «indipendentemente dall’aver
concluso un percorso di transizione». Tutto chiaro per Fratoianni. «Quali
sarebbero – chiede, infatti – gli effetti negativi della sanzione contro la
discriminazione fondata sull’identità di genere? Nessuno, non se ne ravvisa
nessuno». Peccato che dimentichi che il ddl Zan è norma penale e come tale deve
possedere quei requisiti della determinatezza e della tassatività, impossibili
da rinvenire nella succitata lettera d). Il sesso degli angeli, insomma, non è
materia del codice. Il compagno Fassina se n’è accorto in tempo. Il compagno
Fratoianni non l’ha ancora capito.
"Testo giusto nei fini, non nel metodo. I
giudici hanno troppa discrezionalità". Sabrina Cottone
l8 Luglio 2021 su Il Giornale. Il professore: "I reati devono essere sempre
definiti: qui non lo sono. Così si rischia che per un'omelia si venga accusati
di omofobia". L'arrivo del ddl Zan nell'aula del Senato il 13 luglio, voluto
dall'asse Pd M5S Leu per un voto al buio che spacca maggioranza e opinione
pubblica, è accompagnato dalla rinascita di «Insieme», partito solitario, più
pensatoio che numeri e sondaggi. Punto di riferimento intellettuale, garante dal
principio, è il professor Stefano Zamagni. L'ex premier Giuseppe Conte ha
tentato un avvicinamento che non è finito bene. Al congresso romano dello scorso
fine settimana hanno mostrato interesse il segretario di Stato vaticano Pietro
Parolin e il laico Andrea Riccardi, fondatore di Sant'Egidio. «Condivisibile nei
fini, sbagliato nel metodo» sintetizza Zamagni parlando del ddl Zan.
Che cosa trova condivisibile di questa legge che
spacca il Parlamento?
«Nessuno mette in discussione la necessità di
combattere i fenomeni di dileggio discriminazione violenza verso le persone che
hanno orientamento sessuale diverso, completando la famosa legge Mancino sui
crimini d'odio che aveva lasciato da parte il sesso. Il fine è sacrosanto ma il
metodo, cioè la via seguita, è sbagliato».
Che cosa la preoccupa maggiormente?
«Io da cittadino devo sapere se l'atto che vado a
compiere è reato oppure no. Un gruppo di costituzionalisti, credenti ma anche
no, hanno detto che il testo non regge proprio perché in una legge penale i
reati devono essere definiti e invece il livello di discrezionalità dei giudici
rimane molto alto».
In molti ne fanno una questione di libertà.
L'identità di genere, la possibilità di scegliersi il sesso, non va in questa
direzione?
«Questioni di bioetica non possono diventare
biogiuridiche senza la mediazione culturale necessaria. Quando si parla di
identità di genere non si può far dipendere il genere da una questione
individualistica legata al singolo perché chi vive in società sa che ci sono
regole che vanno rispettate. Non posso dire: faccio quel che voglio in questa
come in altre questioni perché distruggo la coesione sociale. C'è una grande
differenza tra libertà e libertarismo».
Perché è a rischio la libertà di espressione?
«Il confine non è tracciato. O la legge determina
dove finisce la libertà di espressione e dove inizia il reato o è evidente che
succederanno cose simili a ciò che è già accaduto in Spagna, in Canada e nei
Paesi dove esistono leggi simili. L'arcivescovo di Valencia, per un'omelia in
cui difendeva il matrimonio tra uomo e donna, è stato accusato di omofobia. Se
anche poi a processo vieni assolto, resta grave, perché intanto devi prendere un
avvocato, incorrere in spese ingenti. Se un rettore di seminario invita un
seminarista omosessuale a lasciare il seminario, il seminarista potrebbe
denunciarlo».
Molte obiezioni riguardano la libertà
d'educazione. Concorda?
«Nelle scuole non può essere lo Stato che decide
sull'educazione dei figli minorenni perché per Costituzione tocca alla famiglia.
Lo Stato ha la responsabilità dell'istruzione, non dell'educazione. Dalla
confusione tra questi due livelli nascono molti equivoci».
Come si spiega la radicalità del segretario del
Pd, Enrico Letta, che arriva da un partito popolare?
«Noto che all'interno delle migliori intenzioni
iniziali, in corso d'opera il testo è stato strumentalizzato da una parte o
dall'altra. Comunque vadano le cose e si concluda la vicenda in Parlamento, non
finirà bene. Lascerà strascichi in un caso o nell'altro».
Che cosa pensa del dibattito sulla giustizia? È
così malmessa?
«Lo vede anche un cieco che non funziona. Io sfido
a trovare un italiano che non sia d'accordo. Ma anche queste tematiche sono
merci di contrattazione in cui si perdono di vista principi e valori. Nel
dopoguerra non era così. E la scuola? Non possiamo isolare una questione
dall'altra perché altrimenti scattano i divieti incrociati. Non è sufficiente
riformare la giustizia, dobbiamo trasformarla».
In che senso una riforma non è sufficiente? E i
referendum?
«La riforma cambia la forma e lascia immutata la
sostanza. È una pezza, come il mastice quando buchi la ruota della bici. La
trasformazione è la giustizia che ha come fine il bene comune, non solo
punitiva. I referendum non li ho ancora approfonditi: non si può esprimersi su
tutto».
"Vi dico perché il Pd fa muro sul ddl
Zan". Francesco Curridori il 7 Luglio 2021 su Il
Giornale. Alessio De Giorgi, ex direttore di Gay.it, ci spiega perché ieri il Pd
ha sprecato un'occasione: "Peccato, potevamo far passare il ddl Zan con i voti
della Lega nonostante guardi a Orban". "Personalmente voterei il ddl Zan così
com'è, ma nel lavoro, negli affetti e anche in politica l'arte della mediazione
è fondamentale". Alessio De Giorgi, a lungo direttore di Gay.it ed esponente di
Italia Viva, ci spiega perché ieri il Pd ha sprecato un'occasione importante.
Perché era così necessario arrivare a una
mediazione?
"Se è vero che la Camera ha approvato quel testo
sulla base di una mediazione proposta sempre da Italia Viva, ma è altrettanto
vero che la maggioranza è diversa da quella del Senato dove i numeri sono più
risicati. Non prendere atto dei rischi che corre questa legge col voto segreto è
da folli perché ci sono dubbi nel Pd, tra i Cinquestelle e non solo. La
presidente del gruppo delle Autonomie, Julia Unterberger, ha detto che è
irragionevole non trovare una mediazione. Poi, faccio notare che Giuseppe Conte,
su tutta questa vicenda, non ha detto una parola e, quindi, non ho idea di cosa
possano fare i deputati contiani per mettere in difficoltà Draghi. C'è il
rischio di arrivare a una 30ina di defezioni e lo schiaffo dato alle posizioni
più ragionevoli nel centrodestra a me sembra un corpo a corpo inutile di cui
potevamo fare a meno".
La frase 'incrociamo le dita' di Alessandro Zan
può danneggiare l'iter del suo Ddl?
"Trovo che sia una follia dire “incrociamo le
dita”, una frase che può dire un uomo della strada, un massimalista che vuol
fare scoppiare le contraddizioni nell'avversario. Non può dirla un uomo come Zan
che ha una storia importante dentro il movimento gay. Capisco e condivido il
punto di vista del Pd, ma non capisco e non condivido il punto di vista del
movimento Lgbt che dovrebbe essere come un sindacato. E, se un sindacato vede
che l'avversario va verso le sue posizioni non deve tirargli uno schiaffo in
faccia. Ieri, a parte una battuta stonata di Ostellari in Aula, dalla Ronzulli e
dallo stesso Ostellari ho sentito parole di grande apertura. Un sindacato non si
permetterebbe mai di non apprezzare una parte politica non vicina che condivide
una sua posizione".
Ma è vero che la mediazione proposta da Italia
Viva non protegge i trans?
"È una fake-news colossale perché una legge deve
comunque essere interpretata da un giudice e, se vogliamo parlare di casi
concreti, voglio proprio vedere un giudice che, per esempio, non valuta come
transfobia la violenza subita, per fare un esempio, da chi non ha neppure
iniziato un percorso di transizione ma occasionalmente indossa abiti non del
proprio sesso".
Le critiche al ddl Zan non provengono solo dal
centrodestra. Cosa turba non solo il Vaticano, ma anche le femministe e una
parte del mondo Lgbt?
"La discussione è uguale a quella che ci fu
sulle unioni civili. Si vuol far fare alla legge qualcosa in più rispetto agli
obiettivi della legge. L'approccio è eccessivamente ideologico. Nel momento in
cui inserisci una norma come l'identità di genere, inserisci una norma che
definisce un punto di vista diverso rispetto alla legge sulla transizione
sessuale. Legge aggiornata dalla Corte Costituzione la quale ha riconosciuto che
l'operazione per passare da un sesso all'altro è molto invasiva e, dunque, si
può cambiare sesso anche senza farla. Dal mio punto di vista, transfobia è un
termine assolutamente appropriato".
Ma perché il Pd non tiene conto dei rilievi
provenienti dal mondo femminista?
"Il Pd non tiene conto delle posizioni delle
femministe per ragioni di posizionamento politico perché, in un governo di unità
nazionale col centrodestra, ha bisogno di caratterizzarsi e di rinsaldare
l'alleanza col M5S. Facendo così, però, passa sopra come uno schiacciasassi a
quelle persone che la legge vorrebbe tutelare e le mette a rischio di non avere
una legge che le protegga. Poi, il Pd non si rende conto che i Cinquestelle sono
allo sbando. La settimana scorsa, in Commissione il M5S ha annunciato il voto
favorevole al provvedimento, ma tre quarti di loro ha votato contro. Io ho
vissuto le battaglie dei Dico e dei Pacs e so perfettamente che sono stati usati
questi temi per caratterizzarsi politicamente a sinistra e poi, però, si è
rimasti con un pugno di mosche in mano".
Crede che la forzatura del Pd possa essere un modo
per affossare la legge?
"Mi auguro non ci sia un accordo sotto banco per
non far passare la legge, facendo muro contro muro. Sarebbe un calcolo cinico
veramente grave perché ci sono episodi di omofobia e transfobia e abbiamo delle
persone da tutelare ed è importante il messaggio culturale che può dare questa
legge. Mi auguro che dentro il Pd si facciano sentire le voci più ragionevoli.
Ma ci rendiamo conto quanto sarebbe importante se l'Italia si dotasse di una
legge contro l'omofobia anche con i voti di quel pezzo di centrodestra che
guarda a Orban? Dopo aver portato Salvini su posizioni europeiste, questa
sarebbe una vittoria di tutti da festeggiare".
Francesco Curridori. Sono originario di un paese
della provincia di Cagliari, ho trascorso l’infanzia facendo la spola tra la
Sardegna e Genova. Dal 2003 vivo a Roma ma tifo Milan dai gloriosi tempi di
Arrigo Sacchi. In sintesi, come direbbe Cutugno, “sono un italiano vero”. Prima
di entrare all’agenzia stampa Il Velino, mi sono laureato in Scienze della
Comunicazione e in Editoria e Giornalismo alla Lumsa di Roma.
Gianluca Veneziani per "Libero Quotidiano" il 7
luglio 2021. Tommaso Cerno è parlamentare nel gruppo del Pd e omosessuale, ma
contrario all' ostinazione dei dem nell' approvare il ddl Zan così com' è.
Condivide piuttosto la linea di Renzi e Salvini, favorevole a togliere dal testo
le parti più divisive, relative a identità di genere, reati di opinione e
giornata contro l' omotransfobia.
Cerno, perché questa sua posizione?
«La legge Zan ha due pilastri. Il primo è la parte
migliore della legge: e cioè la condanna delle violenze contro gli omosessuali,
intese non più come violenze private ma come atti contro i rappresentanti di una
minoranza. Questa parte supera i limiti della legge Mancino, che di fatto
istigava a delinquere contro i gay, tutelando tutte le minoranze tranne gli
omosessuali. La seconda parte, che riguarda i reati di opinione e l'identità di
genere, invece non mi soddisfa perché è scritta male e fa troppo poco per
conseguire gli obiettivi che si propone. E allora io la lascerei in sospeso. La
sinistra dovrebbe rendersi conto che, se la destra per la prima volta nella
storia è disposta a votare una legge che punisce i reati di odio contro i gay,
si tratta di un passo enorme. E perciò mi terrei stretto quel primo passo. E
poi, oltre al testo della legge, pesa il contesto: la sinistra ha deciso di fare
un governo con la Lega? Bene, allora deve tenerne in considerazione le
posizioni».
Se la legge arriva in Aula con il voto a scrutinio
segreto e non modificata, c' è il rischio che non passi?
«Sì, e per questo non si dovrebbe arrivare a quel
punto. Se legge non passasse, romperebbe la maggioranza e metterebbe Draghi
nelle condizioni di dimettersi. Perciò dico al Pd: sarebbe folle creare una
crisi di governo per una parte di legge scritta male. Idem ricordino che non è
un testo intoccabile: Zan non è Mosè e non ha ricevuto le tavole della legge dal
dio dei gay».
Renzi è stato minacciato di morte sui social per
questa sua posizione. Anche lei ha ricevuto attacchi dalla comunità Lgbt?
«Sì e, in nome della libertà intellettuale,
accetto queste critiche, purché non siano violente. Se invece sono intolleranti,
mi batterò contro la loro intolleranza. In generale, i membri della comunità
Lgbt hanno tutto il diritto di esprimere il loro pensiero fino a quando non
diventa eterofobico. A me comunque interessano molto di più le minoranze
silenziose, quei gay che sono discriminati sul posto di lavoro o picchiati dai
genitori, e non hanno voce per difendersi».
Il ddl Zan, da battaglia etica, si è trasformato
in una battaglia politica con cui i partiti stanno saggiando la loro forza?
«È possibile. Renzi, che aveva fatto passare le
unioni civili un po' perché ci credeva e un po' perché gli interessava, ora farà
passare la parte migliore della legge un po' perché ci crede e un po' perché gli
interessa. Lui, come Salvini, è un animale politico e sa come muoversi. Anzi, è
più segretario del Pd da quando non lo è più di quanto non lo sia stato nel
periodo in cui lo era».
Secondo lei, è sotto attacco perché rischia di
essere decisivo nella partita per il Colle?
«Lui è sotto attacco a
prescindere: fa di tutto per esserlo a causa delle sue opere e omissioni. Ma è
difficile dire se l'asse Salvini-Renzi sul ddl Zan sia il banco di prova per una
futura convergenza tra centrodestra e Iv nell' elezione del capo dello Stato.
Può essere anche che la votazione finale sia la prova generale per un governo
che segni la fine del bipolarismo. Se la legge modificata viene votata da
Salvini, Renzi e Letta, si può immaginare un governo con loro dentro, che lasci
agli estremi le destre e le sinistre. E potrebbero essere quelle stesse forze a
eleggere il nuovo capo dello Stato».
"Hanno rimosso un video dove mi dicevo
critico sul ddl Zan". Francesco Boezi il 13 Luglio
2021 su Il Giornale. Il viceministro Alessandro Morelli, esponente della Lega,
segnala la rimozione di un video in cui venivano esposte le problematiche del
ddl Zan. Il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili Alessandro Morelli, esponente della Lega contrario, almeno per come
il provvedimento è strutturato sino a questo momento, al disegno di legge Zan,
ha reso noto di essere stato "censurato" da Facebook in relazione proprio al Ddl
che si è discusso al Senato in queste ore. Quella in corso è una fase fervente,
perché il Partito Democratico, che non è disposto al dialogo sul ddl Zan,
potrebbe presto schiantarsi contro la realtà dei numeri. Le previsioni
parlavano di un "Vietnam" parlamentare. E oggi il Senato ha iniziato a lavorare
sul testo, senza prendere una decisione definitiva. La sensazione è che la
trattativa sia destinata a durare nel tempo. L'unica novità riguarda il
respingimento delle pregiudiziali. La Lega sembra convinta della necessità di
modifiche al ddl Zan. Ma nonostante le aperture in merito, il Pd tira dritto.
Morelli, dal canto suo, ha illustrato i motivi della sua contrarietà in un
video, che può ancora essere visto dagli utenti su YouTube. Durante il filmato,
l'esponente leghista elenca gli articoli di legge a suo dire problematici,
partendo dal primo, che è poi uno di quelli accusati di voler introdurre nel
nostro sistema giuridico la cosiddetta "teoria gender". Il viceministro, che è
espressione del partito guidato da Matteo Salvini, prende poi in considerazione
l'articolo 2, ponendo il tema della libertà d'espressione e quello della
discrezionalità, che sono altre due argomentazioni utilizzate dai critici del
ddl Zan per mettere in evidenza la natura problematica del provvedimento.
L'articolo 4, ancora, sarebbe contraddittorio. E così via, sino a toccare punto
per punto tutte le perplessità che il viceministro ha in materia. Una
particolare attenzione viene riservata da Morelli alla Giornata dedicata alla
comunità Lgbt. Insomma Morelli punta il mirino sia in relazione ai contenuti
giuridici sia rispetto al sottofondo ideologico su cui il ddl Zan potrebbe
contare. Al netto delle preoccupazioni relative alla poca chiarezza dei confini
di alcune fattispecie introdotte, la Lega ha manifestato, Morelli compreso,
preoccupazione per come il ddl Zan potrebbe essere in qualche modo sfruttato per
diffondere l'"ideologia gender" all'interno degli istituti scolastici italiani.
In conclusione del filmato, il leghista, dopo aver spiegato tutti i suoi perché,
ribadisce la sua posizione. Ma qualcosa non va come previsto con il filmato: il
politico della Lega, attraverso una nota stampa, ha reso noto che il video è
stato rimosso dal social network. Il viceministro, nella sua premessa, cita il
caso di Donald Trump a mo' di esempio, sottolineando come la policy dei social
possa "minare" la "libertà d'espressione". Poi l'accusa: "La settimana
scorsa pubblico un video in cui spiego i contenuti della legge. Ne evidenzio i
punti critici, mettendo in fila le ormai arcinote perplessità sulle questioni
relative a identità di genere, reato di opinione e priorità educativa dei
genitori. Passa poco tempo e il video viene cancellato dalla piattaforma che,
sinora, ha evaso le mie reiterate richieste di spiegazioni". Facebook non
avrebbe dunque fornito i perché della sua scelta al viceministro Morelli, che ne
fa anche una questione complessiva: " Una società privata che svolge un servizio
di pubblica utilità si riserva il potere di limitare la libertà di
espressione. Siamo arrivati così al paradosso che i sacerdoti del pensiero
unico, nel nome della tolleranza, riducano a brandelli la libertà di parola. Chi
non la pensa come loro non ha diritto di cittadinanza sulla pubblica piazza e
viene esiliato dai social", chiosa il parlamentare, che ha voluto mettere al
corrente della "rimozion" subita attraverso un altro video
pubblicato su Facebook.
Francesco Boezi. Sono nato a Roma il 30 ottobre
del 1989, ma sono cresciuto ad Alatri, in Ciociaria. Oggi vivo in Lombardia.
Sono laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso la Sapienza
di Roma. A ilGiornale.it dal gennaio del 2017, mi occupo e scrivo soprattutto di
Vaticano, ma tento spesso delle sortite sulle pagine di politica interna. Per
InsideOver seguo per lo più le competizioni elettorali estere e la vita dei
partiti fuori dall'Italia. Per la collana "Fuori dal Coro" de IlGiornale ho
scritto due pamphlet: "Benedetti populisti" e "Ratzinger, il rivoluzionario
incompreso".
«Il ddl Zan è più grave del codice
fascista». E il Senato diventa la curva anti-gender.
Simone Alliva su L'Espresso il 15 luglio 2021. Gli interventi durante la
discussione generale trasformano la legge contro l’omotransfobia in un’apertura
all’utero in affitto, che limita le libertà a diffonde le ideologie fluid. E
“ghender”.
Parla Giacomo Caliendo, senatore di Forza Italia:
"Questa legge è più grave del codice Rocco, il codice del fascismo". È la prima
battuta della giornata. Ce ne sarà un festival a Palazzo Madama, tutto dedicato
al ddl Zan. Il bestiario politico offerto dal Senato parte da qui. Due giorni di
discussione generale. Una giostra di accuse, insulti, complotti. C’è tutto: la
fantomatica teoria del gender (che diventa fluid-gender o ghender a seconda del
senatore), l’utero in affitto, la lentissima caduta dell’impero.
Perosino, anche lui senatore di Forza Italia, ha
il fiato corto e la mascherina sotto il naso: "Conosco tanti gay che vivono la
loro condizione con dignità. Questa legge è l'anticamera dell'utero in affitto.
La diffusione della teoria gender e le trasformazioni dei bambini che sono
contronatura". Fa una pausa e poi conclude: "Il ddl Zan è la costruzione di un
concetto nichilista della società ha gli stessi sintomi della caduta dell'impero
romano". Applausi e fischi. Il web segue questo spettacolo ogni minuto
sorprendente in cui succede proprio quello che non ha logica: il capogruppo al
Senato di Italia Viva, Davide Faraone accusa la senatrice del PD Monica Cirinnà
di averlo messo alla gogna: “Mi ha ripreso mentre applaudivo Matteo Salvini.
Chiedo provvedimenti”. Ignazio La Russa, oggi in Fratelli d’Italia, esprime
solidarietà a Faraone e confessa che anche lui è stato discriminato “dai Cirinnà
dell’epoca” per le sue idee politiche.
Tutti applaudono, tutti urlano. Il senatore
Pillon, leghista e noto alle cronache per aver annunciato una “caccia alla
stregoneria nelle scuole”, parla per 20 minuti. Forse per questo si confonde:
"Con il ddl Zan si potrà dire che due uomini sono famiglia, due donne sono
famiglia". Ma lo sono già. Per lo stato dal 2016, legge sulle unioni civili.
Dopo di lui interviene Tiziana Drago, ex
cinquestelle, oggi in Fratelli d’Italia. Nel 2019 si presentò a sorpresa al
Congresso delle Famiglie di Verona. Oggi fa parte dell’intergruppo parlamentare
che raccoglie i sostenitori pro-vita e anti-lgbt: “Vita, Famiglia e Libertà”. Fa
lunghe pause. Ogni tanto si inceppa e poi ricomincia sorreggendo un foglio
scritto a mano: "Assistiamo a un'ingerenza governativa sul ddl Zan” la stoccata
è diretta all’ex collega di partito, Barbara Floridia che sul proprio profilo
Facebook ha sostenuto il ddl Zan per i corsi contro il bullismo omotransfobico:
“La sottosegretaria all'istruzione ha pubblicato un post a favore dell'art.7.
Non solo le istituzioni. Le produzioni cinematografiche e anche i cartoni
animati hanno cercato a informare sul ddl Zan a senso unico".
Sonia Fregolent, senatrice Lega, fa riferimento
all’istituzione della giornata contro l'omotransfobia prevista dalla legge Zan e
già riconosciuta dall'UE e dall'ONU dal 2004, per ricordare il 17 maggio del
1990, giorno in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha depennato
l'omosessualità dalle malattie mentali: "Perché non istituire una giornata
contro l'eterofobia o l'orgoglio eterosessuale?".
La vicepresidente del gruppo Forza Italia al
Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli
alleati, Licia Ronzulli, fa sempre riferimento alla Giornata contro
l’omotransfobia: “con l’articolo 7 si vorrebbe introdurre la teoria del fluid
gender nelle scuole, una cosa che ci trova assolutamente contrari”. Da gender a
fluid gender. Mentre Giampiero Maffoni senatore di Fratelli d’Italia vede nella
legge: “Una discriminazione al contrario. Presentare il ddl Zan come una
proposta per aggiungere altre discriminanti alla Mancino è fuorviante. Siamo
sicuri che allungare l'elenco non costituisca un discrimine nei confronti delle
altre: i senzatetto?"
L’intervento più infervorato è del
senatore Vescovi anche lui Fratelli d’Italia: “Qual è il vostro intento?
distruggere i valori?”. Non riesce a tenere la mascherina, interviene con una
veemenza e un afflato che fanno temere i commessi: “Fermiamoci. Una bambina di
sette anni è venuta a dirmi: si possono sposare due uomini o due donne. Ma dove
lo hanno imparato. Lasciamoli giocare".
Calma è invece Nadia Pizzoli, leghista, l’incipit
è semplice: "I bimbi hanno diritto a un padre e a una madre. Quando sono grandi
vogliono sapere perché la madre li ha abbandonati e soffriranno moltissimo per
tutta la vita. Non potete pretendere questo con l'utero in affitto. Fateli
nascere normalmente". E continua: "Non siamo nell'ex unione sovietica dove i
bambini venivano tolti dalle famiglie ed educati dal partito. I vostri desideri
non vanno confusi con i diritti. Sono capricci ideologici e quindi mi opporrò
con ogni mezzo a questa legge. Penso che ai bambini non vada assolutamente
trasmessa l'ideologia gender. Ma cosa volete insegnare ai bambini se non c'è
nessuna evidenza scientifica. E come affermassi che piovono patate e non acqua".
Applauso. Uno. Quello della collega di banco.
Segue sul finale la senatrice leghista Raffaella
Fiormaria Marina, di professione psicologa: "La scuola che non vorrà celebrare
la giornata contro l'omofobia potrà farlo o sarà destinata a pagare questa
libertà?” chiede “Chi osa obiettare finisce sotto processo. Della cosiddetta
ideologia gender o ghender si è capito che anziché promuovere libertà di scelta,
solleva dubbi sulla libera espressione. Chiunque potrà essere vittima di un
procedimento penale, intercettazione o addirittura misure cautelari". Chiude per
oggi Stefano Lucidi, senatore umbro alla seconda legislatura ex M5s oggi con la
Lega: "Non abbiamo bisogno di modelli europei, di modelli trans europei ma
ricordarci le nostre tradizioni e la nostra cultura". La discussione generale
sulla legge contro l’omotransfobia riprenderà martedì 20, giorno in cui scade il
termine di presentazione degli emendamenti al ddl. Attesi gli interventi del
leghista Andrea Ostellari, del capogruppo del Carroccio Massimiliano Romeo e del
leader Matteo Salvini. Lo spettacolo continua.
Capanna contro il ddl Zan: legge da
buttare, crea solo nuovi reati e non la voterei.
Redazione venerdì 16 Luglio 2021 su Il Secolo d'Italia. Mario Capanna non
voterebbe il ddl Zan. L’ex leader del Movimento studentesco sessantottino ha
spiegato perché a margine della presentazione al Senato del libro di cui è
co-autore "Parlamento mondiale – Perché l’umanità sopravviva" scritto per
Santelli editore. “Non lo voterei perché è sbagliato – ha detto – continuare a
produrre provvedimenti di legge che creano nuovi reati. Noi dobbiamo creare
nuovi diritti, non nuovi reati”. Alla domanda se sia opportuno un dialogo perché
il testo superi il vaglio dell’aula, Capanna replica reciso: “No, detto papale
papale: il ddl Zan va buttato via. Non serve. Per punire certi reati le norme
esistono già”. La stessa posizione dunque di molti esponenti di destra, accusati
per questo di essere omofobi e contro i diritti delle minoranze. Anche verso
Capanna arriveranno accuse di questo tipo? E’ improbabile, a dimostrazione della
strumentalità di un dibattito che mira solo a colpire chi non ai adegua al
“pensiero unico” dell’ideologia gender. Capanna non è stato tenero, nelle sue
dichiarazioni, nei confronti della sinistra. “Se la sinistra non torna a fare il
suo lavoro – ha detto – è ovvio che lo spazio viene invaso dalla destra e da
vari populismi”. “Lo stato della sinistra – ha aggiunto- è chiaramente
sofferente: perché ha largamente introiettato il punto di vista dominatore e non
fa più il suo mestiere. Quando ha fatto il suo mestiere, ed era all’opposizione,
mi riferisco al Pci, con le lotte di massa si conquistarono cose fondamentali di
cui ancora oggi godiamo i frutti: Statuto dei lavoratori, divorzio, assistenza
sanitaria nazionale, il nuovo diritto di famiglia”. “Era opposizione
-sottolinea- ma aveva rapporto diretto e linfa vitale con larghi settori
popolari. Oggi niente, la sinistra galleggia in questa iper-coalizione in cui
non svolge più il suo mestiere. Se non svolta, la storia la costringerà a
chiudere bottega”. Quanto al Pd da lungo tempo – chiosa Capanna – non ha più
nulla di sinistra. “E’ un semplice partito riformista che non ha la levatura e
il prestigio della Spd o del Labour. E’ in difficoltà, non solo perché lo dicono
i sondaggi ma perché è in difficoltà nella stessa azione di governo”.
Fabio Amendolara per "la Verità" il 14 luglio
2021. L'ultimo flop della legge Mancino, codificata nell'articolo 604 bis del
codice penale, è targato Verona. Lì il Tribunale, ieri, ha assolto 19 imputati
che rischiavano 32 anni di reclusione, rei di aver protestato contro una coop
dell'accoglienza che a Roncolevà di Trevenzuolo voleva trasformare una villetta
residenziale in un centro per rifugiati. I fatti risalgono al 2017, quando due
comitati di cittadini per mesi portarono avanti la loro battaglia con slogan e
striscioni. «Fu un assedio», secondo l'accusa, rappresentata in aula dal
procuratore Angela Barbaglio, con finalità di «odio razziale». Una contestazione
pesantissima che, però, è crollata miseramente durante il processo, con le
difese che hanno fatto en plein. All'inizio gli imputati erano 22. Poi si è
scoperto che uno era minorenne e, quindi, gli atti sono stati mandati alla
Procura minorile. Un secondo imputato è stato prosciolto perché vittima di uno
scambio di persona. Ma per gli altri 19, tra gli attivisti di «Roncolevà alza la
testa» e «Verona ai veronesi», la Procura chiedeva con forza una condanna. Si è
ritrovato imputato perfino un pensionato settantaduenne che con gli altri
cittadini aveva manifestato il suo «no» contro le attività della coop
Versoprobo. Il Tribunale ha quindi stracciato i capi d'imputazione pieni di
insulti, che non hanno trovato riscontro, agli ospiti del centro d'accoglienza:
da «scimmie» a «sporchi negri». E alla rappresentante della cooperativa:
«Schiavista, sfruttatrice». La pena più alta era stata chiesta per Nicola
Bertozzo di «Verona ai veronesi», 2 anni di reclusione, mentre per gli altri 18
la Procura aveva chiesto una condanna a 1 anno e 8 mesi. Bertozzo, considerato
l'uomo che «dirigeva il movimento costituito per finalità di odio razziale», era
accusato anche di aver pubblicato sulla sua pagina Facebook quella che la
Procura riteneva un'istigazione, ovvero aveva invitato «a difendere Roncolevà
dal business dell'accoglienza... la popolazione si è raccolta per contrastare il
nuovo affare che specula sulla pelle dei migranti». Non solo, l'accusa è piena
di ricostruzioni di «aggressioni», «provocazioni ai richiedenti asilo e aglio
operatori della cooperativa», «danneggiamenti», «lanci di luce laser» e
strombazzate «di clacson». E addirittura si era ipotizzato che l'imprenditore
che doveva costruire la recinzione attorno all'immobile fosse stato minacciato
con queste parole: «Sappiamo chi sei, se accetti di fare il lavoro ti bruciamo
il furgone». L'indagine è partita da una segnalazione via email molto generica,
mandata alle autorità da una operatrice della coop. Si è poi nutrita di alcune
annotazioni di servizio dei carabinieri che effettuavano servizio sul posto. Ma
le accuse sono state smontate durante le udienze dai difensori. L'assoluzione è
stata una botta pure per l'Osservatorio migranti, che con la stessa coop si era
costituito parte civile. Il gruppo consiliare della Lega a Verona esprime
«solidarietà ai veronesi ingiustamente attaccati». «La paura», scrivono i
consiglieri leghisti, «era che quella ventina di richiedenti asilo finisse a
bighellonare e vagabondare turbando la tranquillità del piccolo centro, che
conta 700 anime». «Una grande vittoria processuale con indagini alquanto
lacunose, che hanno coinvolto persone, anche di una certa età, totalmente
incensurate e innocenti», ha commentato l'avvocato Andrea Bacciga, difensore di
alcuni imputati, che ha aggiunto: «Quella protesta non aveva alcun fondamento
discriminatorio. Era nata per ribadire il fermo no al business
dell'accoglienza». Una sonora sconfitta di un tentativo maldestro di applicare
una legge ideologica.
Ddl Zan, Alessandro Sallusti e le conseguenze
pericolose: "Gender nostro che sei nei cieli..." Alessandro Sallusti su
Libero Quotidiano il 16 luglio 2021. Se la legge Zan passasse come chiedono i
promotori si aprirebbe un enorme problema di libertà di opinione dagli esiti
imprevedibili perché affidati, in buona sostanza, al giudizio dei magistrati che
in quanto uomini hanno idee diverse tra loro e spesso un equilibrio instabile.
Prendiamo il caso dell'insegnamento cattolico. Non solo le sacre scritture al
punto "Dio li creò maschio e femmina" ma anche buona parte del catechismo
finirebbe fuori legge perché discriminante e tendenzialmente omofobo là dove si
legge che "l'omosessualità è una condizione disordinata contraria alla legge
naturale" e che le persone in tale stato "devono essere chiamate alla castità".
Fino a oggi gli insegnamenti in campo etico e sessuale della Chiesa sono
semplicemente un pensiero della Chiesa che nessuno è tenuto a leggere e
tantomeno a seguire. Insegnarli, crederci e applicarli è una scelta libera e
privata. Con il decreto Zan invece un magistrato - su denuncia di qualcuno o per
sua iniziativa- potrebbe, anzi dovrebbe, intervenire a tutela della parità di
genere. Una sorta di Medioevo all'incontrario nel quale finiscono al rogo non i
miscredenti ma i credenti. Già me lo vedo: avvisi di garanzia a parroci ed
educatori, sequestri di vangeli e testi sacri sospensione delle prime comunioni
che prevedono per l'appunto lo studio del catechismo. Vogliamo arrivare a tutto
questo? Che i cattolici facciano i cattolici e i laici i laici in piena libertà.
E a chi sostiene che ciò non potrà mai accadere ricordiamo le follie avallate
dalle istituzioni tipo togliere i presepi dalle scuole e dai luoghi pubblici per
non offendere i credenti di altre religioni. Io già me la vedo l'interpellanza
parlamentare che chiede al ministro dell'Interno come sia possibile che si
reciti il Padre Nostro e chieda di sostituire le prime parole con: "Gender
nostro che sei nei cieli" perché non esiste più la differenza tra padre e madre
(in molte anagrafi è già così, i famosi genitori uno e due). Questo è un
giornale laico che difenderà la laicità dello Stato fino alla morte. Ma ci
batteremo anche per la libertà di religione ed educativa delle comunità
cattoliche. Non sarà uno Zan a cancellare la storia della nostra civiltà.
Il discorso in Senato. Chi è Barbara
Masini, la senatrice di Forza Italia a favore del ddl Zan che ha fatto coming
out. Antonio Lamorte su Il Riformista il 17 Luglio
2021. Barbara Masini si è commossa in Senato, parlando in difesa del ddl Zan, il
disegno di legge contro l’omotransfobia. La senatrice di Forza Italia ha fatto
coming out a inizio luglio. Masini ha votato con la maggioranza (Forza Italia,
contraria al ddl, ha lasciato libertà di coscienza ai suoi parlamentari). “A voi
tutti auguro di poter guardare negli occhi i vostri cari. Quelli di oggi e
quelli di domani, e anche quelli che un domani saranno diversi dai vostri
desideri. E poter dire loro, io nel mio piccolo ti ho protetto dalla paura”, ha
detto Masini ringraziando il suo partito “per il rispetto che mi ha sempre
dimostrato”. La senatrice ha 47 anni. Laureata in scienza politiche
all’Università degli Studi di Siena. È stata eletta consigliere comunale a
Pistoia con Forza Italia, risultando la donna più votata della coalizione di
centro-destra sostegno del sindaco Alessandro Tomasi. È stata eletta al Senato
alle politiche del 2018. Fa parte della commissione Politiche dell’Unione
Europea. Masini si è raccontata in un’intervista a Il Corriere della Sera. Ha
raccontato della sua infanzia, quando “per noi lesbiche nate negli anni Settanta
c’era soltanto Lady Oscar” e quando per imitare le amiche aveva dei fidanzatini
e aveva anche pensato di costruirsi una famiglia. Questo prima di innamorarsi di
una donna e di staccarsi da tutto andando a vivere in Belgio. Quindi il ritorno.
“Mia madre è una donna eccezionale, anche bellissima. Però devo dire pure mio
padre lo è, non lo nomino mai. Loro due, medici, hanno una mentalità
apertissima, hanno sempre votato per i radicali. A mia madre poi non ho dovuto
nemmeno dirlo – ha raccontato – Una volta mi ha guardato e mi ha detto: ‘Barbara
ma quell’amica che ti è venuta a salutare all’areoporto…’. Era la mia fidanzata
dell’epoca”. La stessa madre, come ha raccontato l’onorevole in aula, aveva
paura per la figlia, che non potesse “vivere felice”. Paura che oggi Masini
percepisce “più di qualche anno fa. C’è stata una recrudescenza”.
La sua idea sul ddl: “L’articolo 1 lo cancellerei,
sono solo definizioni che esistono già nella giurisprudenza e non deve essere
certo Zan a spiegarcele. È l’articolo 2 che dà le tutele. Poi toglierei il 4,
non stravolge la legge. E sul 7 metterei dei limiti: nessuna educazione ai
bambini delle elementari. Però siamo chiari: se la legge rimane così com’è io la
voto tutta la vita“.
Antonio Lamorte. Giornalista professionista. Ha
frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di
Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di
stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.
ALESSANDRA ARACHI per il Corriere della Sera il 17
luglio 2021.
Senatrice Barbara Masini, giovedì mattina
nell'aula del Senato si è emozionata parecchio...
«Le emozioni sono un atto di coraggio».
Nel suo intervento ha parlato di sua madre, della
sua omosessualità: si può dire che di coraggio ne abbia avuto abbastanza?
«Sì, ma mi sono emozionata di più nel ringraziare
il mio gruppo, Forza Italia, che sulla parte personale».
Una decina di giorni fa, sempre in aula, aveva già
fatto il suo coming out.
«L'ho fatto perché ho pensato di poter aiutare il
dibattito sul ddl Zan. Nella mia vita ho sempre vissuto la mia omosessualità
alla luce del sole, ma senza farne troppa pubblicità».
Adesso la sua sessualità è nota a tutti...
«Servirà ad aiutare qualcuno. Sono contenta di
poter essere un modello. Ai miei tempi di modelli non ce n'erano. Per noi
lesbiche nate negli anni Settanta c'era soltanto Lady Oscar».
Il cartone animato?
«Sì, una grande donna disegnata che mi è stata
molto utile da piccola».
Già da piccola ha capito di essere omosessuale?
«No, non bene. Avevo dei fidanzatini, ce l'avevano
tutte e io imitavo. Poi ho avuto un fidanzato vero, dai 18 ai 25 anni, avevo
anche pensato di mettere su famiglia».
Poi?
«C'era qualcosa che non mi tornava. Poi mi sono
innamorata di una donna».
Che ha fatto?
«Sono scappata da tutti, anche da me stessa, e
sono andata a vivere in Belgio per un anno».
E il suo fidanzato?
«Non gli ho detto la verità quando sono scappata.
Dopo ho deciso di tornare e di affrontare tutto con tutti».
Come è andata?
«Mia madre è una donna eccezionale, anche
bellissima. Però devo dire pure mio padre lo è, non lo nomino mai. Loro due,
medici, hanno una mentalità apertissima, hanno sempre votato per i radicali. A
mia madre poi non ho dovuto nemmeno dirlo».
Se ne è accorta lei?
«Sì, le mamme sanno. Una volta mi ha guardato e mi
ha detto: "Barbara ma quell'amica che ti è venuta a salutare all'aeroporto...".
Era la mia fidanzata dell'epoca».
E adesso?
«Adesso ho 47 anni e convivo con Pamela da
dodici».
In aula ha detto che sua madre quando ha saputo ha
avuto paura.
«Per me, che non potessi vivere felice».
Lei ha paura?
«Adesso più di qualche anno fa. C'è stata una
recrudescenza».
I suoi colleghi di partito?
«Mi rispettano tutti. Con Annamaria Bernini c'è
anche un legame di affetto, come con altri. Giovedì ho avuto pure messaggi
affettuosi dai leghisti».
Che sul ddl Zan si sono messi di traverso.
«È vero, ma sul ddl Zan adesso è Letta che
sbaglia. Noi siamo parlamentari, dobbiamo mediare, non stiamo giocando la finale
degli Europei. Per avere una legge si può accettare anche di togliere qualche
bandierina».
Lei quale bandierina toglierebbe?
«L'articolo 1 lo cancellerei, sono solo
definizioni che esistono già nella giurisprudenza e non deve essere certo Zan a
spiegarcele. È l'articolo 2 che dà le tutele. Poi toglierei il 4, non stravolge
la legge. E sul 7 metterei dei limiti: nessuna educazione ai bambini delle
elementari. Però siamo chiari: se la legge rimane così com' è io la voto tutta
la vita».
Oltre alla Lega c'è anche il suo partito che è
molto contrario alla legge Zan.
«Lo so, al Senato sono stata l'unica a votare a
favore, ma sono sicura che col voto segreto sarebbero molti di più. E poi alla
Camera sono stati in cinque a votare a favore, tra questi Elio Vito, un
grande».
Ha mai pensato di unirsi civilmente?
«Non ci tengo particolarmente. Però sono felice
che ci sia una legge così in Italia».
A proposito del suo unico fidanzato, siete rimasti
in buoni rapporti?
«Altroché. È il commercialista di mia madre e
della mia compagna. Non penso di dover aggiungere altro».
"Io, femminista, vi spiego perché la
legge è sbagliata". Sabrina Cottone il 14 Luglio 2021
su Il Giornale. L'ex deputata dei Ds: "È un capovolgimento della realtà, mi
sorprendo che la sinistra la appoggi". «Che cosa sta succedendo in Senato?».
Francesca Izzo, storica del pensiero moderno e contemporaneo specializzata in
cultura politica delle donne, deputata ds tra il 1996 e il 2001, impegnata da
sempre nei movimenti femministi, spera ardentemente che la legge Zan sia
modificata. «È un capovolgimento della realtà. Per questo insieme ad altre donne
continuo a battermi senza lasciarmi intimidire. Sono sorpresa da come la
sinistra sposi queste posizioni senza dibattito».
I sondaggi dicono che le persone sono in
maggioranza favorevoli alla legge Zan. Lei pensa che la contrapposizione in
Senato rispecchi una divisione viva nel Paese?
«Per fortuna si è aperta un po' più di discussione
nell'ultimo mese e mezzo, anche se molto limitata, ma la gente non ha ancora
chiaro quali siano i contenuti del testo. Fondamentalmente c'è quest'idea che la
legge Zan cerchi di tutelare al meglio le persone omosessuali e trans e per
questo si dichiara favorevole. Ma non c'è solo quello».
La legge Zan non combatte le discriminazioni?
«Insieme a questo obiettivo è presente in maniera
surrettizia la volontà di far passare in una legge di rilievo penale una
posizione sulla sessualità umana molto discutibile. È giusto che se ne discuta
nelle sedi accademiche, nell'opinione pubblica, ma non che la questione entri in
sedi penali».
Si riferisce all'identità di genere? L'espressione
è già stata usata in sentenze della Consulta.
«È stata utilizzata in un altro senso, non in
quello che è specificato all'articolo uno della legge Zan, ovvero il concetto di
sesso percepito. In tutto il nostro ordinamento, quando si parla di identità di
genere riferita alle persone transessuali, ha sempre un ancoraggio al sesso.
Utilizzando la polisemia si dice: è già nell'ordinamento ma non è così».
Come donna e come femminista, che cosa teme di
più?
«Molte femministe sono contrarie perché questa
concezione espressa dal termine identità di genere mette in discussione
radicalmente il binarismo, cioè che il genere umano è diviso in donne e uomini.
La legge sottende che la divisione in due sessi è una costruzione ideologica,
culturale, che organizza la famiglia in un certo modo, mentre invece esiste una
pluralità di espressioni sessuali. Così, la legge Zan mette in discussione
l'esistenza delle donne. Nega che possa esserci una differenza tra una donna
biologicamente tale e una donna transgender. Diventerebbe un atto di
discriminazione affermare che una donna di sesso femminile è differente da un
transessuale o da un uomo che si percepisce donna».
Questo è confusivo e dannoso per i bambini?
«Ovviamente le conseguenze possono essere anche
molto spiacevoli sui bambini, perché si introduce un'altra idea di umanità e lo
si fa di nascosto, in due articoli che cambiano una legge penale. C'è l'idea che
per combattere la discriminazione nei confronti di omosessuali e transessuali
bisogna dire che siamo tutti uguali. Io penso che la discriminazione si superi
mantenendo le differenze e non discriminando, accettando che esistano
omosessuali, transessuali e queer senza discriminarli, ma mantenendo che
esistano donne e uomini».
C'è un capovolgimento della realtà in questa
legge?
«Certo, perché salta il dato biologico, che non
sono solo cromosomi ma l'intera corporeità umana, l'esistenza fisico-
relazionale. In questa visione il corpo non esiste più. Io mi vesto da donna, ho
atteggiamenti da donna e sono una donna. Ormai sembra che biologico sia una
parola offensiva».
Vede in questa legge il rischio della maternità
surrogata?
«Non è un rischio, è una conseguenza. Se io mi
sento una donna e voglio avere un figlio che faccio? Viene rivendicato il
ricorso alla maternità surrogata perché una volta che io sono una donna non mi
si può discriminare».
Ha timori anche per la libertà di espressione?
«Se si toglie l'identità di genere cadono
moltissimi rischi. Siamo tutti d'accordo sul non colpire omosessuali e
transessuali. Ma con questa legge, nel minimo, se io dico che sono una donna e
che l'umanità è divisa in uomini e donne, rischio come già accade in altri Paesi
di essere censurata. Sono molto preoccupata». Sabrina Cottone
Ddl Zan, la sinistra perde
pezzi. Le femministe di “Se non ora quando”: «Così com’è non serve».
Redazione mercoledì
30 Giugno 2021 su Il Secolo d'Italia. Il Pd non cede: il ddl Zan deve andare in
aula così com’è. L’appuntamento è già fissato per il 13 luglio. A sostenerlo, il
senatore Franco Mirabelli. «La Lega perde tempo», dice. A muovere i dem,
tuttavia, è più la forza della disperazione che un’ordinata disamina del campo
di battaglia. Enrico Letta, infatti, non mette in conto né la nota verbale
della Santa Sede né, più prosaicamente, la dissoluzione in atto nel M5S che
rischia di provocare un “rompete le righe” dagli esiti imprevedibili,
ricacciandogli in gola la sua legittima voglia di rivincita. Per lui, infatti,
il ddl Zan è solo una bandierina da sventolare in segno di avvenuta riscossa. Ne
è in qualche modo ossessionato, come un centravanti da troppo tempo a digiuno di
gol. È per questo che non s’accorge che non sta giocando in attacco bensì in
difesa. Anzi, è addirittura sotto assedio. Prova ne siano i rilievi al ddl Zan
avanzati da “Se non ora quando”, associazione molto accreditata a sinistra. La
sua portavoce Fabrizia Giuliani è un’ex-deputata del Pd. È proprio lei a
rivelare che l’attuale testo non la convince fino in fondo, pur ricordando che
l’Italia «sconta un ritardo» sull’omotransfobia. «Così com’è il – è la sua
critica – ddl Zan manca l’obiettivo, non rispettando i principi
di tassatività e determinatezza». Per poi aggiungere: «Identità di genere è poi
il punto più controverso che è necessario emendare. La nostra proposta è
sostituirla con identità sessuale». Non ha torto: tassatività e determinatezza
sono requisiti essenziali della norma penale. Non tenerne conto, equivale
esporre il disegno di legge – se approvato senza modifiche – ai rilievi
della Corte Costituzionale. Anche per questo, Italia Viva continua a rilanciare
l’intesa del tavolo sul ddl Zan. La loro preoccupazione è che l’assenza di
un accordo finisca per favorire il pantano parlamentare con tanti saluti alla
legge contro le discriminazioni omotransfobiche. Un esito confermato
indirettamente dall’indisponibilità leghista ad avanzare proposte di mediazione.
A quanto si apprende da fonti parlamentari, durante la riunione di
maggioranza gli esponenti del Carroccio avrebbero ribadito le loro perplessità
sul provvedimento che andrebbe modificato in larga parte. Segno evidente che la
partita non è ancora chiusa. Il 13 luglio è solo l’inizio.
Alessandro Rico per "La
Verità" il 29 giugno 2021. Marina Terragni: giornalista, scrittrice, femminista,
che proprio nel nome del femminismo, contrasta l'identità di genere.
Il ddl Zan vuole imporla nelle
scuole?
«Vada su Feministpost.it: si
parla di una mamma americana che si rivolta contro la propaganda trans tra i
banchi. Una contestazione rarissima, perché lì vivono nel terrore».
La prospettiva post Zan
sarebbe questa?
«Ovunque è così. Ma dopo anni
di dominio delle associazioni come Mermaids, in Gran Bretagna questi corsi non
si fanno più. Il punto di svolta è stato la sentenza Keira Bell».
Keira Bell è la ragazza
britannica alla quale, a 16 anni, furono somministrati in modo molto disinvolto
i farmaci per bloccare la pubertà. Poi scelse di tornare indietro, ma i danni
erano già irreparabili. Ha fatto causa al Sistema sanitario e i giudici hanno
stabilito che a 16 anni non si può prestare un vero consenso informato a questi
trattamenti. Corretto?
«Sì. Ora siamo in attesa della
sentenza d'appello. Quello è stato il giro di boa, perché si è intervenuti in
difesa di bambini che vengono già bombardati dalla propaganda».
In che modo?
«Ho visto addirittura dei
cartoni animati con la famiglia arcobaleno di castori e la castorina che aveva
la doppia mastectomia. Una castora trans. La propaganda è pesantissima,
soprattutto in Canada e negli Usa. E in Gran Bretagna ci hanno dato un taglio:
evidentemente, hanno messo in correlazione questo lavoro di propaganda con
l'aumento vertiginoso delle transizioni infantili».
Di nuovo: è questo che ci
aspetterebbe dopo il ddl Zan?
«Ma guardi che già qualche
anno fa, nello scuole, lo spettacolo più rappresentato non era Pirandello,
Molière, Goldoni o Shakespeare, ma Fa'afafine».
Il Corriere lo presentò come
lo spettacolo sul «terzo sesso dei bambini».
«Appunto. E poi c'è tutto il
filone della "carriera alias"».
Cioè?
«Ti chiami Luigi, ma ti senti
Luigia e quindi ti fai assegnare un'identità di genere diversa da quella
anagrafica, valida dentro la scuola o l'università. Lo sa che in Canada adesso
c'è l'unicorno Gegi?».
Cos'è?
«Un pupazzetto disegnato che
aiuta i bimbi che si sentono di un genere diverso da quello biologico a far
fronte alla resistenza dei genitori. Una specie di "consulente legale". Perché
in Italia lo scenario dovrebbe essere diverso? Anche sull'utero in affitto».
Scusi, ma lo scopo qual è?
Aumentare i casi di transessualità infantile?
«A quanto pare».
Ma perché?
«C'è un mercato. E non è un
concetto banale. Tra i più grandi sostenitori di Barack Obama c'è stata la
famiglia Pritzker: Big pharma».
Allude alla vendita dei
farmaci che bloccano la pubertà?
«Certo».
C'è chi obietta: se si
sospetta una disforia di genere nel minore, è meglio somministrargli quei
farmaci e sospendere la pubertà. Tanto, il processo è reversibile.
«No, assolutamente. È stato
comprovato da vari studi che gli effetti sono irreversibili: ad esempio, quelli
sulla densità ossea. E ci sono rischi sulla fertilità futura. Ma c'è anche un
altro aspetto impressionante».
Quale?
«Molti dei bambini ai quali si
diagnostica la disforia di genere, in realtà sono autistici. Sarebbero più o
meno la metà di quelli che si rivolgono alle cliniche per l'identità di genere.
E poi qualsiasi consulto psicologico viene liquidato come una "terapia
riparativa"».
Cioè, un tentativo di far
diventare eterosessuale un omosessuale.
«Il che sarebbe una forma di
tortura. Ma Keira Bell dice un'altra cosa: dovevo essere aiutata perché ero
depressa, invece, dopo due incontri alla Tavistock, mi hanno prescritto gli
ormoni. Perciò, di recente, la Finlandia ha reintrodotto le terapie
psicologiche. C'è un paradosso».
Ovvero?
«Gran parte di questi
ragazzini sono semplicemente gay e lesbiche. Ma con loro si fa come in Iran,
dove se sei gay ti attaccano a un albero, ma se invece cambi sesso, vieni
accettato».
Il documento politico del gay
pride milanese ha chiesto esattamente che le transizioni di genere siano
consentite senza alcun consulto psicologico.
«Si chiama self id».
Sarebbe?
«Lei domani si sveglia e fa un
atto amministrativo in cui, senza alcuna perizia, senza sentenze, senza
testimoni, chiede di essere registrato come donna. Esiste a Malta, in Canada. In
Inghilterra, invece, dopo anni di lotte hanno chiuso...».
Chiaro. Ma se dopodomani mi
risveglio e voglio tornare uomo?
«Non saprei. Questo fenomeno
non l'hanno ancora esplorato. Intanto, il 29 giugno, in Spagna, il cdm esamina
la ley trans. All'inizio, Podemos era scatenato, mentre il Psoe aveva fatto
molta resistenza».
E poi?
«I socialisti hanno
improvvisamente cambiato posizione. Ora sa qual è una delle mediazioni che hanno
trovato?».
Qual è?
«Lei può sempre andare
all'ufficio a dire che si chiama Alessandra. Ma poi deve tornare tre mesi dopo a
confermarlo. Questa sarebbe la mediazione. Ma mi lasci tornare un attimo alla
questione dei soldi».
Prego.
«Lo spiegò benissimo Ivan
Illich in un libro profetico del 1984, Gender. L'obiettivo è creare individui
sciolti da ogni relazione, perfino quella con il loro corpo».
Perché?
«Perché questi sono i precari
assoluti: non hanno più nemmeno la certezza del corpo. Sono perfettamente
funzionali a produzione, consumo. Quello che mi serve, sei».
Il gay pride milanese chiede
anche il pieno accesso degli omosessuali a tutte le tecnologie riproduttive.
Incluso l'utero in affitto, allora.
«Be', questo lo hanno sempre
rivendicato».
In sostanza, lo scopo è andare
ben oltre Zan, no?
«Zan è l'apripista, con
l'imposizione del concetto di identità di genere. È questo che a loro interessa
di quella legge, insieme alle scuole. Tutto il resto è contorno».
Il mondo Lgbt è misogino?
«Sì»
Ma in che senso?
«I rapporti tra il mondo gay e
quello femminista sono molto antichi. Da parte delle donne c'è sempre stato
questo approccio protettivo nei confronti di persone che, fino a un certo punto
della nostra storia, sono state effettivamente perseguitate».
Però?
«Ora c'è una specie di
emancipazione del mondo gay dal femminile».
Che intende?
«Il gay "femmineo" non è più
una figura apprezzata: sono tutti palestrati, barbuti. C’è una maschilizzazione
del mondo gay, che ci riporta in dinamiche di contrasto tra donne e uomini. Ma
bisogna stare attenti».
A cosa?
«Non facciamo l'errore di
pensare che tutto il mondo gay sia questa roba qua. Ad esempio, non tutti i gay
sono di sinistra».
Naturalmente.
«Se vai in certi ritrovi gay
di Milano, a Porta Venezia, trovi pure gente che vota Lega, Forza Italia,
Giorgia Meloni. Ci sono imprenditori di grande talento, che hanno aperto locali
molto belli, e che se va Monica Cirinnà a fare la lezione sull'utero in affitto,
vivono la cosa con una certa insofferenza. Non gliene frega niente degli
obiettivi politici dell'Arcigay».
Il caso Saman ha messo in
imbarazzo le femministe?
«Non attribuiamo al femminismo
gli imbarazzi della sinistra. Il femminismo non appartiene né alla sinistra né
alla destra».
Ma ha senso ricondurre un
episodio del genere alla stessa matrice del cosiddetto «femminicidio»?
«Il dominio di un sesso
sull'altro, che Joseph Ratzinger ha definito perversione, è un fatto
incontestabile».
In Italia è un reato.
«Ma come vede non basta. In
più ci sono una cultura estremamente arretrata e un feroce autosessismo delle
donne: la mamma ha avuto una funzione essenziale in questo presunto omicidio.
Abbiamo il peggio del peggio del patriarcato, che s'intreccia con motivi legati
a fondamentalismo religioso che, per esempio, impongono il velo, perché il corpo
di una donna è considerato un pericolo».
Appunto.
«Però non si può nemmeno
incolpare l'islam. L'islam era anche l'Egitto di Nasser, la Persia di Reza
Pahlavi, Kabul con i night club Certo, in questo momento, la ripresa del
fondamentalismo fornisce una cornice culturale e religiosa a questi fenomeni».
E la fatwa dell'Ucoii?
«Una cosa sbagliatissima. Così
si equipara la legge coranica alla legge dello Stato».
Si condanna il matrimonio
forzato, ma non quello combinato. Una femminista non dovrebbe inorridire?
«Se hanno scritto questo, è
perché devono salvare capra e cavoli. È comunque illibertà femminile: corpi di
donne intese come oggetti che servono allo scambio tra famiglie».
Citava il velo.
«Lo rispetto. Ma in questi
giorni di caldo, io sto in canotta e la ragazza islamica sta con una coperta
sulla testa. Faccio fatica a capire: il corpo chiederebbe anche a lei di
scoprirsi, ma il suo corpo è concepito solo come il disordine pre Maometto».
Cioè?
«L'idea di una donna
sessualmente incontentabile, vorace, che va costantemente controllata, a cui si
affida il compito di custodire l'onore maschile. Una fantasia drammatica, che
nasce dalla paura».
Gli ultras del Ddl Zan
usano la Carrà appena morta.
Ignazio Stagno il 6 Luglio
2021 su Il Giornale. Già partita la petizione per cambiare nome al disegno di
legge. Tra i fan della proposta anche nomi dello spettacolo. Il Ddl Zan sta
accendendo la politica di casa nostra da parecchie settimane. Mentre sfuma
l'intesa nella maggioranza e ci si avvia verso lo scontro finale in Senato il
prossimo 13 luglio, gli ultras del ddl non si arrendono e arruolano
pure Raffaella Carrà morta solo 24 ore fa. Già sul web e soprattutto sui social
diversi profili hanno rilanciato messaggi e post per legare il nome della Carrà
al disegno di legge sulla omotransfobia. Ma c'è anche chi si è spinto oltre
usando la morte della conduttrice per dare un'accelerazione all'approvazione
della norma. E così è nata l'idea sul web di cambiare nome al Ddl Zan
tramutandolo in Ddl Carrà. La conduttrice non era mai entrata nel merito del
provvedimento. Ma tant'è. Così lo sceneggiatore Enrico Cibelli ha deciso di
lanciare online una vera e propria petizione per cambiare il nome della norma.
Non ha usato giri di parole, come riporta l'Adnkronos: "Direi di chiamarlo Ddl
Carrà, approvarlo e fine del discorso". E la proposta ha fatto il giro del web
ed è stata retwittata anche da nomi dello spettacolo come ad esempio il cantante
Ermal Meta che ha sentenziato: "Sono totalmente d'accordo". Insomma i tifosi del
Ddl Zan sono disposti a tutto. Usano la morte di una delle conduttrici, showgirl
e attrici più amate per portare acqua al mulino delle proprie battaglie
ideologiche e politiche. Un vizio che soprattutto a sinistra sta diventando una
sorta di moda. Per un intero giorno è stata usata la morte del giovane
Seid, suicida ad appena 20 anni, per sponsorizzare lo Ius Soli. Solo
l'intervento dei genitori ha riportato le cose al loro posto e ha zittito, in un
momento di estremo dolore, i cori dei kompagni. Proprio in quell'occasione
furono i genitori ad affermare che con la morte del ragazzo il razzismo aveva
poco a che fare. La scena si è ripetuta con la morte di Orlando Merenda che si è
tolto la vita qualche giorno fa. Anche in quel caso la morte è stata usata per
tirare la volata al Ddl Zan. Ma niente da fare, puntuale è arrivata la frenata.
Gli stessi inquirenti e gli
amici del ragazzo hanno affermato che il motivo del gesto potrebbe essere figlio
di altri contesti e altri problemi che avevano reso la vita impossibile a questo
ragazzo. Ora con la Carrà si è fatto il salto di qualità. Usare la morte di un
vip per cavalcare le battaglie politiche. Forse il vero omaggio che merita la
Carrà è quello di questa sera quando Spagna e Italia si riscalderanno sulle sue
note. Infine ricordiamo le parole di Mogol che tenendosi alla larga dagli ultrà
del ddl Zan ha proposto un gesto concreto per ricordare la Carrà, dedicarle
l'Auditorium Rai del Foro Italico: "Non devo spendere troppe parole per
raccontare cosa ha rappresentato Raffaella Carrà per la televisione nel nostro
paese e in particolare per la Rai. Un'eccellenza assoluta che ha dato prestigio
all'azienda e al nostro Paese nel mondo. Auspico che questa proposta, sostenuta
dai centomila associati SIAE che rappresento, venga accolta con favore". Un
gesto semplice che non ha il sapore dello sciacallaggio partito sui social.
Ignazio Stagno. Nato a Palermo
nel 1985. Palermitano prima di tutto, a Milano da quasi 10 anni. Dal 2015 lavoro
per il sito de ilGiornale.it. Due passioni: il Milan e le sigarette. Un solo
vizio: la barba lunga.
Lo sciacallaggio rosso che
fa politica sui morti.
Ignazio Stagno il 29 Giugno 2021 su Il Giornale. Dopo il caso
Seid, la sinistra ci ricasca: questa volta "usa" la morte di un ragazzo di 18
anni per spingere il Ddl Zan. Lasciate stare in pace i morti. Regola non
scritta, scolpita nel galateo del rispetto, ma totalmente ignorata e dimenticata
dalla sinistra. Negli ultimi tempi il blocco rosso (e anche parte dei Cinque
Stelle) cavalcano i casi di cronaca (con corpi ancora caldi) per portare acqua
al mulino delle battaglie ideologiche. Solo qualche settimana fa la morte del
povero Seid è stata usata e strumentalizzata per spingere il progetto della
legge sullo Ius Soli. Da più parti a sinistra si erano affrettati a mettere il
cappello sul gesto disperato di un ragazzo tirando fuori la solita retorica sul
razzismo. Solo l'intervento degli stessi genitori del ragazzo ha spento lo
sciacallaggio vergognoso su quel suicidio. Parole chiare: "Con la morte di Seid
il razzismo non c'entra". In pochi attimi Seid è stato abbandonato nell'oblio da
tutti i vari Saviano e Letta che avevano cercato di usare quella morte per
sponsorizzare lo Ius Soli e attaccare i nemici classici di turno come Salvini e
Meloni. Dall'esperienza del caso Seid, la sinistra non ha imparato nulla.
Giuseppe Legato per "la Stampa" il 9 luglio 2021.
No. Quel messaggio postato su Instagram da Orlando Merenda, il diciottenne morto
suicida a Torino il 20 giugno scorso, non c' entra niente con il movente di
questa tragedia. «Il problema delle menti chiuse è che hanno la bocca aperta»,
aveva scritto sul suo profilo social forse per superare l'ennesimo insulto di
qualche deficiente a caccia di battutone demenziali sui gay e sugli orientamenti
sessuali. Ma non è omofobia e nemmeno bullismo la chiave del giallo sulla morte
di questo giovanissimo ragazzo. Si è gettato sotto un treno per uscire da un
vicolo cieco che avevo reso, di colpo, tutto buio nella vita che a quell' età
può conoscere fragilità, ma non merita tenebre. Nella riservatezza delle
indagini della procura che lavora alla soluzione del caso, c' è una svolta che
da alcuni giorni ha orientato le indagini lontano dall' ignoranza di chi non
rispetta le scelte soggettive di ognuno. Non è qui la soluzione al mistero.
Orlando, che aveva compiuto 18 anni da un mese, era - in qualche modo e chissà
per quale motivo - finito (già da quando era minorenne) a contatto con un giro
legato alla prostituzione. Forse obbligato, forse ingannato. Certo non aiutato a
prenderne le distanze quando forse stava cercando la forza di farlo per
allontanarsi velocemente da un contesto che non gli apparteneva. E' in questo
quadro che si muovono le indagini del pm Alessandra Barbera e della polizia. In
questo contesto sarebbe maturato un ricatto che potrebbe averlo portato a
togliersi la vita. La omosessualità non era, per la vittima, vissuta come una
diminutio della sua personalità. Non c' era imbarazzo, adesso. Il percorso,
probabilmente, non era stato facile, ma da un po' di tempo rivendicava le sue
scelte con personalità. I profili social del giovane restituiscono l'immagine di
un ragazzo che voleva e aveva deciso di essere se stesso. Gli insulti omofobi
post mortem che hanno riempito le cronache fino a pochi giorni fa, sono gravi e
contemporaneamente estranei alla dinamica dei fatti. Ma quella storia del
ricatto, del brutto giro in cui sarebbe finito negli ultimi tempi ha iniziato ad
affiorare dalle testimonianze di alcuni amici, dalle chat del telefono
analizzate dagli investigatori. Quel turbamento che non ha saputo superare,
diventato insormontabile - di colpo - alla sua età, avrebbe contribuito a
maturare la scelta di gettarsi sotto un treno al confine tra Torino e
Moncalieri. In quest' ottica - e con una inquietante logica - tornano in mente
le parole raccontate dal padre a La Stampa in una recente intervista: «Nelle
ultime settimane mi aveva detto che aveva paura di un paio di persone. Mi aveva
raccontato di essere stato minacciato, ma non aveva aggiunto altro. Forse per
timore. Gli avevo chiesto chi fossero. Gli avevo proposto di incontrarli con
lui, di avere un confronto. Ma Orlando minimizzava. Diceva che non era il caso.
Gli avevo anche chiesto se dovesse dei soldi a qualcuno. Di spiegarmi quale
fosse il problema, che l'avremmo affrontato insieme. Però i suoi atteggiamenti
non sembravano allarmanti e così gli avevo consigliato di pensare alle vacanze».
Il giovane sarebbe partito a breve per trascorrere i mesi estivi in Calabria. L'
inchiesta - per istigazione al suicidio - è a un bivio. La pista del giro di
prostituzione in cui il giovane sarebbe caduto senza riuscire a uscirne
rimanendo intrappolato in un ricatto troppo complesso da affrontare per
chiunque, amplierebbe peraltro la sfera dei reati ipotizzati.
La storia si ripete. E
puntualmente la storia si è ripetuta. Questa volta al centro delle cronache c'è
la morte tragica di Orlando Merenda, un ragazzo di appena 18 anni che ha deciso
di togliersi la vita a Torino. Immediatamente è scattata la corsa a dare subito,
in modo affrettato, un movente a quel gesto. A sinistra è partito il coro di chi
voleva collegare ad ogni costo questa morte al bullismo omofobo tirando la
volata al Ddl Zan. Eppure, secondo quanto riportato dagli inquirenti, sarebbe
già caduta l'ipotesi che il gesto estremo di Orlando possa essere collegato a
offese o insulti per il suo orientamento sessuale. I primi a strumentalizzare la
morte di Orlando sono stati proprio gli esponenti del mondo Lgbt politicizzato:
"Diamo la nostra solidarietà alla famiglia di Orlando Merenda, suicidatosi a 18
anni, gettandosi contro un treno perchè vittima di omofobia", ha affermato
Fabrizio Marrazzo, portavoce nazionale del Partito Gay per i diritti LGBT+. E
ancora: "Siamo stufi di sentire solidarietà dalle istituzioni, quando avvengono
fatti tragici come quello di oggi, ma in realtà mancano azioni concrete e
quotidiane - ha dichiarato Davide Betti Balducci, candidato sindaco di Torino
per Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale - la
lotta al bullismo ed alle discriminazione è uno dei punti principali del nostro
programma, per dare maggiori tutele ai nostri studenti ai nostri cittadini, per
fare si che casi come quello di Orlando non si ripetano più". E la musica non
cambia se ad esempio si leggono le parole di Mario Perantoni, presidente della
commissione Giustizia alla Camera e parlamentare M5s: "Continuano le violenze
omofobe. Siamo ad un bollettino quasi quotidiano di casi anche estremi, come
quello del suicidio del giovane Orlando. Eppure la destra insiste nella sua
campagna di bugie, continuando a dire che nel ddl Zan sono previsti reati di
opinione: è falso, l'opposizione alla legge nasce da un oscurantismo ideologico
che penalizza i diritti delle persone LGBT ed ha il terrore di affrontare certe
tematiche. Si approvi il testo al Senato, il parlamento dia questa prova di
responsabilità".
Dem in prima fila. Anche dalle
parti del Pd non si sono certo lasciati sfuggire l'occasione. Con un comunicato
congiunto, la segretaria metropolitana del Pd di Milano, Silvia Roggiani e il
responsabile dei Diritti, Michele Albiani hanno affermato: "Storie come queste o
come quella di Orlando che, a soli 18 anni, si è tolto la vita, molto
probabilmente perché sopraffatto dall'omofobia, dimostrano il clima pericoloso
di intolleranza, che sta crescendo nel nostro Paese. E, nonostante tutto, c'è
ancora qualcuno che lo nega. C'è ancora chi dice che non serve una legge. Una
legge serve eccome. Serve per punire chi pensa che sia uno scherzo insultare due
persone dello stesso sesso che si tengono per mano. Nessuno di noi resti in
silenzio, adesso c'è bisogno di dire tutti insieme che il tempo è finito e va
approvato il disegno di legge Zan". Ebbene sul fronte delle indagini ora si va
in altre direzioni. La stessa procura che indaga sulla morte di Orlando usa
prudenza. Come riporta il Corriere, in un primo momento le attività di indagine
si sono concentrate su omofobia e bullismo. Poi la svolta: il fascicolo aperto
dal pm Antonella Barbera ipotizza il reato di istigazione al suicidio. A quanto
pare negli ultimi tempi il ragazzo era molto turbato. A raccontarlo è stato il
fratello Mario: "Aveva paura di qualcuno...". Ma non finisce qui: alcuni amici
hanno parlato di un "brutto giro" e di un "ricatto" che non riusciva più a
sopportare. Di certo in questa sede non vogliamo certo trovare le cause di
questo gesto estremo. Un gesto che solo la prudenza e la serietà delle indagini
chiariranno. Non certo le uscite ideologiche a sinistra che servono solo a fare
(ancora una volta dopo Seid) di una morte il simbolo di una battaglia politica.
Ignazio Stagno. Nato a Palermo
nel 1985. Palermitano prima di tutto, a Milano da quasi 10 anni. Dal 2015 lavoro
per il sito de ilGiornale.it. Due passioni: il Milan e le sigarette. Un solo
vizio: la barba lunga.
La Serie A difende i gay ma
non da chi li uccide: la vergogna, ecco il logo fatto ad hoc per gli arabi.
Andrea
Morigi su Libero Quotidiano il 29 giugno 2021. Mancherebbe soltanto una versione
arcobaleno in versione araba e la battaglia per i diritti lgbtq+ diventerebbe
globale. La Lega Calcio di Serie A però non ha avuto il coraggio di osare tanto
e si è limitata a rendere variopinto il proprio logo solo sul profilo twitter in
italiano, inglese e spagnolo. Le comunicazioni in lingua araba destinate ai
Paesi islamici rimangono rigorosamente tinte di azzurro e con una scritta
tricolore dello sponsor Tim, tranne pochi retweet in inglese. Forse avevano
finito i pennarelli, ironizza il pubblico che ha notato la differenza di stile.
In realtà sono rimasti a secco per un problema culturale che riguarda non solo
il Medio Oriente, ma anche l'Africa, il Brunei, le Isole Maldive e in genere
tutti gli Stati i cui ordinamenti giuridici si fondano sulla legge coranica e
dove le autorità vietano la celebrazione del Gay Pride: l'omosessualità è un
reato punito in vari modi. Se molti, come in Indonesia, prediligono le frustate
e in Iran invece hanno ormai adottato la consuetudine dell'impiccagione per chi
viene condannato per atti di sodomia, altrove, come nei territori governati
dal Califfato o dai Talebani, vi sono varianti locali, tutte ispirate alla
lapidazione per gli atti impuri: il colpevole viene in qualche gettato dal tetto
di un edificio preferibilmente alto per favorirne lo sfracellamento, oppure va
immobilizzato vicino a un muro che poi sarà abbattuto da un bulldozer
rovinandogli addosso fino a ucciderlo. Forse sarebbe il caso di sensibilizzare
quei popoli e le loro istituzioni civili e religiose a una maggior tolleranza
nei confronti del vizio, piuttosto che prendersela con l'Ungheria. Al Parlamento
di Budapest si sono limitati ad approvare una legge che tutela il diritto dei
genitori a educare i figli in conformità con le loro convinzioni religiose,
filosofiche e pedagogiche, come recita la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea. E proprio da Bruxelles li attaccano come omofobi. Le
pressioni internazionali nei confronti dell'Italia, affinché approvi il disegno
di legge Zan, che si trasformerebbe in un attacco alla libertà educativa dei
genitori, sono speculari. Ma si preferisce prendersela con le presunte ingerenze
della Santa Sede, che si è limitata a ricordare le «esigenze della libertà di
religione, insegnamento ed espressione», come ha sottolineato il segretario di
Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin. Per tutta risposta, sabato scorso al
Gay Pride di Milano qualcuno ha messo in scena una rappresentazione della salita
al Calvario, messa in scena da un uomo travestito da donna. Del resto, dai
cristiani non c'è da temere una rappresaglia violenta per gli atti di blasfemia.
Semmai la cronaca è piena di atti di terrorismo compiuti da musulmani, come nel
caso di Charlie Hebdo o delle vignette satiriche danesi su Maometto e il
Corano. L'accusa di islamofobia fa notevolmente più paura dell'omofobia. Perciò
contro il Qatar, che ospiterà i prossimi mondiali di calcio, nessuno si permette
di protestare e nemmeno contro gli Emirati Arabi Uniti, le cui linee aeree
sponsorizzano almeno una squadra di serie A italiana. Gli sceicchi non
minacciano vendetta, ovviamente, ma si sa che hanno a disposizione cospicue
ricchezze e detengono importanti partecipazioni azionarie in società
occidentali. Vedere calare gli investimenti esteri dal mondo arabo si
rivelerebbe economicamente più dannoso di un eventuale boicottaggio da parte
della comunità gay. La scelta di essere forti con i deboli e deboli con i forti
può anche trasformarsi in una pratica politica. Si traduce nel cedimento alla
logica del ricatto. E non in un progresso civile.
"Bullismo etico della
sinistra". Ricolfi demolisce il ddl Zan.
Martina Piumatti il 6 Luglio
2021 su Il Giornale. Il ddl Zan, la prepotenza della sinistra che non è più di
sinistra e la destra che è diventata “un po’ di sinistra”. Lucido, diretto,
spesso tranchant. Luca Ricolfi all’establishment progressista piace poco.
“Pochissime recensioni, nessuna intervista, rari inviti in tv”. Fuori dai
salotti che piacciono alla gente che piace, ma teme il “confronto di idee”.
Mentre a citare come faro dell’indipendenza di pensiero il sociologo, da sempre
di sinistra, ci pensa la destra. Un ribaltamento di ruoli ormai evidente nella
politica spaccata in due sul ddl Zan. Da una parte, una sinistra prona alla
prepotenza progressista, che ‘bullizza’ chi non si sottomette ai suoi diktat.
Dall’altra, la difesa della libertà di espressione che diventa prerogativa di
una destra sempre “un po’ più di sinistra”.
Il ddl Zan dovrebbe approdare
in Senato entro la metà di luglio. Ma la scia di polemiche che lo accompagna è
lontana dall’essere archiviata. La sua posizione a riguardo è netta: l’ha
definito il “cavallo di Troia del politicamente corretto”, cosa intende?
"Intendo sottolineare il suo
carattere proditorio. Basta leggere i disegni di legge precedenti, Zan-Annibali
e Scalfarotto-Zan, entrambi ragionevoli e accettabili per chiunque (destra
compresa), per rendersi conto che con il ddl Zan la cosiddetta comunità LGBT ha
visto una ghiotta occasione di imporre a tutti la propria, specifica e
minoritaria, visione del mondo: un atto di pura prepotenza culturale".
Quale tra gli “effetti
aberranti” del disegno di legge teme di più?
"L’articolo 1, il più temuto
anche dal mondo femminista, perché scatenerebbe un uso opportunistico della
scelta soggettiva del genere, con i carcerati che chiedono il trasferimento nei
reparti femminili, gli atleti 'ex maschi' che gareggiano con le atlete, e più in
generale l’assalto ai benefici di genere, ossia riservati a uno dei due sessi. E
poi l’articolo 7, che apre le porte all’indottrinamento degli scolari e – nella
misura in cui sancisce per
legge che il genere è una questione di scelte soggettive – rischia pure di
suscitare dubbi, e innescare crisi esistenziali, in un periodo della vita molto
delicato per qualsiasi ragazzo o ragazza".
C’è bisogno davvero di una
legge ad hoc contro l’omotransfobia o in fondo basterebbe l’impianto vigente?
"Prima di rispondere alla
domanda, mi consenta una riflessione linguistica. Le parole con il suffisso
'fobia' (paura), tipo omofobia, transfobia, ma anche xenofobia, andrebbero
completamente bandite dalla legge penale, e sostituite con parole che utilizzano
suffissi derivati dal greco 'misein', odiare, come correttamente già avviene
quando si parla di misoginia (odio verso la donna), o di misantropia (odio
contro gli esseri umani). Già è assurdo e illiberale sindacare sui sentimenti,
ma è ridicolo demonizzare la paura. In una società libera ognuno ha il diritto
di provare i sentimenti che vuole, e stigmatizzare la paura è semplicemente un
non senso".
Quindi serve o no?
"Dipende. Se si accetta che lo
strumento per combattere le discriminazioni e la violenza sia la legge Mancino,
non si può non riconoscere che quella legge è incompleta, perché dimentica
omosessuali e transessuali, nonché una caterva di altre categorie talora oggetto
di atti aggressivi più o meno gravi: ad esempio i disabili, i barboni, i bambini
'diversi' in quanto grassi, timidi, secchioni, con pochi like,
eccetera. Ma, più ci penso,
più mi convinco che il difetto stia nel manico, cioè nella legge Mancino, ovvero
nell’idea che per combattere violenza e discriminazioni la strada sia quella di
moltiplicare le categorie protette: l’elenco delle categorie degne di
protezione, infatti, è arbitrario e potenzialmente illimitato".
Quanto c’è di vero
nell’endorsment della sinistra? Intercetta un’istanza sentita dalle masse o
insegue i trend dettati da un’élite di pseudo influencer?
"La seconda che ha detto".
Lei che conosce bene le pieghe
della società, qual è lo sfondo culturale che ha trasformato, proprio ora, la
legge contro l’omotransfobia in una necessità? In fondo la sinistra è stata al
governo dal 2013 fino al 2018, poteva farlo prima…
"Forse conosco 'le pieghe
della società', ma ignoro quasi del tutto quelle della politica. Perché sono
stati fermi nel 2013-2018? Mah, forse pensavano di non avere i voti al Senato,
forse non volevano irritare il Vaticano, forse erano troppo impegnati sul
versante dei migranti. Insomma: non lo so".
Ma non è che per essere sempre
‘più civili’ diventeremo sempre meno liberi? Penso anche alla polemica
sull’inginocchiarsi o meno. Chi non lo fa viene considerato automaticamente
razzista…
"Siamo già molto meno liberi
anche di solo 20 anni fa. Io noto questa differenza: nell’ultima parte del
secolo scorso il politicamente corretto era un modo di affermare la propria
superiorità morale, nel XXI secolo sta assumendo tratti intimidatori. È un
passaggio sociologicamente molto importante, perché segnala una pericolosa
mutazione dell’establishment progressista. Ieri si accontentavano dell’egemonia
culturale, oggi aspirano al dominio. Dalla 'maestrina dalla penna rossa', al
prepotente che umilia chi non si sottomette. Dal pavone al bullo. È per questo
che, oggi, io non parlo più di 'razzismo etico' (una espressione coniata
vent’anni fa da Marcello Veneziani), ma mi sento costretto a parlare di
'bullismo etico'".
Se chi vota (a giudicare dai
sondaggi impietosi) e soprattutto una parte, le nuove leve, dentro il Pd si
sgola per dire che le battaglie sono altre, perché la sinistra insiste?
"Perché la base sociale della
sinistra, da almeno 30 anni, sono diventati i 'ceti medi riflessivi' (così li
battezzò lo storico Paul Ginsborg), e la sua base popolare in parte è scomparsa
(con il restringimento della classe operaia), in parte è stata ceduta alla
destra, che difende il lavoro autonomo e il diritto delle periferie ad aver
paura dell’immigrazione".
Non è un po’ il solito
“complesso dei migliori” in cui cade la sinistra: “Solo noi sappiamo cosa è
giusto e ve lo imponiamo, democraticamente”?
"In realtà, come accennavo
prima, al complesso dei migliori è subentrata la prepotenza dei paladini del
bene. Ma non è strano, se si evidenziano tutti i passaggi. Dopo il 1989 c’è
stata una saldatura fra l’establishment politico-finanziario, che vuole solo
globalizzazione e frontiere aperte, l’establishment mediatico, che vuole solo
intrattenimento, internet e buone cause (dal riscaldamento globale al Black
Lives
Matter), e l’establishment
politico progressista, che vuole solo espandere il proprio potere per guidare il
cambiamento sociale. Avendo quasi tutti i poteri forti dalla propria parte,
l’establishment progressista si è fatto più aggressivo: non gli basta dire 'noi
siamo moralmente superiori', ora pretende di stabilire come dobbiamo parlare,
come dobbiamo comportarci, a quali valori dobbiamo inchinarci".
Creando delle categoria
protette il paradosso è che la discriminazione rischia di essere doppia: per chi
ne è fuori, ma anche per chi è dentro, in un certo senso ghettizzato come specie
da tutelare. Neri, donne, omosessuali non sono semplicemente persone?
"È così, e molte femministe lo
hanno capito. Forse l’effetto sociale più importante del ddl Zan è stato di
spaccare il mondo femminista".
Dalle favole riscritte al
linguaggio declinato in chiave inclusiva: l’attenzione, a volte ridicola, nel
proteggere queste categorie per non urtarne la sensibilità le protegge davvero?
"È difficile valutare quale
sia il saldo fra gli effetti di protezione e quelli di umiliazione. Quel che
però mi sembra indubbio è che ci sono anche effetti negativi sui non protetti:
la protezione speciale accordata a determinate categorie, inevitabilmente
suscita il risentimento delle categorie escluse. E poi c’è l’effetto perverso
del linguaggio politicamente corretto: a forza di proclamare che non devi dire
negro ma nero, non devi dire handicappato ma diversamente abile, non devi dire
cieco ma ipovedente, automaticamente metti in mano ai portatori di cattivi
sentimenti un armamentario di parole contundenti che prima – quando Cesare
Pavese parlava tranquillamente di negri, e Edoardo Vianello esaltava i Watussi
'altissimi negri' – semplicemente non c’erano, perché quelle parole erano
neutre, puramente descrittive. È come se, a un certo punto, qualcuno avesse
deciso che per ogni cosa che nominiamo, debbano esistere due termini, uno
rispettoso e l’altro irrispettoso, anziché un solo termine neutro: come si fa a
pensare che sia una buona idea?".
Poi, però, la difesa a spada
tratta non vale sempre. Su Saman la sinistra ha taciuto, perché?
"La sinistra ha un occhio di
riguardo per l’Islam, e le persone di sinistra coraggiose e intellettualmente
oneste (come Ritana Armeni, che ha denunciato il silenzio sul caso di Saman),
sono troppo poche".
Ma la strumentalizzazione ad
uso e consumo della politica può essere un boomerang. Come nel caso di Malika,
la ragazza lesbica ripudiata dalla famiglia ‘usata’ come eroina pro ddl Zan.
Poi, si è scoperto che con i soldi raccolti per sostenerla si è comprata auto di
lusso e cani di razza. Anche qui tutti zitti da sinistra. Dice che avranno
imparato qualcosa?
"No. L’incapacità di imparare
dall’esperienza è uno dei tratti del software mentale dell’establishment
progressista".
Lei ha dichiarato di essere
stato abituato a pensare che la censura fosse “una cosa di destra” e che la
difesa delle libertà di opinione, di pensiero e di espressione fossero “ben
incise nelle tavole dei valori del mondo progressista”. Ora ha cambiato idea?
"Il trionfo del politicamente
corretto, ma soprattutto l’autocensura in atto da anni fra scrittori,
giornalisti, artisti, intellettuali, mi hanno costretto a prendere atto che
sinsitra e libertà di espressione sono diventate due cose incompatibili".
Il ddl contro l’omotransfobia
del centrodestra, con Licia Ronzulli come prima firmataria, tutelerebbe meglio
la libertà di espressione?
"Ovviamente sì, ma non
abbastanza. Finché non si riscrive la legge Mancino la libertà di espressione è
in pericolo, perché quella legge lascia in mano ai giudici la facoltà di
stabilire se una certa idea determina oppure no il 'concreto pericolo' di azioni
violente o discriminatorie".
Lei che è dichiaratamente di
sinistra viene citato spesso dalla destra. Come vive la cosa?
"Potrei dirle, citando una
frase di Alfonso Berardinelli del 2005: 'non credo che la sinistra sia di
sinistra'. Ma c’è una risposta più radicale, che mi trovo costretto a darle: la
realtà è che alcune, fondamentali, bandiere della sinistra sono passate a
destra".
Quali?
"Almeno tre: la libertà di
espressione, chiaramente insidiata dal politicamente corretto; la difesa dei
veri deboli, che oggi sono innanzitutto i membri della 'società del rischio',
ossia le partite Iva e i loro dipendenti, esposti alle turbolenze del mercato ed
ora decimati dal Covid; e poi la parità uomo-donna in politica, un tema su cui
la sinistra è addirittura retrograda. Le sembra possibile che, in tanti decenni,
non sia mai emersa una leadership femminile a sinistra né in Italia né in
Europa? È mai possibile che un elettore che auspicasse un premier donna sia
costretto, oggi come in passato, a guardare a destra? In Europa tutti i
leader-donna importanti degli ultimi 50 anni sono di destra: Margareth Thatcher,
Angela Merkel, Marine Le Pen, Marion Le Pen, Theresa May, Ursula von der Leyen,
Giorgia Meloni. Come possiamo credere in una sinistra in cui tutti i posti
chiave sono occupati da maschi?".
E se gliel’avessero detto
trent’anni fa, che sarebbe diventato simbolo di libertà di pensiero per la
destra contro le degenerazioni ideologiche della sinistra?
"Non ci avrei creduto,
trent’anni fa. Ma vent’anni fa, quando scrissi La frattura etica e cominciai a
lavorare a Perché siamo antipatici?, forse sì".
Da sinistra però qualche
nemico se lo sarà fatto per le sue 'sparate' politicamente scorrette?
"Mi spiace che lei le
definisca 'sparate', io di solito mi baso sui miei studi, e sono piuttosto
analitico, poco umorale. Anche se, questo lo ammetto, non ho peli sulla lingua.
Quanto ai nemici a sinistra, non saprei. Quel che mi succede è semplicemente di
essere ignorato. Pochissime recensioni, nessuna intervista, rari inviti in tv.
L’establishment di sinistra, fatto non solo di politici ma di giornalisti,
scrittori,
conduttori televisivi,
operatori culturali, si comporta come se avesse paura del confronto di idee, e
forse anche per questo si è così spesso lasciato spiazzare dai cambiamenti della
realtà".
Ma soprattutto: quella
italiana, il Pd di Letta si può ancora definire sinistra?
"No, non è sinistra, ma non è
nemmeno destra. Il Pd di Letta è semplicemente establishment, nient’altro che
establishment".
Lei si riconosce in questa
sinistra o no?
"No".
Non sarà davvero diventato di
destra?
"No. È la destra che è
diventata un po’ di sinistra". Martina Piumatti
Chiara Ferragni e Fedez, se
sul ddl Zan superano Letta a sinistra.
Riecco la coppia dei miracoli
contro il compromesso sull'omotransfobia (ma ci sarà un motivo se le femministe
sono contro la legge, no?) Francesco Specchia su Libero Quotidiano il 09 luglio
2021.
Francesco Specchia, fiorentino
di nascita, veronese d'adozione, ha una laurea in legge, una specializzazione in
comunicazioni di massa e una antropologia criminale (ma non gli sono servite a
nulla); a Libero si occupa prevalentemente di politica, tv e mass media. Si
vanta di aver lavorato, tra gli altri, per Indro Montanelli alla Voce e per
Albino Longhi all'Arena di Verona. Collabora con il TgCom e Radio Monte Carlo,
ha scritto e condotto programmi televisivi, tra cui i talk show politici
"Iceberg", "Alias" con Franco Debenedetti e "Versus", primo esperimento di talk
show interattivo con i social network. Vive una perenne e macerante
schizofrenia: ha lavorato per la satira e scritto vari saggi tra cui "Diario
inedito del Grande Fratello" (Gremese) e "Gli Inaffondabili" (Marsilio), "Giulio
Andreotti-Parola di Giulio" (Aliberti), ed è direttore della collana
Mediamursia. Tifa Fiorentina, e non è mai riuscito ad entrare in una lobby, che
fosse una...
Rieccoli all’attacco. Riecco
i Ferragnez in versione arcobaleno, nella consueta posa da templari del Ddl Zan,
mentre la legge contro la omostransfobia s’arrampica su sentieri legislativi
tortuosi, ostacolata dal centrodestra, dal Vaticano e dal Renzi Matteo che butta
un occhio al proprio elettorato cattolico e l’altro al suo nuovo palcoscenico.
Dunque, avviene questo. Di prima mattina l’influencer da 20 milioni di
followers Chiara Ferragni pubblica, a raffica, tre stories su Instagram immerse
nella denuncia sociale e nel dileggio del Palazzo. Nella prima storia, in
particolare, svetta una foto di Matteo Renzi con sopra la scritta “L’Italia è il
paese più transfobico d’Europa” (cosa, peraltro non vera); e il commento: “Che
schifo che fate politici”. Che suona un po’ come “quelli che la politica è una
roba sporca” della canzone di Enzo Iannacci sul qualunquismo. E spiegazione
dello “schifo” non è esattamente un articolato di legge: «La triste verità è che
nonostante una legge che tuteli donne, disabili e persone appartenenti alla
categoria lgbtq+ serva nel nostro paese e sia attiva nel resto dell’Europa da
decenni, in Italia non verrà mai approvata perché la nostra classe politica
preferisce guardare sempre il proprio interesse personale. La tutela contro
l’odio verso queste categorie dovrebbe essere un obiettivo di tutta la
popolazione e di tutti i partiti politici e il fatto che il ddl Zan non verrà
probabilmente mai approvato è una grande sconfitta per tutti noi. Una sconfitta
per ognuno di noi». Renzi che nei social ci zampetta assai, viene tramortito
dall’impeto di Ferragni, e replica su Facebook: “Fa bene Chiara Ferragni a dire
quello che pensa. Solo che da lei mi aspettavo qualcosa in più di una frasina
banale e qualunquista”. E continua il segretario di Italia Viva: “Da una persona
che stimo mi aspetterei un confronto nel merito. Perché sapete chi fa davvero
schifo in politica? Fa schifo chi non studia, chi non approfondisce, chi non
ascolta le ragioni degli altri, chi pensa di avere sempre ragione”. Non che
Renzi abbia tutti i torti. Anche perché pur il senatore ribadendo e articolando
tutti i punti su cui Iv chiederà la modifica del ddl Zan –ossia gli articoli 1,4
e 7 su definizione di genere, libertà d’espressione e autonomia delle scuole
cattoliche- non riesce ad ottenere dalla Ferragni che una silente indifferenza.
Renzi si dice anche “pronto a un dibattito pubblico con la dottoressa Ferragni,
dove vuole e come vuole. Sono sempre pronto a confrontarmi con chi ha il
coraggio di difendere le proprie idee in un contraddittorio. Se ha questo
coraggio, naturalmente”. Ma pare che Chiara, impegnata nella pubblicità di un
prodotto per capelli di cui è testimonial non abbia questo coraggio. O forse,
banalmente, non ha tempo. L’indifferenza è l’ultimo terrore, scriveva Tommaso
Landolfi (e Renzi, all’indifferenza, è molto sensibile). Ma ecco, ad un tratto,
intervenire Fedez, nelle veci della moglie, stavolta via Twitter. “Stai sereno
Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la
pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia”, dice il rapper. Ce ne
fosse uno che usasse lo stesso social. Reazioni politiche? Pochissime, la
materia è incandescente. C’è giusto l’ipercattolico Mario Adinolfi: «Con il mio
nuovo look fresco e estivo mi rendo conto di non poter competere con lo stile di
Chiara Ferragni e del marito Fedez. Allo stesso modo, consiglio ai suddetti
d’adottare messaggi dubitativi quando s’occupano di politica, evitando il
qualunquismo e accettando il confronto». E neppure Adinolfi ha torto. Anzi, in
questa ennesima querelle, dal loro punto di vista, avrebbero tutti ragione. Ha
ragione Chiara Ferragni nel dire che non c’è interesse della classe politica ad
attuare una “legge di civiltà”; pure se non ha interesse nemmeno la sinistra ad
andare al voto in aula senza modifiche, a testa bassa, senza avere i numeri, col
voto segreto (anche perché se passa così è un trionfo ma se non passa la colpa
sarà comunque di Renzi e di Salvini). E ha ragione Renzi quando richiama l’arte
del compromesso in politica e dice che è meglio una legge lievemente modificata
che nessuna legge (d’altronde le Unioni civili sono nate stralciando la
stepchild adotion, e pure il Concordato e lo Statuto dei lavoratori sono stati
il frutto di accordi). La differenza tra la coppia shakespeariana dei social e i
politici che “fanno schifo” sta nel fatto che per i primi non puoi pensarla
diversamente da loro che subito ti scaraventano addosso la forza d’urto dei
propri followers. Ma, in realtà, cari Fedez e Ferragni, servirebbe far
transitare le idee. Per esempio: vi siete chiesti se passasse l’interpretazione
dell’art.1 della Legge Zan che fine farebbero le quote rosa? Ci sarà un motivo
se molte femministe sono incazzatissime contro lo Zan? Dite che Renzi in Senato
ripudia il testo che aveva firmato alla Camera? Certo, ma non era intervenuta la
Santa Sede col suo elettorato. Magari la politica farà schifo, ma se la si
prendesse sul serio ho idea che varrebbe della marca di una lacca o di legioni
di followers…
Fedez e Chiara Ferragni,
figuraccia colossale sul ddl Zan: per chi scambiano Ivan Scalfarotto.
Libero Quotidiano
il 10 luglio 2021. Figuraccia colossale per Fedez e la consorte Chiara Ferragni,
ormai divenuti paladini della sinistra pro-ddl Zan. Peccato però che sulla legge
contro l'omotransfobia la coppia di influencer sappia ben poco. È bastata
la diretta Facebook tra il rapper, Pippo Civati ex deputato dem della
Brianza, Marco Cappato ed Alessandro Zan, il promotore della legge, a
dimostrarlo. "Nell'imbarazzo - spiega Il Tempo -si ritrova, l'onorevole Zan, a
dover spiegare al Lucia (cognome di Fedez), quelli che sono i meccanismi
parlamentari difendendo pure Matteo Renzi". Il quotidiano romano parla di
continui "strafalcioni". Uno a caso? Il marito della Ferragni scambia Ivan
Scalfarotto, deputato renziano, per un giornalista. Non solo perché poi il
rapper si lascia andare a difese ridicole: "Mia moglie è una imprenditrice e
dice ciò che pensa come cittadina italiana. Renzi è invece pagato dagli
italiani". E ancora: "Che Renzi voglia confrontarsi con mia moglie, è qualcosa
di imbarazzante". E in effetti, visto il livello...La nota più divertente della
diretta è però il siparietto che vede coinvolta proprio la Ferragni che a un
certo punto manda un messaggio in diretta, ricordando a tutti quanti,
l'importanza del dibattito in corso: "Ciao Fede amore mio, che fai? Mi saluti in
diretta?". Chiarissimo.
Da "liberoquotidiano.it" l'11
luglio 2021. Un Vittorio Sgarbi da prendere, ritagliare e incorniciare. Un video
postato sui suoi canali social in cui punta il dito contro Fedez, nuovo "totem"
del Pd e della sinistra. Un video in cui punta il dito anche contro quel Pd che
rifiuta ogni tipo di dialogo sul ddl Zan, affidando nei fatti la sintesi della
propria posizione proprio al rapper più amato dalle bambine che, in modo
grottesco e impresentabile, si sta "spacciando" come punto di riferimento
politico. Eh già, i compagni sono messi male. Malissimo. "Una volta si chiamava
dialogo - esordisce Sgarbi -. E iniziarono a dialogare due omosessuali, l'amico
Zan e l'amico Ivan Scalfarotto. Quest'ultimo poi è andato in Italia Viva, dunque
si è contaminato con quell'eterosessuale di Matteo Renzi. Perché oggi non si
possa far ancora dialogare i due appare incomprensibile. Salvo che a Fedez...
uno statista, un grande personaggio, uno che ha espresso grandi teorie sulle
teorie dell'uomo. Invece è uno stronz*** malc*** che ha scritto canzoncine
dimenticabili, si è sposato con una donna molto fortunata e decide di fare
politica in Italia. Quindi Scalfarotto è uno str***", picchia durissimo il
critico d'arte. Quindi Sgarbi ricorda il caso di Rosamaria Sorge, esponente del
Pd, che per essere "politicamente scorretta" con Scalfarotto si è rivolta a lui
affermando: "Froc*** di mer***". E Sgarbi commenta: "Se ci fosse il ddl Zan
sarebbe già in galera". E ancora: "Nessuno vuole condannare nessuno, ma il
dialogo cos'è? Persone che parlano per trovare punti comuni. Ma Fedez crede in
maniera irrevocabile e definitiva solo a Zan. Scalfarotto gli fa schifo perché
ha osato toccare quell'eterosessuale di Renzi". "Non si può dialogare, bisogna
ascoltare Fedez". Quindi Sgarbi riprendere un'intervista di Ettore
Rosato a Libero, colloquio in cui l'esponente di Italia Viva ricorda proprio
come il Pd stia rifiutando ogni tipo di dialogo e mediazione sul ddl Zan. E
Sgarbi rincara: "Non si può dialogare, bisogna ascoltare Fedez. Mi pare che sia
precisa la posizione di Rosato: il dialogo. Tutta la vita ci hanno parlato di
dialogo. Ora abbiamo il monologo di quel mona di Fedez. Ma vaff***, ma vaff***",
conclude un monumentale Vittorio Sgarbi.
Francesco Olivo per "la
Stampa" il 9 luglio 2021. Più degli emendamenti poterono i post. Una storia, un
tweet, un video di pochi secondi può cambiare il codice penale e magari anche il
risultato elettorale. Per Elodie i politici «sono indegni». Per Chiara Ferragni
«fanno schifo». Alessandra Amoroso mostra la mano con lo slogan e l'hashtag
disegnato, Fedez attacca Renzi. Milioni di visualizzazioni, tantissimi like.
Segue dibattito, ma dura il tempo di una «storia» su Instagram. Emozioni molte,
e impegno, forse effimero ma molto diffuso. Al centro dello scontro c' è il ddl
Zan, il disegno di legge contro l'omo-transfobia, che è finito quasi da subito
dallo stenografico del parlamento alla popolarità, ormai non più virtuale, dei
social. Con gli influencer, grandi e piccini, che dominano la scena e i politici
costretti ad adeguarsi, quasi mai ribellandosi. Dietro ci sono rischi e
opportunità: un dibattito semplificato e superficiale, che però per la prima
volta non esclude la cosiddetta generazione Z, che volutamente evita la politica
dei partiti (spesso ricambiata) e diffida dei media tradizionali. I numeri
dell'Osservatorio di Buzzoole, una società che si occupa del cosiddetto
«influencer marketing», certificano la realtà: da gennaio a oggi sono oltre 12
mila i post pubblici degli influencer, etichettati con gli hashtag della
campagna a favore del disegno di legge (#ddlzan; #iostoconzan; #alessandrozan;
#leggezan). Le persone raggiunte, sempre secondo i calcoli di Buzzoole, sono 5,5
milioni. Così, se ci si limita a seguire la vicenda parlamentare di un disegno
di legge, si rischia di perdere il grosso dello scontro nel Paese. «Il ddl Zan
funziona molto bene sui social è un tema adatto per la costruzione di una
propria identità - spiega Nicoletta Vittadini, docente di Sociologia della
Comunicazione e dei Media Digitali alla Cattolica di Milano -, con una dinamica
polarizzata tipica del tifo, si è pro o contro e lo si esprime negli spazi
pubblici di oggi». Quello che appare chiaro è che questo modello non scomparirà
presto: «Non ce ne libereremo - dice Alberto Marinelli, professore di Sociologia
dei processi culturali alla Sapienza di Roma -, si è creato uno schema in cui la
politica, in forma più o meno consapevole, assume le forme delle piattaforme:
messaggi secchi, semplificati, a volte settari. I primi a capirlo sono stati
Trump e in Italia Salvini e ora la cosa si estende. I partiti non controllano il
dibattito, ma gli corrono dietro, cavalcandolo o al limite tacendo». Non è la
prima volta che l'introduzione o, come in questo caso, l'estensione dei diritti
provoca divisioni nel Paese, «ma nel caso dell'aborto o del divorzio - conclude
Marinelli - il Parlamento aveva la consapevolezza della propria centralità e i
partiti non rinunciarono a operare delle mediazioni». Proprio la difficoltà di
trovare compromessi, come emerso in questi giorni, «è la conseguenza
dell'aumento della polarizzazione e dello scontro tra tifoserie - spiega
Giovanni Diamanti, comunicatore politico, co-fondatore di YouTrend -, ma va
sottolineato che gli influencer avvicinano alla politica una generazione la cui
fiducia nei partiti è inferiore al 10 per cento. Sul ddl Zan in tanti stanno
partecipando per la prima volta al dibattito pubblico ed è un fatto rilevante».
L' allargamento del pubblico è il dato più rilevante, secondo Vincenzo Cosenza,
responsabile del marketing di Buzzoole, «sono molte di più le persone alle quali
arrivano le informazioni. Magari sono pochi quelli che approfondiscono, ma è
comunque un allargamento. La politica ora subisce la fascinazione, d' ora in poi
dovrà tenere conto degli influencer, le aziende già lo fanno da tempo». C' è poi
una nuova frontiera: i media si concentrano sulle "celebrities", «ma stanno
nascendo influencer impegnati su temi specifici, come l'ambiente e le questioni
di genere. Non hanno ancora il seguito dei più noti, ma stanno crescendo». «La
pandemia ha cambiato molte cose - conclude Vittadini -. Durante la pandemia gli
influencer hanno preso posizioni che sono state molto valorizzate, aiutando la
campagna di vaccini. Ora hanno un ruolo ed è impossibile non considerarli».
Chiara Ferragni contro
Renzi e Salvini: "Politici, fate schifo". Ddl Zan e insulti: "Sei hai coraggio,
parliamone".
Libero Quotidiano il 06 luglio 2021. Ci mancava solo Chiara
Ferragni contro Matteo Renzi. La polemica sul Ddl Zan spacca la sinistra e fa
guadagnare ai suoi leader una bella raffica di insulti. Per Matteo Salvini, due
piccioni con una fava. L'influencer, potentissima su Instagram, è da tempo
schierata insieme al marito Fedez a favore della legge contro
l'omostransfobia sostenuta dal Pd e difesa a spada tratta da Enrico Letta,
mentre il leader di Italia Viva si è schierato a favore
dell'alternativo Ddl Scalfarotto, alla ricerca di un "compromesso" con la Lega
per far passare "una buona legge". All'insegna del motto "piuttosto che niente,
meglio piuttosto". Ma la Ferragni non ci sta e sui social tuona, senza mezzi
termini, contro il Parlamento che non sa (o non vuole) decidere su un argomento
spinoso sì, ma molto sentito dai giovani. "Entra nel dibattito sulla Legge Zan
dicendo ai suoi 24 milioni di follower 'Che schifo che fate politici', con la
mia faccia - scrive su Facebook Renzi, in tutta risposta - Sono pronto a un
dibattito pubblico con la dottoressa Ferragni, dove vuole e come vuole. Sono
sempre pronto a confrontarmi con chi ha il coraggio di difendere le proprie idee
in un contraddittorio. Se ha questo coraggio, naturalmente". Già a maggio, al
famoso concertone, Fedez si era schierato a favore del Ddl Zan e accusando la
Lega di posizioni omofobe, per poi montare la polemica contro la Rai che a suo
dire aveva tentato di censurarne il monologo sul palco. "L'Italia è il Paese più
transfobico di Europa - è l'accusa ora della Ferragni -. Ed Italia viva (con
Salvini) si permette di giocarci su". La foto di Renzi e la scritta "Che schifo
che fate politici" era piuttosto inequivocabile. "Ho sempre difeso Ferragni da
chi la criticava quando postava dagli Uffizi o da chi vorrebbe minimizzare il
ruolo degli influencer - continua Renzi nella sua replica -. Lo faccio anche
oggi. Fa bene Chiara Ferragni a dire quello che pensa. Solo che da lei mi
aspettavo qualcosa in più di una frasina banale e qualunquista. Dire che i
politici fanno schifo è il mediocre ritornello di chi vive di pregiudizi. Da una
persona che stimo mi aspetterei un confronto nel merito. Perché sapete chi fa
davvero schifo in politica? Fa schifo chi non studia, chi non approfondisce, chi
non ascolta le ragioni degli altri, chi - incalza - pensa di avere sempre
ragione. Io ho firmato la legge sulle unioni civili, mettendoci la fiducia:
quella legge - ammonisce - dura più di una storia su Instagram. Per firmarla ho
preso insulti, ho rischiato la vita del governo, ho fatto compromessi".
Ddl Zan, Pietro Senaldi
contro Fedez dopo gli insulti a Renzi: "L'uomo delle caverne di Chiara Ferragni,
maschilista con la clava".
Libero Quotidiano il 06 luglio 2021. "Si scopre che anche le
menti più evolute e moderne hanno istinti da uomini delle caverne". Pietro
Senaldi, condirettore di Libero, interviene oggi sul botta e risposta tra Chiara
Ferragni - che ha attaccato Matteo Renzi perché non condivide le sue idee
sul Ddl Zan -, il leader di Italia Viva e il rapper Fedez. Senaldi ricorda che
"Chiara Ferragni è la più grande influencer italiana, una potenza economica,
mediatica in confronto alla quale Renzi è polvere sul comò". Il problema, è che
"anziché lasciarli dibattere fra di loro", puntualizza il direttore, "interviene
il John Wayne della situazione, il maschio forte: Fedez. Che subito tira fuori
tutta l'attrezzatura in difesa della moglie dicendo, con la consueta gentilezza
che 'Renzi piscia sulla testa degli italiani'". "Un comportamento, quello di
Fedez, che è maschilista", dice Senaldi che continua rivolgendosi direttamente
al rapper: "Tu sei sposato con la donna più potente d'Italia, lei critica
legittimamente un politico anche se lo fa in maniera ruvida, il politico
risponde in maniera più garbata di come è stato trattato, e tu subito devi
tirare fuori la clava". "Francamente è un po' ridicolo", puntualizza il
direttore Senaldi facendo notare che "siccome i Ferragnez non hanno grande
classe, prenderanno una bella lezione da Renzi". "Immagino che Agnese, la moglie
di Renzi, non risponderà in difesa del marito perché ha una classe superiore",
conclude Senaldi.
E Fedez risponde: "Matteo
stai sereno".
Rissa tra Renzi e i Ferragnez sul ddl Zan: “Banale e qualunquista
dire che i politici fanno schifo”. Vito Califano su Il Riformista il 6 Luglio
2021. Quel voltafaccia, quell’antipatico, quel machiavellico opportunista
di Matteo Renzi e di tutta Italia Viva. Chiara Ferragni, e il marito Fedez, per
brevità detti Ferragnez, si sono indignati per l’inversione a U di Iv sul ddl
Zan. “Che schifo che fare politici”, ha scritto l’influencer condividendo una
stories della pagina felicementelgbt che recitava: “L’Italia è il Paese più
transfobico d’Europa ed Italia Viva (con Salvini) si permette di giocarci su!”.
È scoppiato un caso, soprattutto sui social network, riguardo al disegno di
legge che sta agitando e dividendo la politica negli ultimi mesi. Renzi ha
risposto, ha proposto un dibattio. Fedez è intervenuto e ha rispolverato lo
“stai sereno” di renziana matrice e memoria, ai danni dell’allora premier e
attuale segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Il punto è sempre il
Ddl Zan dunque. Prevista oggi pomeriggio la calendarizzazione del disegno di
legge contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere,
identità di genere e abilismo. È stato approvato alla Camera nel novembre 2020 e
in impasse al Senato per l’opposizione di Lega, Fratelli d’Italia e parte di
Forza Italia. Il relatore è il leghista Andrea Ostellari. All’ultimo giorno e
momento disponibile Iv ha presentato i suoi emendamenti gettando scompiglio sul
ddl. Renzi & co. hanno proposto modifiche agli articoli 1, 4, 7 del testo di
legge, gli stessi fortemente contestati da Lega e Forza Italia. A firmare gli
emendamenti il capogruppo al Senato Davide Faraone e il capogruppo in
commissione Giustizia Giuseppe Cucca. I passaggi più delicati prevedono di
cancellare il riferimento all’”identità” di genere” e “tornare al testo di Ivan
Scalfarotto dove si parlava soltanto di omofobia e transfobia” e quindi il
rispetto “dell’autonomia scolastica” per quanto riguarda l’istituzione della
Giornata contro omotransfobia prevista dall’articolo 7. Italia Viva aveva votato
la legge alla Camera. Da qui il patatràc degli ultimi giorni. E l’indignazione
dell’influencer italiana più famosa al mondo, e tra le più famose al mondo in
assoluto, oltre che la più imitata e anche corteggiata, anche dalla politica,
sulla quale negli ultimi tempi non ha esitato a esprimersi, in particolare sulla
gestione della pandemia. “Fa bene Chiara Ferragni a dire quello che pensa. Solo
che da lei mi aspettavo qualcosa in più di una frasina banale e qualunquista.
Dire che i politici fanno schifo è il mediocre ritornello di chi vive di
pregiudizi”, ha osservato Renzi sulla sua pagina Facebook rispondendo alla
stories di Ferragni. “Io ho firmato la legge sulle unioni civili, mettendoci la
fiducia: quella legge dura più di una storia su Instagram. La politica è
serietà, passione, fatica: non è un like messo per far contenti gli amici – ha
aggiunto l’ex premier – Se Chiara Ferragni vuole confrontarsi sugli articoli 1,
4, 7 della legge Zan e sugli emendamenti Scalfarotto io ci sono. Se chiara
Ferragni vuole conoscere come funziona il voto segreto al Senato, ai sensi
dell’articolo 113.4 del Regolamento, io ci sono. Se Chiara Ferragni vuole
discutere, criticare, approfondire io ci sono. Ma sia chiaro. La politica, cara
Ferragni, è un’attività nobile e non fa schifo. E la politica si misura sulla
capacità di cambiare le cose, non di prendere i like”. Un dibattito tra un
politico, ex premier, contro un’influecer sarebbe sicuramente un inedito. I
dibattiti ormai vanno avanti d’altronde a colpi di post. E infatti: manco il
tempo di postare che è arrivato il post, decisamente più aggressivo, di
Fedez: “Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto
sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia”.
Fedez che pure si è costantemente espresso sul Ddl Zan facendo scoppiare un
mezzo caso sul palco del Primo Maggio, nell’ultima edizione, leggendo un
messaggio e accusando la Rai di averlo voluto censurare. Nessun accordo intanto
fuori dai social: alle 16:30 in Senato di voterà per calendarizzare il testo in
Aula per il 13 luglio. Italia Viva si è impegnata a votare tale
calendarizzazione con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali.
Il centrodestra avrebbe provato a portare a domani il voto di oggi. Niente da
fare.
Vito Califano. Giornalista. Ha
studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive
principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di
televisione e teatro.
Selvaggia Lucarelli? Se non
nomini Alessandro Zan ti bastona: "Non so se è peggio Chiara Ferragni o Matteo
Renzi", a cosa si è ridotta.
Libero Quotidiano il 06 luglio
2021. Poteva mai la sacerdotessa del giusto, ovvero Selvaggia Lucarelli,
esimersi dall'alzare il metaforico-ditino social e dire la sua sul caso politico
del giorno, ossia la presa di posizione di Chiara Ferragni contro Matteo
Renzi in primis ma anche contro Matteo Salvini? L'influencer, infatti, si è
spesa in un democraticissimo "che schifo i politici" riferendosi ai due, "rei" -
secondo l'insindacabile giudizio della Ferragni - di star brigando per limare il
ddl Zan, così come chiesto dalla Lega. Insomma, la Ferragni appiattita sulle
posizioni del Pd: vietato il dialogo, o il ddl Zan lo si fa così come chiesto e
imposto dalla sinistra o si fa "schifo", ci permettiamo di produrci in una
brevissima sintesi del pensiero della moglie di Fedez, il rapper più amato dalle
bambine il quale, parimenti, si è assai speso in favore del ddl Zan (tutti
ricorderanno la sceneggiata del presunto martire Fedez, quando gridò alla
censura contro la Rai in occasione del concertone del primo maggio, salvo poi
essere tutto tranne che censurato). Bene, e dopo queste lunghe e inevitabili
premesse, ecco che si arriva alla sacerdotessa del giusto. La sentenza di
Selvaggia Lucarelli, va da sé, piove su Twitter, laddove cinguetta: "Non so se è
peggio la Ferragni che 'CHE SCHIFO I POLITICI' dimenticando che anche Alessandro
Zan è un politico o Matteo Renzi che la invita a UN CONFRONTO", conclude la
Lucarelli. Se ne evince, insomma, che per certo Renzi le faccia schifo. Ma anche
la Ferragni, insomma, tanto giusta non è: si è addirittura dimenticata di
mettere tra le esenzioni a quel "che schifo" il piddino Alessandro Zan,
dimenticanza questa che, per la sacerdotessa del giusto Selvaggia, è più che
sufficiente per provare "schifo", nei confronti della Ferragni. La sacerdotessa
ha sentenziato...
Selvaggia Lucarelli
per "tpi.it" il 9 luglio 2021. Confesso che avevo paura di guardare l’incontro
Fedez/Civati/Zan/Cappato perché temevo la sensazione atroce che mi avrebbe
permeata in seguito. E in effetti la sensazione che mi permea dopo essermi
sorbita un’ora di Fedez è che siamo sempre troppo severi nei confronti di Matteo
Renzi. Che è quello che è, senza sconti, ma sa quello che dice, sempre. Il
problema insuperabile di Fedez è quello di non sapere mai nulla di quello che
dice oltre le 4 cose che gli segnalano le Fiorellino98 sul web o che si appunta
sulla mano come in terza elementare e di diffonderle, però, con il piglio del
rivoluzionario cubano. Mi ricorda un po’ Flavia Vento quando parlava di animali,
che a forza di sentirle dire scemenze pure quando nella sostanza aveva ragione,
si finiva per comprare un fucile a canne mozze per impallinare cerbiatti. Io una
volta dopo che ho sentito Flavia Vento dire che “Verrà un giorno che io sarò
premier, tutti saranno felici, i canili non ci saranno più e le guerre pure”, ho
mangiato una marmotta viva. E il bello è che Fedez ha fatto una figura
incresciosa giocando in casa con quei tre fuoriclasse amici di
Civati/Zan/Cappato, figuriamoci cosa potrebbe fare in un confronto con degli
avversari. Ti credo che rifiuta il caffè con Salvini. Roba che probabilmente
scapperebbe prima di aver girato lo zucchero come Sandra Milo chiamando
Ciroooooo e la Lega arriverebbe al 98 per cento, con voto della Boldrini
incluso. Come al solito, la moglie che si sottrae alla dialettica e
scrive banalità nelle sue storielle su Instagram senza rischiare nulla, è più
furba di lui. Conosce i suoi limiti, si ferma prima. Lui no. Lui si lancia con
la superba vanità dell’arruffapopoli, con un italiano zoppicante, con una totale
assenza di cultura giuridica e politica ma con indosso la maglietta del suo
podcast che vende come gadget perché “parlo di ddl Zan e la foto finirà nelle
home di tutti i siti, mica so’ scemo”. E quindi, in questa surreale diretta in
cui con le facce imbarazzate dei suoi interlocutori si potrebbero ricreare le
controfigure del pubblico di Sanremo durante “Dov’è Bugo?”, succede nell’ordine
che:
a) Fedez premette subito che
segue la politica, è appassionato, ha una coscienza civica e politica quindi lui
si interessa di questi temi e ha il diritto di parlare.
b) Che uno dice “e va bene,
parla”. Parla “Ora vi leggo una cosa che ha scritto il giornalista Scalfarotto”.
IL -GIORNALISTA-SCALFAROTTO. Cioè, Scalfarotto è da mesi sui tutti i giornali e
le tv prima per le dimissioni da sottosegretario dal governo assieme alle due
ministre, ora per aver rivisto la sua posizione sulla legge Zan, dopo che lui
stesso ne era stato firmatario. In questi giorni occupa la discussione politica,
la infiamma, è accusato da tutta la comunità Lgbt (o quasi) di essersi venduto a
Renzi e Fedez, l’appassionato di politica e il grande sostenitore della Legge
Zan, crede che anziché un deputato e sottosegretario sia un editorialista di
Libero.
c) Quando dice “il giornalista
Scalfarotto” a Zan viene la faccia di quello che non sa se correggerlo tipo
quando Di Maio ha detto che Matera era in Puglia e Emiliano ha suggerito “no, in
Basilicata” sottovoce, tipo anche un po’ ai bambini quando si stanno scaccolando
al ristorante e non vuoi sgridarli ad alta voce. Zan alla fine sceglie
saggiamente di fingersi morto e di farlo finire di leggere le parole del
giornalista Scalfarotto sperando che non citi anche la testata perché se poi
dice “sull’Unità di oggi” gli deve anche spiegare che l’Unità non esce più da un
po’.
d) Poi Fedez chiarisce che Zan
(?), Cappato e Civati gli piacciono perché fanno politica fuori dal palazzo e
allora uno dice “Accidenti, non conosce quelli che stanno nel palazzo, conosce
quelli che stanno fuori!”. Ma tu pensa.
e) Allora inizia a chiarire
finalmente quello per cui si sta battendo da quando sul palco del Primo Maggio
ci ha ricordato che i lavoratori ‘sti cazzi dello stipendio e dei licenziamenti
anche perché io so’ testimonial Amazon e devo distrarvi, devo sventolare il
drappo rosso sennò il toro incorna me. E allora uno dice: bene ora finalmente ci
spiega i nodi principali della battaglia.
f) Solo che lui non ha capito
niente del ddl Zan e, come la Meloni che però ha la faccia di dire “il gender
non so che sia”, non ha capito neppure cosa sia l’identità di genere. Notare che
l’identità di genere è il cuore del dibattito che vuole cavalcare, della legge
che sostiene, delle paure delle destre che lui schifa, dell’avversione nei
confronti della Legge che vuole venga approvata. E quindi Fedez, nella sua beata
ignoranza, afferma: “Ho visto un video bellissimo con una ragazza che ha in mano
la carta di identità e dice ‘guardate ho cambiato sesso!’, insomma, ha cambiato
la sua identità di genere!”.
Zan fa di nuovo la faccia di
Emiliano con Di Maio a Matera patria delle orecchiette con le cime di rapa. Ma
Zan è un uomo buono, un tollerante vero sennò avrebbe chiuso la diretta in tutta
fretta dicendo che aveva yoga e fa lo gnorri. Non gli spiega che l’identità di
genere è come uno si percepisce al di là di un eventuale percorso di transizione
e dell’eventuale cambio di sesso. Ma Fedez non lo sa, si crede beatamente
istruito e preparatissimo e sorride senza sospettare l’immane figura di merda
che ha appena fatto.
g) Poi comincia a discettare
di ego, di idea grandiosa di sé, di manie di protagonismo, di cose fatte non per
reale interesse ma per obiettivi altri e di una tendenza accentratrice. Si
riferisce a Renzi ma potrebbe tranquillamente parlare di sé, nessuno noterebbe
la differenza.
h) Poi è tutto un premettere
“io sono una mente semplice”, “io sono ignorante”, “io non so niente eh però”,
che uno dice: e allora visto che hai milioni di follower e vuoi parlare di
politica e diritti civili perché non vai a studiare e torni quando sai qualcosa,
per esempio?
i) Cappato, eroicamente, prova
a spiegargli che la questione del voto segreto è un po’ più antica e complessa
di come la mette giù lui (“io voglio sapere cosa votano i miei senatori di
riferimento!”), ma Fedez è troppo preso dallo stupore di aver scoperto come si
fanno i referendum, descrivendo i “banchetti per le firme” come unicorni rosa
volanti.
j) Quindi Fedez spiega che
tranquilli, lui e Chiara Ferragni non vogliono buttarsi in politica, ma parlare
di politica da cittadini. Che voglio dire, non avevamo dubbi: ce li vediamo i
due a rinunciare alle marchette milionarie per uno stipendio da parlamentari,
come no. Molto meglio “fare politica” conservando tutti i privilegi del caso,
mica scemi.
k) Poi cita Montanelli, che è
il giornalista più citato da tutti quelli che non l’hanno mai letto e più in
generale da tutti quelli che non hanno mai letto, e questa volta, al contrario
che con Scalfarotto, non specifica “giornalista”, quindi sarà stato convinto di
citare un ex segretario di partito.
l) Poi la grande chiusura:
“Renzi potrebbe far passare la legge Zan così si fa perdonare l’Arabia Saudita”.
E’ certo. Invece lui che va in vacanza con tutta la famiglia a Dubai, altra
culla del nuovo Rinascimento in cui i gay sono accolti con le collane di fiori
in aeroporto come in Polinesia, è già perdonato. Del resto, mica è un politico,
l’ha detto lui. È solo un gran paraculo. E no, non è nemmeno utile a cause che
spoglia di profondità, di spessore, di valore. Cause che veste di boria furba e
superficiale.
Del resto, per rimanere in
tema, è la percezione che ha di sé, il suo guaio, ma per capirlo dovrebbe
studiare cosa sia l’identità di genere. Lo farà con calma, magari dopo che una
legge di cui non ha capito nulla sarà approvata, chissà. Senza fretta.
Da liberoquotidiano.it il 7 luglio 2021. "A
fr****e di m***". Chissà Rosamaria Sorge, dirigente Pd ed ex candidata a
Civitavecchia, invocherà il diritto di satira oppure dirà di essere stata
fraintesa. Ma la frase scritta dall'incauta e improvvida esponente democratica
su Facebook scatena un nuovo psicodramma a sinistra sul Ddl Zan. Sono le ore,
caldissime, dello scontro tra Pd e Italia Viva sulla legge contro
l'omotransfobia. I dem non rinunciano al disegno il cui capofirmatario è il
deputato Alessandro Zan e vogliono lo scontro in aula, il voto che potrebbe far
approvare in Senato la norma, oppure affossarla clamorosamente. Dall'altra parte
ci sono i renziani, ufficialmente "compagni di coalizione" nel centrosinistra ma
in realtà nemici giurati, vuoi per agenda, vuoi per strategia politica vuoi per
semplici rancori personali. Matteo Renzi ha sganciato la bomba nei giorni scorsi
proponendo a Matteo Salvini e alla Lega una mediazione, "un compromesso per
portare a casa una buona legge" piuttosto che fare il gioco delle bandierine
ideologiche e rimanere, alla fine, con un pugno di mosche in mano (il rischio
che corre Enrico Letta, niente di più, niente di meno). Il terreno della
trattativa è rappresentato dal Ddl Scalfarotto, che prende il nome da Ivan
Scalfarotto, ex Pd e oggi tra i big di IV. Al Nazareno l'hanno presa malissimo,
accusano i renziani di tradimento, di voltafaccia a gay, lesbiche e trans
(avevano votato il Ddl Zan alla Camera, anche se in un contesto politico
totalmente differente), di inciuci con Salvini (ora, ma soprattutto in vista
dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica tra 6 mesi). E così le frasi
della Sorge, non certo una dirigente di primo piano dei dem, non possono che
scatenare la reazione piccata di quelli di Italia Viva. "Mi chiedo cosa ne pensi
Enrico Letta delle parole vergognose", chiede polemica su Twitter l'ex ministra
dell'Agricoltura Teresa Bellanova, pubblicando lo screenshot del post della
Sorge. "Non stiamo forse esagerando?". A voi la risposta.
Da repubblica.it il 7 luglio 2021. Non è finita.
Continua anche oggi lo scontro via social tra politici e influencer. I
protagonisti sono sempre i “Ferragnez” contro i due 'Matteo', Renzi e Salvini.
L'oggetto? Sempre il ddl Zan, che il 13 luglio sarà all'esame finale dell'aula
del Senato. Questa mattina Fedez è tornato sul botta e risposta a distanza tra
la moglie Chiara Ferragni e il leader di Italia viva. A colazione con la tazza
in mano, ha fatto una nuova storia su Instagram dove ha attaccato di nuovo
Matteo Renzi dopo la replica di ieri al commento di Ferragni ("Che schifo che
fate politici") sul Ddl Zan e l'invito da parte del leader di Italia viva ad un
dibattito sul tanto discusso disegno di legge. "Cogliere la bassezza della
politica italiana è vedere Matteo Renzi chiedere un dibattito pubblico a Chiara
Ferragni, questa è la cosa triste", commenta il rapper che chiede di non fare
più paragoni tra Renzi che "è un politico pagato dagli italiani per
rappresentarli" e la moglie che "è un'imprenditrice che non grava sulle tasche
degli italiani e che esprime un suo pensiero e può permettersi di farlo anche in
maniera banale''. I toni quindi non si abbassano. Oggi anche Matteo Salvini ha
lanciato la sua frecciata al rapper di Rozzano: "Renzi nel mirino di Fedez per
il ddl Zan? Mi piace l'ultimo pezzo ma io preferisco Orietta Berti". Tra i due
la tensione è alta da tempo, soprattutto dopo il Concertone del Primo maggio
quando dal palco Fedez ha attaccato il partito di Salvini sul disegno di legge
contro la omotransfobia accusando anche la Rai di censura. Ora Ferragni e, di
conseguenza anche suo marito, hanno puntato il dito contro Italia viva che ha
chiesto modifiche al testo come anche la Lega, altrimenti il disegno di legge in
Senato non passerà. "Meglio un compromesso che nessuna legge", ha dichiarato
Renzi in una intervista a Repubblica. ''Quello che mi stupisce è che ogni volta
che io e mia moglie ci permettiamo di esprimere un nostro libero pensiero sul
nostro paese è vedere questa distesa di intellettuali, politici e giornalisti
che, dandoci degli ignoranti a noi, non fanno altro che mettere sullo stesso
livello il pensiero di Chiara Ferragni e quello dei politici italiani", continua
il rapper su Instagram dove ha annunciato la diretta nel pomeriggio dedicata
proprio al Ddl Zan. "Per chi volesse approfondire cosa sta succedendo in Senato
- spiega - ho organizzato una diretta stasera alle 18.30 con Alessandro Zan,
Marco Cappato e Giuseppe Civati, voci più autorevoli della mia, che posso farvi
comprendere meglio quello che sta accadendo e che potrà avvenire''. Poi
rivolgendosi a Matteo Renzi chiede: "Ci tiene davvero al Ddl Zan o è il solito
parac... che ha sempre dimostrato di essere in questi anni di politica italiana?
Il voto segreto sul Ddl Zan è davvero necessario? Perché io, mente stupida,
semplice e ignorante da cittadino - dice ironico - vorrei sapere che cosa votano
i senatori che ci rappresentano per valutare il loro operato e allora perché
secretare il loro voto?''. Il leader di Iv risponde con la dedica che compare in
"ControCorrente", il suo ultimo libro: "'A chi in quelle ore difficili ha
creduto ancora in noi e a chi sa ancora riconoscere la differenza tra politici e
influencer'. L'avevo scritta un mese fa. Vedendo quello che sta succedendo in
queste ore sembra costruita a tavolino. O fai politica con le tue idee o segui
la massa e i populisti. Noi siamo ControCorrente", dice Renzi. Nel dibattito sul
ddl Zan interviene anche il segretario del Pd, Enrico Letta: "Nella legge di
Orban l'omosessualità è posta al livello della pornografia e la protezione dei
bambini è usata solo per discriminare dice @vonderleyen. Noi stiamo con Ue.
Salvini e Meloni con Orban. Come si può dar credito alle loro presunte proposte
di mediazione sul ddlZan???". Gli risponde direttamente il leader della Lega:
"Noi continuiamo a chiedere a Letta ascolto, confronto e dialogo, non è
possibile non voler ascoltare e andare allo scontro in aula che significa non
approvare nulla - dice a L'aria che tira estate su La7 - Letta parla
dell'Ungheria? Ma cosa c'entra l'Ungheria? Perché Letta scappa? Ha paura del
confronto, ha paura del Papa e delle associazioni gay e lesbiche che chiedono un
confronto?".
Piergiorgio Odifreddi per “La Stampa” il 7 luglio
2021. Sul ddl Zan gli schieramenti contrapposti sono da tempo al muro contro
muro, e ciascuno ha i suoi dubbi sponsor: Salvini e il Vaticano, da una parte, e
Fedez e la Ferragni, dall'altra. Chi abbia i modi eterei e raffinati di
quest'ultima, può dire semplicemente che "fanno schifo tutti", e finirla così.
Ma nel frattempo a scompaginare le carte si è intromesso pure Renzi, sul quale
si può peraltro pensarla allo stesso modo. Forse sarebbe però più sensato
evitare di fare la ola per l'uno o per l'altro, come se le vicende parlamentari
fossero un'estensione dei campionati di calcio. Sulle leggi non si dovrebbe
tifare per una squadra, ma ragionare tranquillamente sulla teoria e sulla
pratica di ciò che esse intendono regolamentare. La cosa sembra semplice, ma che
sia complicata lo ricorda un'osservazione che fece una volta Yogi Berra, il
famoso giocatore di baseball dal quale ha preso il nome l'Orso Yoghi. Berra era
famoso per pronunciare frasi enigmatiche, e una di queste era appunto: "La
teoria e la pratica, in teoria sono uguali, ma in pratica sono diverse". Ora, la
pratica del ddl Zan è che non ci devono essere discriminazioni di tipo sessuale:
ognuno ha il diritto di scegliere con chi avere dei rapporti sentimentali e
sessuali, e sono e devono essere soltanto fatti suoi. La teoria su cui il
decreto basa questa sacrosanta pratica, è invece la "dannata" ideologia di
genere: secondo i promotori, il diritto alla libertà sessuale si baserebbe
sull'affermazione che i sessi non esistono. O, se proprio esistono, comunque non
contano, perché a contare non è quello che uno è, ma quello che uno sente di
essere. In questa logica c'è però un "non sequitur". Si possono infatti
benissimo difendere i diritti dei diversi, senza dover per forza affermare che i
diversi non esistono. Anzi, forse si dovrebbe fare proprio questo: un mondo in
cui ci sono diversità è molto più bello e variegato di uno monolitico in cui
tutti sono uguali. In politica però le cose si ingarbugliano sempre, perché i
ragionamenti logici cedono il passo agli interessi partitici, che nel caso in
questione sono abbastanza chiari ed evidenti. Il Pd ha trovato nella difesa a
oltranza dell'identità di genere una battaglia considerata "di sinistra", la
Lega nel suo rifiuto a oltranza della stessa nozione una battaglia considerata
"cattolica", e Renzi nel suo ondivagare dall'approvazione alla Camera alla
disapprovazione in Senato un modo per diventare di nuovo visibile e determinante
nella scena politica. In realtà, sbagliano tutti. Sbaglia il Pd, perché semmai è
di sinistra la difesa dei diritti dei diversi, e non la professione di
un'ideologia che è stata contrastata, anche a sinistra, da tutti coloro che
credono che l'identità di genere non abbia senso. Ad esempio, le femministe, che
per poter essere tali devono appunto pensare di essere femmine. O i
transessuali, che per poter pensare di voler cambiare sesso, devono appunto
pensare di essere del sesso sbagliato, e di poter transire a un altro. Per non
parlare degli eterosessuali, che sono la stragrande maggioranza (secondo
l'Istat, superiore al 90%), e pensano semplicemente che i sessi sono i loro due.
Sbaglia la Lega, perché il cattolicesimo è variegato, e mentre esiste al suo
interno uno schieramento conservatore e ottuso, che rifiuta le unioni civili e i
diritti dei sessualmente diversi (schieramento che, a scanso di equivoci,
comprende anche il Papa regnante), esiste anche uno schieramento contrapposto
che la pensa al contrario, e che è l'analogo dei cattolici che nel 1974 votarono
a favore del divorzio civile, pur pensando che il matrimonio religioso dovesse
essere indissolubile. E sbaglia Renzi, perché non sarà certamente su un
argomento così marginale e di nicchia che un partito potrà basare la propria
diversità politica. L'identità di genere non è affatto un problema sentito dalla
maggioranza della popolazione, com'era appunto il divorzio negli anni '70. È
piuttosto un problema sentito da una minoranza della politica, che è disposta a
tutto pur di inserirlo in una legge: anche a non fare compromessi sulla difesa
dalla violenza sui diversi, che rischia di essere sacrificata sull'altare di
un'ideologia alla moda.
La diretta con Zan, Civati e Cappato.
Fedez contro Renzi su Instagram per il ddl Zan: ma il bastonatore finisce
bastonato. Aldo Torchiaro su Il Riformista il 7 Luglio
2021. Fedez è l’influencer che ha deciso di dimostrare plasticamente che la
quantità di follower non ha nulla a che fare con la quantità di informazioni in
gioco. Anzi, talvolta il bilancio è davvero magro. Nella diretta di queste ore
il cantante ha deciso di attaccare Matteo Renzi a testa bassa, forte di un
appunto di carta che ha tenuto accanto a sé durante l’improvvisato show. E lo ha
attaccato sul Ddl Zan, chiamando Alessandro Zan a fargli da spalla. Il senso
dell’attacco di Fedez? “Renzi non vuole questa conquista di civiltà. Cerca un
pretesto per non votare la legge Zan”. Come tutti sanno, fino a oggi Renzi al
contrario ha certificato nero su bianco il suo voto e quello di Italia Viva a
favore, ma messo tutti in guardia per i prevedibili agguati che il voto segreto
riserva a chi si avventura in Senato su questioni etiche. Fedez, a quanto pare,
non l’ha capito. “Renzi si è messo d’accordo con Salvini”, è quello che ripete.
Come? Quando? Perché? Non lo si dice. Ma si sarebbe accordato con Salvini per
far naufragare il Ddl Zan. Zan, che è presente, alza il sopracciglio. Non
obietta a muso duro ma si vede l’imbarazzo. Fedez non sa che Zan è stato eletto
in quota renziana, nel Pd a guida Renzi. Fu proprio il Matteo di Firenze a
volerlo in lista come esponente di punta del mondo Lgbt. “Ma Renzi ce l’ha con i
gay”, continua Fedez. E allora Zan lo ferma, ed obietta: “Veramente è quello che
ha realizzato la legge sulle Unioni Civili”. Allora Fedez guarda al foglio che
deve aver appeso accanto al telefono con cui va in diretta. “La ministra Bonetti
è di Italia Viva e non difende il Ddl Zan”. Il diretto interessato lascia
cadere, sempre più in imbarazzo. E allora Fedez chiama in live anche Marco
Cappato. L’esponente radicale si collega e sorride, ma inizia con i distinguo.
Non può essere Renzi l’obiettivo di tutto questo circo. “Renzi al Senato vuole
far votare i suoi con il voto segreto per affossare la legge”, va giù duro
Fedez. Cappato lo prende idealmente per mano, sorride ancora e spiega:
“Veramente non è Renzi, è che il regolamento del Senato prevede il voto segreto
sempre, per le questioni etiche”. Fedez non ha capito. Torna: “È perché si
vergognano a votare in modo diverso dalle indicazioni dei partiti”. Cappato è
gentile ma fermo: “No, si fa sempre così. È la prassi del Senato”. E gli tocca
precisare: “Renzi non ha detto una cosa sbagliata, ha fatto notare un rischio
reale, perché da Pd e M5S è lecito aspettarsi diversi franchi tiratori, che in
aula voteranno secondo coscienza e dunque contro il Ddl Zan”. Fedez non demorde:
“Bisognerebbe avere il coraggio di votare apertamente, di metterci la faccia”. A
quel punto anche Cappato alza le mani, capisce che non c’è partita senza avere
un playground su cui giocarla. “Ho letto un articolo del giornalista
Scalfarotto…” prova a dire Fedez disperato, arrampicandosi su specchi che non
ha. Ivan Scalfarotto è in realtà un parlamentare di Italia Viva, non un
giornalista. I fan si accorgono della mala parata e qualcuno commenta in
diretta: “Forse è meglio se non parli di politica, si vede che non ne sai”. In
effetti chi guarda si fa un’opinione piuttosto severa sul bastonatore che
finisce bastonato. A Fedez mancano alcune imprescindibili basi: la politica è
fatta di regolamenti, leggi, prassi, conseguenzialità, correlazioni, accordi,
disaccordi: parti di una strategia articolata e di lungo corso che contempla e
contempera mille cose. Non servono quarti di nobiltà, né doti particolari.
Bisogna però studiarli in controluce, i passaggi in filigrana di quelle leggi di
cui si parla. Piano piano, magari quando la diretta è finita.
Aldo Torchiaro. Romano e romanista,
sociolinguista, ricercatore, è giornalista dal 2005 e collabora con il
Riformista per la politica, la giustizia, le interviste e le inchieste.
Salvatore Dama per "Libero
quotidiano" l'8 luglio 2021. I "Ferragnez" non mollano il polpaccio di Renzi.
Dopo Chiara, che aveva dato dello "schifoso" a Matteo per aver ipotizzato un
compromesso che salvasse il ddl Zan (messo a rischio al Senato dalla prova di
forza di Enrico Letta), ora tocca a Fedez. Martedì lo aveva accusato di pissing.
Cioè di «pisciare in testa agli elettori» facendo passare la minzione per
pioggia. Ieri mattina il rapper è tornato alla carica definendo il leader di
Italia viva «un paraculo». E annunciando un dibattito nel pomeriggio sul suo
canale Instagram. Dibattito che in realtà si rivela a tratti un comizietto di
periferia, a tratti un processo in contumacia. Federico Lucia chiama al
confronto non Renzi, come magari era opportuno fare, ma Alessandro Zan,
promotore della legge sull' omotransfobia, e il radicale Marco Cappato. A
seguire, in uno dei quadrati della diretta Instagram, riciccia fuori anche un
vecchio nemico renziano sparito dal radar: Giuseppe Civati. Ed è subito effetto
"Primarie Pd 2013". Manca solo Gianni Cuperlo.
IN DIFFICOLTÀ Fedez lascia la parola ai suoi
interlocutori. Ai quali però fa delle domande. Dalle quali si intuisce tutta la
difficoltà della webstar con i regolamenti parlamentari. Lucia prova a spiegare
cosa sia il voto segreto: «È un non senso». Però poi, nel definirne il
funzionamento, si incasina. E lo aiuta Marco Cappato. Quindi Fedez sale di
livello. E tenta di spiegare ai suoi follower il referendum, ma si inceppa nella
differenza tra "costituzionale" e "abrogativo". Anche qui lo salva l'ex leader
radicale. Bocciato pure sulla cronaca parlamentare: «Non era Pillon il relatore
del ddl Zan?», chiede a Zan. Sbagliato: «Era Ostellari», lo riprende il deputato
democratico. C' è pure qualcuno fuori onda che prova a dargli qualche
suggerimento. Ma non è una cima manco lui. Il gobbo. «Però i politici non sono
depositari della politica», insiste il marito di Chiara Ferragni, «io cerco di
dare il mio contributo da cittadino, mettendo a disposizione la mia utenza», 12
milioni di seguaci, «a persone che possono dire qualcosa di interessante».
Purché siano contro Renzi. Visto che i suoi ospiti però non gli danno grande
soddisfazione (a parte un po' Civati), alla zeppa pesante ci pensa lui: «Voglio
lasciare un messaggino all' ego di Renzi: con il ddl Zan ha l'occasione di
riscattarsi, dopo aver fatto quell' elogio dell'Arabia Saudita, che non è
proprio un esempio sui diritti». Questa se l'era preparata. È chiaro. Nell'
attacco al Vaticano, invece, Federico trova la sponda di Cappato e un po' meno
quella di Zan: i dem non vogliono fare arrabbiare ulteriormente la curia romana.
A difendere Renzi interviene poi Ivan Scalfarotto, a SkyTg24: «La cosa singolare
è che Fedez pensi che sia lecito parlare di Renzi ma non con Renzi». Poi il
sottosegretario all' Interno ricorda quando il cantante nei suoi testi offendeva
i gay: «In passato su di noi ha detto cose terribili. Sono felice che ora Fedez
difenda le persone lgbt, che abbia cambiato idea».
VOTO SEGRETO Italia viva fa sapere che non
chiederà il voto segreto sul ddl Zan al Senato. Ma lo farà il centrodestra. Ed è
un bel problema soprattutto per il Pd. Perché non sono pochi i senatori dem che
hanno perplessità sul testo da votare. Ieri è venuto allo scoperto Mino Taricco:
«L' attuale testo presenta delle criticità e la necessità di alcune correzioni
nei punti più sensibili di cui molto si è parlato in queste settimane ed anche
in questi ultimi giorni». Pure lui cita gli articoli 1,4 e 7. Il paradosso è
che, con il voto segreto, potrebbe non venire meno il consenso di Italia viva,
ma quello del partito di Zan e Letta. Cosa che entrambi fanno finta di non
vedere. Apparentemente. Il segretario dem mette di nuovo nel mirino il leader
leghista: «Noi stiamo con l'Unione Europea. Salvini e Meloni con Orban». Matteo
replica così: «Noi proveremo col dialogo fino all' ultimo, se Letta vuole
affossare la legge, ci sta riuscendo». E su Fedez che attacca Renzi: «Mi piace
l'ultimo pezzo, ma io preferisco Orietta Berti…»
Guia Soncini per "linkiesta.it" l'8 luglio 2021.
C’è un momento in cui il marito della Ferragni dice «come diceva Montanelli», e
io penso ma tu guarda, che apertura mentale, non è più un vecchio porco,
razzista e pure pedofilo, è un saggio il cui pensiero è citabile dal club dei
giusti – e invece no. È solo che l’intersezionalismo non funziona, almeno non
l’intersezionalismo delle sinapsi, quello che mentre la giusta causa del mese è
la lotta alla transfobia pretenderebbe tu ti ricordassi di chi era il nemico la
settimana in cui la giusta causa era la lotta al sessismo, o quella al razzismo.
Ieri, dunque, è andata così. Che al mattino il marito della Ferragni ci ha
spiegato quanto siamo scemi a scrivere di lui e di sua moglie come avessero il
dovere di capirci qualcosa: mica sono politici, loro; e al pomeriggio ha
organizzato una diretta Instagram, con ospiti Alessandro Zan, Giuseppe Civati, e
Marco Cappato (che in confronto al resto dei convenuti pareva Churchill). La
moglie era a Cannes, e in diretta scriveva nei commenti, lasciava bandierine
arcobaleno o compitava solleciti «ciao amore». È stata, quella della diretta
Instagram dell’Harvey Milk che ci possiamo permettere, un’ora interessante non
per aspiranti giuristi o per preoccupati omosessuali, ma per studiosi del
concetto di personal branding. A un certo punto il marito della Ferragni dice:
«C’è un po’ di protagonismo, di voler mettere il cappello su questa storia». Sta
parlando di sé? Macché: sta parlando di Renzi, che incombe sulla conversazione
tra i quattro come neanche Rebecca la prima moglie. Poco dopo dice: «Non vorrei
che passasse la narrazione che un politico con manie accentratrici che non aveva
a cuore i diritti delle persone si mettesse il gagliardetto “io ci ho provato”».
Dice «politico», ma intende «influencer», è ovvio. A un certo punto mi viene in
mente Berlusconi, e la sua saggia convinzione che l’elettore sia un ragazzino
delle medie che non è neanche il primo della classe. I presenti, consapevoli
d’aver davanti uno con gli strumenti culturali d’un ripetente di seconda media,
col quale è tuttavia bene essere ossequiosi per non alienarsi i dodici milioni e
fischia di follower (trentamila che seguono la diretta, e dodici milioni che
senz’altro la recupereranno successivamente), fanno dei giri di parole per non
dirgli di ripresentarsi quando avrà studiato. Il marito della Ferragni dice che
loro sono su Instagram perché «non esiste un luogo depositario in cui parlare».
Nessuno gli chiede: intende «preposto»? Non è madrelingua? Non è paroliere? Il
marito della Ferragni dice che è scandaloso il voto segreto, l’elettore ha
diritto di sapere, e Civati aspetta mezz’ora prima di illustrargli il concetto
di libertà di coscienza con parole così semplici che secondo me sta pensando «Ti
faccio un disegnino». Il marito della Ferragni fa un esempio delirante per
spiegare l’identità di genere – una ragazza operata che fa vedere il documento
con scritto «femmina» – e mezz’ora dopo (cosa sarà mai mezz’ora, con la soglia
d’attenzione con cui guardiamo le dirette Instagram) arriva Cappato e dice che
la ragazza col documento problemi di identità di genere non li ha, il punto è
chi non s’è operato ma ha la sua brava disforia, è lui che dovresti tutelare
(nessuno dice «disforia», perché sono tutti abbastanza svegli da non usare
parole più complesse di «cane, pane, minestrina col dado»). Nell’articolare il
suo esempio, il marito della Ferragni aveva anche pronunciato la formidabile
frase «Identità di genere è: maschile, femminile». Che, considerato che
l’indispensabilità del concetto nell’articolazione della legge viene sostenuta
in relazione alla questione dei non binari, dimostra che il portavoce delle
giuste cause che ci possiamo permettere non ha capito quale giusta causa
sostiene. Il personal branding ti vuole sostenitore di buone cause, mica
informato sulle stesse: se non è Zeitgeist questo (mi permetto di dire
«Zeitgeist» perché ho meno pubblico della famiglia Ferragni: quando ti rivolgi
alla nicchia a volte puoi osare persino un quadrisillabo bisdrucciolo). È la
diretta del vale tutto, è evidente quando Zan dice «bisogna aiutare questi
bambini nel loro percorso di transizione», e lì non c’è non dico uno psichiatra
ma anche solo uno che abbia letto mezzo testo sul tema e sappia che la maggior
parte delle disforie infantili si risolve senza alcun bisogno di transizione. A
proposito di «non c’è uno»: sono tutti maschi (maschi cis, direbbero loro:
maschi nati maschi, orrendi colonizzatori e padroni dell’universo), ma nessuno
pare notarlo, o comunque non chi commenta «Questa diretta è un orgoglio
nazionale». Meno male che Cappato c’è, e prova a spiegare che la testa della
gente non si cambia a botte di codice penale, e che tuttavia da ’sta benedetta
legge si può solo sperare che cambi la testa di chi è così rincitrullito da
menare la gente per strada, non certo che uno pensi che non gli conviene menarti
perché gli danno sei anni di galera invece di quattro. Poco dopo arriva Civati e
dice «se una cosa è giusta e la fanno altri paesi europei», ed evidentemente i
suoi genitori non gli hanno mai spiegato che a loro non importava di cosa
facessero gli altri bambini, gli è rimasta la smania di emulare gli altri.
Sembra ieri che i suoi promotori dicevano che la Zan sarebbe stata la prima
legge di questo impatto in Europa: in un niente è diventata l’ultima. Il marito
della Ferragni dice che viviamo in «uno scenario distopico», e invoca
«l’opportunità di essere un pochino al passo coi tempi, di non essere
anacronistici», e non sta ipotizzando un paese in cui i gay possano adottare o i
paralitici possano trovar liberi i marciapiedi (ci sarebbe anche l’abilismo,
nella Zan, ma va meno di moda parlarne). Sta parlando solo di darci il permesso
di dirci maschi seppur con molte tette, ovvero di tutelare l’identità di genere,
quella cosa che lui crede sia «maschile, femminile». Va tutto bene. «Siamo ai
primi di luglio e già il pensiero è entrato in moratoria. Drammi non se ne
vedono, se mai disfunzioni», scriveva cinquanta estati fa Montale, che persino a
casa Ferragni avranno avuto nei testi delle medie. Zan, un altro che non è certo
lì per il personal branding, a un certo punto promette di dare il merito a Renzi
se la legge passerà, col tono con cui potrebbe dire che Bruto è un uomo d’onore
(scusate, lo so che alle medie non si fa Shakespeare). Intanto, sotto, passano i
commenti del paese reale che sta guardando la diretta che ci renderà un paese
migliore: «Ciao Fede mi saluti?».
Massimiliano Panarari per "la Stampa" il 7 luglio
2021. Renzi vs. Ferragnez. No, non è un peplum - quei film che furoreggiavano
nell' Italia balneare di qualche decennio or sono, stile Maciste contro Ercole
-, ma il rumore di spade e il clangore di trombe è il medesimo. Come lo sono le
botte da orbi che si sono scambiate l'influencer e il politico intorno al ddl
Zan. Il duello tra Chiara Ferragni e Matteo Renzi è un compendio degli effetti
del tracimare della disintermediazione, allorché la classe politica sempre più
sovente (e sconsolatamente) segue - un po' come l'intendenza. E un'istantanea
degli eccessi della celebrity politics, che ha fragorosamente abolito da tempo
le distinzioni di ambito professionale in materia di acquisizione della
popolarità e della visibilità nelle democrazie del pubblico, composto di
cittadini-consumatori, cittadini-elettori, cittadini-spettatori e "opinionisti"
a seconda delle tipologie dei media. E dove tra spettacolo e politica spesso
non vi è più alcuna soluzione di continuità. Esattamente come in queste «baruffe
chiozzotte» che si nutrono, infatti, della chiacchierata infinita che si svolge
sui social network. Solo che - per citare l'«antropologa del cyberspazio» Sherry
Turkle - non siamo dalle parti della «conversazione necessaria» del faccia a
faccia (che è stato fondamentale per portare in tanti casi la lotta politica a
convertirsi in dialogo tra i diversi), ma alla guerra simulata transmediale. E,
una volta di più, alla starizzazione della politica, alimentata da politici-star
contro star che si mettono a fare quella che può sembrare politica. Nella
fattispecie, la singolar tenzone è, ovviamente, smaterializzata. E, quindi, in
attesa di sapere se Ferragni, sfidata da Renzi a incrociare le lame de visu,
raccoglierà il guanto, per adesso la saga si può seguire solo via social. In un
tripudio di litigation e tifoserie, come tipico del processo di
hooliganizzazione da cui la politica viene pressoché istantaneamente assorbita
una volta trapiantata sui media sociali e "personali". Ovvero quegli strumenti
tecnologici che avrebbero dovuto garantire le sorti magnifiche e progressive di
una rinnovata partecipazione e «democrazia diretta», e hanno invece generato
soprattutto un'escalation di aggressività. A conferma del fatto che chi di
disintermediazione colpisce, può perire. O, quanto meno, si ferisce. Perché è
stato proprio l'attuale leader di Italia viva che, da segretario del Pd e
premier, ha spinto più in alto l'asticella della disintermediazione - insieme a
quella della personalizzazione - nel campo del centrosinistra. Infrangendo dogmi
e consuetudini per sintonizzarsi sullo spirito del tempo postmoderno e
antipolitico, ma scoperchiando così un vaso di Pandora che ha liberato potenze
incontrollabili. E ha prodotto un effetto boomerang che finisce per
ritorcerglisi contro, dal momento che nel mare magnum del web vale la stessa
regola sintetizzabile con le (presunte) parole pronunciate da Stalin al vertice
di Yalta: «Quante divisioni ha il Papa?». Che su Internet si chiamano milioni di
follower, come i 24 sonanti posseduti da Chiara Ferragni. Il match
Renzi-Ferragnez, quindi, è soltanto l'ultima pagina di una politica pop sempre
più mediatizzata in cui le barriere sono cadute da tempo, e si sconfina
"allegramente" alla ricerca dell'obiettivo fondamentale, che è di tipo
rigorosamente quantitativo. Un like non corrisponde precisamente a un voto (e
men che meno a uno ponderato), ma sempre e comunque di costruzione del consenso
si tratta per la campagna elettorale permanente di un partito (specie se non
baciato dalla fortuna nei sondaggi). Così come certe forme di impegno civico
degli influencer, a volte, danno l'impressione di essere l'equivalente della
voce «allargamento del mercato» di un business plan, o di risultare ispirate da
una forma opportunistica di marketing. Nel frattempo ci tocca così assistere
pure all'«istituzionalizzazione» di Instagram, diventato la "Quinta" o "Sesta
Camera" (ormai si è perso il conto...). Per Renzi, boxeur e pokerista, la
battaglia con i Ferragnez è una sorta di «piatto ricco, mi ci ficco», ancor più
perché alla vigilia dell'uscita di un libro (e il suo fiuto autopromozionale
oramai sopravanza parecchie altre cose che sarebbero più opportune per chi fa
politica). Ma dire - come ha fatto Ferragni - «che schifo che fate politici»
suona effettivamente come uno slogan populista (e pure, giustappunto, un po'
qualunquista). E, difatti, c' è chi scommette che il marito Fedez stia scaldando
i muscoli per inserirsi nel vuoto politico lasciato da un grillismo prossimo
alla smobilitazione.
«Politici fate schifo», Ferragnez
influencer da gabbia e da voliera. Carlo Fusi su Il
Quotidiano del Sud il 7 luglio 2021. LA STORIA insegna che “Politici fate
schifo” è il bramito più squisitamente qualunquista che ci sia. È ricorrente,
perché periodicamente riempie la gola di chi scaglia il proprio disprezzo verso
il Palazzo e ciò che rappresenta. Esempi vecchi e nuovi non mancano: il
dannunziano lancio del pitale sul Parlamento ad opera del pilota Guido Keller
nel novembre del 1920. O il cappio sventolato in aula a Montecitorio dal
leghista Luca Leoni Orsenigo il 16 marzo del 1993. Stavolta l’urlo è arrivato
via social dall’influencer Chiara Ferragni, moglie del rapper Fedez, già noto
per la polemica con Salvini e la Rai nel concertone del primo maggio. Il post
della signora Ferragni conteneva l’immagine di Matteo Renzi e il riferimento era
alla legge Zan e ai suoi tortuosi – e platealmente criticati – arabeschi
parlamentari. A condimento, la scritta “l’Italia il Paese più transfobico
d’Europa ed Italia Viva con Salvini si permette di giocarci su”, per togliere
ogni dubbio a chi ci si voleva riferire. Renzi ha replicato per le rime: per ora
la cosa è finita così ma non sono escluse repliche. Il punto di partenza
obbligato, come detto, è il singulto qualunquista – che naturalmente è cosa che
non c’entra nulla col diritto intoccabile di ciascuno di esprimere ciò che pensa
– che stavolta però assume una curvatura particolare. Negli anni, infatti, in
particolare per ciò che concerne i sistemi democratici, un simile riflesso
scattava quando andava in tilt il rapporto tra Paese reale e Paese legale.
Quando cioè il legame tra rappresentanti e rappresentati si deteriorava fin
quasi a spezzarsi e uno iato inquietante finiva per dividere i cittadini dalle
istituzioni. Adesso a quel binomio si è aggiunto un terzo attore, ossia la
dimensione social. Che è capace di, appunto, influenzare il dibattito pubblico
perché alimentato da personaggi che hanno una dimensione virtuale ma che sono in
grado di trascinare con loro milioni di utenti. Naturalmente i like sono
tutt’altro rispetto ai voti raccolti nelle urne, hanno una qualità e un peso
molto differente. Per loro natura sono più “leggeri”. Tuttavia sarebbe
sbagliato sottovalutare la capacità di orientamento degli influencer, che
passano con tranquillità dalla moda alla politica trascinandosi appresso i
tantissimi che si fidano di loro. Forse però il punto è proprio questo. La
distanza tra Paese reale e Paese legale veniva di norma riempita dalle elezioni:
il voto popolare ridisegnava i rapporti di forza tra i partiti e dunque
assegnava a quelli più in sintonia con l’umore dei cittadini il potere di
governare. Niente del genere avviene nell’universo digitale. I like vanno e
vengono con velocità non paragonabile ai voti, costruendo così una bolla
autoreferenziale che smarrisce il rapporto con la realtà. Il che fa sì che nel
perimetro social non solo si possano scatenare gli impulsi più primordiali e
dare in tal modo spazio ad eserciti di “odiatori” in grado di scegliersi di
volta in volta i bersagli. Quel che davvero conta è che la possibilità di
confronto ne risulta fortemente ridotta, in non pochi casi del tutto azzerata.
Uno dei riflessi condizionati del caleidoscopio social è che ritiene di
esportare la propria capacità di condizionamento sul mondo legale. Quando ciò
non avviene perché le regole della politica e il ruolo delle istituzioni hanno
finalità opposte e il compito specifico di favorire il confronto, di stimolare
la discussione e soprattutto di definire una sintesi finale da mettere nero su
bianco, allora il mondo social esplode. Per il semplice motivo che appare
evidente che la sua presa sul “reale-istituzionale” è inevitabilmente limitata.
Di qui il bramito, figlio di un ridimensionamento considerato inaccettabile. Se
si innesca una simile discussione, a questo punto di norma ci si trova di fronte
alla considerazione “però la politica oggi si fa così”. È una valutazione del
tutto legittima, ma parziale: bisogna aggiungere che in tal modo si avvelenano i
pozzi, anche se per onestà intellettuale va detto che quelli della politica sono
in forte via di essiccazione. Ma anche fosse, quell’essiccazione non può essere
considerato un alibi per nessuno. Per quanto screditata, infatti, la politica e
le modalità con la quale viene esercitata nel circuito della democrazia
delegata, rimane l’unico strumento – concreto, non virtuale – in mano ai
cittadini per far sentire la loro voce e, stavolta sì, influenzare direttamente
le scelte parlamentari e di governo. Solo rispettando questa mission e anche
tutelando la legittimità di chi la pensa diversamente è possibile ottenere
risultati che implementino la civiltà della vita sociale. Il mondo social
esercita una perversa attrattività perché fornisce la sensazione che le regole
si fanno e disfano praticamente a piacimento. E in caso di tracimazioni, nessuno
o quasi paga dazio. È possibile, e per alcuni casi persino doveroso, bannare.
Tuttavia si tratta sempre e solo di una parodia del meccanismo democratico.
Anche per gli influencer da milioni di follower succede che la realtà è altrove.
Fuori portata, o se si preferisce a distanza di sicurezza, dei like.
Luigi Mascheroni per "il Giornale" il 7 luglio
2021. La più grande impresa di Chiara Ferragni e del marito Fedez - in arte, e
business: «Ferragnez» - alla fine sarà quella di averci reso simpatico Matteo
Renzi. Anche se resta ancora da capire chi sia il più insopportabile fra i tre.
I primi due sono furbi. L' altro, cinico. E non si sa cosa è peggio. Solo in una
Repubblica 2.0 in cui la democrazia è fondata sui like invece che sui voti
poteva succedere che un ex presidente del Consiglio che gioca a fare il
ragazzino si mettesse a litigare sui social con due ragazzini che si credono gli
Obama. In mezzo: il Ddl Zan. Prima la influencer su Instagram accusa Renzi di
boicottare il decreto pro gender, aggiungendo: «I politici fanno schifo». Renzi
replica su Facebook: «Banale e qualunquista, parliamone se hai coraggio. Io ho
firmato la legge sulle unioni civili, mettendoci la fiducia: quella legge dura
più di una storia su instagram...». E alla fine, a chiudere il post, arriva
Fedez, fine politologo: «Stai sereno Matteo. C' è tempo per spiegare quanto sei
bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia». I
Ferragnez hanno rispettato la prima regola dei social: «Sapere poco, commentare
tutto». Renzi ha infranto quella della politica: «Mai scendere a livello dei
tuoi avversari». La celebre coppia dello spettacolo che da tempo si è buttata in
politica ha dimostrato di non avere idea di come sia fatta una proposta di
legge: ignora cosa sia un iter legislativo. Il famoso politico al quale è sempre
piaciuto dare spettacolo ha confermato di mancare di senso delle proporzioni: se
hai il 2% è suicida polemizzare con chi ha 24 milioni di follower. Come
l'ideologia da salotto e il fatturato dei clic possono battere l'intelligenza e
l'arte della politica. Ferragnez supremacy. E così, la Sinistra - che ha perso
il popolo e ha guadagnato le «celebrity» - riparte dai #Ferragnez: qualunquismo
(dire che i politici fanno schifo è solo un gradino sotto i Cinque Stelle),
populismo (aizzare i propri follower contro il nemico lo è) e grandi patrimoni.
L' élite all' italiana. I diritti civili ultimamente sono un trend sui social. E
i #Ferragnez sono un marchio. Il combinato disposto, oltre a aumentare i ricavi
della Ditta, influenza il dibattito pubblico. Probabilmente Enrico Letta ha
anche messo un «Mi piace» alle Instagram Stories dei due influencer...
Opportunismo commerciale, rap omofobo, unghiette arcobaleno e protagonismo
comunicativo. Non ne usciremo, nonostante tutto l'impegno di Mario Draghi. E per
il resto, se i #Ferragnez vogliono fare politica, come disse quel tale (di
Sinistra), fondino un partito. E vediamo quanti voti prendono! (Speriamo di no).
Giuliano Guzzo per "la Verità" il 7 luglio 2021.
Da quando domenica, in prima pagina su Repubblica, è uscita la notizia di alcuni
emendamenti da parte di Italia viva al ddl Zan, il clima festoso tra i
sostenitori della legge contro l' omotransfobia è improvvisamente venuto meno,
lasciando spazio a critiche velenose, frecciatine, perfino insulti. Così, dove
prima risplendeva l'arcobaleno, ora volano stracci. Ad accendere la miccia dello
scontro ci ha pensato direttamente il primo firmatario del ddl, Alessandro Zan.
Il deputato del Pd, in una diretta su Facebook lunedì pomeriggio, ha preso di
mira il partito di Matteo Renzi e, in particolare, l'idea di Italia viva di
espungere dal testo già approvato alla Camera a novembre il concetto di identità
di genere, riprendendo quelli di omofobia e transfobia contenuti nel ddl a suo
tempo proposto da Ivan Scalfarotto. Una proposta giudicata irricevibile. «La
locuzione "contro tutte le discriminazioni motivate da omofobia e transfobia"
del testo Scalfarotto», ha spiegato Zan, «non si può utilizzare da un punto di
vista giuridico. Perché in una proposta di legge si devono inserire termini
neutri, per garantire la tassatività dell'azione penale». «Per questo abbiamo
usato "identità di genere", "orientamento sessuale" e "sesso", che sono parole
che comprendono tutti», ha concluso il dem. Ora, a parte che il ddl Scalfarotto
fu firmato appena due anni fa pure dallo stesso Zan, il quale dunque dovrebbe
spiegare come mai ieri sottoscriveva proposte che invece oggi boccia così
sonoramente, comunque il parlamentare Pd sul punto ha ragione. Nel senso che, in
effetti, «omofobia e transfobia» sono termini che difettano di precisione e
univocità. Beninteso, la stessa identità di genere è in realtà un concetto di
vaghezza notevole - tanto che il suo significato ricade nell' inafferrabile
sfera delle «percezioni di sé» -ma non si può dire che «omofobia e transfobia»
siano parole il cui senso sia da tutti condiviso. Da tale constatazione, però,
scaturisce un dilemma di non poco conto, e cioè: perché allora questi termini,
così poco «neutri» da non poter rientrare in una norma a detta di Zan, possono
restare centrali sui media e, ancor prima, nel dibattito pubblico? L' ambiguità
non dovrebbe esser rifiutata sempre? L' impressione è che omofobia e transfobia,
proprio per la loro vaghezza, siano clave lessicali perfette in mano al
movimento Lgbt, che grazie ad esse può bollare in malo modo chiunque si opponga
ai diktat arcobaleno. Del resto, gli indizi che vanno in questo senso abbondano.
Per dire, nel marzo 2017 perfino Repubblica venne accusata di omofobia solo
perché in un articolo aveva definito «compagno» - anziché marito - il partner
del premier lussemburghese Xavier Bettel. A muovere l'accusa sul suo profilo
Facebook, manco a dirlo, fu proprio Ivan Scalfarotto. Lo stesso che oggi, per
aver detto che «il ddl Zan è un'ottima legge, ma senza modifiche non passerà», è
sotto il fuoco delle critiche. Per rendersene conto, basta farsi un giro su
Twitter, dove Scalfarotto è descritto in un modo al cui confronto Giuda
Iscaritota diventa un emblema di fedeltà: «Stai deludendo tanti di noi», «non ti
vergogni?», «ipocrita», «pagliaccio». Questo il tenore dei commenti grandinati a
decine sul suo profilo in queste ore. Per completezza, va precisato che i
critici non sono stati più teneri con Matteo Renzi. Contro l'ex sindaco di
Firenze e quanti osano giudicare emendabile il ddl Zan sono infatti scesi in
campo nientemeno che i Ferragnez. «Fate schifo», è stato il raffinato commento
della reginetta delle influencer postato sotto una foto di Renzi, mentre il
marito, per non essere da meno, ha rincarato la dose: «Stai sereno Matteo, oggi
c' è la partita. C' è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla
testa degli italiani dicendogli che è pioggia». Così, tra richiami urinari e
accuse di tradimento, sia Renzi sia Scalfarotto sono finiti nel tritacarne
social di chi osa dissentire dal verbo Lgbt. Il risultato è quindi che il ddl
Zan finirà nell'aula del Senato il 13 luglio, e non solo manca un accordo tra le
forze di governo, ma potrebbero davvero non esserci i numeri. Del resto, se si
pensa che l'ago della bilancia è ancora una volta nelle mani di Italia viva -
che, come dimostra il naufragio del Conte bis, quando si impunta poi son dolori
-, c' è da aspettarsi di tutto. Nel frattempo, per tornare a noi, non si può che
ringraziare Alessandro Zan per aver confermato che omofobia e transfobia sono
termini da prendere con le molle. Peccato che siano tra quelli che lui per
primo, ogni santo giorno, usa di più.
Pietro Senaldi a gamba tesa: "Fate una
legge per Renzi. Altro che gay, è lui l'unica minoranza che si può insultare".
Pietro Senaldi su Libero Quotidiano il 07 luglio 2021.
Bisognerebbe fare una legge che punisca il reato di Renzi -fobia. In questo
clima di tutela assoluta delle minoranze, i seguaci dell'uomo di Rignano e i
parlamentari di Italia Viva sono la sola minoranza che chiunque può insultare, e
perfino minacciare di morte, senza incorrere in sanzioni o reprimende. Eppure,
oggi in Italia i renziani sono molto meno degli immigrati, degli omosessuali o
dei disabili che vuole tutelare la legge Zan, almeno a guardare i trattamenti
Inps che vengono erogati. L'insulto a Renzi è di moda, lo si fa per sentirsi
democratici. E se il tapino si difende, si passa direttamente alla lapidazione.
Quanto successo ieri con Chiara Ferragni e Fedez è solo l'ultimo capitolo. La
premessa è che il Matteo di sinistra, come quello di destra, non condivide la
legge Zan e la vuol cambiare. L'influencer milionaria lo ha perciò insultato in
rete, postando la sua foto sopra la scritta «i politici fanno schifo». L'ex
potente ha risposto «parliamone» e per questo è stato investito dagli improperi
del marito della signora, un Fedez in versione John Wayne. «Matteo stai sereno,
guarda la Nazionale e smettila di pisciare in testa agli italiani» è stato il
civile messaggio del rapper che ama la libertà d'espressione al punto da
coltivare il vizietto di registrare a tradimento chi parla con lui al telefono.
Il macho dalla parte degli omo ha alzato la voce per perorare la causa della sua
donna come un bullo di periferia, malgrado la Ferragni sia in grado di
difendersi da sé. Al momento Renzi non gli ha fatto rispondere dalla moglie
Agnese, impartendo alla bella e al tatuato una lezione di stile. Non c'è da
stupirsi. Per aver successo sui social basta vedere cosa dice la massa e
ripeterlo con parole meglio confezionate. Se poi c'è un bersaglio facile, come è
Renzi, gli si spara contro con la maggior violenza possibile e il gioco è fatto,
si passa per maitre a penser sagaci, spietati e illuminati. Ci provano anche i
politici, solo che non sono del mestiere e per questo gli va sempre male quando
si scontrano contro i guru della rete. Il Pd lo ha capito meglio di tutti e
ormai si serve di cantanti, calciatori e influencer per fare politica. Si limita
a fornire loro l'obiettivo e questi sparano. Matteo Renzi è la preda preferita
dalla sinistra, ancora più di Salvini e della Meloni. Ma perché tanto odio?
Certo, Letta non gli ha perdonato di avergli fatto le scarpe con un messaggino
canzonatorio, il famigerato «Enrico stai sereno». La sinistra poi mal sopporta
che l'ex premier abbia cercato di usare il Pd come un tram e ora si faccia gli
affari suoi. Ma quello che i dem non possono tollerare è che l'ex capo levi loro
per la prima volta il pallino nella scelta del presidente dello Repubblica.
Letta e i suoi sono terzi o quarti nei sondaggi, dopo le scissioni hanno una
forza parlamentare del 14% scarso, ma ritengono di avere il diritto divino di
decidere chi deve andare al Colle. Solo che, se Renzi si mette di traverso, con
i grillini squagliati come sono, la sinistra non ha i numeri. La modifica della
legge Zan suona alle orecchie dei dem come un campanello d'allarme, una prova
generale di una nuova maggioranza, che oggi può cambiare la legge anti-omofobia
e domani scegliere il sostituto di Mattarella. Per esempio Draghi, un nome che
Letta dovrebbe trangugiare senza poter fare storie. Nel caso, chi sostituirà
SuperMario a Palazzo Chigi, un tecnico indicato direttamente dal nuovo capo
dello Stato, potrebbe essere poi lo stesso uomo che guiderà l'Italia del governo
di centrodestra che scaturirà dalle elezioni del 2023. Una figura di garanzia,
all'estero e in patria, inattaccabile dai soloni della sinistra.
(ANSA il 6 luglio 2021) - "Fdi
ha presentato in Parlamento una mozione per impegnare il Governo ad andare in
Europa per chiedere che la UE condanni apertamente gli Stati che prevedono nei
loro ordinamenti il reato di omosessualità e non stringa con loro accordi di
cooperazione culturale. Sono ben 69 le Nazioni che, spesso in virtù
dell'applicazione della legge coranica, prevedono pene variabili da un anno fino
all'ergastolo e alla pena capitale. Vedremo come si esprimeranno i cosiddetti
'paladini dei diritti Lgbt', che oggi chiedono di censurare le leggi rimasti in
silenzio quando si parla di difendere gli omosessualii"- Lo ha detto la Giorgia
Meloni.
Ddl Zan, cortocircuito:
"Vergognatevi, giù le mani dagli immigrati". Lesbiche contro gay pride: se ci
fosse già la legge...Libero
quotidiano il 24 giugno 2021. “Non aderiamo al Milano Pride perché nel suo
documento politico si avanza indirettamente la richiesta per noi inaccettabile
dell’utero in affitto. Il Milano Pride mette nero su bianco che le persone
omosessuali sono ‘costrette a migrazioni per costruire la propria famiglia. Lo
Stato italiano deve vergognarsi’. Ma secondo noi la vergogna è paragonare coppie
bianche, privilegiate e facoltose alle persone migranti”. Così in una nota
stampa Cristina Gramolini, presidente di Arcilesbica Nazionale. Insomma, siamo
al cortocircuito: la scissione delle lesbiche dal Pride di Milano. Uno strappo
che arriva proprio nei giorni in cui si discute del ddl Zan. Un'accusa, quella
della Gramolini, in cui si parla apertamente di discriminazioni. Insomma,
circostanza che potrebbe portare proprio all'applicazione della tanto discussa
legge. Curioso anche il fatto che il movimento delle donne si scagli contro
quello del Pride, che raccoglie tutto l'universo Lgbt, tirando in ballo gli
immigrati. Che vergogna, questa la sintesi del loro pensiero, paragonarsi ai
poveri migranti, voi uomini bianchi e ricchi che potete migrare all'estero per
coronare i vostri sogni. Pagando. Insomma, un assoluto e totale cortocircuito,
come accennato qualche riga sopra. “Il Milano Pride chiede anche che si possa
autocertificare il cambio anagrafico di sesso, trasformato in una ‘procedura
comunale’, questa per noi è una banalizzazione della transessualità e
altererebbe le statistiche (su gap salariale, violenze ad esempio) danneggiando
le donne in tanti i campi: quote, sport, pari opportunità. A noi- continua
Gramolini- importano i diritti lgbt+, i diritti delle donne e i diritti umani,
che devono progredire insieme in una sintesi responsabile e senza
mercificazioni. Per questo la nostra giornata di Pride a Milano sarà domenica 27
giugno con il convegno "Differenti, non escludenti", pieno di voci decise a
confrontarsi affinché continui la dialettica delle idee”. “Ascolteremo la
giornalista di Micromega Cinzia Sciuto, la filosofa Raffaella Colombo, la
scrittrice Monica Lanfranco, l’assessora del PD Irene Zappalà. E parleremo con
tante attiviste di nuovi diritti e falsi diritti, di realtà del sesso, di
necessari emendamenti al ddl Zan e di relazioni tra donne”, spiega ancora la
Gramolini. Intanto, Palazzo Marino si è acceso da mercoledì e fino a sabato coi
colori dell’arcobaleno proprio per il Milano Pride 2021. Per la prima volta
l’illuminazione dura quattro notti: dal tramonto fino all’alba la facciata della
sede istituzionale in piazza della Scala si tingerà dei sei colori della
bandiera arcobaleno.
Povia contro Fedez:
"Vergogna, il ddl Zan è una dittatura".
Federico Garau il 10 Luglio
2021 su Il Giornale. Povia attacca il ddl Zan e chiama in causa anche Fedez: "Ti
devi vergognare di dare spazio a questa gente. Se passa la legge rischiamo una
dittatura". Nuovo affondo di Povia contro il ddl Zan, durante il quale il
cantante attacca apertamente i sostenitori della proposta di legge con lo scopo
principale di tutelare i bambini e la loro innocenza. "Allora, guardate, se
l'evoluzione del comunismo e di tutta la sinistra si riconosce oggi in questa
gente, anni di lotta operaia, di lotta per la famiglia, di movimento
studentesco, articolo 18, sindacati in piazza...anni di Gramsci, di Togliatti,
di Hegel, di Marx, che non si sarebbero mai sognati di violare la mente dei
bambini...", esordisce polemicamente Povia in un video caricato sui social. "Per
carità, potete seguire questa gente, potete dargli spazio, tutti hanno diritto
allo spazio, ma non potete dirmi che quello che dicono è giusto". Il cantante
passa poi a tirare in ballo direttamente due dei principali protagonisti del
dibattito di questi giorni, in primis il collega Fedez: "Ti devi vergognare a
dare spazio a questa gente". Poco dopo Povia punta il dito contro il promotore
del disegno di legge: "Zan, lei si deve vergognare anche solo di proporre una
legge che imporrà ai genitori di accompagnare i bambini nell’altro sesso perché
si percepiscono opposti al loro sesso di nascita...bambini..." sottolinea con
enfasi mista a profondo stupore. "Ma i bambini sono spugne, sono registratori
perfetti di informazioni, quello che tu gli dici lo prendono per buono",
prosegue il cantante, rimarcando l'enorme rischio di compromettere l'innocenza
dei più piccoli. "Noi adulti abbiamo la capacità di capire che tutto questo è
una follia. Ma i bambini...i bambini comprati, venduti, imbottiti di farmaci,
informazioni sbagliate e influenze esterne. I bambini non hanno la capacità di
capire che state facendo un torto a loro e alla loro crescita spontanea e
naturale", affonda Povia. "Ma che fretta avete di colonizzare ideologicamente la
testa dei bambini? Eh no, caro Zan", dice rivolgendosi ancora una volta a colui
che ha dato il proprio nome al tanto contestato disegno di legge, "i genitori
oggi non sono fortunatamente più sensibili, li state confondendo con la vostra
propaganda ideologica, che nulla ha a che fare con il bene dei bambini. Mi
meraviglio proprio che venga discusso un testo così assurdo. E se passa",
dichiara preoccupato il cantante, "è invece l'inizio di una nuova dittatura".
Sulla difesa dell'innocenza dei più piccoli, Povia non transige: "Io posso
parlare perché ho scritto “I bambini fanno oh”, e ho scritto anche 'Dobbiamo
salvare l'innocenza'. Ma anche Giorgio Gaber, prima di morire, scrisse 'non
insegnate ai bambini la vostra morale malata e le vostre illusioni sociali",
conclude il cantante. Povia si era apertamente schierato contro il ddl Zan lo
scorso maggio, quando aveva spiegato che nel nostro Paese già esistono leggi in
grado di punire chi si macchia di reati connessi alla discriminazione
sessuale: "Nel 2013 a Napoli fu picchiato un ragazzo gay, sapete quanti anni di
galera hanno dato agli aggressori applicando la legge più l’aggravante? 10 anni!
Abbiamo 200mila leggi in Italia, di che stiamo parlando?".
Federico Garau. Sardo,
profondamente innamorato della mia terra. Mi sono laureato in Scienze dei Beni
Culturali e da sempre ho una passione per l'archeologia. I miei altri grandi
interessi sono la fotografia ed ogni genere di sport, in particolar modo il
tennis (sono accanito tifoso di King Roger). Dal 2018 collaboro con
IlGiornale.it, dove mi occupo soprat…
L'arcobaleno che nasconde
le purghe della sinistra.
Marco Zucchetti il 10 Luglio 2021 su Il Giornale. A sinistra non
si respira aria buona. Il clima intorno al ddl Zan, infatti, è ben più mefitico
e cupo di quanto le gioiose manifestazioni arcobaleno di piazza lascino
immaginare. A sinistra non si respira aria buona. Il clima intorno al ddl Zan,
infatti, è ben più mefitico e cupo di quanto le gioiose manifestazioni
arcobaleno di piazza lascino immaginare. Perché il paradosso è che una legge
nata per garantire libertà, sicurezza e uguali diritti a chiunque sta diventando
l'occasione per una caccia alle streghe e un ritorno delle «purghe» staliniane.
Con due differenze: in Urss finivano nei gulag gli oppositori di una dittatura;
ora finisce perseguitato sui social media e defenestrato dal consesso dei veri
progressisti (l'unico consesso con dignità umana secondo loro) chiunque sollevi
anche il minimo dubbio sul testo di legge, ormai diventato sacro e intoccabile
come Il Capitale di Marx, o il Corano. Nelle ultime settimane sono tante le
personalità - di certo non catalogabili come vicine alla destra - che hanno
provato a mediare, a sostenere la tesi del compromesso. Che è semplice e assai
di buonsenso: se giuristi, associazioni di femministe, filosofi, politici,
scienziati e perfino attivisti dei diritti degli omosessuali hanno espresso
riserve su alcuni punti della legge, forse è meglio metterci mano. Soprattutto
sul tema dell'identità di genere, sull'educazione gender a scuola e sulla
libertà di espressione. Meglio una legge che tuteli dalla violenza
omotransfobica di nessuna legge. Nulla di retrogrado o violento, dunque, eccetto
la reazione dei fondamentalisti, di cui il Pd lettiano è diventato guida
spirituale, tipo gli ayatollah. Chi ha provato a chiedere un'intervista a
qualcuno dei pochi che ha avuto il coraggio di esporsi in tal senso sui social
ha ricevuto cortesi rifiuti. Basta così, sul ddl Zan non voglio più dire nulla.
Come se si parlasse della Stasi, dei boss di camorra o del Grande Fratello di
Orwell. Zitto, la psicoZanpolizia ti ascolta. E la psicoZanpolizia fa paura,
perché in un attimo può distruggere la tua storia e devastare la tua carriera.
Poco importa che tu sia stato sostenitore dei diritti Lgbt da quando ancora il
Pci considerava tutti «deviati» o che tu abbia fatto approvare le unioni civili
omosessuali. Diventi nemico del popolo, omofobo. «Fai schifo», come insegnano le
squadracce dei Ferragnez, il braccio virtuale violento della legge (Zan). Poi,
se per caso sul tema voti contro la linea del partito, rischi di non venire
ricandidato, la tua patente di superiorità morale ti verrà stracciata in faccia.
E finirai i tuoi giorni accomunato ai leghisti che vogliono riaprire i forni
crematori per gli invertiti. La domanda è: ma perché dovrebbe fare schifo chi
vuole approvare una legge con una modifica? Perché si dovrebbe vergognare uno
scienziato fieramente ateo come Piergiorgio Odifreddi, che sostiene come «la
percezione psicologica del genere non è la stessa cosa della realtà
fisiologica», o Stefano Fassina di Leu, per cui «si lascia troppa
discrezionalità ai giudici»? Perché fare a pezzi un uomo di spettacolo come Luca
Bizzarri se scrive che forse la legge è scritta male e «a volte gli slogan e i
pasticci fanno più danni degli omofobi»? La risposta è sempre la stessa: perché
non si parla più di una legge, ma di un totem ideologico indiscutibile. Ragion
per cui non siamo più nel campo della politica, ma della religione più
oltranzista. Con i suoi inquisitori e le sue lettere scarlatte di infamia, i
suoi peccati mortali e i suoi roghi, i suoi eretici e la sua promessa di
dannazione eterna. No, nel Pd non si respira più, si consiglia di areare il
partito prima di soggiornarvi.
Gabriele Laganà
per ilgiornale.it il 9 luglio 2021. Sì all’approvazione del ddl Zan ma con
modifiche. L’ultima richiesta di correzioni del disegno di legge contro
l’omotransfobia non arriva da settori della Chiesa o da qualche esponente del
centrodestra bensì da Cristina Gramolini, presidente nazionale di Arcilesbica.
"Questo conflitto sulla legge Zan mi addolora", ha spiegato a Repubblica la
Gramolini. Quest’ultima ricorda di essere "attivista lesbica da una vita, ho 58
anni, insegno in un liceo, ma è da quando facevo la supplente che so cos'è la
paura: di essere discriminata, insultata, aggredita. Perciò vorrei che il ddl
venisse approvato: è importante che un Paese stabilisca che l'omotransfobia è
una cosa brutta, da punire in modo esemplare". Una lunga premessa che allude ad
un però. Ed è un però grande quanto una casa. Per la presidente nazionale di
Arcilesbica il ddl Zan va cambiato perché "così com'è non va bene". Una
posizione, questa, che già da tempo era stata evidenziata da Arcilesbica. "Lo
diciamo da mesi. Da quando il testo era in discussione alla Camera abbiamo
scritto, fatto delle riunioni con Alessandro Zan per spiegargli che in quegli
articoli ci sono grossi rischi di interpretazione che spalancano le porte a
scenari aberranti", ha ricordato la Gramolini. La presidente di Arcilesbica,
infatti, ha evidenziato che senza modifiche potrebbe verificarsi il caso che
"chi critica le persone che vanno all'estero a fare la Gpa" (in sostanza la
pratica dell'utero in afffitto, ndr) potrebbe essere denunciato per omofobia. Ed
i rischi sono concreti. Per evitarli basterebbe compiere modifiche del testo. Un
po’, ha spiegato la Gramolini, come ha fatto il governatore dell’Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini, che nel 2019 ha fatto una legge contro l'omotransfobia "in
cui c'è scritto chiaramente che la Regione non finanzierà quelle associazioni
che promuovono la surrogazione di maternità”. “Perché allora non inserirlo anche
nella norma nazionale?", si è chiesta la presidente di Arcilesbica. Modificare
il ddl Zan al Senato comporterebbe un nuovo passaggio alla Camera dove rischia
di arenarsi a causa dell'ingorgo di decreti e leggi. Una eventualità che la
Gramolini è disposta a correre viste le conseguenze che potrebbero derivare da
un’approvazione del testo così come è. Estremamente difficile considerare la
presidente di Arcilesbica vicina a Italia viva. Ma la Gramolini ha spiegato che
le considerazioni lanciate da Matteo Renzi sono codivisibili: "Senta, io vengo
dalla militanza in Rifondazione, non posso certo essere considerata renziana.
Però Renzi ha detto una cosa di buon senso: rivediamo i punti più controversi e
poi stringiamo un patto solenne fra tutte le forze politiche per approvarla
subito alla Camera. Mi pare che Lega e Fi siano d’accordo". Secondo la Gramolini
è "ottuso" pretendere di non cambiare il ddl "di un millimetro pur in presenza
di pesanti controindicazioni. Soprattutto sull'identità di genere". E questo è
un altro punto su cui insiste la Gramolini. La presidente di Arcilesbica vede su
questo tema un altro grande rischio: "Specificare che l'identità di genere è
"l'identificazione percepita di sé" anche se "non corrispondente al sesso"
significa aprire un varco all'autodefinizione legale di genere. Basta
dichiararsi donna all'anagrafe per diventarlo". Per la Gramolini ciò è sbagliato
perché "nuoce ai diritti delle donne, alle nostre poche quote, alle nostre poche
pari opportunità, ai nostri sport subalterni che non possono essere ceduti al
primo uomo che si alza un giorno e decide di dichiararsi femmina". Per rimarcare
il concetto la Gramolini prende d’esempio le Olimpiadi di Tokyo che inizieranno
tra pochi giorni: "Se un maschio dice che si sente donna e vuole partecipare ai
tornei, con la Zan lo può fare. Pensiamo a Valentina Petrillo, una trans
italiana che intende concorrere alle competizioni femminili". In sostanza, per
la presidente di Arcilesbica l'espressione "identità di genere" è "troppo ampia.
Basterebbe estendere la definizione di transessuale, già prevista da una legge
dello Stato, anche a quelli che sono nel percorso della transizione, non solo a
chi lo ha completato". In considerazione di tutto ciò la Gramolini ha spiegato
di ritenere questa "una cattiva legge" perché "minaccia i diritti delle donne e
ingenera solo confusione e problemi, aprendo a contenziosi legali a pioggia che
pagheremo tutti".
Legge anti-omofobia, i gay
si ribellano: "Casta di ottimati omosessuali, ce la vediamo in Tribunale".
Antonio
Rapisarda Libero quotidiano il 26 luglio 2020. «Sostengono a parole il fatto che
siamo tutti "uguali" e poi proprio loro creano una casta di "ottimati" Lgbt?
Rispetto alla quale è vietata, codice penale in mano, persino la critica?».
Finirà che per difendere gli insegnamenti di «Alessandro Magno o di Yukio
Mishima», omosessuali che «hanno garantito la continuità di imperi e ridestato
tradizioni», anche Mario Ravetto Flugy, gay e conservatore, 61enne e dirigente
di Fratelli d'Italia, se la vedrà in Tribunale. Tutto questo grazie al
cosiddetto ddl Zan: il controverso testo unico che intende perseguire gli atti
discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o
sull'identità di genere». Un paradosso? Lo stesso accadrà ad Umberto La Morgia,
31enne romano con la tessera della Lega in tasca, che in un video-denuncia
diventato virale spiega che sarà messo all'Indice come «omofobo interiorizzato»
per il semplice fatto di essere un gay che crede nella famiglia naturale. E che
dire, poi, di Giorgio Ponte - scrittore e insegnante - consapevole che con tale
dispositivo «pensano di aver trovato il modo per fermarmi»: ossia di bandire la
sua storia di omosessuale cattolico «come fanno i Black lives matter con le
statue». Non se ne sorprende, infine, Carlotta che dal Veneto racconta come fin
dagli anni di Sociologia si è sentita «più discriminata come donna di destra
dagli stessi militanti "arcobaleno" che come lesbica da tutti gli altri».
Sono quattro storie "diversamente omosessuali", quattro testimonianze raccolte
da Libero di quella maggioranza silenziosa che si oppone a fianco delle piazze
pro-family di "Restiamo liberi" al dispositivo della legge liberticida,
ammantata di anti-omofobia, targato Pd. Progetto che in realtà rappresenta per
tanti gay "non allineati", di destra, cattolici o conservatori, nient' altro che
l'arbitrio vetero-marxista e decostruzionista di una «classe sì ma di
privilegiati». Da Palermo Mario Ravetto, di destra fin dai tempi dei calzoni
corti, smonta alla radice l'allarmismo che sta alla base del ddl: «In Italia non
c'è mai stato odio contro noi omosessuali. Pensiamo solo che addirittura era un
tratto distintivo sotto l'impero romano...». A surriscaldare il clima, al
contrario, sono proprio gli agenti di quella che lui chiama «intolleranza
arcobaleno»: «Molti giovani genitori mi dicono di essere spaventati non dal
naturale sviluppo dell'orientamento sessuale del proprio figlio, quanto dal
fatto che alcune presunte "innovazioni" didattiche come le favole impregnate
dalla teoria gender o le campagne Lgbt innestate dentro le serie tv possano
influenzare e confondere i più piccoli. Ecco: con questa legge opporsi a tutto
questo sarà penalmente rilevante».
LA COSTITUZIONE
Trent' anni in meno ma spinto
dallo stesso afflato conservatore è Umberto La Morgia, sviluppatore di start-up
che si è messo in testa di creare un "ponte" fra comunità gay e Family day:
«Credo che la famiglia, a prescindere dai sentimenti, sia quella inserita e
riconosciuta nella nostra Costituzione: l'unione fra uomo e donna, cellula
fondamentale per lo sviluppo». Affermare un'ovvietà del genere sarà presto reato
con la legge Zan? «Lo scopriremo dopo il 25 luglio», sorride anche se ammette
che già questo dubbio è preoccupante: «L'impianto della legge è nebuloso. Ma
ancora più pericoloso è il meccanismo logico: per tutelare e per difendere una
minoranza non si può essere "eterofobici", ossia discriminatori verso una
maggioranza, o avere comportamenti intimidatori nei confronti di chi dissente.
Io stesso sono stato vittima di insulti inquietanti da parte degli estremisti
Lgbt per il solo fatto - da consigliere comunale nel bolognese - di essermi
dichiarato omosessuale di destra già lo scorso anno, contro le volgarità dei Gay
Pride e la follia dell'utero in affitto».
Giorgio Ponte da parte sua si
è rivolto direttamente ai vari Zan, Scalfarotto e Boldrini. «Ho chiesto a loro:
per quale ragione ritenete quella Lgbt una categoria protetta in maniera
"speciale" rispetto a qualsiasi altra? Qual è il senso di essere diseguali di
fronte alla legge? Non credete che sia questa discriminazione?». Risposte non
pervenute. La sua è la storia di un omosessuale che ha trovato nella Chiesa la
spinta per accettarsi senza scadere nel rivendicazionismo: «Mi ha reputato
all'altezza dell'esistenza e mi ha scosso dal mio vittimismo». Troppo per certo
attivismo gay, dato che per «loro devi essere della "giusta" visione». Il
risultato? «Dal 2015 sono riempito di messaggi in cui mi incitano ad
ammazzarmi o che mia madre avrebbe fatto meglio ad abortire». Giorgio ha
continuato a testimoniare la sua esperienza, «come fanno i medici e gli
psicologi che sostengono che un bambino ha bisogno di una madre e di un padre».
Il dubbio monta adesso, leggendo il testo unico Zan: «Con una legge simile hanno
uno strumento in più per bloccarci. Un bavaglio di massa».
CRIMINALIZZATI
Il paradosso dei paradossi è
incarnato da Carlotta. Stigmatizzata da sinistra in quanto donna di destra e
come donna lesbica da parte degli integralisti dei diritti gay. «Tentano di
criminalizzarci: ci accusano di non essere omosessuali come gli altri...». Tutto
questo per il fatto di credere che i sessi esistono: «Noi siamo fatti di natura
e cultura, non siamo essere "fluidi"». Uno stigma per i sostenitori del ddl Zan
che gridano alla transfobia contro lesbiche e femministe: «Con la scusa di
combattere l'odio intendono istituire l'odio per legge. Chiunque osa dire
qualcosa di diverso - come è avvenuto alla Rowling (la creatrice della saga di
Harry Potter, ndr) - diventa un discriminatore da bastonare con la legge».
Insomma, anche per gli omosessuali non irregimentati quella contro il ddl Zan è
una battaglia di civiltà. «È una Lepanto sociale», tuona Ravetto, contro «una
religione mortifera: l'omosessualismo ideologico non contempla la
continuità...».
Sulla stessa scia La Morgia
secondo il quale tutta questa temperie nichilista è parallela all'implosione
della sinistra: «Prima l'obiettivo era la lotta di classe, poi è diventata lotta
fra i sessi. Oggi si è ridotta alla lotta all'interno della persona stessa, con
lo scopo di distruggere l'identità. Perché una persona spaccata interiormente è
più manipolabile». La crociata anti-omofoba, dunque, come grande operazione di
mercato. «Sul desiderio di riscatto dell'omosessuale hanno costruito un impero -
conclude Ponte. E all'insoddisfazione di fondo che muove ciascuno di noi, hanno
dato l'illusione che la felicità sarà possibile solo quando tutti staranno
zitti». Dietro questo "bisogno" si costruisce una narrazione che diventa legge?
«Sì, perché basta una persona che sussurri la verità e quella ti farà crollare».
«Noi cattolici Lgbt, figli
di un Dio minore. Papa Bergoglio ci ascolti e dica sì al ddl Zan».
Simone Alliva su
L'Espresso il 24 giugno 2021. Condannati dalla Chiesa i fedeli omosessuali
chiedono apertura: l’orientamento da tutelare è quello del bene. «Qualunque
proposta che serve per proteggere chi è più debole deve essere appoggiata da chi
fa del Vangelo la propria vita». Dai Pacs alle unioni civili, passando per una
legge contro l’omotransfobia. I toni della Chiesa cattolica contro le leggi di
riconoscimento per le persone Lgbt sono storicamente aspri e senza appello.
“Disordine”, “sciagura”, “pericolo per la pace”: erano queste le parole che fino
a pochi anni fa le gerarchie cattoliche rilasciavano a indirizzo degli
omosessuali. Oggi il registro cambia. “Chi sono io per giudicare un gay” è la
frase di apertura alla comunità arcobaleno più nota di Papa Bergoglio. Ma la
posizione del papato resta sempre la stessa. Il muro che il Vaticano ha alzato
nei confronti della comunità arcobaleno sembra invalicabile. In ultimo la
decisione di impugnare il Concordato con lo Stato per chiedere all’Italia di
modificare il disegno di legge contro il ddl Zan. Un «verbo» che si mostra
potente; eppure, fragilissimo di fronte alla fede di moltissimi cattolici Lgbt.
«Per me la fede è come l’aria che respiro. Non riuscirei a immaginare una vita
senza» dice Paolo Spina 35, medico ospedaliero. «La Chiesa ha generato in me la
fede. Vivo ogni giorno seguendo il Vangelo dal lavoro al mio rapporto con gli
amici fino a quello con il mio fidanzato Domenico con cui vivo da un anno e
mezzo». Paolo fa parte del “Progetto Giovani Cristiani LGBT”, formato da ragazzi
e ragazze, fra i 18 ed i 35 anni. «Per tanto tempo sono stato arrabbiato. Non
nei riguardi di Dio ma di una gerarchia che si discosta dalla vita della gente.
Da questa arrabbiatura è nata una consapevolezza: non so se voglio la
benedizione del Papa della mia unione con Domenico ma so che è finito il momento
di chiedere permesso. Mi va di vivere da cristiano, testimoniare anche con i
miei errori, come la mia vita possa essere diversamente buona da un momento in
cui viene proposto». Sul ddl Zan Paolo non ha dubbi: «Qualunque proposta che
serve per tutelare chi è più debole deve essere appoggiata da chi fa del Vangelo
la propria vita». E la deriva liberticida denunciata dalla Chiesa? «La
preoccupazione di ogni cattolico dovrebbe essere quella di diffondere il
Messaggio del Vangelo che è di rispetto, bontà, amore, comprensione condivisione
ed empatia. La ricerca di ciò che ci unisce rispetto a ciò che ci divide
dovrebbe essere prioritario. Mi piacerebbe una Chiesa che camminasse di più che
riconoscesse che non c’è nulla di irriformabile se non l’orientamento del bene».
LA REPUBBLICA E LE INGERENZE
Chi condanna non vede, o non
vuol vedere, e agisce come se fede cattolica e omosessualità fossero
inconciliabili. Ma il popolo dei credenti è ben altra cosa. Lo racconta
bene Alberto Lisci, genitore di Costanza, Pietro e Francesco: «Sono cattolico
praticante da sempre, mi sono avvicinato al mondo Lgbt da quando mia figlia ci
ha detto di essere lesbica e di avere una relazione con una donna. Come genitore
non posso che cercare con i mezzi che possiedo di tutelare mia figlia e
difenderla da attacchi verbali o fisici. Quello che mi ferisce non è la critica
al ddl Zan ma che la mia Chiesa, o almeno una parte di essa, pensi a tutelare
non il bene della sua gente, di tutta la sua gente, ma il proprio».
Le parole di Alberto
riflettono quelle di moltissimi genitori di omosessuali e mettono in luce due
modi di vivere la Chiesa: «Ho sempre pensato che esistessero due Chiese, una
misericordiosa, accogliente, inclusiva e non giudicante, l’altra giudicante e
condannante, in virtù di un potere che le permetteva di agire senza mai
ascoltare il suo popolo e a cui tutto le era permesso. Mi spiace, ma da quella
parte non ci sto, ascolto chi mi ama, e vuole il mio bene, mi accoglie e cammina
al mio fianco. Di preti, religiosi e religiose, operatori pastorali, uomini e
donne di buona volontà ne ho incontrati tanti ed è a loro che do ascolto, è a
loro che affido la mia parte più intima. Spero vivamente che questa primavera di
cambiamenti porti a un mondo migliore e spero vivamente che tutti noi possiamo
farne parte».
Alessandra Gastaldi, project
manager all’interno del Grants Office di un Istituto di ricerca. Nel mondo
dell’associazionismo è legale rappresentante di Cammini di speranza ODV-
associazione nazionale di cristiani Lgbt: «La fede è parte fondamentale della
mia vita, quando ho preso coscienza del mio orientamento ho provato a ignorarla
per un po’, ma poi mi sono accorta che non era possibile, quindi ho cercato i
gruppi di credenti Lgbt che mi hanno aiutato a capire che il Dio mi ama senza se
e senza ma. Una volta che capisci questo anche le difficoltà con la dottrina
sono meno schiaccianti». E aggiunge: «Da cattolica non capisco come una legge
che tutela le persone ad oggi discriminate nella nostra società senza intaccare
il diritto di opinione possa essere un problema».
Confusione e rabbia sono
sentimenti comuni di moltissimi fedeli Lgbt: «Da cattolico gay provo tanta
rabbia», racconta Luigi, 27 anni, dottorato in Matematica a Milano. «Cerco di
portare questi temi nelle mie comunità: la parrocchia e gli spazi cattolici che
abito. Ma c’è sempre un muro di silenzio. Non si conoscono i temi, c’è anche
paura a parlarne. Le chiusure non sono inaspettate, ma si parla di noi senza di
noi. Sono mesi che sul ddl Zan la Cei chiede un tavolo ma noi non siamo invitati
a partecipare. Dalla mia chiesa vengo trattato come uno scandalo da nascondere».
Sull’opposizione della Chiesa contro la Giornata contro l’Omotransfobia, Luigi
ride: «Sono anni che i vescovi partecipano alle veglie di preghiera “contro”
durante la giornata. Nel 2019 il 17 maggio il vescovo di Palermo aveva invitato
una lettera a tutte le diocesi per andare alla veglia, così il cardinale di
bologna Zuppi ha presieduto la veglia. Non si capisce questa perplessità».
La capacità di ascolto delle
gerarchie vaticane è quello che manca anche per Andrea Rubera portavoce di
'Cammini di Speranza', associazione nazionale di persone cristiane Lgbt: «La
Chiesa avrebbe dovuto avviare un approfondimento interno. Ciò che spaventa è
l’accezione identità di genere», spiega: «Del resto tutto l’impianto di teologia
morale della Chiesa è basato su due monoliti inscalfibili: uomo e donna
concepiti come complementari, a cui vengono attributi ruoli sociali e familiari.
Un impianto difficile da smantellare. Invece di capire le sfumature
dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere si preferisce combattere.
Auspico che la Chiesa affronti con consapevolezza un percorso di approfondimento
e conoscenza, riconoscendo le persone che vivono sulla loro pelle un argomento
che la Chiesa tratta solo in modo ideologico. Serve l’incontro con le persone
omosessuali e transessuali, approfondimento e chiarezza. Solo così si potrà
rasserenare anche su un eventuale legislazione a supporto delle persone
omosessuali e transessuali».
La comunità Lgbt cristiana
resiste dunque, vittima di condanna secolare, ma convinta più dell'amore di un
Dio che degli uomini che vogliono rappresentarlo, ed è una comunità che risponde
di sé dinanzi alla propria coscienza. Come dice Paolo: «Due fidanzati
eterosessuali lo sanno che la Chiesa vieta il sesso prima del matrimonio, però
valutano dentro la loro conoscenza. Io sono cattolico, voglio credere a questa
Chiesa e prima o poi guardando come vivo io si accorgeranno che c’è qualcosa
oltre il loro naso. Mi appello alla mia coscienza. La coscienza è l’ultima voce
a cui devo rispondere, si posiziona anche sopra quella del Papa, come dice San
Tommaso D’Aquino».
"Io gay cattolico odiato
dagli omosessuali. E vi dico perché...."
Francesco Curridori il 15 Giugno 2021 su Il Giornale. Giorgio Ponte, scrittore e
omosessuale cattolico racconta a ilGiornale.it la propria esperienza di vita e
il motivo per cui si schiera contro il ddl Zan. "La mia speranza è che, quando
qualcuno finisce un mio libro, possa aver ricevuto qualcosa che lo spinga a
riprendere in mano la sua vita". Giorgio Ponte, giovane scrittore, insegnante e
omosessuale cattolico racconta a ilGiornale.it la sua esperienza di vita e
spiega le sue prese di posizione politiche.
Quando e come hai scoperto di
essere omosessuale?
"La mia tendenza omosessuale
si è sviluppata con l'adolescenza. Inizialmente è stata preceduta da una
confusione sul mio sesso d'appartenenza. Già verso i sette anni fantasticavo
sulla possibilità di trasformarmi in una principessa e i miei giochi avevano al
centro figure femminili. Poi, questa cosa è venuta meno e, nel momento in cui
sarei dovuto essere attratto da chi sentivo diverso da me, ho sviluppato
un'attrazione verso chi mi era simile perché, essendo cresciuto sempre in un
contesto femminile, di fatto, non conoscevo il mio sesso d'appartenenza.
Sentivo, quindi, diverso da me chi mi era simile perché non avevo relazione con
quel tipo di mondo. All'inizio questa attrazione è nata come un'attenzione verso
gli uomini più grandi e, poi, tutto si è acuito dopo l'esperienza di abusi che
ho subito".
Di che tipo di abusi si
trattava?
"Tra gli 11 e i 14 anni mi è
capitato che più di una volta venissi disturbato da persone più grandi mentre
prendevo i mezzi per andare a scuola. La mia impotenza davanti a questi abusi mi
ha confuso. Queste persone mi confusero ancora di più, incuneandosi in un modo
distorto nel mio bisogno di attenzione da parte del mondo maschile. Non riuscire
a difendermi mi faceva sentire corresponsabile, colpevole e questa è una cosa
molto comune a tantissime vittime di abusi".
Quando hai fatto coming-out?
"Non ho mai fatto coming-out:
ho fatto una condivisione di vita, che è ben diverso. il coming-out è una
dichiarazione in cui si antepone la propria omosessualità alla propria identità,
facendo coincidere le due cose. La persona si pone davanti agli altri con questa
etichetta pretendendo di essere riconosciuto in quanto omosessuale. Io, invece,
ho condiviso con la mia famiglia verso i 26-27 anni la mia storia personale e le
ferite che mi portavo dietro, mentre verso i 25 ho smesso di vivere nascosto la
mia omosessualità. Non ho mai fatto dichiarazioni. Ho semplicemente lasciato che
questa cosa fosse una tra le mille altre della mia vita. Non nascondo la mia
omosessualità né la esalto. Il coming-out è una cosa diversa".
La tua famiglia come ha preso
la notizia?
"Per la mia famiglia non è
stata una sorpresa perché c'erano già stati tanti segnali. Il punto non è stato
l'omosessualità, ma condividere le nostre ferite comuni da cui l'omosessualità è
nata. È stato importante poter guardare in faccia i miei genitori e i miei
fratelli e raccontarci tutta la sofferenza interiore che ci portavamo dentro da
tanto. Era importante poterci perdonare a vicenda del male che ci eravamo fatti
involontariamente".
Quando hai scoperto la fede?
"La fede ha sempre fatto parte
della mia vita. Vengo da una famiglia dove Dio non è un rito, ma una persona
reale, uno “di casa” e questo è stato certamente un dono. Tuttavia la mia
esperienza di fede a un certo punto doveva portarmi a chiedermi le mie ragioni
per cui credevo, diverse da quelle dei miei genitori. Dovevo capire chi fosse
davvero quella Persona che abitava la mia casa e di cui mi dicevano cose che non
mi sembravano vere. Di fronte agli abusi subiti mi chiedevo: perché Dio, che
dovrebbe amarmi, non mi ha difeso? Le risposte sono arrivate grazie a un cammino
di fede fatto con una congregazione di suore che gestiva mia scuola, giù a
Palermo: Dio era lì con me, in quel dolore, e aspettava solo che me ne
accorgessi, per trarre con Lui da esso nuova Vita".
Come riesci a conciliare la
tua fede e il tuo orientamento sessuale?
"A una persona omosessuale non
è richiesto nulla di diverso da quel che è richiesto ad ogni altra persona sulla
terra e cioè di coltivare la castità dell’amore che non è semplicemente
continenza, ma imparare ad amare senza possedere e questa cosa è richiesta a
tutti, anche agli sposi. Esiste infatti anche una castità matrimoniale. A volte
si possono avere rapporti sessuali con la propria moglie formalmente perfetti ma
sostanzialmente non liberi: anche tua moglie puoi usarla solo per il tuo piacere
personale. Così come potresti non alcun rapporto sessuale eppure non essere
comunque casto. La castità è l'amore gratuito che, a seconda del proprio stato
di vita, significa anche, ma non solo non avere rapporti sessuali. Io da questo
punto di vista non sono diverso da qualsiasi altro single o non spostato. Se una
persona arriva a 50 anni senza essere sposato gli viene chiesto la stessa
condizione di vita che viene richiesta a me: una castità che è anche continenza.
Questo non vuol dire che io riesca sempre a viverla. I periodi di maggiore
libertà di solito sono quelli in cui il mio cuore è colmo d'amore, ma ho anche
periodi in cui il peso delle situazioni che vivo fa riemergere la mia fragilità.
Vivo la vita che vivono tutti e combatto come tutti per essere sempre più
libero. Per fortuna so che questa non è una battaglia che combatto da solo, ma
con Dio. So che c'è una bellezza più grande che ho anche sperimentato e perciò,
per quante cadute possa avere, quella è la direzione verso la quale cerco di
camminare".
Hai mai subito delle
discriminazioni omofobiche?
"No e non all'interno della
chiesa. Ho subito del bullismo legato al fatto che ero un bambino facilmente
emarginabile perché grasso e non bravo nello sport. L’omosessualità è venuta
dopo. L’essere emarginato mi ha portato a desiderare un riconoscimento da parte
del mondo dei maschi che si è erotizzato diventando un'attrazione omosessuale.
Sono stato discriminato più dal mondo gay in quanto cattolico che dal mondo
cattolico in quanto omosessuale".
Che tipo di discriminazioni
hai ricevuto dal mondo Lgbt per le tue posizioni?
"Il mondo Lgbt giudica omofobo
il fatto che io parli di ragioni psicologiche dell'omosessualità e di storie di
persone che hanno riscoperto una dimensione eterosessuale, così come il fatto
che io cerchi la castità. Per quel mondo, io sono un omofobo interiorizzato,
cioè qualcuno che odia se stesso, pur avendo dimostrato il contrario in molti
modi e occasioni. Ho ricevuto ridicolizzazioni, minacce e diffamazioni da gente
che mi attribuisce cose che io non ho mai detto o manipola le mie
dichiarazioni".
Cosa ti ha spinto a esporti
pubblicamente e a partecipare al Family Day?
"Sapevo che c'era un universo
di gente con una visione di vita diversa da quella del mondo Lgbt la cui voce
non era rappresentata da nessuno. Non è solo un fatto di fede, ma di come si
guarda il mondo e l'essere umano. Oggi ci sono tante persone che non si sentono
libere di parlare perché hanno paura di esprimere un pensiero in contrasto con
quello del Main Stream. A un certo punto ho capito che c'era bisogno che
qualcuno si esponesse per dare coraggio a tanti altri che sono convinti di
essere i soli al mondo a vivere diversamente, soltanto perché chi vive secondo
l'ideologia Lgbt ha più voce per farsi sentire".
Perché sei contrario ai
matrimoni gay?
"Celebrare il matrimonio gay
significa alimentare la convinzione che ci sia una stabilità a lungo termine in
un rapporto omosessuale cosa che, nella mia esperienza diretta e osservata, non
è possibile per ragioni strutturali di non complementarietà. Poi è chiaro che
anche tra uomo e donna oggi la stabilità delle relazioni è terribilmente
precaria, per la stessa immaturità affettiva che sta alla base anche
dell’attrazione omosessuale, ma in quel caso si tratta di un'opzione. Tra
uomini, invece, è la regola: una coppia o si frantuma una volta passata
l’idealizzazione, a lungo andare non è in grado di restare fedele. Al di là di
questo, il matrimonio gay si basa su un falso antropologico: se cose uguali
davanti alla legge devono avere lo stesso trattamento, dare gli stessi
riconoscimenti a una coppia omosessuale come a una eterosessuale significa dire
che le due coppie sono sostanzialmente uguali, ma perché questo sia vero,
bisogna anche sostenere che uomo e donna sono sostanzialmente intercambiabili. E
questo è falso. Uomo e donna sono sostanzialmente diversi, né migliori né
peggiori, ma diversi, pertanto due uomini, non possono essere uguali a un uomo e
una donna (anche qui, diversi non vuol dire peggiori), e quindi non possono
avere lo stesso trattamento davanti alla legge. E se fingiamo di credere che le
unioni civili italiane siano diverse dal matrimonio perché non richiedono
fedeltà e non permettono le adozioni, siamo degli illusi: come in tutte le
nazioni dove simili leggi “a metà” sono passate, sappiamo che questo è solo il
primo passo per poi ammettere in futuro anche le adozioni gay che non tengono
conto del bene del bambino, il quale per crescere ha bisogno, nelle migliori
delle condizioni possibili, almeno di un padre e di una madre".
Cosa pensi del ddl Zan?
"Penso che sia una legge non
necessaria, esattamente come non lo era quella sulle unioni civili. In quel caso
perché a livello di diritto privato tutto ciò che doveva tutelare la legge era
già tutelato, mentre per quanto riguarda il DDL, già adesso chiunque dovesse
picchiare un omosessuale è punibile per legge con in più avrebbe l'aggravante
per futili motivi. Il DDL Zan non solo non aggiunge niente a livello di tutele,
ma aggiunge moltissimo a livello di prevaricazione perché categorizza un certo
tipo di reato rendendolo più grave rispetto alle discriminazioni che altre
persone possono subire per altre ragioni. Inoltre non definendo in maniera
oggettiva quali siano le condotte omofobe rende, di fatto, denunciabile
qualsiasi atto non conforme a un certo tipo di ideologia in quanto potrebbe
ledere “la sensibilità” di una persona omosessuale, anche la semplice
espressione di idee contrarie. La sensibilità, infatti, non è un dato giuridico,
poiché per definizione essa cambia da persona a persona, e l’applicazione di una
legge non può quindi mutare in funzione di essa. La legge deve basarsi su
qualcosa di oggettivo e misurabile e né un'opinione né un desiderio hanno queste
caratteristiche. Inoltre, proprio come la legge sulle unioni civili, il ddl Zan
fa un torto antropologico perché dice che non esiste più la distinzione
uomo-donna, ma parcellizza l’identità umana sulla base di categorie aleatorie
legate al desiderio. Questo è molto pericoloso perché potremmo arrivare al
paradosso per cui chiunque, anche se non ha fatto l'operazione totale, potrebbe
pretendere che la gente lo riconoscesse come donna e in quanto donna richiedesse
di accedere, per esempio, alle quote rosa in una lista di partito: pena denuncia
per discriminazione. Al di là di quel che uno vive nella sua vita privata,
infatti, fare una legge su criteri del tutto interpretabili rischia di generare
un caos incontrollato anche all'interno dello stesso attivismo che sta
sostenendo la legge: da mesi Lesbiche e femministe sono sul piede di guerra
contro i Trans per questa ragione. Non si capirà più chi è la vittima e chi è il
carnefice e tutti avranno un pretesto per denunciarsi a vicenda e, in qualche
modo, ci sarà sempre qualcuno a cui verrà fatto un torto".
Politicamente come ti
identifichi?
"In questi anni non sono mai
stato sotto il cappello di nessun movimento, partito o associazione. Anche
quando ho militato tra le Sentinelle in Piedi non l'ho fatto come segno
d'appartenenza, perché le sentinelle sono una forma di manifestazione, non
un’organizzazione cui aderire. Mi riserbo, perciò, il diritto di restare in
silenzio e libero su questo. Dal momento che non nutro una fiducia
incondizionata in nessuno che non sia Cristo, per il resto voto quei partiti che
difendono i valori in cui credo, a prescindere dai motivi per cui lo fanno e a
prescindere dalle condotte personali dei loro leader. In fondo, un uomo politico
è chiamato a guidare la società e il bene collettivo e dei singoli individui e
non è detto che una persona brava a fare questo nella vita pubblica sia
altrettanto bravo a farlo nella sua vita privata. Sappiamo bene che i grandi
uomini politici che hanno salvato l'Occidente in tempi di grande crisi, a
livello personale, avevano tonnellate di vizi. La coerenza non è di questo
mondo, purtroppo, e chi si ritiene al di sopra di questa legge non scritta,
pecca di superbia. Se invece parliamo di correnti politiche, senza soffermarci
su un partito o su un altro, personalmente credo che se una persona è davvero
cristiana, non si può identificare oggi con quell’ala della sinistra che
sostiene tutte le leggi contro la vita e l’essere umano nelle sue componenti
strutturali, solo in virtù dell’appeal che ha quella millantata attenzione verso
gli immigrati, che in realtà, il più delle volte è un'attenzione fatta di spot e
di buonismo e non di concretezza. Aborto, eutanasia, divorzio, unioni civili,
suicidio assistito, leggi omosessualiste… Tutte le battaglie della sinistra
moderna sono per la distruzione della società. Non posso scandalizzarmi per gli
uomini che muoiono in mare, se lascio che migliaia di bambini tutti i giorni
vengano uccisi nelle pance delle loro madri. Non posso preoccuparmi solo di come
accogliere lo straniero, se lo accolgo in un mondo disintegrato alle sue
fondamenta. Inoltre non posso amare una corrente ideologica che nasce dalla
divisione del mondo in poveri buoni e ricchi cattivi e sull’odio sociale tra
essi. L’odio non è mai la strada. Ci sono emergenze sociali sul cui approccio si
può discutere e poi ci sono i fondamenti della vita: i valori non negoziabili".
Quando e come è nata la tua
passione per la scrittura?
"È nata con me. Fin da piccolo
ho sempre avuto il desiderio di raccontare storie, perché ne ho sempre
riconosciuto il grande potere salvifico e di insegnamento: un storia ti permette
di trasmettere un concetto rendendolo vivo, molto più che parlare del concetto
stesso in maniera teorica. Io desideravo raccontare la speranza e la scrittura è
il modo con cui cerco di farlo".
La tua più grande paura?
"Morire senza aver fatto tutto
quello per cui Dio mi aveva chiamato a questo mondo: senza aver amato
abbastanza; senza aver speso tutti i talenti che avevo; senza aver raccontato
tutte le storie che avevo da raccontare o aver speso ogni goccia di questa vita
per il bene che mi era chiesto"
Il tuo più grande errore?
"Non saprei decidere. Di
errori ne ho fatti molti, ma a parte quelli dettati dal vizio, gli altri erano
sempre mossi da una ricerca autentica della volontà di Dio, e nel momento in cui
li ho commessi mi sono fidato di ciò che in quel momento mi sembrava la scelta
migliore. Così ho fatto esperienza di come, per quanti errori si possano fare,
se si sta realmente cercando la propria strada, nessun errore è veramente tale,
ma solo un passo in più che ti avvicina alla strada che Dio ha pensato per te".
Francesco Curridori. Sono
originario di un paese della provincia di Cagliari, ho trascorso l’infanzia
facendo la spola tra la Sardegna e Genova. Dal 2003 vivo a Roma ma tifo Milan
dai gloriosi tempi di Arrigo Sacchi. In sintesi, come direbbe Cutugno, “sono un
italiano vero”. Prima di entrare all’agenzia stampa Il Velino, mi sono laureato
in Scienze della Comunicazione e in Editoria e Giornalismo alla Lumsa di Roma.
Dal 2009 il mio nome circola sui più disparati giornali web e siti di
approfondimento politico e nel 2011 è stata pubblicata da Aracne la mia...
Ddl Zan, Spirlì: «Si può usare la parola
frocio? Sì se non dispregiativo e io la userò».
Francesco Ridolfi su Il Quotidiano del Sud il 28 maggio 2021. Il presidente
facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, non è il tipo che le manda
a dire e riguardo l’utilizzo di determinati termini non ha mai nascosto il suo
pensiero. Lo scorso ottobre aveva espresso a chiare lettere l’idea che «ci
stanno cancellando le parole di bocca, come se dire zingaro sia già un giudizio
negativo, negro è la stessa cosa, in calabrese dico niurio per dire negro, non
c’è altro modo». Ora ritorna sul tema parlando a La Zanzara, in onda su Radio
24, del discusso disegno di legge Zan che tanta polemica e discussione sta
generando in Italia: «Se mi chiameranno in audizione – ha dichiarato Spirlì –
sul ddl Zan ci andrò sicuramente. Non sono d’accordo e invece sono per la
proposta del centrodestra che è molto più umana, più rispettosa e non crea
categorie». Il massimo esponente istituzionale calabrese mette all’indice la
proposta di legge Zan che «censura, tappa la bocca e mette paura alla gente di
usare le parole. Questa – asserisce con decisione – è la santa verità». Per
Spirlì, «esistono gli stati d’animo che disprezzano, non le parole, fra poco
dovremo stare attenti a come respiriamo per non finire in tribunale. Si può
usare la parola frocio? Sì, se non è usata in modo dispregiativo la userò e
continuerò a usarla. Se noi la utilizziamo per un gioco o perché la leggiamo in
un libro corriamo il rischio di essere accusati». In conclusione, per il
presidente facente funzioni della Regione Calabria la legge Zan «è un capestro,
una forca caudina. Cerca di tappare la bocca e impedire la libertà per cui
abbiamo combattuto duemila anni e adesso dobbiamo stare attenti a quello che
diciamo». In sostanza, Spirlì si chiede e chiede agli ascoltatori: «Vi rendete
conto che già non possiamo utilizzare parole come zingaro, negro, siamo alla
follia. Le parole non sono armi, se non quando caricate a pallettoni da chi le
pronuncia».
Da la Zanzara – radio24.it il 28 maggio 2021. A La
Zanzara su Radio 24 il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì, leghista,
omosessuale, attacca a tutto spiano la legge Zan: “Se mi chiameranno in
audizione sulla legge Zan ci andrò sicuramente. Non sono d’accordo e invece sono
per la proposta del centrodestra che è molto più umana, più rispettosa e non
crea categorie”. “La legge Zan – dice Spirlì - censura, tappa la bocca e mette
paura alla gente di usare le parole. Questa è la santa verità. Esistono gli
stati d’animo che disprezzano, non le parole, fra poco dovremo stare attenti a
come respiriamo pe non finire in tribunale”. Si può usare la parola frocio?:
“Sì, se non è usata in modo dispregiativo la userò e continuerò a usarla. Se noi
la utilizziamo per un gioco o perché la leggiamo in un libro corriamo il rischio
di essere accusati. La legge Zan è un capestro, una forca caudina. Cerca di
tappare la bocca e impedire la libertà per cui abbiamo combattuto duemila anni e
adesso dobbiamo stare attenti a quello che diciamo. Vi rendete conto che già non
possiamo utilizzare parole come zingaro, negro, siamo alla follia. Le parole non
sono armi, se non quando caricate a pallettoni da chi le pronuncia”. “Omofobia
in Italia? Ma no, riguarda altri paesi. L’Italia non è un Paese omofobo, i paesi
omofobi sono quelli dove ti tagliano la testa se sei omosessuale, come l’Iran
dove vengono impiccati. Gli omosessuali italiani non lo dicono questo, che nei
paesi musulmani vengono ammazzati i gay. E invece la sinistra e gli omosessuali
italiani scelgono di stare dalla parte di Hamas, dove gli islamici ammazzano i
gay”. Spirlì è un fiume in piena: “Le associazioni gay? Non servono a niente,
solo a fare soldi. E questa legge serve a rafforzare l’associazionismo
multicolore”. “Gli omosessuali -dice ancora - possono avere la giornata
dell’orgoglio dove possono offendere chiunque, sopra i carri c’è gente
travestita da prete o da suora col culo di fuori. Loro possono offendere la
religione…Devono starsene a casa e vivere l’omosessualità come le persone
serene, a casa, in silenzio e a farsi le proprie cose in tranquillità.
L’omosessuale non è un essere speciale, è un essere normale come tutti gli
altri, appartiene all’umanità. Il Gay Pride mi ha sempre fatto schifo, una
carnevalata inutile che non è mai servita a niente e a nessuno. Se dovessi avere
un figlio omosessuale e lo vedessi su un carro del Gay Pride lo prenderei a
calci nel culo con gli anfibi e lo accompagnerei a casa e gli spiegherei cosa
significa essere omosessuali con dignità, senza bisogna di diventare un
deficiente su un carro a fare il deficiente”. “Chi difende la legge Zan prosegue
- vuole fare passare gli altri per pazzi, invece dietro le parole nasconde tutta
una serie di censure e gravissimi pericoli per la libertà, se passasse
tapperebbe la bocca a tutti. Voglio vivere senza categorie e voglio poter dire
che la famiglia è fatta da una madre, da un padre e dai figli. Appena lo dici, e
non aggiungi che ci sono anche le famiglie omosessuali corri un pericolo. Due
gay fanno una coppia di persone che si vogliono bene, ma non sono famiglia. Se
passasse la legge Zan per queste cose che ho detto potrei essere querelato”
In libreria scaffali pieni di libri
Lgbtqia per i bambini. Ecco come cercano di indottrinarli.
Redazione sabato 7 Agosto su Il Giornale.
Alla libreria Feltrinelli di piazza Piemonte, a Milano, c’è un’intera parete
denominata Wunderkammer, come “stanza dei desideri”. Lo racconta il Giornale che
osserva come «sugli scaffali di questa nicchia privilegiata troviamo oggi decine
di titoli dedicati a un tema di moda, la presunta normalità di essere LGBTQIA,
questa sigla che ormai si estende a tutte le sfumature arcobaleno della
sessualità, basta che non sia etero. Un insieme che contiene un vasto
sottoinsieme, proposto ai visitatori degli scaffali in periodo di rifornimento
pre-vacanziero: quello per ragazzi, e soprattutto per bambini». Si comincia,
scrive il Giornale, da un piccolo/grande classico, quel Piccolo uovo di
Francesca Pardi, illustrato da Altan (ed. Lo Stampatello, 2011), «dove un
protagonista asessuato incontra tutte le combinazioni di famiglie bi- e
omogenitoriali, decidendo che l’una vale l’altra. Di fianco, una ghiotta
occasione per mettere il figlio in età prescolare alla pari con la vulgata
corrente: come favola della buona notte, si può leggere al proprio figlio
quattrenne La bambola di Luca (ed. Nube Ocho, 2021), storia di questo bambino
che va pazzo per una bambola, finché arriva il solito bullo e gliela deturpa. Ma
il bullo fra l’altro è un bambino di colore, e nessuno vuole che un bambino di
colore sia anche ostile alle teorie gender fluid. Perciò egli si pente e si
riscatta e diventa buonissimo, cioè gioca con le bambole anche lui». Poi, scrive
ancora il Giornale, «…I due papà di Fiammetta, di Émilie Chazerand e Gaëlle
Souppart (ed. La Margherita, 2019), dove i soliti bulli prendono in giro la
bambina e lei invece li convince di quanto è fortunata, mentre la sua amica che
ha invece due genitori biologici è disperata perché divorziano». E poi ancora:
«O, pensando ai ragazzi più grandicelli, Le semplici cose di Massimiliano De
Giovanni e Andrea Accardi (Feltrinelli Comics, 2019), una graphic novel su
quanto sia appropriato, per due maschi quarantenni, servirsi di un utero per
conto terzi». E poi tanto altro ancora.
Scrittrice trans “osa” contestare il ddl
Zan. Contro di lei una valanga di insulti e minacce.
Fortunata Cerri sabato 7 Agosto su Il Giornale. Scrittrice trans criticata
ferocemente perché contesta il ddl Zan. Il giornalista Francesco Borgonovo de La
Verità ha intervistato Neviana Calzolari, una trans «Male to Female». Sociologa
e scrittrice recentemente ha espresso le sue idee su MicroMega, rilasciando
dichiarazioni che La Verità ha ripreso. Subito dopo, Neviana è stata oggetto di
attacchi feroci. «Controllando le notifiche su Facebook, mi sono imbattuta in un
post di Antonia Monopoli, che fa parte di un’associazione trans milanese»,
racconta. «Nel suo post mostrava solo alcune righe dell’articolo della Verità in
cui appariva il mio nome e commentava: “Ecco un’attivista trans che si è bevuta
il cervello”. In quel post non veniva riportato nulla dell’articolo, non
venivano citate le mie parole». E poi ancora: «Veniva dato per scontato che,
essendo stata citata in un articolo della Verità, mi fossi fatta
strumentalizzare dalla destra, che fossi una fascista». Poi sono arrivati altri
commenti…«Me ne hanno dette molte: fascista, kapò… Quel primo post è stato una
sorta di chiamata alle armi affinché iniziasse una pressione intimidatoria nei
miei confronti…». Poi spiega: «Il problema del movimento Lgbtq e delle persone
che dicono di rappresentarlo solo perché sono a capo di associazioni è che alla
fine si pongono sempre in modo estremamente aggressivo e verbalmente violento
nei confronti di chi esprime delle posizioni divergenti dal manistream del
movimento. Cercano di intimidirti, e se reagisci ribaltano la frittata». «Ti
accusano di avere un atteggiamento aggressivo, mentre gli aggressivi sono loro».
E racconta ancora al giornalista de La Verità. «Ma la cosa più ridicola è
questa: nel vostro articolo, avete citato delle frasi che ho detto a MicroMega.
Ebbene, poiché MicroMega è un santuario della sinistra, l’articolo uscito lì non
ha suscitato reazioni, nessuno mi ha criticato. Ma non appena le stesse parole
sono state riportate sulla Verità è successo il finimondo». «Ciò dimostra la
profonda malafede di certe persone, che non si danno nemmeno la pena di leggere
e documentarsi. Però è accaduto anche qualcosa di inaspettato. Io non faccio più
parte di associazioni, quando prendo posizione pubblicamente lo faccio a titolo
personale. Ma sui social dopo gli attacchi ho ricevuto un grande sostegno. Chi
mi segue ha iniziato a segnalare i post aggressivi nei miei confronti, e alla
fine Facebook li ha rimossi. I miei accusatori non avevano previsto che
accadesse una cosa simile». La sociologa spiega inoltre che a far scatenare gli
attacchi è stato «ciò che ho detto sui bloccanti della pubertà…». «…Secondo me
il vero problema è il concetto di identità di genere. Sesso e genere sono cose
diverse. La transessualità ha a che fare con il sesso, mentre i fautori
dell’identità di genere sostanzialmente dicono che le persone transessuali
rientrino nell’ombrello transgender. Io però non sono dentro questo ombrello. La
transessualità ha a che fare con una spinta forte, insopprimibile a lungo
andare, a cambiare le caratteristiche del proprio corpo a favore del sesso di
elezione». Il giornalista de La Verità osserva che chi sostiene il ddl Zan dice
che nel progetto di legge non si parla di bloccanti della pubertà o di cambio di
sesso dei minori. «È un’ipocrisia. Questo è il segreto di Pulcinella. È chiaro
che il concetto di identità di genere è stato introdotto come caposaldo perché
si vuole puntare proprio a questo: a rendere indistinguibili, come se si
trattasse di cose intercambiabili, transizione di sesso e genere». Lei è molto
critica verso il ddl Zan. Perché? «Per tanti motivi. Mi dica: perché mai il
genere, che ha che fare con il vissuto e la percezione, dovrebbe avere rilevanza
pubblica e legale? Cercare di ancorare ipotesi di reato penale a vissuti
soggettivi ci porterebbe al caos più completo. Altro che certezza del diritto:
ogni giudice andrebbe a ruota libera. E poi, così come è scritto, il ddl Zan è
un’arma di distrazione di massa dai veri problemi dei transessuali». E quali
sono? «Il vero problema è che c’è un sistema di aiuti e assistenza socio
sanitaria che fa pena, che è inadeguato rispetto alla creazione di un benessere
personale e una vera integrazione sociale. Ma le associazioni trans e il
movimento Lgbtq hanno interesse a rimuovere questi problemi – che sono
prioritari per la salute delle persone – e preferiscono concentrarsi su aspetti
repressivi di carattere penale. Funziona così: poiché non sono in grado di
garantire alle persone trans assistenza e benessere, queste ultime sono spesso
frustrate e insoddisfatte. E allora le associazioni dicono: la responsabilità
non è nostra, o dello Stato, ma del mondo infame che non riconosce le
soggettività trans. In realtà credo che gli attivisti che mi attaccano abbiano
paura di affrontare i temi che metto sul piatto. Ad esempio quello che non va
nei consultori per le persone trans, su cui le associazioni mettono la
bandierina politica».
Alessandra Arachi per il “Corriere della Sera” il
4 giugno 2021. I filmati non lasciano spazio all'immaginazione: due donne che si
baciano scambiandosi una caramella, la stessa caramella che viene passata di
bocca in bocca tra un uomo steso in un letto che abbraccia due donne, che si
intuiscono nude. E ancora: due adolescenti che sempre con quella caramella si
baciano chiudendosi a chiave nella cameretta, l'aria complice. No, Vittorio
Sgarbi non ha potuto sopportare tutto questo nella pubblicità delle caramelle
Dietor-Dietorelle. Ecco che l'onorevole ha fatto prendere carta e penna al suo
avvocato, Giampaolo Cicconi, e ha fatto scrivere all'autorità garante
dell'Infanzia, all'autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e all'autorità
garante della Concorrenza e del mercato. Ci sono almeno cinque o sei violazioni
che Sgarbi avrebbe individuato in quella pubblicità che va in onda in orari in
cui anche i bambini guardano la televisione. Due spot di trenta secondi l'uno
che - a dire dell'onorevole - cominciano violando la Convenzione Onu sui diritti
del fanciullo datata 1989 e attraversano la direttiva numero 450 del 1984 che
disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa. Di tutto si può dire
dell'onorevole Sgarbi, ma non di certo che sia un uomo bacchettone o moralista.
«Sono un libertino naturale», dice lui. E puntualizza: «Però non è possibile che
in epoca di ddl Zan si pensi di difendere le categorie fragili come i trans o le
lesbiche e non si pensi alla fragilità dei bambini». Quelle immagini che nei
trenta secondi sfilano sulle note della molto famosa canzone Bésame mucho lo
hanno colpito a tal punto da far riempire al suo avvocato due pagine fitte
scritte in punta di diritto, che riguardano anche la televisione di Stato. In
particolare la legge 223 del 1990 (la legge Mammì) che disciplina la tutela del
diritto morale e d'autore e dell'interesse pubblico relativo ai messaggi
pubblicitari. Effettivamente quella pubblicità di Dietor-Dietorelle va in onda a
tutte le ore del giorno e della sera e quelle immagini, secondo l'onorevole
Vittorio Sgarbi - che cita la legge - «offendono la dignità della persona» oltre
ad «offendere convinzioni religiose ed ideali», nonché «indurre a comportamenti
pregiudizievoli», ma, soprattutto «arrecano pregiudizio morale o fisico a
minorenni». «Non capisco perché ci sia la censura nei film e invece si lasci
libertà agli spot in tv che vengono visti anche dai bambini di sei o otto anni».
L'autorità garante dell'Infanzia ha già raccolto la denuncia, mentre Sgarbi ci
tiene a precisare di non essere contrario al ddl Zan, ma anche lì: «Quando si
parla di fare educazione nelle scuole bisogna farla a ragazzi superiori ai
14anni, oltre ad emendare la parte dove si parla di libertà di opinione».
Gli italiani vogliono il ddl Zan. Anche a
destra. Luca Bottura su La Repubblica il 14 giugno
2021. Questo dicono i sondaggi. E la conseguenza è che i consensi di quel che
resta del progressismo italiano potrebbero persino crescere e pescare da lì. Il
disegno di legge Zan viene dipinto da fior di commentatori come un tema
divisivo. Si assume che il Paese non sia pronto, che ci sono altre priorità. Il
fatto che il segretario del Pd Letta ne faccia bandiera viene salutato dai
pasdaran centristi con un concerto di pernacchie alternate a violente accuse di
autolesionismo. Gente che viaggia sotto il 2 per cento che spiega come si vince:
solo in Italia. Poi vai a vedere i sondaggi. ad esempio quello svolto
dall’istituto Piepoli una settimana fa. E scopri che il 75 per cento degli
italiani, 3/4 del Paese, una maggioranza che si potrebbe definire bulgara se
solo in Bulgaria esistessero ancora maggioranze bulgare, è d’accordo. Ma non è
tutto. A fronte di un 92% di elettori del centrosinistra che supportano il
provvedimento, c’è un 83 per cento di Cinque Stelle che li tallona. E (udite,
udite) nel centrodestra i consensi sono al 51%. Di uno sputo, ma pur sempre
maggioranza. Volendo fare l’Ilvo Zirconi della situazione, cioè un Ilvo Diamanti
decisamente meno capace, mi pregio di ricavare alcuni dati. Il primo: sui
diritti, il centrosinistra è compatto. Questo significa che ripartire da lì è
tutt’altro che folle. Il secondo: il larghissimo consenso sulla Legge Zan da
parte dei grillini conferma la percezione empirica, e cioè che il dimezzamento
dei voti a Cinque Stelle ne ha purgato la base dalla presenza del voto di
protesta a trazione iper-destrorsa. Che infatti ingrossa il consenso di Fratelli
d’Italia, la quale ha parimenti succhiato sangue e voti alla Lega. Ne consegue
che l’unica strategia possibile, quella lettiana, di cercare una convergenza con
un popolo ormai simile al proprio, cammina praticamente da sola. Ma è il terzo
dato ad essere clamoroso, quel mezzo italiano virgola uno, come direbbe l’ex
assessore Gallera, che pur votando la Destra italiana, illiberale, rancorosa,
aggressiva, impresentabile, sostiene Zan e il suo progetto. Sarà perché alla
fine è vero: hanno amici gay. Sarà perché gli italiani, anche quegli italiani,
spesso sono meglio dei loro leader. Sarà perché nel centrodestra è ancora
conteggiata Forza Italia, che rispetto a Italia Viva e talvolta ad Azione è una
specie di comitato centrale del Pcus, fatto sta che mezzo “Paese reale”, alias
“paese di Rete4” vorrebbe tutelare gli e le omosessuali, i trans, i queer e
tutto il cucuzzaro perché ha ben presente, nonostante la martellante campagna
dei media da cui è giornalmente sedotto, come questo sia fondamentalmente buono
e giusto. La conseguenza è che almeno su quel 51 per cento una sinistra capace
di tenere la barra ferma può, punto per punto, comma per comma, iniezione di
contemporaneità dopo iniezione di contemporaneità, esercitare una possibile
attrattiva. Che, cioè, i consensi di quel che resta del progressismo italiano
potrebbero persino crescere e pescare a Destra, ché il centro non esiste più,
senza dover borbottare “ma non è il momento” o cambiar nome in Confindustria. Il
51 per cento. Mi sembra una buona notizia. Al 100 per cento.
Diego Dalla Palma, l'orrore subito dal
guru della moda: "Pestato dal mio fidanzato fino a farmi perdere i sensi".
Libero Quotidiano il 15 giugno 2021. Diego Dalla
Palma ha confessato di essere stato picchiato dal suo compagno fino a perdere i
sensi. L’uomo è stato immediatamente denunciato, ma si trova ancora in libertà.
Il guru della moda si è messo a nudo svelando anche dettagli molto personali e
delicati della sua vita. "Sono stato molto amato da alcune persone che non
potevo amare. In generale, ho avuto tre storie d’amore molto importanti: una con
una donna, Anna, le altre due con due uomini che non vogliono che faccia il loro
nome. Non ci sentiamo più e questo per me è un vuoto enorme: perché non avere
contatti? Allora quello di un tempo non era amore», confessa. Il visagista ha
ammesso di essere stato vittima di manipolazioni psicologiche. "C’è un uomo che
mi ha picchiato quattro anni fa. Fu uno shock enorme, mi ha picchiato fino al
punto di farmi perdere conoscenza. Quell’uomo è stato denunciato ma grazie alla
legge se ne sta tranquillamente in giro per l’Italia. Non ho paura di rivederlo.
Una sola cosa mi fa paura: lo stordimento, il non capire chi sono, il dipendere
da altri. Se avessi delle avvisaglie in questo senso, farei una scelta precisa:
andarmene", confessa. Sul Ddl Zan si dice favorevole: "Sono assolutamente
favorevole al DDL Zan. Ma gli omofobi, che sono dei perdenti alla ricerca
disperata di dare un senso ai loro fallimenti esistenziali, continueranno ad
esistere fino a quando non ci sarà una profonda rivoluzione culturale. Cosa
penso di Platinette che è contraria a questa legge? L’ho trovato sorprendente,
sono sincero", conclude.
Da "ilfattoquotidiano.it" il 15 giugno 2021. Il
Parlamento ungherese ha approvato il disegno di legge volto a vietare la
“promozione dell’omosessualità ai minori”, presentato da Fidesz – il partito del
Primo ministro Viktor Orban – la scorsa settimana e criticato da Amnesty
International e Human Rights Watch come un attentato ai diritti Lgbtq. Il
provvedimento è passato con 157 voti a favore e un solo contrario. “Al fine di
garantire la protezione dei diritti dei bambini – si legge nel testo –
la pornografia e i contenuti che raffigurano la sessualità fine a se stessa o
che promuovono la deviazione dall’identità di genere, il cambiamento di genere e
l’omosessualità non devono essere messi a disposizione delle persone di età
inferiore ai diciotto anni”. Fidesz ha promosso l’iniziativa come parte di un
programma per proteggere i minori dalla pedofilia. Le lezioni di educazione
sessuale, inoltre – si legge ancora – “non dovrebbero essere finalizzate a
promuovere la segregazione di genere, il cambiamento di genere o
l’omosessualità”. In base a questo testo, una pubblicità come quella lanciata
dalla Coca-Cola nel 2019 per promuovere l’accettazione dei gay in Ungheria non
sarebbe ammessa, così come film e libri che mettono in scena dinamiche di amore
omosessuale. E infatti il canale televisivo commerciale RTL Klub Hungary ha già
fatto sapere che pellicole come “Il diario di Bridget Jones”, “Harry Potter” e
“Billy Elliot” saranno trasmesse d’ora in poi soltanto in seconda serata e
accompagnate da un divieto di fruizione ai minorenni. Lunedì sera oltre 5mila
persone si erano radunate di fronte al palazzo dell’assemblea legislativa, in
riva al Danubio, per protestare contro un testo che – sostengono – limita
gravemente la libertà di espressione e i diritti dei bambini. Anche Dunja
Mijatovic, Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa, aveva
invitato a “vigilare contro tentativi di introdurre misure che limitano i
diritti umani o stigmatizzano alcuni membri della società”. Le organizzazioni
per i diritti umani, ha ricordato, sostengono il diritto dei bambini a
un’educazione sessuale completa, che verrebbe resa impossibile dalla censura sui
temi Lgbt. “La legge contrasta con gli standard internazionali ed europei”, ha
detto. “È una legge incompatibile con i valori fondamentali delle società
democratiche europee e con i valori dei cittadini ungheresi, soltanto l’ultimo
dei molti vergognosi attacchi ai diritti Lgbtiq dal governo di Viktor Orbán”,
scrive in una nota Anna Donath, eurodeputata ungherese del gruppo liberale Renew
europe (successore dell’Alde). Il gruppo a Bruxelles condanna la
“putinizzazione dell’Ungheria da parte di Viktor Orban” e descrive la legge come
“una replica della legge russa in vigore dal 2013 che vieta la propaganda Lgbtiq
e che, proprio come in Russia, diventerà uno strumento
di molestia e discriminazione”.
Quel nichilismo sessuale che si nasconde
dietro la legge Zan. Karen Rubin il 29 Maggio 2021 su
Il Giornale. L'attrice Ellen Page una nomination all'Oscar per la sua
interpretazione nel film «Juno», nel ruolo di una adolescente incinta, ha
pubblicato sui social una foto dopo la mastectomia, ashtag #transisbeatyful.
Dopo l'asportazione del seno chiede di essere chiamata Elliot. Nella sua
biografia su Wikipedia è descritto come Elliot ma le foto che accompagnano il
racconto sono ancora quelle di una femminilissima Ellen. A differenza della
cantante Demi Lovato, che si è dichiarata non binaria, cioè né femmina né
maschio, Ellen-Elliot ha scelto di essere un uomo dopo più di trent'anni
trascorsi da donna. Dopo la copertina dell'Espresso in cui campeggiava un uomo,
ex donna, incinto ma con la barba, i giornali hanno definito toccante il
discorso di Valeria Solarino al WeWorld Festival: «Sono maschio e sono femmina,
sono uomo e sono donna. Sono due in uno anzi, uno in due. Sono tutto, sono Dio».
Come recitava Ivan dei Fratelli Karamazov se Dio non c'è tutto è consentito. Ma
c'è la psichiatria: due in uno si chiama sdoppiamento della personalità e
credere di essere Dio configura un palese delirio di onnipotenza. Tra la
concezione ultraconservatrice di Pillon, per cui alle donne compete l'ostetricia
e non l'ingegneria mineraria, e quella di Zan, per cui è possibile definirsi
donna anche senza esserlo c'è la realtà, non quella soggettivamente percepita ma
oggettiva. Ci sono state e ci sono donne che nel campo della scienza dimostrano
talenti che si ritenevano prerogative maschili confutando l'ipotesi di Pillon.
Lo stesso non si può dire del genere sessuale. Il dato anatomico non è una
credenza né una costruzione culturale, non è una percezione soggettiva ma pura
biologia. Gli appartenenti alla specie Sapiens nascono donna o uomo, nulla può
cambiare questo semplice e incontrovertibile dato di realtà. Ellen Page può
eliminare il seno, può ingerire testosterone, può indossare il frac, ma la
percezione di essere Elliot è un autoinganno perché era e rimane una donna, a
prescindere dalla mutilazione, dall'abito, dal ruolo sociale e dall'orientamento
sessuale. Dopo un secolo di lotte per scardinare il dualismo cartesiano che
voleva una scissione tra corpo e mente siamo tornati alla svalutazione del
corpo, come se fosse irrilevante al punto da poterlo negare o addirittura
cancellare. Liberarsi dei propri organi sessuali e riproduttivi è diventata una
proclamazione di libertà. Un nichilismo in cui non c'è più la differenza
sessuale, Dio ma neanche la madre, sostituiti da un uomo barbuto che trasforma
la generatività in un delirio distruttivo di onnipotenza.
Chi sono le «Terf», le
femministe «critiche del genere» che si oppongono al ddl Zan.
Elena Tebano il 6/5/2021 su Il Corriere della Sera. Uno dei luoghi comuni nella
discussione del Ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia e gli altri
reati d’odio, è che vi si oppongano anche «le femministe» e «le associazioni
lesbiche». Come molti luoghi comuni non è vero: vi si oppone una minoranza di
femministe, con una netta connotazione generazionale (sono soprattutto, anche se
non solo, donne over 50), e un’unica associazione lesbica, Arcilesbica, rimasta
ormai isolata nell’associazionismo lgbt+. La maggior parte delle associazioni
lesbiche italiane infatti ha preso posizione a favore del Ddl Zan, così come lo
ha fatto la parte più corposa dei gruppi e delle militanti femministe,
soprattutto quelle più giovani. Le femministe critiche del genere, meglio
conosciute come Terf («Trans Exclusionary Radical Feminists», «femministe
radicali trans escludenti») — un acronimo nato nei circoli femministi degli anni
70 che loro rifiutano definendosi solo «femministe radicali» — hanno infatti una
visibilità sovradimensionata rispetto alla loro diffusione reale nel movimento
delle donne e in quello lgbt+, soprattutto nei media tradizionali, grazie a due
motivi principali. Uno è il fatto che le sue esponenti di punta vengono per lo
più dal mondo dei media, di cui conoscono bene i meccanismi, come la regista e
scrittrice Cristina Comencini e la giornalista Marina Terragni (autrice di «Gli
uomini ci rubano tutto»). L’altra è l’alleanza con il mondo del cattolicesimo di
destra: Arcilesbica, per esempio, era quasi scomparsa negli ultimi anni sia in
termini numerici — l’associazione non rende pubblici i dati sulle sue tesserate
— che di visibilità pubblica. Ma grazie alle sue posizioni critiche nei
confronti delle persone transgender e contro la gestazione per altri, rilanciate
spesso da siti e testate che si riconoscono nel conservatorismo cattolico, ha
acquisito una rilevanza mediatica che non aveva mai avuto. Il conflitto tra
questa minoranza e il resto del movimento femminista e lgbt+ però non è
irrilevante, perché mette in luce alcuni dei nodi principali che riguardano la
condizione delle donne in Italia e in generale nel mondo più ricco. Per capirlo
appieno è utile vedere come si è sviluppato questo «femminismo radicale».
L’attivismo delle «femministe critiche del genere», o Terf, italiane è legato
infatti a doppio filo con quello britannico, che infatti esso cita costantemente
come proprio riferimento politico e culturale, e che vede nella scrittrice JK
Rowling la propria esponente più nota. Mentre negli Stati Uniti l’opposizione
alle istanze lgbt+ e in particolare transgender è guidata soprattutto dalla
destra religiosa, in Gran Bretagna è portata avanti da attiviste che vengono
dal mondo progressista e della sinistra. Come è possibile? In un’inchiesta su
Lux la giornalista Katie J.M. Baker spiega che la fazione femminista «critica
del genere» si è sviluppata quando nel Paese veniva discusso il Gender
Recognition Act («Legge per il riconoscimento di genere», o Gra) del 2004, una
legge che sul modello di altri Paesi, come Argentina, Irlanda e Portogallo,
avrebbe permesso alle persone trans di cambiare il loro genere legale sui
documenti senza l’obbligo della sterilizzazione forzata e senza una diagnosi
medica. La cosa interessante è che in Gran Bretagna la legge per il
riconoscimento di genere — come già il matrimonio egualitario, le nozze gay —
era stata proposta dal governo conservatore dei Tory, allora guidato da Theresa
May. E quindi anche per questo trovava “naturalmente” opposizione a sinistra. A
diffondere le idee delle femministe trans-escludenti in Gran Bretagna, però, è
stato soprattutto un sito, Mumsnet, la «rete delle mamme», un social network
creato 21 anni fa che verteva soprattutto — scrive Baker — su «consigli su come
disincrostare la lavastoviglie e associato a mamme compiaciute e snob che
confrontavano passeggini di fascia alta e si lamentavano del cane del vicino che
mangiava le loro begonie». Mumsnet si definisce «la comunità online più popolare
del Regno Unito “per i genitori”», ma le ricerche mostrano che quasi tutti i 7
milioni di Mumsnetters (le utenti di Mumsnet) sono donne. «Più specificamente —
spiega ancora Baker —, si ritiene che siano per lo più donne bianche, borghesi
ed eterosessuali» di reddito medio alto. La sua base di utenti «è considerata
ricca e influente, ed è molto attraente sia per i commercianti che per i
politici» (vi ha tenuto incontri anche Hillary Clinton).
Ddl Zan e il dibattito su
genere e sesso. È proprio l’esperienza della maternità condivisa online, secondo
Baker, che ha portato le utenti di Mumsnet a radicalizzarsi contro le donne
transgender, che non considerano tali e definiscono spesso «uomini mascherati».
«Leggendo una discussione dopo l’altra, ho notato che molte delle donne che
postavano hanno scritto di essersi sentite di nuovo prive di diritti e isolate
dopo aver partorito; buttate fuori da una società in cui avevano precedentemente
goduto di potere in virtù della loro relativa ricchezza e istruzione.
Organizzandosi intorno a questo tema “tabù” stavano sperimentando la solidarietà
e il senso di avere uno scopo che era mancato nelle loro vite post parto —
racconta Baker — . “Non sto dicendo alle persone trans che sono sbagliate perché
sono trans, sono arrabbiata perché le donne vengono chiamate transfobiche se
dicono che le loro funzioni biologiche sono solo loro”, ha scritto una donna in
un thread di giugno 2020 intitolato “Pro Women, Not Anti Trans - Why Biology Is
Important” (“Pro donne, no anti trans. Perché la biologia è importante”). Ha
continuato: “Non si tratta di genere, si tratta di sesso e anatomia e di come
influenzano le donne ogni giorno, e di quanto sia dannatamente ingiusto per gli
altri negare i nostri corpi, come funzionano o le nostre opinioni perché non
sono considerate inclusive per coloro che non potranno mai essere biologicamente
gli stessi”». «Essere incinta, partorire e allattare sono l’unico momento della
mia vita in cui ho sentito una giusta consapevolezza di essere femmina» scrive
un’altra utente. «Non intendo in senso di identità di genere, ma in senso di “ho
un corpo femminile e sto facendo qualcosa che solo una persona con un corpo
femminile può fare”». L’insistenza sull’importanza del legame biologico nella
maternità è anche il tema ricorrente delle attiviste Terf italiane. In Italia
però, a differenza che nel Regno Unito, lo hanno sostenuto soprattutto a
proposito della gestazione per altri (gpa). Non è un caso che le «femministe
radicali» italiane se la siano presa soprattutto con i gay che ricorrono
alla maternità surrogata, che pure sono una minoranza rispetto alle coppie
etero. Non dipende solo dal fatto che i gay sono più visibili (non possono
fingersi genitori biologici dei bambini che nascono da madri surrogate). Ma
anche perché — come ha detto con la chiarezza intellettuale che la
contraddistingue la filosofa Luisa Muraro —: la gpa dei gay «fa sparire le
mamme». Priva l’atto biologico del partorire di quel valore simbolico — il
Materno — intorno al quale questa corrente femminista costruisce l’identità
delle donne. Secondo Baker insomma le community online hanno radicalizzato le
donne fornendo loro un «capro espiatorio» (le persone transgender) a
un malessere che è motivato da questioni molto reali. «Alcune di queste nuove
Mumsnetters “gender critical” erano donne relativamente privilegiate che non si
erano mai sentite emarginate fino a quando non hanno partorito e si sono sentite
isolate nelle loro famiglie nucleari e (giustamente!) indignate per la mancanza
di sostegno alle madri nel Regno Unito» scrive. «Il forum sui diritti delle
donne di Mumsnet non ha solo offerto alle donne uno spazio sicuro per
organizzarsi. Fornendo una piattaforma che tollerava l’ideologia Terf, ha anche
consegnato alle utenti un comodo capro espiatorio per tutti i loro problemi: non
l’austerity, non la misoginia, ma la relativamente piccola ed estremamente
marginalizzata e oppressa popolazione trans». In una società in cui le donne
hanno fatto passi avanti nella rivendicazione di diritti e opportunità, la
gravidanza e la maternità rimangono ancora uno scoglio che le rigetta nella
solitudine (e nella sensazione di una condizione unica) perché non ci sono
servizi adeguati per chi ha figli piccoli. Manca una cultura della condivisione
e della responsabilità comune — anche sociale (gli asili, una società che non
sottometta la vita al lavoro) —nei confronti della genitorialità. Ed è proprio
qui l’equivoco di fondo delle «femministe critiche del genere». Non è tornando
all’idea di sesso che riusciranno a uscire dall’isolamento a cui la società
consegna le donne facendone le uniche depositarie della cura dei figli. La
soluzione non sta nell’attribuire alla riproduzione biologica la fonte di
legittimità del valore delle donne, ma nel condividere la cura dei bambini (e
degli anziani) a prescindere dal genere di appartenenza. Il concetto di genere,
storicamente, è stato il più grande strumento di emancipazione delle donne.
Sintetizzato nella famosa frase di Simone de Beauvoir («Donne non si nasce, si
diventa») è servito a emancipare le donne dal loro destino biologico. Ha
permesso di capire che nascere con i cromosomi XX o i genitali femminili non
significa avere un libretto di istruzioni per la vita che verrà: le donne sono
libere di riempire quella vita come vogliono. Le nuove generazioni hanno portato
questa emancipazione un passo più in là: sanno che quei cromosomi o
quell’anatomia non obbligano a un orientamento sessuale. E neppure
necessariamente a definirsi donne (o uomini). E infatti ci sono sempre più
persone transgender che rifiutano di essere definite in base a una dicotomia di
genere. Questo spiega la frattura delle «femministe radicali» con le nuove
generazioni. Questo spiega perché un rapper maestro dei social come Fedez ha
potuto dare voce alle istanze di quei ragazzi e quelle ragazze: «rappresenta —
come nota lo scrittore Jonathan Bazzi su Domani — anche una nuova generazione di
genitori, più liberi, in grado di anteporre il bene dei figli al copione che la
società ha predisposto per loro». Perché parlare di genere non significa
negare la libertà delle donne, ma potenziarla.
(Questo articolo è tratto
dalla newsletter «Il Punto» del Corriere della Sera.)
L’ingiustizia che creerà il
ddl Zan applicato alle competizioni sportive.
Carlo Panella il 6/5/2021 su L'inkiesta. Il senatore Zan, la Senatrice Cirinnà e
tutti gli oltranzisti del dogma della “identità di genere”, devono rispondere a
questa domanda: si rendono conto che con la loro legge mandano in galera Caitlyn
Jenner, noto transessuale americano, medaglia d’oro olimpica nel 1976 nel
decathlon maschile prima del cambio di sesso e candidata Gop alla carica di
governatore della California, e Marina Navratilova eccelsa tennista lesbica, che
sostengono che nello sport l’identità di genere è né più né meno che una truffa
che mortifica e penalizza le donne? Secondo l’articolo 4 della legge Zan la
risposta è inequivocabile: le manderebbero in galera, così come tutti gli
italiani che la pensano come loro, perché l’una e l’altra hanno sostenuto tesi
apertamente discriminatorie nei confronti delle donne e ragazze trans nello
sport. Caitlyn Jenner ha detto: «La partecipazione delle ragazze trans negli
sport femminili non è giusta. È una questione di giustizia, per questo mi
oppongo alla partecipazione nello sport femminile delle ragazze trans, ma
biologicamente maschi. E dobbiamo proteggere gli sport femminili nelle nostre
scuole». Da parte sua Martina Navratilova ha scritto sul Sunday Times:
«È ingiusto che le donne debbano competere contro persone che, biologicamente,
sono ancora uomini. Sono felice di rivolgermi a una donna transgender in
qualsiasi forma preferisca, ma non sarei felice di competere contro di lei».
Come si vede, se si guarda allo sport, il bianco e il nero sulla questione del
genere diventa meno impalpabile e scivoloso di quanto accade se si discute o
discetta riferendosi alla sfera sessuale. Nell’esercizio dello sport esistono
solo uomini e donne, maschi e femmine, nessuna sfumatura, per una ragione reale,
incontrovertibile, fisiologica: la massa muscolare, la struttura ossea e il
sistema ormonale di chi è nato maschio, uomo, esprimono incomparabilmente più
potenza e forza di quelle che può esprimere chi è nata femmina, donna. Il cambio
di sesso, non modifica questa realtà dettata dalla natura. Nello sport si è uomo
o donna. Niente terzo sesso e varietà soggettive. Dunque, nello sport,
«l’identificazione percepita di sé, anche se non corrispondente al sesso», base
strutturale della teoria del genere, non può, non deve essere applicata. È
necessario, la natura questo impone, discriminare per sesso di nascita. Se non
lo si fa, si commette una palese, intollerabile, ingiustizia che per di più
manda a catafascio tutta la struttura di base di tutte le attività sportive. E
questo non riguarda lo sport di élite, professionale, ma una platea di centinaia
di milioni di studenti e giovani che praticano attività sportive e dunque
partecipano a tornei e campionati. Dunque, una delle basi concettuali del
disegno di legge Zan, che ribadisce infinite volte nei suoi articoli il termine
“genere” è fasulla, sbagliata e impraticabile. Ma ancor più grave e ingiusto è
che chi sostiene, a ragione, che nello sport è indispensabile discriminare
(secondo la Treccani: distinguere, separare, fare una differenza) tra donne e
uomini, chi è nata femmina e chi è nato maschio, possa un domani essere
condannato a pene detentive pesanti sulla base dell’articolo 4 della legge Zan.
Ma questo avverrà grazie alla insostenibile leggerezza dell’essere del pensiero
di una sinistra progressista che ha scelto di inseguire pasticciate chimere.
Gianluca Veneziani per "Libero Quotidiano" il 19
aprile 2021. Fortuna che c'è chi dice no, resiste e non si adegua al conformismo
cretino che porta vip e non ad aprire le mani e imbrattarsele con una scritta,
«Ddl Zan», riferita a un testo di legge che molti di loro non hanno neppure
letto. Quelle mani aperte sono un mani in alto, un segno di resa al Monopensiero
che fa compiere gesti a mo' di automi, solo per obbedire a chi detta l'agenda
culturale, con spirito gregario. E invece c'è chi non ci sta, anche se proviene
dal mondo arcobaleno e in teoria dovrebbe sposarne a pieno le battaglie. Una, ad
esempio, come Anna Paola Concia, attivista Lgbt, lesbica ed ex parlamentare del
Pd, che in un'intervista ad Avvenire ha snocciolato le sue perplessità sul ddl
Zan, il provvedimento che vorrebbe punire con la reclusione chiunque compia o
esorti a compiere non meglio definiti «atti di discriminazione» nei confronti di
gay, trans e altre "minoranze" sessuali. La Concia chiede di togliere il «sesso»
dall'elenco delle possibili ragioni di discriminazione, perché così - sostiene
lei - si coinvolgerebbero anche le donne che sono la metà dell'umanità, non
esattamente una minoranza. Poi esorta a rivedere le cavillose distinzioni,
contenute nell'articolo 1 del ddl, tra «sesso, genere, orientamento sessuale e
identità di genere», categorie, aggiungiamo noi, non scientifiche ma figlie
dell'ideologia gender. E ancora, la Concia si pone una domanda di natura
politica: se questa legge è tanto «divisiva», pur volendo essere inclusiva e
anti-discriminatoria, è proprio il caso di approvarla così com'è? L'ultima
obiezione dell'ex deputato è forse la più pertinente: per tutelare gay, trans e
altri orientamenti sessuali - lascia intendere - non c'è bisogno di alcuna legge
ad hoc. Nel caso essi subiscano violenze, esistono già le leggi ordinarie a
difenderli; semmai si potrebbero applicare «delle aggravanti» per quello come
per gli altri crimini di odio. Le sue affermazioni diventano ancora più
interessanti, in quanto dette da una parlamentare che nel 2008 proponeva una
legge contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o
dall'identità di genere. Si vede che, col tempo, la Concia deve aver capito che
certe leggi, creando categorie protette, lungi dal tutelarle, finiscono per
ghettizzarle. Un processo quasi inverso, quello della Concia, rispetto a quello
vissuto da Alessandra Mussolini che ora, lasciata la politica e datasi al ballo,
ha dimenticato anche le sue vecchie convinzioni. La nipote del Duce che nel 2006
gridava a Luxuria «Meglio fascista che frocio!» aderisce adesso alla campagna
delle mani aperte e promuove il ddl Zan come panacea contro le
«discriminazioni». Se prima era nel torto, ora non si può dire che abbia
ragione. Di sicuro, a farle difetto è la coerenza. Naturalmente il coro dei
benpensanti plaude alla Mussolini e insulta la Concia. Per aver osato
manifestare il suo pensiero, la ex parlamentare Pd è stata riempita di improperi
sui social, da «non sei mai stata un'aquila» a «esprimi solo cazzate», da
«perché non stai zitta?» a «dovresti vergognarti» fino a «che schifo fai» (a
proposito, dove sono le femministe e i paladini Lgbt che condannano il
linguaggio di odio?). Questa vicenda dimostra chiaramente una cosa. Non solo il
ddl Zan, se approvato, andrà a limitare la libertà di espressione (la reclusione
per chi commette o istiga a commettere atti di discriminazione rischia di
riguardare anche chi si oppone civilmente a nozze gay o utero in affitto). Ma
già adesso la dottrina unica delle Mani Aperte e dei Cervelli Chiusi imbavaglia
chi dice la propria e osa pensarla diversamente. E meno male che il ddl Zan
tutela la diversità.
"Vi spiego perché il ddl Zan non ha
senso". Francesco Curridori il 4 Maggio 2021 su Il
Giornale. Il magistrato ed ex parlamentare Alfredo Mantovano, in questa lunga
intervista, ci aiuta a capire nel dettaglio tutte le contraddizioni del ddl Zan.
Abbiamo interpellato il magistrato ed ex parlamentare Alfredo Mantovano, autore
del libro Legge omofobia perché non va. La proposta Zan esaminata articolo per
articolo, per capire nel dettaglio tutte le contraddizioni del ddl Zan.
Quali sono le lacune giuridiche del ddl Zan?
"Se si prendono in considerazione le relazioni che
accompagnano le varie proposte di legge che, poi, sono confluite nel testo del
relatore, l'onorevole Zan, ci sono due costanti. La prima è quella di denunciare
una grave emergenza di reati, anche gravi, commessi a causa dell'orientamento
sessuale. La seconda è la constatazione che, a fronte di questa emergenza, il
quadro normativo è incompleto e c'è la necessità di intervenire con nuove
disposizioni. Questi due presupposti, al confronto con la realtà, non reggono".
Perché?
"Basta guardare i dati oggettivi forniti dal
ministero dell'Interno che nel 2010 ha istituito un osservatorio che si occupa
del monitoraggio sulle offese basate sulle discriminazioni di vario tipo, tra
cui quelle relative all'orientamento sessuale. Facendo la media dei dati
disponibili, in un decennio, risultano segnalazioni per offese relative
all'orientamento sessuale pari al 26,5% l'anno su tutto il territorio nazionale.
Non mi pare un'emergenza, dal momento che 26 segnalazioni in un anno ci sono in
una scuola per fatti di bullismo. Qui, invece, si sta parlando di atti avvenuti
non in un singolo istituto scolastico, ma su tutto il territorio nazionale".
Ma, per punire determinati reati, nel nostro
ordinamento non esistono già delle aggravanti?
"Sì. Per quanto riguarda il secondo presupposto su
cui si basa il ddl Zan, ossia che il quadro normativo attuale sia incompleto,
invito a scorrere le norme del codice penale e si può vedere che non c'è
esclusione applicativa per nessuno e per le offese portate nei confronti di
qualcuno quanto a percosse, violenze, stalking, violenze di vario tipo. Anzi, il
codice penale, in aggiunta a questa rassegna di reati, aggiunge due aggravanti:
la minorata difesa e i motivi abbietti e futili che possono trovare applicazione
in vicende come quelle di cui si parla. Se uno provoca lesioni a una persona a
causa dell'orientamento sessuale è probabilmente per un motivo futile o
riprovevole. E se queste lesioni sono il frutto di un'attività coordinata si
approfitta della posizione di forza e, quindi, della minorata tutela della
vittima. Anche dal punto di vista di situazioni particolari l'ordinamento è
complesso".
Ma le disposizioni del ddl Zan possono ledere la
libertà d'espressione?
"Queste norme, poi, sono considerate gravemente
discriminatorie perché sono così generiche che si corre il rischio che la loro
applicazione leda la libertà di esprimersi di una persona, la libertà di
educazione nelle scuole ecc... Se si prende in considerazione la relazione della
proposta di legge che vede come primo firmatario l'onorevole Scalfarotto si fa
l'esempio di una mamma alla quale la figlia riferisca che sta per iniziare la
convivenza con una persona dello stesso sesso. Secondo Scalfarotto, se tale
madre proverà a dissuadere la figlia non sarà mai condannata perché davanti al
giudice avrà la possibilità di esprimere le proprie ragioni. Ora, che una
semplice conversazione avvenuta nelle mura domestiche si trasferisca in un'aula
di tribunale, al di là dell'esito del processo, costituisce un trauma per chi
subisce il processo, soprattutto se si tratta di una persona che non ha mai
avuto a che fare con la giustizia come la maggior parte delle mamme di famiglia.
Ma non solo. Il testo costituisce anche un pesante condizionamento per tanti
genitori che saranno dissuasi dall'affrontare tali temi con i propri figli. Ma
lo stesso discorso vale per i catechisti che insegnano il creazionismo, il
rispetto tra uomini e donne nel matrimonio ecc...".
Qual è il limite più grande del ddl Zan?
"Il limite più grande di tale legge è che consegna
al giudice una tale genericità di espressioni che al loro interno ci può stare
davvero tutto. Nei lavori alla Camera, la commissione Affari Costituzionali ha
dato il suo parere di conformità alle nuove norme e ha posto delle condizioni,
tra cui la richiesta di precisazione delle disposizioni contenute nel ddl,
essendo a rischio il criterio della tassatività proprio della norma penale. Alla
Camera è stata, dunque, introdotta la norma salva-idee volta nelle intenzioni a
disinnescare i gravi effetti contenuti nella norma. Ciò però significa che
quelle disposizioni sono pericolose altrimenti non ci sarebbe bisogno di quella
norma. Inoltre, poi, tale norma aumenta la genericità perché si dice che viene
riconosciuto il diritto a esprimere le proprie opinioni che, prima che dal ddl
Zan viene riconosciuto dalla Costituzione e lascia al giudice decidere qual è il
limite di esprimibilità delle stesse".
Il ddl Zan introduce il concetto di identità di
genere. In merito, cosa ci può dire?
"Per dare seguito al parere della commissione
Affari costituzionali, è stato inserito l'articolo 1 che dà la definizione di
identità di genere, un concetto che non era mai stato usato prima. In tale
articolo si dice che l'identità di genere è la percezione che qualcuno ha di se
stesso nel momento in cui una persona sta facendo un percorso di transizione da
un sesso all'altro anche se tale percorso di transizione non si è definito. Ma,
dall'esterno, un comune cittadino o anche un giudice come fa a coglierlo e come
fa il giudice, sulla base di elementi così vaghi, a irrogare anni di reclusione?
Il problema, però, non è tanto quel che si stabilisce con la sentenza, ma che
quando la reclusione supera certi tetti di pena, durante le indagini, possono
essere chieste ordinanze limitative della libertà. In sintesi si può finire in
carcere in via cautelare o si può essere intercettati. Ogni magistrato, quindi,
può interpretare una norma così generica in base al proprio condizionamento
ideologico e arrivare ad applicazioni veramente contrastanti col diritto e col
buonsenso".
Ma se un giorno un minorenne esprime la sua
volontà di cambiare sesso, i suoi genitori possono essere perseguiti se glielo
impediscono?
"Non c'è nessun ostacolo per cui non ci sia la
persecuzione. Ma si troverebbe in difficoltà anche il titolare di una palestra
davanti al quale si presentasse un uomo che dichiara di aver iniziato un
percorso per diventare donna e chiedesse di allenarsi con la squadra femminile
oppure di usare i bagni delle donne. In nazioni dove norme come il ddl Zan sono
diventate leggi, sono emersi casi del genere. In Spagna nel 2014 un vescovo,
Sebastian Aguilar, nominato cardinale da papa Francesco, disse in un'intervista
che le persone omosessuali vanno rispettate, ma le loro scelte di vita non
possono equipararsi alla famiglia tra uomo e donna perché una delle
caratteristiche di quella famiglia è l'apertura alla vita e, quindi, non è
possibile per una coppia omosessuale avere dei figli. In virtù di tale
dichiarazione è stato iscritto nel registro degli indagati per omofobia, poi il
procedimento si è fermato perché il cardinale nel frattempo è morto però,
intanto, si era avviata l'azione penale nei suoi confronti. In Francia, qualche
anno fa, un padre di famiglia che indossava una felpa che raffigurava un padre e
una madre che prendevano per mano dei figli ha trascorso una notte in cella
perché quel disegno è stato considerato omofobo".
Ma poi è stato assolto?
"Al di là di come finiscono i singoli procedimenti
penali, la condizione di indagato e arrestato lascia un segno e, quindi,
determina un condizionamento per il futuro".
Un partito come il Popolo della Famiglia potrebbe
esistere?
"Con un pubblico ministero molto ligio nel far
applicare il ddl, il Popolo della Famiglia verrebbe considerata un'associazione
omofoba e, quindi, verrebbe sciolta per legge come se fosse un partito
neonazista e i suoi promotori rischiano una condanna fino a sei di reclusione".
Alessandra Arachi per il “Corriere della Sera” il
4 maggio 2021. Non soltanto la maggioranza, il ddl Zan divide l'universo
femminista. E divide anche le famiglie: Cristina Comencini guida lo schieramento
delle donne che il testo sull'omotransfobia vorrebbero emendarlo, mentre la
sorella Francesca sta con le femministe che vorrebbero approvarlo così come è.
Premesso che sono tutte ovviamente favorevoli a una simile legge, il disegno di
legge Zan ha tuttavia frantumato anche lo schieramento di «Se non ora quando» e
adesso nella parte che si chiama «Libere» è la voce di tante storiche femministe
che si leva a chiedere cambiamenti alla legge. «Aver esteso il ddl Zan anche ai
reati di misoginia e disabilità fa regredire le donne nel passato, le considera
una categoria, una minoranza, mentre siamo più della metà del Paese», commenta
Francesca Izzo, storica del pensiero moderno e contemporaneo e da sempre
femminista. E aggiunge: «Anche sull'identità di genere bisognerebbe fare dei
cambiamenti». È Marina Terragni a spiegarci quali cambiamenti per l'identità di
genere. Storica femminista che ha fatto le battaglie accanto al Mit, Movimento
italiano transessuali, Terragni dice: «L'identità di genere è un oggetto non
definito e non puoi mettere in una legge penale un oggetto non definito. Nel
testo si parla di identità autopercepita che è l'ambiguità che apre la porta
alla Self-Id , l'autopercezione del genere. Per capire: in California, dove la
Self-Id è diventata legge ci sono stati 270 detenuti che si sono dichiarati
donne e hanno chiesto di andare nel carcere femminile, con il terrore delle
detenute. In Gran Bretagna è successo lo stesso con uno stupratore che si è
dichiarato donna. Non basta l'autocertficazione per cambiare sesso, ci vuole un
percorso». Per Terragni è da modificare anche l'ingresso nelle scuole per
parlare della gravidanza per altri (l'utero in affitto): «Non si capisce, per
l'ora di religione ci vuole il consenso dei genitori e per questo no, perché lo
decide una legge». Sulla gravidanza per altri, Gpa, si esprime anche la
presidente di Arcilesbica Cristina Gramolini: «Bisognerebbe emendare il ddl Zan
seguendo una legge approvata dall'Emilia-Romagna: la Regione non finanzia le
associazioni che propagandano la Gpa. Con il ddl Zan criticare l'utero in
affitto viene considerato omofobia». A chiedere emendamenti al disegno di legge
zan anche tante altre voci storiche del femminismo. Dice Terragni: «Cè l'Unione
donne italiane, Udi, la Libreria delle donne e anche una associazione di uomini
come Equality Italia, guidata da Aurelio Mancuso».
Fausto Carioti per "Libero Quotidiano" il 4 maggio
2021. «Sono cominciate come legittime campagne per i diritti umani. È per questo
che sono arrivate a tanto. A un certo punto, però, si sono sfondate le barriere
di sicurezza. Non contenti di essere uguali, hanno preso a collocarsi su
posizioni insostenibili in quanto "migliori". Qualcuno ribatterà che l'intento
era semplicemente quello di passare per un po' da "migliori" in modo da
pareggiare il campo di gioco della storia. Finora nessuno ha suggerito quando si
sia ottenuta tale ipercorrezione, o su chi si possa contare (...) (...) per
darne l'annuncio. Quel che tutti sanno è come verranno chiamati coloro che
pestino queste trappole esplosive piazzate di recente. "Intolleranti",
"omofobi", "sessisti", "misogini", "razzisti" e "transfobici", tanto per
cominciare». Pare un filmato girato nel giardino italiano, dove risuonano gli
anatemi di Michela Murgia e altri nanetti del pensiero. Invece le parole qui
sopra le ha scritte nei mesi scorsi un commentatore politico inglese che si
chiama Douglas Murray, conservatore, incidentalmente omosessuale. Il fatto che
il movimento Lgbt abbia «cominciato a comportarsi - da vincitore - come un tempo
facevano i suoi avversari» (sempre Murray), dettando ciò che è giusto e ciò che
non lo è, finendo poi scavalcato dai suoi aspiranti salvatori nella corsa verso
le nuove intolleranze, non è, insomma, un'esclusiva italiana. Fa parte
dell'attentato alla libertà di espressione in atto in ogni angolo d'Occidente.
Un'isteria collettiva che qui da noi si è raggrumata attorno al disegno di legge
Zan, già approvato alla Camera e presto all'attenzione del Senato. Quello per
cui Fedez (ognuno ha il Bob Dylan che si merita) ha predicato l'altro giorno,
dal palco del concertone. Basterebbe un numero, per smontare l'urgenza del
provvedimento: 35,1. Sono le segnalazioni relative a crimini o discorsi d'odio
contro l'orientamento sessuale o l'identità di genere che ogni anno, in media,
arrivano all'Oscad, l'Osservatorio del Viminale cui affluiscono i dati di
polizia, carabinieri, vittime, associazioni, testimoni. Appena 316 casi dal 2011
al 2019. Semplici segnalazioni, non reati veri e propri, che alla fine saranno
ancor meno. Le sole profanazioni di tombe per odio razziale e religioso
risulterebbero essere quattro volte di più, 146 l'anno, ma nessuno ne fa una
battaglia politica. L'ultimo dei problemi reali che hanno gli italiani, a
maggior ragione in tempo di Covid, è dunque quello in cima all'agenda della
sinistra e dei grillini. Pure ieri costoro, galvanizzati da Fedez, hanno
proseguito la crociata che dovrebbe liberare l'Italia dal male. Per alimentare
l'ossessione devono far credere non solo che ci sia un'emergenza enorme,
smentita dai numeri, ma anche che i crimini ai danni di omosessuali, lesbiche e
trans oggi rimangano impuniti. Come ha detto il cantante, la legge Zan serve a
difendere «persone che vengono quotidianamente discriminate fino alla violenza».
Che è una menzogna, ovviamente: quelle persone sono già tutelate, dalle stesse
leggi che valgono per ogni italiano. L'idea di inasprire le pene per ridurre i
reati ai loro danni non solo crea disuguaglianze tra cittadini, ma è infondata
quanto la pretesa di limitare gli omicidi punendo gli assassini con la pena di
morte: cosa che non accade, come dimostrano le statistiche. Dove la legge di
Alessandro Zan e Laura Boldrini promette di essere efficace, invece, è nel
limitare la libertà di parola. Finirà dinanzi al giudice chi si ostina a credere
che il sesso sia un dato biologico. Il caso che in Inghilterra ha visto Joanne
Rowling bruciata dalla nuova inquisizione è nato così: la scrittrice si era
permessa di difendere una fiscalista cacciata dall'istituto in cui lavorava per
aver sostenuto che l'identità sessuale di un individuo non può essere cambiata
da un provvedimento amministrativo. Rischierà l'insegnante che dovrà spiegare
agli alunni le differenze tra uomo e donna, i docenti cattolici dovranno
prendere a pugni la loro coscienza e trasmettere dogmi in cui non credono o
pagare in prima persona il prezzo della coerenza. Il tutto affogato in un mare
di storture e superficialità che gli stessi omosessuali conoscono bene e spesso
disprezzano. Come l'idea che esista una «comunità» Lgbt alla quale appartengono
felicemente, in piena identità di vedute, gay, lesbiche, bisessuali e
transessuali. Gruppi (e già è un errore chiamarli così) che sui confini dei
diritti dei trans, ad esempio, hanno mostrato di avere idee contrastanti:
razzisti e transfobici pure loro? O la vigliaccheria con cui si sorvola sul
fatto che i pericoli non vengono dalle istituzioni occidentali, assediate dagli
zeloti dei «nuovi diritti», ma da musulmani come Omar Mateen, l'affiliato
all'Isis che nel 2016 uccise 49 persone in un club gay di Orlando, in Florida. O
nei 73 Paesi dove è illegale essere gay, in otto dei quali è prevista la pena di
morte per gli omosessuali, incluso l'Iran che tanto piace ad Alessandro Di
Battista: pure lui paladino della legge Zan, manco a dirlo.
Francesca Galici per ilgiornale.it il 31 agosto
2021. Quella di Vincenzo De Luca alla festa dell'Unità di Bologna è stata una
voce fuori dal coro. Come spesso accade quando prendere la parola, il presidente
della Regione Campania non ha avuto filtri e rivolgendosi alla platea ha
espresso, tra le altre cose, tutto il suo dissenso per l'attuale formulazione
del ddl Zan. Vincenzo De Luca ha parlato a ruota libera, affrontando di petto
alcuni argomenti caldi per il Partito democratico, definito una "casa
sgangherata" dal presidente, ma offrendo un punto di vista completamente diverso
rispetto a quello dei suoi compagni di partito. Senza girarci troppo intorno, il
presidente della Regione Campania ha bocciato il ddl contro l'omotransfobia: "Io
così com’è il decreto Zan non lo avrei votato, perché se non si cambia almeno la
parte che riguarda le scuole io non lo avrei votato. Ma voi pensate davvero che
sarebbe ragionevole che alle elementari si faccia la giornata contro
l’omotransfobia? Ma andate al diavolo". Non usa mezzi termini e di fatto boccia
la linea del Partito democratico, promotore del ddl Zan, che insieme al
Movimento 5 stelle spinge per la sua approvazione. De Luca ha spiegato anche
perché ha un'opinione così avversa sulla questione: "Un conto è se tu mi dici
che alle ultime classi delle superiori facciamo una giornata di riflessione.
Questo va bene. Ma dobbiamo sapere che, quando affrontiamo temi delicati come
questo, occorre grande misura, grande senso di responsabilità". Dal palco,
quindi, ha proseguito a bacchettare il suo partito per la linea intrapresa:
"Abbiamo fatto una crociata sulla legge Zan e poi abbiamo detto che dobbiamo
dare il voto ai 16enni. Per quello che ho colto io, queste sono le proposte nel
programma del Partito democratico. Ma voi pensate che sulla base di queste
proposte conquistiamo la maggioranza degli elettori?". Vincenzo De Luca,
completamente senza freni, ha aggiunto: "Dobbiamo difendere i diritti, ma non è
immaginabile che su questioni che hanno contenuti morali che vanno aldilà della
politica noi ideologizziamo i problemi". Inevitabilmente, il discorso di
Vincenzo De Luca non è stato accolto con gli applausi dal Nazareno, che è stato
colpito dall'interno e da uno dei suoi esponenti più influenti. "Mentre il Pd
assume con coraggio il profilo di un partito per cui diritti sociali e diritti
civili marciano uniti, qualcuno pensa con furbizia di coprire uno spazio
politico arretrato e anacronistico, alle spalle di cittadine e cittadini le cui
libertà oggi sono ancorate a un livello inferiore che nel resto d’Europa. De
Luca pensi a governare la sua Regione, in cui le aggressioni contro le persone
Lgbti riempiono le pagine di cronaca", ha scritto su Facbook Roberta Li Calzi.
Il governatore della Campania alla Festa
dell'Unità. De Luca contro il Ddl Zan: “A scuola la giornata contro
l’omostransfobia? Ma andate al diavolo!”. Antonio
Lamorte su Il Riformista il 31 Agosto 2021. De Luca spara a zero contro il Ddl
Zan. Per presunte posture ideologiche, per il contestatissimo e dibattutissimo
articolo 7, per ragioni elettorali anche. Le dichiarazioni alla festa dell’Unità
di Bologna domenica sera. Il punto sul quale si stanno concentrando per la
maggior parte i titoli dei giornali: la contrarietà del governatore alla
“istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la
bifobia e la transfobia”, proprio quell’articolo 7 che non gli avrebbe fatto
votare il disegno di legge. “Io così com’è il decreto Zan non lo avrei votato
perché se non si cambia almeno la parte che riguarda le scuole io non lo avrei
votato. Ma voi pensate davvero che sarebbe ragionevole che alle elementari si
faccia la giornata contro l’omotransfobia? Ma andate al diavolo!”, ha detto De
Luca. L’articolo del ddl riconosce nel giorno 17 maggio la Giornata nazionale
contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia “al fine di
promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i
pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale
e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari
dignità sociale sanciti dalla Costituzione” attraverso cerimonie, incontri e
iniziative. E proprio su questo punto De Luca non è d’accordo. “Un conto è se tu
mi dici che alle ultime classi delle superiori facciamo una giornata di
riflessione. Questo va bene. Ma dobbiamo sapere che, quando affrontiamo temi
delicati come questo, occorre grande misura, grande senso di responsabilità – ha
argomentato il governatore – Abbiamo fatto una crociata sulla legge Zan e poi
abbiamo detto che dobbiamo dare il voto ai 16enni. Per quello che ho colto io,
queste sono le proposte nel programma del Partito democratico. Ma voi pensate
che sulla base di queste proposte conquistiamo la maggioranza degli elettori?”.
E ancora, sul ddl Zan, intervistato dalla giornalista Lucia Annunziata: “Certo
che dobbiamo difendere i diritti, ma non è immaginabile che su questioni che
hanno contenuti morali che vanno aldilà della politica noi ideologizziamo i
problemi. Credo che abbiamo sbagliato a rispondere al cardinale Parolin come
abbiamo risposto. Il cardinale Parolin è una personalità rilevante del mondo
cattolico. Nel mondo cattolico c’è uno scontro in atto tra forze conservatrici e
mondo progressista. Noi abbiamo risposto a Parolin in termini volgari e
politicamente insopportabili. I Patti Lateranensi? E che diavolo c’entrano i
Patti Lateranensi. Ma fa’ che il segretario di Stato non può esprimere la
propria opinione? Ma stiamo scherzando?”. L’intervento di De Luca sta facendo
discutere in queste ore – e non c’è da stupirsi, visto che il ddl Zan è stato
tra gli argomenti più dibattuti negli ultimi mesi. Il disegno è passato alla
Camera e ora è fermo al Senato. Oltre 700 gli emendamenti presentati a luglio.
La discussione è slittata a settembre. A criticare le parole di De Luca la
consigliera comunale del Pd a Bologna e portavoce, Roberta Li Calzi, attraverso
Facebook: “Mentre il Pd assume con coraggio il profilo di un partito per cui
diritti sociali e diritti civili marciano uniti, qualcuno pensa con furbizia di
coprire uno spazio politico arretrato e anacronistico, alle spalle di cittadine
e cittadini le cui libertà oggi sono ancorate a un livello inferiore che nel
resto d’Europa. De Luca pensi a governare la sua Regione, in cui le aggressioni
contro le persone Lgbti riempiono le pagine di cronaca”. Particolare da non
dimenticare: Piero De Luca, figlio di De Luca, è vice capogruppo dei dem alla
Camera dei deputati. Il governatore ha comunque infierito sul ddl – “La legge
non è stata approvata e non sarà approvata” – e sul Partito Democratico – “La
capacità di attrazione del Pd oggi è pari a zero. Noi dobbiamo parlare di
sicurezza, sennò facciamo un regalo a quel Neanderthal di Salvini”.
Antonio Lamorte. Giornalista professionista. Ha
frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di
Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di
stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.
Otto e Mezzo, scontro
Sallusti-Padellaro sul ddl Zan: "Il tuo giornale mi ha definito putt*** da
strada".
Libero Quotidiano il 05 maggio 2021. Alessandro Sallusti e Antonio
Padellaro sono stati ospiti di Otto e Mezzo, in onda su La7 e condotto da Lilli
Gruber. Il dibattito del talk verte sul Ddl Zan. E le scintille tra i due non
sono mancate: "Parla di pericolo concreto di comportamenti aggressivi, si
salvaguarda la libertà d'opinione", "Non è così, ci sono già le leggi. Il tuo
giornale mi ha definito put***a da strada". Il botta e risposta tra i due che ha
animato il dibattito. "Se io aggredisco una persona di colore o omosessuale
perché istigato da una idea violenta. La legge dice questo non viola nulla",
spiega Padellaro. Pronta la replica di Sallusti: "C'è il rischio che io scriva
contro l'utero in affitto e un giudice può dire che il mio pensiero è razzista".
Con la replica di Padellaro che smentisce le affermazioni del direttore del
Giornale. "La legge viene interpretata dalla destra in un certo modo perché
pensa di seguire l'elettorato di destra che è contraria a certi temi. In Italia
abbiamo ancora la destra del cortile di casa nostra", spiega Padellato. Alché
gli ricorda Sallusti che esiste già una legge che tutela certe minoranza e che
una altra legge sarebbe inutile. Padellaro invece spiega che la destra si dice
contraria al Ddl Zan solo per fare un dispetto alla sinistra.
DiMartedì, Pietro Senaldi contro Concita
De Gregorio: "Il reato d'opinione non vale per Fedez ma per i leghisti sì".
Libero Quotidiano il 05 maggio 2021. "Tutto sta
nell'essere contro o a favore al reato d'opinione". Secondo Pietro Senaldi, in
collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, il punto è questo. Nella
settimana successiva alle clamorose polemiche intorno a due show nel giro di
poche ore, Pio e Amedeo "politicamente scorretti" su gay e persone di colore
a Felicissima sera su Canale 5 e Fedez, che ha accusato la Rai di aver tentato
di censurarlo al Concertone del Primo maggio per il suo monologo su Ddl Zan e
leghisti, il direttore di Libero sottolinea come sia "curioso che tra chi è a
favore del reato d'opinione ci siano persone che danno del fascista agli altri".
Vale a dire, la sinistra, ben rappresentata in studio a La7 da Concita De
Gregorio, ex direttore dell'Unità e penna di punta di Repubblica. Che mentre
parla Senaldi, scuote spesso il capo in segno di disappunto. D'altronde,
suggerisce Senaldi, sono proprio quegli stessi per cui, quasi magicamente, le
critiche e gli attacchi vengono "sospesi" qualora incappino in qualche buccia di
banana. Un esempio? Fedez sbeffeggia Tiziano Ferro per il suo coming
out ("Cristicchi, vuoi che te lo ficchi?", recitava un suo pezzo) e nessuno dice
nulla. Pio e Amedeo su Canale 5 suggeriscono a un omosessuale di farsi una
risata se qualcuno per strada lo chiama "ricch***e" e vengono tacciati di
omofobia a tempo di record. "Se Fedez dice che a Tiziano Ferro piacciono i
wurstel, allora nessuno dice niente perché è un artista - sottolinea non a caso
Senaldi -. Se quattro consiglieri leghisti assolutamente periferici e alcuni
anche espulsi dalla Lega dicono certe cose, allora diventano oggetti di un
comizio e oggetti di condanna". "Le stesse cose, persone diverse. Questo è il
pericolo del reato d'opinione, che si giudichi non la cosa in sé ma chi l'ha
detta".
Ddl Zan, Renato Farina dalla parte di
Giorgia Meloni: "Perché ha ragione", ecco l'imbroglio sinistro.
Renato Farina Libero Quotidiano il 04 maggio 2021. «La nuova
legge alimenta la censura» La verità elementare sulla censura e la guerra alla
libertà di pensiero e di parola l'ha detta Giorgia Meloni. «Parla di censura chi
vorrebbe introdurre con il ddl Zan la censura per legge e punire con il carcere
chi non si allinea al pensiero dominante». A queste parole tutti si alzano
indignati a dire: non è vero, ma è una furbizia dialettica, un modo per stare
nei binari della Costituzione. Questo disegno di legge già approvato alla
Camera e oggi sul tavolo dei senatori non è così sfacciato. Non dice: vi
censuro, e vi mando in galera per le vostre opinioni. Ma è già adesso un
permesso all'aggressione verbale e alla reclusione morale nel lazzaretto dei
malati nella testa, di chi non scatta negli applausi verso chi non è pronto a
scattare in un applauso entusiasta alle tesi sul sesso fluido e l'educazione
gender (stimolare la decisione a quale genere appartenere sin dall'asilo, a
prescindere dal sesso biologico) e l'utero in affitto che sono l'ipertesto non
dichiarato del disegno di legge (ddl) Zan, di cui il Concertone dei sindacati è
stato il manifesto appeso grazie alla Rai nelle case degli cittadini, e senza
contraddittorio.
SOLO UNO SPOT. Ha detto Meloni al Messaggero: «Il
Concertone è stato usato come pretesto per battaglie ideologiche, come il ddl
Zan, che non c'entrano nulla con il lavoro e i diritti dei lavoratori. Il tutto
sulla tv pubblica e a spese degli italiani. In questo contesto c'è chi usa quel
palco per farsi pubblicità e confezionarsi un megaspot, utile per affermarsi
ulteriormente nei circuiti che contano». Questa ideologia è stata perfettamente
visibile nelle proclamazioni, cosiddetta trasgressiva perché in topless e con il
fiocchetto sui cap**li con i colori arcobaleno della "libertà di amare", come se
ci fosse una legge che lo vieta e impedisce espressione dei sentimenti. Nelle
dichiarate intenzioni il ddl Zan vorrebbe punire le discriminazioni e aggravare
le pene per reati di violenza contro disabili, omosessuali e transessuali
(peraltro le aggravanti ci sono già, e giustamente, non solo nel codice ma nella
prassi dei tribunali). E allora perché questa urgenza? Lo scopo di questa norma
che ha per primo firmatario il deputato del Partito democratico Alessandro
Zan (socio di una ditta che organizza il Padova Pride, fonte L'Espresso) è
l'imposizione del catechismo della morale politically correct. Essa, come
dimostrano le censure inflitte ad esempio dall'Ordine dei giornalisti, ancora
non c'è, ma è già fatta valere come una spada morale per sbudellare i
diversamente pensanti. La punizione in realtà non è ancora penale ma tutto
lascia intendere che un avviso di garanzia a chi parla contro il matrimonio omo
sessuale, le adozioni per coppie gay o lesbiche con annesso il diritto ad aver
figli con l'utero in affitto, non mancheranno. Come si spiega questa urgenza? La
sinistra e i 5 Stelle temono di non riuscire a condurre a termine il programma
di vaccinazione forzata delle loro idee sulla vita e sulla famiglia. Persino le
inoculazioni anti-Covid sono su base volontaria, invece qui si vuole iniettare
l'ideologia nel popolo con la minaccia di sanzioni e piantando uno spillone
voodoo per isolare socialmente chi abbia idee suscettibili di essere definite
omofobe.
ESEMPIO PRATICO. Un esempio pratico? Tempo fa lo
aveva spiegato la stessa Meloni: «Vengo definita omofoba decine di volte al
giorno solo perché considero l'utero in affitto una pratica barbara. Questo non
vuol dire che odi qualcuno, ma che voglio soltanto difendere il sacrosanto
diritto di un bambino ad avere un padre e una madre. Per amore, e non per odio,
conduco queste battaglie. Siamo davanti ad una proposta di legge profondamente
sbagliata, che rischia di creare davvero delle discriminazioni e dei
cortocircuiti incredibili». Basti leggere l'articolo 4 intitolato «Pluralismo
delle idee e libertà delle scelte» per capire a cosa si riferisce la leader di
FdI: «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di
convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al
pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a
determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o
violenti». Se si sente il bisogno di precisare l'ovvio significa che l'impianto
trascina in una situazione di regime da pensiero unico. E la frasetta finale è
minacciosa. Parole che spingano «al concreto pericolo di atti discriminatori»,
che vuol dire? È discriminante vietare l'utero in affitto? È pericoloso, dunque
sarebbe reato, mobilitarsi per contestare questa pratica? Chi lo decide? Fedez?
Gender: da Soros in su, ecco brand e
imprenditori che sponsorizzano la causa. E fanno business.
Bianca Conte mercoledì 26 Maggio su Il Secolo d'Italia. Causa
trans e business: da Soros in su, sono molti e tutti degni di nota, i brand e
gli imprenditori che sponsorizzano la crociata gender e il suo giro d’affari
socio-umanitari, oltre che particolarmente rispondenti a logiche politiche e di
marketing. Del resto, è vero: le idee camminano sulle gambe degli uomini, come
ebbe a dire il grande Giovanni Falcone all’epoca delle sue inchieste. Ma senza i
soldi di alcuni Paperoni mondiali non arriverebbero molto lontano, si potrebbe
aggiungere oggi. E allora, sempre seguendo gli insegnamenti e le strategie del
magistrato siciliano, urge anche rispolverare il metodo «follow the money». Ed è
proprio partendo da questo presupposto che Francesco Borgonovo, vice direttore
de La Verità, muove i suoi circostanziati passi alla ricerca di flussi e
transazioni di denaro che hanno «ridato motivazioni a tante Ong arcobaleno ormai
a corto di obiettivi». E da Soros a Stryker. Da aziende e istituzioni. Tra
passaggi societari ascrivibili al mondo dell’attivismo Lgbt, l’inchiesta
giornalistica indica tutti i «ricchi maschi bianchi» affezionati alla causa. E
altrettanti finanziamenti utili alla causa gender…
Trans, il business e i numeri del censimento.
Tutto parte, nella ricostruzione de La Verità, all’inizio del 2020: quando
l’Università di Firenze. L’azienda ospedaliera Careggi. La fondazione The
bridge. L’Osservatorio nazionale sull’identità di genere e l’Istituto superiore
di sanità, hanno dato il via a un’indagine chiamata Spot. Ossia: «Stima della
popolazione transgender adulta in Italia». Lo scopo dello studio mirava a
ricostruire, in una sorta di censimento, quanti fossero effettivamente – a
transizione avvenuta o in procinto di raggiungimento – i transgender sul
territorio italiano. Ebbene, come riferisce il quotidiano diretto da Maurizio
Belpietro, «nel presentare l’indagine, Marina Pierdominici dell’Istituto
superiore di sanità, parlando con Repubblica, azzardò una stima: «I dati della
letteratura scientifica internazionale suggeriscono che la percentuale di
popolazione transgender dovrebbe essere compresa tra lo 0,5 e l’1,2% del totale.
Se confermata anche nel nostro Paese, consterebbe in circa 400.000 italiani».
Una cifra che rimanda a percentuali piuttosto basse. E allora, la domanda sorge
spontanea: al di là del fatto incontrovertibile secondo cui anche le minoranze
hanno diritto e necessitano di rappresentanza, come mai la crociata gender ha,
specie da un punto di vista mediatico, tanta rilevanza e spazi ad hoc nel mondo
dell’intrattenimento televisivo? E, soprattutto, come e perché si è approdati al
punto di asserire come improcrastinabile la necessità di una legge che, come
prima cosa, prevede l’autodeterminazione dell’identità di genere, idea
chiaramente caldeggiata dai movimenti trans, ma altrettanto palesemente invisa
in chiave bipartisan, da molti sia a destra che a sinistra?
Causa trans e business mondiale, il ruolo della
britannica Stonewall. Ma tant’è: ci si domanda, però, come sia possibile che
argomenti come quello del «gender Id» siano diventati prioritari nel dibattito
politico, nonostante la evidente residualità numerica asserita negli studi
statistici? Domande che si affastellano a domande e che alimentano una
discussione che va ben oltre i limiti etici e giuridici. Sui cui aspetti
economici l’inchiesta de La Verità rileva quanto segue: «La prima organizzazione
a compiere un massiccio investimento sulla promozione delle istanze trans è
stata la britannica Stonewall, una delle più grandi in Europa».
L’ombra di uno «scarso impegno sui diritti
transgender». E ancora: «Proprio in questi giorni la Commissione per
l’uguaglianza e i diritti umani (Ehrc) britannica – finanziata con denaro
pubblico – ha cancellato la sua adesione al programma «Diversity champions»
di Stonewall. Il motivo ufficiale è il cattivo rapporto qualità-prezzo del
servizio. In realtà dietro la rottura ci sono tensioni legate soprattutto alle
questioni trans, dato che Stonewall ha pubblicamente criticato l’Ehrc per il suo
presunto scarso impegno sui diritti transgender». Dunque, a parte il fatto
che La Verità sottolinea che l’associazione britannica in questione, che nasce
nel 1989 con l’obiettivo di occuparsi per lo più di gay e lesbiche, ha iniziato
a occuparsi di problematiche trans dopo il 2013, cioè l’anno in cui nel Regno
Unito sono state approvate le unioni omosessuali.
Il contributo delle Associazioni sostenute anche
da denaro pubblico. Va detto, più in generale, che la causa transgender nel
tempo è riuscita ad avocare a sé spazi e protagonisti per associazioni Lgbt
molto influenti. Che rischiavano di venire depauperati, almeno in parte, e il
loro operato svuotato di senso. «Queste associazioni – scrive infatti Borgonovo
– sostenute pure da soldi pubblici (come nel caso della britannica Mermaids che
si occupa di ragazzini con varianza di genere), hanno conquistato negli anni un
forte peso mediatico e politico, e lo sfruttano con furbizia e un pizzico di
cinismo». Il punto, allora, resta quello dell’importanza. Quasi della centralità
che il tema ha acquisito. Prendendo piede dal punto di vista sociale, anima
istituzionale e corpo economico. Per cui, per esempio, sottolinea l’inchiesta
giornalistica in oggetto, «attualmente del programma Diversity champions fanno
parte circa 850 aziende e istituzioni: Stonewall (dietro pagamento di una quota)
offre loro consigli su come «gestire le diversità», poi emette una sorta di
bollino arcobaleno. Iniziative come queste hanno contribuito a creare un
patrimonio di circa 8 milioni di sterline».
Il ruolo della Open society foundations di George
Soros. Ma non è ancora tutto. Perché l’improvvisa accelerazione che la crociata
trans ha registrato negli ultimi tempi non può essere giustificata soltanto con
l’ausilio del lavoro promosso da associazioni Lgbt particolarmente attive e
capaci. Dietro, infatti, secondo il lavoro svolto da Borgonovo, ci sarebbero
anche «organizzazioni dotate di notevole potere economico, ad esempio la
solita Open society foundations di George Soros». E su questo, Borgonovo, cita
cifre e dati ben precisi. Quelli, per esempio, riferiti già da Kelly Riddell
Sadler – giornalista, già consulente per la comunicazione di Donald Trump alla
Casa Bianca – il quale diede sostanza numerica a dubbi e ipotesi, «calcolando
che tra il 2013 e il 2016 Soros avesse finanziato associazioni come la Gay
straight alliance (100.000 dollari nel solo 2013) o la Gate (Global action for
trans equality, 244.000 dollari nello stesso periodo)». Tutto verificabile,
rilancia La Verità: «Del resto basta farsi un giro sul sito di Open society per
trovare più di un articolo in cui si sostiene che è tempo di «dare all’attivismo
trans il supporto di cui ha bisogno».
Trans e business, tutti gli imprenditori al soldo
della causa. Un business, quello legato al mondo Lgbt che si è incrementato nel
tempo e dilatato nello spazio. E che, a un certo punto, registra un’impennata
che fa parlare proprio di svolta, dovuta soprattutto al contributo dell’attività
svolta da Arcus. Una Ong, illustra Borgonovo nel suo ampio servizio, «fondata e
curata da Jon Stryker, ricco magnate dell’industria sanitaria. Come ha
documentato la giornalista e attivista Jennifer Bilek (i cui articoli sono stati
ben sintetizzati da Feministpost.it), “tra il 2016 e l’aprile 2021 Arcus ha
investito quasi 74 milioni di dollari in promozione della giustizia sociale. La
maggior parte dei suoi beneficiari avevano a che vedere con l’ideologia
dell’identità di genere”».
La crociata trans, un business a livello globale.
Non solo. A detta del servizio, «Arcus è stata una delle principali promotrici
della causa trans a livello globale. Finanzia associazioni Lgbt storiche e
potenti come Ilga. Arcus ha sovvenzionato anche la britannica Stonewall. Arcus,
nel 2013, «ha scelto come direttore del programma internazionale per i diritti
umani Adrian Coman, proveniente dalla Open society foundations. Nel 2015,
invece, la Arcus ha raccolto 20 milioni di dollari per la New global trans
iniziative in collaborazione con una fondazione chiamata Novo, che si occupa
anche di sostenere Black lives matter e altri movimenti analoghi».
Tutti i Paperoni che foraggiano la causa trans e
il suo business. Ebbene la Arcus haq il suo padre nobile nella figura di Peter
Buffett, figlio di Warren Buffett. Ma nbon sarebbe il solo Paperone a foraggiare
la causa trans. «Secondo Jennifer Bilek – riferisce infatti La Verità – , dietro
l’esplosione delle istanze trans ci sarebbero principalmente “uomini. Bianchi.
Estremamente ricchi e con un’enorme influenza culturale”. Tra cui il già citato
Soros, Jennifer Pritzker (imprenditore trans con un patrimonio da due miliardi
di dollari circa). L’attivista, imprenditrice e transumanista orgogliosa Martine
Rothblatt. L’imprenditore Tim Gill (il primo gay dichiarato nella lista dei 400
ricchissimi di Forbes). In effetti, tutti costoro risultano finanziare e
spalleggiare a vario titolo i movimenti transgender.
Ecco i brand e le firme illustri che appongono il
marchio di fabbrica alla crociata trans. E insieme a loro, compaiono le sigle di
grandi holding. Perché La causa trans gode del sostegno, se non altro
propagandistico e mediatico, di alcune tra le più grandi aziende del mondo. Come
dimostrato quando, nel «settembre 2020, Stonewall ha organizzato un grande
evento a sostegno della causa trans intitolato «Trans rights are human rights».
Lo hanno sostenuto 136 grandi aziende tra cui Amazon, Aviva, Citi, Google,
Deliveroo, Deloitte, Microsoft, JP Morgan, Disney, Visa, P&G, Zurich». Brand e
marchi illustri che hanno apposto il loro marchio di fabbrica sulla causa
gender. Insieme ad altre grandi firme, scrive Borgonovo, «schierate
politicamente per bloccare “le leggi che influenzerebbero l’accesso alle cure
mediche per le persone transgender. I diritti dei genitori. I servizi sociali e
familiari. Gli sport studenteschi o l’accesso a strutture pubbliche come i
bagni”. Tra queste ci sono Apple, Airbnb, Dell, Facebook, Hilton, Ibm, Ikea,
Nike, Pepsi, Pfizer, Uber, Unilever, Wells Fargo. Nulla di illegale».
Semplicemente tutti sono concordi nell’alimentare un business su cui si urla
tanto alla congiura. Ma che, a ben vedere, ha più crociati al suo soldo che
frondisti contro. Tutti solerti nel foraggiare e godere di un business che di
sicuro non langue…
Francesco Borgonovo per "la Verità" il 26 maggio
2021. All' inizio del 2020, l' Università di Firenze, l' azienda ospedaliera
Careggi, la fondazione The bridge, l' Osservatorio nazionale sull' identità di
genere e l' Istituto superiore di sanità hanno dato il via a un' indagine
chiamata Spot, cioè «Stima della popolazione transgender adulta in Italia». A
che cosa serve la ricerca? Ovvio: a fare un censimento dei trans sul territorio
italiano, perché ad oggi non sappiamo esattamente quante siano le persone che
hanno modificato il proprio genere o sono in procinto di farlo. Nel presentare
l' indagine, Marina Pierdominici dell' Istituto superiore di sanità, parlando
con Repubblica, azzardò una stima: «I dati della letteratura scientifica
internazionale suggeriscono che la percentuale di popolazione transgender
dovrebbe essere compresa tra lo 0,5 e l' 1,2% del totale. Se confermata anche
nel nostro Paese, conterebbe circa 400.000 italiani». I numeri sono in aumento,
soprattutto per quel che riguarda i minorenni, ma parliamo ancora di percentuali
piuttosto basse. Viene da chiedersi, allora, come mai la causa trans goda di
così tanta pubblicità a livello mediatico e ottenga tanto spazio nel mondo dell'
intrattenimento, soprattutto quello di marca statunitense. Chiaro: una fetta di
popolazione, per quanto esigua sia, ha comunque diritto a essere rappresentata.
Però qui si parla addirittura di approvare una legge che, come prima cosa,
prevede l'autodeterminazione dell' identità di genere, idea carissima ai
movimenti trans ma avversata da molti sia a destra sia a sinistra. Ci si domanda
allora come sia stato possibile che temi come quello del «gender Id» siano
diventati centrali nel dibattito pubblico nonostante l' evidente marginalità sul
piano statistico (la quale permetterebbe, per giunta, di seguire adeguatamente e
con rispetto ogni singola situazione, senza bisogno di nuove norme che impongano
discutibili decostruzioni della natura umana).
Il ruolo di Stonewall. La prima organizzazione a
compiere un massiccio investimento sulla promozione delle istanze trans è stata
la britannica Stonewall, una delle più grandi in Europa. Proprio in questi
giorni la Commissione per l' uguaglianza e i diritti umani (Ehrc) britannica -
finanziata con denaro pubblico - ha cancellato la sua adesione al programma
«Diversity champions» di Stonewall. Il motivo ufficiale è il cattivo rapporto
qualità-prezzo del servizio, in realtà dietro la rottura ci sono tensioni legate
soprattutto alle questioni trans, dato che Stonewall ha pubblicamente criticato
l' Ehrc per il suo presunto scarso impegno sui diritti transgender. Attualmente
del programma «Diversity champions» fanno parte circa 850 aziende e istituzioni:
Stonewall (dietro pagamento di una quota) offre loro consigli su come «gestire
le diversità», poi emette una sorta di bollino arcobaleno. Iniziative come
queste hanno contribuito a creare un patrimonio di circa 8 milioni di sterline.
L' associazione britannica, che dalla nascita nel 1989 si è occupata per lo più
di gay e lesbiche, ha iniziato a spingere sui temi trans dopo il 2013, cioè l'
anno in cui nel Regno Unito sono state approvate le unioni omosessuali. Come ha
scritto Jo Bartosch su Spiked, «quando Ruth Hunt è stata nominata Ceo di
Stonewall nel 2014, si è trovata a capo di un ente di beneficenza ricco di
personale e denaro ma improvvisamente privo di una causa. Hunt ha trovato la
nuova causa - e i donatori - grazie alla "lotta" per i diritti dei trans». Ecco
una prima risposta al quesito iniziale: la causa trans crea nuovi spazi per
associazioni Lgbt molto influenti che rischiavano di esaurire, almeno in parte,
la propria funzione. Queste associazioni, sostenute pure da soldi pubblici (come
nel caso della britannica Mermaids che si occupa di ragazzini con varianza di
genere), hanno conquistato negli anni un forte peso mediatico e politico, e lo
sfruttano con furbizia e un pizzico di cinismo. Ma dietro l' exploit trans non
ci sono soltanto associazioni Lgbt particolarmente scaltre. Ci sono anche
organizzazioni dotate di notevole potere economico, ad esempio la solita Open
society foundations di George Soros. Kelly Riddell Sadler - giornalista, già
consulente per la comunicazione di Donald Trump alla Casa Bianca - calcolò che
tra il 2013 e il 2016 Soros avesse finanziato associazioni come la Gay straight
alliance (100.000 dollari nel solo 2013) o la Gate (Global action for trans
equality, 244.000 dollari nello stesso periodo). Tutto alla luce del sole,
ovviamente. Del resto basta farsi un giro sul sito di Open society per trovare
più di un articolo in cui si sostiene che è tempo di «dare all' attivismo trans
il supporto di cui ha bisogno». Come farlo? Ad esempio sostenendo iniziative
come l' International trans fund, che riunisce attivisti da tutto il mondo.
La svolta improvvisa. Le sigle arcobaleno hanno
cominciato a ottenere maggiori donazioni già all' inizio degli anni Duemila. Ma
se fino al 2013/2014 - lo scrive sempre Open society - le associazioni trans
potevano contare su budget che in media si aggiravano intorno ai 10.000 dollari
l' anno, da quel momento le cose hanno iniziato a cambiare. E se la situazione è
mutata lo si deve molto all' attività di Arcus, una Ong fondata e curata da Jon
Stryker, ricco magnate dell' industria sanitaria. Come ha documentato la
giornalista e attivista Jennifer Bilek (i cui articoli sono stati ben
sintetizzati da Feministpost.it), «tra il 2016 e l' aprile 2021 Arcus ha
investito quasi 74 milioni di dollari in promozione della giustizia sociale. La
maggior parte dei suoi beneficiari avevano a che vedere con l' ideologia dell'
identità di genere». Arcus è stata una delle principali promotrici della causa
trans a livello globale. Finanzia associazioni Lgbt storiche e potenti come Ilga
(una sorta di sigla ombrello che riunisce tantissimi gruppi arcobaleno di tutto
il mondo), la quale guarda caso ha da poco espulso dalla sezione europea le
femministe di Arcilesbica, considerate «trans escludenti». Arcus ha
sovvenzionato anche la britannica Stonewall: ben 142.000 dollari versati «appena
prima che ampliasse il suo mandato per coprire le questioni transgender». Nel
2013, Arcus ha scelto come direttore del programma internazionale per i diritti
umani Adrian Coman, proveniente dalla Open society foundations. Nel 2015,
invece, la Arcus ha raccolto 20 milioni di dollari per la New global trans
initiative in collaborazione con una fondazione chiamata Novo, che si occupa
anche di sostenere Black lives matter e altri movimenti analoghi. Sapete chi l'
ha fondata? Peter Buffett, figlio di Warren Buffett. Secondo Jennifer Bilek,
dietro l' esplosione delle istanze trans ci sarebbero principalmente «uomini,
bianchi, estremamente ricchi e con un' enorme influenza culturale», tra cui il
già citato Soros, Jennifer Pritzker (imprenditore trans con un patrimonio da due
miliardi di dollari circa); l' attivista, imprenditrice e transumanista
orgogliosa Martine Rothblatt, l' imprenditore Tim Gill (il primo gay dichiarato
nella lista dei 400 ricchissimi di Forbes). In effetti, tutti costoro risultano
finanziare e spalleggiare a vario titolo i movimenti transgender.
Le grandi corporation. Non sono i soli. La causa
trans gode del sostegno, se non altro mediatico, di alcune tra le più grandi
aziende del mondo. Nel settembre 2020, Stonewall ha organizzato un grande evento
a sostegno della causa trans intitolato «Trans rights are human rights». Lo
hanno sostenuto 136 grandi aziende tra cui Amazon, Aviva, Citi, Google,
Deliveroo, Deloitte, Microsoft, JP Morgan, Disney, Visa, P&G, Zurich All' inizio
di maggio, un altro centinaio di corporation hanno firmato un documento di
protesta contro gli Stati americani che avevano approvato leggi «anti Lgbtq»,
con particolare attenzione alle norme riguardanti «i giovani transgender». In
sostanza queste aziende (così spiegano in una dichiarazione congiunta) si sono
schierate politicamente per bloccare «le leggi che influenzerebbero l' accesso
alle cure mediche per le persone transgender, i diritti dei genitori, i servizi
sociali e familiari, gli sport studenteschi o l' accesso a strutture pubbliche
come i bagni». Tra queste ci sono Apple, Airbnb, Dell, Facebook, Hilton, Ibm,
Ikea, Nike, Pepsi, Pfizer, Uber, Unilever, Wells FargoNulla di illegale. E
nessun complotto, per carità. Però quando si parla di persecuzioni,
discriminazioni e ingiustizie, beh, forse conviene un po' abbassare i toni.
Il dibattito sul ddl zan. L’identità di
genere merita riflessione, c’è il rischio caos.
Giovanni Guzzetta su Il Riformista il 26 Maggio 2021. La radicalizzazione dello
scontro politico sul ddl Zan è particolarmente grave perché sta trasformando una
questione delicatissima in un conflitto manicheo all’insegna della
semplificazione. Rischiano così di rimanere schiacciate le due dimensioni reali
che dovrebbero interessare. La prima è quella della comprensione dei fenomeni
che si intende disciplinare. La seconda è quella degli specifici problemi
tecnico-giuridici per farlo. Il primo aspetto è oggetto di un dibattito che
interessa non solo la cultura e gli orientamenti sociali, ma anche settori
disciplinari specifici come la sociologia, la psicologia e persino la filosofia.
È noto che tale dibattito, legato agli studi di genere, non è recente, ma è
altrettanto noto che nel tempo si è andato arricchendo di nuovi contenuti e
“frontiere”. Non è un caso ad esempio che la American Psychological
Association (Apa) solo nel dicembre 2015 abbia diramato delle linee guida per i
propri associati su come affrontare il fenomeno delle persone Transgender e Non
conforming, coloro cioè che abbiano un’ “identità di genere non completamente
allineata con quella del sesso loro riconosciuto alla nascita”. Nel 2017, una
speciale inchiesta del National Geographic è stata dedicata alla Gender
Revolution in tutto il mondo. In quel contesto, Susan Goldberg ricordava come
l’app Tinder avesse identificato circa 40 identità di genere a fronte delle 50
di Facebook. Non stupisce che di fronte a un tale fenomeno si possa sviluppare
ogni sorta di atteggiamento, dal più scettico al più entusiasta. E forse non è
nemmeno compito della politica prendere una posizione epistemologica su processi
culturali così complessi, radicali e, soprattutto, in divenire. Nella
prospettiva dell’identità di genere, infatti, anche i confini con le altre
manifestazioni culturali o sociali dell’identità rischiano di attenuarsi. Sono
le stesse linee guida dell’Apa a ricordare che l’espressione di genere
può “avere una notevole intersezione con altri aspetti dell’identità”. Di fronte
alla vastità di tali problematiche, che finiscono per investire il cuore della
soggettività, la questione di come il diritto si debba porre, e con quali
tecniche e modalità, non può essere frettolosamente liquidata. E per questo la
strumentalizzazione politica del dibattito è gravissima. La complessità delle
manifestazioni umane ha indotto i costituenti italiani (al pari di altri) a
prevedere una tutela generale della dignità umana e sociale, senza
discriminazione alcuna (art. 3). Ciò non esclude che possano esservi ulteriori
interventi di speciale protezione o di specifica promozione (si pensi
all’accesso ai pubblici uffici dei cittadini “dell’uno e dell’altro sesso”, art.
51, o alla tutela del lavoro, art. 37 Cost.). La discrezionalità legislativa in
materia non esime, però, da una valutazione delle tecniche e delle modalità
degli interventi. Il dibattito sul ddl Zan, per quanto inquinato dalla
polarizzazione partitico-ideologica, non è dunque inutile, ed è anzi
giustificato dalla salienza delle questioni che intende affrontare. Questioni
che forse, riguardando una concezione della società e dei suoi componenti che si
è molto trasformata dal 1948, richiederebbero un dibattito costituzionale. Vi
sono tre specifici profili critici del ddl quanto alle tecniche di politica del
diritto. Innanzitutto, aspirando a una sistemazione giuridica di categorie, esso
ricorre a definizioni, in parte nuove, senza considerare che alcuni termini
erano già presenti nell’ordinamento, ma con significati diversi. Ciò pone un
problema di coordinamento di notevole complessità. Si pensi al concetto di
genere o di identità di genere che, per lo più, sono stati sinora utilizzati dal
legislatore e dalla giurisprudenza (anche costituzionale) come sinonimo
di identità o di orientamento sessuale, mentre le nozioni proposte dal ddl Zan
alludono a concetti sensibilmente differenti. Ciò genera un secondo problema.
Nel definire tali nuove categorie il legislatore ricorre ai cosiddetti concetti
giuridici indeterminati (cioè extra-giuridici), il cui significato deve, cioè,
ricavarsi al di fuori dell’ordinamento, ricorrendo ad altre scienze, alla
coscienza sociale o alla “percezione di sé”. Definendo il “genere” come
“qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o
contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso” si assume che
qualcuno sia in grado, fuori del diritto, di compiere un’attendibile
ricognizione delle (mutevoli) aspettative sociali. Certo, i concetti giuridici
indeterminati esistono (si pensi al senso del pudore), ma bisogna aver chiaro
che, nel ricorrere ad essi, il legislatore compie una precisa scelta di
trasferimento del potere. Rinuncia in larga misura a definire, e rinvia alle
definizioni di altri operatori, a cominciare dai giudici, con le oscillazioni
che ne possono derivare. Ciò vale a maggior ragione per concetti nuovi, della
cui esatta portata si discute ancora anche negli ambiti scientifici in cui sono
stati elaborati. Circostanza ulteriormente preoccupante atteso che la scelta di
affrontare e codificare tali nozioni si trova in un progetto che ha ad oggetto
la materia penale, nella quale vige il principio costituzionale di tipicità dei
reati (art. 25 cost.) e in cui le conseguenze sanzionatorie sono le più
afflittive. A ciò si aggiunga che, per limitare la portata delle norme penali
introdotte, il ddl ricorre a nozioni anch’esse piuttosto indeterminate, per cui,
ad esempio, sarebbero fatte salve le opinioni e le condotte
legittime “riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle
scelte”. Mettendo di fronte due concetti indeterminati o scarsamente
determinati, difficilmente il risultato sarà una chiarezza dei reciproci
confini. Oltre alle opzioni culturali di merito politico, ci sono dunque
importanti problemi di tecnica legislativa. Per questo discutere non è inutile,
tanto più se lo si facesse in modo laico e non nel contesto assordante del
rullare di tamburi e del sibilare di pifferi. Giovanni Guzzetta
Riparte la discussione sul Ddl Zan: tra
giravolte e incertezze dei leader, ecco cosa succede.
Simone Alliva su L'Espresso il 26 ottobre 2021. Il disegno di legge contro
l’omotransfobia atteso da un passaggio chiave mercoledì al Senato. Intanto si
cerca una mediazione dopo mesi di dichiarazioni contraddittorie. Enrico Letta
apre a una possibilità di trattativa sul ddl Zan e tra i renziani è tutto un
balletto di sorrisi e pacche sulle spalle: «Avevamo ragione noi», festeggiano.
«Lo avevamo sempre detto» twitta l'ex forzista Donatella Conzatti, oggi
senatrice di Italia Viva. «Le leggi si fanno con i numeri, il resto è inutile
perdita di tempo e demagogia» le fa eco il deputato Ettore Rosato. Parole che
trovano sintonia anche dentro la Lega: «Letta prende atto che il ddl Zan è
impresentabile» commenta Simone Pillon. Non esattamente. «Modifiche» ha
specificato il segretario del PD ospite domenica a Che Tempo Che Fa, «purché non
siano cose sostanziali». Bisogna far fede alle parole, sono la cosa più
importante quando si discute di un disegno di legge contro i reati d’odio che
dal novembre 2019 infiamma il dibattito. E sono quelle che rischiano di cambiare
e modificare totalmente l’impianto della legge contro l’omotransfobia. Va da sé
che ad oggi sul ddl Zan se non c'è accordo è perché nessuno si fida di nessuno.
Ogni partito insegue il filo della propria trama cambiando posizione, alzando
muri oppure chiedendo modifiche, ritocchi, cancellando o omettendo trattative
già concluse e approvate. La Lega, trainata da Matteo Salvini, negli ultimi mesi
ha costruito una fortezza contro il ddl Zan escludendo ogni possibilità di
trattativa auspicata da Letta: «Io gli aumenti di pena per chi discrimina,
offende o aggredisce due ragazzi o due ragazze che si amano le approverei oggi
stesso», diceva l’8 luglio nel corso dell'assemblea di Noi per l'Italia, al
Teatro Quirino di Roma. Alla velocità di un tweet la sua posizione diventa meno
netta: il 22 luglio chiede «col cuore in mano che il Pd accetti il dialogo». Il
27 luglio sbatte la porta: «Il ddl Zan lo lascio agli altri, noi ci occupiamo di
lavoro e famiglie». Da Lanciano, in provincia di Chieti, il 12 settembre in
piena campagna elettorale mette infine un punto: «Mi attaccano tutti, ma io
porto avanti le mie battaglie contro tasse, sbarchi, Ius Soli e ddl Zan».
Contro. Mai a favore. Per capirlo sarebbe comunque bastato leggere i 672
emendamenti presentati proprio dalla Lega. Quasi tutti soppressivi al disegno di
legge. Oppure la richiesta di non passaggio agli articoli (proposta presentata
dal leghista Roberto Calderoli in coppia con il collega di Fratelli d’Italia,
Ignazio La Russa). Si deciderà mercoledì con voto segreto, l’arresto definitivo
del disegno di legge contro l’omotransfobia è a un passo, nessuna discussione o
mediazione. Dentro la maggioranza pro-Zan, si fa per dire, spicca per richieste
di modifica Italia Viva. Di emendamenti al testo ne ha presentati solo quattro,
chirurgici. Uno è da vertigine: interviene sul primo articolo della legge,
quello proposto da Italia Viva stessa alla Camera e approvato con orgoglio dai
renziani. L’articolo più dibattuto negli ultimi mesi, quello della formulazione
delle definizioni: orientamento sessuale, sesso, genere, identità di genere.
L’articolo 1 nasce da un emendamento (ancora visibile agli atti) a prima firma
Lucia Annibali, deputata di Italia Viva. Il suo inserimento nell’impianto della
legge arriva da una richiesta della Commissione Affari Costituzionali della
Camera: fare riferimento a definizioni giuridicamente precise e il più possibile
consolidate nella giurisprudenza. Italia Viva, dunque, presenta e ottiene
l’inserimento dell’articolo così come lo conosciamo. Oggi la richiesta del
partito di Renzi al Senato è di soppressione dello stesso e di un ritorno alla
formula: “omofobia e transfobia”. Un passo indietro che riporta alla mente tutti
i tentativi di legge degli ultimi 25 anni, quelli naufragati per assenza di
precisione tecnica. Come già raccontato su L’Espresso: i termini “omofobia” e
“transfobia” sono usati nel linguaggio politico che è diverso da quello
giuridico. Vanno bene per la denominazione della giornata contro l’omofobia e
transfobia, per esempio, ma non per la denominazione di un movente di reato, che
richiede parametri più precisi. “Omofobia” e “Transfobia” inoltre sono termini
che non assicurerebbero protezione a tutte le soggettività che il ddl Zan si
propone di tutelare. Quei reati d’odio sulle persone bisessuali, non binarie o
gender non conforming, non riconducibili alla condizione transessuale e, dunque,
alla transfobia. Se il problema è, come dichiarato spesso dal capogruppo di IV
Davide Faraone, il concetto di “identità di genere”, queste tre parole restano
anche dopo la soppressione del primo articolo. Il concetto di identità di genere
resta negli articoli 2 e 3 (che modificano il codice penale e il codice di
procedura penale) essendo una definizione già presente nella legislazione
italiana, ma anche nel diritto europeo e nella giurisprudenza delle più alte
Corti. Le modifiche all’articolo sulla libertà d’espressione o pluralismo delle
idee (art. 4) illuminano un’altra giravolta. Questa volta di quel centrodestra
favorevole del ddl. Il “rispetto della libertà d’espressione” è frutto di un
lavorio portato avanti da Enrico Costa, all’epoca deputato di Forza Italia oggi
in Azione. Presenti alla trattativa con il Pd c’erano Giusi Bartolozzi (ex
azzurra oggi al Misto) ma anche Francesco Paolo Sisto, oggi Sottosegretario alla
Giustizia nel Governo Draghi in quota berlusconiana. Forza Italia decise che
bisognava specificare che la legge contro l’omotransfobia, l’abilismo e la
misoginia non colpisse la libertà di espressione. Precisazione non necessaria
dal punto di vista giuridico ma politicamente obbligata di fronte a un quadro
politico incerto. Trattative, cambiamenti e infine ritocchi. Con un sospiro di
sollievo il 4 novembre 2020 le larghe intese Pd-FI riescono. Oggi gli
emendamenti firmati da Ronzulli-Binetti chiedono la modifica. Fa discutere
infine la richiesta di soppressione della giornata mondiale contro
l’omotransfobia nelle scuole. “Richiesta inammissibile”, fanno sapere fonti dal
Pd. Gli emendamenti sono i più disparati: i senatori Ostellari (Lega) e Ronzulli
(Forza Italia) vorrebbero trasformare il 17 maggio nella “giornata contro le
discriminazioni”. Eppure, dal 2004 è in tutto il mondo nota come “Giornata
contro l’omotransfobia” e non è un caso. Il 17 maggio 1990 l'Organizzazione
mondiale della Sanità ha depennato l'omosessualità dall'elenco delle malattie
mentali. In Italia, ogni anno, il Presidente della Repubblica, il Presidente del
Consiglio e i Presidenti di Camera e Senato rilasciano dichiarazioni sul tema.
La legge Zan prevede che, in occasione della Giornata mondiale contro
l’omotransfobia, le scuole organizzino attività di sensibilizzazione per
«contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati
dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere». Prevenire atti di
bullismo e discriminazioni. Nessuna scuola sarà obbligata a celebrarla, si legge
nel ddl Zan: «Nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al
comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto
educativo di corresponsabilità». Ma per Italia Viva non basta, i senatori
renziani Faraone e Cucca chiedono venga specificata anche “la piena autonomia
scolastica”. Un’operazione di facciata che insegue una convinzione espressa dal
leader Renzi in un’intervista rilasciata a luglio per Fanpage, cioè che il ddl
Zan potrebbe aprire alla «teoria del gender e la presenza di alcuni di questi
temi nella scuola», sintonia massima con il leghista Pillon, noto per la sua
caccia alla stregoneria nelle scuole. Passi indietro e dimenticanze. Eppure nel
2016 era stata la sua “Buona Scuola” accusata di imporre la teoria del gender.
Quell’anno la ministra dell'Istruzione, Stefania Giannini dovette smentirne
l’esistenza con una circolare alle scuole. Oggi Renzi accusa il ddl Zan di
imporre la stessa teoria nelle scuole. Ma i margini per effettuare queste
modifiche ci sono? Il padre del testo, il deputato Zan, non solo dovrà trattare
con i suoi ex colleghi renziani per rassicurarsi quei 17 voti che mancano per
approvare il testo. Ma in caso di modifiche dovrà cercare delle garanzie
pubbliche per il terzo passaggio alla Camera. Il vicolo è stretto: chiudere in
pochissimi giorni al Senato, costringere la Lega a ridurre i 672 emendamenti
depositati, approvare la legge modificata e poi trovare una finestra alla Camera
per calendarizzazione e votazione. Tutto questo mentre un’altra legge,
decisamente più ingombrante, cioè quella di bilancio, viene discussa al Senato.
Più che pontiere, a Zan toccherà interpretare il ruolo del funambolo che cammina
sulla fune, in bilico sul baratro. Sugli spalti per nulla contenti i diretti
interessati a questa legge: la comunità lgbt. Gabriele Piazzoni, segretario
generale di Arcigay ha bollato come «un fulmine a ciel sereno» l’uscita del
segretario del PD Letta: «L'approvazione rapida del testo a prima firma Zan si
avrebbe solo senza modifiche». Alessia Crocini presidente di Famiglie Arcobaleno
è più corrosiva: «Questa legge è già frutto di un compromesso. Nella comunità la
stanchezza di sentirsi sempre oggetti e mai soggetti ha ormai raggiunto il
limite. Quando le leggi vengono ridotte o mediate a cambiare non è la vita di
Renzi, Letta, Salvini o Berlusconi è la nostra. Stiamo difendendo una legge che
avrebbe dovuto essere approvata 25 anni fa, siamo a un passo dal dare una chance
al futuro di questo paese, ma come sempre non ci riusciamo».
Ddl Zan, dal Vaticano nuovo appello alla
politica: legge "ingiusta" come l'aborto. Felice Manti
il 27 Ottobre 2021 su Il Giornale. Come si deve comportare un cattolico di
fronte alla legge Zan? E qual è il dovere di un politico che si ispira ai valori
della Chiesa? Due semplici domande per una risposta che non lascia dubbi. Come
si deve comportare un cattolico di fronte alla legge Zan? E qual è il dovere di
un politico che si ispira ai valori della Chiesa? Due semplici domande per una
risposta che non lascia dubbi. «Vale ciò che Papa Francesco disse sul gender
nell'Esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia («Il gender è
un'ideologia che nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna,
prospetta una società senza differenze di sesso, e svuota la base antropologica
della famiglia») e ciò che Giovanni Paolo II scrisse nell'enciclica Evangelium
Vitae agli articoli 73 e 74», dice una nota della Congregazione della Dottrina
della Fede che Il Giornale ha potuto consultare in esclusiva. Si tratta infatti
della risposta che la Congregazione ha inviato a Pro Vita & Famiglia Onlus,
storicamente contraria alla norma perché «impone una visione della sessualità
soggettivista, fluida, non binaria, contraria all'etica naturale e
all'antropologia biblica e cristiana». Il ddl Zan, fa intendere la lettera
datata 1 ottobre, è da considerarsi «intrinsecamente ingiusto al pari di aborto
e eutanasia», che per la Chiesa restano «crimini che nessuna legge può
pretendere di legittimare». Chissà che cosa ne pensano i famigerati «cattolici
adulti» del Pd e del centrodestra, che in più di una circostanza hanno
manifestato aperture alla norma. Con quale faccia diranno che non c'è alcun
contrasto tra le loro convinzioni religiose e una legge che rischia di
restringere pericolosamente il campo della libertà di espressione? Già oggi chi
ha osato dissentire rispetto al ddl Zan è oggetto di pesante aggressione e di
odio. Sarà ancora lecito dire che un bambino ha diritto a una mamma e un papà o
che l'utero in affitto è una pratica spregevole senza rischiare di finire
davanti a un giudice? La lettera di Pro vita risale ai primi di luglio, quando
la legge che in teoria punta a punire - giustamente - la violenza di matrice
omofobica e transfobica e tutelare la comunità Lgbt e i «generi» esistenti
dall'odio aveva disvelato il suo vero volto: separare il sesso dal genere
(articolo 1) e sdoganare «l'identità di genere percepita» a uno spettro di
«orientamento sessuale» a sua volta mutevole, per arrivare a una identità di
genere fluida. Una percezione del sé che fa a pugni con la dottrina cattolica
del «maschio e femmina li creò» ma anche con il buonsenso. È infatti in questa
confusione che è facile cadere vittima di affermazioni che suonino come
«omofobe» senza volerlo essere. Già la Cei si era espressa criticamente per ben
due volte. Poi era arrivata la forte presa di posizione della Segreteria di
Stato della Santa Sede, in una «nota verbale» indirizzata all'Ambasciata
d'Italia, rilevando che la normativa avrebbe inciso negativamente sulle libertà
assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime
concordatario. Ora l'autorità dottrinale della Congregazione per la Dottrina
della Fede conferma l'incompatibilità assoluta tra la Fede cattolica e il ddl
Zan. Una grave criticità per i cattolici sta nell'idea di portare la fluidità di
genere nelle scuole. «Iniziative come la Giornata nazionale contro l'omofobia,
la lesbofobia, la bifobia e la transfobia si moltiplicheranno - avverte Pro Vita
& Famiglia Onlus - perché le organizzazioni Lgbtq+, forti della copertura legale
del ddl Zan», sanno già che «la resistenza da parte di genitori o professori
sarà bollata come transfobica e potenzialmente discriminatoria». Ma è giusto
parlare di sessualità in una scuola materna? «Ci sembra che, rispetto a questa
impostazione ideologica, la dottrina cattolica si ispiri a principi del tutto
opposti, e dunque - conclude Pro Vita & Famiglia Onlus - le norme avrebbero
l'effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa
cattolica». E qui si torna al monito contenuto nell'Enciclica di San Giovanni
Paolo II: «I cristiani, come tutti gli uomini di buona volontà, sono chiamati,
per un grave dovere di coscienza, a non prestare la loro collaborazione formale
a quelle pratiche in contrasto con la Legge di Dio». Il senso e il fine della
libertà per i cattolici, infatti, «risiede nell'orientamento al vero e al bene».
Punto. Per la Dottrina della Fede il ddl Zan è una di queste «legislazioni
globalmente ingiuste», il cui assenso non può mai essere giustificato «né
invocando il rispetto della libertà altrui, né facendo leva sul fatto che la
legge civile la prevede e la richiede». Ora i sedicenti «cattolici adulti» dei
due schieramenti non facciano i bambini, fingendo di non capire. Il tempo degli
infantilismi e dei facili alibi è finito. Felice Manti
"Su questi temi la Chiesa non è sola".
Matteo Sacchi il 27 Ottobre 2021 su Il Giornale. La
storica: "La realtà è che esistono due sessi. E nessuno può negarlo". Lucetta
Scaraffia ha insegnato Storia contemporanea all'università La Sapienza di Roma
ed è membro del Comitato nazionale di bioetica dal 2007. Nel corso di una lunga
carriera, che vanta collaborazioni anche con molte testate giornalistiche, tra
cui Le Monde, si è occupata di storia della chiesa e di storia della
religiosità. Date monografie come La fine della madre, Storia della liberazione
sessuale o Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia è naturale
chiedere la sua opinione sul dibattito chiaramente riaperto dal Ddl Zan sui
rapporti tra Stato e Chiesa cattolica.
Partiamo dal Ddl Zan. Ci sono stati degli
interventi della Chiesa cattolica che possiamo definire delle ingerenze?
«Onestamente a me sembra di no. La Chiesa
Cattolica ha solo ribadito la sua dottrina, che per altro era nota, non mi
sembra abbia minacciato alcunché. Né di levare l'investitura di cattolico a
deputati o senatori, né di togliere i sacramenti o chessò io a chi vota il Ddl
Zan. Nessuno ha parlato di scomuniche, ha semplicemente espresso il suo parere.
Cosa che ha diritto di fare come hanno diritto di fare tutti. Come del resto
hanno fatto molte persone o istituzioni che non sono d'accordo con il Ddl Zan
pur non essendo cattolici».
Quali sono i documenti prodotti dalla Chiesa che
hanno un valore specifico in questo dibattito?
«Tutti i testi che fanno riferimento all'esistenza
di due sessi e per la Chiesa questa è una realtà che non può essere negata. Ma
in questo la Chiesa non è sola, ci sono persone, e non solo di destra che
sostengono le stesse posizioni. Vorrei ricordare che, in Francia, Sylviane
Agacinski, la moglie di Jospin con una solida storia a sinistra, ha scritto un
libro in cui dice chiaramente che l'umanità è divisa in uomini e donne. Poi
capire come trattare le persone a cavallo tra i due sessi è questione
legislativa per lo Stato, morale per la Chiesa. Ma senza mettere in discussione
il fatto».
Quali sono i casi in cui, durante la storia
italiana l'intervento della Chiesa su temi etici si è fatto sentire di più?
«Sicuramente per il divorzio e per l'aborto, che
sono state due battaglie perdute per la Chiesa. Tra l'altro sono state perdute
anche perché le donne volevano sia il divorzio che l'aborto. Ma sia il
referendum per il divorzio che quello per l'aborto presentavano una struttura
molto diversa rispetto al Ddl Zan. Il problema era punire o impedire la libertà.
Un conto è dire che l'aborto è un peccato, io sono cattolica e lo penso, però
mandare in prigione le donne che hanno abortito è una cosa crudele e inutile...
Questo di nuovo non vuol dire che la Chiesa non può dire che l'aborto è un
peccato».
Retrospettivamente la chiesa ha mai fatto
pressioni dirette o si trattava di moral suasion?
«Di pressioni dirette nessun politico ha mai
raccontato. Di certo il rischio di perdere elettori c'era, era quello a far
paura. I cattolici sono stati, ed in piccola parte lo sono ancora, un bacino
elettorale ambito. Persino il Pci stava attento a non scontentarli. Oggi sono
meno forti. Ma questa resta un'influenza legittima».
Quindi per trovare un'ingerenza vera davvero
dobbiamo tornare al Non Expedit?
«Sì però è durato poco e molti cattolici in quel
caso hanno disobbedito. Era una battaglia inutile contro il nuovo Stato
italiano, solo una questione di potere. Ma non ha davvero nessun legame con la
politica di oggi. Il Papa fa molte ma molte più pressioni, sui migranti, per
motivi giusti e comprensibili, che sul Ddl Zan. In quel caso si è rivolto
direttamente allo Stato. Ma non si scandalizza nessuno. E non si spaventa
nessuno».
Matteo Sacchi. Classe 1973, sono un giornalista
della redazione Cultura e Spettacoli del Giornale e tenente del Corpo degli
Alpini, in congedo. Ho un dottorato in Storia delle Istituzioni
politico-giuridiche medievali e moderne e una laurea in Lettere a indirizzo
Storico conseguita alla Statale di Milano. Il passato, gli archivi, e le serie
televisive sono la mia passione. Tra i miei libri e le mie curatele gli ultimi
sono: “Crudele morbo. Breve storia delle malattie che hanno plasmato il destino
dell’uomo” e “La guerra delle macchine. Hacker, droni e androidi: perché i
conflitti ad alta tecnologia potrebbero essere ingannevoli è terribilmente
fatali”. Quando non scrivo è facile mi troviate su una ferrata, su una moto o a
tirare con l’arc
Ddl Zan, maggioranza spaccata: si va alla
conta in Aula col rischio "tagliola". Federico Garau
il 26 Ottobre 2021 su Il Giornale. Domani il ddl sarà discusso in Aula al
Senato, ma la tensione è alle stelle. La sinistra teme la tagliola del
centrodestra ed il voto segreto. Dopo giorni di scontro, domani potrebbe davvero
essere il giorno decisivo per il ddl Zan, ormai divenuto una vera e propria
ossessione per i partiti della sinistra. La discussione in Aula al Senato è
fissata alle 9:30, ed il clima è già tesissimo.
Il Pd di nuovo alla carica
A fare la sua mossa solo alcuni giorni fa il
segretario del Partito democratico Enrico Letta che, messe da parte la crisi
economica che sta attraversando l'Italia ed il malcontento crescente della
popolazione, è tornato alla carica con il disegno di legge, deciso ad arrivare
alla sua approvazione. Per portare a casa il ddl, Letta è disposto anche ad
apportare delle modifiche, cosa che ha fatto insorgere il mondo Lgbt.
Retromarcia di Letta sul ddl Zan. Ed è bufera Lgbt
Nessun accordo
L'accordo fra i partiti, tuttavia, non è arrivato.
Le trattative si sono chiuse con un nulla di fatto, e tutto è rimandato a
domani, quando si terrà una nuova discussione in Aula al Senato, come disposto
in calendario. Attese le richieste di sospensiva di discussione
degli emendamenti al testo inoltrate sia da Lega che da Fratelli d'Italia.
Il ddl Zan dovrà affrontare il voto, che molto
probabilmente sarà segreto. Il timore di chi sostiene il provvedimento è che
questo possa affossare una volta per tutte il disegno di legge. Accordi, del
resto, non se ne sono trovati: Lega e Forza Italia hanno chiesto di rinviare di
una settimana, mentre Pd, Leu e M5s, spaccati fra loro, si sono detti contrari.
Al termine della riunione dei capigruppo, stando
ad alcune indiscrezioni rilasciate dalle agenzie di stampa, volavano scintille,
con Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd, furiosa con la Lega, rea di
non aver voluto trovare una mediazione, ritirando la cosiddetta 'tagliola' in
cambio di uno slittamento del voto in Aula. Slittamento, fra l'altro, chiesto
anche da Italia Viva.
A controbattere è stato il presidente dei senatori
del Carroccio Massimiliano Romeo, che ha accusato i rappresentanti del Partito
democratico di aver fin troppo forzato la mano, spingendo per portare il testo
in Aula. Il leghista ha inoltre espresso la propria intenzione di chiedere il
riscorso al voto segreto, cosa che ha letteralmente terrorizzato i dem,
prontissimi a dare battaglia. "La 'tagliola' resta, certo che resta, e poi ci
sarà la richiesta del voto segreto", ha promesso Romeo. "La Lega aveva dato
disponibilità a cercare una mediazione sul testo del provvedimento, ma ci hanno
detto di no". Ed in casa Pd hanno cominciato ad innervosirsi.
Lo scontro domani in Aula
Tutto è rimandato a domani quando si tornerà
nuovamente a discutere dell'argomento. Per il ddl Zan sarà una giornata
decisiva. I favorevoli al disegno di legge temono moltissimo la 'tagliola',
della quale farà parte anche Forza Italia. Il voto segreto, inoltre, potrebbe
davvero mettere la parola fine ad uno dei sogni dem.
La tensione, come dimostrato anche da alcune
dichiarazioni dei politici, è altissima. "Il segretario del Pd Letta ha
garantito a tutti che domani ci sono i voti. Speriamo bene", dicono alcune fonti
di Italia Viva, come riportato da LaPresse.
"È da irresponsabili aver deciso di andare subito
in aula senza trovare prima un accord , occorreva fare un rinvio di una
settimana per entrare nel merito del provvedimento cercando un'intesa, come
aveva chiesto Iv, cercando quelle modifiche auspicate anche da Letta", ha
protestato il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone. "Senza
questa intesa si rischia il naufragio in Aula".
"Provare a rinviare il voto di domani sul ddl Zan
sarebbe stato il modo doveroso di mettere al riparo una legge indispensabile" ha
commentato su Twitter anche un preoccupato Ivan Scalfarotto. "Chi ha cercato il
muro contro muro anche a costo di far naufragare la legge si assumerà una
terribile responsabilità".
Intanto il Movimento Arcobaleno si appella ai
politici, chiedendo di votare a scrutinio palese e di non sottrarsi alle proprie
responsabilità.
Federico Garau. Sardo, profondamente innamorato
della mia terra. Mi sono laureato in Scienze dei Beni Culturali e da sempre ho
una passione per l'archeologia. I miei altri grandi interessi sono la fotografia
ed ogni genere di sport, in particolar modo il tennis (sono accanito tifoso di
King Roger). Dal 2018 collaboro con IlGiornale.it, dove mi
Retromarcia di Letta sul ddl Zan. Ed
è bufera Lgbt. Luca Sablone il 25 Ottobre 2021 su Il
Giornale. Il segretario del Partito democratico apre a modifiche, ma Arcigay è
sul piede di guerra: "Letta deve chiarire, così i tempi slittano ancora". Ecco
cosa può succedere al Senato. Sul tema del ddl Zan arriva un cambio di passo
rispetto ai toni duri usati fino a pochi mesi fa. Se in estate il dialogo per
alcuni miglioramenti sembrava impossibile, ieri si è registrata un'apertura non
scontata da parte di Enrico Letta: il segretario del Partito democratico ha
fatto sapere che a breve chiederà ad Alessandro Zan, il padre della legge contro
l'omotransfobia, di fare un'esplorazione con le altre forze politiche "per
cercare di capire le condizioni che possano portare a un'approvazione rapida del
testo". Dunque il numero uno del Pd non ha chiuso a possibili modifiche. Anzi,
si è detto pronto a valutare eventuali correzioni mantendendo però i pilastri
fondamentali del ddl.
L'ira di Arcigay
Tuttavia le dichiarazioni di Letta trovano un muro
proprio dal mondo Lgbt. Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay, fa
notare che - anche con una sola modifica - il testo dovrebbe tornare alla Camera
con tutte le incertezze dal caso. Da qui il timore di far slittare ulteriormente
i tempi per l'approvazione del ddl Zan. La linea di Arcigay è chiara: il disegno
di legge contro l'omotransfobia va approvato così com'è, senza altre mediazioni
e rinvii.
Piazzoni è convinto che nessuno, e quindi neanche
il segretario del Partito democratico, sarebbe in grado di garantire la
conclusione dell'iter entro la fine della legislatura. Ma c'è anche un'altra
questione su cui si vuole far luce. "Viene poi da chiedere: quali sono le forze
politiche con cui il deputato Zan viene mandato a trattare? Letta ha per caso
intenzione di far scrivere a Salvini la legge contro i crimini d'odio?", si
chiede il segretario nazionale di Arcigay. Da qui la richiesta a Letta di
"chiarire" il prima possibile la sua posizione.
Esultano centrodestra e renziani
Dall'altra parte invece l'apertura di Letta trova
gli applausi del centrodestra. A parlare per conto di Forza Italia è il senatore
Maurizio Gasparri, che vuole eliminare ogni muro contro muro dal campo: i motivi
delle opposizioni al ddl Zan non vanno trovati nell'impianto teorico del testo
per combattere le discriminazioni, ma riguardano alcune norme "che prevedono
l'indottrinamento scolastico, la persecuzione delle opinioni e una rivoluzione
antropologica con l'autodichiarazione di appartenenza di genere che causerebbe
un caos totale".
Esulta anche la Lega di Matteo Salvini. Il
senatore Simone Pillon sottolinea che "ora anche Letta prende atto che il ddl
Zan è impresentabile" dopo aver ricevuto critiche pure dal mondo Lgbt, dal mondo
femminista e dal Vaticano: "Meglio tardi che mai". La linea dell'apertura al
dialogo è la stessa proposta da Italia Viva. Ecco perché Matteo Renzi gioisce e
apprezza la svolta di Letta: "Se vogliamo che la legge passi, vanno cambiati i
passaggi più delicati". I parlamentari del Movimento 5 Stelle mettono invece in
guardia: "Nessuna mediazione al ribasso".
La partita in Senato
Come andrà a finire la partita del ddl Zan? Le
risposte sono ovviamente ancora ignote. Sta di fatto che quelle in corso sono
ore decisive: nel palazzo, in particolare al Senato, sono partite le trattative
febbrili. Il disegno di legge contro l'omotransfobia dovrà affrontare il primo
vero scoglio mercoledì a palazzo Madama: l'Aula dovrà esprimersi sulle due
richieste di Lega e Fratelli d'Italia di non affrontare l'esame degli articoli.
Un voto segreto, un passaggio fondamentale per il
provvedimento. Si tratta di un voto "in o out" che potrebbe provocare molteplici
effetti. Potrebbe sbarrare le porte dell'Aula e dunque portare il ddl Zan su un
binario morto oppure potrebbe metterlo sul treno che porta all'approvazione. Il
tutto è legato all'appello di mercoledì.
Intanto Alessandro Zan ha riconosciuto che "la
partita è complicata", ma si è detto fiducioso "che alla fine si troverà un
punto di incontro". La mossa di Lega e Fratelli d'Italia viene vista come un
tentativo di "affossare la legge" e dunque è stata giurata battaglia in Aula
"perché non accada". Domani Zan inizierà ad ascoltare i capigruppo dei vari
partiti, ma ha già messo le mani avanti: "Cercherò di capire quali sono le
richieste dei singoli gruppi e se si può arrivare ad una mediazione, che non sia
però al ribasso".
Zan contro Salvini e Meloni per non
attaccare Letta. Luca Sablone il 26 Ottobre 2021 su Il
Giornale. Alessandro Zan se la prende con Salvini e Meloni, ma scorda che
l'apertura alle modifiche del ddl è arrivata proprio da Letta. Il cortocircuito
della sinistra. La sinistra italiana riesce a incartarsi anche sul ddl Zan,
ritenuto il principale cavallo di battaglia per combattere l'omotransfobia. Per
il fronte rosso però c'è un problema: a sollevare critiche e perplessità non è
stato soltanto il centrodestra, ma addirittura il mondo Lgbt, la galassia
femminista e il Vaticano. Una serie di mugugni che hanno spinto Enrico Letta
ad aprire a possibili modifiche rispetto al testo originale. Proprio su questo
fronte emergono tutte le contraddizioni che palesano uno stato confusionario con
cui il ddl rischia di finire su un binario morto.
Zan all'attacco, ma Letta...
Non possono ovviamente mancare attacchi frontali
verso il centrodestra, che da sempre non ha nascosto punti interrogativi sul
disegno di legge. Oggi Alessandro Zan inizierà ad ascoltare i capigruppo dei
vari partiti per provare a trovare un punto di comune accordo, ma ha già
avvertito gli avversari: "Nessuna mediazione al ribasso. Non va stravolta la
legge". E se da una parte c'è l'apertura a rivalutare l'educazione nelle scuole,
dall'altra c'è un netto "no" alla possibilità di rinunciare all'identità di
genere. Una posizione che difficilmente otterrà il parere favorevole del
centrodestra.
Il primo ostacolo dovrà essere superato al Senato
mercoledì, quando l'Aula sarà chiamata a esprimersi sulle due richieste di Lega
e Fratelli d'Italia di non affrontare l'esame degli articoli. Una mossa che
secondo Zan nasconde il tentativo di "ammazzare la legge". Ecco perché il
deputato del Pd se l'è presa con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, accusati di
non voler "discutere della legge ma di affossarla".
Il cortocircuito della sinistra
Evidentemente Zan ha già scordato che ad aprire al
dialogo a eventuali miglioramenti è stato proprio il segretario del suo
partito, Enrico Letta. Il numero uno del Partito democratico nelle scorse ore
aveva anticipato l'intenzione di fare una sorta di esplorazione con le altre
forze politiche "per cercare di capire le condizioni che possano portare a
un'approvazione rapida del testo". Mettendo così in discussione l'attuale testo.
Le parole di Letta hanno trovato il muro del mondo
Lgbt. A esplicitare irritazione e a chiedere chiarezza in tempi brevissimi è
stato Gabriele Piazzoni: il segretario generale di Arcigay ha fatto notare che
anche una sola modifica potrebbe far tornare il testo alla Camera con tutte le
incertezze dal caso. Di conseguenza i termini potrebbero slittare ulteriormente.
Ecco perché c'è chi guarda con sospetto alla mossa di Letta.
Mentre Zan preferisce prendersela con Salvini e
Meloni (che lecitamente fanno il lavoro di opposizione rispetto a un ddl che non
condividono), Arcigay punta il dito contro il segretario del Partito
democratico. "Viene poi da chiedere: quali sono le forze politiche con cui il
deputato Zan viene mandato a trattare? Letta ha per caso intenzione di far
scrivere a Salvini la legge contro i crimini d'odio?", si è chiesto Piazzoni.
Una rappresentazione plastica del cortocircuito della sinistra italiana.
Cosa succede in Senato
In queste ore caldissime, con tanto di trattative
febbrili, si sta provando a raggiungere un compromesso per poter contare su una
maggioranza ampia. Ma la partita è difficile: non sarà una passeggiata coniugare
i pilastri radicali del ddl con le richieste di modifiche del centrodestra.
Mercoledì il Senato voterà sulla proposta di non procedere all'esame degli
articoli: un possibile voto segreto dagli esiti imprevedibili. Le strade sono
due: portare il ddl Zan verso la morte o metterlo sul treno che porta
all'approvazione.
Luca Sablone. Classe 2000, nato a Chieti.
Fieramente abruzzese nel sangue e nei fatti. Estrema passione per il calcio,
prima giocato e poi raccontato: sono passato dai guantoni da portiere alla
tastiera del computer. Diplomato in informatica "per caso", aspirante
giornalista per natura. Provo a raccontare tutto nei minimi dettagli,
possibilmente prima degli altri.
(ANSA il 27 ottobre 2021) - La
cosiddetta "tagliola" - che è stata applicata al disegno di legge Zan al Senato
e richiesta da Lega e Fratelli d'Italia - è una procedura parlamentare che può
condizionare di fatto la sorte di un provvedimento. E' prevista dall'articolo 96
del regolamento del Senato: "Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un
disegno di legge, un senatore per ciascun gruppo può avanzare la proposta che
non si passi a tale esame", recita l'articolo. In sostanza, prevede che,
conclusa la discussione di un provvedimento, non si proceda all'esame degli
articoli e al voto degli emendamenti, come da prassi. Se la "tagliola" viene
approvata, il disegno di legge si arena perché a quel punto, fermandosi l'iter
parlamentare, quella votazione corrisponde a una bocciatura del provvedimento.
Di conseguenza si deve ricominciare da zero ma bisogna aspettare almeno 6 mesi,
per una proposta di legge che, una volta depositata, deve essere calendarizzata
da uno dei due rami del Parlamento per la discussione. Nel caso del ddl Zan,
Lega e FdI hanno anche chiesto che la votazione del non passaggio agli articoli
venisse fatta a scrutinio segreto. Quest'ultima è una possibilità prevista
dall'articolo 113 del regolamento di Palazzo Madama e che deve essere presentata
da 20 senatori. La presidenza può accettare la richiesta, come è avvenuto oggi
in Aula da parte della presidente Casellati.
Si utilizza per
contingentare i tempi di intervento. Che cos’è la tagliola che ha fatto saltare
il ddl Zan e come funziona.
Redazione su Il Riformista il
27 Ottobre 2021. La tagliola si è abbattuta sul disegno di legge contro
l’omotransfobia che tornerà così in Commissione Giustizia da dove probabilmente
non riemergerà più. Ma in che cosa consiste il meccanismo della “tagliola”? Per
capire come funziona occorre far riferimento all’articolo 96 del Regolamento
del Senato, in base al quale “prima che abbia inizio l’esame degli articoli di
un disegno di legge, un senatore per ciascun Gruppo può avanzare la proposta che
non si passi a tale esame”. In sostanza si utilizza per contingentare i tempi di
intervento. Ogni gruppo ha un certo numero di ore di parole in aula, al termine
delle quali si può solo votare. Nel caso del ddl Zan la richiesta è stata
presentata da Fratelli d’Italia e Lega. In sostanza la tagliola prevede che,
conclusa la discussione di un provvedimento, non si proceda all’esame degli
articoli e al voto degli emendamenti, come di consueto. Una volta approvata, il
disegno di legge si arena perché a quel punto, fermandosi l’iter parlamentare,
quella votazione equivale a una bocciatura del provvedimento. Nel caso del ddl
Zan è stata richiesta una “tagliola” a scrutinio segreto. Qui sta alla
presidenza la decisione, come è avvenuto oggi con Maria Elisabetta Alberti
Casellati. Ora è caccia ai cosiddetti franchi tiratori ma intanto il ddl Zan
viene messo nel cassetto.
Ddl Zan, al Senato è
effetto “tagliola”: chi erano gli assenti.
Alessandro Artuso il
27/10/2021 su Notizie.it. Grande tensione all’interno del Senato per il voto sul
Ddl Zan: quali partiti hanno fatto registrare il maggior numero di presenze.
Il Ddl Zan trova diversi ostacoli in Senato e scatta il caos. Le percentuali di
presenza sono state comunque molto alte: Fratelli d’Italia al gran completo.
Al Senato sono stati 154 i voti favorevoli, 131 i contrari e due gli astenuti.
Il risultato della cosiddetta “tagliola” ha dato il via alla caccia a chi ha
boicottato il Ddl Zan a palazzo Madama. Hanno partecipato
alla votazione 287 senatori, erano presenti in Aula in 288 su 320 (escluso il
presidente Casellati che non vota ndr). Come dato aggiuntivo il tabellone
di palazzo Madama ha decretato che, al voto, erano presenti 288 senatori e che
i votanti sono stati 287. Fatti i calcoli su 320 senatori (315 più i senatori a
vita ed esclusa la presidente Casellati ndr), gli assenti sono stati 31. Come
riportato da palazzo Madama il centrodestra aveva 135 senatori più sette
di Idea-Cambiamo che aderisce al Misto. Nel centrosinistra hanno partecipato
alla votazione 136 senatori. Secondo il tabellone riportato sul sito di palazzo
Madama sono state registrate defezioni nel Gruppo Misto. Era presente in Aula
soltanto il 33% dei 49 partecipanti del Misto. Dei 49 del Misto erano presenti
in 33 (dieci assenti e 6 in missione) con il 67,35% di partecipanti al voto.
Assenti 4 esponenti di Italia Viva, presente il 94,59% dei senatori dei 5
Stelle, 96,88% della Lega, 94,74% del Pd e 94% di Forza Italia. Percentuale
dell’87% per le Autonomie.
(ANSA il 27 ottobre 2021) -
"Per mesi ho chiesto di trovare un accordo per evitare di far fallire il ddl
Zan. Hanno voluto lo scontro e queste sono le conseguenze. Chi polemizza sulle
assenze dovrebbe fare i conti con i 40 franchi tiratori. La responsabilità di
oggi è chiara: e dire che per Pd e Cinque Stelle stavolta era facile, più facile
dei tempi di 'O Conte o morte'. Non importava conoscere la politica, bastava
conoscere l'aritmetica". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi ai suoi
parlamentari.
Simonetta Dezi per ANSA il 27
ottobre 2021. Il Senato archivia definitivamente il ddl Zan. Affossato, ad un
anno dall'approvazione della Camera, dalla 'tagliola' chiesta da Lega e Fratelli
d'Italia. 154 voti favorevoli, 131 contrari, e due astenuti hanno messo fine a
un percorso ad ostacoli fatto di ostruzionismo, rinvii, incontri, scontri,
tentativi di mediazione tra favorevoli e contrari che ha tenuto banco a palazzo
Madama dalla primavera all'autunno. La votazione, avvenuta a scrutinio segreto,
è accolta da un lungo applauso del centrodestra trionfante che si dice pronto a
"ripartire da zero". Il disegno di legge, che reca misure di prevenzione e
contrasto della discriminazione e della violenza per sesso, genere o disabilità,
non potrà più essere riproposto e un nuovo ddl con un tema analogo dovrà
aspettare sei mesi per essere trattato in Senato. Queste sono le regole. Le
stesse che hanno portato il presidente Elisabetta Casellati a dare il via libera
al voto segreto. "La mia decisione, per quanto legittimo contestare, perché si
tratta di interpretazione, ha delle solide fondamenta di carattere giuridico",
chiarisce Casellati e mette un punto alle accese contestazioni che si levano
dall'area Pd e M5s. Sono 288 i senatori presenti in Aula per il voto e 287 i
votanti e sono 23 i voti di scarto che decretano la sconfitta di Pd, M5s e Leu.
Eppure in casa dem fino a ieri si contava su almeno su 140 voti a favore, "ne
mancano all'appello almeno 16", spiegano fonti Pd al Senato. I parlamentari
democratici puntano l'indice su Italia viva anche se qualcuno non esclude
sabotatori interni di area riformista. Lo stesso Goffredo Bettini della
direzione del partito è convinto che siano state le "giravolte di sovranisti e
riformisti ad affossarlo". Ma la risposta arriva da Matteo Renzi che parla di
ben 40 franchi tiratori e invita a non pensare alle assenze. "La responsabilità
di oggi è chiara - dice il leader di Iv - Non importava conoscere la politica,
bastava conoscere l'aritmetica". I renziani, che ora accusano Pd, M5s e Leu,
alla Camera avevano votato compatti in favore del ddl Zan, poi in Senato si sono
presi il ruolo di mediatori tra le due fazioni, puntando a una rivisitazione del
testo e proponendo come testo base il ddl Scalfarotto. Sempre tabulati alla mano
gli assenti nel centrosinistra sono almeno 10, mentre nel centrodestra solo 5.
Gli assenti di Italia viva 4, uno di questi Matteo Renzi. Tutti presenti i
senatori di Fratelli d'Italia. "Meglio lo stop di una porcata", chiosa il
Leghista Roberto Calderoli gongolando per la vittoria di cui si intesta la
paternità per aver puntato sulla 'tagliola'. "Sconfitta l'arroganza di Letta e
dei 5Stelle", esulta il leader leghista Matteo Salvini, mentre Enrico Letta
scandisce "hanno fermato il futuro e riportato l'Italia indietro con i loro
inguacchi". "Chi oggi gioisce per questo sabotaggio dovrebbe rendere conto al
Paese" sono le parole del presidente M5s Giuseppe Conte, mentre per il ministro
degli Esteri Luigi Di Maio ritiene "vergognoso" che il ddl Zan sia stato
"spazzato via, nel segreto dell'urna". Secondo la leader di FdI Giorgia Meloni "
i primi ad aver affossato la legge sono i suoi stessi firmatari, Zan in testa" e
definisce "patetiche le accuse di Letta, Conte e della sinistra". La capogruppo
di Fi in Senato, Anna Maria Bernini, accusa la Sinistra di voler solo
"prevaricare" senza un reale interesse per una trattativa. Nel pomeriggio volano
gli stracci anche tra gli alleati: Il "M5s si è fidato dell'esperienza del Pd,
questo è il risultato", commenta Alessandra Maiorino (M5s). Tutti contro tutti.
Ma Loredana De Petris navigata senatrice di Leu le definisce "Prove generali per
il Quirinale", lasciando intendere, ai giornalisti davanti alla buvette, che il
problema dei franchi tiratori si ripresenterà molto presto.
Alessandra Arachi, Carlotta De
Leo per corriere.it il 27 ottobre 2021. Il ddl Zan cade alla prova dell’Aula. Ha
funzionato la «tagliola» con voto segreto richiesta da Lega e FdI. Il Senato
l’ha approvata e così il testo della legge - che prevede le misure di
prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per sesso, genere
o disabilità - tornerà in commissione non prima di sei mesi.
Casellati dice sì alla
tagliola
La presidente del Senato,
Elisabetta Casellati ha dato il via libera alle due richieste di non passaggio
all’esame degli articoli del ddl Zan (la cosiddetta «tagliola») e, ha definito
«ammissibile» in base ai regolamenti e ai precedenti il voto segreto chiesto dai
senatori Calderoli (Lega) e La Russa (FdI). La scelta di Casellati è stata
contestata in Aula da Pd, M5S e Leu. «La mia decisione ha solide fondamenta di
carattere giuridico» ribatte la presidente del Senato.
Calderoli: «Non è una
bocciatura»
Lega e Fratelli d’Italia hanno
infatti chiesto di andare direttamente al voto finale evitando l’esame degli
emendamenti e vogliono il voto segreto. «Piuttosto di fare una porcata, e io me
ne intendo, preferisco fermarci qui» ha detto il senatore leghista Roberto
Calderoli, illustrando la proposta di passare alla «tagliola». «Mi appello a
tutti - ha aggiunto - perché ciascuno possa esprimersi liberamente nel segreto
dell’urna. Fermiamoci oggi. Non è una bocciatura di una legge, si può ripartire
immediatamente ad esaminare un testo vero, meglio uno stop oggi che un ahimé
domani». . A favore della «tagliola», nella maggioranza anche Forza Italia.
Zan: la lega vuole solo
affossare la legge
«La Lega ha chiesto il voto
della tagliola, questo dimostra che vuole affossare la legge. Il rinvio è un
bluff. Quelli della Lega non hanno detto ‘ritiriamo la tagliola per cercare una
mediazione’, hanno detto ’rinviamo il voto della tagliola’. Ma votarla oggi o
tra una settimana non cambia» ha detto Alessandro Zan deputato del Pd e primo
firmatario della legge a L’aria che tira. Zan aveva chiesto a Casellati di non
concedere il voto segreto che «avrebbe potuto uccidere la legge», supportato
dalle associazioni per i diritti dei gay, primo tra tutti il Movimento
arcobaleno. «Faccio un accorato appello a Italia viva perché anche con il voto
segreto votino per respingere questa tagliola» aggiunge Zan. Il leader di Iv,
Matteo Renzi, non è in Aula. L’esame del provvedimento - già approvato dalla
Camera nel novembre scorso - era stato interrotto il 20 luglio per la pausa
estiva. Ma senza un accordo nella maggioranza il testo rischia di finire su un
binario morto.
Da music.fanpage.it il 27
ottobre 2021. Non poteva mancare la posizione di Fedez contro la Politica che ha
affossato il DDL Zan al Senato, dopo mesi e mesi di discussioni e tentativi di
trovare un accordo per farlo passare. Oggi il DDL è stato definitivamente
affossato, per come lo conosciamo, approvando con voto segreto la tagliola su
disegno di legge su proposta di Lega e Fratelli d'Italia e evitando che si
arrivasse alla discussione degli articoli. Una scelta che ha fatto infuriare il
cantante che nei mesi scorsi si era speso, mettendoci spesso la faccia e anche
le forze social, per sensibilizzare sull'argomento. "Bravi tutti, mi piace
ricordarvi così, discussione in Senato in cui avete dato spettacolo – scrive
nelle storie Fedez -. Un saluto al caro Renzi che ci ha trapanato i coglioni per
mesi e oggi pare fosse in Arabia Saudita (Paese in cui l'omosessualità è
accettata con un piccolo prezzo da pagare… la pena di morte). Ancora tante
grazie". Alla storia si associa anche un tweet, sempre contro il leader di
Italia Viva, che nei mesi scorsi si era raffreddato rispetto alò DDL Zan: "Ma il
Renzi che si proclamava paladino dei diritti civili è lo stesso che oggi pare
sia volato in Arabia Saudita mentre si affossava il DDL Zan? Per celebrare la
libertà di parola organizziamo una partitella a scarabeo con Kim Jong-un? Gran
tempismo". Oltre alla notizia dell'affossamento del DDL, il rapper ha condiviso
un vecchio intervento della Senatrice della Lega Raffaella Fiormaria Marin che
metteva in dubbio la sostanza contro cui si scagliava il disegno di legge,
ovvero che esistesse una violenza dettata proprio dall'orientamento sessuale
delle persone: "Ma l'alibi si regge sul fatto che le persone non etero subiscano
maggiormente violenze rispetto alle persone etero. Chi l'ha detto? Dove sta
scritto? Siamo sicuri che gran parte di questi atti violenti siano
esclusivamente messi in atto per ragioni di orientamento sessuale?".
Da rollingstone.it il 29
ottobre 2021. Ieri sera, in diretta dal Teatro Repower di Milano, sono iniziati
i live di X Factor 2021, la fase finale e più attesa del talent. Prima di dare
spazio ai cantanti in gara, i giudici della trasmissione – in particolare Emma
Marrone e Mika – hanno sfruttato l’inizio della puntata per parlare
dell’affossamento del ddl Zan (ne abbiamo parlato qui) e delle reazioni della
destra al voto in Senato. «Mi dispiace di non poter festeggiare questa sera un
passo avanti che aspettavamo e che riguarda tutti noi perché riguarda i diritti
di tante persone», ha detto Emma. «Le immagini che abbiamo visto ieri in Senato,
quando è stato definitivamente bloccato il percorso del ddl Zan, sono state
imbarazzanti e rimarrà una brutta pagina della nostra storia. Dicendo questo,
credo di poter parlare anche a nome dei miei colleghi al tavolo, in un programma
che si è sempre impegnato e battuto contro ogni forma di discriminazione». Per
Mika, invece, le immagini del Senato non rappresentano «l’Italia che amo e che
mi ha accolto e difeso in questi anni. Ma là fuori c’è ancora l’Italia capace di
amare e accogliere e nella quale voglio continuare a credere». I giudici di X
Factor non sono gli unici musicisti ad aver commentato duramente l’affossamento
del disegno di legge. Prima di loro è intervenuto Fedez – «Avete dato
spettacolo», ha detto –, oltre a Gaia (che ha condiviso sulle storie Instagram
le immagini della manifestazione di ieri a Milano), Alessandra Amoroso, Michele
Bravi e altri. Ne hanno parlato anche alcuni artisti internazionali, come Daryl
Hannah («Vergogna», ha scritto su Twitter) e Jennifer Beals, che ha commentato
le immagini del Senato in italiano: «Schifoso».
Claudio Bozza per il “Corriere
della Sera” l'8 novembre 2021. D'un tratto, in diretta tv, la voce di Vincenzo
Spadafora s' incrina: «Perché ho deciso di rivelare che sono omosessuale? Io
l'ho fatto anche per me stesso. Perché, anche se l'ho imparato troppo tardi, è
importante volersi bene e innanzitutto rispettarsi». L'ex ministro dello Sport,
intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa , si commuove. Poi, sostenuto
anche da un applauso in studio, prende fiato e inizia a raccontare di quanto
anche il suo impegno politico sia stato bersagliato da un «chiacchiericcio»
improntato all'omofobia. Il deputato del M5S nel suo libro Senza riserve
(Solferino) ne parla appunto a ruota libera. «Penso che la vita privata delle
persone debba rimanere tale - riprende Spadafora - e se noi fossimo un Paese
culturalmente più avanzato, soprattutto sul tema dei diritti, forse anche i
dibattiti di queste settimane non li avremmo neanche affrontati. Penso però
anche che chi ha un ruolo pubblico, politico come il mio, in questo momento
storico, abbia quale responsabilità in più». Il coming out prosegue poi così:
«Oltre a quella privata, c'è anche un'altra motivazione in questa mia scelta,
quella politica: è appunto un modo per testimoniare il mio impegno politico. Per
tutti quelli che ogni giorno - rivendica - combattono per i propri diritti e
hanno meno possibilità di farlo rispetto a quante ne abbia io grazie al mio
lavoro». Spadafora tiene a marcare anche la propria fede cattolica come fattore
«non in contraddizione» e chiude con un'altra riflessione privata: «Il tema
dell'omosessualità, in politica, purtroppo viene ancora utilizzato per ferire
l'avversario, per quel brusio di fondo a volte molto squallido e che ho subito
anche io. Io questa sera volevo spegnere questo brusio - sottolinea in tv -
sapendo che resto l'uomo che sono, con tutto il percorso, anche complicato,
personale, che ognuno di noi fa nella sua vita, per qualunque motivo. E di cui
dobbiamo avere molto rispetto». E infine: «Spero di essere considerato da domani
per quello che faccio, per come lo faccio, lo stesso uomo di sempre. Forse da
domani - dice con il volto decisamente più disteso rispetto all'inizio
dell'intervista - sarò solo un po' più felice. Perché sarò anche più libero». Il
parlamentare M5S, che in passato aveva guidato anche la segreteria del ministero
dei Beni culturali con Francesco Rutelli e aveva presieduto l'Unicef, chiuso il
capitolo personale passa a quello prettamente politico e lancia un altolà. Dice
che nel M5S il rischio di scissione «c'è e io lavoro affinché ciò non avvenga».
E per evitarlo invita Conte a «non interpretare la sua leadership in modo
solitario: coinvolga tutti». Sul nodo Quirinale, Spadafora spera inoltre che
«Conte voglia convocare i gruppi: penso che siano finiti i tempi in cui queste
cose si decidevano altrove, ora si decidono insieme. Dal M5S può uscire la linea
politica che chiede a Draghi di restare a fare il presidente del Consiglio», per
«il bene del Paese». Ma l'ex premier «non lo ha ancora esplicitato».
Il coming out dell'ex
ministro Spadafora: "Sono omosessuale".
Francesca Galici il 7 Novembre
2021 su Il Giornale. Da Fabio Fazio, Vincenzo Spadafora ha fatto coming out
rivelando la propria omosessualità, argomento di cui parla anche nel suo libro.
Ospite in tv di Fabio Fazio, l'ex ministro Vincenzo Spadafora ha fatto coming
out: "Penso che la vita privata delle persone debba rimanere tale e se noi
fossimo un Paese culturalmente più avanzato, soprattutto sul tema dei diritti,
forse anche i dibattiti di queste settimane non li avremmo neanche affrontati.
Penso però anche che chi ha un ruolo pubblico, politico come il mio, in questo
momento storico, abbia quale responsabilità in più". L'occasione è il libro dal
titolo Senza riserve che l'ex ministro ha in uscita il prossimo 11 novembre,
dove parla in maniera articolata di questo tema, così caldo in Italia: "Io l'ho
fatto, devo dire, anche per me stesso, perchè ho imparato, forse molto tardi,
che è molto importante volersi bene e innanzitutto rispettarsi. Poi ci sono due
motivazioni", ha detto Spadafora mostrando una certa commozione davanti alle
telecamere di Che tempo che fa. "Una motivazione è molto politica, questo è un
modo per me anche per testimoniare il mio impegno politico. Per tutti quelli che
ogni giorno combattono per i propri diritti e hanno meno possibilità di farlo
rispetto a quante ne abbia io grazie al mio lavoro", ha sottolineato. Un coming
out arrivato a pochi giorni dalla bocciatura del ddl Zan in Senato, anche e
soprattutto a causa dei franchi tiratori che l'hanno affossato. Spadafora ci ha
tenuto a marcare anche la propria fede cattolica, che dal suo punto di vista non
è un fattore "in contraddizione" con l'orientamento sessuale. Quindi, ha
aggiunto: "Questo tema in politica purtroppo viene ancora utilizzato
per ferire l'avversario, per quel brusio di fondo a volte molto squallido e che
ho subito anche io". Quindi, ha concluso: "Io questa sera volevo spegnere questo
brusio - sottolinea - sapendo che resto l'uomo che sono, con tutto il percorso,
anche complicato, personale, che ognuno di noi fa nella sua vita, per qualunque
motivo. E di cui dobbiamo avere molto rispetto". "Spero di essere considerato da
domani per quello che faccio, per come lo faccio, lo stesso uomo di sempre.
Forse da domani sarò un po' più felice. Perché sarò anche più libero". Questo
sarebbe il secondo coming out in Rai in pochi giorni. Il primo dovrebbe essere
stato quello del giornalista e conduttore Alberto Matano, che davanti alle
telecamere de La vita in diretta ha fatto un veloce passaggio senza mai scendere
troppo nel dettaglio. Una confessione smorzata, in cui ha rivelato di
aver ricevuto insulti omofobi nel giorno della bocciatura del ddl Zan.
Francesca Galici. Giornalista
per lavoro e per passione. Sono una sarda trapiantata in Lombardia. Amo il
silenzio.
Da striscialanotizia.mediaset.it il 9 novembre 2021. Pinuccio approfondisce il
coming out di uno dei "Re della Rai" (nonché"ex ministro per le Politiche
Giovanili e lo Sport)"Vincenzo Spadafora. Domenica sera "in diretta da Fabio
Fazio" l'esponente pentastellato ha rivelato di essere gay, e allora - chiede
Pinuccio - adesso non potrebbe fare coming out anche su quante persone ha
piazzato in Rai?
Annalisa Cuzzocrea per “La
Stampa” il 10 novembre 2021. «Nella vita ho amato più uomini che donne»,
racconta Vincenzo Spadafora fin dalle prime pagine della sua autobiografia. L'ex
ministro dello Sport, già sottosegretario ai Giovani e alle Pari Opportunità,
ora deputato semplice di un Movimento 5 stelle in subbuglio, parte dalla sua
omosessualità solo accennandola. E ci torna alla fine, quando - come ha fatto a
Che tempo che fa - spiega che «la vita privata è un elemento che difficilmente
un politico può tenere solo per sé». Parlarne per sentirsi liberi, quindi. Per
far smettere il brusio di fondo di chi alle spalle racconta. Per «incoraggiare
altri a non sentirsi soli e a non avere paura». Ma le pagine di libri come
questo Senza riserve. In politica e nella vita, in uscita domani per Solferino,
vanno lette in filigrana per coglierne il senso reale. E sfrondate dalle
notazioni personali e dalle aspirazioni di un uomo che ha realizzato il suo
sogno di bambino, diventare un politico (l'alternativa era il presentatore tv e
qualsiasi riferimento a Matteo Renzi è puramente casuale), queste pagine
raccontano del sodalizio con Luigi Di Maio. Delle battaglie combattute come di
quelle in corso. Così, Spadafora non risparmia critiche alla gestione del
Movimento da parte di Giuseppe Conte. Avvertendo: «Se si chiude, è perduto». Se
qualsiasi voce critica continuerà a essere vissuta come un fastidio, una
scissione sarà inevitabile. Sa bene che i 5 stelle arrivano da tempi in cui le
voci critiche, più che mal tollerate, erano cacciate al primo mugugno. Lo sa e
non nasconde di essere stato, al principio, un marziano. Come quando disse a Di
Maio: «Se riusciamo a sopravvivere al confronto con l'establishment sarà già un
ottimo risultato» e lui lo avvisò: «Vincenzo, ti prego, non usare mai quella
parola». O quando dice di aver capito prima degli altri che uscire su un balcone
a dire: «Abbiamo abolito la povertà», con tanto di militanti chiamati a portare
le bandiere, sarebbe stato un boomerang. Come fu. E così Senza riserve sembra
fare da complemento a Un amore chiamato politica. Laddove Di Maio tace, il suo
(ex?) consigliere più fidato rivela. Rapidamente, quando si tratta di momenti
scomodi («L'ansia di prestazione e la volontà di non rinnegare il passato
movimentista portarono Luigi a un gesto sconsiderato: andare a incontrare i
Gilet gialli»). Più approfonditamente, quando vuole tirare stoccate agli
avversari interni. Almeno due sono rivolte a Roberto Fico: quando il Movimento
trattava per la sua elezione alla presidenza della Camera e lui - il primo dei
duri e puri - confermò che non bisognava andare per il sottile pur di arrivarci.
O quando, mentre gli altri puntavano ancora a un Conte ter, diede a Draghi il
numero di telefono di Grillo: «Una mossa non concordata con nessuno aveva messo
tutti di fronte al fatto compiuto». Gli aneddoti sono molti: quando Conte era a
Gaeta e non voleva andare a Milano per incontrare Di Maio e Salvini, che
dovevano fargli quella sorta di "provino" con cui fu scelto per guidare il
governo giallo-verde (fu Spadafora a comprargli il biglietto). Quando Giorgetti
si alzava per telefonare e andare in bagno e Salvini, che ne soffriva
l'autorevolezza, si affrettava a dire: «Le conclusioni si tirano con me». O
ancora Giorgetti, che davanti alla rosa del Movimento dice: «Il prefetto no, la
donna no, se volete incontriamo questo avvocato». E poi - nella pazza estate del
2019 - smette di rispondere al telefono e ai messaggi: il segnale che quel
governo stava per finire. Sulla fine del Conte due, invece, Spadafora esplicita
quel che Di Maio aveva accennato: l'operazione dei responsabili ribattezzati
"costruttori" fu una follia. Così come fu sbagliato non aprire un tavolo con
Renzi su rimpasto e riforma della giustizia. Ma è il giudizio sull'oggi, il più
severo. Quello sulla politica dei selfie e dei like che non diventano voti (ma
non valeva anche prima?). E su un Movimento che starebbe rimettendo un uomo solo
al comando, ripetendo l'errore di sempre.
Striscia la Notizia
demolisce Vincenzo Spadafora: "Su cosa deve fare coming-out", bomba sulla Rai.
Libero
Quotidiano il 09 novembre 2021. Tiene ancora banco il coming-out di Vincenzo
Spadafora, l'ex ministro dello Sport grillino che, domenica sera a Che tempo che
fa di Fabio Fazio su Rai 3, ha rivelato la sua omosessualità, per quanto fosse
di fatto nota da tempo (ma mai confermata in modo ufficiale dal diretto
interessato). Il coming-out di Spadafora ha fatto rumore per una serie di
differenti ragioni. La prima, ovviamente, il semplice fatto di parlarne, perché
non è mai così semplice così come può sembrare. Dunque per le critiche, per le
polemiche e i sospetti. Ad aprire le danze era stato Dagospia, che ha un poco
maramaldeggiato sul tempismo, sulla coincidenza con il fatto che nei giorni
scorsi anche Alberto Matano abbia rivelato la propria omosessaulità. Dunque la
stilettata da Maria Giovanna Maglie, che in un tweet si è spesa in tre
considerazioni piuttosto velenose: "Vincenzo Spadafora, ex ministro e deputato
5s fa coming out da Fazio. Urgono considerazioni :
1) deve vendere il libro in
cui lo ha scritto già, 2) lo sapeva chiunque soprattutto in RAI, 3) infine, e
semplicemente, chi se ne frega". Quindi, ancora Dagospia, che in serata ha
insistito su una frase di Spadafora: "Il tema dell'omosessualità, in politica,
purtroppo viene ancora utilizzato per ferire l'avversario", aveva detto l'ex
ministro da Fazio. Frase che secondo Dagospia poteva essere rivolta contro Il
Fatto Quotidiano, che a maggio 2018, in un ritrattone di Marco Lillo, silurarono
le possibilità di Spadafora di ri-diventare ministro tirando fuori alcune
vecchie intercettazioni". Bene, e dopo tutto questo ecco scendere in campo,
contro Spadafora, anche Striscia la Notizia. Il tutto nella puntata in onda su
Canale 5 nella serata di lunedì 8 novembre. Ad occuparsi del coming-out,
ovviamente, l'inviato "specializzato" in Rai e dintorni, ovvero Pinuccio, che si
pone una semplice e fragorosa domanda: "Adesso Spadafora non potrebbe fare
coming-out anche su quante persone ha piazzato in Rai?", conclude Pinuccio. E la
bomba di Striscia è servita.
"Anche io vittima...": la confessione di
Matano in tv. Novella Toloni il 29 Ottobre 2021 su Il
Giornale. Nell'ultima diretta del suo programma il conduttore ha raccontato il
suo dramma privato: "È successo anche a me, l'ho provato sulla mia pelle". L'eco
della bocciatura in Senato del ddl Zan è arrivato anche negli studi televisivi e
non solo sotto forma di notizia. Nelle scorse ore molti volti noti della
televisione, in particolare conduttori, hanno aperto o chiuso i loro programmi
riservando commenti e riflessioni personali sulle votazioni svoltesi a palazzo
Madama. Anche a La vita diretta, il programma del pomeriggio di Rai Uno, si è
discusso a lungo sullo stop al ddl Zan. Ma al di là dei commenti e del dibattito
sono state le dichiarazioni fatte in studio dal presentatore e
giornalista Alberto Matano, che avrebbe fatto un vero e proprio coming out
parlando di vicende del suo passato in cui lui stesso fu vittima di violenza
omofoba. La regia era da poco rientrata in studio dopo la messa in onda di un
servizio, in cui si raccontavano alcuni episodi di violenza omofoba avvenuti
negli ultimi anni in Italia. Storie di pestaggi, abusi e vessazioni subite da
giovani, uomini e donne, e ripercorse in una cronistoria intensa. Al termine
della clip le telecamere hanno indugiato sul primo piano di Alberto Matano, che
si è lasciato andare a un'accorata riflessione personale letta da tutti come un
vero e proprio coming out: "Storie come queste mi fanno particolarmente male,
perché quando ero adolescente è successo anche a me, l'ho provato sulla mia
pelle, quindi so cosa significa. Allora mi auguro che con il contributo di tutti
su un tema così importante ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo
dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto". La riflessione di
Alberto Matano ha provocato uno scossone sul web, dove in molti si sono chiesti
se dietro alle sue parole ci fosse una dichiarazione sulla propria
omosessualità: "Ma quindi indirettamente ha fatto coming out?", "Scusate, ma
Alberto Matano ha appena fatto coming out a La vita in diretta?". Il pubblico si
è letteralmente diviso in due, scisso tra chi ha trovato "delicato e garbato" il
suo modo di esporsi e chi invece ha intravisto una mancata presa di posizione:
"Si è come sempre sprecato, la solita ipocrisia di dichiarare che sei gay senza
però ammetterlo pubblicamente e apertamente. D'altronde lavora sempre in Rai
Matano!". Un anno fa Alberto Matano, però, aveva dichiarato -
durante un'intervista al settimanale Chi - di non essere gay e di non amare
"etichette e categorie", scegliendo di essere valutato per il suo lavoro da
giornalista e non per la sua vita privata, che da sempre tiene al riparo da
gossip e rumor.
Novella Toloni. Toscana Doc, 40 anni, cresco con
il mito di "Piccole Donne" e del personaggio di Jo, inguaribile scrittrice
devota a carta, penna e macchina da scrivere. Amo cucinare, viaggiare e non
smetterò mai di sfogliare riviste perché amo le pagine che scorrono tra le dita.
Appassionata di social media, curiosa per natura, il mio motto è "Vivi e lascia
vivere", perché non c’è niente di più bello delle cose frivole e leggere che
distolgono l’attenzione dai problemi
Ddl Zan, Antonella Clerici
in diretta: “Peccato, abbiamo perso un’occasione”.
La conduttrice Rai, molto
amareggiata, parla del Ddl Zan: "Come italiani abbiamo vinto davvero tutto,
siamo al top. Peccato per i diritti civili perché abbiamo perso un'occasione".
Il Fatto Quotidiano il 28 ottobre 2021. Durante la puntata di È sempre
mezzogiorno andata in onda oggi 28 ottobre, Antonella Clerici ha esordito
facendo riferimento all’ok alla tagliola di ieri 27 ottobre che ha di fatto
interrotto l’iter del Ddl Zan. Con il sottofondo delle note di Beggin cantata
dai Maneskin, la conduttrice ha detto: “Vogliamo parlare dei Maneskin? Il 6
novembre a Las Vegas apriranno il concerto dei Rolling Stones! Un grande
fenomeno del momento e sono italiani, questo mi piace moltissimo”. Poi,
ripercorrendo gli ultimi successi del nostro Paese (dallo sport al Nobel per la
Fisica), è arrivata dritta al punto: “Abbiamo vinto davvero tutto, siamo al top.
Peccato per i diritti civili perché abbiamo perso un’occasione“. Infine ha
concluso, con tono amareggiato: “Ma questa è un’altra storia”.
Il Corriere della Sera, che
sin dalla fondazione nel 1876 crede nel valore primario dell’informazione, ha
aderito al Trust Project. Si tratta di un’iniziativa internazionale che
coinvolge centinaia di testate in tutto il mondo e punta a chiarire da subito ai
lettori la credibilità e l’autorevolezza di un contenuto giornalistico. Per
farlo, assegna una etichetta riconoscibile sulla base di standard uniformi e
condivisi.
(ANSA il 28 ottobre 2021) -
"E' inutile fare i finti paladini dei diritti civili, quando ieri al Senato
alcuni partiti politici hanno affossato il ddl Zan. Un provvedimento a favore
proprio dei diritti civili, un provvedimento di dignità, spazzato via tra gli
applausi umilianti dell'Aula. Il quotidiano britannico The Guardian definisce il
voto di ieri 'vergognoso'. Confermo e sottoscrivo. Questa è l'immagine
dell'Italia che la politica consegna al mondo". Lo scrive su Facebook il
ministro degli Esteri Luigi Di Maio.
(ANSA il 28 ottobre 2021) -
"Nel mio libro parlo del tema dell'omosessualità. Per me è inaccettabile che
tutt'oggi questo tema venga usato con un'accezione negativa, dispregiativa,
denigratoria. È agghiacciante che una parte della politica, con il
coinvolgimento di alcuni media, provi a screditare le persone dando un
significato negativo alla parola omosessualità. Non c'è cosa più meschina". Lo
scrive il ministro Luigi Di Maio in un post su Facebook sul ddl Zan. "Continuo a
leggere commenti sessisti e omofobi, così si alimenta la cultura dell'odio che
colpisce e ferisce le persone. Ora, però, bisogna fermarsi un attimo, realizzare
che forse è stato superato ogni limite e bisogna mettere un punto a tutto
questo. Un punto fermo. L'Italia nel 2021 non può accettare discriminazioni di
questo genere", conclude il titolare della Farnesina.
Vittorio Feltri per “Libero
quotidiano” il 28 ottobre 2021. La legge Zan non mi pare abbia un futuro
luminoso. Se non sbaglio sarà cassata o fortemente ridimensionata. La botta
finale al provvedimento che balla in Parlamento è stata data dalla Chiesa, che
ogni tanto invece di occuparsi di immigrati, si impegna in campi ad essa più
congeniali. In effetti i Papi, quando la smettono di predicare su temi
strettamente politici e affrontano questioni etico-morali, hanno voce in
capitolo e si fanno ascoltare. Le pretese di Zan sono assurde e ha fatto bene la
Santa Sede a farlo notare. Personalmente non sono credente e non sempre sono del
parere dei Pontefici allorché essi esprimono il loro pensiero su vari argomenti,
ma nel caso in questione, la sciocchezza di Zan, sono d'accordo con loro nel
contestarla. Senza entrare nei dettagli, non volendo tediare i lettori, non
capisco perché non si possano considerare diversi gli omosessuali rispetto agli
eterosessuali. Difatti è indiscutibile che i sessi siano due: maschile e
femminile. E vanno definiti come meritano. Il particolare che esistano parecchi
gay non significa che essi vadano disprezzati o addirittura insultati. Ci
mancherebbe. Ciascuno ha i propri gusti e nessuno è autorizzato a discutere su
quelli che vanno approvati oppure respinti. Ma mettere in dubbio che la natura
ha distinto strutturalmente gli uomini dalle donne significa ignorare la realtà.
Noi italiani siamo abituati a scherzare: prendiamo in giro i preti, abbiamo un
linguaggio disinibito, ridiamo dei politici, i carabinieri sono una fonte
inesauribile di barzellette, se però dici una battuta sui pederasti rischi
'emarginazione. Se passasse la scemenza Zan, chi sfotte i gay sarebbe
giudiziariamente perseguibile. Siamo al delirio. Ormai la faccenda del
politicamente corretto è diventata seria e minaccia di sfociare nella più tetra
delle censure. È intollerabile che si faccia la guerra addirittura al dizionario
della lingua italiana, che distingue da sempre ciò che è maschile da ciò che è
femminile. Se poi un uomo giace con un altro uomo, chissenefrega. Ma vietarci di
far notare la differenza è un'autentica idiozia. Va da sé che insultare un omo
per i suoi gusti sessuali è ingiusto e punibile, ma questo vale anche per un
etero. Non c'è bisogno di una legge per confermare questo sacrosanto principio,
che è già chiaro a tutti.
Giampiero Mughini per Dagospia
il 28 ottobre 2021. Caro Dago, non ricordo più se fosse il 1974 o il 1975, e io
avevo da poco cominciato a guadagnarmi il pane battendo ai tasti della macchina
da scrivere per la terza pagina del “Paese Sera”, il quotidiano romano che prima
della nascita della “Repubblica” era il giornale prediletto della sinistra. Il
mio interlocutore diretto era Giulio Goria, un comunista torinese di quando il
termine “comunista” svelava davvero un’identità, una storia personale e
professionale. Fatto è che fu certamente Goria a dirmi di coprire
giornalisticamente un convegno di omosessuali italiani che si sarebbe svolto in
due successive giornate in un teatro romano che di solito ospitava spettacoli di
avanguardia. Non lo ricordo con esattezza, ma mi sembra che ad organizzare
quelle due giornate fosse stato il “Fuori” di Angelo Pezzana, il raffinato
libraio torinese di cui ero amico. Poco meno di cinquant’anni fa, eccome se
quelle non erano le prime uscite pubbliche di un mondo che fino a quel momento
se ne stava celato al possibile, che stentava a dire di sé. Molto molto molto
lontano dall’oggi e dalle sue usanze. Tanto più che ero alle prime armi del
mestiere, in quel teatrino romana dove la luce era soffusa e dove in sottofondo
suonava una canzone dei Pink Floyd mi muovevo in punta di piedi. Lo capivi a
volo di avere a che fare con una comunità umana non riconosciuta come tale e che
per la prima volta pronunziava a voce alta le cose che la riguardavano. Stavo ad
ascoltare con tutto me stesso, così come loro si esponevano con tutto loro
stessi. L’exploit di gran lunga il più risonante e drammatico lo fece Mario
Mieli, e a quell’exploit assistetti come trattenendo il fiato. Milanese,
penultimo di sette figli, lui aveva in quel momento poco più di trent’anni e
gliene restavano da vivere poco meno di dieci. Era salito sul palco e non è che
parlasse, agiva a mezzo delle parole, comunicava quello che stava vivendo nel
raccontare furiosamente la sua omosessualità. Era un uomo dolente, una persona
che stava misurando le sue cicatrici e che in tutto questo ci metteva un
orgoglio smisurato. Non esagero, era uno che in ogni parola che diceva restava
in bilico costante tra la vita e la morte. Mai avevo visto o sentito nulla del
genere, qualcosa di talmente drammatico, di talmente coinvolgente. Nello
scrivere quei due pezzi per il “Paese Sera” cercai di trasmetterla tutta quanta
quella mia emozione, quel mio stupore innanzi a una “provocazione” umanamente e
intellettualmente talmente affinata. Non so ci riuscii. Se ci furono altri
giornali che diedero conto di quell’appuntamento che poco meno di mezzo secolo
s’era dato il nascente movimento degli omosessuali italiani? Non ne sono sicuro,
qualcuno forse sì. Tutto questo per dirvi invece quanto non abbia provato invece
la benché minima emozione innanzi alla vicenda tutta politicante del decreto
contro la omotransfobia che è andato ieri gambe all’aria in Parlamento. Non ho
provato emozione (semmai ripugnanza) per quelle urla cialtronesche provenienti
dalla parte del Senato che più spavaldamente lo aveva bocciato, ma non ho
neppure provato emozione per il modo e per gli argomenti con cui lo sostenevano
accanitamente alcuni di quelli che il decreto Zan lo avevano promosso e che lo
hanno mandato a impattare contro uno scacco parlamentare. Bastassero poche righe
di un testo legislativo a placare l’odio di cui la nostra società ribolle tutta
intera e di cui in tantissimi - da una parte e dall’altra dell’emisfero
politico - hanno preso a nutrirsi come dell’aria che respirano.
Giacomo Susca per "il
Giornale" il 29 ottobre 2021. Il meccanismo social che distorce azioni e
reazioni ci sta abituando a cortocircuiti che rispondono a logiche bizzarre,
anche quando la logica sembra aver abbandonato il dibattito pubblico. Prendete
la vicenda del ddl Zan, naufragato in Aula sotto i colpi dei franchi tiratori
Pd, Iv e M5s. In tanti tra gli strenui difensori del provvedimento stanno
rivolgendo ogni tipo di accusa nei confronti dei senatori che hanno messo una
pietra tombale su un testo così divisivo. Fuori dal Palazzo, la questione ha
scatenato l'indignazione di molti volti noti dello spettacolo, che definiscono
il voto del Senato «indegno di un Paese civile». Se il criterio di giudizio
fosse uniforme, dovrebbero scandalizzare le esternazioni di chi, deluso per la
battaglia persa, paragona l'Italia ai regimi totalitari in fatto di tutela delle
minoranze. Insomma, se è giustamente bollata come un'idiozia vaneggiare di
«dittatura sanitaria» nelle piazze dei No green pass, nulla da obiettare invece
quando si assimila il nostro Paese a un regime talebano che perseguita la
comunità Lgbtq. Se c'è un merito nella discussione sulla legge contro
l'omotransfobia è di aver spostato l'attenzione sul peso delle parole. Perciò fa
riflettere che la principale paladina social della causa arcobaleno, Chiara
Ferragni, abbia postato uno sfogo, questo sì, davvero «colorito». Dall'alto dei
suoi milioni di seguaci, l'influencer si è scagliata contro la classe politica:
«Siamo governati da pagliacci senza palle». Tralasciando il fatto che governo e
Parlamento sono due cose diverse, non bisogna essere esperti di diritto
costituzionale per riconoscere che «senza palle» altro non è che un insulto
sessista. Proprio come quelli che il ddl Zan avrebbe voluto punire severamente.
E non si tratta di sfumature lessicali, visto che l'odio e il pregiudizio
viaggiano sul crinale del linguaggio adoperato. Un team di linguisti provenienti
da 12 Paesi non ha avuto dubbi nel decretare che l'espressione «senza palle»
corrisponde a una «cultura fortemente maschilista». La stessa Michela Murgia,
grande sponsor della legge appena affossata, inserisce la locuzione «avere/non
avere le palle» nel decalogo delle frasi discriminatorie «che non vogliamo
sentire più». Se non basta, ecco la Cassazione con una sentenza del 2012 a
stabilire che «l'espressione ha una evidente e obiettiva valenza ingiuriosa,
atteso che con essa si vuole insinuare non solo e non tanto la mancanza di
virilità del destinatario, ma la sua debolezza di carattere, la mancanza di
determinazione, di competenza e di coerenza, virtù che, a torto o a ragione,
continuano ad essere individuate come connotative del genere maschile». A
proposito di cortocircuiti gender, di caccia alle streghe e presunti golpe
liberticidi.
Dagospia il 29 ottobre 2021.
PER FORTUNA CHE ERANO QUELLI CONTRO IL LINGUAGGIO D'ODIO! "UCCIDERE UN FASCISTA
NON E' UN REATO", "OBIETTORE, TI SDRAIAMO SENZA FARE RUMORE", A ROMA NELLA
MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CONTRO LO STOP AL DDL ZAN VA IN SCENA LA FURIA
ARCOBALENO TRA INSULTI A RENZI, MINACCE DI MORTE A PILLON E UN OSCENO REVIVAL DI
SLOGAN ANNI '70 - MIGLIAIA IN CORTEO, LA SENATRICE CIRINNA': "SIAMO PIU'
INCAZZATI MA PIU' UNITI" (IL CANE MILIONARIO, COME STA?)
Da fanpage.it il 29 ottobre
2021. Migliaia di persone stanno manifestando in all'inizio di via San Giovanni
in Laterano, la ‘gay street' di Roma, per protestare contro lo stop al disegno
di legge Zan votato ieri al Senato. All'incrocio della strada che collega piazza
San Giovanni in Laterano al Colosseo è stato allestito un piccolo spazio con un
microfono al quale si stanno alternando tante voci per manifestare il dissenso
con quanto accaduto ieri con il voto che ha di fatto detto la parola fine, per
almeno sei mesi, all'approvazione della legge contro la omotrasnfobia. ‘Questa
voce nessuno la affossa', c'è scritto su uno dei cartelli dei manifestanti, e
‘restistiamo' su un altro. Il sit in si è poi trasformato in un vero e proprio
corteo nelle strade del centro di Roma. "Avete bloccato la legge Non bloccherete
la lotta", lo slogan dello striscione alla testa della manifestazione. Non è
chiaro se il corteo sia stato autorizzato dalle forze dell'ordine oppure no.
Diverse le pattuglie della polizia locale intervenute nella zona del Colosseo
per agevolare il traffico automobilistico. Sul posto anche alcune camionette
della polizia per gestire eventuali disordini, ma tutto, per il momento, si sta
svolgendo senza particolari problemi. Migliaia di persone sono scese in piazza
anche a Milano per protestare contro l'affossamento del ddl Zan. "Noi qui
possiamo venire a testa alta, forti della battaglia che abbiamo portato avanti
con coerenza, dall'inizio alla fine", ha scritto sui sociale vicepresidente del
Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando, che è
presente alla manifestazione in corso a Roma. In piazza anche la senatrice dem
Monica Cirinnà: "Il voto non ci ha sconfitto, siamo più forti e più unite che
mai. Da oggi parte una nuova iniziativa sui diritti, forte, egualitaria.
rappresentativa, radicata nel rapporto tra @pdnetwork, le associazioni, il
movimento. Non ci fermiamo. Siamo più incazzati, ma siamo anche più forti e più
uniti".
François de Tonquédec per "la
Verità" il 29 ottobre 2021. Quella di eri sera, in una Roma che stava iniziando
a blindarsi, tra divieti di sosta e rimozioni perfino di biciclette e
monopattini, per il G20 di questo fine settimana, doveva essere una protesta dei
sostenitori del ddl Zan, contro lo stop all'iter parlamentare della legge. In
piazza era previsto che ci fossero: il circolo di cultura omosessuale Mario
Mieli, gli studenti di Uds e Link, Arci Roma. Ma dopo poco più di un'ora si è
trasformato in quella che sembrava più una prova generale delle proteste contro
il vertice dei capi di Stato che si terrà all'Eur. Una prova generale che
risulta priva di autorizzazione, anche se in piazza alcuni esponenti delle forze
dell'ordine che si confrontavano sul tema ritenevano che il via libera ci fosse.
Contattato dalla Verità, l'ufficio stampa della Questura di Roma ha spiegato due
volte, la prima durante la mattinata, la seconda a meno di un'ora dall'inizio
della protesta, di non sapere nulla di una manifestazione a via di San Giovanni
in Laterano, nella cosiddetta gay street, a due passi dal Colosseo. Anche fonti
interne ad Atac, l'azienda del trasporto pubblico locale capitolino, hanno
confermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione di un evento che poteva
avere ricadute sul servizio di tram. Cosa puntualmente successa, quando i
partecipanti accalcati hanno invaso i binari, paralizzando quel quadrante di
Roma. Presente una delegazione di +Europa, composta dal segretario Benedetto
Della Vedova, dal presidente Riccardo Magi e da Rita Di Sano della segreteria.In
piazza anche Alessandro Zan, firmatario del provvedimento caduto sotto la
«tagliola» del Senato, Monica Cirinnà, in cappotto rosso e con mascherina
arcobaleno, ma senza la ormai famosa cane. A differenza di molti manifestanti,
con cuccioli a seguito, ben poco felici della calca in cui erano stati
trascinati. Impossibile sentire con chiarezza gli interventi, con il pubblico
che passava da un «non ho capito niente di quello che ha detto», riferito
all'oratore di turno, a scroscianti applausi, evidentemente sulla fiducia.
Principale bersaglio, anche se inizialmente non nominato direttamente, il leader
di Italia viva, Mattero Renzi, reo di aver proposto di «trattare». Questo almeno
fino a quando, al grido di «corteo, corteo!» i manifestanti hanno trasformato la
manifestazione in una sfilata verso piazza San Giovanni, scortati da un cordone
di forze dell'ordine e sorvegliati dall'alto da un elicottero. In testa al
corteo davanti allo striscione, l'ex parlamentare di Rifondazione comunista
Vladimir Luxuria, preceduta da un gruppetto di partecipanti che intonava il
pacifico coro «Renzi merda». Ma a metà del percorso, il tema della
manifestazione è cambiato, abbandonando i diritti negati e facendo emergere il
vero bersaglio: il G20. «Oggi siamo qui, in piazza, insieme a tante altre
piazze, in giro per l'Italia. Oggi stiamo facendo anche un'altra cosa. Ci stiamo
riprendendo questa città, bloccata dai grandi della terra, che discutono nelle
loro stanze segrete», ha arringato nel microfono uno dei leader della protesta,
che ha proseguito il suo percorso con pugni alzati e slogan antifascisti come
«fascio stai attento, ancora fischia il vento» o contro il leader della Lega
Matteo Salvini, apostrofato con «capitano stammi lontano». Che il clima non
fosse dei migliori era chiaro già dalle ore precedenti, quando su Twitter
circolavano commenti come quello (poi rimosso) in risposta a un post del
senatore leghista Simone Pillon: «Pillon muori, Pillon crepa, Pillon Bastardo,
Pillon infame, sparate a Pillon, Pillon appeso a testa in giù, Pillon a piazzale
Loreto». Messaggi di pace, insomma. Quasi contemporaneamente, a Milano era in
corso una manifestazione gemella, all'Arco della Pace. Alla protesta, indetta da
Sentinelli Milano, Arcigay e Coordinamento Arcobaleno, avrebbero partecipato,
secondo gli organizzatori, 10.000 persone. Molte di più di quelle, alcune
centinaia, che hanno fatto quello che volevano nella capitale. A quanto sembra
all'insaputa delle autorità, come ormai pare abitudine a Roma. Un eccellente
viatico per il G20.
Mattia Feltri per "la Stampa"
il 28 ottobre 2021. Sono una brutta persona, lo so, ma lo spettacolo tardo
pomeridiano di destra contro sinistra - dopo la tumulazione del ddl Zan contro
l'omofobia - mi pare lo spettacolo del trionfo globale, delle bandierine che
sono state piantate dove dovevano essere piantate per segnalare a vista d'occhio
la distanza dal maledetto avversario. Sono una brutta persona e al primo sì, al
secondo pure, ma al terzo, al quarto e al quinto che ha scritto della
possibilità rimasta intatta di picchiare, aggredire o insultare gli omosessuali
- e parlo di parlamentari, giornalisti e intellettualità varia - non mi posso
trattenere. No, picchiare, aggredire e insultare è vietato, pure senza ddl Zan e
indipendentemente dalle inclinazioni sessuali del picchiato o dell'aggredito. Se
il picchiato o l'aggredito è tale proprio a causa delle sue inclinazioni
sessuali, la punizione è già adesso, pure senza ddl Zan, più severa (mai sentito
parlare dei futili e abietti motivi?). Si voleva soltanto introdurre punizioni
ancora più severe delle punizioni già più severe: potrà piacere, ma è tutto un
altro discorso. Però il punto è un altro: sono una brutta persona e proprio non
capisco questa ambizione di vietare l'odio per legge (odiare non è un diritto,
dicevano gli striscioni). Sarebbe come vietare per legge l'invidia o la viltà,
cioè la natura umana. E infatti vorrei dire a chi ieri - anche lì, parlamentari,
giornalisti e intellettualità varia - ha definito vigliacchi, miserabili,
incivili, ignobili, orribili, retrogradi e vomitevoli gli avversari del ddl Zan,
ecco, vorrei dirgli di tenerselo stretto il diritto all'odio.
Dal “Giornale” il 28 ottobre
2021. L'omofobia è un'azione spregevole, specie se tracima nell'odio, verbale e
fisico. Ma il ddl Zan saltato ieri per l'azzardo parlamentare di Enrico Letta si
proponeva di colmare un vuoto legislativo. Niente di più falso. Già oggi gli
insulti al mondo Lgbtq+ vengono puniti e sanzionati. Ieri il Garante delle
Comunicazioni comunicava la multa da 125mila euro a Radio 105 per lo show Lo Zoo
di 105, accusato di aver usato nel corso della trasmissione «espressioni volgari
e denigratorie rivolte in particolar modo contro donne e omosessuali» in almeno
due puntate (e nonostante una diffida) andate in onda alla fine del 2020.
Insulti di matrice omofoba - dice il Garante - pronunciate «in maniera
continuativa e morbosa» assieme a «allusioni sessuali e messaggi di
intolleranza». A nulla è valsa la difesa di Radio 105 («erano solo battute»)
perché secondo il Garante l'umorismo sarebbe «un'aggravante che contribuisce a
creare accettazione e consenso sociale intorno al linguaggio d'odio». Va bene
non scherzare sull'omofobia. Ma a ddl Zan vigente per gli ironici conduttori
sarebbe scattata una denuncia penale.
Da corriere.it il 28 ottobre
2021. Ogni giorno, un milione di persone non si perde le due ore con Marco
Mazzoli e il suo “Zoo di 105”. Il programma radiofonico — oltre ad essere il più
seguito — è anche quello con il risaputo record di parolacce pronunciate: un
linguaggio irriverente che è anche il tratto distintivo della trasmissione che
ha debuttato nel 1999. Ma tra i fan dello show non c’è l’Agcom: l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni ha messo infatti sotto la lente d’ingrandimento
in particolare due puntate della trasmissione, quella del 26 ottobre e dell’11
dicembre 2020, riscontrando violazioni «di elevata entità» alle regole del Testo
unico della radiotelevisione, oltre a 247 parolacce in quattro ore on air.
La sanzione
Per questo, la società a cui
fa capo Radio 105 dovrà pagare una sanzione di 125mila euro quale risarcimento
per quelle frasi che «risultano idonee a nuocere allo sviluppo fisico, psichico
o morale dei minori e a turbare, pregiudicare, danneggiare i delicati complessi
processi di apprendimento dell’esperienza e di discernimento tra valori diversi
o opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione delle loro
personalità».
La replica
L’accusa non è rimasta nel
vuoto. Dalla radio hanno fatto sapere che lo show è solo «un esempio non isolato
di comicità grossolana imperniata sull’uso iperbolico di espressioni grezze,
capaci di suscitare il riso». Niente di nuovo, insomma, secondo il network. Ma
questa tesi non ha convinto l’Agcom: «L’accettazione di tale tesi, assolutamente
soggettiva, giustificherebbe in ogni caso la diffusione di parolacce,
turpiloquio, offese alla dignità della persona, messaggi di intolleranza e
lessico omofobico». Non è la prima volta che la trasmissione attraversa dei
guai: nel 2010 era già stata sospesa e multata, sempre per la troppa volgarità e
le parolacce in diretta. Allora la decisione era stata presa dal Garante
dell’Editoria e Mazzoli aveva replicato così: «Sono tra lo sconvolto e
l’incredulo. Ci hanno sospeso e multato perché diciamo parolacce? Sono dieci
anni che le diciamo e il Garante se ne accorge solo adesso? Non è lo Zoo che
insegna le volgarità alla gente, ma è semplicemente lo specchio della nostra
società. Lo Zoo parla come il popolo, pensa e dice quello che il cittadino
vorrebbe gridare in faccia a chi ci governa».
Marco Tarquinio per “Avvenire”
il 28 ottobre 2021. Il cosiddetto ddl Zan va in archivio. E non è un bel giorno
per la società italiana. Un ambizioso ma brutto disegno di legge nato per
contrastare in modo specifico omofobia e transfobia (e che ostinatamente non si
è voluto ben calibrare se non per renderlo ancora meno centrato sull'obiettivo
dichiarato) è stato fermato. E «il modo ancor m' offende». Non certo per il
libero voto dei senatori della Repubblica, bensì per l'insensata prova di forza
che ha prodotto quest' esito deludente e per il solito coro zeppo di luoghi
comuni che, con qualche felice eccezione, dalle opposte sponde si è subito
levato. «Genderofili» (perdenti) contro «omofobi» (vincenti), in una sorta di
bipartitismo caricaturale e insopportabile. Ma l'Italia, grazie a Dio e alla
civiltà di tantissimi suoi cittadini e cittadine, non è una terra di odiatori e
menatori seriali e neanche di ideologi dell'indifferenza (umana, morale e
sessuale). È perciò politicamente e civilmente assurdo e autolesionista forzare
per incasellarci tutti in questa scatola di ferro spaccata a metà. Così si
semina vento e si raccoglie tempesta, aggravando fenomeni reali ed esaltando gli
esaltati. Che pure ci sono. Sì, ci sono quelli che insultano e vessano le
persone omosessuali e transessuali, così come ci sono quelli che pretendono, nel
nome dell'«infinita possibilità», di negare la realtà della differenza sessuale,
di maternità e paternità e persino la libertà di affermarle. Ecco perché argini
espliciti a tutto ciò - alla violenza verbale e fisica sulle persone e a ogni
illiberale rimozione e intimidazione antropologica - vanno posti o mantenuti. E
bisogna farlo in modo semplice e chiaro. Come anche la Chiesa italiana ha
raccomandato, per voce dei suoi vescovi, con buona pace dei, variamente
distribuiti, seminatori di slogan a buon mercato e di pessimo contenuto. Il ddl
Zan era e resta sbagliato, e su queste pagine l'abbiamo scritto e documentato a
fondo, dando spazio a tante voci, trasversali agli schieramenti eppure
silenziate o stravolte dalle pretese caricaturali di cui sopra. Quella proposta
“idolatrata” da persuasori e influencer decisi a darla già per approvata in
forza di un plebiscitarismo digitale e mediatico da far accapponare la pelle,
era fuori centro in più punti sul piano concettuale, dell'architettura giuridica
e delle sue conseguenze. Non lo si è voluto ammettere e ora si raccolgono i
frutti della presunzione. Ma meglio nessuna legge di una cattiva legge, perché
di leggi vigenti e cattive o incattivite (come quelle sulle migrazioni e sulla
cittadinanza) ne abbiamo già troppe, e perché quando si tratta di reati e di
libertà, cioè 'dei delitti e delle pene', non si può essere approssimativi e
avventurosamente 'filosofici'. Lo strepito che si sente non è incoraggiante, ma
speriamo che di questo fallimento si sappia far tesoro.
Paolo Bracalini per "il
Giornale" il 28 ottobre 2021. Due anni esatti. Il viaggio parlamentare del ddl
Zan ha impiegato ben due anni, impegnando commissioni parlamentari, aule,
capigruppo, e monopolizzando in diversi frangenti il dibattito pubblico, tutto
questo nel mezzo di una pandemia che ha sconvolto l'Italia con emergenze molto
più gravi. Era appunto il 24 ottobre 2019 quando il parlamentare Pd che dà nome
alla legge, Alessandro Zan, annunciava la buona novella: «Questa mattina è
ufficialmente iniziato l'iter di approvazione della legge contro
l'omotransfobia», una vera urgenza perché «la situazione nel Paese è
estremamente critica, con una vera e propria escalation delle violenze e dei
crimini d'odio» contro gay e trans. Ma è ancora da prima che ci aveva provato,
già nel maggio 2018 (quindi siamo a più di tre anni), presentando alla Camera un
disegno di legge con gli stessi contenuti, sempre a prima firma Zan, «rimasto
però totalmente inascoltato e minimamente recepito dalla precedente maggioranza»
segnata dall'«oscurantismo della Lega». Con il Conte bis, e quindi l'arrivo al
governo del Pd insieme al M5s, la questione dell'omotransfobia è diventata un
leitmotiv costante, anche con la maggioranza Draghi. Due anni di dibattiti
estenuanti, tira e molla, tattiche parlamentari come le piogge di emendamenti
per stopparla, vertici di maggioranza, negoziazioni e compromessi dietro le
quinte, il tutto accompagnato da sterminate discussioni nei talk show e furbate
mediatiche alla Fedez. Non sarà la principale urgenza del paese, ma è stato
certo l'argomento che ha catalizzato più polemiche e assorbito tempo in
Parlamento e fuori. Con picchi intermittenti, a seconda della convenienza
politica di metterlo al centro dell'agenda oppure no. Ad esempio, dopo aver
imperversato per settimane fino a sembrare la nuova bandiera della sinistra e a
forzare il calendario parlamentare per portarlo al Senato prima dell'estate, il
ddl Zan si è poi inabissato con l'avvicinarsi della campagna elettorale per le
amministrative. Un tema troppo scivoloso per la sinistra e per il M5s, meglio
nasconderlo sotto il tappeto per un po', rinviando la calendarizzazione a dopo
le elezioni. Salvo poi appunto tirarlo fuori a urne chiuse. Una tempistica ben
spiegata da Monica Cirinnà, la piddina con i cani facoltosi, grande sponsor
della legge: «Ora è il momento di decidere, i risultati delle elezioni
amministrative dimostrano che è forte nel Paese la domanda di eguaglianza e
giustizia». Ma la manovra è andata male. Torneranno alla carica? È sicuro, con
un'altra legge dallo stesso contenuto e magari lo stesso nome, ormai un brand.
Nel frattempo si è buttato al vento molto tempo. Nel dossier della Camera sul
ddl sono riportate tutte le date in cui è stato discusso in commissione
Giustizia, e poi in aula. Un elenco lunghissimo. Sterminato poi è il numero
degli emendamenti proposti dai singoli parlamentari e dai partiti, come
sterminata è la mole di articoli e programmi tv dedicati al fondamentale testo
di Zan. Per poi finire nel nulla. Un risultato che secondo il leader della Lega
Matteo Salvini va addebitato al Pd: «Letta non ha voluto ascoltare il Papa, le
associazioni, le famiglie, le parrocchie. Ha voluto dare una prova di forza.
Risultato: mesi e mesi persi».
Dagoreport il 28 ottobre 2021.
Il naufragio del Ddl Zan, per quanto la contropropaganda del Nazarano provi a
scaricarne la colpa ai renziani, ha un unico responsabile: Enrico Letta. La sua
arroganza intellettuale lo ha accecato impedendogli di fare l'unica cosa utile
in politica: trattare. Invece di perdere anni a Parigi a discettare di alta
politica a Sciences Po, Enrichetto avrebbe potuto impiegare il tempo in maniera
più redditizia facendo ripetizioni di "vera" politica dallo zio, Gianni Letta.
Colpevole in solido con Enrichetto, la sua segreteria politica. Invece di
spingere il pennellone pisano a un bagno di realismo e umiltà, cioè trattare con
l'odiato Renzi per portare a casa il risultato, ha soffiato sulla sicumera del
segretario del Pd. Tutti conoscevano i rischia di un atteggiamento
intransigente. Era chiaro che il Ddl Zan sarebbe andato a sbattere contro
l'opposizione della maggioranza del Senato: i segnali erano arrivati (anche dal
Vaticano). Ignorarli è stato un gesto da fessi o da arroganti. Soprattutto se
non si hanno i numeri per decidere in autonomia: o si dialoga o si affonda.
D'altronde la hybris survoltata di Letta è stata punita da quella che, sulla
carta, è la sua area politica: renziani, franchi tiratori del Pd e qualche
alleato cinquestelle (a dimostrazione che Conte non conta, visto che non
controlla i gruppi parlamentari. Anzi, ormai c'è una mezza ribellione in atto).
Risultato: sono mancati almeno 16 voti. Ma c'è chi ne ha conteggiati 23 o
addirittura 40. Un disastro. Sbagliano i quotidiani che già si agitano
collegando le spaccature sul Ddl Zan come prova generale per l'elezione del
nuovo Capo dello Stato. E' un link improprio, quasi una minchiata. In questo
caso il Senato doveva esprimersi su un disegno di legge discutibile e divisivo.
A febbraio, per il Colle, si voterà una persona. L'importanza della votazione, e
del peso specifico nel "Sistema" ricoperto dal presidente della Repubblica, non
ammette capricci e approssimazioni. Sul capoccione di Renzi, poi, non è piovuto
solo il livore del Partito democratico per l'affossamento del Ddl Zan. Gli è
arrivato un calcione da Carlo Calenda per l'alleanza in Sicilia con Forza
Italia: "Come cavolo ti viene in mente di legarti all’Arabia Saudita e allearti
con Micciché. Non comprendi il rischio di distruggere anche la Legacy di una
stagione di cambiamento?". Evidentemente Calenda sa che si scrive Micciché e si
legge Dell'Utri…In tutto questo marasma, assiso sul suo trono di
imperturbabilità, Mario Draghi se ne sbatte. Di queste e altre minuzie non
sembra affatto curarsi…
Dall'account twitter di Carlo
Calenda: sei stato uno dei PDC più riformisti della storia di questo paese.
Dalle Unioni civili a Industria 4.0 abbiamo fatto cose che nessun governo era
riuscito a fare prima. Ti ho visto difendere la democrazia e diritti delle
minoranze davanti a Putin in Russia. Prendendo più applausi di lui. Hai
combattuto per una riforma sacrosanta della Costituzione. Ma come cavolo ti
viene in mente di legarti all’Arabia Saudita e allearti con Micciché. Non
comprendi il rischio di distruggere anche la Legacy di una stagione di
cambiamento? Dovremmo lavorare insieme e costruire un grande polo riformista. Ma
come possiamo farlo credibilmente se continui così! Fermati un secondo a
riflettere. Te lo chiedo pubblicamente dopo averlo fatto tante volte
privatamente. Fermati.
Gabriele Barberis per "il
Giornale" il 29 ottobre 2021. Sono le 16,45 quando Maria Elena Boschi prende in
mano lo smartphone e scrive su Twitter: «Basta bugie». È il day after della
clamorosa votazione al Senato che ha cancellato la legge sull'omofobia. La
capogruppo alla Camera di Italia Viva è infastidita dal clima di resa dei conti
a sinistra. «Non sono arrabbiata, sono amareggiata perché la legge non è
passata» confida a fine serata. Mattinata all'assemblea dei costruttori Ance sul
Pnrr, pomeriggio a Montecitorio tra incontri con il governo per la legge-delega
sulla disabilità ed altre votazioni. È sdegnata per aver letto cose atroci sui
social: «Leoni da tastiera che minacciano di morte Renzi... Ecco questi
rappresentano la negazione dello spirito del ddl Zan. Io questo testo l'ho
firmato e l'ho votato alla Camera. Al Senato lo abbiamo sostenuto come il Pd,
non accetto toni esagerati e ingiustificati».
Onorevole Boschi, il Pd ha
aperto la caccia ai renziani dopo l'affossamento in aula del ddl Zan. Non vi
siete stancati delle continue richieste di patenti di progressismo? Il
segretario Letta ha parlato di rottura a tutto campo con Italia Viva e Forza
Italia.
«Noi abbiamo approvato la
legge sulle unioni civili, Letta ha fatto molte interviste sulla legge Zan.
Questa è la differenza. Penso che Letta dovrebbe preoccuparsi della rottura con
un pezzo del gruppo del Pd al Senato che a voto segreto ha votato contro la
legge. Più che di Iv e Forza Italia dovrebbe preoccuparsi di Pd e M5s».
Anche nel Pd è stata messa
sotto accusa la gestione di Letta di questa partita. Alla fine come vanno
ripartite le responsabilità del flop?
«Letta ha fatto la strategia e
Letta ha perso politicamente, insieme al M5s che lo ha seguito nel muro contro
muro. Lo riconoscono molti anche nel Pd e nel M5s. Purtroppo però il loro
fallimento lo paghiamo tutti, ma soprattutto lo pagano migliaia di persone che
avrebbero potuto avere delle tutele in più e ora dovranno aspettare chissà
quanto».
L'allontanamento del
proporzionale rende attuali coalizioni elettorali omogenee. Il futuro di Italia
Viva è scontato con il Pd e i grillini?
«Noi siamo impegnati a
sostenere lealmente il governo Draghi perché la priorità è mettere in sicurezza
il Paese. Il 2023 è ancora lontano. Certo, mi risulta difficile immaginare un
futuro con il M5s. Dal reddito di cittadinanza, al ponte sullo stretto di
Messina, al garantismo siamo all'opposto su tutto. Ma non capisco come il Pd
possa parlare di europeismo con chi andava a braccetto coi gilet gialli»
Quali scenari apre tra i
moderati un Pd sempre più radicale ed estremista che non pronuncia più la parola
riformismo?
«Sicuramente c'è un grande
spazio politico al centro. Moltissime persone purtroppo non sono andate a votare
alle amministrative perché non trovano una proposta convincente. Per un centro
europeista, riformista e liberale c'è' una prateria».
Renzi era in Arabia Saudita
anziché votare al Senato tra le ironie di Pd e M5s. Cosa replica a chi lo
considera spregiativamente un lobbista con un partito al 2%?
«Con il 2% abbiamo mandato a
casa Conte e portato Draghi. E ci attaccano perché tutte le volte siamo
decisivi, altro che irrilevanti. Quanto a Renzi: mercoledì era assente, si. Ma
la sua assenza non ha pesato sul risultato visto che siamo andati sotto di 23
voti. Solo che dare la colpa a Renzi ormai è lo sport nazionale. E soprattutto
l'alibi di chi ha sbagliato i conti».
La votazione sul ddl Zan ora
viene vista a sinistra come la prova generale di un'elezione al Quirinale in cui
sarà il fronte moderato ad esprimere il presidente della Repubblica. Chi darà le
carte?
«Dopo ciò che è accaduto ieri
credo che nessuno sarà così folle da lasciare che il nome di un presidente sia
bruciato dai franchi tiratori: all'elezione del presidente della Repubblica
servirà una maggioranza molto ampia».
È vero che voi renziani
puntate su Pier Ferdinando Casini al Colle?
«Stimo molto Casini ma non è
così. Noi non abbiamo un candidato al Colle fin tanto che al Colle ci sarà il
presidente Mattarella per rispetto al suo ruolo e alla sua persona. E comunque
fare i nomi ora serve solo a farli bruciare».
Rebus Draghi: capo dello Stato
o premier a oltranza?
«Draghi può fare
autorevolmente il presidente della Repubblica come sta facendo benissimo il
presidente del Consiglio. Direi però che la miglior cosa che possiamo fare per
il Paese ora è lasciarlo lavorare senza fibrillazioni. A febbraio, non oggi,
parleremo del prossimo presidente della Repubblica».
Prevede colpi di scena o si
rivoterà nel 2023?
«La legislatura deve arrivare
al 2023 come prevede la Costituzione e come serve al Paese. Certo se la
strategia parlamentare la fanno grillini e dem come l'hanno fatta ieri si
rischia la paralisi. Ma spero che la lezione di ieri sia servita a capire che in
Parlamento serve la politica, non il populismo».
Italia viva si è spesa per una
commissione d'inchiesta sulle mascherine di Arcuri durante il governo Conte.
Porterà risultati o è uno strumento di negoziato nel centrosinistra?
«Noi abbiamo chiesto, e
continueremo a farlo, in Parlamento con le nostre proposte di legge e ovunque
una commissione di inchiesta che faccia chiarezza su cosa è successo in Italia
durante la pandemia, non solo sulle mascherine. Se qualcuno è arricchito
illegalmente sulle spalle degli italiani deve pagare. Lo dobbiamo alle migliaia
di nostri connazionali morti e alle loro famiglie che meritano giustizia».
Dagospia il 29 ottobre 2021.
Da “Radio Cusano Campus”. Mario Adinolfi, presidente del Popolo della famiglia,
è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal
direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano
Campus. Sull’affossamento del Ddl Zan. “L’imboscata è stata interna al Pd,
questo ormai è assodato –ha affermato Adinolfi-. Ci sono stati segnali molto
precisi alla leadership di Enrico Letta, è un passaggio evidente, sancito dalle
lacrime della Fedeli. Non fai fuori un presidente di gruppo amato come Andrea
Marcucci pensando di non pagare poi dazio, a Enrico Letta sono stati presentati
i conti. Letta comunque è stato politicamente sconclusionato. Fissare il Pd,
mettendo come elemento centrale della propria identità la battaglia lgbt, in un
momento economico come questo, è un errore che all’interno di un partito
popolare alla fine paghi. Renzi ha fatto una sua battaglia molto chiara, ha
detto quali articoli secondo lui andavano rimossi dal ddl Zan, non è quello il
punto. Il punto è che se il PD sceglie questa come battaglia principale della
sinistra, in un momento in cui vanno in crisi il diritto al lavoro, la
condizione delle famiglie, la scuola, è normale che dentro il partito qualcuno
pensa che così non sia”.
Sulla proposta alternativa di
Salvini al Ddl zan. “La politica si fa con una scala di priorità. Partiamo da
altri priorità. Io nego che l’Italia sia un Paese omofobo, non è vero”.
Sul gender nelle scuole. “Io
non voglio che nella scuola di mia figlia di 3 anni si vada a fare la giornata
della omotransfobia spiegando cose che una bambina di 3 anni non può capire, con
un indottrinamento affidato ad una lobby che ha interessi economici e interessi
propri che io come famiglia contesto. Lo decido io quando e come affrontare
certi argomenti con mia figlia, non lo decide lo Stato. Questa cosa era
vergognosa ed è un sollievo che il Parlamento l’abbia abbattuta, quella di
mercoledì è stata una giornata di liberazione”.
(ANSA il 30 ottobre 2021) - "Rinunciare al
compromesso possibile per sognare la legge impossibile è stata una scelta
sbagliata, figlia dell'incapacità politica del Pd e dei 5S". Intervenendo sul
fallimento al Senato del ddl Zan, il leader di Iv Matteo Renzi scrive alla
Repubblica, accusando i dem di aver "preferito scrivere post indignati sui
social anziché scrivere leggi". L'ex premier osserva che è vero che ci sono
stati franchi tiratori, e Iv ha contestato la decisione di concedere il voto
segreto sul non passaggio agli articoli. "Ma al di là di tutto - aggiunge -,
resta il fatto che la legge è fallita per colpa di chi ha fatto male i conti e
ha giocato una battaglia di consenso sulla pelle di ragazze e ragazzi". E
"additare il Parlamento come il luogo dei cattivi e la piazza come il luogo dei
buoni: anche questo è populismo". "Il triste epilogo del disegno di legge Zan
divide per l'ennesima volta il campo dei progressisti in due. Da un lato i
riformisti, che vogliono le leggi anche accettando i compromessi - spiega il
leader di Iv -. Dall'altro i populisti, che piantano bandierine e inseguono gli
influencer, senza preoccuparsi del risultato finale. I primi fanno politica, gli
altri fanno propaganda. I fatti sono semplici. Il Ddl Zan era a un passo dal
traguardo. Sui media, ma anche in Aula nel dibattito del 13 luglio 2021, avevamo
chiesto di evitare lo scontro ideologico trovando un accordo sugli articoli
legati alla libertà d'opinione e all'identità generale, come richiesto da molte
forze sociali e dalle femministe di sinistra". "Non è un caso che l'unica legge
a favore della comunità omosessuale mai approvata in Italia sia stata quella
delle unioni civili, figlia del compromesso e della scelta di mettere la fiducia
fatta dall'allora governo. Fino ad allora e dopo di allora la sinistra preferiva
e anche oggi preferisce riempire le piazze, fare i cortei, cullarsi nella
convinzione etica di rappresentare i buoni, il popolo, contro i cattivi, il
Parlamento. Additare il Parlamento come il luogo dei cattivi e la piazza come il
luogo dei buoni: anche questo è populismo". Secondo Renzi, in Italia il
centrosinistra "dovrà scegliere se inseguire le parole d'ordine populiste, come
la vicenda Zan sembra suggerire o tornare al riformismo".
Quell’odio cordiale tra
Letta e Renzi.
Ora che Iv è accusata di aver affossato il ddl Zan, il segretario
può vendicarsi del torto subito 7 anni fa. Francesco Damato su Il Dubbio il 30
ottobre 2021. Che Enrico Letta, tornato da Parigi dove si era ritirato a causa
di Matteo Renzi, non avesse dimenticato per niente il torto subito sette anni
prima col sostanziale licenziamento da presidente del Consiglio e avesse ben
poca voglia di riannodare da segretario del Pd i rapporti con lui, si era capito
subito. E se ne era avuta la prova dal calendario degli incontri obbligati del
successore di Nicola Zingaretti al Nazareno con gli interlocutori della
maggioranza di governo. Renzi era finito all’ultimo posto: proprio l’ultimo, ben
dopo Giuseppe Conte fresco di mezza designazione verbale, o intimistica, a
presidente del MoVimento 5 Stelle, e ancora orgoglioso della qualifica di “punto
di riferimento dei progressisti” conferitagli dal predecessore di Enrico Letta,
cioè Nicola Zingaretti, quando il professore e avvocato pugliese sembrava ben
saldo a Palazzo Chigi. Pareva addirittura in grado di sottrarsi alle minacce di
crisi da parte di Renzi – sempre lui – tessendo la tela di un suo terzo governo
in tre anni. Per fortuna, d’altronde, lo stesso Renzi aveva dato ad Enrico Letta
ragioni e occasioni di un rapporto a distanza lasciando il Pd, nella tarda
estate del 2019, ben prima quindi che Nicola Zingaretti si stufasse della sua
esperienza al Nazareno e addirittura ne fuggisse via denunciando il clima
avvelenato che vi si respirava. Renzi si era messo in proprio con un partito
piccolo ma numericamente decisivo in Senato per tenere in piedi, o appeso, il
secondo governo Conte. Un partito piccolo, dicevo, ma quasi dichiaratamente
corsaro, trattenuto a stento, o costretto a rallentare le sue incursioni, quando
la sopraggiunta pandemia in qualche modo aveva avvolto l’allora presidente del
Consiglio in un involucro di emergenza, straordinarietà e quant’altro. Ma
figuriamoci se Renzi, con quel temperamento che ha, poteva trattenersi più di
tanto. Proprio la pandemia, con l’obiettiva e crescente difficoltà di gestirla,
gli avrebbe poi dato motivi e occasioni per disarcionare Conte e fare arrivare a
Palazzo Chigi un fuoriclasse come Mario Draghi: tanto fuoriclasse che Enrico
Letta lo vorrebbe a quel posto “almeno” fino alla conclusione ordinaria della
legislatura, nel 2023. Ciò significa anche dopo, se le circostanze potranno
permetterlo, visto che il piano della ripresa varato con i finanziamenti
miliardari dell’Unione Europea, e condizionato ad un percorso di riforme, dovrà
arrivare alla scadenza del 2026. Costretto dagli umori, a dir poco, dei gruppi
parlamentari, di cui è riuscito a cambiare i presidenti ma non certo la
composizione, rimasta quella derivata dalle candidature volute nel 2018
dall’allora segretario del partito Renzi, sempre lui, Enrico Letta ha
dichiaratamente lavorato sino all’altro ieri, diciamo così, per la costruzione
di un centrosinistra “largo”, tradotto da qualcuno in una nuova edizione
dell’Ulivo, esteso da Renzi a Bersani, un altro ex segretario del Pd andatosene
dal Nazareno. E vi ha lavorato ignorando, o facendo finta di ignorare, la
preclusione a Renzi, e anche a Carlo Calenda, dichiarata da Conte. Che non è più
quello immaginato da Nicola Zingaretti alla testa di uno schieramento
progressista, è formalmente alla guida di un movimento malmesso elettoralmente e
in crisi ormai cronica di identità, ma rimane pur sempre la seconda forza della
coalizione coltivata dal segretario del Pd. Forse già rassegnato in cuor suo a
sorbirsi Renzi, oltre a Calenda, perché consapevole di avere in fondo un potere
contrattuale inferiore a quello sbandierato in pubblico, e cui in fondo non
credono molto neppure molti grillini, Conte si è visto quasi sorpassare
nell’antirenzismo da Enrico Letta dopo l’infortunio del segretario del Pd al
Senato nello scontro col centrodestra sul disegno di legge del piddino
Alessandro Zan contro l’omotransfobia, già approvato dalla Camera. Con Renzi mai
più, ha praticamente gridato e giurato Enrico Letta attribuendogli, dietro la
cortina di una corsa in Arabia Saudita solitamente ben retribuita, la regia
dello stop imposto al provvedimento a scrutinio segreto. E di chissà quali altri
giochi, a cominciare dalla sempre più vicina e ingarbugliata partita del
Quirinale. Renzi, dal canto suo, non si è lasciato scappare l’occasione per fare
a Letta, stavolta in pubblico, un mezzo processo politico come quello del 2013
parlando al telefono col generale della Guardia di Finanza Michele Adinolfi, che
non sapeva di essere intercettato per un’indagine. In quell’occasione Renzi
disse di Letta presidente del Consiglio che non era adatto a stare al suo posto,
dove infatti lui lo avrebbe di lì a poco sostituito: magari, sarebbe stato più
indicato per il Quirinale, aggiunse sapendo bene che vi sedeva allora del tutto
tranquillo Giorgio Napolitano, confermato da alcuni mesi soltanto, e che Letta
non aveva neppure l’età per aspirarvi a breve, avendo ancora 47 anni, contro i
50 richiesti dalla Costituzione. Alto e forte, tuttavia, si è levato dal Pd il
monito di un uomo non sospettabile di collusione con Renzi: l’ex capogruppo al
Senato Luigi Zanda. Secondo il quale «non è dall’esito di uno scrutinio segreto
certamente grave sul ddl Zan che il Pd deve elaborare la sua politica delle
alleanze». Non è così che deve essere definito «il perimetro del
centrosinistra», anche perché ci si «dovrebbe rassegnare a restare in minoranza
nell’aula del Senato da qui fino alla fine della legislatura». A meno che Enrico
Letta non stia maturando sotto sotto un progetto di elezioni anticipate. Ma
questo Zanda non lo ha sospettato, o, almeno, non lo ha detto.
Che te lo Dico a fare?
Letta, Zan e l’eterno ritorno della sinistra degli stereotipi.
Francesco Cundari su
L'Inkiesta l'1 Novembre 2021. Sulla legge contro l’omotransfobia, il Pd è
tornato a fare quello che ha fatto per un decennio con Dico, Pacs e Cus senza
ottenere nulla. E ora vuole trasformare Renzi nella nuova Binetti per aver
proposto di trattare (come lo stesso Letta e ieri sera anche Prodi). Sul ddl Zan
e su come siamo arrivati a questo punto, ovviamente, tutte le opinioni sono
legittime. Personalmente, disapprovo sia la scelta compiuta da Matteo Renzi di
andarsene in Arabia Saudita invece che a votare in Senato, sia la scelta
compiuta da Enrico Letta di lanciare una fatwa contro Italia viva invece di una
seria analisi della sconfitta. Comunque la pensiate, però, c’è qualcosa che
dovrebbe preoccuparvi, specialmente se siete elettori del centrosinistra
(parlandone da vivo), nella piega che ha preso tutto il delirante dopopartita. A
partire da una certa sensazione di déjà vu. Il Partito democratico sembra
infatti fermamente intenzionato a fare con la legge contro l’omotransfobia
quello che ha fatto per oltre un decennio con Pacs, Dico e Cus. E cioè
assolutamente nulla, dal punto di vista legislativo, ma un nulla gravido di
scontri tanto esasperati quanto inconcludenti, su cui gruppuscoli, partitini e
leaderini hanno costruito fortune, a spese della coalizione, dei governi di
centrosinistra e dello stesso Partito democratico, la cui gestazione fu
enormemente complicata proprio da questa dinamica autodistruttiva. A leggere i
giornali – per non parlare dei social, che vent’anni fa per fortuna non c’erano
– sembra infatti di essere tornati al tempo dei girotondi e alle stucchevoli
discussioni sull’identità della sinistra, generalmente riassumibili nel
concetto: essere davvero di sinistra significa gridare molto forte quanto ti fa
schifo la destra, non scendere a compromessi con la destra, non parlarci
nemmeno, con la destra (lasciando inevasa la domanda su cosa la sinistra ci stia
a fare, a quel punto, dentro un’istituzione chiamata non per caso «Parlamento»).
Sembra di essere tornati ai tempi in cui fior di intellettuali sostenevano che
essere di sinistra significava definire il governo di Silvio Berlusconi un
“regime”, paragonandolo esplicitamente al fascismo. E senza più neanche un
Antonio Pennacchi a replicare, come fece in un’indimenticabile assemblea del
2002, che «quello [Berlusconi, ndr] aveva un’idea del Paese e noi non ce
l’abbiamo», perché noi «sappiamo fa’ solo battaglie de stereotipi».
Evidentemente è proprio così. Sappiamo combattere – noi di sinistra – solo a
colpi di stereotipi. E quando ci viene a mancare il problema su cui allestire la
parodia di una guerra civile a colpi di contrapposti luoghi comuni, magari
perché a qualcun altro viene in mente di risolverlo, il problema, occorre
trovarne un altro. Il giorno dopo l’approvazione della legge sulle unioni
civili, chi ha più sentito parlare di Paola Binetti? In un battibaleno erano
scomparsi tanto i bersaglieri pronti a una nuova breccia di Porta Pia, quanto le
armate clerico-fasciste decise a riportarci nel medioevo. Ed ecco che, dopo
essere andati a sbattere in Senato sulla legge Zan, per uscire dall’imbarazzo, i
dirigenti del Pd sembrano avere deciso di trasformare Renzi nella nuova Binetti,
facendo delle inconfessabili manovre renziane il luogo comune espiatorio su cui
scaricare tutte le responsabilità, allo scopo di alimentare una mobilitazione
che altrimenti non saprebbero come motivare. Si può non condividere la posizione
di Italia viva sulla legge Zan (io l’ho criticata qui già a luglio) e trovare al
tempo stesso surreale la campagna scatenata dal Partito democratico contro gli
esponenti di Italia viva. Campagna particolarmente surreale, in primo luogo,
perché fondata sull’accusa – ovviamente indimostrabile – di avere votato in
segreto diversamente da come pubblicamente dichiarato. E in secondo luogo perché
l’indizio decisivo sarebbe il fatto di avere invitato a trattare con il
centrodestra, che è quanto Letta aveva proposto di fare, con una svolta radicale
e inattesa, proprio alla vigilia del voto. Nulla però è stato surreale come
sentire Romano Prodi spiegare ieri sera in tv che sarebbe stato semplicissimo
fare due o tre piccole modifiche («quelle di cui si discuteva») per approvare la
legge Zan, e che dunque se si è andati allo scontro è perché «si è voluto
l’incidente». Salvo precisare subito che l’apertura di Letta, alla vigilia del
voto, non era stata affatto tardiva, perché se si vuole l’accordo si trova anche
all’ultimo minuto. Dunque, di chi è la colpa: di chi voleva trattare o di chi
non voleva farlo? Di chi voleva snaturare la legge o di chi l’ha
strumentalizzata per andare allo scontro? E chi era che voleva trattare: Letta o
Renzi? Non ha nessuna importanza. Nelle «battaglie di stereotipi» contano solo
gli stereotipi.
La contesa destra-sinistra.
Noi “liberali” contro il ddl Zan: era repressivo.
Tiziana Maiolo su Il
Riformista il 31 Ottobre 2021. È mancata la voce dei liberali. Forse manca
addirittura un Partito Liberale, in Italia. Non perché non ci siano state voci
critiche nei confronti del disegno di legge Zan sull’omotransfobia tra
costituzionalisti, intellettuali, giornalisti, oltre che associazioni di
femministe. Ma perché tutti questi soggetti non hanno trovato
in Parlamento (dove pure i liberali esistono, sparsi in diversi partiti) una
rappresentanza politica sufficientemente robusta da rendere palese il fatto che
mai come in questo caso la diversità di idee non si indentifica con
destra-sinistra. E neanche con la contrapposizione laici-cattolici. Con la
proposta di legge che porta il nome di Alessandro Zan la sinistra ha mostrato la
peggiore faccia della repressione e della pretesa educativa al contempo. Una
parte della destra, con una proposta di legge alternativa, si è limitata a
ipotizzare pene più alte e più manette in cambio dell’eliminazione della parte
pedagogica della norma. Ma siamo sempre nell’ambito di un pensiero tanto diffuso
quanto storicamente fallimentare. E cioè che l’aumento delle pene produca come
conseguenza la diminuzione dei reati. Se così fosse converrebbe per paradosso
reintrodurre la pena di morte. Ma prima ancora di arrivare alla specifica norma
penale, poniamo la prima domanda, anche alle tante persone che scendono nelle
piazze, in gran parte inconsapevoli non solo del testo della proposta di legge
(di questa “distrazione” io sono certa al cento per cento) ma anche della sua
reale finalità. Il quesito è: sapete quante fattispecie di reato esistono
nel codice penale? Trentacinquemila circa. E, garantiamo, coprono e prevedono e
sanzionano una serie infinita di comportamenti. Troppi, sicuramente. Quando le
piazze, e in particolare i giovani, ma anche i cantanti del politicamente
corretto, e addirittura un deputato come Elio Vito, radicale di Forza
Italia, protestano perché “due ragazzi che si baciavano sono stati picchiati” e
“quindi” ci vuole la legge Zan, ci prendono in giro? Si, ci prendono in giro.
Veramente credono che il codice penale esistente non abbia gli strumenti per
intervenire sul reato di lesioni, oltre tutto aggravato da motivi ignobili e
discriminatori? Lo sanno benissimo, e sanno altrettanto bene che la norma in
discussione parla d’altro. Parla dell’odio. Il punto è proprio questo, e
qualifica indubitabilmente la proposta di legge Zan come norma liberticida.
Perché, con l’intento di offrire una protezione particolare contro le parole di
odio basate sull’orientamento sessuale, introduce un nuovo reato e una nuova
aggravante. Di cui non c’è bisogno e di cui, a detta anche di costituzionalisti
come Michele Ainis, non si sentiva la mancanza. Infatti l’articolo
414 del codice penale prevede l’istigazione a delinquere e il nostro ordinamento
all’articolo 61 ha già provveduto a introdurre un consistente aumento della pena
con l’aggravante delle motivazioni abiette o futili. Un altro costituzionalista,
ex presidente della Consulta, Cesare Mirabelli, in clima di conciliazione, aveva
proposto nei mesi scorsi di aggiungere all’articolo 61 l’aggravante di aver
agito con intenti discriminatori lesivi della dignità umana. Un compromesso
dignitoso respinto con sdegno dai puristi del tutto o niente. Quelli che
preferiscono intasare le norme con una serie di specificità: i neri, gli ebrei,
le donne, i gay, i trans, i disabili…E perché non gli anziani, i malati
psichici, gli orfani, i poveri? Forse questi soggetti non meriterebbero tutela
qualora fossero vittime di istigazione all’odio nei loro confronti? Altre
osservazioni vengono dalla cultura liberale. Chi decide il mio tasso e la
qualità del mio odio? Della sua capacità di influenzare gli altri fino al punto
di indurre qualcuno a commettere un reato? Un giudice? E con quali
specializzazioni sui sentimenti umani? L’ipotesi mi atterrisce. Siamo ancora
alla concezione filosofico-politico-giudiziaria dei Cattivi Maestri? Se la
mettiamo sul piano giudiziario potremmo ricordare che la storia processuale di
questo Paese dimostra che i Cattivi Maestri della sinistra sono stati tutti
assolti nelle aule di tribunale. Se invece restiamo sul piano pedagogico, mi si
deve spiegare che cosa c’entra la norma penale. In uno Stato laico. A meno
che Enrico Letta non dica esplicitamente di aver sposato, più o meno
hegelianamente, la filosofia politica dello Stato etico. O non si sia fatto
telebano. Ma a questo punto dovremmo entrare nel punto più delicato della norma,
quello appoggiato da una parte del mondo femminista, ma con altrettanto vigore
criticato da altre associazioni (elencate ieri sul Messaggero da Luca Ricolfi)
come Udi, Se non ora quando, Arcilesbica, oltre a 300 gruppi presenti in cento
Paesi, riuniti sotto la sigla Whrct, che rifiutano di vedere le donne trattate
come una minoranza (mi associo). Il punto è quello che qualifica l’identità di
genere come “identificazione percepita”. E pare proprio, oltre a voler
valorizzare una fluidità che nei fatti si è già a volte rivelata pericolosa, il
principio irrinunciabile dei sostenitori della proposta di legge. Qui siamo in
un vero vicolo cieco, cui sicuramente non può essere la norma penale a dare
risposte.
Tiziana Maiolo. Politica e
giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e
XIII legislatura.
Natalia Aspesi per “la
Repubblica” il 31 ottobre 2021. Commuove vedere le folle di giovani che
riempiono le piazze contro l'affossamento della legge Zan; ci si schifa nel
rivedere una parte dei parlamentari applaudire per il triste evento; si plaude
ai tanti opinionisti che ovunque hanno attaccato l'orrido risultato; poi però ci
si può anche chiedere: ma quante di queste persone progressiste e non hanno
avuto voglia di leggere per intero sia gli articoli di legge che le modifiche
che il decreto Zan voleva, vuole apportare e prima o poi apporterà? Io ci ho
provato e se non sei del ramo è una faticaccia, temo quindi che non tutti quelli
che hanno protestato, o esultato, e forse persino qualcuno che ha votato o sì o
no, possano addirittura immaginare che, senza la Zan, qualunque ragazzo o
ragazza o altro che abbia un suo orientamento sessuale non conforme alla Bibbia,
può essere impunemente randellato da chiunque ne abbia il ghiribizzo al grido di
"frocio frocio" o chissà, per i fluttuanti non mi viene in mente l'insulto
giusto trattandosi di cosa nuova non ancora metabolizzata dalla fantasia
popolare. In apparenza la Zan non chiedeva l'impossibile, cioè aggiungere
all'art. 604 bis e ter, che puniscono "chi istiga a commettere o commette atti
di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi", anche quelli sul sesso, però precisando "sul genere,
sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere", e anche, e credo non
c'entri col sesso, "la disabilità". Domanda sciocca: non bastava "sul sesso", o
"sull'orientamento sessuale", sapendo che la parola gender, di cui io con molti
altri non ho ancora capito il significato, fa imbestialire le autorità
cattoliche, i profamilia e i "ci vogliono mamma e papà"? Io me ne stavo zitta
zitta perché avendo la sfortuna di essere di sinistra sin dalla nascita temevo
che sussurrando il minimo dubbio sull'efficacia del balsamo Zan e sulla
probabilità di ottenerne l'approvazione sarei stata bollata oltre che di
Alzheimer, di fascismo, omofobia, transfobia con tutte le variabili. Variabili
di cui gli antiquati binari, e pure i gay non militanti, conoscono l'esistenza
ma non (non so come dirlo) il funzionamento pratico, cioè cosa, come, con chi?
Insomma si vorrebbe essere più informati oltre che dalle immagini dei
celeberrimi Maneskin, dalla voce di Madame, le confessioni un po' confuse di
adolescenti su Instagram, la meravigliosa serie Pose e quella illuminante che
viene dal Messico, La casa dei fiori , 33 puntate di massima, simpatica
confusione sessuale; oltre i nostri nipoti, che raccontano contenti delle
compagne bisessuali e degli amici che alle feste arrivano con la gonna. E non
solo ad Halloween. Poi ho letto su Repubblica un articolo del professor Carlo
Galli, di suprema difficile luminosa scalata, che parlando di tattica politica e
di scontro ideologico, mi ha incoraggiato ad assolvermi dando nobiltà ai miei
rustici dubbi. Sempre Repubblica , che ogni tanto ci azzecca, ha ospitato un
articolo del più odiato e forse più intelligente dei nostri attuali politici
(pardon!) Matteo Renzi, cui è stata data la responsabilità del fallimento della
legge Zan e mai nessuno che si ricordi che all'antipatico senatore quando era
premier si deve la sola legge positiva per gli omosessuali, cioè le unioni
civili. Altro sostegno l'ho trovato in Tommaso Cerno, da me votato a suo tempo,
senatore gay del Pd che non ha votato la legge, «perché scritta male e perché ne
andavano discusse modifiche che l'avrebbero fatta approvare». Io ho altri
pensieri certamente prepolitici e antichi, per esempio che sia una legge
soprattutto punitiva, e va bene, che però configura omo e trans solo come
vittime, non in grado di difendersi, e non tiene conto che se io pestassi una
non binaria direi che non sapevo che lo fosse e l'ho fatto perché aveva una
maglietta con su scritto Dior e non è colpa mia se lo è. Anche l'idea della
giornata contro l'omolesbobitransfobia è plumbea, perché non trovarne una
positiva? Quanto alla scuola in cui Zan vorrebbe fosse introdotta una cultura
del rispetto e della inclusione anche dell'orientamento sessuale (e che tra i
ragazzi dovrebbe esserci già), non so, non mi fiderei; non è che tutti gli
insegnanti in quanto tali la pensino così, non è che se gli viene in classe una
bimba che vuole diventare bimbo e ne parla continuamente, sa come comportarsi.
Del resto in questi fatti della vita i giovani oggi sono più avanti dei genitori
e dei politici e hanno le loro fonti di informazione e svago (ignorate dagli
adulti) forse pericolose, forse liberatorie. Insomma si spera che la prossima
Zan sarà più realistica, più positiva, più approvabile.
Gigi Di Fiore per “Il Mattino” il 30 ottobre 2021.
I contenuti del disegno di legge Zan bocciato dal Senato sono conosciuti dalla
maggioranza degli italiani? C'è qualche dubbio che i dettagli dei dieci articoli
del ddl sull'omofobia siano patrimonio diffuso. Lo confermano i sondaggisti e i
dati delle opinioni raccolte sin da luglio sul disegno di legge Zan, diventato
cavallo di battaglia politica dei dem, di Leu e dei 5 Stelle. Proprio come sono
stati minoranza i votanti nelle recenti elezioni amministrative, anche sul ddl
Zan è una minoranza ad averne conoscenza, almeno parziale. Spiega Antonio Noto,
direttore di Ipr marketing: «Diciamo che generalmente l'opinione pubblica prende
posizione su base emotiva sui diversi temi, senza approfondire. Sul testo Zan è
passato il racconto che sia un provvedimento che, nella totalità, difende i
diritti civili. Da qui l'idea che la sua bocciatura sia stata una lesione dei
diritti civili generali». Subito dopo la bocciatura del ddl Zan, l'Ipsos Italia
presieduto da Nando Pagnoncelli ha raccolto pareri sul tema della
«discriminazione di genere in Italia». Il 54 per cento degli intervistati ha
risposto che «esiste oggettivamente una discriminazione», mentre il 30 per cento
che sia un tema «sollevato da pochi intellettuali». Un 13 per cento era senza
opinione chiara. È emerso che un 41 per cento sul ddl Zan ha idee confuse. Dando
un parere finale sulla legge, il 49 per cento la ritiene «giusta», il 31 per
cento che è «sbagliata» e il 20 per cento non ha una sua opinione. Da qui le
conclusioni della società di Pagnoncelli: «I risultati del sondaggio
evidenziano, ancora una volta, una spaccatura nell'opinione pubblica su questo
disegno di legge, in sintonia con il concitato dibattito politico sul tema
dell'omofobia». Se solo una parte sa di cosa si parla, in questo gruppo
minoritario sono in maggioranza i favorevoli al decreto Zan. E confermava già
questo orientamento il sondaggio che a maggio ha raccolto la Swg, in cui un 57
per cento si dichiarava a favore della legge, mentre il 23 per cento era
contrario. Il 43 per cento sosteneva invece che la legge andava modificata.
Commentava, sempre a maggio, Alessandra Ghisleri, direttrice dell'Euromedia
research: «Letta ha avuto sul ddl Zan un consenso nel Paese che risulta molto
forte, più che su altre sue proposte». Dopo il voto al Senato, afferma ora
Alessandra Ghisleri: «Non abbiamo, dopo la bocciatura parlamentare, ancora dati
su come si sono modificati i consensi al provvedimento. Li stiamo raccogliendo
per valutarli». Resta l'idea che, nel merito, sul disegno di legge Zan siano
davvero in pochi a saperne a fondo, specie su quali siano gli aspetti
controversi che hanno diviso i partiti. E afferma Nicola Piepoli, presidente
dell'Istituto Piepoli: «La mia idea è che nella maggioranza del Paese non ci sia
alcuna percezione reale sul testo e sul merito delle norme. Ora sono convinto
che, dopo l'esito della votazione al Senato, non si parlerà di omofobia per
molto tempo. Arriveranno altri temi caldi, come il Recovery che monopolizzeranno
il dibattito politico e l'interesse del Paese reale». Un tema «divisivo», ma
anche a conoscenza solo di una parte del Paese. E dice ancora Antonio Noto:
«Raccontato come provvedimento di difesa dei diritti civili, ha raccolto
consensi senza l'approfondimento dei dettagli delle norme. C'è stata una
semplificazione culturale, che ha prodotto anche manifestazioni spontanee in
piazza. Su questo tema, si conferma come l'opinione pubblica abbia reazioni
emotive, sulla base di eccessive semplificazioni sui diversi temi».
Ettore Martinelli per “La Verità” il 30 ottobre
2021. Ecco, mancava proprio il ddl Zan a riempirci le giornate. Sono convinto
che non sia diventato legge solo per il gusto di procurare una nuova rottura di
scatole ai cittadini. Insomma, una meschina e ghiotta arma di distrazione di
massa a uso e disgusto del popolino. Ma l'avranno letto il testo del proverbiale
Zan? Dal vociare, parrebbe proprio di no. Fosse stato altrimenti non
assisteremmo alle reazioni scomposte seguite alla votazione. Ne conoscessero il
contenuto, non verrebbe considerato il baluardo dei diritti civili. Banalmente
perché non c'entra nulla con l'estensione di diritti, al massimo si tratta d'una
tutela ulteriore per le persone offese o umiliate nella loro identità. Una sorta
di aggravante processuale è stata trasformata, dalla politica e dall'infinito
mondo dei buontemponi, in strumento di battaglia civile e sociale. Il tutto in
nome dei diritti civili, visto che parlarne va di moda e «rende» in contatti e
talvolta persino in contanti. Gli importassero davvero codesti sacrosanti
diritti negati, alzerebbero lo sguardo. Difatti altrove si consuma
quotidianamente la lesione di diritti imprescindibili, che toccano persone in
carne e ossa. Anziché guardare la realtà in maniera giudiziosa e adoperarsi per
cambiarla si limitano a riempirsi la bocca con i «diritti civili». Eppure li
ignorano. È più comodo trascurare questi temi dove invece occorre intervenire
immediatamente. A partire dalle migliaia di lavoratori sfruttati e sottopagati,
ad esempio. Ma Fedez e compari preferiscono la spensieratezza dei colori
arcobaleno al sudore e alle lacrime dei maltrattati. Quando muoiono persone sul
posto di lavoro o quando scendono in piazza denunciando le nuove forme di
schiavitù, non se ne accorgono, la merce non è «instagrammabile». La politica,
dopo l'esito dello scrutinio segreto al Senato, non si è smentita, anzi, ha dato
il peggio di sé: «Chi per mesi ha seguito le sirene sovraniste che volevano
affossare il ddl Zan è il responsabile. È stato tradito un patto politico che
voleva far fare al Paese un passo di civiltà. Le responsabilità sono chiare»,
urla il deputato dem Alessandro Zan. Il centrosinistra si è perso per strada un
gruzzolo di voti e la colpa di chi è? Del guastafeste Matteo Renzi. «Hanno
voluto fermare il futuro», twitta Enrico Letta, «hanno voluto riportare l'Italia
indietro. Ma il Paese è da un'altra parte. E presto si vedrà». Ci vuol coraggio.
Giuseppe Conte, fedele alla linea del bla bla bla, registra: «Chi oggi gioisce
per questo sabotaggio dovrebbe rendere conto al Paese che su questi temi ha già
dimostrato di essere più avanti delle aule parlamentari». Ma di cosa sta
parlando? Non poteva mancare Andrea Orlando, che sommessamente commenta:
«Pensano di aver fatto un dispetto al Pd, hanno fatto uno sfregio all'Italia».
Ma pensano chi? I democratici e i pentastellati sono in maggioranza dal Conte
bis.
Maria Teresa Meli per
il "Corriere della Sera" il 28 ottobre 2021. Non si vede nessuno del Pd. Quando
la votazione è finita, il centrodestra ha riempito di applausi l'emiciclo di
Palazzo Madama e i senatori hanno cominciato ad abbandonare l'aula, davanti alla
buvette compare soltanto Roberta Pinotti che con lo sguardo torvo allunga il
passo lungo il corridoio lasciando vuoti tutti i taccuini dei cronisti. Non si
vede nessuno del Pd. Sono corsi tutti al Nazareno. Dopo il voto del Senato nella
sede nazionale dem si è riunito una sorta di gabinetto di guerra ed è Enrico
Letta, che ha fatto filtrare la linea decisa dal partito. Se ne prende la
responsabilità: la linea su quel provvedimento è la sua. Il segretario, non si
tira indietro e davanti ai suoi ci mette la faccia. Precisazione inevitabile,
del resto, quella di Letta, per arginare il bailamme che dietro le quinte del
Senato è scoppiato nel partito. Davanti, dopo la Pinotti, si erano viste del
resto le lacrime di Valeria Fedeli. Andrea Marcucci si era sfogato su Twitter:
«È stata una gestione fallimentare. Il partito dovrà interrogarsi a fondo su
quanto è avvenuto». E a lui aveva fatto eco Dario Stefano, presidente della
Commissione Politiche dell'Unione europea: «Sì, ci vuole una riflessione
profonda». Chi non riflette è invece Ignazio La Russa. Il presidente dei
senatori di Fratelli d'Italia non fa altro se non camminare avanti e indietro
davanti alla buvette gongolando e godendo di tutti quei microfoni che lo
inseguono, mentre il leghista Andrea Ostellari allunga le labbra stiracchiando
addirittura un sorriso. A ridere di gusto ci penserà il pomeriggio il suo
compagno di partito Simone Pillon, ineffabile con il suo cravattino nero.
Incontra Gaetano Quagliariello e lo stringe in un abbraccio: «Ci hai regalato un
sogno». L'esponente di «Cambiamo» è riuscito a portare i suoi sette voti al
mulino del centrodestra. «Non è stato facile, ci sono diversi libertini tra i
miei», dice mentre abbracciato a Pillon intona, parafrasando Massimo Ranieri:
«Perdere la Zan, quando si fa seraaa...». E Tommaso Cerno, che non ha votato,
osserva: «Era ovvio che finisse così, il Pd non ha voluto dare retta a me, unico
gay dichiarato in Senato, ed è andato avanti sulla linea "o tutto o niente" con
questo bel risultato». Ma Letta è convinto che «non vi fosse alternativa
possibile, perché il centrodestra ai più alti livelli ci aveva già fatto sapere
di non voler mediare». E ai suoi spiega: «Italia viva ci aveva promesso di
essere compatta, così non è stato». Una versione che però non convince tutti,
soprattutto i diretti interessati. Secondo Matteo Renzi i franchi tiratori «in
realtà erano 40». Il leader di Iv ribalta l'accusa su Pd e M5S: «Non solo non
conoscono la politica, ma nemmeno l'aritmetica». Già, anche il numero dei
franchi tiratori in questa giornata caotica cambia a seconda di chi parla. Per i
dem sono 16, per i giornalisti che nel pomeriggio impazziscono sui tabulati
delle votazioni sono 23 e per Renzi addirittura 40. Al Nazareno comunque la
parola d'ordine è: niente rimorsi. «Se avessimo accettato il rinvio la legge non
sarebbe andata avanti e dopo un mese avrebbero accusato noi per questo ritardo».
Letta non si pente nemmeno della linea dura di prima della pausa estiva. Gli
alleati dei Cinque Stelle sono sospettati (non dai dem, o, almeno, non
ufficialmente) di aver avuto più di un franco tiratore. Giuseppe Conte approda
al Senato e dice ai suoi parlamentari: «Dobbiamo attaccare quelli di Iv».
Qualche esponente del Pd, però, scuote la testa e ricorda: «L'ex premier non ha
mai detto una parola per difendere il ddl Zan in tutto questo periodo...».
Questo voto di ieri, però, racconta anche un'altra storia ed è un campanello
d'allarme per Letta e Conte. È Pier Luigi Bersani a indicare il punto dolente:
«Temo che sia stata una prova generale di quando si arriverà al quarto scrutinio
per il Quirinale...».
Il dibattito sul ddl zan. Cosa prevedeva
il ddl Zan: il gender, un’ideologia che cancella le differenze.
Giuliano Cazzola su Il Riformista il 29 Ottobre 2021. Il ddl
Zan è finito su di un binario morto. Mi capita quindi di essere ancora una volta
“politicamente scorretto” su di un quotidiano come Il Riformista che non censura
le opinioni. Io sono un sostenitore del bicameralismo paritario (come previsto
dalla Costituzione); per questo ho votato No nel referendum sulla legge
Renzi-Boschi come ho fatto anche nella consultazione riguardante l’amputazione
di pezzi delle due Assemblea, tanto che nella prossima legislatura non si
riuscirà non solo a formare le Commissioni (i relativi regolamenti sono ancora
in alto mare) ma neppure a trovare il quarto per la partita a scopone. Tutto ciò
premesso, devo dire grazie al Senato che anche in questa occasione ha dimostrato
maggiore saggezza della Camera. A mio avviso, il ddl Zan era (l’uso
dell’imperfetto è un auspicio) un’impostura, un maledetto imbroglio. Col
pretesto di assicurare una maggiore tutela agli omotransessuali tentava di
insinuare (articoli 1, 4 e 7) nell’ordinamento giuridico una visione ideologica,
priva di qualunque riscontro scientifico. Il sesso – che è l’unico dato reale ed
evidente – veniva relegato ad un tratto di penna all’anagrafe, ad un adempimento
burocratico che avrebbe imprigionato, surrettiziamente, il corpo alla natura
degli organi genitali. Tutto ciò passando sopra all’esistenza di differenze
(visibili e intuitive) che da miliardi di anni distinguono in tutti gli esseri
viventi il maschio dalla femmina (se esiste qualche specie ermafrodita mi scuso
per la mia ignoranza). E sono quelle differenze che consentono di procreare. Da
questo vincolo non si sfugge, nonostante tutti i surrogati e le diavolerie che
una scienza, un po’ disumana e mercificata, ha inventato per sottrarre il
concepimento alle leggi della Natura. Che cosa c’entrano i diritti civili
(spesso evocati a sproposito) con l’identità di genere? Esercitare un diritto
significa poter dare espressione libera alle proprie attitudini sessuali in un
quadro di tutele contro la violenza, la discriminazione, la repressione;
significa poter dare a queste unioni un riconoscimento giuridico con i relativi
diritti e doveri. Vi sono opinioni che sostengono l’inutilità di sezionare per
categoria i diritti di libertà, già ampiamente protetti in termini generali
dalla Costituzione. Ad individuare delle categorie specifiche, con fattispecie
di reati e di sanzioni rischia di limitare, non estendere il perimetro delle
tutele per quelle categorie che non vengono ricomprese nell’elenco. In
quell’Europa in cui si aggirava, nel XIX secolo, il fantasma del comunismo, oggi
siamo chiamati a fare i conti con una nuova visione della biologia e
dell’evoluzione, assolutamente priva di basi scientifiche. Su che cosa si basa,
infatti, il concetto di gender? I suoi sostenitori rifiutano i concetti di
dottrina e di teoria, ma come si deve definire un pensiero per cui l’identità
sessuale di un individuo non viene stabilita dalla natura e
dall’incontrovertibile dato biologico ma unicamente dalla soggettiva percezione
di ciascuno che sarà libero di assegnarsi il genere percepito, “orientando” la
propria sessualità secondo i propri istinti e le proprie mutevoli pulsioni. È il
genere – come emerge nei testi in cui si diffondono queste teorie – che
stabilisce, in ultima analisi, l’identità sessuale di un individuo. Non si è
uomini e donne perché nati con certe identità fisiche, ma lo si è solo se ci si
riconosce come tali. Non ci sono maschi e femmine ma ci sono semplicemente
esseri umani liberi di assegnarsi autonomamente il genere che percepiscono al di
là del loro sesso naturale. Le tradizionali identità di maschi e femmine
diventano così dei vecchi clichés, delle categorie mentali superate, inadatte a
rappresentare la complessità sociale moderna e per questo vanno rimosse. La
parola chiave degli ideologi del gender è “decostruire”, ossia, cancellare la
natura, tentando di smantellare, pezzo per pezzo, un pensiero considerato
obsoleto e oramai fuori tempo. Ma se l’orientamento sessuale viene difeso dalla
legge, per quale motivo la teoria dell’identità di genere
(ovvero «l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere,
anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un
percorso di transizione») deve trovare posto, in modo arbitrario e truffaldino,
nell’ordinamento giuridico alla stregua di un valore comune? Determinando così
una vistosa contraddizione: quanto viene percepito diventerebbe reale a norma di
legge, mentre ciò che è platealmente reale (il sesso) si trasformerebbe in
un’opinione, magari un po’ retrò e a rischio di essere ritenuta una
prevaricazione. Peraltro, a pensarci bene, il fatto che la combriccola del ddl
Zan abbia rifiutato – come è stato sottolineato nel dibattito – ogni mediazione
e abbia deciso di resistere fino in fondo nella difesa degli articoli
‘’ideologici’’ significa che era questo per loro l’obiettivo più importante,
alla faccia della lotta alla violenza e alle discriminazioni. La caduta del ddl
Zan deve divenire oggetto di un dibattito più ampio. Non può passare come un
colpo di mano dei reazionari bigotti, incapaci di interpretare i fenomeni
evolutivi della società. Non basta evocare, alla stregua di un pensiero unico
che non ammette né dubbi né repliche, i “nuovi” diritti civili, ignorando il
loro lato oscuro, favorito oggi dallo sviluppo di innovazioni tecniche che
aprono inedite prospettive (si pensi a tutte le possibili manipolazioni del feto
consentite dalla tecnologia prenatale che ha già provocato un effetto
eugenetico: la scomparsa dei soggetti down). Proprio la visione di queste nuove
possibilità amplia lo spazio delle aspirazioni del singolo e dei gruppi, facendo
perdere di vista il limite etico insito nel concetto stesso di libertà. È
divenuto legittimo il dubbio che siano appunto le leggi a trasformare in diritti
comportamenti, propensioni, attitudini riconducibili al massimo ad una idea di
libertà. Per dirla con Dante lo Stato è sempre più disponibile a seguire il
seguente principio: “libito fé licito in sua legge”, In una società organizzata
è vigente solo il diritto positivo come determinato dalla stessa gerarchia delle
fonti giuridiche? È questa una conclusione corretta, ma pericolosa, perché è
diritto positivo anche quello vigente in uno Stato autoritario attraverso leggi
promosse ed approvate mediante le procedura disposte dall’ordinamento e dagli
organi (ordinari o straordinari) a cui è riconosciuto quella funzione
nell’ambito degli assetti di potere esistenti, in una determinata fase storica.
Un diritto positivo, un sistema di legalità, intesa come conformità alle leggi,
esistono anche in uno Stato autoritario, in un regime dittatoriale e in base a
quel sistema viene esercitata la funzione giurisdizionale. Senza scomodare il
giusnaturalismo, nella storia del pensiero dell’umanità vi è sempre stato un
sistema di valori, che si arricchisce nel tempo, a cui si ispira il diritto
positivo, fino al punto di ritenere inique le leggi formalmente legittime che
quei valori conculcano. Poiché il diritto naturale viene prima delle leggi i
suoi principi non possono essere violati dal diritto positivo. Ciò accade non
solo quando i diritti sono conculcati da un potere autoritario che li nega, li
disconosce, li limita. Ma anche quando si abusa di essi, come in molti aspetti –
quelli più controversi – del ddl Zan. Un ultima considerazione riguarda uno dei
punti più controversi: come affrontare queste delicate problematiche con i
minori. Un conto è educarli a rispettare la diversità da sé; è un altro paio di
maniche spiegare loro che la diversità non esiste. Io non credo – come ho letto
con grande dissenso – che si nasca omosessuali o eterosessuali; ma che lo si
diventi. E che tanti di noi possono intraprendere e riconoscersi in ciascuna di
queste attitudini in conseguenza di molti fattori che intervengono nella
formazione della personalità. Per questi motivi ogni comunità familiare ha il
diritto – sancito dalla Costituzione – di educare i figli secondo la propria
coscienza e le proprie convinzioni; senza sentirsi colpevole di nulla se li si
aiuta ad avere un orientamento eterosessuale. Certo, come in tutti i rapporti
umani occorrono equilibrio, tolleranza e amore. Giuliano Cazzola
Dagospia il 29 ottobre 2021. Dal profilo Instagram
di Alberto Dandolo. Mi fa molta tenerezza questa enorme onda di indignazione del
popolo social e dei media in merito all'affossamento del Ddl Zan. Questo
innaturale urlo di vergogna e di collettivo dolore, questa patetica difesa di un
Ddl che la maggior parte di voi non ha probabilmente nemmeno letto mi inquieta.
L'unica vergogna è stata semmai nella non volontà di arrivare a una democratica
mediazione da parte di chi ci rappresenta. Nessuno la voleva in realtà sta
legge! Altrimenti si sarebbe trovato un accordo. Ciò premesso, il Ddl se fosse
passato così come era scritto sarebbe stato per alcuni versi assai pericoloso.
Mi riferisco in particolare ad una clausola dell'articolo 4 che ribadiva la
punibilità delle opinioni che integrerebbero il "concreto pericolo" che si
compiano discriminazioni o violenze. Ma decidere cos' è che incita alla violenza
e cosa no, sarebbe rimasta una prerogativa del magistrato. E questo è molto
pericoloso perché le opinioni non possono correre il rischio di essere
sottoposte ad una sorta di scrutinio giudiziario. Conferire sanzione normativa
all'identità di genere avrebbe rappresentato un vero controsenso. Soprattutto
se poi fossero stati puniti quelli che non condividono quest' ideologia. È
invece, al contrario, proprio la libertà di pensiero ed espressione a costituire
la base di tutti i diritti. Basta lasciare ogni persona libera di scegliere il
comportamento sessuale che preferisce, senza che questo debba avere a che vedere
con la sua identità sessuale. Un controsenso anche la istituzione di una
giornata sulla omotransfiobia che doveva essere celebrata nelle scuole. Ma ai
bambini non si dovrebbe semmai insegnare il rispetto dell'altro in generale, di
ogni persona, di ogni essere umano anziché insegnare il rispetto per categorie
(i disabili, gli omosessuali...)??? Alcune categorie sono protette e vanno
rispettate. E gli altri? Per fortuna il Paese reale è assai più avanti delle
leggi e dei ddl. Io se fossi in alcuni di voi mi indignerei per ben altro in
questo momento storico.
Da “la Repubblica” il 29 ottobre 2021. Caro Merlo,
molti hanno detto che il ddl Zan è imperfetto o scritto male (condivido in
parte), ma che andava votato comunque. Davvero è meglio una cattiva legge che
nessuna legge? Non si poteva fare di più? Matteo M. Mauro
Risposta di Francesco Merlo: Si doveva fare di
più. La verità spiacevole è che anche il deputato Zan è stato inadeguato.
Intanto avrebbe dovuto evitare le troppe imperfezioni, anche linguistiche, che
hanno indebolito la legge, perché se è vero, come ha detto Emma Bonino, che non
si vedono leggi perfette da tempi immemorabili, è anche vero che proprio questa
doveva essere formalmente inattaccabile. Poi, non solo in un libro, Zan si è
messo a fare allusioni sui parlamentari di destra che nascondono le tendenze
gay, così impoverendo di forza e serietà una materia di libertà e non di
peccati, di diritti e non di gossip. Con il fallimento, infine, della mediazione
che Enrico Letta gli aveva, con superficialità, affidato, Zan è diventato il
nome di una sconfitta, come Waterloo e come Caporetto.
Luca Ricolfi per “il Messaggero” il 29 ottobre
2021. Non ho idea di che cosa abbia spinto Enrico Letta e il suo partito a
rifiutare, fin da prima dell'estate, ogni compromesso sul ddl Zan. Errore di
calcolo? Voglia di inasprire lo scontro con il centro-destra? Manovre
sull'elezione del presidente della Repubblica? Chissà. Ora che la frittata è
fatta, e che l'approvazione di una legge conto l'omotransfobia è rimandata alle
calende greche, forse varrebbe la pena che il Pd esaurita la raffica di
contumelie contro la destra retrograda, razzista e omofobica si fermasse un
attimo a riflettere. Tema della riflessione: come mai i dubbi sul ddl Zan,
anziché essere esclusivi della destra, sono così diffusi anche dentro il campo
progressista? Già, perché al segretario del Pd forse è sfuggito, ma la realtà è
che le perplessità sul ddl Zan sono piuttosto diffuse in diversi settori della
sinistra. E in molti casi non sono di tipo tattico, come quelle espresse da
Renzi e dai suoi, per cui sarebbe meglio una legge imperfetta che nessuna legge.
No, ci sono movimenti, associazioni, politici, studiosi di area progressista che
sono convinti che si possa fare una legge a tutela delle minoranze migliore e
non peggiore del ddl Zan. Chi sono? Diverse associazioni femministe, tanto per
cominciare. Non solo italiane (Udi, Se non ora quando, Radfem, Arcilesbica) ma
oltre 300 gruppi in più di 100 Paesi, riuniti sotto la sigla Whrc (Women's Human
Rights Campaign). La rappresentante italiana nella Whrc è Marina Terragni, da
decenni impegnata nelle battaglie per i diritti delle donne, degli omosessuali e
dei transessuali. A queste associazioni non piace che le donne, che sono la metà
dell'umanità, siano trattate come una minoranza; ma soprattutto non piace che il
mondo femminile, con i suoi spazi e i suoi diritti, sia arbitrariamente
colonizzato da maschi che si autodefiniscono donne, come è già capitato ad
esempio in ambiti come le carceri e le competizioni sportive; per non parlare
dei dubbi sui rischi di indottrinamento (e di cambiamenti di sesso precoci) dei
minori. Poi ci sono gli studiosi, e specialmente i giuristi, che hanno
analizzato l'impianto della legge, e ne hanno individuato almeno tre criticità:
rischi per la libertà di espressione, difetto di specificità e tassatività dei
reati perseguiti con il carcere, conflitto con l'articolo 26 della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo del 1948 («I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta del genere d'istruzione da impartire ai loro figli»). Fra i
giuristi che hanno sollevato obiezioni, oltre a diversi costituzionalisti, c'è
anche Giovanni Maria Flick, ex ministro della Giustizia del primo Governo Prodi.
Ma forse il caso più interessante, e clamoroso, di disallineamento con
l'integralismo Lgbt di Letta e del Pd è quello dell'estrema sinistra, in Europa
ma anche in Italia. Forse non tutti sanno che, non da ieri, in una parte della
sinistra radicale le battaglie Lgbt, e più in generale le battaglie per i
diritti civili, sono guardate con ostilità come campagne di distrazione di
massa, che la sinistra riformista irrimediabilmente compromessa con il
capitalismo e con le logiche del mercato utilizzerebbe per spostare l'attenzione
dal vero problema, ossia l'arretramento dei diritti sociali. Su questa linea, ad
esempio, troviamo filosofi come Jean Claude Michéa e, in Italia, Diego Fusaro.
Ma anche uomini politici di sicura fede progressista, come Mario Capanna
(assolutamente contrario, perché «la legge aggiunge reati, non diritti») o il
sempre comunista Marco Rizzo, forse la voce più severa sui diritti Lgbt e sulle
celebrities che di quei diritti si servono per autopromuovere se stesse (ma, è
il caso di notare, osservazioni del medesimo tenore sono talora venute anche da
un riformista doc come Federico Rampini). E poi ci sono i (pochi) politici
progressisti fuori dal coro, che hanno il coraggio di dire la loro anche se il
partito non è d'accordo. Penso ad esempio a Paola Concia (Pd, sposata con una
donna), che nello scorso aprile sollevò varie e argomentate obiezioni, chiedendo
di modificare il testo della legge. O Valeria Fedeli (Pd), che nello scorso
maggio sollevò perplessità analoghe, pure lei convinta che le modifiche
avrebbero potuto migliorare la legge. Ma forse il caso più interessante di
posizionamento politico è quello di Stefano Fassina, ex parlamentare Pd, poi
transitato in Sinistra italiana e approdato a Leu. In una conversazione con Il
Foglio, giusto il giorno prima dell'affossamento del ddl Zan, Fassina non solo
osserva che l'articolo 4 (sui limiti alla libertà di espressione) andrebbe
eliminato per «il suo portato di arbitrio giurisdizionale», ma afferma che
«sarebbe gravissimo per il nostro stato di diritto non intervenire sull'articolo
1 (quello che definisce l'identità di genere come scelta soggettiva).
Quell'articolo, infatti, introduce «norme che si configurano come visione
antropologica - legittima ma di parte». Una visione che «non è stata
esplicitata, condivisa e discussa, e quindi non può stare nel disegno di legge e
diventare progetto educativo universale». Che dire? Forse una cosa soltanto: una
parte del mondo progressista, Letta o non Letta, continua a ragionare con la
propria testa. Ed è un bene, perché certe battaglie, come quelle sul pluralismo
e sulla libertà di espressione e di educazione, hanno più probabilità di essere
vinte se non diventano proprietà esclusiva di una sola parte politica.
Laura Cesaretti per “il Giornale” il 29 ottobre
2021. «Il ddl Zan? Altro che legge di civiltà che ci allontana da Polonia e
Ungheria: un testo tardo-medievale, già vecchio, malfatto: per questo non ho
partecipato al voto». Tommaso Cerno, «unico gay dichiarato del Senato», eletto
nelle liste Pd, non nasconde il suo dissenso dalla battaglia epocale intrapresa
dai dem, e fallita miseramente mercoledì. Racconta di aver provato per mesi,
anche con interventi pubblici, a convincere il suo partito a correggere le
principali storture, anche per evitare contraccolpi. «Ho ripetuto in tutte le
salse che quel testo aveva molti difetti, che rischiava di istituire un
grottesco e sbagliato reato di opinione, che poteva essere migliorato. Invece lo
hanno proclamato intoccabile, come se Zan fosse Mosè e il suo ddl fossero le
tavole della legge dettate dal dio dei gay». La linea massimalista ha prevalso,
anche se era chiaro che questo avrebbe creato problemi di numeri. Tommaso Cerno
dice di essere stato tagliato fuori: «Mi hanno escluso da qualsiasi tavolo sulla
questione, nonostante io sia l'unico gay dichiarato di Palazzo Madama, perché
contestavo il merito della legge e la linea dem del tutto o niente. Sono
arrivati persino a telefonare alle trasmissioni tv che mi invitavano, per
dissuaderle. Mercoledì ho chiesto di intervenire in aula e mi è stato detto che
era un dibattito solo procedurale e non serviva. Si sono comportati da omofobi,
loro che si dipingono come omofili». Prima dell'ultimo passaggio parlamentare,
racconta, «mi ha telefonato Zan dicendo ti prego, aiutami. Ma ormai c'era poco
da aiutare: il risultato era scritto, e del tutto prevedibile. Arrivati al voto,
ho comunicato che non avrei partecipato, per evitare di passare per boicottatore
a voto segreto». I franchi tiratori, sostiene, sono stati molti più di quelli
contati dal Nazareno: «Il Pd dice 16, Matteo Renzi dice 40, secondo me qualcosa
di meno. Per stare certi direi 31, visto che so chi sono i 15 del centrodestra
che hanno votato con il Pd a sostegno del ddl, e 16 più 15 fa trentuno. Ora
Enrico Letta dà tutta la colpa a Renzi, ma anche se tutti quelli di Italia viva
avessero votato col centrodestra, non hanno certo quei numeri. Molti franchi
tiratori venivano dal Pd: alcuni perché condividevano le mie critiche al testo,
altri perché molto cattolici e quindi contrari in toto». Che il voto di ieri
fosse un salto nel buio si sapeva, ma il Pd gli è corso incontro: «L'unica cosa
che gli importava non era avere una buona legge, ma avere una bandierina con il
marchio Pd. Si sono appesi al feticcio di una legge al ribasso, nata vecchia e
scritta male, hanno raccontato che avevano i voti, e il risultato si è visto. La
destra ha fatto quel che aveva annunciato, con qualche senatore che ha votato
dall'altra parte. La sinistra ha fatto la sinistra, e si è spaccata. Ora
scoprono che sull'elezione del capo dello Stato ci sarà il mercato delle vacche:
forse devono provare ad eleggere un gay». E se gli si chiede perché il Pd ha
dato retta a Zan e non a lui replica: «Mah, cosa le devo dire, siamo tutti
finocchi ma qualcuno è più finocchio degli altri».
ESTRATTO DELL’ARTICOLO DI JACOPO IACOBONI PER LA
STAMPA il 29 ottobre 2021. Non è vero che tutto il mondo LGBT abbia battezzato
il colpevole. Certo, la destra ha mostrato di nuovo il suo volto, con gli sconci
applausi in Senato. Certo, molti nella comunità LGBT sono sicuri che Italia Viva
abbia sommato i suoi voti a quella destra. Ma altri fanno ragionamenti diversi:
ci sono stati grossi problemi anche tra i cattolici del Pd, e del M5S. Cerno:
“Molti franchi tiratori venivano dai dem”. Franco Grillini rilancia:
“Presenteremo una proposta per estendere la legge Mancino, così si toglieranno
tutti gli alibi”
Il pifferaio magico.
Augusto Minzolini
il 28 Ottobre 2021 su Il Giornale. L'espressione l'aveva coniata non più di una
settimana fa proprio Enrico Letta, rivolta ai leader sovranisti che hanno
secondo lui l'abitudine di menare il can per l'aia. L'espressione l'aveva
coniata non più di una settimana fa proprio Enrico Letta, rivolta ai leader
sovranisti che hanno secondo lui l'abitudine di menare il can per l'aia, ma dopo
l'affossamentro del ddl Zan, non me ne voglia, quel nome si attaglia
perfettamente proprio al segretario del Pd: pifferaio magico. Eh sì, perché
Letta - dopo aver fatto la voce grossa per mesi, rispondendo picche ad ogni
trattativa sul testo di un provvedimento che ha diviso il Paese; e ancora, dopo
aver riaperto la porta ad una mediazione e dopo averla richiusa tentando una
prova di forza -, si è ritrovato in mano un pugno di mosche e una grande
responsabilità: ha impedito al Paese di fare un passo avanti sulla strada dei
diritti civili nel tentativo velleitario di farne due e, alla fine della storia,
è stato costretto a tornare due passi indietro. Una sconfitta politica di non
poco conto, che dimostra come Letta sia affetto della stessa sindrome di cui in
questa legislatura hanno sofferto in momenti diversi altri due «pifferai
magici»: il Matteo Salvini del Papeete e il Giuseppe Conte dell'ultima crisi di
governo. Una malattia che ha un sintomo inconfondibile, l'arroganza di
immaginare di potere tutto. Se Salvini si è contagiato per un'ubriacatura da
sondaggio mentre Conte ha risentito dell'ebrezza degli indici di popolarità, il
segretario del Pd ha perso la testa per il risultato dell'ultima tornata di
elezioni amministrative. La malaparata sul ddl Zan gli ha ricordato che la
situazione è molto più complessa e che questo Parlamento è una brutta bestia per
tutti. Non c'è nessun uomo forte, ma tante debolezze. Il voto di ieri è stato
non solo un pizzino di Matteo Renzi al leader dei democratrici, ma anche la
fotografia delle tante anime che compongono il Pd e delle mille fazioni in cui
si dividono i 5 stelle. Un segnale che non si esaurisce sul ddl Zan ma,
soprattutto, è un monito per una battaglia ben più strategica, quella che
riguarda l'elezione del nuovo inquilino del Colle. Inoltre la vicenda di ieri
evidenzia un baco nella strategia di Letta: se l'asse con il Pd rimedia simili
figuracce in un Parlamento in cui i grillini hanno il doppio dei seggi che gli
assegnano ora i sondaggi, è evidente che l'idea guida della politica di Letta,
cioè l'asse preferenziale con Conte, non va da nessuna parte. Soprattutto, il
nuovo Ulivo che è nella mente del segretario del Pd si infrange
sull'incompatibilità tra l'area centrista e quella grillina. Ora Letta può anche
infischiarsene, può continuare a suonare con il piffero la stessa musica, ma
rischia di portare il nuovo Ulivo alla disfatta sia nella battaglia per il
Quirinale, sia nelle elezioni politiche del 2023. Provocando la morte prematura
della sua creatura. Augusto Minzolini
Popolo buono, Parlamento
cattivo. Il girotondismo di Letta e il ritorno dell’antipolitica.
Mario Lavia su
L'Inkiesta.it il 29 Ottobre 2021. La logica binaria è dominante nei ragionamenti
del segretario: il Partito democratico è il bene, tutti gli altri il male.
Questo atteggiamento populista sul ddl Zan rischia di assecondare l’umore
generale di un Paese sempre più lontano dalle istituzioni. La scoppola sulla
legge Zan almeno un pregio ce l’ha: mostra plasticamente che questo è un
Parlamento vecchio («Così si leggerà tra dieci anni nei libri di storia») a
fronte di una società che è molto più avanti. Non è che sia contento, Enrico
Letta, ma insomma adesso è più chiaro dove stia il Partito democratico – con i
diritti – e dove la destra – con la Polonia e l’Ungheria – una destra a cui si
sono accodati altri, Italia viva e Forza Italia. Nella versione agrodolce di
Letta tutto è più limpido, adesso risulta evidente che si è trattato di «una
trappola ordita da tempo». L’obiezione verrebbe automatica – ci siete cascati –
ma ormai la vulgata è passata, noi buoni gli altri cattivi, il resto sono
chiacchiere da Transatlantico, roba da addetti ai lavori: il popolo è con
noi. Qual è dunque la morale della favola, secondo il leader del Pd? Qual è la
lezione di fondo, diciamo, al di là della politica stretta, cioè la
(definitiva?) rottura con Italia viva? Ascoltandolo ieri a Radio Immagina (la
web radio del Pd), dove per il segretario erano giunte tantissime richieste di
rompere con Matteo Renzi, è sembrato di cogliere due discorsi in uno. Il primo,
ovvio, è quello intriso di amarezza per come sono andate le cose, per il
tradimento di «quelli che hanno seguito Matteo Salvini e Giorgia Meloni» per
fare «giochini politici sulla pelle delle persone», cioè Renzi con cui non c’è
più fiducia e Forza Italia che ha preferito Viktor Orbán a Ursula Von der Leyen,
amarezza perché «i numeri ci sarebbero dovuti essere» ma poi qualcuno ha
disertato dietro lo scudo del voto segreto. Però poi, come dicevamo all’inizio,
c’è un’altra faccia della medaglia, come se il voto sulla Zan avesse portato un
raggio di sole a squarciare la nebbia politica e regalato agli elettori
distratti un vistoso elemento chiarificatore, chi sta di qua e chi sta di là,
secondo la logica binaria dominante nei ragionamenti del segretario: ed è un
discorso che però finisce per ammantare il Parlamento in carica di un’aura di
arretratezza culturale a forti tinte di immoralità, persino, per cui la logica
conseguenza democratica dovrebbe essere quella della richiesta di elezioni
immediate che Letta ovviamente non può avanzare e mai avanzerà finché c’è Mario
Draghi a Palazzo Chigi. Di qui il contrasto tra un oggi morto e un domani che
stenta a nascere nel quale il Pd non sembra mai azzeccare i tempi della lotta.
Ma il racconto lettiano non solo non contraddice ma rischia di assecondare
l’umore generale di un Paese sempre più lontano dalle istituzioni e dalla
politica rischiando così di tagliare l’erba su cui egli stesso cammina e di
portare legna da ardere su quel falò dell’antipolitica che può bruciare anche il
Partito democratico che non si salverebbe neppure se cavalcasse l’onda
antiparlamentare. E d’altra parte non è una posizione facile quella di sparare
contro questo Parlamento “ungherese” dove si fanno «i giochini» mentre proprio
in quello stesso Parlamento si è voluta issare la bandiera della legge Zan
malgrado tutte le risapute difficoltà, anche a rischio, come si è verificato, di
uno smacco parlamentare e dove peraltro si ha intenzione di tornare con una
nuova Zan sotto forma di legge di iniziativa popolare (ma perché non dovrebbe
essere bocciata anche quella?) e poi sullo Ius soli; e sparare su tutti mentre
si sta al governo insieme con Italia viva, Forza Italia e persino con la Lega,
con i traditori e gli oscurantisti. Enrico Letta pensa di sfuggire alle
contraddizioni dell’oggi «guardando avanti» – è una locuzione che ripete spesso
– contando cioè sull’assioma che la società sia più avanti del Parlamento
riproponendo implicitamente che esso non sia lo specchio del Paese e dunque
predisponendosi chiaramente allo scioglimento di un nodo che verrà tagliato alle
elezioni del 2023: il che è un modo psicologico per preparare la piattaforma
culturale e d’immagine della campagna elettorale del Pd, quella del nuovo contro
il vecchio, cadendo nel rischio che si annida in questo schema di contrapporre
il popolo buono alla politica cattiva, nella qual cosa sta il germe del
girotondismo dei primi anni del secolo sbracato poi nel populismo grillino degli
anni Dieci perlomeno nei suoi aspetti più a-democratici. Ed esattamente come nel
populismo scattano in queste ore nel segretario del Pd gli allarmi contro i
complotti, le trame, i giochini, i tradimenti – i buoni contro i cattivi – e dà
per scontato, nel caso specifico, che i renziani abbiano tutti e 12 votato per
la tagliola e pazienza se degli altri voti mancanti il segretario non parla, né
si pone il problema che il suo Nuovo Ulivo è già secco, tanto in ogni caso era
una trappola ma almeno ora tutti sanno che «il Pd sta dall’altra parte»: ecco,
questo tratto immacolato portiamolo a petto nudo nelle piazze, anzi, nelle Agorà
ove il popolo buono propone con un clic e sceglie con un like.
MARCO CONTI per il Messaggero
il 29 ottobre 2021.
Senatore Marcucci Perché sul
ddl Zan non si è seguito il metodo usato per portare a casa nella scorsa
legislatura le unioni civili?
«Il confronto mi sembra molto
difficile, intanto perché le Unioni Civili sono nel nostro ordinamento grazie al
fatto che il governo di Matteo Renzi, allora in carica, mise la fiducia. Questa
volta sul ddl Zan, per la sua natura istituzionale, secondo me molto
opportunamente, l'esecutivo è rimasto alla finestra».
Domenica scorsa Letta aveva
aperto alla mediazione, ma poi al tavolo Leu e M5S non si sono presentati. E
stato un errore lasciare a Zan la mediazione?
«Se il Pd rinuncia al
confronto ed al riformismo come metodo di lavoro, sceglie la politica delle
bandierine e della rigidità, rischiamo l'isolamento e l'impossibilità di
incidere in Parlamento.
Questo è ciò che è successo al
Senato sul ddl Zan. È stato un errore e dobbiamo chiedere scusa, tutta la classe
politica dovrebbe farlo piuttosto che accusarsi a vicenda, perché l'Italia
aspettava e voleva una legge contro l'odio è per la difesa dei diritti, in
particolare dei più deboli. Quando la politica non è capace di mediare, di
concretizzare, e migliorare la vita dei cittadini, fallisce sempre».
Lo scontro continua, teme
conseguenze sul governo?
«Penso e spero di no. Il
governo di Mario Draghi sta programmando con molta serietà l'uscita del Paese
dalla colossale crisi causata dal Covid. Disturbare il guidatore in questo caso
sarebbe ancora più grave del solito. Apprezzo la responsabilità e la flemma del
Presidente del Consiglio: sono ottimista, non ci saranno conseguenze».
Il voto di ieri l'altro per
qualcuno serviva per ridefinire i confini del campo largo?
«Le dico la verità, sullo Zan
gli errori partono da lontano. Il segretario Letta partecipò a un'assemblea di
gruppo dei senatori dem a maggio scorso ed annunciò in quella sede che il
disegno di legge sarebbe stato immodificabile. In quell'occasione iniziai a
pensare che si stesse tentando di issare più un vessillo propagandistico che
lavorare a una legge vera sui diritti. Non è questione di campo largo, credo che
si sia proprio sbagliato il campo di gioco. I riformisti in Parlamento
dovrebbero lavorare soprattutto su leggi che hanno la concreta possibilità di
essere poi approvate. È il passaggio fra annunciare le cose e farle davvero che
ci deve differenziare».
Letta dice che con Iv si è
rotto il rapporto di fiducia, quindi niente apertura al centro come sembrava
dopo la direzione di lunedì?
«Non cambio idea, le
responsabilità sul fallimento dello Zan vanno equamente divise tra tutti, anche
noi del Pd abbiamo sbagliato. Avvicinarsi e parlare ai riformisti significa
anche evitare che lo faccia prima la destra, sia in vista del Quirinale che
delle elezioni politiche».
Il risultato del voto di
martedì emargina il Pd dalla partita del Quirinale?
«Bersani, che ha lanciato
questo allarme ieri, ha vissuto sulla sua pelle le incertezze che si registrano
quando si sceglie un nuovo Capo dello Stato. In più, oggi, a differenza di altre
volte, arriviamo a quel voto con una maggiore frammentazione parlamentare, con
il M5S che sta attraversando una fase interna assai delicata, con altre
divisioni in altri gruppi parlamentari. In ogni caso ogni partita ha la sua
storia. E molto dipende anche da come queste si gestiscono oltre che al
contesto. Di certo non si possono commettere gli stessi errori».
Mentre il centrodestra si
ricompatta sul nome di Berlusconi come successore di Mattarella, il Pd fatica a
trovare un nome con i 5S dove si riscopre la corsa solitaria. Si tornerà ad una
legge elettorale proporzionale?
«Ogni cosa a suo tempo. Ho già
detto del mio ottimismo, alla fine sono convinto che il buon senso prevarrà e
che avremo un Capo dello Stato all'altezza della situazione. Quanto alla legge
elettorale, dopo febbraio bisognerà correre. Pensare di votare con il
Rosatellum, in presenza della riduzione di parlamentari, significherebbe
lasciare molti territori senza rappresentanza, un vero e proprio vulnus
democratico. Io spero ci siano le condizioni per un sistema proporzionale con
soglia alta di sbarramento».
Antonello Piroso per la Verità
il 29 ottobre 2021. Cari amici, vicini e lontani, della sinistra (chiunque voi
siate: nel senso che non mi è chiaro quante e quali sinistre ci siano oggi in
Italia, ma transeat), capisco vi sentiate «sinistrati», dopo l’intervenuta
«tagliola» sul ddl Zan, ma vorrei provare a sottoporvi alcuni spunti di
riflessione:
1.Vi siete impossessati dello
slogan «legge e ordine», tipicamente di destra. Norme, sempre più norme, che
dovrebbero garantire una più efficace repressione dei comportamenti criminali o
criminogeni. Per capirci, con un esempio necessariamente grossier, prendiamo
l’omicidio, articolo 575 del codice penale: «Chiunque cagiona la morte di un
uomo è punito...». Lo disciplinano anche altri articoli che aumentano la pena,
se sussistono la premeditazione o le cosiddette aggravanti (assassinio per
motivi «futili e abietti», la compresenza di «sevizie» o «crudeltà» ecc).
2 Ad un tratto, però, si è
ritenuto che tutto questo non bastasse più, e si è iniziato ad inasprire
ulteriormente le sanzioni in caso di determinate vittime. Come? O con
l’introduzione di articoli bis, ter e quater, o con leggi ad hoc. Muore, o è
vittima di brutalità o discriminazioni, un nero, un ebreo, un sionista, un
arabo, un musulmano, e, perché no, un «terrone»? Ecco la norma nuova di zecca
sul delitto compiuto per motivi di odio etnico-razziali, nazionali, religiosi.
3 Stesso format con l’omicidio
stradale (da colposo in volontario, con molti dubbi su estensione e campo di
applicazione), nonché con la legge sul cosiddetto femminicidio, un pigro mantra
come se fosse in atto uno sterminio del genere femminile da parte di maschi
desiderosi di annientarlo, e non casi - sempre troppi, terribili e dolorosi - di
donne uccise da uomini che non meritano neppure di essere definiti tali.
4 Quindi ci si è preoccupati
dei comportamenti esecrandi, vili e sadici verso omosessuali e lesbiche, cui poi
si sono aggiunti i trans, e poi i queer, gli asessuali, con la proliferazione
dell’acronimo da Lgbt a Lgbtqia+ etc, da sanzionare anch’essi con prescrizioni
app o s i te.
5 La domanda sorge spontanea:
quante e quali altre tipizzazioni delle vittime di violenza e omicidio vanno
previste? Quali categorie andranno vieppiù protette? Se i minori sono tutelati,
come la mettiamo per esempio con gli anziani? Immaginando il geriatricidio? E
perché fermarsi agli umani? Che fare con soppressione e maltrattamenti dei
nostri amici animali?
6 Manette agli evasori,
spazzacorrotti, codice degli appalti, codicilli, editti, pandette e grida
manzoniane. Massì, facciamo vedere che abbondiamo. Un aumento dei precetti
penali, però, non comporta una diminuzione dei reati. Fosse così, avrebbero
ragione i sostenitori della pena di morte. Che non è mai stato un deterrente,
mentre semmai lo è la sua abolizione. Potete verificare voi stessi sul sito
nessunotocchicaino.it: «Un rapporto ha esaminato i tassi di omicidio in 11 Paesi
che hanno abolito la pena capitale, constatando che dieci di essi hanno
registrato un calo di tale reato nel decennio successivo all’abrogazione».
7 Vogliamo stigmatizzare lo
spettacolo «indecoroso e degradante», «gli applausi e quell ’orrido tifo da
stadio» intervenuti alla proclamazione del risultato sul ddl Zan? Facciamolo
pure, ma evitando di fare i sepolcri imbiancati: sottintendere, o sostenere, che
questo dimostrerebbe la consustanziale omofobia della destra (vi do una notizia:
esistono gay pure lì) significa cercare di lanciare la palla in tribuna per
occultare la sconfitta politica incassata, a colpi di franchi tiratori (a
sinistra). Chi a destra si è lasciato andare a sgradevolezze, lo avrebbe fatto
su qualsiasi altra mozione sostenuta dalla sinistra e bocciata dopo mesi e mesi
di martellante campagna propagandistica a favore. L’incivile scompostezza dei
politici, nelle aule parlamentari o fuori, è trasversale, e non è una novità,
fin dal 1949 per l’adesione dell’Italia alla Nato: si vide un cassetto volare da
una parte all’al - tra dell’aula. Senza dimenticare le scuse tardive, vedi Luigi
Di Maio, il balcone, l’esultanza, l’abolizione della povertà: «Sbagliai il gesto
e le parole».
8 Ultimo, ma non in ordine
d’importanza. Il segretario del Pd Enrico Letta, nel commentare la debacle, è
ricorso ai toni apocalittici: «Hanno voluto fermare il futuro». Nientemeno. C’è
da chiedersi: qual è invece il futuro di lavoro, previdenza, sanità, insomma,
qual è il posto riservato a sinistra per i diritti sociali? Non è una
provocazione, e non intendo certo declassare quelli civili, contrapponendoli ai
primi. Ma è questione urticante. Lo certifica questo testo del dicembre 2017:
«La motivazione fondamentale, e ufficiale, della rottura tra il movimento di
Giuliano Pisapia e il Pd è stata la mancata tempestiva calendarizzazione in
Parlamento dello ius soli, un argomento importante, una battaglia di civiltà,
ma, rispetto alle questioni aperte, alquanto circoscritto». Circoscritto.
Continuiamo: «Anche in questo caso si conferma una singolare inversione di
priorità nelle politiche della sinistra: i diritti civili ormai prevalgono su
quelli sociali, che hanno sempre meno spazio nei programmi». Però. Andiamo
avanti: «Questo mutamento è evidente da quando a sinistra si è affermata la
linea più liberale che socialista della “terza via”: i diritti (individuali)
civili sono diventati centrali nella strategia di sinistra e di fatto la loro
rivendicazione è diventata un alibi, una sorta di copertura, rispetto al fatto
che le problematiche sociali venissero, se non abbandonate, lasciate sulla
sfondo». I diritti civili come alibi. Conclusione: «Così facendo si ponevano le
premesse per una rinnovata contrapposizione con la destra conservatrice su basi
diverse rispetto al passato e per l’acquisizione del consenso dei ceti medi
cosiddetti “riflessivi”. Ma al tempo stesso si minava alle radici il rapporto
tradizionale tra sinistra e ceti popolari».
9 Su che giornale o sito di
destra è comparsa tale critica analisi? Nessuno. :Le ritrovate sul web
all’indirizzo nens.it, Nuova economia nuova società, il centro studi fondato da
Vincenzo Visco e da Pier Luigi Bersani. Non riesco a immaginare qualcuno più a
sinistra di lui (senza offesa). ANTONELLO PIROSO
Ddl Zan, ecco chi sono
i traditori giallorossi.
Francesco Boezi il 27 Ottobre 2021 su Il Giornale. In Senato si
fanno i nomi dei parlamentari del Pd che avrebbero "tradito" Enrico Letta sul
ddl Zan. La fronda cattolica ha deciso di ascoltare il Vaticano. Qualche
defezione del Partito Democratico c'è stata eccome: questa è la spiegazione
maggioritaria tra quelle che circolano sulla votazione relativa al Ddl Zan. Tra
i corridoi del Senato, si fanno i nomi delle senatrici Valeria Fedeli, Valeria
Valente e dei senatori Stefano Collina e Dario Stefano. Ma di senatori del Pd
che hanno votato in maniera contraria a quanto indicato da Enrico Letta e
compagni ce ne sarebbero almeno altri tre. Quei 24 voti di scarto, altrimenti,
si spiegano con difficoltà. E il resto delle defezioni potrebbe essere
attribuito ai grillini. I pentastellati, del resto, non sono mai stati un coro
unanime in materia bioetica e affini. Il segretario del Partito Democratico non
ha voluto dialogare con le forze del centrodestra sul merito del disegno di
legge. Questo è avvenuto nonostante Lega e Forza Italia avessero manifestato una
ferma volontà di discutere, pur di approvare una legge in grado di contrastare
l'omofobia. Anche Italia Viva di Matteo Renzi, a dire il vero, si era detta
disponibile ad una revisione parziale del testo di Zan, con la proposta di
Scalfarotto. Il testo dal quale, l'onorevole Lella Paita, ad esempio, chiede ora
di ripartire. Il punto di caduta, tuttavia, è rimasto il profilo ideologico
della proposta. Ma pure su quell'aspetto Letta non ha voluto sentire ragione. E
oggi il Ddl Zan è affondato. Pallottoliere alla mano, è possibile dire che anche
nel partito che ha sede nel nazareno non esisteva una vera e propria unanimità
sul provvedimento. "È vero - vocifera una fonte de ilGiornale.it, tra gli
addetti ai lavori - quella di oggi è una vittoria dei cattolici del Pd". Il
Vaticano, del resto, era stato chiaro sul punto. E tanti appelli sono arrivati
ai parlamentari cattolici durante i mesi in cui è andata avanti la discussione
politica. Tra questi moniti, proprio quello proveniente dalla Congregazione per
la Dottrina della Fede pubblicata da Il Giornale in un articolo a firma di
Felice Manti. L'ex Sant'Uffizio aveva spiegato quale dovesse essere il corretto
atteggiamento che un parlamentare di fede cattolica avrebbe dovuto tenere nei
confronti del ddl Zan. Stando ai numeri che sono emersi oggi a Palazzo Madama,
verrebbe da dire che più di qualche senatore piddino, magari cattolico, ha
deciso di dare ascolto a quell'appello o comunque di procedere in senso opposto
all'ostruzionismo portato avanti da Enrico Letta e dal MoVimento 5 Stelle, che
ha chiuso a sua volta qualunque linea per il dialogo. Decisiva, per l'esito
della votazione, è stata la compattezza del centrodestra. Pochissime defezioni
tra gli scranni di Forza Italia, Lega e Fdi, che si sono espressi, loro sì,
all'unanimità. Forse uno dei due voti di astensione proviene da quelle fila, ma
niente più. Al massimo si è verificato un solo voto contrario alla "tagliola".
Poi, oltre a questo dettaglio, c'è il caso del senatore Elio Vito che, avendo
annunciato da tempo di votare con il Pd, aveva pure dichiarato che avrebbe
lasciato l'incarico in Forza Italia in caso di passaggio della "tagliola" con il
supporto del centrodestra. Per quel che riguarda il centrosinistra, qualche mal
di pancia era emerso in tempi non sospetti. L'ex ministro Valeria Fedeli, ad
esempio, aveva già dichiarato di essere quantomeno dubbiosa sulla natura del
testo, pur sottolineando che, per ragioni legate alla necessità di non dividere
il Pd, avrebbe votato comunque. Ma le cose potrebbero essere andate in maniera
diversa. Al netto dei "sospetti" ventilati su Repubblica, per quel che
riguarda Italia Viva, invece, tra i corridoi del Senato non si parla di
defezioni: dal partito fondato dall'ex premier fanno sapere di aver votato in
maniera compatta con il Pd. Qualche franco tiratore, come premesso, potrebbe
risiedere tra le fila del MoVimento 5 Stelle. Sono sedici, del resto, i voti che
mancano ai giallorossi rispetto ai conti che erano circolati.
Ddl Zan, il vero omofobo è
il Pd. IL DISEGNO DI LEGGE LIBERTICIDA È STATO AFFOSSATO PER BUONA PACE DEI
CENSORI ARCOBALENO.
Giovanni Sallusti il 27 Ottobre 2021 su NicolaPorro.it.
Sì, l’omofobia ha stroncato ancor prima di nascere il Ddl Zan, e non ci si
meravigli per la tesi. Che differisce da quella mainstream per un solo,
lievissimo dettaglio: il punto di osservazione. Chi ha ucciso politicamente
l’idea, e perché. Come ha capito quasi chiunque, ma non dice pressoché nessuno,
l’idea l’ha uccisa il Pd, con le incursioni delle squadracce arcobaleno
Zan-Cirinnà e la benedizione dell’ex democristiano Enrico Letta, ridotto a
luogocomunista politically correct. E l’hanno fatto costoro, i buoni, i civili,
i #restiamoumani, per un approccio omofobo nel senso lato e peggiore,
subdolamente discriminatorio e sostanzialmente offensivo. Una commedia
dell’ipocrisia svolta in passaggi successivi e strettamente collegati tra loro,
che val la pena di riepilogare, prima di essere sommersi dalla retorica
lacrimevole sul diritto stracciato, che peraltro era da sempre la tappa finale.
Primo: proclamarsi esclusivi
depositari della causa gay, Lgbt, dei diritti civili, della “tolleranza”
popperiana (quindi liberale, non ex o post-cattocomunista!), frullando la lunga
e molteplice storia del movimento omosessuale italiano in un santino social,
come se il pioniere libertario Angelo Pezzana fosse pari alla censora
liberticida Vladimir Luxuria, come se difesa dell’individuo e attacco del
dissenso coincidessero, e non fossero i perfetti opposti. Il tutto peraltro
soprassedendo allegramente sull’oggettiva storia omofoba di famiglia, come se il
Pd non fosse il partito erede di quel Pci che cacciò Pier Paolo Pasolini per
“indegnità morale” e come se il Che Guevara ostentato tutt’oggi in numerose
piazze sinistre non avesse allestito graziosi campi di concentramento per gay
(loro, si sa, non devono chiedere scusa mai, mentre qualunque dirigente della
destra italiana del 2021 deve ripudiare la marcia su Roma del 1922 fino al
settimo grado di parentela).
Secondo: su questa presunzione
farlocca di superiorità etica, si costruisce un disegno di legge
irragionevolmente talebano, che compromette palesemente una quisquilia
costituzionale come la libertà di pensiero (articolo 4 del Ddl Zan) e fa delle
intricatissime tematiche dell’identità di genere (su cui si è lontanissimi
dall’avere una quadra in ambito scientifico, pedagogico, psicanalitico) del
disinvolto materiale di chiacchiericcio (non vogliamo dire propaganda, non siamo
talebani all’incontrario) nelle scuole (articolo 7). Su queste premesse
oltranziste, e de facto oscurantiste, si rifiuta qualunque minimo elemento di
confronto civile e culturale, di dialettica parlamentare, di trattativa, ovvero
si deraglia scientemente dall’ambito della politica, per entrare in quello della
teologia. Laica e arcobaleno, ma pur sempre teologia: il Ddl Zan è il Bene
legislativo incarnato, o ci si inginocchia o si cade nell’apostasia. Vien da sé
che rifiutando di calare le altisonanti e non impegnative dichiarazioni di
principio nel terreno fattuale, sofferto e vincolante della politica, si fa un
torto anzitutto alla battaglia con cui formalmente ci si trastulla. I diritti o
stanno nella realtà effettuale e imperfetta della politica, o sono sermoni di
convenienza.
Terzo: si finisce per far
naufragare il disegno di legge esclusivo e imprescindibile, non si fa neanche
finta di elaborare il presunto lutto, e si passa subito all’incasso
ideologico, l’urlaccio propagandistico contro la destra barbara e retriva. È la
linea che dà subito il compagno segretario Letta su Twitter: “Hanno voluto
fermare il futuro. Hanno voluto riportare l’Italia indietro. Sì, oggi hanno
vinto loro e i loro inguacchi, al Senato. Ma il Paese è da un’altra parte. E
presto si vedrà”. Del resto, è quello che volevano da subito, e i manganellatori
fucsia meno accorti come Monica Cirinnà lo avevano già dichiarato quest’estate:
“Sì, voglio morire in battaglia insieme ai gay, ai trans, ai bambini libellula”.
È la retorica della “bella morte” nella ridotta ultra-Lgbt (che non ha convinto
molte esponenti storiche del femminismo italiano e anche molti omosessuali non
intruppati), non a caso materiale attinto dall’immaginario della Repubblica di
Salò, per dire il tasso di liberalismo e di disposizione al dialogo.
Sintesi inevitabile: per mesi
abbiamo assistito a una strumentalizzazione conclamata, selvaggia,
oggettivamente cinica e falsamente paternalista della causa omosessuale,
culminata nello psicodramma di oggi al Senato e nel prossimo tormentone sui
sovranisti che “hanno fermato il futuro”, logico sviluppo del tormentone
antifascista tornato buono sotto elezioni. Come si vede, per questa gente i gay,
le lesbiche, i transessuali e gli altri appartenenti alla galassia Lgbt
rappresentano, nel migliore dei casi, quelli che Lenin chiamava “utili idioti” a
disposizione del Partito. È fin peggio, che la mera omofobia. Giovanni Sallusti,
27 ottobre 2021
Casa Sinistra.
Massimo Gramellini
su Il Corriere della Sera il 28 ottobre 2021. L’incomunicabilità tra conviventi
non è prerogativa dei coniugi: esiste anche nella casa scombiccherata che va dai
nostalgici di Blair a quelli dell’Urss e che per abitudine e approssimazione ci
accomodiamo a chiamare ancora Sinistra. A ogni svolta più o meno decisiva,
questo connubio di individualisti che si credono altruisti va a picco tra
reciproche accuse di arroganza e una caccia ai traditori guidata quasi sempre da
un traditore. Dopo la carica dei 101 grandi elettori che impallinarono Prodi,
ormai più famosi dei cani di Crudelia, adesso tocca ai 16 (la Storia si ripete
in forme più stitiche) che hanno affondato il disegno di legge Zan contro
l’omotransfobia a causa della fobia che molti di loro provano per gli
alleati, facendo mancare i voti a un provvedimento d’aula che in gergo è
chiamato “tagliola”, forse nella presunzione che a cascarci dentro potessero
essere delle volpi e non, come invece è stato, i soliti polli. Per evitare
l’ennesima figura barbina sarebbe bastato che i variopinti inquilini della
casa facessero qualcosa non di sinistra, ma di inedito: parlarsi. Discutere,
litigare, mediare e poi uscirsene fuori con un accordo di compromesso che, non
accontentando nessuno, potesse venire condiviso da tutti. Uno sforzo
evidentemente superiore alle forze di questa congrega di “Lei non sa chi sono
Io” e di “Lei non sa che sono Dio”, specializzati nel presentarsi agli
appuntamenti con la sconfitta in ordine sparso: Renzi in Arabia e gli altri,
come sempre, su Marte.
Zan, il grande bluff del Pd. Addio al ddl
sull'omofobia. Laura Cesaretti l'8 Settembre 2021 su
Il Giornale. Altro che priorità. I democratici si oppongono alla
calendarizzazione del testo: non hanno i voti. Ricordate il ddl Zan? Ecco,
scordatevelo: ieri, con l'avallo del Pd, è stato rinviato sine die. Ed è assai
improbabile che riemerga dalle secche del Senato, se non profondamente cambiato.
Fino a un mese fa la legge contro l'omotransfobia sembrava la priorità numero
uno nell'agenda politica del Pd: «Su questo andremo avanti, punto - giurava a
luglio Enrico Letta - chi ci vuole attrarre in un pantano di negoziazioni vuole
solo far saltare una legge necessaria e urgente». Lo slogan «Ddl Zan subito»
veniva ripetuto senza tregua sui social dalla propaganda dei partiti della
sinistra, le accuse di ostruzionismo omofobico contro la destra che ne
ostacolava l'approvazione si sprecavano. Poi, con l'avallo del Pd, il ddl è
stata rinviata a dopo le vacanze, prima che l'aula di Palazzo Madama iniziasse a
votarlo. Alla ripresa dei lavori, secondo quanto avevano promesso i dem, la
legge sarebbe dovuta tornare immantinente all'attenzione del Senato: «Chiederemo
subito la calendarizzazione», avevano giurato i dirigenti parlamentari del Pd.
Ieri era finalmente l'occasione, con la prima conferenza dei capigruppo
post-vacanze, convocata per decidere il calendario con la legge
anti-omotransfobia in testa alla lista dei provvedimenti rimasti in sospeso. Ma
il Pd non solo non ne ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno, ma si è
anche detto contrario alla richiesta in tal senso fatta dal capogruppo di Iv
Davide Faraone. Risultato: di ddl Zan non si parlerà più fino a ottobre
inoltrato, dopo il secondo turno delle amministrative. «Anche Letta non vuole:
troppi provvedimenti delicati in ballo, e il clima pre-elettorale non
aiuterebbe», è stato il succo delle spiegazioni che la capogruppo Simona Bonafè
ha dato a chi tra i suoi chiedeva ragione della ritirata. In realtà, le ragioni
sono le stesse per cui il Pd volle il rinvio del ddl a dopo le vacanze: i voti
per approvarlo non ci sono. Nei Cinque Stelle e nel Pd stesso serpeggiano dubbi
e resistenze, e tutti sanno da tempo che a voto segreto il testo originario
verrebbe crivellato di colpi. E che l'unico modo per varare una legge contro le
discriminazioni è quello di trattare con l'opposizione, modificando alcuni
articoli tra i più contestati, per ottenerne il voto. Salvini si era detto
disponibile, ma il Pd ha sdegnosamente rigettato la mediazione: «Vogliono
cambiare il testo solo per rimandarlo alla Camera e scordarselo. Meglio votare
subito», era il refrain dei dem. Ora è il Pd che preferisce scordarselo, per
evitare di andare al voto amministrativo dopo una sconfitta in aula, o dopo
essersi rimangiato il «no» alle modifiche e avere aperto la trattativa con la
Lega, come li invitava da tempo a fare Matteo Renzi. Si prende tempo fino alle
elezioni, e dopo si deciderà: o il ddl Zan verrà definitivamente sepolto, col
silenzioso assenso del Pd, oppure si cercherà un accordo con la Lega per farlo
passare. Ma è una mossa che il Nazareno può permettersi solo a urne chiuse, per
non perdere la faccia con i suoi elettori. Dal centrodestra si prende di mira la
ritirata dem: «Vogliono parlarne dopo le elezioni», dice Ignazio La Russa, «ci
hanno fatto impazzire, ci hanno fatto portare il provvedimento in aula prima che
fossero conclusi i lavori della commissione per l'urgenza che avevano. Adesso se
ne parla dopo le elezioni. Strane le urgenze a doppia velocità». E proprio di
omofobia, paradossalmente, Matteo Salvini accusa il dem Zan, reduce da Mykonos
con la rivelazione di aver visto un deputato leghista baciare un uomo: «Se un
mio parlamentare bacia un uomo o una donna sono affari suoi. Denunciarlo denota
l'omofobia, l'arroganza e il razzismo che spesso stanno a sinistra». Laura
Cesaretti
SALVATORE DAMA per Libero
Quotidiano l'11 settembre 2021. Anno 1994. Esattamente martedì 22 marzo. Mancano
pochi giorni alle elezioni politiche, che si sarebbero celebrate domenica 27.
Una data a suo modo scolpita nella storia recente. Perché Silvio Berlusconi,
dando vita a una coalizione tra diversi partiti- Forza Italia, Lega Nord,
Alleanza Nazionale, Ccd -, riesce a vincere contro ogni pronostico. Sconfiggendo
quella che, non senza ironia postuma, fu ribattezzata la "gioiosa macchina da
guerra" di Achille Occhetto. Uno dei fatti nuovi della politica è Alleanza
Nazionale. Gli ex missini attirano l'interesse di vari reduci della vecchia
partitocrazia. Ma, al Nord, fanno proseliti anche tra i leghisti. Che pure sono
un movimento di avanguardia. Succede così che alcuni di loro mollano Umberto
Bossi e passano con Gianfranco Fini. Questa transumanza non piace a un giovane
studente padovano. All'epoca non c'era internet. Non c'erano i social. Pure il
popolo dei fax era ancora in fase embrionale. Per divulgare la propria opinione
c'era la posta. Si andava all'ufficio di corrispondenza con una lettera scritta
a macchina e la si spediva a un quotidiano.
APPELLO ACCORATO Il ragazzo in
questione si dichiara un elettore della Lega Nord e, infatti, non scrive
all'Unità, ma a L'Indipendente, già diretto da Vittorio Feltri, quotidiano molto
attento alle dinamiche interne del centrodestra. La lettera viene pubblicata. È
il 22 marzo 1994, come si diceva. Colonna di sinistra della pagina «Tribuna
aperta», dedicata al contributo dei lettori. Titolo: «Attenzione ai transfughi».
Firma: Alessandro Zan. Da Mestrino, Padova. Un rapido controllo anagrafico non
lascia dubbi. Al Comune di Mestrino è risultato residente un unico Zan
Alessandro, classe 1973, nato a Padova e trasferitosi a Mestrino, appunto, nel
1979, al seguito della famiglia, quando aveva sei anni. All'inizio della lettera
pubblicata da L'Indipendente il ragazzo parte con le presentazioni: «Sono uno
studente universitario». E anche questo torna. Alessandro Zan nel 1994 ha quasi
21 anni e frequenta il corso di Ingegneria delle Telecomunicazioni
all'Università di Padova. Quindi, scorrendo il testo, arriva la dichiarazione di
fede politica: «Alle ultime elezioni politiche», rivela il giovane Alessandro
Zan, «ho dato il mio voto alla Lega Nord proprio perché pensavo, e lo penso
ancora, che questo movimento politico attraverso la spinta federalista potesse
prima smuovere il vecchio sistema partitocratico e poi avviare l'Italia verso
una struttura federalista». Anche questo dato temporale coincide. Le precedenti
politiche si erano svolte nel 1992, quando l'attuale promotore della legge
contro l'omotransfobia, raggiunta la maggiore età da un anno, aveva potuto
barrare convintamente il simbolo del Carroccio.
«CON UMBERTO E MARONI» Ci
crede proprio, Zan. Il suo è un leghismo puro, genuino. Per questo se la piglia
con i «traditori» che hanno scelto An: «Concordo con Bossi e con Maroni, i
transfughi che si muovono verso An fanno solo un favore alla Lega». Poi, cosa è
successo? L'orientamento politico di Alessandro è virato da tutt' altra parte. A
sinistra. E ci sta, è lecito. È stato assessore all'ambiente a Padova, quindi è
sbarcato in Parlamento, eletto alla Camera prima con la lista di Sel (2013) poi
riconfermato con il Partito democratico (2018). Ma, soprattutto, Zan è diventato
un paladino dei diritti Lgbt, cosa che lo ha reso famoso alle cronache. È il
firmatario dell'omonimo disegno di legge contro l'omotransfobia. Ma questa è una
storia nota a tutti. Dell'infatuazione giovanile per la Lega, invece, non se ne
sapeva nulla. Interpellato da Libero, il deputato del Pd conferma di essere
l'autore di quella lettera. E precisa: «Sono cresciuto in una famiglia leghista
come peraltro racconto anche nel mio libro, quello è un voto di un ventenne
contro la partitocrazia della prima Repubblica che usciva da Tangentopoli e che
conosceva esclusivamente quella realtà socio culturale, ma che nella lettera già
rivendica con orgoglio di essere convintamente antifascista». Infatti, aggiunge
Zan, «in quella lettera di quasi trent' anni fa denuncio la virata a destra
della Lega che oggi è diventata omofoba e razzista. Poi a ventun'anni
all'università aderisco ai movimenti pacifisti e di sinistra: la mia prima
tessera di partito è stata quella dei Ds».
Gianluca Veneziani per “Libero quotidiano” il 7
settembre 2021. Ma chi lo ha detto che un gay debba necessariamente essere a
favore del ddl Zan? Lo prevede mica il nuovo codice etico imposto dal Pensiero
Unico, per cui si è veri omosessuali solo se si votano le leggi caldeggiate dal
Pd? Se fosse così, alla sigla LGBTQIA+ bisognerebbe aggiungere la lettera Z, una
delle poche che manca, a indicare la fedeltà al guru Zan come requisito di
certificata omosessualità. Viene da pensarlo leggendo le anticipazioni del libro
"Senza paura. La nostra battaglia contro l'odio" (Piemme) di Alessandro Zan, il
deputato Pd primo firmatario della cosiddetta legge contro l'omofobia.
Denunciando la presunta doppia morale di molti politici di destra, il
parlamentare dem, gay dichiarato, se la prende con «un deputato della Lega,
incontrato in vacanza a Mykonos, del quale mi ricordo cartelli particolarmente
aggressivi contro la legge Zan. Stava baciando un uomo». Sommo scandalo! Ma il
problema qual è? Che un leghista vada a Mykonos? Che un leghista baci un uomo?
Oche un gay sia contrario al ddl Zan? Esattamente quest' ultimo. Come può, è la
logica del deputato Pd, un omosessuale tradire la Nostra Causa, sostenuta dalle
associazioni arcobaleno, promossa dalla sinistra tutta, grillini compresi, e
avallata dai grandi media buonisti, alfieri del politicamente corretto? Delle
due l'una: o non è un vero gay o è un gay ipocrita. E cioè è talmente plagiato
dal salvinismo da sacrificare pubblicamente la sua identità sessuale agli
interessi superiori del partito. Questa tesi di Alessandro (Intolleran)Zan,
presa alla lettera e estesa a tutti i gay, ha risvolti inquietanti: prevede cioè
che, a prescindere, un omosessuale - di destra, di sinistra, di centro,
apolitico - non possa dissentire dal Vangelo da lui predicato e codificato in
quel testo sacro. E non possa, ad esempio, avanzare obiezioni sui rischi per la
libertà di espressione e la libertà educativa nelle scuole né sull'utilizzo
avventuroso a livello giuridico di concetti come «identità di genere» o sulle
ricadute in termini di violazioni del principio di eguaglianza, per cui alcuni
cittadini finirebbero per essere tutelati più di altri. No, se è gay,
semplicemente deve adeguarsi, stare zitto o ancor meglio tifare a favore del
ddl. Ammazza oh, alla faccia della libertà di pensare, oltreché di amare, degli
omosessuali. È un fatto tuttavia, con buona pace dello Zan Alessandro,
imperatore di tutti i rossi e gli arcobaleno, che gay dissenzienti, onesti
intellettualmente e non intruppati nel gregge monopensante ce ne sono. Anche in
Parlamento. Come quel Tommaso Cerno che, ai microfoni di Libero, aveva definito
il ddl una legge «scritta male» che fa «troppo poco per conseguire gli obiettivi
che si propone», aggiungendo: «Zan non è Mosè e non ha ricevuto le tavole della
legge dal dio dei gay». Zan tuttavia crede di essere investito di un'autorità
divina. E, in nome di quella, pretende di dividere l'umanità tra Giusti e
Reprobi, e gli omosessuali tra chi è con noi echi è contro di noi. Questi ultimi
meritano tutto lo sprezzo e lo sdegno possibili e magari la revoca
dell'appartenenza alla comunità Lgbt. E menomaleche Zan si vanta di essere un
paladino contro la discriminazione... Avesse usato un politico di destra le sue
parole nei confronti di un deputato di sinistra, difensore della famiglia e
scoperto a baciare un uomo, si sarebbe parlato di omofobia. Invece a Zan tutto è
concesso. Insomma, altro che «senza paura». Nel caso venisse approvato il ddl, i
primi ad avere paura dovrebbero essere gli omosessuali eterodossi, rei di
pensare con la propria testa e costretti alla condanna per questo.
Dal “Venerdì di Repubblica”
l'8 settembre 2021. Anni fa le scrissi parlando di amore, del mio compagno. Oggi
potrei ripeterle le stesse parole, solo aggiornando i numeri. Siamo insieme da
35 anni, da cinque uniti civilmente, anche se io dico Sposati, con la maiuscola,
e siamo Marito e Marito e non unito e unito (scusi l'ironia). L'amore permane,
alimentato dalle nostre passioni comuni, da una mai cessata, dalla condivisione
di tutto quanto accade, dal non lasciar passare nulla sulle spalle senza averlo
almeno discusso insieme, quando non condiviso. La passione, quella corporale,
come sempre giustamente dice, dopo un po' se ne va, talvolta torna, ma sono
fuochi artificiali che durano quel tempo lì, ma servono anche quelli. Ma l'amor,
quello spirituale, rimane e cresce se lo sai alimentare. Noi siamo ancora capaci
di ridere insieme, ma anche di piangere, e persino di stare seri. Non siamo
uguali, ci mancherebbe, anzi per certi aspetti siamo diversi, ma negli anni
abbiamo percorso un cammino talvolta parallelo, talvolta convergente, ma sempre
mano nella mano, e questa è stata la nostra forza. Siamo stati, e siamo tuttora,
apprezzati da chi ci ha conosciuto, da chi ha percorso un po' di cammino
insieme, e fortunatamente non siamo soli in questo ma molte nostre conoscenze
hanno fatto percorsi simili. Quest' anno siamo andati al Gay Pride di Milano,
fieri della nostra storia ma curiosi di quanto c'era di nuovo. In particolare ci
ha colpito la grande quantità di giovani che in vario modo hanno partecipato
alle giornate organizzate ma soprattutto alla finale all'Arco della Pace.
Coloratissimi, fluidissimi, gioiosi, femmine e maschi e tutte le sfumature che
possono passare tra questi due punti. Per noi è stata una gioia vedere come i
ragazzi affrontano questa questione. Sono sicuro che c'erano molti che
partecipavano per solidarietà ovvero perché credono nella libertà e non sono
certo gay lesbiche o altro. Ma la loro presenza ci ha colmato di emozioni.
Adesso c'è da vedere come andrà la legge Zan. Claudio Oscar Moschini -
sacco25@tim
Risposta di Natalia Aspesi:
Come ha visto, la legge Zan è stata rimandata. Del resto se ricorda, quella
delle unioni civili è stata in sospeso per 40 anni, e solo il vituperato Renzi è
riuscito a farla approvare, e quindi ad acconsentire a tanti, anche a lei, di
diventare Marito di un Marito, come a tante Mogli di avere una Moglie. Noi
tradizionalisti del sesso, o banaloni o privi di coraggio o trogloditi o quel
che vuole lei, però democratici, già dall'inizio abbiamo partecipato
festosissimi ai primi Gay Pride italiani e ricordo che chi li aveva, portava
anche i bambini. Intanto complimenti: la descrizione che lei fa di una unione
che dura da decenni, è quella di cosa si intende per matrimonio, che non sempre
però riesce ad essere così. Io l'ho già detto tante volte, sempre insultata:
l'unione più solida e serena è quasi sempre proprio quella tra persone dello
stesso sesso, mi piacerebbe che un esperto mi spiegasse, se è vero, perché. Mi
consenta un attimo di ironia: secondo lei, visto che l'informazione e la cultura
non parlano che di trans, fluidi, gay, avrà diritto di essere rappresentata
ancora la coppia etero, nei film, nei libri, nella vita?
"Versione luxury...",
"Influencer..". La bufera su Fedez.
Francesco Curridori il 10
Luglio 2021 su Il Giornale. Fedez e sua moglie Chiara Ferragni dettano l'agenda
della politica, soprattutto sul Ddl Zan. A tal proposito ecco le opinioni dei
deputati Augusta Montaruli (FdI) e di Fausto Raciti (Pd) per la rubrica Il
bianco e il nero. L'attivismo di Fedez e di sua moglie Chiara Ferragni a favore
del Ddl Zan continua a dividere la politica. Per la rubrica Il bianco e il
nero abbiamo interpellato la deputata di FdI, Augusta Montaruli e il piddino
Fausto Raciti. Cosa pensa dell'impegno mediatico di Fedez a favore del ddl Zan?
Montaruli: “Che appunto è
mediatico e l’impegno non può essere consegnato ai like. Dopodiché il lusso non
fa lo stile e la notorietà non fa la verità. Il tentativo di utilizzare la
popolarità del personaggio Fedez così come di altri per fare pressione
sull’approvazione del ddl zan avviene perché se gli stessi si calassero nella
piazza reale subirebbero un irresistibile contraddittorio”.
Raciti: “Non ci vedo nulla di
male né nulla di strano, da sempre le personalità della musica, della cultura,
dello sport, del cinema, dicono la loro. Che Fedez faccia una diretta Instagram
su un argomento popolare è del tutto in linea col suo modo di comunicare. È un
influencer, no?”.
Secondo lei, Fedez punta a
entrare in politica? Potrebbe avere successo?
Montaruli: “Non so a cosa
punti Fedez sicuramente interpreta il suo personaggio da influencer. Non credo
quanto un like possa trasformarsi in un vero consenso. Spero ancora che la
politica sia un’altra cosa”.
Raciti: “Mi sembra uno
abbastanza contento della vita che fa e dei soldi che guadagna col suo lavoro.
Lavoro che sa fare molto bene dato che mi sta facendo un'intervista su di lui.
Purtroppo molti politici sembrano degli influencer o gli piacerebbe sembrarlo,
da un lato. Dall'altro il partito di maggioranza relativa è stato fondato e
guidato da un comico”.
I politici fanno veramente
tutti schifo, come dice la Ferragni oppure una frase del genere stavolta indigna
meno perché è rivolta a Renzi che vuol modificare il ddl Zan?
Montaruli: “I politici non
fanno tutti schifo e dirlo è grave sempre ancora di più se a prescindere dalle
posizioni lo dice una persona che ha l’ambizione di comunicatore a tanti
italiani soprattutto giovani. Minare la fiducia nei confronti dei politici e del
dibattito politico è fare un danno alle nuove generazioni. Stiamo assistendo ad
un grillismo versione luxury”.
Raciti: “Lo chiede a uno che
si è iscritto a un partito a 15 anni e oggi fa il parlamentare, non sarò mai
d'accordo con una cosa così qualunquista. Detto questo il nostro parlamento è
pieno di gente che ci è entrata dicendo esattamente la stessa cosa. La Ferragni
non è stata molto originale”.
Stefano Feltri, direttore del
Domani, ha proposto di regolamentare Per legge l'influenza degli influencer. Lei
sarebbe d'accordo?
Montaruli: “La differenza tra
noi e Fedez è che noi rispettiamo la libertà di pensiero per questo non credo
che ci possano essere provvedimenti che la limitano. Per ottenere par condicio
versione social sarebbe già tanto arrivare ad impedire censure che attualmente
avvengono da parte dei gestori ma sempre e solo a senso unico contro un’unica
parte politica o persone che interpretano idee non compiacenti ai colossi della
comunicazione”.
Raciti: “Non ho capito cosa
dovremmo regolamentare. Mi sembra come quando si diceva che Berlusconi vinceva
le elezioni per le televisioni di cui era proprietario. Poi ti accorgi, e le
difficoltà di Forza Italia oggi lo dimostrano, che la situazione era un po' più
complessa. Invece di fare leggi sugli influencer bisogna farle sui partiti, che
oggi sono formazioni di latta. E finanziarli anche, perché è lì che si dovrebbe
formare una classe dirigente”.
Fedez ha detto che avrebbe
messo a disposizione una piattaforma online per discutere di politica. Non è un
film già visto e mal riuscito?
Montaruli: “Assolutamente sì ,
non sarebbe una novità. La democrazia non può essere mai appannaggio di un click
ed anche chi si è illuso in passato di ciò ha avuto e sta avendo in questo
periodo la conferma del fatto che tali piattaforme hanno ridotto lo spazio di
confronto”.
Raciti: “Non saprei che dirle.
Mi sembra che quel tipo di cose le abbiano già fatte con successo altri, oggi in
crisi. Non so se c'è ancora lo spazio per quel tipo di cose. Ma quindi non mi
voleva parlare del ddl Zan? “
Francesco Curridori. Sono
originario di un paese della provincia di Cagliari, ho trascorso l’infanzia
facendo la spola tra la Sardegna e Genova. Dal 2003 vivo a Roma ma tifo Milan
dai gloriosi tempi di Arrigo Sacchi. In sintesi, come direbbe Cutugno, “sono un
italiano vero”. Prima di entrare all’agenzia
Fedez, un nichilista
esperto in giravolte.
Karen Rubin il 26 Giugno 2021 su Il Giornale. Nella sua canzone
"Tutto il contrario" Fedez si prendeva gioco di Tiziano Ferro, che
coraggiosamente aveva dichiarato la sua omosessualità. «M i interessa che
Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti.
Si era presentato in modo strano con Cristicchi. Ciao sono Tiziano, non è che me
lo ficchi?» Nella sua canzone «Tutto il contrario» Fedez si prendeva gioco di
Tiziano Ferro, che coraggiosamente aveva dichiarato la sua omosessualità. Il
video ufficiale, su Youtube, conta 12.623.407 visualizzazioni. Una realtà che
non si attaglia all'attuale Fedez, paladino del mondo Lgbt, sostenitore del ddl
Zan al punto da contrapporsi alla nota verbale con cui la chiesa cattolica
auspica delle modifiche alla legge nel timore che vada in collisione con il
Concordato. Ma perché si ritengono legittime le esternazioni di Fedez e non
quelle di monsignor Galantino? Di Fedez sappiamo che ha frequentato un liceo
artistico ma non si è diplomato, che ha scritto canzoni come «Tutto il
contrario», «Generazione boh», «Faccio brutto», «Paranoia Airlines». Nunzio
Galantino è laureato in teologia e filosofia con una tesi di laurea dal titolo
«L'antropologia di Bonhoeffer come premessa al suo impegno politico». Bonhoeffer
fu un teologo protagonista della resistenza al nazismo. Il monsignore ha
insegnato nella scuola media statale e nelle università. Del rapper conosciamo
moglie e figli esibiti sui social senza tutele per la loro tenera età, in pasto
alla morbosità degli utenti. In rete una foto del piccolo Leone con il papà ha
suscitato questo commento: «Sei un bel down come tuo padre». Ed ecco che a
pagare le spese di questa sovraesposizione sono il bambino, inconsapevole, e le
persone affette da sindrome di Down, grazie ad un circo organizzato per
l'arricchimento personale mentre sponsorizza una legge che deve difendere la
disabilità. Sappiamo che grazie a questa notorietà è diventato testimonial di
Amazon, un'azienda criticata per le condizioni di lavoro dei suoi dipendenti, ma
è lui ad essere chiamato sul palco della festa dei lavoratori il Primo maggio.
Il vescovo è noto per aver sostenuto la conoscenza di Antonio Rosmini, beato che
sottolineò l'inalienabilità dei diritti umani della persona e sostenne la
necessità della separazione del potere temporale da quello spirituale. Rosmini
fu condannato dalla chiesa e poi riabilitato. Anche Fedez ha subito dure
critiche quando per il suo compleanno, festeggiato in un supermercato, lui e i
suoi amici hanno giocato a calcio con ortaggi e panettoni in barba alla povertà
di cui soffrono milioni di italiani. La festa, trasmessa minuto per minuto sul
profilo Instagram del rapper, è testimone di una scena che costrinse Fedez a
fare una promessa di beneficenza riparatoria ai suoi follower inferociti. Ed è
così che il nichilismo di Fedez si trasforma in filantropia, per riguadagnare un
consenso andato perso. Karen Rubin
Dal palco l'attacco ad Ostellari per il
ddl Zan. Primo Maggio, show di Fedez contro la Lega sul ddl Zan: “Rai voleva
censurarmi”. Carmine Di Niro su Il Riformista l'1
Maggio 2021. “E’ la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un
mio intervento perché venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione
che purtroppo non c’è stata in prima battuta o meglio, dai vertici di Rai3 mi
hanno chiesto di omettere dei partiti e dei nomi ed edulcorarne il contenuto. Ho
dovuto lottare un pochino, ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi
liberamente. Come ci insegna il 1 maggio, nel nostro piccolo dobbiamo lottare
per le cose importanti. Ovviamente da persona libera mi assumo tutte le
responsabilità e le conseguenze di ciò che dico e faccio. Buon primo maggio”. È
l’intervento, tramite una story su Instagram, di Fedez, il rapper che stasera si
esibirà Concertone del 1 maggio organizzato dai sindacati. Un intervento che
arriva dopo un video pubblicato dal segretario della Lega Matteo Salvini, che
ricordando il costo per gli italiani di circa 500mila dell’evento, attraverso la
Rai, aveva denunciato che “i comizi ‘de sinistra’ sarebbero fuori luogo”. Non
era quindi mancata la replica del rapper, che aveva ricordato all’ex ministro
dell’Interno che al Corto organizzato da Cgil, Cisl e Uil “vado gratis e e pago
i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da
uomo libero senza che gli artisti debbano inviare i loro discorsi per
approvazione preventiva da voi politici. Il suo partito ci è costato 49
milioni di euro”. Ma contro Fedez sono intervenuto a spron battuto
anche senatori e deputati della Lega in Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio
(capogruppo), Giorgio Bergesio, Laura Cavandoli, Dimitri Coin, Umberto Fusco,
Elena Maccanti e Simona Pergreffi. Gli esponenti del Carroccio in una nota hanno
avvertito la tv di Stato in questo modo: “Se Fedez userà a fini personali il
concerto del 1 maggio per fare politica, calpestando il senso della festa dei
lavoratori, la Rai dovrà impugnare il contratto e lasciare che i sindacati si
sobbarchino l’intero costo dell’evento”. Secondo gli esponenti leghisti “se
davvero il signor Federico Leonardo Lucia deciderà di promuovere la propria
figura attaccando Lega e Vaticano, sarà un insulto al 1 maggio. Non si usano i
diritti dei lavoratori per promuovere la propria immagine e fare ulteriori
profitti. La Rai non può comprare interventi d’odio a scatola chiusa e non si
invochi la censura, perché al rapper non mancano certo spazi per manifestare il
suo pensiero, tra l’altro noto anche ai sassi. Viale Mazzini ha ancora qualche
ora per rimediare, dopodiché la Lega si muoverà in tutte le sedi competenti. E i
sindacati si ricordino che il lavoro appartiene a tutti, non lo si svilisca per
regalare qualche like a un cantante milionario”.
IL MONOLOGO DI FEDEZ – Fedez sul palco del
Concertone inizia il suo monologo rivolgendosi al premier Draghi: “Buon primo
maggio a tutti i lavoratori, anche a chi il lavoro ce l’ha ma non ha potuto
esercitarlo per oltre un anno – ha detto il rapper -. Per i lavoratori dello
spettacolo questa non è più una festa. Caro Mario (rivolto al premier Draghi,
ndr), capisco che il calcio è il vero fondamento di questo Paese, però non
dimentichiamoci che il numero dei lavoratori del calcio e quello dello
spettacolo si equivalgono. Quindi, non dico qualche soldo, ma almeno qualche
parola, un progetto di riforma in difesa di un settore che è stato decimato da
questa emergenza e che è regolato da normative stabilite negli anni 40 e mai
modificate fino ad oggi. Quindi, caro Mario, come si è esposto nel merito della
Superlega con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il suo intervento
nel mondo dello spettacolo”. Quindi l’attacco frontale alla Lega: “A proposito
di Superlega, due parole per l’uomo del momento, il ‘sonnecchiante’ Ostellari”,
presidente della commissione Giustizia del Senato e relatore del ddl Zan
sull’omotransfobia. “Ha deciso che un disegno di legge di iniziativa
parlamentare, quindi massima espressione del popolo, che è stato già approvato
alla Camera come il ddl Zan, può essere tranquillamente bloccato dalla voglia di
protagonismo di un singolo, cioè sè stesso. D’altronde, Ostellari fa parte di
uno schieramento politico che negli anni si è distinto per la sua grande lotta
alle diseguaglianze”, aggiunge ironicamente Fedez, elencando alcune delle frasi
che esponenti del Carroccio hanno pubblicamente espresso in questi anni sul tema
dell’omotransfobia, in alcuni casi anche chiedendo scusa. L’artista ricorda
frasi come “se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno”, “gay vittime di
aberrazioni della natura”, “i gay sono una sciagura per la riproduzione” o “il
matrimonio gay porta l’estinzione della razza”. Fedez, poi, prende di mira anche
i ProVita: “A proposito di diritto alla vita, quella del presidente
dell’Associazione ProVita, l’ultra cattolico e antiabortista, Jacopo Coghe,
amicone del leghista Pillon, in questi mesi è stata la prima voce a sollevarsi
contro ddl Zan. L’anti-bortista, però, non si è accorto che il Vaticano ha
investito più di 20 milioni di euro in un’azienda farmaceutica che produce la
pillola del giorno dopo – dice dal palco Fedez -. Quindi, cari anti-abortisti,
caro Pillon, avete perso troppo tempo a cercare il nemico fuori e non vi siete
accorti che il nemico ce l’avevate in casa. Che brutta storia”, conclude.
LA NOTA RAI (SMENTITA DA FOA) – Viale Mazzini in
una nota, rispondendo così a Fedez e alla sua denuncia di essere stato
sottoposto ad approvazione, ha descritto come “fortemente scorretto e privo di
fondamento” l’accusa da parte del rapper di aver chiesto preventivamente i testi
del suo intervento. “Si tratta di una cosa che non è mai avvenuta”, si legge in
una nota. ” Né la Rai né la direzione di Rai3 hanno mai operato forme di censura
preventiva nei confronti di alcun artista del concerto – continua il comunicato
-: la Rai mette in onda un prodotto editoriale realizzato da una società di
produzione in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil, la quale si è occupata della
realizzazione e dell’organizzazione del concerto, nonché dei rapporti con gli
artisti. Il che include la raccolta dei testi, come da prassi”. Una precisazione
però incredibilmente "smentita" da fonti della presidenza Rai, che hanno
spiegato come “la nota inizialmente diffusa dalla Rai su Fedez e il Concerto del
Primo maggio non era stata sottoposta preventivamente all’approvazione del
presidente Foa come di consueto”.
FEDEZ PUBBLICA IL VIDEO DELLA CENSURA – Come aveva
preannunciato su Instagram, Fedez ha quindi pubblica su Twitter il video della
telefonata incriminata, in seguito alla quale ha accusato la Rai di avere
provato a censurare il suo monologo sul palco del Concertone del Primo maggio.
“La Rai smentisce la censura – scrive Fedez -. Ecco la telefonata intercorsa
ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria Capitani insieme ai suoi
collaboratori mi esortano ad ‘adeguarmi ad un sistema’ dicendo che sul palco non
posso fare nomi e cognomi”. Poi pubblica il video nel quale lo si vede e sente
mentre parla in viva voce e spiega cosa ha intenzione di dire sul palco,
mentre dall’altro lato del telefono gli rispondono di non fare nomi e cognomi di
politici perché “questo non è il contesto corretto”. “La direzione di Rai3
conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli artisti
intervenuti al concerto del Primo Maggio – richiesta invece avanzata dalla
società che organizza il concerto – e di non aver mai operato forme di censura
preventiva nei confronti di alcun artista”. Lo comunica Rai3 con una nota. “In
riferimento al video pubblicato sul suo profilo Twitter da Fedez – si legge nel
comunicato – notiamo che l’intervento relativo alla vicedirettrice di Rai3
Ilaria Capitani (l’unica persona dell’azienda Rai tra quelle che intervengono
nella conversazione pubblicata da Fedez) non corrisponde integralmente a quanto
riportato, essendo stati operati dei tagli. Le parole realmente dette sono: ‘Mi
scusi Fedez, sono Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai3, la Rai non ha proprio
alcuna censura da fare. Nel senso che… La Rai fa un acquisto di diritti e
ripresa, quindi la Rai non è responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe
altro, né di quello che lei dirà”. E ancora: “Ci tengo a sottolinearle che la
Rai non ha assolutamente una censura, ok? Non è questo […] Dopodiché io ritengo
inopportuno il contesto, ma questa è una cosa sua”.
Carmine Di Niro. Romano di nascita ma trapiantato
da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia
Carlo Moretti per repubblica.it il 2 maggio 2021.
Fedez irrompe nel concertone a mezza sera con una lunga tirata politica e
attacca la Lega. Nel suo discorso che, annunciato, nel pomeriggio aveva
suscitato la reazione preventiva del leader leghista Matteo Salvini su Twitter,
il rapper e influencer milanese ha attaccato le posizioni della Lega sul Ddl Zan
e ne ha criticato alcuni esponenti elencando le loro frasi e definendole
omofobe. "Oggi mi hanno chiesto come fosse la mia prima volta al Primo Maggio.
Effettivamente è la prima volta anche di dover inviare un mio discorso perché
doveva essere messo al vaglio della politica. Approvazione che in prima battuta
dai vertici di Rai3 non c'è stata, perché mi hanno chiesto di omettere i
riferimenti ai partiti, ai nomi dei politici. Ho dovuto lottare un pochino e
alla fine mi hanno dato il permesso di dire ciò che dico, assumendomene le
responsabilità. E comunque il contenuto è stato definito dalla vicedirettrice di
Rai3 "inopportuno". Dopo un riferimento a Draghi chiamato solo Mario per il
diverso trattamento riservato al mondo del calcio e al mondo dello spettacolo,
vista la difesa del campionato per il tentativo della Superlega e il silenzio
invece per lo stop di concerti e spettacoli live, Fedez ha attaccato: "Ostellari
(Andrea Ostellari, il leghista a capo della Commissione Giustizia in Senato) ha
deciso che un disegno di legge già approvato alla Camera può tranquillamente
essere bloccato dall'iniziativa di un singolo, cioè se stesso. Ma d'altronde
Ostellari fa parte di uno schieramento politico che negli anni si è distinto per
la sua lotta all'uguaglianza. Vorrei decantarvi un po' di loro aforismi, se
posso", ha aggiunto per poi citare frasi come "'Se avessi un figli gay lo
brucerei nel forno', Giovanni De Paoli, consigliere regionale della Lega
Liguria. 'I gay? Che inizino a comportarsi come tutte le persone normali',
Alessandro Rinaldi, consigliere per la Lega, Reggio Emilia". Poi Fedez ha
obiettato a Ostellari la necessità del Senato di concentrarsi su questioni più
serie rispetto al Ddl Zan: "Si sono occupati di etichettatura del vino, la
riorganizzazione del Coni, l'indennità per il bilinguismo dei poliziotti di
Bolzano, il reintegro del vitalizio di Formigoni, evidentemente più importante
dei diritti di tutti e di persone che vengono continuamente discriminate fino
alla violenza". E a proposito della presa di posizione del vice-presidente di
ProVita, "l'utracattolico e antiabortista Jacopo Coghe, amicone del leghista
Pillon, è stato il primo a esprimersi contro il Ddl Zan ma non si è accorto che
il Vaticano ha investito milioni di euro in un'azienda che produce la pillola
del giorno dopo. Cercavate il nemico altrove ma non vi siete accorti che il
nemico ce l'avevate in casa. Che brutta storia". Salvini in serata ha risposto
con un post su Facebook in cui, tra le altre cose, ha scritto: "Chi aggredisce
un omosessuale o un eterosessuale, un bianco o un nero, un cristiano o un
buddhista, un giovane o un anziano, rischia fino a 16 anni di carcere. È già
così. Reinvito Fedez a bere un caffè, tranquilli, per parlare di libertà e di
diritti". E' poi intervenuto anche il deputato Pd Alessandro Zan che ha voluto
ringraziare Fedez con un post su Facebook in cui si legge: "Il coraggio di Fedez
al Concertone dà voce a tutte quelle persone che ancora subiscono violenze e
discriminazioni per ciò che sono. Il Senato abbia lo stesso coraggio ad
approvare subito una legge per cui l'Italia non può più attendere. Grazie
Fedez". In serata anche la reazione della Rai, che si difende dall'accusa di
censura: "Rai 3 e la Rai sono da sempre aperte al dibattito e al confronto di
opinioni, nel rispetto di ogni posizione politica e culturale. È fortemente
scorretto e privo di fondamento sostenere che la Rai abbia chiesto
preventivamente i testi degli artisti intervenuti al tradizionale concertone del
Primo Maggio, per il semplice motivo che è falso, si tratta di una cosa che non
è mai avvenuta. Né la Rai né la direzione di Rai 3 hanno mai operato forme di
censura preventiva nei confronti di alcun artista del concerto" dicono da viale
Mazzini. E continuano: "La Rai mette in onda un prodotto editoriale realizzato
da una società di produzione in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil, la quale si
è occupata della realizzazione e dell'organizzazione del concerto, nonché dei
rapporti con gli artisti. Il che include la raccolta dei testi, come da prassi".
Ma la reazione di Fedez non si è fatta attendere e su Twitter ha chiarito
pubblicando la telefonata intercorsa con la vicedirettrice di Rai 3, Ilaria
Capitani: "La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera
dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria Capitani insieme ai suoi collaboratori
mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare
nomi e cognomi".
Dagospia il 2 maggio 2021. Comunicato: La
direzione di Rai3 conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli
artisti intervenuti al concerto del Primo Maggio – richiesta invece avanzata
dalla società che organizza il concerto – e di non aver mai operato forme di
censura preventiva nei confronti di alcun artista. In riferimento al video
pubblicato sul suo profilo Twitter da Fedez, notiamo che l’intervento relativo
alla vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani (l’unica persona dell’azienda Rai
tra quelle che intervengono nella conversazione pubblicata da Fedez) non
corrisponde integralmente a quanto riportato, essendo stati operati dei tagli.
Le parole realmente dette sono: “Mi scusi Fedez, sono Ilaria Capitani,
vicedirettrice di Rai3, la Rai non ha proprio alcuna censura da fare. Nel senso
che… La Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, quindi la Rai non è
responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe altro, né di quello che lei
dirà.” […] “Ci tengo a sottolinearle che la Rai non ha assolutamente una
censura, ok? Non è questo […] Dopodiché io ritengo inopportuno il contesto, ma
questa è una cosa sua.”
Il paladino Lgbt con
gli scheletri nell'armadio: le canzoni di Fedez contro i gay.
Federico Garau il 2 Maggio 2021 su Il Giornale. Dopo il
concertone del primo maggio, sono in tanti ad andare a scavare nel passato di
Fedez. Ecco cosa abbiamo trovato. Delle frasi omofobe pronunciate dal nuovo
paladino della comunità Lgbt Fedez? Sembrerebbe impossibile, visto l'ardore con
il quale il rapper milanese ha voluto difendere la libertà di esprimere il
proprio pensiero durante il concertone del primo maggio: uno sfogo telefonico
coi vertici di "Mamma Rai", rei di aver limitato i contenuti del discorso a
favore del ddl Zan che il cantante ha voluto portare integralmente sul palco.
Fedez si è mostrato talmente convinto del fatto suo da aver violato le norme
sulla privacy diffondendo, senza il consenso dei diretti interessati, la
telefonata con la vicedirettrice di RaiTre Ilaria Capitani, con lo scopo di
mostrare ai suoi follower la bontà dei suoi intenti e la "brutalità" della
censura subita. Telefonata che, secondo l'emittente televisiva, è stata
invece tagliata e incollata ad arte per ottenere l'effetto desiderato dal
diretto interessato. Ma non è tanto la materia giuridica ad interessare, dato
che se ne occuperà eventualmente chi di dovere ed ha gli strumenti adatti a
dirimere la questione, quanto i trascorsi del rapper. In queste ore di caos
totale, in molti si sono andati a cercare le canzoni più "spinte" del rapper. Il
contenuto che ha destato più scalpore, ed è tornato prepotentemente alla ribalta
in queste ultime ore, è una parte del testo della canzone" Tutto il
contrario" (2011). Prendendo spunto dall'outing fatto da Tiziano Ferro, il
rapper milanese aveva utilizzato delle parole abbastanza dirette e che non
lasciavano spazio ad interpretazioni alternative: "Mi interessa che Tiziano
Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era
presentato in modo strano con Cristicchi: 'Ciao sono Tiziano, non è che me lo
ficchi?'". Punto sul vivo dai troppi rimandi al testo, il rapper milanese, in
evidente imbarazzo, ha voluto giustificarsi parlando di una canzone scritta
quando aveva solo 19 anni e dunque anche della eventualità di poter cambiare
idea rispetto al passato:"In questo momento alcuni leghisti stanno
controbattendo riportando un vecchio testo di quando avevo 19 anni", ha
dichiarato il cantante, come se si trattasse di un'attenuante da
valutare. "Tutti cambiano idea nella vita. Il vostro leader è passato da “senti
che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani” a voler
governare il Paese", ha proseguito Fedez. "Comunque la mia canzone si intitola
Tutto il contrario: io scrivo tutto il contrario di quello che penso. Non è
difficile". Sempre nel 2011 ("Contenuti") comunque, lo stesso attuale paladino
della comunità Lgbt, con l'intento di attaccare il Parlamento, si lasciava
sfuggire un'altra espressione discretamente "ambigua": "Tu li hai chiamati e li
chiami "membri del parlamento". Invece io li chiamo "parlamento di membri".
Fuori, per minorenni e donne con il membro. Anzi donne con il ca**o così sei più
contento". Nel 2011, Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, cantava anche "Ti
porto con me". Nel testo, la frase, per nulla politically correct, "Non fare
l’emo fr***o con lo smalto sulle dita". Proprio lui che adesso una linea di
smalti l'ha addirittura lanciata. Facendo qualche passo indietro nel tempo
(2006) la stessa intitolata "Canzone da gay" lascia ben poco
all'interpretazione: "Io lo so che ti piaccion le canzoni da gay, devo farle
perché a te piacciono. Io lo so che ti piaccion le canzoni da gay, più ti guardi
allo specchio più ti credi una lei. Poi ti chiedi perchè faccio le canzoni da
gay, perchè senza di te io come camperei?". Superando gli anni della pubertà del
rapper e quelli della non ancora completa maturità (quella dei 19 anni, dopo i
quali si può cambiare idea, come da lui stesso affermato), si può comunque fare
un salto al 2020. Siamo ad un anno fa, quindi, coi 19 anni alle spalle da tempo
e, probabilmente, anche con una importante modifica alle proprie idee già
attuata. Eppure la canzone "Le feste di Pablo", rifacimento di un brano della
giovane rapper Cara, contiene una parte di testo che ha irritato e non poco
proprio la comunità Lgbt: "Pablo sei un pacco, tipo tipa con la sorpresa". Una
frase che non c'era nella versione originale del pezzo, aggiunta dal cantante
per dare un tocco personale al suo singolo. "Il punto, però, è che nel testo c’è
una frase che gronda transfobia come un ghiacciolo lasciato al sole. Un "pacco",
una fregatura, come una “tipa con la sorpresa” ovvero uno dei tantissimi modi
denigratori con cui si definiscono le donne trans che non si sono sottoposte
all’intervento chirurgico", commentavano lo scorso anno sul sito "gaypost.it".
Insomma, il paladino ha qualche scheletro nell'armadio.
Chi è Ilaria Capitani e cosa ha detto a
Fedez al telefono: “Nel video ci sono tagli, ecco com’è andata”.
Rossella Grasso su Il Riformista il 2 Maggio 2021. La polemica
incalza sul caso Fedez al concerto del Primo Maggio. Non solo per il suo
monologo contro la Lega ma anche per l’accusa contro la Rai di aver tentato di
“censurare” il testo del suo monologo o almeno di edulcorarlo. Il rapper ha
attaccato i vertici di Rai3 anche durante il suo monologo sul palco e subito è
scoppiata la bufera a colpi di richiesta di scuse da parte della Tv pubblica
nazionale e dimissioni dei suoi vertici. Dopo una prima smentita da parte di Rai
3 Fedez ha pubblicato sui suoi social la registrazione della telefonata avuta
con alcuni vertici Rai tra cui Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai 3.
La telefonata di Fedez con i vertici Rai. “Le
asserzioni che riporto nel mio testo sono consiglieri leghisti che dicono ‘se
avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno’”, tuona Fedez. ‘Le sto chiedendo di
adeguarsi a un sistema – si sente dell’altro capo del telefono – Tutte le
citazioni che lei fa con nomi e cognomi non possono essere citate. Questo non è
il contesto corretto’. Fedez replica: “Chi lo stabilisce? Io dico quello che
voglio sul palco. Nel mio testo non c’è turpiloquio, sono imbarazzo per voi”.
“Io ritengo inopportuno il contesto”, gli dice a quel punto la vicedirettrice
Capitani. “Ma io faccio quello che voglio visto che non c’è contesto di
censura”, sbotta lui che poi conclude: “Nel vostro futuro i diritti civili sono
contemplati sì o no?”.
La replica della Rai: “Mai chiesto i testi”. “La
direzione di Rai3 conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli
artisti intervenuti al concerto del Primo Maggio – richiesta invece avanzata
dalla società che organizza il concerto – e di non aver mai operato forme di
censura preventiva nei confronti di alcun artista”. Lo comunica Rai3 con una
nota. “In riferimento al video pubblicato sul suo profilo Twitter da Fedez – si
legge nel comunicato – notiamo che l’intervento relativo alla vicedirettrice di
Rai3 Ilaria Capitani (l’unica persona dell’azienda Rai tra quelle che
intervengono nella conversazione pubblicata da Fedez) non corrisponde
integralmente a quanto riportato, essendo stati operati dei tagli. Le parole
realmente dette sono: ‘Mi scusi Fedez, sono Ilaria Capitani, vicedirettrice di
Rai3, la Rai non ha proprio alcuna censura da fare. Nel senso che… La Rai fa un
acquisto di diritti e ripresa, quindi la Rai non è responsabile né della sua
presenza, ci mancherebbe altro, né di quello che lei dirà”. E ancora: “Ci tengo
a sottolinearle che la Rai non ha assolutamente una censura, ok? Non è questo
[…] Dopodiché io ritengo inopportuno il contesto, ma questa è una cosa sua”.
La risposta di Fedez alla rai. Tramite le sue
Instagram Stories, Fedez ha già fatto sapere che metterà “a disposizione la
registrazione integrale della telefonata agli organi competenti della Rai
laddove ci fosse la voglia di fare chiarezza su quanto accaduto. Anche se per
ora vedo solo una gran corsa a discolparsi a prescindere da ciò che è successo”.
Chi è Ilaria Capitani, la vicedirettrice di Rai3.
Ilaria Capitani è la vicedirettrice di rai Tre. È intervenuta nella telefonata
con Fedez, quella in cui la Rai avrebbe chiesto a Fedez di edulcorare i toni del
suo discorso. Prima di diventare vicedirettrice era caporedattrice del Tg2, per
anni ha seguito Palazzo Chigi. È entrata in Rai nel 199 lavorando con Aldo
Biscardi a Il processo del lunedì. Poi, in occasione delle Olimpiadi di Atlanta,
il passaggio alla testata giornalistica sportiva della Rai. Per alcuni anni ha
lavorato alla Tgr del Lazio, per poi arrivare a condurre Cominciamo bene.
Successivamente torna in Rai per condurre il Tg Parlamento e rubriche di
approfondimento politico.
Rossella Grasso. Giornalista professionista e
videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali
occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di
Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha
collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di
stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana,
si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo
Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al
Napoli Film Festival.
Il commento del segretario della
commissione di Vigilanza Rai. Caso Fedez, Anzaldi: “È l’apice del fallimento Rai
targato M5S, è da anni che denuncio”. Rossella
Grasso su Il Riformista il 2 Maggio 2021. “Il caso Fedez rappresenta l’apice del
fallimento targato Movimento 5 stelle nella gestione della Rai”. Così Michele
Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai
è intervenuto con un post su Facebook sulla questione della presunta “censura”
da parte della rai sul monologo di Fedez durante il concerto del Primo Maggio.
“Da 3 anni il partito di Beppe Grillo, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Roberto
Fico, Alessandro Di Battista gestisce la Rai, dopo aver guidato nei 5 anni
precedenti anche la commissione parlamentare di Vigilanza Rai, e il risultato è
questo – continua il post – Da 3 anni denuncio violazioni, abusi, errori,
malagestione di questa Rai e adesso, a pochi giorni dalla fine del mandato, c’è
ancora chi si stupisce? Dalla Rai gialloverde alla Rai giallorossa, la
principale continuità è stata quella di negare l’accesso agli atti in Parlamento
sulle schede della votazione illegittima su Foa, che abbiamo chiesto insieme
agli allora capigruppo Pd Delrio e Marcucci con atti ufficiali a Fico,
Casellati, Barachini senza ricevere risposta”.
“Ecco perché è urgente chiudere definitivamente la
stagione del Cda a guida M5s-Lega-Fdi e aprire finalmente una nuova fase ora
pienamente nella responsabilità del presidente del Consiglio Draghi – scrive
ancora Anzaldi – Spetta a Draghi e al ministro Franco convocare al più presto
l’Assemblea dei Soci Rai e chiudere ufficialmente il mandato di questi vertici,
altrimenti saranno complici di situazioni come quella vista per il Primo
Maggio”. “Dal caso del Concertone apprendiamo alcuni elementi davvero
sconcertanti – denuncia Anzaldi – Innanzitutto la Rai, guidata
dall’amministratore delegato Salini scelto da M5s, conferma che la realizzazione
dell’evento del Primo Maggio, trasmesso su Rai3 guidata dal direttore Franco di
Mare scelto da M5s, è stata totalmente esternalizzata. A produrre lo spettacolo,
a suon di centinaia di migliaia di euro pubblici, è stata l’ennesima società
esterna. Perché la Rai M5s continua ad affidare all’esterno pezzi così
importanti di palinsesto? Perché non è stata mai applicata la Risoluzione della
Vigilanza contro i conflitti di interessi di agenti, autori e conduttori?”
“Dalla telefonata con i vertici di Rai3 pubblicata da Fedez, come si evince
anche dal comunicato stampa Rai, il cantante si confronterebbe sui contenuti del
suo intervento non solo con la vicedirettrice della rete ma anche con un
delegato della società esterna che avrebbe chiesto di verificare il contenuto
del suo intervento: come è possibile che le società esterne decidano la linea
editoriale del servizio pubblico? Per questo paghiamo il canone?”, continua il
post. “La Rai è stata trascinata da questa dirigenza, la peggiore che l’azienda
abbia mai avuto, in un polverone imbarazzante di tipo censorio per totale
incapacità, se non peggio. E’ chiaro che in onda nessuno avrebbe potuto impedire
ad un artista sul palco di esprimere liberamente il suo pensiero, è sconcertante
l’intera gestione di questa vicenda – conclude il post Michele Anzaldi – Viene
anche da chiedersi: perché Fedez si è prestato ad anticipare i contenuti del suo
intervento alla produzione? Nella storia del Concertone gli artisti che hanno
voluto manifestare liberamente il proprio pensiero, anche creando grandi
polemiche, non hanno certamente mai chiesto il permesso”.
Rossella Grasso. Giornalista professionista e
videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali
occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di
Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha
collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di
stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana,
si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo
Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al
Napoli Film Festival.
Michela Tamburrino per “La Stampa” il 4 maggio
2021. Angelo Guglielmi lo ripete sempre. Lui la televisione ha smesso di
guardarla, quasi in contemporanea con quando ha smesso di farla. Correvano gli
Anni Ottanta a cavallo dei Novanta e lui era il guru di Raitre. Un mondo bell'e
finito dal quale guardare l'oggi con occhi disincantati. Non guarda la tv ma i
giornali li legge eccome, Guglielmi, la politica la sente nella pelle anche se
l'ha praticata pochissimo.
Il suo è un approccio intellettual-passionale e la
Rai è come se gli scorresse dentro. Guglielmi, ha visto la tempesta perfetta che
si è scatenata in queste ore? Fedez, la censura, i politici della Lega, le
accuse di omofobia dal palco del Primo maggio. La Rai, le telefonate e le
smentite. Lei che ne dice?
«Lo chiedo da 40 anni, la Rai deve superare la
lottizzazione che autorizza comportamenti indegni. La lottizzazione è uguale
alla censura per chi vuole manovrare l'azienda».
Censure incrociate tra partiti?
«Ma certo. Mettiamo, io sono comunista, faccio
qualcosa da comunista e un democristiano o un socialista mi censura. Abolendo
questo sistema, anche i controlli saltano. Quello che è accaduto in queste ore è
frutto di una scelta fatta dai Cinque stelle e dalla Lega che, all'indomani
delle elezioni, forti del 33% e del 17%, decisero per questa dirigenza. Sono
loro che per star tranquilli hanno tentato di controllare il testo di Fedez».
Lei perciò pensa che il rapper sia nel giusto?
«Credo in lui e in quello che ha detto nel suo
libero canto. E credo pure che in Rai si siano spaventati negando di aver fatto
quello che invece hanno fatto. Io credo a chi dice piuttosto che a chi nega».
Che cosa bisognerebbe fare?
«Bisognerebbe fare come dice il presidente della
Camera Roberto Fico, abolire le nomine politiche. Lui fa un intervento a
proposito di governance assolutamente condivisibile e lo fa contro il partito
del quale fa parte, il M5S, e lo riconosce. Non più Salini, non più Foa ma un
grande manager e un presidente che non si riferisce ai partiti. Adesso è tempo
di tornare alla nomine di spessore. In fondo basta aspettare le scadenze a
giugno».
Preoccupato? Scettico?
«Per quanto riguarda l'Ad sto tranquillo, perché
del premier Draghi mi fido molto. Certamente segnalerà chi dice lui. Per quanto
riguarda il Presidente sono più scettico. Eppure le condizioni ci sarebbero,
nonostante l'azionista di riferimento sia il Mef. Con una maggioranza alle
Camere tanto allargata, la politica potrebbe avere il coraggio di fare un passo
indietro per guardare a un profilo di competenza che non faccia riferimento ad
alcun partito. Sarebbe un bel segno di libertà».
Sarebbe una bella vittoria?
«Tornando indietro nel tempo, io fui il frutto di
una nomina di fine impero. De Mita per la Dc, Craxi per il Psi e Veltroni,
responsabile culturale del Pci, decisero di dare al Pci morente una rete, la
terza. E arrivai io che non avevo mai fatto politica, pur avendo sempre votato
Pci. Per 8 anni feci quello che ritenevo giusto, superai la fine dell'Urss, dei
partiti italiani, della guerra fredda, di mani pulite. Ma non superai l'arrivo
di Letizia Moratti, messa lì da Berlusconi, che prima mi chiuse in una stanzetta
senza far nulla e poi mi propose di fare il professore ai nuovi direttori. Io la
televisione la faccio, non la insegno. E me ne andai».
Da chi sarebbe composta la troika oggi?
«Non lo so. Io mi fido solo di Draghi. Mi
piacerebbe che si avverasse quello che avevamo sperato, il superamento della
lottizzazione. Dopo 40 anni, è tempo».
Carlo Freccero per “il Fatto Quotidiano” il 16
maggio 2021. Se dovessimo prendere alla lettera le affermazioni di Luttazzi,
dovremmo concludere che, chiunque non abbia la possibilità di allestire un suo
programma in Rai, pagato secondo le sue aspettative, sia un censurato. È come se
Luttazzi fosse impermeabile allo scorrere del tempo. Il suo universo si è
cristallizzato in un anno, il 2001, in cui è stato oggetto di processi che anch'
io ho subito. Avrei voluto dargli una possibilità. Si è riproposto scrive lui,
con le stesse tariffe di 12 anni prima e chiedendo assoluta libertà di
espressione. Nel frattempo il mondo era cambiato e oggi lo è molto di più. In
quanto alla valutazione dei compensi direi che sono stati svalutati. Il
meccanismo dell'austerity ha prodotto, invece della svalutazione della moneta,
una svalutazione feroce dei salari. Oggi l'Italia è un Paese di poveri. Oggi
potersi esprimere liberamente è già di per sé un privilegio. E chi ha qualcosa
da dire lavora su internet gratis o, al massimo, col contributo economico dei
suoi ascoltatori. Io stesso ho accettato di dirigere la Rai senza compenso. Non
solo, ho dovuto pure pagare le tasse sulle trasferte per servizio. Anche Fedez,
comunque si vogliano valutare le sue affermazioni, quando ha denunciato la
censura, ha potuto comunque dichiarare di non avere ricevuto compenso per il suo
intervento. Luttazzi chiedeva un compenso di base di 100 mila euro a puntata
come conduttore/autore a cui doveva essere aggiunto il compenso per altre voci,
per un totale che, anche se non venne mai negoziato direttamente, era in ogni
caso troppo al di fuori della possibilità della rete. Per questo non vi furono
ulteriori trattative, che tra l'altro non competevano a me, ma al settore
amministrativo. E veniamo al secondo argomento che Luttazzi sembra non
comprendere: la compatibilità della singola trasmissione con la linea editoriale
della rete è il raggiungimento dell'audience preventivata. Una volta la Rai
aveva funzioni di servizio pubblico, sostenute dal canone. Oggi deve fare
quadrare i suoi bilanci e questo implica due conseguenze: il ridimensionamento
dei compensi e la ricerca dell'audience per ottenere pubblicità. Oggi il
problema principale della Rai è il problema di qualsiasi azienda che deve essere
produttiva. Può pagare compensi elevati solo in presenza di un ritorno
economico. In ogni caso deve rispettare una linea editoriale e un'audience
concordata con i pubblicitari. All'interno di un'azienda industriale, come oggi
di fatto è la Rai, non c'è censura, ma ricerca del profitto. Nessuna azienda
acquisterebbe un prodotto da vendere al pubblico senza prima prenderne visione.
Dal mio punto di vista non potevo prendere Luttazzi a scatola chiusa senza
sapere quanto il prodotto che mi proponeva fosse compatibile con la Rai2 del
2019. Dopo 20 anni non conoscevo la sua nuova produzione, ma sapevo che la
vecchia non era compatibile con la Rai di oggi. La Rai2 del 2001 era tutta
basata sulla satira, la Rai2 del 2019 non aveva spazio per performance
solitarie, ma solo per un lavoro di gruppo. Quella che Luttazzi legge come
censura è semplicemente ricerca dell'audience. Luttazzi sembra non capire che le
sue performance del 2001 sarebbero "politicamente scorrette" e quindi prive di
audience. E questa stessa censura, qualora l'avesse applicata a Luttazzi prima
di tutto l'avrei applicata a me stesso. Io avevo accettato l'incarico di
Direttore di Rai2 gratuitamente per potere fare finalmente un'informazione
libera. Per informazione libera intendo l'altra faccia della medaglia, le
informazioni che non arrivano sul mainstream, ma rimangono su Internet.
Purtroppo proprio l'informazione è stata penalizzata dall'audience e quindi non
ho potuto svilupparla come avrei voluto. Il pubblico non era interessato a
notizie che non appartenessero già all'agenda dei media e al gossip conseguente.
Io stesso quindi ho dovuto sacrificare le mie ambizioni all'audience complessiva
della rete, perché non tutti gli argomenti sono compatibili con le richieste del
pubblico in quel momento. Non so se tutti conoscano il meccanismo della finestra
di Overton. Secondo Overton, sociologo e attivista statunitense, morto nel 2003,
in ogni epoca, in ogni momento, esiste una "finestra" che inquadra ciò che può
essere detto su un determinato argomento. Se si vuol promuovere un argomento
impopolare, bisogna passare attraverso una serie di tappe successive.
L'argomento viene prima presentato come intollerabile, poi viene discusso
aprendo alcune possibilità, infine lo si sdogana e diventa popolare. Le tappe
sono le seguenti: inconcepibile, estrema, accettabile, ragionevole, diffusa,
legalizzata. È facile capire come l'audience corrisponda perfettamente alla
finestra in atto. Naturalmente la finestra potrebbe essere spostata e con essa
l'audience, ma ciò richiederebbe tempi lunghi. In ogni caso non sarebbe
possibile saltare tappe. Il rapporto mainstream/audience è automatico. La
notizia accettabile non è la notizia vera, ma la notizia verosimile e
compatibile con lo spirito del tempo. Non so se anche l'audience sia una forma
di censura. In effetti lo è, ma è motivata non dall'ideologia, ma dal bilancio.
A suo tempo io avevo fortemente dissentito dalla trasformazione del servizio
pubblico in azienda industriale. Ma come professionista ho dovuto adeguarmi a
scelte che non sono mie e che neppure condivido. Luttazzi sembra non capire
tutto ciò. Critica Pio e Amedeo che hanno audience molto importanti. Rivendica
un diritto che allora spetterebbe a tutti i cittadini italiani: andare in
televisione, dire quello che si vuole, portare a casa un lauto compenso.
Serena Danna per open.online il 3 magio 2021. Il
discorso di Fedez, la comicità di Pio e Amedeo, la hit di Checco Zalone: il
critico e autore televisivo, veterano del servizio pubblico, commenta «il
festival della comunicazione» andato in onda nel weekend. Nessuno conosce la
televisione italiana come Carlo Freccero. Il critico e autore televisivo, classe
1947, non è solo l’uomo che ha contribuito a creare la tv privata quando
Fininvest era un’idea, ma è soprattutto un veterano del servizio pubblico. In
quasi 30 anni di carriera ha rivestito diversi ruoli: direttore di rete,
consigliere d’amministrazione, fondatore di Rai 4. Della tv conosce tutti i
meccanismi, censura compresa: era sua la Rai 2 sottoposta al famigerato “editto
bulgaro” di Silvio Berlusconi che portò alla cacciata di Luttazzi, Biagi e
Santoro. Difficile non pensare a lui alla fine di questo weekend in cui il mondo
della spettacolo – dalla nuova hit di Checco Zalone La vacinada alle polemiche
per la trasmissione di Pio e Amedeo su Canale 5 fino all’attacco di Fedez sul
palco del Concertone del Primo maggio – è stato protagonista assoluto. Un
weekend che Freccero definisce «un piccolo festival della comunicazione».
Freccero, di recente non si è mai parlato tanto di
tv e comunicazione come in questo weekend. Che è successo?
«Questo weekend ha dimostrato quanto tutto sia
interconnesso. E così anche la spiegazione esige molti piani – informazione,
politica, intrattenimento – dove il tema della comunicazione diventa centrale».
Partiamo da Pio e Amedeo. Il monologo della
puntata finale di Felicissima sera ha attirato molte polemiche.
«Conosco Pio e Amedeo da anni e li ritengo molto
bravi. Loro attaccano il politicamente corretto e si sono ribellati a un dato di
fatto: sulle reti Mediaset ci sono gay a ogni ora. E loro che sono “trumpiani”,
in quanto eterosessuali bianchi, si ribellano a questa narrativa unica. Non solo
hanno ragione, ma soprattutto dimostrano che Mediaset è libera. Pio e Amedeo
sono solo il contraltare di un onnipresente Tommaso Zorzi (il vincitore del
Grande Fratello, ndr) e dimostrano che a Mediaset puoi dire quello che vuoi. Mi
hanno ricordato il 1979, quando ho iniziato a Canale 5: si poteva dire qualsiasi
cosa, come nel programma Drive In».
Appunto, sembrava una comicità stile Drive in,
inadeguata a rappresentare una nuova sensibilità…
«Ma non è vero! Hanno preso in giro il pubblico di
Mediaset, hanno portato sul palco i cantanti neomelodici che piacciono da morire
al Sud e nelle tv generaliste non hanno spazio, hanno preso in giro tutte le
categorie televisive. Loro sono intelligenti, astuti, e hanno continuamente dato
prova di libertà immensa».
E poi hanno preso in giro categorie fragili in una
maniera percepita come “vecchia”.
«Vecchissima, non vecchia. Ma come è vecchio il
travestimento di un uomo che si veste da donna. Sono modalità vecchie ma –
vissute in un contesto diverso – diventano diverse e nuove. Prenda Achille
Lauro».
E allora come si spiega l’indignazione di molti
cittadini e cittadine?
«I motivi sono due: a criticarli non è il pubblico
che consuma la televisione ma sono quei pochi che leggono i giornali e i
tantissimi dell’universo social. E poi su questi temi scattano le tifoserie e si
perde sempre di vista il senso di tutto».
Solo poche ore prima della trasmissione di Pio e
Amedeo, Checco Zalone ha pubblicato la sua ultima produzione: La vacinada, la
storia di un uomo che si innamora di una donna anziana solo perché vaccinata.
Come mai nessuno si è indignato per frasi come «Y non mi importa se trovo al
mattino il suo sorriso sul mio comodino»?
«Zalone ha fatto un capolavoro di propaganda.
Vaccinarsi ti rendo bravo, bello e sessualmente appetibile anche da vecchio. È
la punta più alta della propaganda sui vaccini, il migliore assist possibile per
Figliuolo».
E poi arriva Fedez.
«E dimostra che la Rai è censurata».
La Rai ha detto che è normale leggere prima i
copioni…
«Ma no, il massimo che capita è che ti chiama il
Comitato di Vigilanza e ti chiede di dare la parola a chi è stato attaccato. I
cantanti non si possono mai controllare. Se lo pensi, vuol dire che non hai mai
fatto tv. Il cantante va per conto suo per definizione. È portatore di un
pensiero, che – al pari della canzone – commuove sull’istante ma non incide.
L’arte è come la satira, non puoi pensare di mettere i paletti».
Da due giorni invece di parlare di Ddl Zan e delle
frasi dei leghisti, il discorso dominante pare essere la Rai.
«Certo, perché Fedez arriva e in pochi minuti ti
mostra la Rai vecchia e da buttare: l’opposto di Instagram, di Tik Tok, e di
tutto quel mondo lì. Fossi stata la vicedirettrice della Rai 3 gli avrei detto:
“Ma le vedi le nostre reti? La vita in diretta, gli opinionisti gay, il Festival
di Sanremo? Siamo costantemente sul tema della fluidità, non puoi non rendertene
conto, non può dire che noi non vogliamo affrontare il tema”. La Rai non è così
vecchia come è apparsa il Primo maggio. Lo stesso non posso dire per la
politica: nel festival della comunicazione andato in onda questo weekend la
politica ufficiale – anzi i valletti della politica – hanno dimostrato tutta la
loro inazione».
I valletti della politica?
«La politica vera è un’altra cosa: è quella che si
decide a Davos oppure nelle stanze di palazzo dove si decide il Recovery Fund».
Fedez ha attaccato anche Draghi perché non si è
espresso sul Ddl Zan.
«Certo che non si è espresso, perché la politica è
altro. Draghi ha fatto solo un errore: è intervenuto sul calcio, ha voluto fare
il politico alla Boris Johnson e ha sbagliato. E sa perché?»
Mi dica.
«Perché è un tifoso: essere romanista è il suo
tallone d’Achille».
A sinistra è in corso il solito “si riparta da
Fedez”.
«Che sinistra è quella che vuole ripartire da uno
che si compra le scarpe da ginnastica con il sangue umano?»
Lei è stato molto vicino al M5S. Giuseppe Conte,
considerato il papabile leader del Movimento, è stato tra i primi a esprimere
solidarietà al cantante.
«Alle persone non frega nulla di quello che Conte
dice su questa storia. E poi, guardi, il Movimento non c’è più. Bisognerebbe
capire cosa hanno conservato del progetto originario. Per me vale solo quello
che ha detto una volta Beppe Grillo: “Se non ci fossimo stati noi, chissà quante
persone sarebbero state in piazza”. La fine dei Cinque stelle è scritta: essere
democristiani e impacchettati bene. Ci siamo».
Dagospia il 2 maggio 2021. Rai: dichiarazione
dell’Ad Fabrizio Salini. In merito all’intervento di Fedez al Concerto del Primo
Maggio, Rai3 ha spiegato di non aver mai censurato Fedez né altri artisti né di
aver chiesto testi per una censura di qualsiasi tipo. Questo deve essere chiaro,
senza equivoci e non accettiamo strumentalizzazioni che possano ledere la
dignità aziendale e dei suoi dipendenti. In questi tre anni ho sempre cercato in
tutti i modi di garantire che in Rai fosse assicurata pluralità di voci e di
opinioni perché ritengo sia il principale obiettivo della mission di Servizio
pubblico. Lo testimonia la nostra programmazione tutti i giorni su tutti i
canali televisivi, in radio e su RaiPlay. Di certo in Rai non esiste e non deve
esistere nessun “sistema” e se qualcuno, parlando in modo non appropriato per
conto e a nome della Rai, ha usato questa parola mi scuso. Su questo assicuro
che sarà fatta luce con gli organizzatori del Concerto, che la Rai acquista e
manda in onda fin dalla sua prima edizione, per capire come sia stato possibile
soltanto ipotizzare un’aberrazione del genere e se esistano delle responsabilità
aziendali. Ringrazio profondamente tutti gli artisti che ieri si sono esibiti
con performance straordinarie studiate appositamente per la Festa del lavoro,
che danno lustro al Servizio Pubblico e ci hanno mostrato in modo evidente
quanto l’arte sia fondamentale per la rinascita del Paese.
Da open.online il 2 maggio 2021. La Rai lo accusa
di aver manipolato ad arte la telefonata in cui dice che l’azienda lo ha
sottoposto alla censura preventiva prima del concerto del Primo Maggio su Rai3,
e Fedez non perde l’occasione per replicare. Con un post pubblicato poco fa su
Instagram, il cantante dice che sarà sua premura mettere «a disposizione il
video integrale agli organi competenti della Rai laddove si decida di fare
chiarezza su quanto accaduto». E affonda il colpo: «Anche se per ora vedo solo
una gran corsa a discolparsi a prescindere da ciò che è successo». Fedez fa poi
riferimento alcuni post apparsi in rete nelle ultime ore. «In questo momento
alcuni leghisti stanno controbattendo riportando un vecchio testo di quando
avevo 19 anni». Il brano cui fanno riferimento è Tutto il contrario, i cui versi
a un certo punto recitano: Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing/Ora
so che ha mangiato più wurstel che crauti/Si era presentato in modo strano con
Cristicchi/”Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?”.
Da vigilanzatv.it il 2 maggio 2021. Giulia
Berdini, fidanzata del Direttore di Rai3 Franco Di Mare, attacca su Instagram il
rapper Fedez per aver "sbugiardato" la Vice Ilaria Capitani sulla telefonata
nella quale invitava il cantante a edulcorare il suo monologo, mettendo nei guai
non solo i vertici della terza Rete ma anche tutta l'azienda pubblica. La
Berdini non le manda a dire e apostrofa Fedez con carinerie tipo: "Nullità del
mainstream", sostenuto da qualche "paraculo occulto", "innocuo come un
omogeneizzato plasmon" che manda messaggi alla "Cetto Laqualunque durante un
comizio in un centro sociale. E ancora, "bisognoso di pubblicità e visibilità".
Invitandolo a far ascoltare la famigerata telefonata in versione integrale,
senza tagliarla a suo comodo e suo piacere, la Berdini conclude con un
"vergognoso" e con l'hashtag "fedeznoncapiscinulla.
Annalisa Grandi per corriere.it il 4 maggio 2021.
Parla di «dichiarazioni gravi e infamanti» il direttore di Rai 3 Franco Di Mare,
convocato in Commissione Vigilanza Rai per la vicenda dell’intervento di Fedez
al Concertone del Primo Maggio. Di Mare, in un post pubblicato sulla sua pagina
ufficiale, scrive: «Le dichiarazioni dell’artista sono gravi e infamanti
parimenti a quanto sono infondate». E poi aggiunge di essere stato appunto
convocato in Commissione Vigilanza dove farà chiarezza su quanto accaduto. Di
Mare fa riferimento alla telefonata intercorsa fra Fedez e i vertici di Rai 3,
esprime «vicinanza e stima professionale» alla vicedirettrice Ilaria Capitani
che interviene nella telefonata e su quanto raccontato da Fedez dice: «Ci si
rende subito conto che nella sua versione ci sono gravi omissioni e che questi
tagli alterano oggettivamente il senso di quanto detto dalla vicedirettrice che
nel colloquio esclude fermamente, ben due volte, ogni intenzione censoria e che
alla domanda esplicita dell’artista se può esprimere considerazioni che lei
reputa inopportune ma lui opportune lei risponde con un netto “assolutamente”.
Ma di questo nella versione di Fedez non c’è traccia alcuna». Insomma, per Di
Mare lo stralcio di telefonata pubblicato dal rapper sarebbe tagliato in modo da
non fornire una versione veritiera dello scambio avvenuto al telefono. E ancor
più chiaramente il direttore di Rai 3 dice: «A me francamente spiace sempre
quando si manipolano conversazioni per far valere le proprie ragioni: che lo
abbia fatto un artista del calibro di Fedez che è anche un riferimento positivo
per tanti giovani mi spiace ancor di più». In difesa di Franco Di Mare era
intervenuta domenica anche la sua fidanzata, Giulia Berdini, che su Instagram in
una storia (che poi scrive essere stata censurata) aveva chiesto a Fedez di far
ascoltare la telefonata integrale «senza tagliarla a tuo comodo e piacere» e
attaccato il rapper definendolo «disgustoso» e «nullità del mainstream», pur
ammettendo però di essere d’accordo con lui nel merito delle affermazioni fatte
sul palco.
Da tvblog.it il 19 maggio
2021. Il “caso” è ormai noto, il rifermento è a Fedez e al Concerto del Primo
Maggio andato in onda su Rai3, con relativo codazzo di polemiche. A margine di
quell’evento musical-televisivo il popolare cantautore denunciò la presunta
censura messa in campo dalla Rai, pubblicando la telefonata intercorsa fra di
lui e gli organizzatori del Concertone qualche ora prima dell’evento ed in cui
intervenne fra gli altri anche la vice direttrice della terza rete Ilaria
Capitani, registrazione poi che è stata successivamente pubblicata nella sua
interezza. In sede di commissione di vigilanza poi il direttore della terza rete
Franco Di Mare spiegò le ragioni della televisione pubblica a proposito della
presunta censura che Fedez denunciò, parlando di una manipolazione dei fatti da
parte dell’artista e respingendo quindi le sue accuse di censura. Nelle scorse
ore lo stesso Fedez ha chiesto di essere sentito dalla Commissione e su questo
il suo Presidente Alberto Barachini ha inviato una lettera al cantante
chiedendogli di fornire all’organismo parlamentare: “ove lo ritenesse opportuno
una memoria in cui siano evidenziati ulteriori fatti o circostanze che abbiano
un elemento di novità rispetto a quanto già reso pubblico fino ad oggi, in modo
da mettere in condizione la Commissione di esprimersi compiutamente in relazione
alla sua richiesta.” Nel frattempo, secondo quanto apprendiamo in queste ore, la
Rai avrebbe dato mandato al suo ufficio legale di avviare querela contro Fedez
per diffamazione aggravata e per grave danno d’immagine a seguito delle vicende
di cui sopra. La querela, secondo le indiscrezioni che abbiamo
raccolto, dovrebbe essere depositata nei prossimi giorni. Per altro, proprio
durante l’audizione in Commissione di Vigilanza è stato consigliato più volte al
direttore della terza rete di procedere a querela a seguito delle sue
affermazioni sulla “manipolazione” operata dallo stesso Fedez alla registrazione
telefonica, la prima pubblicata dal cantautore lombardo. Ma su quello, come
detto dallo stesso dirigente in quella sede, doveva essere la Rai a decidere di
procedere e stando a quanto apprendiamo la decisione da parte dell’azienda
radiotelevisiva pubblica sarebbe arrivata proprio in queste ultime ore. Il caso
Fedez-Rai dunque si arricchisce di nuovi tasselli e sembra davvero molto lontano
dall’essere considerato chiuso.
Concertone primo maggio. La Rai querela
Fedez, il leghista Capitanio: “Show organizzato per un pugno di like”.
Redazione su Il Riformista il 24 Maggio 2021. Dopo le accuse
di censura, la Rai ha deciso di querelare Fedez. “Apprendiamo oggi che ‘la Rai
ha conferito mandato ai propri legali di procedere in sede penale nei confronti
di Federico Leonardo Lucia, in arte ‘Fedez’, in relazione all’illecita
diffusione dei contenuti dell’audio e alla diffamazione aggravata in danno della
società e di una sua dipendente avvenuti in occasione del concerto del primo
maggio’“. E’ quanto annuncia Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e
capogruppo in Vigilanza Rai, in merito alla risposta alla interrogazione in
Vigilanza sulle polemiche legate al concerto del Primo Maggio. Per il deputato
di Matteo Salvini “si tratta di un atto dovuto e doveroso perché su temi
fondanti della nostra democrazia, come la libertà di espressione e il rispetto
della persona, non è possibile scherzare né tantomeno organizzare show per un
pugno di like. Noi speriamo solamente che emerga la verità: non abbiamo sete di
vendetta e ci siamo già dichiarati disponibili ad accogliere la richiesta di
Fedez di venire in audizione in Vigilanza. Quella sera sono state fatte e dette
cose troppo gravi, sarebbe offensivo del nostro ruolo fare finta di niente”.
Fedez aveva lanciato accuse di censura, pubblicando anche l’audio della
telefonata con Ilaria Capitani (vicedirettrice di Rai Tre, ndr), in merito al
testo dell’intervento che aveva preparato in occasione del concertone in
occasione della festa dei lavoratori. Testo in cui attaccava proprio la Lega e,
nello specifico, il presidente della commissione Giustizia del Senato e relatore
del ddl Zan sull’omotransfobia Andrea Ostellari. “Ha deciso che un disegno di
legge di iniziativa parlamentare, quindi massima espressione del popolo, che è
stato già approvato alla Camera come il ddl Zan, può essere tranquillamente
bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo, cioè se stesso. D’altronde,
Ostellari fa parte di uno schieramento politico che negli anni si è distinto per
la sua grande lotta alle diseguaglianze“, aggiunse ironicamente Fedez, elencando
alcune delle frasi che esponenti del Carroccio hanno pubblicamente espresso in
questi anni sul tema dell’omotransfobia, in alcuni casi anche chiedendo scusa.
L’artista ricorda frasi come “se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno”,
“gay vittime di aberrazioni della natura”, “i gay sono una sciagura per la
riproduzione” o “il matrimonio gay porta l’estinzione della razza”. Lo scorso 5
maggio, nel corso dell’audizione davanti alla commissione di vigilanza Rai, il
direttore di Rai 3 Franco Di Mare accusò Fedez di aver “tagliato tutto il
passaggio della telefonata in cui Ilaria Capitani (vicedirettrice di Rai Tre,
ndr) afferma che ‘la Rai non ha assolutamente una censura‘”. Di Mare ribadì che
“la Rai non ha chiesto il testo” dell’intervento di Fedez al Primo Maggio,
quindi “la prima affermazione di Fedez è falsa”. Sarebbe stata “l’organizzazione
dell’evento a chiedere il testo, come previsto dal contratto, è un atto
doveroso”. Organizzazione affidata a una società esterna. “Le scelte editoriali
di chi produce l’evento non competono alla nostra azienda”.
Da "rollingstone.it" il 25 maggio 2021. La Rai ha
conferito mandato ai propri legali di procedere in sede penale nei confronti di
Fedez per avere diffuso illecitamente l’audio della celebre telefonata
intercorsa alla vigilia del concerto del Primo Maggio fra il cantante, i
rappresentanti dell’organizzatore iCompany, la vicedirettrice di Rai 3 e Lillo.
Fedez ha risposto nelle storie di Instagram chiamando «vigliaccheria di Stato»
il comportamento della Rai e aggiungendo un nuovo elemento: non ci sarebbe stata
censura al Primo Maggio perché l’organizzatore del concerto (e di conseguenza la
Rai) sapeva che il cantante aveva registrato la telefonata. «La Rai» ha detto
Massimiliano Capitanio, capogruppo in vigilanza Rai e deputato della Lega citato
dall’Ansa «ha conferito mandato ai propri legali di procedere in sede penale nei
confronti di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, in relazione all’illecita
diffusione dei contenuti dell’audio e alla diffamazione aggravata in danno della
società e di una sua dipendente avvenuti in occasione del concerto del Primo
Maggio». «Si tratta di un atto dovuto e doveroso perché su temi fondanti della
nostra democrazia, come la libertà di espressione e il rispetto della persona,
non è possibile scherzare né tantomeno organizzare show per un pugno di like»,
continua Capitanio. «Noi speriamo solamente che emerga la verità: non abbiamo
sete di vendetta e ci siamo già dichiarati disponibili ad accogliere la
richiesta di Fedez di venire in audizione in Vigilanza. Quella sera sono state
fatte e dette cose troppo gravi, sarebbe offensivo del nostro ruolo fare finta
di niente». Fedez ha risposto nelle storie di Instagram: «Mi assumo la
responsabilità di ciò che ho detto e ho fatto e quindi affronto le conseguenze.
Sapete la differenza fra me e voi, amici della Rai? Io la telefonata l’ho
pubblicata mettendoci la faccia e pagando le conseguenze, mentre voi, dirigenti
della tv di Stato che mi avete registrato a vostra volta, l’avete data ai
giornalisti che devono coprire le loro fonti. Questo non è un illecito
giuridico, ma vi siete parati il culo e questa è vigliaccheria di Stato». Vi
sono infatti due audio della telefonata in cui si è discusso dell’opportunità di
riportare sul palco del Primo Maggio le frasi omofobe di alcuni politici
leghisti. Il primo è stato registrato in video e diffuso su Twitter da Fedez, ma
si tratta di una versione editata dal cantante. Dopo lo scoppio del caso, è
uscita una versione pressoché integrale della telefonata registrata
evidentemente da qualcuno dei suoi interlocutori: si sentono parlare
l’organizzatore e il direttore artistico del concertone, la vicedirettrice di
Rai 3, il comico Lillo. Continua Fedez: «Nonostante abbiate fatto il grandissimo
sforzo di scatenare tutta la stampa a vostro favore per cercare di dire che la
telefonata integrale assume un senso completamente diverso rispetto a quella che
ho publicato io su Twitter, perché su Twitter ci stanno solo due minuti di
video, andate a leggervi i commenti su YouTube di cosa pensa la gente. La
telefonata integrale è pure peggio di quella tagliata. E non ho pubblicato tutto
quello che ho ancora in mano. Speriamo che almeno in commissione vigilanza Rai
mi faranno parlare e dire la mia visto che c’è bisogno del contraddittorio.
Indovinate un po’, per farvi capire come funziona la stampa italiana: la prima
testata che ha pubblicato la telefonata integrale sostenendo che stravolgeva
tutto il significato, indovinate chi ha intervistato subito dopo per pararle il
culo? La vicedirettrice di Rai 3». Secondo Fedez ci sono altre cose da chiarire:
«Come ha fatto la Lega a diramare un comunicato stampa sei ore prima che salissi
sul palco dicendo: se Fedez sale sul palco a leggere il suo testo la Rai non
deve pagare il concertone? E a tutti quelli che dicono “eh però sei salito sul
palco a dire quelle cose”, sì, ma potrebbe essere che dopo quella telefonata io
abbia chiamato l’organizzatore dell’evento e gli abbia detto che avevo
registrato tutto perché mi piace giocare a carte scoperte. E guarda un po’, poco
dopo mi è stato dato il permesso di salire sul palco». Fedez si dice
«orgogliosissimo di quello che ho fatto, lo rifarei altre mille volte. E cari
amici della stampa amica della Rai: non si tratta di farlo per vendere qualche
smaltino in più come fate intendere voi perché io la mia famiglia la mantengo
anche senza gli smaltini. Si tratta di metterci la faccia e pagare le
conseguenze perché io che sono un privilegiato mi posso difendere da voi, ma ci
sono persone a cui voi molto probabilmente avete riservato lo stesso trattamento
che non hanno il privilegio di potersi difendere e che magari davanti a voi
hanno abbassato la testa, hanno piegato la schiena e hanno obbedito alle
schifezze che gli avete proposto». Fedez nota che «a comunicare la querela della
Rai è stato un leghista che ha detto che io avrei detto delle cose gravissime
sul quel palco. Amico Fritz della Lega, le cose che ho detto sono parole di
gente del tuo partito che è ancora lì dentro a far carriera e che intervistata
dopo il Primo Maggio ha ribadito che i gay e i matrimoni omosessuali
porterebbero all’estinzione della razza umana. Ma dove cazzo vivete?». Infine,
riguardo alle «robe abominevoli» dette dal direttore di Rai 3 Franco Di
Mare circa le motivazioni del cantante, Fedez ha aggiunto: «Lo dico come lo
direbbe un leghista in commissione di vigilanza Rai: atto doveroso, denuncerò
per diffamazione il direttore di Rai 3. Iniziamo le danze amici, ci divertiremo
un sacco per i prossimi tre, quattro anni».
Concertone, la Vigilanza Rai dice no
all'audizione di Fedez: "Impropria e inopportuna. Invii una memoria sul caso
Primo Maggio". La Repubblica il 25 maggio 2021.
Respinta la richiesta del rapper di essere udito per esporre la sua versione sui
fatti. Ieri la querela per diffamazione contro il rapper. No all'audizione
di Fedez in Vigilanza, sì ad una memoria del rapper sul caso “Rai-Primo Maggio”.
La commissione parlamentare di Vigilanza Rai non ha votato sulla richiesta di
audizione formulata da Fedez, ma ha deciso, accogliendo all'unanimità la
valutazione del presidente della Commissione vigilanza Rai, Alberto Barachini,
di non audire il rapper poiché si tratta di un'audizione impropria e
inopportuna. Impropria per il ruolo della Commissione ed anche alla luce del
fatto che non vi sono precedenti. Inopportuna per le azioni legali in corso,
intraprese da Rai e annunciate da Fedez sui social. La Commissione, poi,
accogliendo le istanze di chi chiedeva comunque di poter avere la versione
di Fedez, ha deciso di inviare al rapper una nuova richiesta di una sua memoria
sui fatti del Concertone. Intanto, il il caso Fedez è destinato a finire in
tribunale, dopo le polemiche nate con il Concertone del Primo maggio. La Rai ha
deciso la querela per diffamazione contro il rapper per "l'illecita diffusione"
dell'audio della telefonata con i vertici di Rai3 e per diffamazione aggravata
"della società e di una sua dipendente". "Sono orgogliosissimo a maggior ragione
di quello che ho fatto, lo rifarei altre mille volte. Affronto le conseguenze",
la replica di Fedez. Il direttore di Rai3 Franco Di Mare nel suo intervento in
commissione Vigilanza Rai, lo scorso 5 maggio, aveva respinto le accuse rivolte
da Fedez al Servizio Pubblico che, a suo dire, non lo avrebbe lasciato libero di
esprimersi sul palco del Concertone. "Nessuna censura, solo manipolazione dei
fatti che ha ottenuto l'effetto desiderato: quello di gettare discredito sul
servizio pubblico - aveva detto Di Mare - Valutiamo una querela per diffamazione
con richiesta civile di danni considerato che esiste un danno di immagine".
Anche in quel caso la replica di Fedez non si era fatta attendere. E cellulare
alla mano, in una storia su Instagram, aveva ribadito: "Io mi assumo la
responsabilità di ciò che ho detto e ho fatto, sapevo benissimo a cosa sarei
andato incontro. Rifarei 100mila volte quello che ho fatto. Se la Rai mi fa
causa, ho i mezzi per potermi difendere".
Laura Rio per "il Giornale" il 26 maggio 2021. La
Rai querela Fedez. Fedez ribatte col fuoco: «Vigliaccheria di Stato» e annuncia
una contro-querela. Come finirà in tribunale poco importa. Certo è che la
battaglia, rispetto al grande pubblico del web, l' ha già stravinta il rapper. I
suoi milioni di follower hanno già stabilito che nella disputa sul tentativo di
censura al Concertone del Primo Maggio ha ragione lui. Ma, la Tv di Stato, dopo
la figuraccia nazionale e internazionale, non poteva esimersi dal «procedere in
sede penale». Ricordiamo che il cantante aveva accusato i vertici di Raitre e i
produttori dell' evento di aver tentato (senza esserci riusciti) di impedirgli
di leggere sul palco un testo a favore della proposta di legge Zan contro l'
omofobia in cui riportava frasi pronunciate da esponenti leghisti come questa:
«Se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno». Ne è venuto fuori un caso di
Stato, un litigio a colpi di pubblicazione di registrazioni della telefonata
intercorsa tra le parti e un' audizione in Commissione Vigilanza. Infine l'
annuncio della querela, ufficializzata da Massimiliano Capitanio (e chissà
perché non dai vertici Rai in contemporanea), capogruppo della Lega in
Commissione e firmatario di un' interrogazione sulla vicenda, che lo ha definito
«atto dovuto e doveroso». Viale Mazzini ha deciso di «procedere in sede penale»
«in relazione all' illecita diffusione dei contenuti dell' audio» della
telefonata (Fedez ne aveva fatto una sintesi di 2 minuti diventati virali) e
«alla diffamazione aggravata in danno della società e di una sua dipendente»,
nello specifico la vice direttrice di Raitre Ilaria Capitani, responsabile della
serata del Primo Maggio. Appena saputo della querela, Fedez si è scatenato sul
suo profilo Instagram, ribattendo che procederà a querelare per diffamazione il
direttore di Raitre Franco Di Mare che in Commissione aveva parlato di un
«complotto» organizzato per screditare la Rai. Ma, soprattutto, il
cantante-imprenditore e novello paladino dei diritti civili ha fatto capire di
avere altre bombe pronte. «E non ho pubblicato tutto quello che ho ancora in
mano - ha raccontato -. Ci sono tante cose che devono emergere. Ad esempio, come
ha fatto la Lega a diramare un comunicato sei ore prima che io salissi sul palco
dicendo: se Fedez legge il suo testo la Rai non deve pagare il concertone?».
Durissimo con i vertici della tv. «Io la telefonata l' ho pubblicata mettendoci
la faccia e pagando le conseguenze - ha continuato -. Voi che mi avete
registrato a vostra volta, dirigenti della tv di Stato, l' avete data ai
giornalisti che devono coprire le loro fonti. Vi siete parati il culo e questa è
vigliaccheria di Stato ma tanto la gente pensa che la versione integrale sia
peggio di quella tagliata». Insomma, siamo solo alle prime puntate, anzi storie
Instagram della battaglia.
"Fedez manda 3 pagliacci alla Rai, offesa
alle istituzioni". Francesca Galici il 26 Maggio 2021
su Il Giornale. La Rai ha querelato Fedez, che non verrà ascoltato in
commissione Vigilanza. Alla mail con richiesta di memoria, il cantante risponde
con tre emoticon. A quasi un mese di distanza dal concertone del Primo maggio è
tornata in auge la querelle tra Fedez e la Rai. Il motivo è la decisione della
Radiotelevisione italiana di querelare il cantante per "l'illecita diffusione"
tramite social della telefonata intercorsa tra Federico Lucia e alcuni membri
Rai e dell'organizzazione dell'evento. Tra i motivi dell'azione legale anche
l'accusa di diffamazione aggravata "della società e di una sua dipendente". Alla
notizia, Fedez ha risposto con una serie di storie Instagram in cui si dice
orgoglioso di quanto fatto al punto che se potesse tornare indietro lo
rifarebbe. In queste ore, inoltre, la Rai ha deciso di non procedere con
l'audizione di Federico Lucia in commissione di Vigilanza Rai, dove il cantante
aveva chiesto di essere sentito per fornire la sua versione dei fatti. Anche in
questo caso non è mancata la replica di Fedez, ovviamente tramite social.
La decisione della Rai. La commissione
parlamentare di Vigilanza Rai non ha votato sulla richiesta di audizione
formulata da Fedez. È stata una decisione basata sulla valutazione del
presidente Alberto Barachini, che ha trovato l'unanimità di tutti i presenti. La
motivazione per la non audizione del cantante è stata che si sarebbe trattato di
una pratica impropria e inopportuna, dal momento che esiste una causa legale in
corso. Tuttavia, accogliendo le istanze di chi voleva ascoltare le ragioni di
Fedez, è stato chiesto al rapper di inviare una nuova richiesta di memoria sui
fatti del concertone. La risposta di Fedez non si è fatta attendere: "Paura eh!
Questi erano quelli del 'serve un contraddittorio'". Il rapper, quindi, ha
attaccato la Lega: "Il leghista che ieri ha annunciato la querela della Rai nei
miei confronti diceva questo: 'Ci siamo già dichiarati disponibili ad accogliere
la richiesta di Fedez di venire in Vigilanza'". E ha poi aggiunto, per iscritto
sotto il video: "E oggi si rifiutano di ascoltare la mia versione dei fatti in
commissione di Vigilanza Rai. Ne prendo atto. Non credo ci sia nulla da
aggiungere".
La risposta della Commissione. Il "leghista" a cui
fa riferimento Fedez nella sua storia è il capogruppo della Lega nella
bicamerale che vigila sul Servizio Pubblico, Massimiliano Capitanio. L'esponente
del partito di Matteo Salvini all'Adnkronos ha contrattaccato: "Mi spiace che
Fedez non capisca l'italiano o preferisca dedicarsi al genere fantasy piuttosto
che raccontare la verità. La Lega ha dato la disponibilità a riceverlo in
commissione e lo ha ribadito anche ieri sera. Semplicemente in Vigilanza abbiamo
preso atto della sua mancata risposta alla lettera della Vigilanza con la quale
gli si chiedeva una memoria sui fatti del Primo maggio e dell'annunciata querela
nei confronti della Rai che, evidentemente, presuppongono il suo ennesimo cambio
di strategia". Capitanio, quindi, ha aggiunto: "La Lega è nella commissione
parlamentare di Vigilanza a lavorare. Non può mettersi né a fare video su
Instagram né show che lasciamo a lui. La richiesta di una memoria, già resa nota
al rapper con una lettera del presidente e reiterata ieri all'unanimità dalla
Commissione, non mi pare abbia avuto risposta. Forse non è raccontare la sua
versione che gli sta a cuore. Lo chiediamo a lui. Noi siamo pronti a leggere
quanto vorrà inviarci, se lo farà".
I "pagliacci" di Fedez. Il rapper non sembra
intenzionato a inviare la sua memoria difensiva. Infatti, questa mattina il
presidente della commissione Vigilanza Rai ha ricevuto mail con tre emoticon a
forma di pagliaccio in risposta alla mail con la richiesta della bicamerale.
Alberto Barachini ha informato i commissari durante le audizioni in corso
commentando così: "La commissione parlamentare di Vigilanza ha rispettato Fedez,
mentre lui non rispetta istituzioni. Sono amareggiato". Il presidente ha
commentato nel merito: "Questa mattina ho inviato al dott. Fedez una lettera con
la quale ho rinnovato l'invito a trasmettere alla Commissione di Vigilanza una
memoria, nella forma che reputa più appropriata, al fine di illustrare le sue
ragioni sulla vicenda del Concerto del primo maggio". Barachini, quindi, ha
spiegato che "con la medesima lettera ho altresì comunicato al dott. Fedez la
decisione, adottata all'unanimità dalla Commissione nella seduta di ieri sera,
di non procedere alla sua audizione, in considerazione del quadro normativo e
regolamentare che disciplina l'attività e la sfera di competenza dell'organismo
da me presieduto, nonchè di motivi di opportunità, per la recente scelta della
Rai e dello stesso Fedez di adire le vie legali". In conclusione, il presidente
della Vigilanza sottolinea: "Io e la Commissione che presiedo abbiamo, pertanto,
rispettato il dott. Fedez e tutelato la sua posizione. La sua risposta - tre
emoticon di clown - denota, invece, una mancanza di rispetto dell'istituzione
parlamentare e della Commissione che mi onoro di presiedere. Di questo sono
amareggiato". Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, informato sulla
mail di Fedez, ha commentato così: "Forse i tre pagliacci di Fedez non erano un
oltraggio al Parlamento ma la sua firma". Una battuta alla quale, però, ha fatto
seguito una più seria richiesta ad Alberto Barachini di "procedere con una
censura ufficiale a un simile atteggiamento di mancanza di rispetto nei
confronti del Parlamento, in quanto la Vigilanza è una commissione bicamerale e
rappresenta il Parlamento, e presenteremo degli atti relativi, perché questo è
un oltraggio". Dura anche la replica di Valeria Fedeli, capogruppo Pd in
commissione di Vigilanza Rai: "Fedez è libero di esprimere il suo pensiero e la
sua opinione ma irridere e offendere un'istituzione è una mancanza di rispetto
non tanto e non solo verso noi commissari e commissarie ma verso le cittadine e
i cittadini che le istituzioni rappresentano".
Marco Zonetti
per vigilanzatv.it il 30 settembre 2021. Dopo aver ingoiato il rospo di Mauro
Corona, reintegrato con tutti gli onori a #Cartabianca dalla quale lo aveva
cacciato, Il Direttore di Rai3 Franco Di Mare ora deve anche pagare l'onta di
veder invitato Fedez a Che tempo che fa, in onda domenica prossima sulla Terza
Rete. Avevamo infatti lasciato Fedez e Di Mare ai ferri corti per il discorso
senza freni del rapper al Concerto del Primo Maggio e per l'accusa del marito di
Chiara Ferragni alla Rai di averlo voluto censurare. Era seguita una querela
della Tv di Stato a Fedez, querela che stride per l'appunto con l'ospitata di
domenica prossima a Che tempo che fa. Striscia la Notizia, intanto, tramite
l'inviato Valerio Staffelli, ha consegnato il terzo Tapiro d'Oro a Di Mare -
come si vedrà questa sera, 30 settembre 2021 a partire dalle 20.35 su Canale5 -
proprio per il grande ritorno sulla Terza Rete dei due suoi nemici Corona e
Fedez. «Lei ha cacciato Corona e poi se l’è ritrovato in prima serata con lo
smoking?» ha domandato Staffelli a Di Mare, che ha risposto: «È stata la Rai a
farlo. Ha deciso l’azienda e io sono d’accordo con l’azienda». «E Fedez? Aveva
promesso fuoco e fiamme, invece domenica sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo
che fa», lo incalza Staffelli. «Io non censuro nessuno. Fazio mi ha chiesto di
Fedez e io ho risposto “Non c’è problema”» è la replica del Direttore di Rai3
prima di fuggire sulla sua auto - parcheggiata per giunta in divieto di sosta.
Se Striscia ipotizza che la querela a Fedez sia stata ritirata per "paura dei
Ferragnez" e del loro potere mediatico, noi di VigilanzaTv rammentiamo
l'intervista rilasciataci in esclusiva dal Segretario della Commissione di
Vigilanza Rai Michele Anzaldi nella quale riguardo alla veridicità della notizia
del procedimento legale della Rai contro il cantante, avanzava il dubbio che
esso "potesse essere un espediente comunicativo per mettere a tacere le
polemiche sul Primo Maggio e soprattutto bloccare tout court i lavori della
Vigilanza Rai che aveva chiesto l'audizione di Fedez".
Marco Zonetti per “vigilanzatv.it” l'1 ottobre
2021. Dopo la notizia dell'ospitata di Fedez da Fabio Fazio su Rai3, ricordata
da un servizio di Striscia la Notizia con la consegna del Tapiro d'Oro al
Direttore Franco Di Mare che aveva annunciato mesi fa la querela al rapper per
diffamazione dopo il caso del Concerto del Primo Maggio, ci eravamo chiesti
assieme a Dagospia se il procedimento giudiziario fosse stato ritirato o,
addirittura, non fosse mai esistito. Ed ecco che Viale Mazzini chiarisce il
nostro dubbio rivelando all'Adnkronos di aver deciso di "non procedere nei
confronti del rapper Fedez in relazione ai fatti del Concertone del Primo Maggio
e all'accusa di censura". Ma c'è di più: "secondo quanto riferiscono fonti
qualificate la decisione, presa dai precedenti vertici, non ha avuto seguito per
mancanza di alcuni requisiti". Questo sarebbe il motivo per cui Fedez potrà
presenziare a Che tempo che fa domenica prossima 3 ottobre 2021. La notizia
della querela mancante di alcuni requisiti non meglio identificati, tuttavia,
non scaccia il sospetto dell'On. Michele Anzaldi, Segretario della Vigilanza
Rai, che a VigilanzaTv esprimeva il dubbio che la querela fosse un espediente
per bloccare l'audizione di Fedez in Commissione. Ricordiamo anche la furiosa
lite - segnalata da VigilanzaTv e Dagospia - tra Di Mare e l'ex Ad Rai Fabrizio
Salini che non voleva procedere con la querela. Una diatriba tutta interna al
M5s, del quale è a tutt'oggi in quota Di Mare, era in quota Salini e in omaggio
al quale Fedez scrisse addirittura un inno. Non sussistendo più la querela, ora
Fedez sarà finalmente audito in Commissione per chiarire cosa accadde nelle ore
precedenti al Concerto del Primo Maggio? E quali sono esattamente i "requisiti
mancanti" che hanno di fatto invalidato l'azione legale contro Fedez? Sarebbe
interessante saperlo.
Marco Zonetti
per vigilanzatv.it il 13 ottobre 2021. Ci è voluta l'audizione in Commissione di
Vigilanza dell'Amministratore Delegato Rai Carlo Fuortes (qui il video
integrale) per apprendere candidamente dalla bocca di quest'ultimo che la
querela al rapper Fedez dopo i fatti del Concerto del Primo Maggio da Viale
Mazzini non è mai partita. E questo malgrado altisonanti comunicati stampa che
vedevano la Tv di Stato, su trazione del Direttore di Rai3 Franco Di Mare,
scagliarsi lancia in resta contro il rapper reo di aver diffamato l'azienda
pubblicando per la gioia dei suoi milioni di follower la famigerata telefonata
intercorsa con la Vicedirettrice Ilaria Capitani, l'autore Massimo Cinque e il
direttore artistico del Concertone Massimo Bonelli, e gridando alla censura del
suo discorso sul Ddl Zan condito di attacchi alla Lega. Discorso poi pronunciato
integralmente sul palco di Piazza San Giovanni a Roma, scatenando le ire di Di
Mare e guadagnandosi una querela... anzi no. Ma vediamo tutte le tappe
dell'intricata vicenda.
1 maggio 2021: al Concertone
Fedez pronuncia il discorso a favore del DDl Zan puntando il dito contro alcuni
esponenti leghisti e ripetendone le dichiarazioni "contrarie all'uguaglianza".
Non prima di aver divulgato sui suoi profili social la telefonata con Capitani,
Cinque e Bonelli tacciando la Rai di tentativo di "censura". Telefonata di
cui VigilanzaTv e Dagospia vengono a sapere anzitempo quel pomeriggio,
scatenando preventivamente il clamore mediatico e istituzionale.
5 maggio 2021: Durante
l'audizione di Franco Di Mare in Commissione di Vigilanza Rai, il Direttore di
Rai3 attacca il rapper accusandolo di "manipolazione dei fatti" e di aver
provocato un "danno gigantesco" alla Rai, accennando al fatto che a Viale
Mazzini si sta valutando "querela per diffamazione" con richiesta di indennizzi
in sede civile. Durante l'audizione di Di Mare, alcuni commissari chiedono che
Fedez sia ascoltato a sua volta in Vigilanza. Nei giorni successivi la vicenda
viene trattata, fra gli altri, da Pinuccio per Rai Scoglio 24 a Striscia la
Notizia, diventando un autentico caso mediatico.
7 maggio
2021: VigilanzaTv apprende di una lite infuocata tra il Direttore di Rai3 Di
Mare e l'allora Ad Fabrizio Salini che vede il primo intenzionato a querelare il
rapper, e il secondo invece proclive a lasciar perdere. Uno scontro tutto in
casa pentastellata: Di Mare e Salini sono in quota grillina, e Fedez per il M5s
ha scritto addirittura un inno.
18 maggio 2021: Fedez chiede
di essere audito in Commissione di Vigilanza Rai per spiegare la sua versione
dei fatti su quanto avvenuto prima del Concertone.
25 maggio 2021: l'Onorevole
Massimiliano Capitanio (Lega) annuncia all'Adnkronos di aver appreso che "la
Rai ha conferito mandato ai propri legali di procedere in sede penale nei
confronti di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, in relazione all'illecita
diffusione dei contenuti dell'audio e alla diffamazione aggravata in danno della
società e di una sua dipendente (Ilaria Capitani ndr) in occasione del concerto
del Primo Maggio". Appreso della querela, la Commissione di Vigilanza annulla la
sua audizione con il rapper per inopportunità e lo annuncia al diretto
interessato che risponde sbeffeggiandola con tre emoticon di pagliacci, e
commentando: "Paura, eh?".
8 luglio 2021: si ventila
l'ipotesi che a condurre l'Eurovision sia Chiara Ferragni, moglie di Fedez, e il
Segretario della Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi (Iv) solleva il
caso di inopportunità (visto il procedimento giudiziario che la Rai dovrebbe
aver mosso contro il rapper) confidandoci tuttavia il suo sospetto che la
querela non sia mai esistita e che l'annuncio sia servito solo come espediente
per impedire che la Vigilanza audisse Fedez.
30 settembre 2021: Striscia la
Notizia consegna il Tapiro d'Oro a Franco Di Mare dopo aver appreso che, di lì a
qualche giorno, Fedez sarà ospite di Fabio Fazio proprio su
Rai3. VigilanzaTv e Dagospia si domandano se la querela sia stata ritirata o se,
in realtà, non vi sia mai stata.
1 ottobre 2021: la Rai fa
sapere all'Adnkronos di aver deciso di "non procedere nei confronti del rapper
Fedez in relazione ai fatti del Concertone del Primo Maggio e dell'accusa di
censura". E inoltre: "secondo fonti qualificate la decisione presa dai
precedenti vertici non ha avuto seguito per mancanza di alcuni requisiti". Quali
siano tali requisiti non viene specificato, e la frase sibillina di Viale
Mazzini lascia intendere che la querela a un certo punto sia effettivamente
partita ma che non abbia avuto per l'appunto seguito.
12 ottobre 2021: Durante
l'audizione in Commissione di Vigilanza Rai, il nuovo Ad Carlo Fuortes confessa
candidamente che la querela a Fedez non c'è mai stata, confermando così
l'ipotesi del Segretario della Commissione di Vigilanza Rai.
Per quale motivo, allora,
Viale Mazzini ha lasciato credere per mesi che il rapper fosse stato querelato?
E quest'ultimo sapeva che l'azione giudiziaria nei suoi confronti non era mai
partita quando ha accettato di andare ospite da Fazio? Insomma, più che un
giallo, una tragicommedia che mette in ridicolo la Rai - che fin dall'inizio con
Fedez non ha fatto una gran bella figura - e anche la Commissione di Vigilanza -
ovvero il Parlamento - finita sbeffeggiata suo malgrado.
La strana farsa Rai-Fedez:
dalle censure al tappeto rosso.
Luigi Mascheroni il 3 Ottobre
2021 su Il Giornale. Fino a ieri tra la tv di Stato e il rapper volavano sfottò
e querele. E stasera Mr. Ferragni è super ospite di Fazio...Gli influencer sono
i nuovi interlocutori della politica, la politica si fa sempre più influenzare
dallo spettacolo, la televisione è bravissima a fare della politica uno
spettacolo, e viceversa, così tutto finisce in uno show. O al circo. Infatti,
abbiamo a che fare coi pagliacci. Tutto è bene quel che finisce bene: la Rai ha
improvvisamente rinunciato a fare causa a Fedez dopo le accuse di tentata
censura lanciate dal cantante sul palco del Concertone del Primo Maggio, e Fabio
Fazio stranamente stasera lo ha invitato come ospite d'onore della prima puntata
- si comincia sempre dal meglio - della sua trasmissione Che tempo che fa. Che è
un po' come se io e te litighiamo ferocemente per sei mesi, io ti accuso di un
reato pesantissimo in diretta televisiva e via social, tu contro-minacci di
querelarmi per diffamazione, poi tutti e due ci ripensiamo, meglio far finta di
niente, capiamo che entrambi ci guadagniamo se lasciamo perdere una cosa inutile
come la dignità, e alla fine io rinuncio ad andare per vie legali tu agli sfottò
e ti invito una sera a casa mia, per una chiacchierata in salotto. E il bello è
che tu accetti di corsa: «Sì, vengo!». Se a qualcuno avanza un naso rosso con
l'elastichino da prestare a Fedez, scrivetemi in privato. E così il Mr. Ferragni
torna a grande richiesta - di chi? - sugli schermi di Viale Mazzini, stasera,
stessa rete - Rai3 - infamata il Primo di neppure tanti mesi fa: era Maggio. Non
si sa che tempo farà, ma scorre veloce. Fabio Fazio di qui e Fedez di qua.
Chissà se il padrone di casa intervisterà l'ospite, o se l'ospite trasformerà in
un comizio l'invito. Del resto entrambi cercano sempre il contraddittorio...
Finiranno col parlare di politica - è il posto giusto - o punzecchiare il
direttore di Rai3, Franco Di Mare, il quale a Fedez ha dato del «manipolatore» e
a Fazio la solita trasmissione... Cose che succedono.
Ma perché è successo? È
successo semplicemente perché Fabio Fazio pur di portarsi in studio un
influencer con la sua legione di follower (più quelli della moglie), che
significano punti di share, è pronto a passare sopra anche alle offese alla
propria famiglia, che di cognome fa Rai. E Fedez perché pur di presentare un suo
prodotto al grande pubblico della tivù (si esibirà con Achille Lauro e Orietta
Berti sulle note del tormentone estivo Mille) fa finta di dimenticarsi con chi
si è preso a pesci in faccia fino a ieri. Pensavo Fosse Amore E invece feat
Fabio Fazio #èsoloBusiness... Forse ci va bene: stasera magari ci fanno pure la
morale. La Rai liscia il pelo agli influencer - meglio averli dalla propria
parte che contro, con quello che pesano i post - e gli influencer, che tutto
sommato è meglio che fare il rapper, lisciano il pelo alla Rai, che resta sempre
un bel palcoscenico: buttalo via. #SenzaPagare
Alla fine tutta questa storia
- Tu mi hai censurato, no non è vero, Io ti querelo, tu hai manipolato i fatti,
Dài ma vieni in trasmissione, Sì va bene, grazie Mille - è Meglio del cinema.
Comico. Il vantaggio è che, come il nuovo pezzo dedicato da Fedez alla moglie,
una ballatina pop innocua, ha un grande pregio. Si dimenticherà in fretta. Su
Rai3, si sa, si è tutti amici.
Luigi Mascheroni lavora al
Giornale dal 2001, dopo aver scritto per le pagine culturali del Sole24Ore e del
Foglio. Si occupa di cultura, costume e spettacoli. Insegna Teoria e tecniche
dell'informazione culturale all’Università Cattolica di Milano. Tra i suoi
libri, il dizionario sui luoghi comuni dei salotti intellettuali "Manuale della
cultura italiana" (Excelsior 1881, 2010); "Elogio del plagio. Storia, tra
scandali e processi, della sottile arte di copiare da Marziale al web" (Ara
"Fedez? È stato un
agguato”. Quell'accusa a Travaglio e Gomez.
Francesca Galici il 5 Maggio 2021 su Il Giornale. Franco Di Mare verrà
ascoltato in Commissione Vigilanza per fare luce e chiarezza sulla telefonata
tra Fedez e la Rai prima del Concertone. Oggi si scriverà una pagina importante
nella querelle tra la Rai e Fedez con il colloquio di Franco Di Mare in
Commissione di vigilanza Rai. Il direttore di Rai3 verrà ascoltato in merito
alla telefonata intercorsa tra il suo vicedirettore Ilaria Capitani e il rapper
il giorno prima del Concertone del Primo maggio. Sono tanti i dubbi che
aleggiano attorno a quella telefonata sulla quale ora la Rai vuole fare
chiarezza, anche se Franco Di Mare pare abbia una sua teoria precisa sulle
dinamiche che si sono sviluppate sulla vicenda, che ha a che fare con le
prossime nomine nel Cda della tivvù pubblica.
La telefonata a Fedez. Su
quella telefonata si è detto tanto. Il primo a renderla nota è stato Fedez, che
sui social ha però pubblicato solo un estratto di nemmeno 3 minuti. Un taglia e
cuci creato a suo uso e consumo, dove erano assenti moltissimi passaggi chiave
per capire l'atteggiamento della Rai. Poco meno di 24 ore dopo, infatti, è stata
diffusa la telefonata quasi integrale e la versione di Fedez è stata smentita
dai fatti. "È stato un agguato", ripete oggi Franco Di Mare stando a quanto
riporta la Repubblica. Il quotidiano spiega che la linea del direttore di Rai 3
non sarà solo quella di difesa dell'operato di Ilaria Capitani e degli altri
interlocutori che si rapportano con Fedez nel corso della chiamata. Di Mare pare
sia pronto anche a muovere accuse ben precise, puntando il dito proprio contro
il rapper, che avrebbe registrato la telefonata all'insaputa di tutti per poi
diffonderla con i tagli già citati. Per Di Mare questa altro non era che una
trappola, "orchestrata, secondo lui, con l'ausilio di Marco Travaglio e Peter
Gomez", scrive Repubblica. Non due nomi a caso, perché è stato lo stesso
cantante a menzionare i due giornalisti durante la telefonata, parlando del
testo che avrebbe letto sul palco del Concertone: "Io ho fatto leggere questo
testo ai miei amici giornalisti: a Peter Gomez, a Marco Travaglio, al direttore
di Repubblica. Nessuno ha notato nella sintassi, nella struttura di questo testo
cose che vertono a qualcosa di sgradevole, perché riporto solo fatti".
I dubbi della Rai. Dal canto
suo la Vigilanza Rai ha molti nodi da sciogliere sulla questione prima di
decidere se procedere legalmente contro Fedez. Come rivela Il Tempo, infatti, è
necessario capire alcuni passaggio tutt'ora poco chiari sulla dinamica di quella
telefonata. Tra i primi quesiti che verranno posti c'è quello basilare: chi ha
chiesto di chiamare Fedez? Perché non ci si è rapportati con il suo manager? I
maggiori vertici Rai erano al corrente di quanto stava accadendo? Franco Di Mare
nelle scorse ore si è già espresso in merito alla telefonata con un post molto
duro pubblicato su Facebook. Ora dovrà chiarirsi con la Vigilanza Rai per dare
chiarezza al pubblico di rete e levare dalla tivvù pubblica l'onta di un'accusa
di cenura.
Caso Fedez in Rai, Di Mare:
"Calcolo dell'artista per ottenere più like, visualizzazioni e consensi".
Francesca Galici il
5 Maggio 2021 su Il Giornale. Franco Di Mare è stato ascoltato in Commissione di
Vigilanza Rai in merito al caso Fedez e ha esposto la sua ricostruzione su
quanto accaduto al Concertone. Come previsto, Franco Di Mare quest'oggi è stato
ascoltato dalla Commissione di Vigilanza Rai in merito alla querelle con il
cantante Fedez per quanto accaduto nelle ore precedenti la sua salita sul palco.
Al centro di tutto la telefonata intercorsa tra Fedez da una parte e un autore,
l'organizzatore e il vicepresidente Rai dall'altra parte, con la partecipazione
iniziale dell'attore Lillo, conduttore dell'evento per la Rai. L'accusa per la
Rai è stata di censura nei confronti di Fedez, che si sarebbe sentito limitato
nella sua libertà di espressione in quanto artista.
"Nessuna censura dalla Rai".
"Nessuna censura, solo manipolazione dei fatti che ha ottenuto l'effetto
desiderato: quello di gettare discredito sul servizio pubblico", ha detto Franco
Di Mare in Commissione, come riporta la Repubblica, spegando dal suo punto di
vista cosa è accaduto in quelle ore concitate del 30 aprile. Franco Di Mare è
sicuro del buon lavoro svolto dai suoi collaboratori e considera strumentale la
polemica montata da Fedez contro la Rai: "Si tratta di una polemica basata
sulla manipolazione dei fatti, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni
dell'autore l'esistenza di una censura che non c'è mai stata. La Rai non ha
chiesto il testo di Fedez, quello che lui dice è falso. La Rai era all'oscuro,
lo ha fatto iCompany". La compagnia citata da Franco Di Mare è quella
responsabile dell'organizzazione dell'evento, venduto poi alla Rai. Il direttore
di Rai3 è ben consapevole dei danni d'immagine causati all'azienda da questa
vicenda: "La Rai è stata crocifissa e condannata prima ancora che Fedez salisse
sul palco. Possiamo rimediare? Mi auguro di sì, ma il danno è gigantesco. La Rai
e Ilaria Capitani si aspettano delle scuse che non arriveranno mai, io temo".
Franco Di Mare, quindi, è entrato nello specifico, spiegando che essendo un
prodotto esterno del quale la Rai acquista solo il diritto di ripresa, "le
scelte editoriali di chi produce l'evento non competono alla nostra azienda".
Pertanto, il direttore ha ribadito: "La Rai non ha chiesto niente. Dunque la
prima affermazione di Fedez, che afferma che la Rai avrebbe chiesto il testo,
non è vera. Il testo è stato chiesto dall'agenzia che organizza l'evento". Posta
questa premessa, Di Mare evidenzia che ogni valutazione sul contenuto "è
demandata alla produzione perché è scritto nel contratto". Si tratta di una
prassi che "si configura nella responsabilità di chi organizza l'evento: è un
atto doveroso".
"Fedez ha fatto un calcolo".
Nel merito della telefonata, Franco Di Mare non crede alla buona fede del
cantante ma non vuole esprimersi in merito a un eventuale complotto: "Non sono
complottista. Forse c'è stato un calcolo dell'artista per ottenere più like,
visualizzazioni e consensi". In audizione, Franco Di Mare ha chiarito anche la
frase di Ilaria Capitani, che si può ascoltare nella telefonata integrale, nella
quale la vicedirettrice parla di contesto inopportuno: "L'artista afferma 'che
il servizio pubblico ha il potere di censurare chi volete'. Un'affermazione
inaccettabile: la dottoressa Capitani ha dunque chiarito la posizione
dell'azienda che viene chiamata in causa in maniera diffamante".
Di Mare, da Fedez
manipolazione fatti, nessuna censura.
(ANSA il 5 maggio 2021) "Si
tratta di una polemica basata sulla manipolazione dei fatti, che avrebbe dovuto
dimostrare nelle intenzioni dell'autore l'esistenza di una censura che non c'è
mai stata". Così il direttore di Rai3, Franco Di Mare, in audizione in
Commissione di Vigilanza sul caso Fedez.
Franco Di Mare svela la porcheria di
Fedez: "Ha manipolato quella telefonata". Libero
Quotidiano il 05 agosto 2021. Franco Di Mare non ha perdonato la "gallina" data
da Mauro Corona a Bianca Berlinguer. E così il direttore di Rai 3 ha deciso di
tenere ancora una volta fuori l'alpinista da CartaBianca, il programma che lo ha
visto ospite fisso nelle stagioni passate. "Non lo ha deciso Di Mare, ma è una
scelta aziendale che condivido", ha comunque tenuto a precisare nel corso di
un'intervista a Repubblica. Togliendosi qualche sassolino dalla scarpa Di Mare
ha preso la palla al balzo per soffermarsi su un altro caso spinoso: la polemica
innescata da Fedez. Il rapper, durante il concerto del Primo Maggio, ha puntato
il dito contro la Rai accusandola di "censura" e scatenando il putiferio. "La
storia del Primo maggio mi ha amareggiato - ha ammesso -. Al netto del fatto che
il signor Federico Lucia ha manipolato una registrazione telefonica, mi ha
lasciato interdetto la reazione delle forze politiche che hanno inseguito una
manipolazione. Eravamo di fronte alla fake news che Rai 3 avrebbe censurato un
cantante, una follia". CartaBianca tornerà il 7 di settembre e le sorti di
Corona ormai sono chiare nonostante i continui tentativi da parte dello
scrittore e della conduttrice di tornare insieme in tv. In alternativa Corona
potrebbe affiancare Paolo Del Debbio, come ospite in collegamento. Proprio il
conduttore di Rete Quattro, alla chiusura di stagione di Dritto e Rovescio,
aveva detto di voler prenotare Corona per la successiva edizione. Invito che
però il diretto interessato aveva preso con le pinze nella speranza di tornare a
Viale Mazzini. "Paolo, vieni su che ne parliamo. Domani incontro Bianchina a
Vicenza, vediamo che dice", era stata la vaga risposta di Corona. Ma adesso il
quadro, dopo il "no" di Di Mare a un suo ritorno, potrebbe essere cambiato.
Di Mare, Rai crocifissa sul
caso Fedez, si aspetta scuse.
(ANSA il 5 maggio 2021) "La
Rai è stata crocifissa e condannata prima ancora che Fedez salisse sul palco.
Possiamo rimediare? Mi auguro di sì, ma il danno è gigantesco. La Rai e Ilaria
Capitani si aspettano delle scuse che non arriveranno mai, io temo". Così il
direttore di Rai3, Franco Di Mare, in audizione in Commissione di Vigilanza. "La
Rai, nel caso del Primo Maggio, fa un acquisto di ripresa per un evento e non ha
alcuna responsabilità diretta su quanto avviene in quel luogo. Le scelte
editoriali di chi produce l'evento non competono alla nostra azienda. I temi da
veicolare sono di esclusiva pertinenza degli organizzatori che decidono il tono
da dare alla serata e lo comunicano alla Rai". Così il direttore di Rai3, Franco
Di Mare, in audizione in Commissione di Vigilanza sul caso Fedez.
Antonella Baccaro per il “Corriere della Sera” il
6 maggio 2021. Rischia di finire in Procura, con tanto di richiesta di
risarcimento danni in sede civile, lo scontro tra Fedez e la Rai sulla
manifestazione del Primo Maggio. È quanto hanno chiesto molti parlamentari ieri,
sia pure con toni diversi, dopo aver ascoltato in commissione di Vigilanza Rai,
il duro atto di accusa del direttore di Rai3, Franco Di Mare, contro il rapper.
A Fedez, il direttore ha addebitato di aver «manipolato» la telefonata
intercorsa tra lui e la società iCompany, organizzatrice del concerto, cui ha
preso parte anche la vicedirettrice di Rai3, Ilaria Capitani. Franco Di Mare ha
esposto quali brani della telefonata sarebbero stati omessi dal rapper
volutamente, brani nei quali Capitani diceva che la Rai non aveva intenzione di
censurare ma che considerava solo inopportuni alcuni passaggi dello speech . La
tesi di Di Mare è che la Rai ha solo acquistato un diritto di ripresa. Per
questo non ha mai chiesto a Fedez di conoscere alcun testo in anticipo perché i
responsabili per contratto dei contenuti della manifestazione sono la iCompany e
i sindacati. Proprio da questi soggetti sarebbe stata inviata un'email, la sera
prima del concerto, a Capitani per avvisarla che il discorso di Fedez, di cui
avevano preso visione, era «duro, polemico, gratuito, soprattutto non in linea
con il messaggio del concerto». Capitani avrebbe risposto che in effetti quella
del rapper era «un'invettiva senza contradditorio» e fuori contesto rispetto al
tema della manifestazione, tuttavia «non sono di nostra competenza nè la scelta
né la responsabilità» di quei contenuti. «Noi, Rai, veniamo crocifissi e
condannati prima ancora che Fedez salga sul palco» ha detto Di Mare. E ancora:
«Siamo finiti sui siti internazionali, perfino a Singapore - ha proseguito -: è
un imbroglio, una manipolazione», ha commentato, aggiungendo che «in alcuni
Paesi la manipolazione è un reato penale». Il direttore ha detto di aspettarsi
delle scuse alla Rai che probabilmente non arriveranno. Infine, più in generale,
ha lamentato che «le indicazioni che ci arrivano dalla politica sono spesso
contraddittorie: ci viene chiesto conto delle scelte editoriali. Non sostengo
che la verifica non sia necessaria, ma un eccesso di interventi può diventare un
impedimento allo svolgimento del nostro lavoro». Il dibattito che è seguito è
stato per certi versi sorprendente. Quasi la totalità dei partiti intervenuti
nel dibattito hanno chiesto che della presunta manipolazione si occupi la
Procura. I toni però sono stati molto diversi: la capogruppo del Pd, Valeria
Fedeli, ha attaccato il direttore e difeso la congruità del discorso di Fedez
rispetto ai temi della manifestazione. E ha sfidato Di Mare ad andare in Procura
se davvero ce ne sono gli estremi. Primo Di Nicola (M5S) invece ha difeso Di
Mare, dicendosi d'accordo sull'andare in Procura, ma sottolineando che
manifestazioni della portata del Primo Maggio non vanno appaltate all'esterno.
Considerazione questa condivisa dal presidente Alberto Barachini. Andrea
Ruggieri di FI ha rivendicato alla Rai il diritto di controllare il contenuto di
quanto mandato in onda e ha consigliato una causa civile per danni contro Fedez.
Quanto al leghista Massimiliano Capitanio, ha detto di apprezzare «che, dopo
l'iniziale timore, la Rai ha avuto il coraggio di chiamare l'operazione di Fedez
per quello che è stato: un imbroglio. Proceda con le dovute azioni legali». Il
rapper replica su Instagram: «Io una causa civile me la posso permettere, ma
quanti in Rai non possono farlo e subiscono?». Infine Davide Faraone di Italia
Viva: «Di Mare accusa Fedez di ciò che Report ha fatto con Renzi: è la stessa
sorte che ha subito Renzi che ha risposto per oltre un'ora alle domande di
Report . Eppure quello che è andato in onda è stato manipolato e
strumentalizzato». Pronta la replica di Di Mare che ha difeso la decisione di
trasmettere le immagini dell'incontro tra Renzi e l'agente dei servizi segreti
Marco Mancini: «Non c'è un colpo basso, né una malevola interpretazione. Credo
che fosse giusto mettere in onda quell'incontro».
Striscia la Notizia, il sospetto su Rai e
concertone del Primo Maggio: "Perché si affida a una società esterna?". Quanto è
costato. Libero Quotidiano il 07 maggio 2021. Striscia
la Notizia, attraverso l'inviato Pinuccio, torna a occuparsi del concertone del
Primo Maggio trasmesso dalla Rai. Dopo l'udienza del direttore di Rai Tre Franco
Di Mare in Commissione di vigilanza, infatti, viene da chiedersi come mai la tv
di Stato si affidi a una società esterna per l'organizzazione dell'evento, con
notevoli costi per l'azienda. Quando in Vigilanza è stato chiesto a Di Mare il
costo del concertone, lui ha risposto così: "Dieci anni fa la cifra complessiva
dell’acquisizione dei diritti di ripresa del concertone del Primo Maggio era di
molto superiore rispetto a quella attualmente pagata, possiamo dire che era
quasi il doppio. Mentre invece a 10 anni di distanza si è dimezzata. Con una
scrematura di un altro 25 per cento negli ultimi tre anni". Poi però
l'onorevole Massimiliano Capitanio, segretario della commissione vigilanza Rai,
gli ha posto la domanda in maniera più diretta: "Ma conosce le cifre?". A quel
punto il direttore di Rai Tre ha replicato: "No, mi sono state fornite queste
indicazioni che le sto dando". Intervistato da Striscia, allora, Capitanio ha
commentato: "Era una domanda semplice. La cifra la sanno tutti e la sapeva anche
il direttore Franco Di Mare. Era tra i 500 e i 600mila euro. Come lo sapevano
tutti i membri della vigilanza, sicuramente lo sapeva anche il direttore".
Parlando della riduzione dei costi, invece, Capitanio ha sottolineato: "Se c’è
stata una diminuzione di costi quest’anno rispetto alle edizioni precedenti non
è stato sicuramente per un’opera di spending review da parte dell’azienda, ma
semplicemente perché il concerto al chiuso ha comportato un costo minore".
Infine un appello: "Non capiamo perché la Rai non faccia il concertone del Primo
Maggio direttamente e si affidi ormai da diversi anni a una società esterna
sicuramente con una lievitazione dei costi. La Rai trasmetta il concertone e non
spenda 600mila euro per pagare una società esterna".
Chi è Giulia Berdini, la fidanzata del
direttore di Rai3 Franco Di Mare che ha attaccato Fedez.
Alice Coppa il 04/05/2021 su Notizie.it. Giulia Verdini è la
fidanzata del direttore di Rai3 balzata alle cronache nei giorni scorsi per il
suo attacco contro Fedez. Giulia Berdini è la fidanzata del direttore di Rai3
Franco Di Mare, balzato alle cronache nei giorni scorsi per il presunto
tentativo di censura attuato dalla Rai nei confronti di Fedez al concerto del 1°
maggio. Giulia Berdini si è scagliata contro il rapper via social.
Giulia Berdini: chi è. Classe 1991, Giulia
Berdini lavora per il servizio pubblico ma è lontana dal mondo dello spettacolo:
è infatti responsabile operativa presso l’azienda che svolge i servizi di
ristorazione in Rai. Grazie al suo lavoro in Rai ha conosciuto Franco Berdini,
il direttore di Rai3 balzato agli onori delle cronache nei giorni scorsi per la
presunta censura attuata nei confronti del discorso di Fedez (che a seguire ha
postato via social la telefonata intercorsa tra lui e il direttore Franco Di
Mare). Nonostante 36 anni di differenza Giulia Berdini e Franco Di Mare sono più
innamorati che mai e lo stesso direttore di Rai3 ha confessato via social a
proposito della loro relazione: “Capisco anche che a guardarla da fuori la cosa
appaia un tantino cliché. Il fatto è che non avevo messo in conto che, molto
banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva
Blaise Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so
che è vero.”
Giulia Berdini: lo sfogo contro Fedez. Dopo che
Fedez si è sfogato in merito al tentativo della Rai di censurare il suo discorso
al concertone del 1° maggio Giulia Berdini ha commentato via social la vicenda
scagliandosi contro il rapper: “Fedez è disgustoso. È l’ipocrisia del
politicamente corretto, la classica nullità del mainstream che, grazie a qualche
paracelo occulto, sta facendo i milioni sparando min***te funzionali al sistema.
È un finto rivoluzionario, innocuo come un omogeneizzato Plasmon”, ha tuonato la
ragazza, visibilmente infuriata con il rapper.
Giulia Berdini: la relazione con Franco Di Mare.
Giulia Berdini e Franco Di Mare sono legati ormai da moltissimi anni, ma i due
hanno sempre vissuto la loro relazione con il massimo riserbo. Prima della
relazione con Giulia il direttore di Rai3 è stato sposato con un’altra donna,
Alessandra, con cui ha adottato sua figlia Stella. Non si sa con precisione
quando il direttore Rai si sia legato alla sua attuale compagna. Alice Coppa
MA PERCHÉ FEDEZ HA VOLUTO
SPOSTARE L’OBIETTIVO SULLA RAI?
La zuffa del Concertone del Primo Maggio, una strumentalizzazione per scatenare
la bagarre. Marco castoro su Il Quotidiano del Sud il 5 maggio 2021. Quando un
ospite viene invitato in un programma Rai in diretta sa gli argomenti su cui
dovrà intervenire ma non entra in studio se prima non ha firmato la liberatoria.
Una prassi che sarà pure antipatica ma va espletata a tutela del programma e
dell’azienda. Perché in diretta, soprattutto se parte l’embolo, può uscire di
tutto. Il caso Celentano di qualche anno fa, ora quello di Fedez ne sono la
testimonianza: un artista quando sale sul palco se ha un peso sullo stomaco si
lascia andare e lo sputa. Sta agli organizzatori e alla produzione far valere la
liberatoria, perché nel caso del Concertone la Rai acquista i diritti e non è
responsabile dei contenuti editoriali. Tuttavia non sempre i messaggi
raggiungono l’obiettivo. Nel suo intervento Fedez ha giustamente sottolineato le
vergognose frasi del politico leghista, che meriterebbe l’espulsione dal partito
come si fa nel calcio, ma alla fine per colpa del video che ha pubblicato (in
cui sono state tagliate le risposte della vicedirettrice di Rai 3, Ilaria
Capitani) nel mirino c’è finita l’azienda di Viale Mazzini. Passata per una tv
che censura i discorsi. E invece è Fedez che ha censurato le risposte della
Capitani. Lo scrive in un post su Fb il direttore di Rai3, Franco Di Mare:
«Nella versione pubblicata da Fedez ci sono gravi omissioni, questi tagli
alterano oggettivamente il senso di quanto detto dalla vicedirettrice – cui va
la mia vicinanza umana e la mia stima professionale – che nel colloquio esclude
fermamente, ben due volte, ogni intenzione censoria e che alla domanda esplicita
dell’artista se può esprimere considerazioni che lei reputa inopportune ma lui
opportune lei risponde con un netto “assolutamente”. A me francamente spiace
sempre quando si manipolano conversazioni per far valere le proprie ragioni: che
lo abbia fatto un artista del calibro di Fedez che è anche un riferimento
positivo per tanti giovani mi spiace ancor di più». Di Mare che oggi viene
ascoltato in commissione Vigilanza, ha dovuto però incassare il parere negativo
di Conte, nuovo leader del M5S (il partito che volle Di Mare alla guida di Rai3)
che in prima battuta ha sposato le ragioni di Fedez. A fari spenti la vicenda
assume sempre più le sembianze della strumentalizzazione politica. Quando c’è di
mezzo la Rai si scatena sempre la bagarre tra i partiti e i media schierati,
tanto più in un periodo in cui la governance è in scadenza di mandato e le
poltrone già ballano il valzer.
Mario Ajello Diodato Pirone per "il Messaggero" il
3 magio 2021. In pieno conto alla rovescia per il rinnovo dei vertici Rai, sul
palco del concertone del Primo maggio è scoccata la scintilla che ha innescato
una polemica violentissima sulla Rai e sul disegno di legge Zan contro
l'omofobia che nei prossimi giorni sarà votato in Senato. Protagonista del caso
il cantante Fedez che, in poche parole, prima ha attaccato la Lega perché
contraria alla legge Zan e poi ha accusato la Rai - emittente che ha trasmesso
il concertone - d' aver tentato di censurarlo. L' effetto è stato quello di un
gigantesco polverone con la Rai che ipotizza una denuncia contro il cantante ma
soprattutto con la politica che, per tutta la giornata, ha bombardato il
quartier generale di Viale Mazzini. Da Giuseppe Conte a Luigi Di Maio, da Enrico
Letta a Nicola Zingaretti, da Andrea Orlando a Stefano Patuanelli tutti hanno
chiesto nuovi vertici e soprattutto invocato una nuova governance «libera da
condizionamenti partitici». Tanto che in serata Matteo Salvini, dopo aver
attaccato Fedez, ha sintetizzato la giornata parlando di «una polemica tutta
interna alla sinistra».
LA SCINTILLA. Tutto inizia sulle prime note del
Concertone quando la Lega scrive in una nota che «se Fedez userà a fini
personali il concerto del 1 maggio la Rai dovrà impugnare il contratto e far
pagare tutto ai sindacati». L' artista prima della sua esibizione risponde su
Instagram: «È la prima volta che mi succede di dover sottoporre il testo di un
mio intervento ad approvazione politica. Ho dovuto lottare un pochino, ma alla
fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente». Poi Fedez, dal palco,
attacca vari esponenti leghisti citando loro affermazioni contro gli
omosessuali. Ma la polemica si fa rovente sulle accuse alla Rai. Dopo che Rai3
respinge al mittente l'accusa di censura preventiva, il cantante pubblica un
video nel quale si sente la telefonata con i vertici di Raitre - la
vicedirettrice Ilaria Capitani e i suoi collaboratori - gli viene chiesto di
«adeguarsi a un sistema». La battaglia riprende ieri mattina quando la Rai
interviene nuovamente per sottolineare che la direzione di Rai3 «non mai chiesto
preventivamente i testi degli artisti, richiesta invece avanzata dalla società
che organizza il concerto». Più tardi l'ad Fabrizio Salini, ha spiegato «di non
aver mai censurato nessuno e di certo in Rai non esiste nessun sistema, se
qualcuno ha usato questa espressione chiedo scusa». Intanto Fedez raccoglie gli
applausi di moltissimi artisti fra cui Celentano e Vasco Rossi. La parola passa
poi alla politica con Letta che chiede «parole chiare dalla Rai, di scuse e di
chiarimento. Poi voglio ringraziare Fedez» e Giuseppe Conte che spiega: «Io sto
con Fedez. E' ora di riformare la Rai». A fare chiarezza sarà la Commissione di
Vigilanza Rai che probabilmente domani o mercoledì ascolterà il direttore di
Rai3 Franco Di Mare per avviare un'indagine. Come leggere tutta la vicenda? La
Rai intanto sta pensando di fare causa a Fedez. Perché - si fa notare a Viale
Mazzini - non si possono registrare le telefonate senza il consenso
dell'interlocutore. «Fedez è stato scorrettissimo», è l'umore dei vertici della
tivù pubblica. Ma non solo. Anche i sindacati sono considerati responsabili di
questa vicenda perché spettava a loro garantire il pluralismo politico anche
durante il concertone. Perché - ci si chiede al Settimo Piano della Rai - i
sindacati, invece di mettersi al seguito degli osanna mainstream per Fedez, non
si assumono le proprie responsabilità? Ma intanto il caso Fedez - inteso come
una sorta di nuovo Pasolini agli occhi dei dem - è diventato anche il modo per
Pd e M5S per chiedere le dimissioni di Salini e Foa. E avviare subito il cambio
del comando in Rai previsto a luglio. Entrambi i partiti accelerano perché,
nella nuova spartizione della tivvù pubblica, vogliono ridimensionare il potere
dell'altro partner di governo, la Lega, che gode ancora di poltrone risalenti al
tempo dell'esecutivo gialloverde. Ridimensionare la Lega anche a costo di
favorire Fratelli d' Italia, che rivendica spazi in Rai sia a livello di guida
di telegiornali sia nelle reti sia per la presidenza dell'azienda. Che, tranne
in rari casi, è sempre stata appannaggio dell'opposizione.
Da liberoquotidiano.it il 3 maggio 2021. La Lega
al contrattacco. Dopo il discorso-invettiva di Fedez al concertone del Primo
Maggio contro alcuni esponenti del partito di Matteo Salvini per il Ddl Zan, il
Carroccio adesso si fa sentire. Lo fa attraverso Massimiliano Capitanio, il
capogruppo della Lega in commissione di Vigilanza, che spiega come si muoverà la
Lega sulla vicenda Rai-Fedez nei prossimi giorni. "Vogliamo vedere il contratto
tra la società esterna che ha organizzato il Concertone e la Rai. Dalle prime
verifiche che ho fatto risulta che la Rai abbia speso circa 600mila euro tra
costi esterni e costi di produzione. Chiederemo approfondimenti per vedere se ci
sono gli estremi per un esposto alla Corte dei Conti e per esprimere un atto di
indirizzo in Vigilanza, affinché l'Azienda di Servizio Pubblico impugni il
contratto alla luce dei gravi errori che ci sono stati sul palco del Concertone
– ha spiegato Capitanio, come riportato da Repubblica -. E mi riferisco sia
all'uso strumentale della festa dei lavoratori per parlare d'altro senza
contraddittorio, peraltro in una rete pubblica, e sia al mancato controllo sulla
promozione di marchi pubblicitari da parte di Fedez, cosa assolutamente vietata
dalle policy Rai". Sulle accuse mosse da Fedez, secondo cui gli sarebbe stato
chiesto di inviare in anticipo il testo del suo discorso per tutti i controlli
del caso, Capitanio ha spiegato: “Non mi risulta che nessuno della Lega abbia
letto preventivamente l'intervento di Fedez, sicuramente nessuno della
Vigilanza, anche perché non abbiamo mai avuto alcun atteggiamento censorio. Chi
poteva leggerlo sono invece i rappresentanti del Pd e del M5s che hanno
lottizzato quella Rete”. E ancora: “Dispiace vedere che alcuni giornali vogliano
attribuire alla Lega responsabilità che stanno tutte a sinistra”. La sera del
concertone, durante la festa dei lavoratori, il popolare rapper se l’è presa
soprattutto con i leghisti in merito al Ddl Zan, facendo l’elenco delle loro
prese di posizione su omosessualità e scelte di genere. Fedez ha recitato il suo
monologo per intero, anche se prima ha accusato la Rai di censura, rivelando che
i vertici dell’azienda gli avrebbero chiesto di leggere in anteprima il discorso
che aveva preparato. Quando Viale Mazzini ha smentito ogni tipo di censura, il
cantante ha pubblicato la telefonata avuta il giorno prima del concertone con il
capo degli autori di iCompany (la società che produce la kermesse per la Rai)
Massimo Cinque e con la vicedirettrice di Rai3, Ilaria Capitani. Entrambi gli
hanno fatto notare che il "contesto è inopportuno”.
Giusy Caretto per startmag.it. Non solo musica al
Concerto del Primo maggio. A metà serata il rapper Fedez ha tenuto un monologo
pro legge contro l’omotransfobia, accusando gli esponenti di Lega non favorevoli
al Ddl Zan. Non solo. Lo stesso cantante ha accusato la Rai di volerlo
censurare. Ma l’azienda radiotelevisiva stipula un contratto per i diritti di
trasmissione in tv dell’evento e non ha voce sui contenuti, gestiti invece da
iCompany. Tutti i dettagli. Partiamo dal ruolo di Radiotelevisione italiana
S.p.A. Secondo quanto sottolineato dal quotidiano Domani, “la Rai paga una somma
che si aggira intorno ai 500mila euro per i diritti di trasmissione
dell’evento”. Non ha alcun ruolo, quindi, nella scelta dei contenuti. Ruolo,
invece, che spetta alla società iCompany, che come si legge sul sito si occupa
di progettazione e realizzazione di eventi musicali. “Se di censura si
trattasse, dunque, semmai questa sarebbe arrivata dalla società e non dalla Rai.
Come si evince anche dal secondo comunicato della Rai sul tema, nel quale si
riporta la conversazione integrale tra Fedez e la vicedirettrice Capitani,
intervenuta a stoppare le parole di un autore, Massimo Cinque, capo progetto di
iCompany, il quale stava chiedendo all’artista di «adeguarsi al sistema»”,
precisa Domani. ICompany, società costituita il 5 novembre 2014, si legge sul
sito, si occupa di “ideazione, produzione, management, edizioni musicali,
comunicazione e percezione, formazione, fundraising, distribuzione, sviluppando
e potenziando le sue attività attraverso collaborazioni e partnership
strategiche con alcune delle principali realtà del settore musicale nazionale”.
La società da sette anni organizza l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL. Quindi
la società cura l’organizzazione dell’evento dopo essere stata costituita poco
mesi prima di occuparsi del Concertone. L’azienda, che ha un capitale sociale di
10.000 euro e che conta in media 7 dipendenti (si oscilla dai 9 del primo
trimestre 2020 ai 4 dell’ultimo), è controllata al 60% da Massimo Bonelli e al
40% da Andrea Lancia. ICompany, nel 2019, ha registrato un valore totale della
produzione pari a 1.402.351 euro, in crescita rispetto ai 1.289.754 euro del
2018. In crescita anche i costi a 1.407.644 (1.275.672 euro nel 2018), per una
rosso pari a 7.660. iCompany aveva chiuso il 2018 con un utile di 8.750 euro.
Luca Dondoni per "la Stampa" il 3 maggio 2021.
«Sono devastato». La mattina dopo il discorso dal palco del Concertone del Primo
Maggio a favore del Ddl Zan e la denuncia di aver subito un tentativo di
censura, il rapper ha la voce che gli trema: «Non voglio sembrare uno che vuole
sfruttare questa situazione per apparire. Quello che volevo dire l'ho detto. Se
la Rai vuole fare chiarezza, bene. Altrimenti quello che è accaduto ieri è sotto
gli occhi di tutti». Mentre lo smartphone si riempie di reazioni, Fedez
incomincia a rispondere alle critiche su Instagram, spiegando ancor meglio il
perché del suo discorso. «Ho dormito poco e niente, ma ho visto che c'è chi mi
ha attaccato su tutto, sul discorso che ho fatto ma anche sulla macchina, sulla
Lamborghini. Ecco una novità, vendo la Lamborghini, tanto non la uso più e butto
lì una domanda: ma se compro una Panda sono più credibile e posso dire quello
che penso?». «Voglio solo tornare dalla mia famiglia», dice Fedez: solo dopo
aver raggiunto Milano, dove vive con la moglie Chiara Ferragni e i due figli
Leone e la neonata Vittoria, si è finalmente sentito più tranquillo. E per
capire l'aria che tirava in casa Ferragnez, bastava dare un'occhiata all'account
Instagram della regina degli influencer. Che, come sempre, sostiene il marito:
«Sono veramente molto fiera di Federico: ha avuto il coraggio di andare contro
tutti e dire ciò che si pensa». Certo non è stato un colpo di testa, quello di
Fedez: era un mese che preparava il discorso da fare al Concertone. Il tema dei
diritti civili gli sta particolarmente a cuore, tanto che il 3 aprile aveva
organizzato una diretta Instagram con il deputato del Pd Alessandro Zan per
parlare della tanto sofferta legge e aveva chiesto, assieme a Chiara, alle oltre
trentamila persone collegate di firmare la petizione e mandare una mail al
Presidente della commissione giustizia del Senato per chiedergli di
calendarizzare la discussione in Aula. «Sono felice di poter mettere a
disposizione il mio Instagram per questa causa». Ma oltre ai problemi di merito
- e la sacrosanta battaglia contro l'omofobia -, ci sono quelli di metodo, le
accuse di censura alla Rai e la rabbia del rapper di fronte al fatto che «mi
vogliano far passare per bugiardo». «Non solo è vero che mi hanno chiesto di non
fare i nomi dei politici leghisti - rincara - ma sono sicuro che sia successo
anche ad altri. Sarebbe interessante indagare dietro le quinte dei concertoni
passati. In queste ore mi stanno scrivendo tanti colleghi anche molto famosi che
mi dicono come situazioni simili siano capitate anche a loro». Così quando è
arrivato il comunicato che sosteneva: «È fortemente scorretto e privo di
fondamento sostenere che la Rai abbia chiesto preventivamente i testi degli
artisti intervenuti al concertone per il semplice motivo che è falso, si tratta
di una cosa che non è mai avvenuta», la reazione di Fedez è stata netta e
inconfutabile: ha subito pubblicato la telefonata intercorsa con la
vicedirettrice Rai che lo invitava ad abbandonare l'idea di fare nomi e cognomi
di alcuni politici leghisti. «Meno male che ho registrato la telefonata e non
pensavo di dover arrivare fino a questo punto, ma evidentemente non c'è limite
alla vergogna - ha detto Fedez nei suoi post -. Io il testo alla Rai l'ho
mandato eccome e al telefono mi hanno detto parole come "devi adeguarti ad un
sistema, i nomi che fai non puoi dirli" e una serie di altre cose. Ora, nel
momento in cui con un comunicato ufficiale mi si dà del bugiardo, sono costretto
a pubblicare la telefonata che fortunatamente ho registrato. Tra l'altro, è
stata una delle telefonate più spiacevoli che ho avuto in vita mia. Adesso la
Rai mi accusa di aver montato ad arte il video, ma io metto a disposizione la
versione integrale e a quanto pare, visto che la stanno facendo girare anche
loro, mi stavano registrando». Una situazione quasi surreale, dice Fedez. «Nella
parte che hanno pubblicato loro si danno la zappa sui piedi da soli. Io chiedo:
"ma allora posso dire quello che voglio?" E la dirigente Rai mi risponde "no,
no, no". A quel punto chiedo se posso dire delle cose che per lei sono
inopportune ma che per me sono opportune, non hanno turpiloqui o bestemmie e
riportano semplicemente i fatti: quel silenzio assordante che si sente di
risposta dice davvero tutto».
Giuseppe Marino per "il Giornale" il 3 magio 2021.
Che fortuna avere una telecamera accesa che ti inquadra perfettamente e registra
durante una telefonata delicata. L' osservazione è ironica, ma apre una finestra
seria su un altro aspetto critico della disputa Fedez-Rai. È legittimo
registrare una chiamata e diffonderla? Nell' era dei social, la risposta al
quesito mette in gioco diritto alla privacy e libertà di espressione. E può
spalancare la porta a un far west senza riservatezza. «Il rischio -dice al
Giornale Guido Scorza, giurista e componente del collegio del Garante della
Privacy- è che migliaia di piccoli Fedez registrino e diffondano qualunque
chiamata, visto che ora è diventato tecnicamente semplice fare entrambe le
cose». La risposta, in realtà, è sfaccettata. Codice penale e codice della
privacy tutelano la riservatezza delle conversazioni, ma di per sé registrare
all' insaputa dell'interlocutore non infrange la legge, se è a scopo personale.
E la legge è molto chiara anche sul fatto che una registrazione può essere usata
per far valere i propri diritti in tribunale. «Il giudizio non può essere
semplificato -chiarisce Scorza, che sottolinea di parlare a titolo personale e
non a nome del Garante- chiaro che se il video fosse rimasto sullo smartphone di
Fedez la questione non si porrebbe. Tutto il contesto suggerisce che la
registrazione non fosse a scopo personale. È una situazione professionale e
l'interlocutrice, in quanto dirigente Rai, assume un ruolo pubblico, quindi
un'aspettativa di privacy attenuata». Fedez non può invocare il diritto di
cronaca come i giornalisti. Ma il codice della privacy prevede esplicite deroghe
alla riservatezza per tutelare «la libertà d' espressione e di informazione» e
le «manifestazioni del pensiero». «Il codice -spiega Scorza- ammette deroghe
alla privacy in riferimento all' attività che si sta compiendo, non a chi la
compie». Come dire: non serve essere giornalisti per aver diritto a informare,
se non si rivelano dati personali ma questioni di rilievo pubblico. «Al telefono
c'era un artista che stava per salire su un palco -aggiunge il giurista- e
l'interlocutrice sapeva di parlare con un influencer avvezzo a rendere pubblica
la propria vita privata. Ma è vero che è un caso che non si presta a giudizi in
bianco e nero, anche perché il codice tutela il bilanciamento tra diritto alla
riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero». Il giurista sottolinea i
rischi di un giudizio non ben circostanziato. «Ciò che spaventa -ragiona Scorza-
è l'impatto su potenziali comportamenti di massa. Dev' essere chiaro che ci si
riferisce a una situazione molto specifica e che essere influencer non dà in
automatico diritto a violare la privacy». C' è poi l'aspetto della possibile
manipolazione della telefonata: «La registrazione pare pianificata -conclude
l'esperto- ma se è stata manipolata, anche solo omettendo qualche parte, in modo
non fedele al vero senso della conversazione, allora cambia tutto».
Da "il Giornale" il 4 maggio 2021. «Visto che
Fedez ha deciso di intervenire dal palco del concertone del Primo Maggio non
solo per cantare ma anche per sensibilizzare su alcuni importanti temi della
società, confesso che due paroline sulla precarietà del lavoro e sulla vita dei
lavoratori precari ci avrebbero sicuramente fatto piacere, le avremmo davvero
gradite». È quanto afferma all' AdnKronos Vincenzo Guerriero, funzionario
Uiltucs di Piacenza, sede del primo e più grande sito di Amazon in Italia.
Osserva Guerriero, a proposito dell' intervento di Fedez, che in passato ha
anche promosso programmi di Amazon Prime Video: «È ovvio che, se si abbracciano
i temi sociali, il mondo del lavoro precario è un tema sul quale ogni intervento
da parte di personalità, come quelle dello spettacolo come Fedez, garantisce un
rilievo e una cassa di risonanza molto maggiore rispetto a tante azioni di
protesta che spesso restano prive di copertura mediatica». Insomma, per uno dei
sindacalisti che segue più da vicino i dipendenti italiani della multinazionale
più volte è finita sotto accusa proprio per la scarsa attenzione alle condizioni
di lavoro, Fedez ha perso un' occasione per parlare di lavoro, materia più
attinente al Primo Maggio dell' omofobia.
M.A. per "il Messaggero" il 4 maggio 2021. Gode
nel suo ruolo di leader politico. Anzi post politico, anti-politico 2.0, che si
sente «più avanti rispetto alla destra e alla sinistra» ma anche riguardo al
grillismo al tramonto. In nome di un populismo commerciale tra temi social e
quelle che un tempo si chiamavano televendite e ora sono - ci si passi l'
eccesso odioso di inglesismi - trade on line. Il giorno dopo il caos Concertone,
il rapper milanese - che volendo potrebbe comprarsi la Rai, come dicono i suoi
amici, ma non gli interessa e neppure ha intenzione di fare politica almeno nel
senso tradizionale - lancia una nuova sfida: «Voi politici ora decurtate una
parte del 2 per mille del vostro introito del partito a favore dei lavoratori
dello spettacolo, se ne siete capaci. Se i lavoratori sono ancora sfruttati in
questo paese, la responsabilità di chi è? E' mia? Io e altri amici dello
spettacolo abbiamo raccolto 4 milioni di euro per sostenere i lavoratori di
questo settore che da oltre un anno sono fermi». Non vuole fare un altro
movimento grillesco Fedez. Ma in politica lui c' è, a caccia non di elettori
bensì di follower, di clienti e di consumatori. Con questa tecnica: lancio
campagne, come quella a favore del ddl Zan o per l' aborto o contro il vitalizio
a Formigoni o in polemica con la Regione Lombardia che ritarda la vaccinazione
di mia nonna di 90 anni, e su queste fidelizzo le truppe targate Ferragnez (35,6
milioni di seguaci) sulla mia griffe e sulle griffe che mi riguardano, da Amazon
(di cui è testimonial) a Nike il cui logo svettava sul cappellino indossato da
Federico nel Concertone e anche nelle scarpe che indossava sul palco. LA
DIARCHIA Il piano Ferragnez, di lui e Chiara, uno più contundente essendo rapper
e una più cauta e più ecumenica essendo imprenditrice e dovendo vendere a tutti,
è quello del lanciamo idee, diffondiamo i valori e i principii del Bene o almeno
del mainstream politicamente corretto e questo fa aumentare il cosiddetto
personal branding. Ovvero dà più forza commerciale a Fedez e a sua moglie
Ferragni in tutto quello che fanno e che piazzano.
Dalle canzoni alle ciabatte. La politica, versione
neo o post e in confronto il grillismo è archeologia, come arma della celebrity
e del trade. E chi non vuole rientrare tra i cattivi, in questo commercio dei
buoni sentimenti, non può che aderire alle campagne dei Ferragnez. Che non sono
una democrazia diretta - Gianroberto Casaleggio? Un matusalemme! - ma un
oligarchia o una monarchia-diarchia assoluta. Alla quale è difficile non
soggiacere. Infatti ieri al Nazareno, quartier generale del Pd, andava forte
questa battuta: «Mai mettersi contro lo stramilionario Fedez, che non ha nulla
da perdere, ha sempre il telefonino acceso e può registrati, controllarti e
ricattarti e dice molto meglio di noi ciò che tutti i nostri elettori pendano».
Ma Fedez non vuole elettori che lo votino, ma da influencer insieme a Chiara
vuole gente che lo segue. Nella campagna contro l' ultra cattolico Giovanardi
sulle droghe leggere così come in quella anti Renzi («Totalmente ininfluente») e
anche su M5S non è tenero ormai: «Di Maio parla alle persone come se fossero
stupide». La politica li lusinga, ma loro non abboccano. Come nel caso di Conte
che da premier provò a ingaggiarli nella campagna a favore dell' uso della
mascherine ma niente: loro sono più furbi di lui e di tutti. Pure Salvini, che
sui social pensa di essere una superstar ma non vale nulla rispetto ai
Ferragnez, in realtà li teme. Guarda caso non ha azzannato Fedez sul primo
maggio ma gli ha detto in maniera riverente: «Prendiamoci un caffè e ne
parliamo». Di fatto siamo di fronte a una nuova oligarchia politica, o post
politica. Che chi non clicca un like moltiplicato 35 milioni e mezzo appartiene,
come la Rai, al mondo di ieri.
Le bugie hanno le gambe corte. Ecco
l'audio integrale fra Fedez e la Rai. Serena Pizzi il
3 Maggio 2021 su Il Giornale. Il "caso Fedez" prende un'altra piega. Pubblicata
tutta la telefonata avuta con la Rai e gli organizzatori del concertone. Così il
rapper ha manomesso l'audio. Fedez ha toppato. Il suo sentirsi sopra tutto e
tutti, la voglia di strafare, il suo ego hanno preso il sopravvento su ogni
cosa. Pure sulla libertà di espressione tanto reclamata e per la quale è
scoppiato il bubbone. La registrazione audio (manomessa) tra lui e alcuni
organizzatori del concertone del primo maggio gli sta tornando indietro come un
boomerang. Il motivo? Il rapper, in primis, ha reso pubblica una conversazione
privata. In secondo luogo, ha forzato la mano tagliando e cucendo le parole dei
suoi interlocutori per suggerire un senso diverso al discorso. Perché lo ha
fatto? Chi lo ha consigliato malamente? Non lo sappiamo, quello che è certo è
che ora tutto l'audio della conversazione lo sbugiarda e lo mette in imbarazzo.
L'audio manomesso. Un passo indietro. Dopo la sua
esibizione dal palco rosso - con tanto di discorso pro ddl Zan con poche parole
rivolte ai lavoratori (peccato!) - il rapper ha condiviso 2 minuti e 19 secondi
di filmato per dimostrare di essere stato censurato dall'azienda. La Rai ha
subito smentito specificando che il video era stato tagliato in più parti e che
non gli è mai stato messo il bavaglio. Il rapper è scattato sulla difensiva
dicendosi pronto ad offrire ai vertici Rai tutta la telefonata registrata. Così
è partita la guerra fra titani, dove non importa tanto il mezzo quanto il fine:
vincere. Si scopre che entrambi hanno registrato la famigerata telefonata
(quando si dice fidarsi l'uno dell'altro...), che entrambi sono convinti di aver
ragione e che entrambi sostengono di aver ricevuto uno sgarbo. E che forse
entrambi si vogliono incontrare in tribunale.
Fedez è la nuova sardina. Ecco. Da sabato primo
maggio alle 22.30 ad oggi è successo di tutto. Comunicati stampa, storie social
di moglie e marito ultramilionari che si dicono indignati ma felici del sostegno
internazionale (sì, pure la Bbc si è divertita a scrivere dei nostri teatrini),
vip o presunti tali che non aspettavano altro che questa occasione per brillare
- per un attimo - di luce riflessa. Politici che si dicono felici "dell'atto di
coraggio di Fedez", del suo "non piegarsi al sistema", delle necessità di
togliere le chiavi della Rai alla politica. Politici che se si stracciano le
vesti per un modus operandi che hanno inventato loro, politici che ora vedono
nel rapper - che abusa di autotune quanto dei social - la loro nuova sardina.
Politici che hanno completamente perso la testa e non sanno dove ritrovarla.
Politici che si sono ridotti a ringraziare Federico Lucia perché credono che
il ddl Zan subirà un'accelerata proprio dopo il suo intervento. Ma fanno
davvero?
Ecco il testo integrale della telefonata. Detto
ciò, torniamo alla telefonata. In un modo o nell'altro pure la Rai o gli
organizzatori del concertone dei kompagni (non sappiamo di preciso) fanno uscire
l'audio integrale. 11 minuti e 49 secondi di telefonata. Ve la alleghiamo qui
perché crediamo che sia importante per tutti sapere cosa sia successo, cosa si
sono detti, cosa hanno spiegato in modo educato la Rai, organizzatori e il
conduttore Lillo, come Fedez sia stato scortese/montato/pieno di sé nell'urlare
risposte sconnesse e pilotate per dare una sua impronta alla storia. Dalle
parolacce a quel "eh sì, certo" passando da quell'indignato "sistema". Il
doppiogioco di Fedez si vede fin da subito. Ha tagliato e cucito le risposte in
modo da passare dalla parte della ragione per essere idolatrato da chi si
accontenta della sua versione dei fatti. Ma il suo taglia e cuci ha avuto vita
breve. Avrebbe dovuto immaginarlo il nostro rapper, il primo a partire in
attacco e a stravolgere le regole del "gioco". Dopo la ramanzina sul suo -
giustissimo - diritto ad esprimersi, gli fanno notare che esiste un editore.
"Qualcuno mi spieghi perché il testo non va bene", chiede. E qui arriva il bello
perché tutto gli viene chiarito ma nel suo estratto pubblicato su Twitter questo
passaggio è stato volontariamente omesso. "(Questo è) servizio pubblico -
spiega Massimo Cinque, uno degli autori del programma - e tu puoi dire tutto
quello che vuoi ma dovresti avere anche le persone che citi nel tuo discorso le
quali potrebbero difendersi". Fedez sbraita aggrappandosi al fatto che negli
scorsi anni non ricorda il contraddittorio presente sul palco. "Non si alteri,
non c'è bisogno", gli dice Cinque. "Certo che mi altero, lei sa cosa mi sta
chiedendo di fare?", urla Federico. "Le sto chiedendo di adeguarsi a un sistema
che probabilmente lei non lo riconosce corretto", continua l'autore del
programma. Ma il rapper di Rozzano schiaccia il piede sull'acceleratore e
procede alla velocità della luce. "Non posso esprimere un'idea su un disegno di
legge...", continua. "No, non ho detto questo. Noi siamo entrati nel merito
perché lei ha citato... Mi scusi, lei ha tutte le sue ragioni, ma permetta anche
agli altri di esprimersi", replica Massimo Cinque. Così Fedez inizia a
fare domande viziate dal "mi spieghi la parte incriminata che non vi sta bene"
al "avete verificato che le citazioni sono vere o false", domande che nel suo
audio si sentono bene. Peccato che le risposte vengano tagliate in modo
sapiente. "Tutte le citazioni che lei fa con nomi e cognomi non possono essere
citate perché non c'è la controparte", ripete l'autore. Nel montaggio del rapper
manca tutto questo scambio di battute dove Cinque spiega che "quelle citazioni
possono essere dette in contesti che non sono quelli che lei sta riferendo". Qui
il marito della Ferragni ci attacca tutte le frasi contro la Lega (frasi tenute
strette nella clip per fare un certo effetto splatter), ma non mette il "non sto
dicendo questo" e mostra il bombardamento di sue domande quasi a voler mostrare
un interlocutore in difficoltà. "Io le sto dicendo - continua Cinque - che
questo non è il contesto corretto per esprimere queste...". Sotto si sente che
qualcuno suggerisce "l'editore". In effetti, ma forse Fedez è abituato a fare
quello che gli pare e non sa quale sia il ruolo dell'editore. "Io le sto dicendo
che prendere un microfono e usare una telecamera, un contesto diverso da quello
che può essere una tribuna politica, non è corretto". E Fedez? "Non è una
tribuna politica, io sto esprimendo un mio pensiero nel merito della politica e
non posso esprimerlo lei mi sta dicendo. Perché non posso?" La telefonata è
parecchio lunga, l'autore continua a spiegargli quali sono i problemi a cui
vanno incontro, "noi vogliamo evitare Fede che la cosa diventi questa, che il
tema diventi questo (propoganda politica, ndr)". "Voi nel servizio
pubblico avete il potere di censurare chiunque, ma io per fortuna posso...", ma
qui poco si sente. Cosa potrà fare il comunista col Rolex? Forse contare sui
milioni di follower che influenza a suo uso e consumo? "Nono, non è una
censura", gli ribadiscono. "Fedez, mi scusi, sono Ilaria Capitani - interviene
la vicedirettrice di RaiTre -. La Rai non ha proprio censura da fare. Se posso
finire di parlare ne sarei grata. La Rai fa un acquisto di diritti e ripresa,
quindi la Rai non è responsabile né della sua presenza né di quello che dirà, ci
mancherebbe altro". "Quindi in questo momento lei non ha voce in capitolo - dice
il rapper-. Vorrei capire con chi parlare, chi è che mi sta muovendo questa
richiesta". Massimo Bonelli, organizzatore: "Io rispondo a Rai e ai sindacati,
perché la Rai mi dà un incarico". A questo punto sbobiniamo l'intero scambio
perché è proprio qui che verte tutto il taglia e cuci fatto al millimetro.
Fedez: "Il vicedirettore della Rai ha appena detto il contrario, che tu non
rispondi alla Rai". Massimo Bonelli: "No, Federico non è così. La Rai acquista i
diritti e vuole un prodotto editoriale che abbia delle caratteristiche" . Fedez:
"La vicedirettrice della Rai in questo momento ha detto 'tu puoi salire sul
palco e dire quello che vuoi'". Ilaria Capitani: "No no, non ho detto questo...
Io trovo che..." Fedez: "Ah quindi io non posso salire sul palco e dire quello
che voglio". Ilaria Capitani: "No va beh, ci tengo a sottolinearle che la Rai
non ha assolutamente una censura. Dopo di che io ritengo inopportuno il
contesto, ma questa è una cosa sua". Fedez: "Perfetto, quindi io potrei
benissimo fare quello che voglio, visto che non c'è un contesto di censura.
Posso salire e fare le cose che per voi sono inopportune ma per me sono
opportune? Questa è la domanda". Capitani: "Assolutamente". Massimo Bonelli:
"Sì, Fede è che ci creiamo..." Fedez: "Si o no? Si o no? È una domanda semplice:
sì o no". Continua a mettere in difficoltà gli organizzatori perché non capisce
il concetto di linea editoriale. È evidente. Ora subentra il "non avete il
coraggio", il "non sapete rispondere", Bonelli spiega che è un problema di
"linguaggio complessivo". Fedez: "Questo palco rappresenta la riapertura e il
futuro. Nel vostro futuro i diritti civili sono contemplati?" Massimo Bonelli:
"Assolutamente sì, Federico". Fedez: "E allora perché non posso parlare di
questa cosa?" Massimo Bonelli: "Perché il contesto in cui lo stiamo facendo, con
questi termini non è editorialmente opportuno". Allora riprendono a spiegargli
della necessità di avere una controparte in grado di ribattere, altrimenti "non
è editorialmente opportuno all'interno del contesto del primo maggio". Fedez
torna ad urlare e gli dicono pure che lui ha ragione a voler dire quelle cose.
Infatti il problema non è la censura, ma il contesto e la scelta editoriale.
Ricomincia la solita solfa del sono un artista e bla bla bla e ovviamente gli
fanno notare che lo hanno chiamato "per cantare in realtà" non per fare comizi.
"Ho fatto leggere il testo a mei amici giornalisti, Peter Gomez, Marco
Travaglio, al direttore di Repubblica, nessuno ha notato cose in questo testo
che vertano in qualcosa di sgradevole. Riporto fatti che non sono contestabili".
Dall'altra parte della cornetta capiscono che hanno una bella gatta da pelare e
ammettono che stanno cercando di capire e Fedez gli dice che è in imbarazzo per
loro. Beh, arrivati alla fine della sboniatura ci viene da dire poco. Lo scambio
di battute parla da solo. Che Fedez dica che questi giornalisti - noti per una
certa propensione politica - gli abbiano dato l'ok fa ridere. Che Fedez non
capisca il significato di editore pure. Che Fedez manometta un audio di 11
minuti e 49 secondi per uscirne bene è davvero singolare. Proprio lui che si
erge a paladino della verità, giustizia, etc ci casca con entrambi i piedi? Che
figura barbina, Fedez.
La pagliacciata del milionario Fedez col
cappellino griffato manda in delirio la sinistra. Luca
Maurelli domenica 2 Maggio 2021 su Il Secolo d'Italia. Il cappellino griffato
dalla Nike, azienda con la quale casualmente ha un pubblico contenzioso per una
vicenda che riguarda un paio di scarpe “horror” non autorizzate dal brand
ufficiale (in violazione delle norme Rai sullapubblicità occulta, tra
l’altro) La telefonata di Fedez sulla presunta censura della Rai registrata,
casualmente, prima di andare in onda. Il monologo incentrato su una frase mai
pronunciata da nessun vertice della Lega contro i gay per promuovere il ddl Zan
su cui, casualmente, il centrodestra è contrario, per ragioni politiche e che
nulla hanno a che vedere col razzismo. Tutto previsto, anche la claque della
sinistra. La sceneggiata e il comizietto di Fedez al Primo Maggio hanno colpito
nel segno a sinistra, mandando in sollucchero opinionisti e leader. Una giornata
triste per la democrazia, il sindacato, il lavoro e perfino per la musica. “E’
la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento
perché venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione che purtroppo non
c’è stata in prima battuta, o meglio dai vertici di Raitre mi hanno chiesto di
ometterne dei partiti e dei nomi e di edulcorarne il contenuto”, ha detto Fedez,
il rapper milionario marito di Chiara Ferragni. “Ho dovuto lottare un pochino ma
alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente. Come ci insegna
il Primo maggio, nel nostro piccolo dobbiamo lottare per le cose importanti.
Ovviamente da persona libera mi assumo tutta la responsabilità di ciò che dico e
faccio Il contenuto di questo intervento è stato definito inopportuno dalla
vicedirettrice di Raitre”, ha spiegato. Ma perché non ha parlato anche delle
accuse di Beppe Grillo alla ragazza che sarebbe stata stuprata dal figlio, per
esempio? Il tema della violenza sulle donne non gli interessava? E degli
scandali della magistratura di sinistra? E delle inchieste di Bibbiano sui
bambini abusati? E delle Ong inquisite per traffico di migranti? E dei suoi
amici Scanzi, il bay vaccinato, e Zingaretti che negavano la pericolosità del
Covid? Andiamo avanti? In tv dovrebbe esserci la par condicio, anche quando si
fa finta di fare musica… “Buon primo maggio e buona festa a tutti i lavoratori,
anche a chi un lavoro ce l’ha ma non ha potuto esercitarlo per oltre un anno.
Per i lavoratori degli spettacolo questa non è più una festa. Caro Mario,
capisco che il calcio è il vero fondamento di questo paese. Non dimentichiamo
che il numero dei lavoratori del calcio e dello spettacolo si equivalgono. Non
dico qualche soldo, ma almeno qualche parola, un progetto di riforma in difesa
di un settore decimato dall’emergenza e che è regolato da normative stabilite
negli anni ’40… Caro Mario, come si è esposto riguardo alla Superlega con grande
tempestività, sarebbe altrettanto gradito il suo intervento nel mondo dello
spettacolo”, ha detto rivolgendosi al premier Mario Draghi. Quindi, il capitolo
relativo alla legge contro l’omofobia, con le farneticanti interpretazioni della
legge in discussione in Parlamento: “Questa era la parte approvata, ora arriva
la parte forte… Due parole sull’uomo del momento, il sonnecchiante Ostellari”,
ha deto riferendosi all’esponente leghista, presidente della commissione
Giustizia a Palazzo Madama, che ha deciso di incardinare il ddl Zan
sull’omofobia ma tenendo per sé il ruolo di relatore. “Ha deciso che un disegno
di legge di iniziativa parlamentare come il Ddl Zan, già approvato alla Camera,
può essere bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo, cioè se stesso.
D’altronde Ostellari fa parte di uno schieramento che si è distinto negli anni
per la lotta all’uguaglianza. Qualcuno come Ostellari ha detto che ci sono altre
priorità rispetto al Ddl Zan” compreso “il vitalizio di Formigoni” che è “più
importante della tutela dei diritti di tutti”. Quindi, la chiusura: “Il
presidente dell’associazione Pro Vita, l’ultracattolico e antiabortista Jacopo
Coghe, è stata la prima voce a sollevarsi contro il Ddl Zan ma non si è accorto
che il Vaticano ha investito più di 20 milioni in un’azienda farmaceutica che
produce la pillola del giorno dopo. Cari antiabortisti, non vi siete accorti che
il nemico ce l’avevate in casa”.
Renato Franco per il "Corriere della Sera" il 3
magio 2021. Comunisti col Rolex (era il titolo di un suo album con J-Ax), Che
Guevara in Lamborghini: per i detrattori si possono assumere posizioni politiche
solo se si è disperatamente alla canna del gas. «Allora vendo la Lamborghini e
mi compro una Panda». Fedez ieri ha rivendicato così il diritto a esprimere le
proprie idee anche a bordo piscina. Al netto del conto in banca, la verità è che
il Fedez «politico» - grazie anche all' unione con Chiara Ferragni - smuove più
like di tanti che il politico lo fanno di professione. Belli, ricchi, famosi, la
vita diventata un reality permanente su Instagram, royal family di uno Stato (il
Ferragnezland) da quasi 36 milioni di follower (una volta si chiamavano
volgarmente sudditi). Andasse alle Politiche la coalizione Fedez-Ferragni
avrebbe tranquillamente la maggioranza (alle ultime elezioni il centrodestra si
fermò a 12 milioni e mezzo di voti). Impegnati, ma non fino al punto di scendere
davvero in campo (almeno così dicono nelle dichiarazioni pubbliche). Lui più
fumantino (del resto è rapper), lei più stratega (del resto è imprenditrice).
Fedez non teme l'uno contro uno e si è scontrato con tutto l'arco parlamentare:
non solo Salvini (ormai è una saga) e Gasparri (che lo definì «coso dipinto»),
ma anche l'ultracattolico Giovanardi (sulle droghe leggere); durissimo con Renzi
(«totalmente ininfluente») ma poi poco malleabile anche con quei 5 Stelle per
cui aveva scritto un inno anti-Napolitano («Di Maio parla alle persone come se
fossero stupide»). Chiara Ferragni è invece più cauta (un'azienda del resto può
sposare solo battaglie di tutti). Il tema del femminismo, di certo meno
divisivo, lo sente suo. «La nostra società è ancora maschilista e patriarcale,
le donne vengono giudicate in maniera differente e spesso il giudizio non arriva
solo dagli uomini ma anche da altre donne pronte ad accusarsi a vicenda», aveva
detto denunciando contestualmente i fenomeni di victim blaming , slut shaming ,
revenge porn (le battaglie civili ormai passano solo per l' inglese). A volte è
la stessa politica a lusingarli, come quando l'allora presidente Conte li
ingaggiò per lanciare una campagna sull' utilizzo delle mascherine. Quindi? «Non
siamo né di destra né di sinistra. Siamo avanti», aveva detto lui. Scendere in
politica? «Non è una velleità». L' italiano medio? «Fa casino durante il minuto
di silenzio e sta in silenzio quando deve far casino». Difficile dargli torto.
Fedez, Sigfrido Ranucci difende la Rai ma
non convince. E se avesse parlato di pedofili nella Chiesa?
Francesco Specchia su Libero Quotidiano il 04 maggio 2021. «C'è
stato un cortocircuito nel modo in cui si sono relazionati Fedez e alcuni
autori. Voglio ricordare che le voci maschili che parlano della telefonata di
Fedez, di "un sistema", che non è giusto "fare i nomi", sono degli autori
esterni alla Rai. Una società di produzione che era stata incaricata dai
sindacati, da una società che doveva gestire l'evento. E qual è, alla fine,
l'ipocrisia di tutta questa cosa: i sindacati dovrebbero cominciare a guardare
dentro la loro pancia, non confondere le libertà sindacali con delle storture.
Il valore che viene difeso dalla Costituzione deve essere rispettato,
un'opportunità non un modo per approfittarsene». L'amico Sigfrido Ranucci,
ottimo cronista e deus ex machina di Report, su questa personale opinione
apparecchia la difesa della Rai sul caso Fedez. Aggiunge che «sono contento che
la Rai abbia chiesto scusa, come solo le grandi aziende sanno fare. Non sono
scuse per una censura, mai avvenuta, ma scuse per la gestione: è grave anche
solamente che una persona possa pensare di essere censurata in Rai». La sintesi
di Sigfrido è: Fedez si comporta come Fedez. Dice che ha il diritto di dire ciò
che vuole; ma la responsabilità della sua concione pro-legge Zan non è della Rai
ma dei sindacati che contrattualmente allestiscono in piena autonomia il
concertone. In teoria Sigfrido ha ragione. I sindacati organizzano e vendono a
viale Mazzini il pacchettone del 1° maggio chiavi in mano, a 600mila euro. La
Rai, di solito, non interviene. Di solito. Stavolta, però Ranucci sbaglia.
Ilaria Capitani, vicedirettrice di Raitre, è intervenuta con una telefonata che
avrebbe dovuto essere risolutiva nella gestione di un formidabile colpo di
marketing (di Fedez) trasformato in tentativo di censura. In realtà bastava
mettersi d'accordo con i sindacati, in sede precontrattuale, sulle regole
d'ingaggio scritte: non si parla di contenuti politici senza contraddittorio a
meno che non siano strettamente attinenti all'evento. Qua, per dire, si poteva
parlare di lavoro, lasciando le polemiche sulla legge Zan ad altre sedi. Dice un
dirigente Rai: «Pensa se Fedez avesse parlato dei pedofili nella Chiesa? Cosa
sarebbe successo?». Ma la frittata era già fatta.
Domenica In, Mara Venier: "Al fianco
degli omosessuali, bisognava avere coraggio ai tempi", stoccata a Fedez?
Libero Quotidiano il 02 maggio 2021. Anche a Domenica In è
stato sfiorato il caso di Fedez, della Lega e della Rai quando in studio da Mara
Venier sono entrate Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Quest’ultima ha esordito
elogiando la padrona di casa, che ha sposato certe cause in tempi non sospetti e
soprattutto molto più complicati di quelli attuali. “Sei sempre stata al fianco
delle nostre lotte, quando non era di moda”, ha dichiarato Imma Battaglia. La
Venier ha gonfiato il petto: “Bisognava avere coraggio, adesso è un po’ più
facile”. Non a caso poi Imma Battaglia ha ricordato com’era difficile ai tempi
fare volontariato o sposare le cause degli omosessuali: “Si parlava dell’Aids
come della malattia degli omosessuali”. A questo punto la padrona di casa è
intervenuta di nuovo per ricordare un episodio che lo ha segnato molto: “Mi
ricordo quando una volta ci siamo incontrate per caso in aeroporto. Ci siamo
abbracciate forte senza dirci niente, erano anni in cui nessuno aveva
coraggio”. Più avanti nel corso dell’intervista Imma Battaglia ha nominato anche
la Lega in accezione negativa correlandola alle sue battaglie, ma la Venier ha
preferito non toccare il tasto politico: “Io sono per la libertà, ognuno può
dire quello che vuole. Non c’entra la politica ma l’amore, una come te le
battaglie le faceva fuori dalla politica”. La Battaglia non è parsa
particolarmente d’accordo…
Dagospia il 2 maggio 2021. Dal profilo Facebook di
Mario Adinolfi. Fedez è come quelli che tiravano i bulloni a Gaber, sta con la
moda corrente, persino Salvini è intimidito e vuole offrirgli il caffè. Il tema
della libertà in Rai va valutato su questo punto: il pezzo di Pio e Amedeo
sarebbe stato mai mandato in onda? O il direttore di Raiuno sarebbe intervenuto
atterrito dalla rivendicazione di vera libertà dei due ragazzi pugliesi? Caro
Salvini, ma quale caffè: come urlava Gaber alla fine di questo pezzo
straordinario contro il conformismo di sinistra cui proprio non riusciva ad
adeguarsi (non riesco a fare/neanche un po’ l’omosessuale…), quando è merda è
merda, definiamola e restiamole lontani.
Paolo Giordano per "il Giornale" il 3 magio 2021.
Comunque vada, lui ci mette la faccia. Sempre. Anche quando rischia di perderla
o, addirittura, la perde proprio. Fedez è il prototipo del rapper 2.0, del
musicista ma non solo, del cantante che si auto promuove, che è imprenditore,
influencer, gaffeur, eroe dei social, capopopolo. Come sabato sera sul palco del
Concertone quando ha iniziato l'atteso, annunciato, temuto, criticato monologo
sul Ddl Zan in diretta radiotv. L' ultimo atto (per ora) della parabola di uno
degli artisti più divisivi in circolazione. Così divisivo da farsi criticare di
volta in volta da «fazioni» diverse. Più che un musicista, è lo specchio delle
nostre contraddizioni o, anche, di quanto sia volubile l'opinione pubblica. Per
capirci, tra chi oggi lo difende c' è anche chi un anno fa lo accusava di
opportunismo per aver lanciato la raccolta fondi per aumentare i posti in
terapia intensiva all' Ospedale San Raffaele di Milano (uno dei crowdfunding più
grandi del mondo, 17 milioni di euro). Allora era un'opportunista. Ora che ha
attaccato la Lega è un eroe. È una popstar a geometria variabile: talvolta vale
milioni di applausi (leggasi click), altre volte è solo le due ultime lettere
del marchio Ferragnez che condivide con la moglie Chiara Ferragni. Di certo lui
non si sarebbe mai aspettato tanto. Milanese cresciuto a Buccinasco, classe
1989, ha iniziato come tanti altri rapper ingenui e spacconi, facendosi largo a
base di rime goliardiche, talvolta inappropriate o addirittura criticabili ma
comunque dotate dell'ingrediente che, in quel mondo, fa la differenza: il flow,
ossia la capacità di «rappare» mantenendo la stessa metrica. Non a caso, prima
su YouTube e poi con il disco Mr Brainwash, il primo ad arrivare in testa alla
classifica, si è trasformato in uno dei punti di riferimento generazionali.
Subito dopo, con il disco Pop-Hoolista, ha allargato l'orizzonte, collaborando
con Elisa, Noemi e Francesca Michielin ed entrando nel grande circuito popolare.
Dopo con J-Ax è entrato anche a San Siro grazie al successo di un disco come
Comunisti col Rolex che prende in giro una categoria senza tempo ma
attualissima, la stessa che, per dire, oggi estremizza il politicamente corretto
fino alla tagliola della censura. Le contraddizioni dei radical chic. Le
paranoie dell'ideologia. Il tutto restando sempre a piedi uniti nella polemica,
volente o nolente. Di certo non si immaginava di passare per «fascista» quando,
da giudice di X Factor, nel 2014 ha criticato un concorrente che aveva scelto un
brano di Lucio Dalla (E non andar più via), definito «comunista e quindi
inadatto». Forse era meno deluso quando si è scatenata la polemica sul «Fedez
grillino». Invitato dai Cinque Stelle al Circo Massimo, sempre nel 2014, aveva
scritto un brano per l'occasione (Non sono partito) che poi si è trasformato in
un inno del Movimento. Risultato: due deputati del Pd chiesero la sua esclusione
da X Factor. Risposta di Fedez: «Il fatto che si chieda la mia testa ci riporta
indietro di 60 anni alla censura e al fascismo». Insomma, un «fascista» che
critica il fascismo ma che allo stesso tempo è pure grillino e, qualche anno
dopo, canta i comunisti con il rolex al polso. Un corto circuito. Di certo, nel
suo piccolo, ha un approccio molto americano perché i rapper Usa non si fanno
problemi a intrecciare business e musica e politica, nuove pubblicazioni e
iniziative collaterali che aiutino a vendere più copie o a fare più click (anche
sugli e-store...). Ma Federico Lucia in arte Fedez, padre di Leone e Vittoria,
colleziona anche memorabili gaffe. Il compleanno al Carrefour con lancio di
carrelli, ad esempio. Oppure la consegna, poco prima di Natale 2020, di buste
con mille euro a cinque persone bisognose di Milano: peccato che fosse a bordo
della sua Lamborghini Huracan da 200mila euro. O per ultima quella prima del
Festival di Sanremo, quando ha per sbaglio spoilerato una piccola parte del suo
brano in gara. Una figuraccia da principianti, una delle tante sfaccettature di
un rapper che, tra alti e bassi, è diventato (anche) un protagonista politico in
una politica con pochi protagonisti.
TESTO DI “FACCIO BRUTTO” BY FEDEZ
Faccio brutto, ho il ferro sotto la mia tuta da
ginnastica
E rime taglienti come le posate in plastica
Anche se a otto anni ho fatto un po' di danza
classica
La mamma mi diceva: "Col tutù mi sei fantastica"
Ma poi insieme ad un mio amico che lavora a Banca
Intesa
Ho iniziato a fare brutto e a preparare la mia
ascesa
Insieme alle mie bitches dormo con la luce accesa
Arrivo con la gang e spaccio buste della spesa
Una volta al giorno lucido la Beretta
Quando non so cosa fare incendio una camionetta
Ogni rapper mi rispetta perché arrivo dalla strada
"Eh in effetti sono rapper anch'io ma io arrivo da
casa"
Voglio la fama dei Beatles ma non i fan di John
Lennon
Ho la marijuana dentro il doppio fondo del termos
La polizia mi ha detto che sono in stato di fermo
"Guarda che non sono un drogato, sono un ragazzo
moderno, zio"
Faccio brutto, faccio brutto, faccio brutto
Ho visto più erba di un corso di giardinaggio
Faccio brutto, faccio brutto, faccio brutto
Ho visto più lame di un corso di pattinaggio sul
ghiaccio
Oggi ho ritirato almeno venti grammi di moffo
Me lo imbosco dentro le mutande gialle di
SpongeBob
Spingo la mia merda e vado molto di corpo
E ad ogni live stacco a morsi la testa di Ozzy
Osbourne
Ho la catenazza d'oro presa nell'uovo di pasqua
Giro coi fusilli crudi e ti chiedo se vuoi una
pasta
Non esco mai di casa se non ho il mio ferro in
tasca
Però prima mi sistemo un po' i capelli con la
piastra
Grido: "Poliziotti infami" ma con voce un po'
indecisa
Poi mi sente mio papà mentre si toglie la divisa
Mangio pane e malavita e pippo polvere da sparo
Ho il poster di Tupac con la faccia di Totò
Cuffaro
Ho un odio represso verso tutte le persone gay
Ma poi limono con la foto del cantante dei Green
Day
Quattro giorni di galera, risse ogni sabato sera
I soliti racconti finti tratti da una storia vera
Una volta al giorno lucido la Beretta
Quando non so cosa fare incendio una camionetta
Ogni rapper mi rispetta perché arrivo dalla strada
"Eh in effetti sono rapper anch'io ma io arrivo da
casa"
Voglio la fama dei Beatles ma non i fan di John
Lennon
Ho la marijuana dentro il doppio fondo del termos
La polizia mi ha detto che sono in stato di fermo
"Guarda che non sono un drogato, sono un ragazzo
moderno, zio"
Faccio brutto, faccio brutto, faccio brutto
Ho visto più erba di un corso di giardinaggio
Faccio brutto, faccio brutto, faccio brutto
Ho visto più lame di un corso di pattinaggio sul
ghiaccio
Vita nel ghetto, ma quando non smazzavo nel
parchetto
Mi vestivo da Naruto alla fiera del fumetto
E non sono cambiato con l'arrivo del successo
Semplice, perché non sono stato mai me stesso
Per amore della fama ogni cosa è lecita
Prendi la tua piccola parte in questa grande
recita
E se menti come gli altri non puoi farne più
altrimenti
La fortuna mi ha baciato prima di lavarsi i denti
Faccio brutto, faccio brutto, faccio brutto
Ho visto più erba di un corso di giardinaggio
Faccio brutto, faccio brutto, faccio brutto
Ho visto più lame di un corso di pattinaggio sul
ghiaccio
Testo di TI PORTO CON ME
Questa sera ti porto a ballare
Non voglio pensare alla merda che ho intorno a me
(Sai che c'è , sai che c'è)
Di merda a cui pensare in questo paese ce n'è
(Beato te beato te)
Non ci voglio pensare ti porto a balla
Dai cazzo federico con sti suoi elettronici
Tu devi far rap con I suoi suoni canorici
Sembrate il coro degli evangelisti cattolici
Fotografa sto cazzo cazzo ti fotografi
Da quando ho incominciato a firmare gli autografi
Uno stronzo mi fa sempre gli scherzi telefonici
Ma non sa che sono l'inventore di scientology
Quindi ho dei seri problemi psicologici
Confondo barbabietole con dei barbiturici
Mi chiudo delle ore dentro i bagni pubblici
E solo perchè colleziono peli pubici
Cazzo questa sera ne ho trovati undici
Fino a un mese fà avevo solo nemici
Ma da quando è uscito il disco son tutti miei
amici
(Oddio ti sto toccando quanto siamo felici)
Ti sorrido mentre sento le stronzate che dici
Questa sera ti porto a ballare
Non voglio pensare alla merda che ho intorno a me
(Sai che c'è , sai che c'è)
Di merda a cui pensare in questo paese ce n'è
(Beato te beato te)
Non ci voglio pensare ti porto a ballare con me
Ti porto a balla
Non so se ne sai molto bene di frazioni
Ho diviso I miei ascoltatori in 16/9
1/4 di sticchia , 1/3 di nicchia
E tu mi hai già rotto 3/4 di minchia
In una valle verde ho sepolto nella valle
Milano è piena di cavalle ma senza le stalle
Ho I denti del colore delle pagine gialle
Si! Sono troppo avanti scusatemi le spalle
Dai fammela menare fino a quando non salgono
Poi ti giuro che torno a dondolare nel angolo
Non fare l'emo frocio con lo smalto sulle dita
Non dire buonafortuna perchè porta sfiga
Non guardare il dito se ti indico la luna
Se c'è il bagno di folla prepara il bagnoschiuma
Scusa devo scappare ho un concerto all'una
(Spacchi di brutto buonafortuna)
Questa sera ti porto a ballare
Non voglio pensare alla merda che ho intorno a me
(Sai che c'è , sai che c'è)
Di merda a cui pensare in questo paese ce n'è
(Beato te beato te)
Non ci voglio pensare ti porto a ballare con me
Ti porto a balla
Sono convinto che il 280 grammi del mc donald
Faccia più male di 200 grammi di coca
Consapevolezza tanta ma di voglia ce n'è poca
(Mi dia un big mc , una patatina e una coca)
Milano è uno stagno quante oche
Ce l'hai una sigaretta , cara poche
Mi canti una canzone ?
Mi hai preso per coglione
Guarda che non sono mica un karaoche
Le donne aristocratiche col visone
Con la faccia tutta gonfia tipo cortisone
(Mio figlio fa la scuola privata di design)
Però magari c'ha l'aids che cazzo ne sai
A tutte ste cazzate non ci voglio pensare
Stasera sei mi ti porto a ballare
E se non vuoi scopare domani ti porto al mare
Ti tocco il culo con la scusa della crema solare
Questa sera ti porto a ballare
Non voglio pensare alla merda che ho intorno a me
(Sai che c'è , sai che c'è)
Di merda a cui pensare in questo paese ce n'è
(Beato te beato te)
Non ci voglio pensare ti porto a ballare con me
Ti porto a balla
Moratti stuprata, D'Urso
uccisa. Frasi choc nei dischi di Fedez.
Massimo Arcangeli il 5 Maggio
2021 su Il Giornale. Negli album cantati e prodotti da Fedez non solo brani
omofobi, ma versi che incitano alla violenza. Nei versi in cui lo offendi, caro
Fedez, quando parli di Tiziano Ferro, non è vero che volevi dire il contrario.
La frase da intendere all'inverso era la sola premessa: «M'interessa che Tiziano
Ferro abbia fatto outing». Tutto il contrario (2011) è però la punta
dell'iceberg. «Non fare l'emo frocio con lo smalto sulle dita» (Ti porto con me,
2011) ne fa appena spuntare un pezzetto di più. C'è altro Fedez, molto altro.
«Cugino, / anche se non hai la parrucca, / io ti sgamo da lontano, / sei una
troia. / Succhia, succhia» (Boom, 2010). «I soliti sospetti verso i soliti
frocetti, / la realtà è sempre peggio / di come te l'aspetti» (Disagio Skit,
2010). «Io non succhio cazzi, / non sono tuo fratello, / e comprati il labello /
al sapore di uccello» (Non ci sto più dentro, 2010; il brano è contenuto nel
mixtape BCPT di Fedez; il rapper duetta qui con Emis Killa, ma la strofa è
cantata da lui). «A me mi piace prendere le cose di petto, / a te ti piace
prendere le cose nel retto. / Io i culi non li lecco, chiedi pure al tuo garzone
/ che fa i testi da finocchio e mi sembra Checco Zalone» (Into My Head, 2010).
«Perché nessuno ha ancora detto a Flavio Briatore / che andare in giro col pareo
è un po' da ricchione? / I tipi da spiaggia con gli slippini bianchi / sembrano
usciti da un festino di Ricky Martin» (Bella vita, 2011). «Lo vedi quel signore
che si mette la gonna? / È Cecchi Paone che si veste da donna. / Mi ha chiesto
se vogliamo fare lo scambio di coppia, / ha già preso un hotel con una camera
doppia» (Una cosa sola, 2011; il brano è dell'album di Fedez Il mio primo disco
da venduto, prodotto da Franco Godi; Fedez è stavolta affiancato da Danti, dei
Two Fingerz, ma la strofa è intonata da lui). «Ho un odio represso verso tutte
le persone gay, / ma poi limono con la foto del cantante dei Green Day» (Faccio
brutto, 2013). Certo, Fedez, si può cambiare idea. Quando però il messaggio è
ancora lì, e musiche e testi sono in rete, a disposizione di tutti, allora
cambiare idea non può più bastare: bisogna chiedere scusa. Poco importa se la
vittima è un gay o una lesbica, un (una) trans o una donna. Sì, Fedez, perché ne
hai avute anche per le donne. «Ti do mezza busta se mi fai un mezzo busto, / te
la do tutta se ammazzi Barbara D'Urso / perché io non posso ancora concedermi
questo lusso» (Blasfemia, 2010; con Emis Killa). «Stupro la Moratti / e mentre
mi fa un bocchino / le taglio la gola / con il taglierino» (B-Rex status domini,
2010; con Rise). «C'è chi fa la ragazza immagine per noia / per alimentare la
sua immagine da troia» (Dove si va, 2010; con Maxi B). «Siete troie, troie, /
non fate le modeste. / Guarda come cazzo / sono vestite queste. / / Riconosco
una bitcha / già da come si veste. / / «La mandi in giro vestita da troia, / poi
piangi se la violentano. / / Sono troie, e se non lo sono / poi lo diventano»
(Si muovono le, 2010; con Bat One, o semplicemente Bat). Sono tutti brani sono
contenuti in BCPT. A cantare è in tutti e quattro i casi Fedez, e il mixtape è
prodotto da lui. Forse, caro Fedez, la tua Chiara non è più così fiera di te.
Non sei comunque da solo in quella selvaggia selva del rap e dell'hip hop che
con la scusa della libertà d'espressione, o della licenza di rima, diffonde
messaggi omofobi o sessisti assorbiti e ritrasmessi dal music system come niente
fosse. Sei in buona compagnia, Fedez. Tanti, chi più chi meno, nemici dei gay e
delle donne, trattate, quando va bene, da oggetto sessuale per il piacere del
maschio dominatore e prevaricatore. Non eri poi molto diverso, Fedez, nei primi
anni della tua carriera, dai politici e politicanti con cui ora te la prendi.
Forse, anzi, sei anche peggiore di loro, perché pretendi di metterti per
calcolo, ipocrisia o altro alla testa di una causa che non sai nemmeno cosa sia.
"Li chiamo infami". Ecco
perché Fedez deve vergognarsi. Ignazio Stagno il 4
Maggio 2021 su Il Giornale. Il rapper ha interrotto il lockdown della retorica
insegnandoci nel weekend i valori in cui (a suo dire) dobbiamo credere. Ma ha
dimenticato gli insulti (vergognosi) a chi difende la sua libertà. Cosa diceva
sulle divise...È salito sul palco per attaccare, per fare un sermone, per usare
uno spazio del servizio pubblico (pagato dai contribuenti) per fare propaganda
politica senza contraddittorio. Al di là della polemica su presunte censure
preventive o meno, Federico Lucia ha scelto di ignorare il tema centrale del
concertone del Primo Maggio, il lavoro, per mettere nel mirino il suo nemico
preferito la Lega. Di certo le citazioni degli esponenti della Lega riportate
nel discorsetto di Fedez sono da condannare, ma resta il fatto che le sedi per
il confronto politico sono altre. Eppure ancora una volta il campione di
moralismo, l'uomo che incarna tutte le libertà moderne (tranne quella di
ascoltare le ragioni altrui) è salito sul pulpito e ha moralizzato tutti in nome
del Ddl Zan. Mentre Fedez sciupava il suo intervento per parlare del disegno di
legge contro la omotransfobia, milioni di lavoratori, che magari in passato
hanno votato a sinistra, vedevano definitivamente morire sul palco del 1 maggio
la tanto amata lotta di classe e i diritti rivendicati per più di un secolo. Più
importante (e soprattutto più figo) per il signor Lucia parlare del mondo Lgbt e
del Carroccio. Il messaggio che ha voluto regalarci Fedez per la festa del Primo
Maggio è il seguente: vi spiego io quali sono i valori in cui credere, vi dico
io qual è la parte giusta in cui stare e soprattutto vi dico io chi sono i
"buoni" e chi sono i "cattivi". Poi l'ambizione di avere una parte del Paese ai
suoi piedi adorante sui social a scrivere "come è bravo", "quanto sto godendo".
Un ego smisurato quello di Federico Lucia che però non ha avuto il tempo di
controllare il suo passato. Già perché il moralizzatore che col bazooka della
retorica e del killeraggio politico contro la Lega ha di fatto ignorato i
lavoratori nel giorno della loro festa, ha scordato quando dal pulpito del rap
offendeva e insultava chi garantisce la sua sicurezza e soprattutto custodisce
lo Stato di diritto in cui Federico pontifica dai palchi. Basta rispolverare il
testo di una sua canzonetta di qualche tempo fa per rendersi conto della
coerenza del signor Lucia. Il testo che va ricordato è "Tu come li chiami". In
pochi pseudo-versi, Fedez attacca forze dell'ordine e militari: "Tutti quei
figli di cani, tu come li chiami, carabinieri e militari, io li chiamo infami,
tutti quei figli di cani". Parole chiare che non meritano commenti. Qui non c'è
odio, sia chiaro. Il moralizzatore segnala l'odio altrui, le sue sono
"opinioni", la sua è "arte", guai a toccaglierla. Lui è libero di insultare chi
vuole, anche le divise, perché vive in un Paese come il nostro. Ma almeno ci
risparmi le lezioncine col microfono in mano. Impari dai suoi testi in libertà
cosa significa davvero democrazia.
DiMartedì, Alessandro Sallusti contro
Fedez: "Invitava a stuprare la Moratti e uccidere la D'Urso".
Libero Quotidiano il 04 maggio 2021. Non le manda a
dire Alessandro Sallusti sul "caso Fedez", da giorni ormai sulla bocca di tutti.
Il rapper dal palco del Concertone del primo maggio ha attaccato la Lega e la
Rai. "Visto il contesto - ha esordito il giornalista a DiMartedì su La7
- sarebbe stato più logico parlare di sicurezza sul lavoro. Basta pensare a
quello che è accaduto oggi a una 22enne a Prato". E ancora, nel salotto
di Giovanni Floris il 4 maggio: "Ma non voglio censurare Fedez. In quanto a
parole non può lanciare la prima pietra, in un album invitava a stuprare la
Moratti e uccidere la D'Urso". Per Sallusti "le parole sono già soggette al
codice penale e civile, quindi quando vengono pronunciate in maniera pericolosa
sono già punibili". Secondo il direttore del Giornale, libero deve essere il
pensiero che deve però essere espresso con delle giuste parole. I famosi brani
del rapper che oggi si dice a favore degli omosessuali hanno creato scalpore
anche in Vittorio Sgarbi. "Fedez e le frasi contro gli omosessuali: 'Ho
sbagliato: anni fa ero più ignorante'. Poi, però, ha capito che poteva vendergli
le unghie smaltate", ha cinguettato il critico d'arte. E infatti il marito
di Chiara Ferragni ha difeso a spada tratta lo smalto sugli uomini, anche contro
qualche consigliere della Lega. Una casualità o solo perché ha lanciato la sua
nuova linea di smalti? Viene spontaneo chiedersi. La stessa Barbara d'Uso a
Pomeriggio 5 ha ammesso: “Io su queste cose ho sempre volato alto, nonostante
fossi a conoscenza bene di questa cosa”, ha dichiarato in riferimento alle
minacce del rapper nei suoi confronti, per poi aggiungere: “Ho sempre comunque
fatto mille applausi per il suo impegno”.
Fedez continua a guadagnare con i vecchi
video violenti e anti-gay. Massimo Arcangeli il 6
Maggio 2021 su Il Giornale. I brani omofobi, volgari e sessisti sono ancora in
Rete, anche sul canale ufficiale di Youtube: così il rapper incassa sponsor e
visualizzazioni. Gli altri testi che non ha mai voluto rinnegare. I video
omofobi e sessisti sono tutti in rete, e Fedez ci guadagna ancora. Alcuni sono
anche sul canale ufficiale Youtube (FedezChanneL), con più di un milione e
ottocentomila iscritti. C'è Ti porto con me (oltre 12 milioni di
visualizzazioni), il brano dell'«emo frocio con lo smalto sulle dita», preceduto
dal suo bell'annuncio pubblicitario, e c'è Tutto il contrario (quello con le
pesanti offese a Tiziano Ferro, anche qui le visualizzazioni superano i 12
milioni). È preceduto da un'avvertenza che attacca così: «Tutti i personaggi e i
luoghi rappresentati in questo video anche quelli che si riferiscono a
personaggi veri sono del tutto immaginari e surreali». Quando, scorrendo il
video, vedi perfino materializzarsi le facce di Ferro e Cristicchi non sai se
ridere o piangere. E intanto pensi ai proventi. 4 giugno 2016 Fedez è vicino a
compiere 27 anni. Quel giorno sembra abbia dato un pugno in pieno viso a un dj,
Cesare Mario Guglielmo Viacava, in arte Mc Cece, presentatore del Nameless
Festival di Barzio (Lecco). Il dj aveva commentato nel marzo precedente su
Facebook, sulla bacheca di un conoscente, riferendosi a Fedez (colpevole di non
essersi presentato a un evento milanese): «Quel gay non dichiarato ne ha
combinata un'altra». Il rapper gli aveva intimato di ripetere quelle parole, Mc
Cece lo aveva fatto e lui gli avrebbe così assestato il pugno. Scrisse al tempo
Mc Cece sulla sua pagina Facebook: «Ci ha provato in tutti i modi a rovinare il
Nameless il rapper Fedez! Tirarmi un pugno alla domanda #seigay e farsi
difendere dal suo buttafuori non ti fa Uomo! Non ti fa Artista! Non ti fa
nemmeno onore!». Il dj cita Fedez in giudizio, il rapper risponde con una
querela per calunnia e dopo una serie ripetuta di udienze si arriva al 3 maggio
scorso, con la ripresa a Lecco del processo a carico di Fedez (aggiornato al 5
luglio). Un discografico serbo, Goran Ilic, ha confermato la versione di Mc Cece
e Fabio Rovazzi quella di Fedez, che dice di non averlo nemmeno sfiorato.
Diranno i giudici se il rapper quel pugno l'ha dato oppure no, ma è ora che
Fedez renda conto del suo passato da omofobo e sessista della peggior specie. 15
gennaio 2012 Fedez annuncia, dalla sua pagina Facebook, la presentazione di un
nuovo mixtape (Fastlife vol. 3) nato in collaborazione con Gué Pequeno. Il post
reclamizza L'idea sbagliata, contenuto in quel lavoro. Ecco un passaggio del
brano, circolante su molti canali Youtube (su uno ha raggiunto oltre 3 milioni
di visualizzazioni): «Si toglie i vestiti insieme / a quel briciolo di dignità
rimasto. / Le tue labbra dicono no, / ma i tuoi occhi dicono Scopami!. / Mi stai
dicendo che non sei come le altre / ma le sante non sono troie, / le troie non
sono sante / e io non sono mai stato / un cristiano praticante. / Perdonami ti
prego, / perdonami anche se / io per te mi ammazzerei / ma solo dopo di te»
(versi cantati da Fedez). 97 Kalash commenta (1 anno fa): «Io per te mi
ammazzerei, ma solo dopo di te» (124 mi piace, 0 non mi piace). Risponde Kerim
Prod (8 mesi fa): «Yes». E ancora, a cantare è sempre Fedez: «Voi non siete
racchie, / ma vere e proprie vacche / giuste per i mattatoi» (Te lo do, con Emis
Killa); «Fuori luogo, / come il feto dentro il ventre di una lesbica» (Fuori
luogo, con Canesecco e Gemitaiz); «Preferisco risultare stonato / che apparire
finocchio. / Se ci ricasco m'ammazzo / mi sento un finocchio del cazzo / quando
uso l'Auto-Tune» (D.O.A., Death Of Autotune). Era proprio agli inizi, Fedez, ma
già prometteva bene.
Fedez contro la Rai? Clamorosa scoperta
sulla telefonata: chi è la figlia dell'uomo dietro alla cornetta.
Libero Quotidiano il 06 maggio 2021. Prosegue la polemica sul
Concertone del Primo maggio in cui Fedez ha attaccato la Lega, rea di essere
contro il ddl Zan (il disegno di legge contro l'omotransfobia). Il rapper non ha
solo inveito dal palco contro il Carroccio, ma anche contro i vertici Rai. Il
motivo? A suo dire Viale Mazzini gli avrebbe impedito di dire certo cose (contro
la Lega appunto). Un botta e risposta, quello tra il marito di Chiara Ferragni e
la Rai, pubblicata da Fedez stesso sui suoi profili social attraverso un
video. "La famosa telefonata pubblicata dal rapper vede come protagonista -
scrive Giuseppe Candela per Dagospia -, oltre alla vicedirettrice Ilaria
Capitani, anche il capoautore dell'evento Massimo Cinque, ritenuto responsabile
di una gestione disastrosa. Tra agli autori dell'evento figura anche sua
figlia Barbara Cinque, impegnata in questa stagione a Oggi è un altro
giorno di Serena Bortone. Nella telefonata integrale Massimo Cinque si rivolgeva
così al cantante: "Il servizio pubblico è il servizio pubblico. Tu puoi dire
tutto quello che vuoi ma a questo punto dovresti avere le persone che citi nel
tuo discorso che a questo punto dovrebbero difendersi. Non c'è bisogno di
alterarsi. Le sto chiedendo di adeguarsi a un sistema che probabilmente a lei
non lo riconosce ma è quello corretto. Lei ha tutte le sue ragioni ma permetta
agli altri di esprimersi. Tutte le citazioni che lei fa con nomi e cognomi non
possono essere citate perché non c'è una controparte. A prescindere dalle
affermazioni vere o meno, quelle citazioni possono essere dette in contesti che
non sono quelli che lei sta riferendo. […] Un contesto diverso da una tribuna
politica non è corretto". Discorso però che non ha convinto Fedez, tanto che il
rapper si è presentato sul palco per dire quanto gli fosse intimato di non dire.
Creando così un vero e proprio putiferio.
Fedez parla ancora e il figlio sbotta:
"Basta..." Novella Toloni il 6 Maggio 2021 su Il
Giornale. Fedez è tornato a parlare del "caso Rai" attraverso alcune storie
Instagram, ma questa volta a dire "basta" è stato il figlio di 3 anni Leone. A
quasi una settimana dal concerto del primo maggio non si abbassano i toni dello
scontro tra Fedez e la Rai sulla questione censura. Una storia che non sembra
trovare fine e che, dopo la riunione della commissione di vigilanza Rai, sembra
prendere una brutta piega per il rapper tra denunce, querele e allontanamento
dei palinsesti televisivi di viale Mazzini. Fedez, però, continua a parlare sui
social network, ma all'ennesima storia Instagram a sbottare e a dirgli "basta"
questa volta è stato suo figlio Leone. Nelle scorse ore l’artista ha esordito
sulla sua pagina Instagram per rilanciare l'assalto ai vertici Rai e in
particolare al direttore di Rai Tre, Franco Di Mare: "Ragazzi si è appena
radunata la commissione di Vigilanza Rai". Ma Leone, all'ennesimo video sulla
polemica che dai sei giorni impazza ovunque, ha gridato spazientito: "Basta, non
voglio!". Un'esclamazione che, oltre a far sorridere, avrà incontrato il
consenso di molti che, da una settimana a questa parte, non leggono altro che
notizie su Fedez. Dopo aver messo a letto il figlio, il rapper si è concesso ai
follower per tornare all'attacco di Rai e Lega in merito al suo comizio del
primo maggio: "In ordine, il direttore di Rai 3 mi accusa di manipolazione del
video e allude al fatto che avrei tramato un complotto alle loro spalle con dei
giornalisti. Dall'altra la Lega propone di denunciarmi". "Di Mare sostiene che
la Rai non c'entra niente col primo maggio - ha proseguito Fedez sul suo canale
social - perché ne acquisiscono solo i diritti. Allora a che titolo la vice
presidente di Rai Tre mi dice di andare cauto nel fare nomi e giudica lei stessa
il mio intervento inopportuno?". Per contro il direttore della terza rete di
Stato, ascoltato in commissione vigilanza Rai, ha parlato di "strumentale
polemica montata da Fedez contro la Rai. Forse c'è stato un calcolo dell'artista
per ottenere più like, visualizzazioni e consensi". Una situazione complicata
che ha portato come prima conseguenza l'allontanamento di Fedez dalle reti Rai e
poi una possibile causa. Le iniziali conseguenze non hanno però sorpreso il
rapper, che è tornato all'assalto: "Sapevo a cosa andavo incontro, ma rifarei
quello che ho fatto 100mila volte. Io sono un privilegiato, se la Rai mi fa
causa io ho i mezzi per difendermi, se la Rai mi bandisce a me non mi cambia la
vita".
Fedez ora prova a difendersi: "Ero
ignorante". Novella Toloni il 4 Maggio 2021 su Il
Giornale. Sui social network il rapper si è scusato per alcune delle sue canzoni
inneggianti all'omofobia ma il tempo del pentimento è durato poco e Fedez è
tornato ad attaccare la Lega, Salvini e anche la stampa. Si potrebbe quasi dire
che il cellulare è diventato l'estensione del braccio di Fedez. L'unico mezzo,
oltre al palco del concertone, dove esprimere la sua opinione a ruota libera
senza la presunta censura. Ma dopo gli attacchi e le arringhe, oggi, attraverso
Instagram sono arrivate le scuse del rapper: "Ho peccato anche io. Da giovane ho
sicuramente detto delle cose omofobe". Dopo giorni di polemica rovente, infatti,
Fedez è passato da paladino dei diritti della comunità Lgtbq a primo odiatore
per le sue dichiarazioni e per alcuni dei suoi brani più famosi palesemente
omofobi. Il riferimento più chiaro è alla canzone "Tutto il contrario", scritta
anni fa, dove il rapper cantava "Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto
outing, ora so che ha mangiato più wurstel che crauti". Una posizione che si
scontra con la sua fervente lotta in difesa dell'approvazione del ddl Zan che,
scherzo del destino, se fosse approvata, vedrebbe proprio Fedez il primo
soggetto ad essere denunciato in base alle nuove disposizioni normative
sull'odio. Non solo. Come riporta Dagospia, passi che quello poteva essere
definito un "errore di gioventù", peccato che quella canzone Fedez abbia
continuato a cantarla nei suoi live fino al 2019 (dopo non avrebbe potuto solo
per colpa del lockdown). "A metà del 2019, nel suo ultimo tour Paranoia
Airlines - riporta il sito di Roberto D'Agostino - Fedez sul palco cantava
ancora il discusso brano "Tutto il contrario". Non dieci anni fa, solo due anni
fa. [...] È sufficiente consultare la scaletta del tour per ritrovare il brano
tra quelli eseguiti con tanto di video". Lo sa bene Jacopo Coghe, vicepresidente
di Pro Vita, che su Instagram è stato deriso dal rapper con una foto con
sopracciglia arcobaleno e che ha inevitabilmente scatenato l'odio degli hater. E
allora, giusto per dare un colpo al cerchio e uno alla botte, ecco arrivare
le scuse di Fedez. "Mi fa strano dover rendere conto di una canzone che ho
scritto dieci anni fa, a 19 anni si è delle persone completamente diverse e ci
si esprime con termini e toni completamente diversi. Certe cose oggi non le
rifarei uguali. Non c'è mai stata nel quartiere in cui sono cresciuto educazione
in tal senso ma poi ho cercato di migliorarmi", ha dichiarato nelle Stories il
marito di Chiara Ferragni. Peccato che il pezzo scritto a 19 anni non sia
l'unico finito nel mirino, ma ci sia anche il più recente "Le feste di Pablo".
La scusa, però, è pronta anche per quel brano: "Ho sbagliato per cose dettate
dall'ignoranza; ho fatto un testo recentemente che è stato giudicato
transfobico, ma non era voluto: ho invitato una ragazza trans al mio podcast,
abbiamo affrontato il tema e ho imparato un sacco di cose perché non mi voglio
dare preclusioni". Le scuse sono durate giusto il tempo di una storia (o due),
però, visto che poche ore dopo il rapper è tornato ad attaccare la Lega, Matteo
Salvini e anche i giornalisti per alcune domande rivoltegli su Grillo: "Ha detto
cose terribili ed aberranti, non esiste giustificazione. Ma esiste una lista di
temi a cui devo dare una risposta prima di esprimere una mia opinione. Mi
spieghi, ora che le ho chiarito il punto su Grillo ho ottenuto il permesso di
parlare di altro? Funziona così?". Nuovi attacchi, nuove provocazioni e nuovi
politici da mettere nel mirino come Guido Crosetto, con il quale il rapper ha
ingaggiato un battibecco social sul tema della magistratura e del Csm "sulle
oltre 30.000 ingiuste detenzioni e sulle carceri italiane". Il rappresentante di
Fratelli d'Italia ha provato a coinvolgerlo nel dibattito, suscitando la replica
seccata del rapper: "Mi chiedo una cosa: un uomo politico che non riesce a
sollevare interesse su battaglie che gli stanno a cuore al punto da dover
chiedere ad un povero ignorante come me, sta forse sbagliando qualcosa?". Una
risposta sprezzante alla quale Crosetto non ha dato corda: "Il mio non era un
messaggio condito di disprezzo, la sua risposta sì. Era semplicemente un modo
per far risaltare l'incapacità della politica di sollevare temi. Cosa che invece
lei fa. Ora potrebbe scusarsi".
Dagospia il 2 maggio 2021. Dal profilo Facebook di
Selvaggia Lucarelli. Alcune considerazioni sparse sul caso Fedez: Oggi abbiamo
scoperto che in Rai esiste il patronato politico, pazzesco. Vorrei raccontarvi
che succede da qualche decennio e che la politica (TUTTA, a destra e sinistra)
non si limita a chiedere a un cantante di non fare politica su un palco, ma
decide amministratori, conduttori, contenuti e veti. Li decidono anche i partiti
di quei politici che oggi twittano Bravo Fedez, con acrobazie degne delle finali
di un campionato russo di ginnastica ritmica. Fedez ha fatto benissimo a non
cedere alle pressioni che abbiamo ascoltato. E ha fatto anche bene a registrare
e a sputtanare chi negava tentativi di censura. Faccio però sommessamente notare
che alla fine sono rimasti tentativi. E’ salito sul palco e ha detto quello che
voleva, non mi pare un passaggio trascurabile. Con un Renzi qualunque dubito
anche solo che sarebbe stato INVITATO su quel palco. Fedez improvvisamente
paladino del mondo Lgbt. Bene. Fedez però è anche quello che quando il primo
cantante italiano famoso anche fuori dai confini nazionali ha fatto
coraggiosamente coming out e nel 2010 - mica ora, con la strada più che
spianata- nella canzone “Tutto il contrario” gli dedicò la strofa” “Mi interessa
che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che
crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi: ciao sono Cristiano non
è che me lo ficchi?”. Ora, era ironico? Va bene. Voleva dire il contrario? Va
bene. Quella strofa però era violenta, qualunque lettura le si voglia dare. La
canzone è ancora lì, mai ritirata. E questo che Fedez definisce “cambiamento nel
modo di esprimersi” lo avrei accompagnato con delle scuse fatte bene a Ferro,
come gli suggerì Mika anni fa: “Si dice sono stato uno stronzo”. Invece, a chi
glielo ha fatto notare negli anni, sempre risposte piccate, infastidite. E
Ferro- che è stato coraggioso quando quel coraggio poteva avere un prezzo molto
alto- non gliel’ha mai perdonato. A ragione. Non importa quanto si sbaglia,
importa come poi decidi di riparare. Fedez coraggioso? C’è una differenza tra
l’essere nel giusto ed essere coraggiosi. Questo secondo me è il passaggio più
importante. Il coraggio si misura con un’unica unità di misura: quanto e cosa si
rischia di perdere, compiendo una determinata azione. Fedez ha sposato una causa
giusta in una fase di consenso per il ddl Zan enorme, e per fortuna. Non lavora
in Rai, non ha bisogno dei pochi soldi della Rai perché ne guadagna moltissimi
altrove. “Beh, intanto lui ha denunciato le pressioni e gli altri no!”, dicono
in molti. Beh, signori miei, non tutti si possono permettere di rinunciare al
loro stipendio in Rai o altrove, per questioni di principio. E lo dice una per
cui i principi sono importanti. C’è chi deve mangiare, Fedez continuerà a
mangiare. Sapete cosa sarebbe stato davvero coraggioso, da parte di Fedez? Fedez
è testimonial Amazon. Guadagna svariati milioni di euro con Amazon. Questo sì
che rappresenta quel “qualcosa da perdere”. Ieri era la festa dei lavoratori,
questo era il tema e su quel palco si doveva parlare soprattutto di lavoro e
lavoratori. Lui quel tema l’ha sfiorato con quel “caro Mario” un po’ frettoloso,
e poi è passato ad altro. Poteva rivolgersi al suo principale datore di lavoro,
Amazon, e usare quel palco per chiedere di tutelare i diritti dei suoi
lavoratori che fanno pipì nelle bottiglie e i cui sindacati sono costantemente
ostacolati. In questo Fedez poteva essere coraggioso. Dimostrare di avere il
coraggio di perdere qualcosa. Sposare - anche- una causa molto meno popolare,
molto meno nota, molto meno raccontata. Di Amazon dentro e fuori il Parlamento,
non frega niente a nessuno. A parte ai sindacati, al Landini che parlava di
questo l’altra sera a Piazza Pulita. Che si sporcano le mani, ma non con una
scritta da fotografare su Instagram. Dunque, Fedez, ha fatto male? No, ha dato
massima visibilità ad una questione che aveva (per fortuna) già molta
visibilità, guadagnando molto in termini di consenso. Per questo, va ringraziato
comunque, al di là del fatto che si intraveda o meno la scintilla della verità
in quello che fa. Contano i risultati. Mi aspetto però che nelle sue battaglie
sia disposto anche a perdere qualcosa, visto che è uno dei pochi che se lo può
davvero permettere. Infine, Salvini. Lui che per ragioni di opportunismo
politico da un po’ ha optato per il registro passivo- aggressivo e risponde
“Andiamo a prenderci un caffè” a qualsiasi provocazione dei suoi avversari
politici, fa pisciare sotto dal ridere. Quasi lo preferivo quando si presentava
con le bambole gonfiabili sul palco: almeno, somigliava alle sue parole.
Da ilgiornale.it il 2 maggio 2021. Più che un
cantante ormai Fedez sembra essere divenuto un politico. È vero che ognuno ha
diritto ad esprimere le proprie opinioni ma colpisce l’impegno sempre più
marcato del rapper su temi sociali tanto cari alla sinistra e al mondo
progressista. Soprattutto perché ogni suo intervento riesce a scatenare
polemiche. Forse, chissà, a Fedez il mondo della musica inizia a stare stretto.
E così il cantante volge la sua attenzione altrove. Ormai da tempo sui suoi
canali social lancia proclami e non risparmia attacchi contro quelli che
considera oppositori. Nel suo mirino, in particolare, ci sono la Lega e Matteo
Salvini. Proprio con l’ex ministro gli scontri verbali sono sempre più
frequenti. L’ultimo infuocato tema sul quale Fedez è intervenuto è il ddl Zan,
il disegno di legge contro le discriminazioni basate su genere, sesso,
disabilità e orientamento sessuale. Una dimostrazione la si è avuta ieri quando
sul palco del concerto dedicato alla Festa del Primo Maggio il rapper si è
esibito in un monologo durante il quale ha citato più volte il leader leghista.
Tripudio per il mondo progressista e radical-chic. Del resto se difendi un
provvedimento tanto caro alla sinistra attaccando un avversario, per di più del
calibro dell’ex ministro, non puoi che essere supportato. Da Pd e M5s si sono
levate voci di sostegno in favore del rapper che ha accusato la Rai di aver
tentato di censurare il suo intervento. Quello che appare è che dal palco degli
spettacoli Fedez si sta trasferendo poco alla volta sulle tribune politiche.
Nuovo idolo della sinistra, sembra essere diventato il rapper. Vicino alle
persone deboli e discriminate tanto che non perde occasione di lanciare proclami
per l’approvazione del ddl Zan. Eppure Fedez non è stato sempre così attivo sul
fronte dei diritti. E qualcuno, nelle ultime ore, lo ha fatto presente. Non solo
gli utenti dei social ma anche il Codacons hanno evidenziato cosa scriveva il
rapper qualche anno fa sui gay. L’associazione dei consumatori, ad esempio, ha
ricorda il testo di una canzone pubblicata da Fedez nel 2011 il cui contenuto
"appare chiaramente omofobo ed offensivo verso i gay, e che sembra dimostrare il
doppio salto carpiato compiuto dal rapper, passato in poco tempo da testi
omofobi a difensore del ddl Zan". Nel testo del brano "Tutto il contrario" si
legge: "Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing/Ora so che ha mangiato
più würstel che crauti/Si era presentato in modo strano con Cristicchi/Ciao sono
Tiziano, non è che me lo ficchi?/E non è vero che il potere è in mano ai
ricchi". Non proprio parole tenere. "Tutti cambiano idea nella vita", ha
spiegato Fedez. "Il vostro leader è passato da "senti che puzza, scappano anche
i cani, stanno arrivando i napoletani" a voler governare il Paese", ha
proseguito il cantante che poi ha evidenziato che la sua canzone si intitola
"Tutto il contrario: io scrivo tutto il contrario di quello che penso. Non è
difficile". Indubbiamente nella vita sono possibili ripensamenti, anche così
clamorosi. Chissà se all'epoca ci fosse stata la legge Zan cosa sarebbe successo
al rapper. Quale sarà la prossima battaglia del rapper? E nel suo mirino ci sarà
sempre Salvini? Lo si saprà nel prossimo futuro. Forse non bisognerà aspettare
molto per le mosse del cantante, nuovo idolo della sinistra.
Quarta Repubblica, Federico Rampini
seppellisce il Pd: "Sceglie Fedez? Ormai è il partito delle celebrità".
Libero Quotidiano il 03 maggio 2021. Il Pd in
ginocchio Fedez si sta scavando la fossa da solo. Ne è convinto Federico
Rampini, storico inviato di Repubblica, non certo tacciabile di simpatie
sovraniste o destrorse. Ospite di Nicola Porro in collegamento con Quarta
Repubblica su Rete 4, il giornalista commenta con durezza le prese di posizione
dei politici dem sul caso della presunta censura di Fedez al Concertone del
Primo maggio. Un caso che coinvolge la Rai (che ha smentito con forza,
scaricando ogni eventuale responsabilità sugli organizzatori esterni), ma anche
la Lega e Matteo Salvini, chiamati in causa dal rapper milanese in quanto
responsabili dell'"insabbiamento" del Ddl Zan. "La sinistra che diventa il
partito delle stars non si accorge che perde popolarità", chiosa Rampini
riassumendo in poche battute una tendenza ormai avviata da anni
nella gauche sempre più salottiera (tv e non) italiana. "Sono cittadino di un
Paese dove è stato legalizzato il matrimonio gay, e lo considero una conquista
di civiltà, ma sono molto perplesso sulla sinistra che tende a diventare il
partito delle celebrities". Gli fanno eco Daniele Capezzone e Stefano Zecchi,
politicamente schierati dalla parte opposta. "Fedez ha fatto tante cose che gli
vanno riconosciute, ciò detto siamo davanti ad un volpone incredibile e polli
quelli che ci cascano", commenta il primo. Secondo il filoso Zecchi invece "c'è
una degenerazione antropologica della politica, non accetto che la politica usi
Fedez in questo modo. Il Pd ormai è il partito dell'establishment, che
stabilisce chi sta bene o chi sta male". E il Concertone del Primo maggio, da
che mondo e mondo, è il palcoscenico perfetto per questo manicheismo.
Da liberoquotidiano.it il 6 maggio 2021. Il Pd in
ginocchio Fedez si sta scavando la fossa da solo. Ne è convinto Federico
Rampini, storico inviato di Repubblica, non certo tacciabile di simpatie
sovraniste o destrorse. Ospite di Nicola Porro in collegamento con Quarta
Repubblica su Rete 4, il giornalista commenta con durezza le prese di posizione
dei politici dem sul caso della presunta censura di Fedez al Concertone del
Primo maggio. Un caso che coinvolge la Rai (che ha smentito con forza,
scaricando ogni eventuale responsabilità sugli organizzatori esterni), ma anche
la Lega e Matteo Salvini, chiamati in causa dal rapper milanese in quanto
responsabili dell'"insabbiamento" del Ddl Zan. "La sinistra che diventa il
partito delle stars non si accorge che perde popolarità", chiosa Rampini
riassumendo in poche battute una tendenza ormai avviata da anni nella gauche
sempre più salottiera (tv e non) italiana. "Sono cittadino di un Paese dove è
stato legalizzato il matrimonio gay, e lo considero una conquista di civiltà, ma
sono molto perplesso sulla sinistra che tende a diventare il partito delle
celebrities". Gli fanno eco Daniele Capezzone e Stefano Zecchi, politicamente
schierati dalla parte opposta. "Fedez ha fatto tante cose che gli vanno
riconosciute, ciò detto siamo davanti ad un volpone incredibile e polli quelli
che ci cascano", commenta il primo. Secondo il filoso Zecchi invece "c'è una
degenerazione antropologica della politica, non accetto che la politica usi
Fedez in questo modo. Il Pd ormai è il partito dell'establishment, che
stabilisce chi sta bene o chi sta male". E il Concertone del Primo maggio, da
che mondo e mondo, è il palcoscenico perfetto per questo manicheismo.
Fabio Martini per "la Stampa" il 6 maggio 2021.
Con i suoi 29 anni vissuti in casa Rai e i quattro trascorsi in casa Cairo a
La7, pochi come lui conoscono i politici, le loro debolezze e le loro pressioni
sui diversi palcoscenici tv, e in questa intervista a La Stampa, Massimo Giletti
spiazza i tradizionali schemi di buoni e cattivi.
Fedez?
«Quanta debolezza culturale nel non capire che
basta mezza frase di personaggi così abili e influenti e sei spacciato: fai
diventare martire chi, magari, non è stato neppure oggetto di una censura! I
martiri veri sono altri!».
Tutti si lamentano della lottizzazione della Rai,
ma nel corso degli anni c' è stata una lottizzazione greve e una lottizzazione
artefice di pagine di ottima tv, magari ripetibili?
«Certo. C' è molta ipocrisia: il Parlamento, come
è giusto che sia, detiene il controllo su un' azienda pubblica. Il problema è
che ai tempi di Ettore Bernabei, la massima espressione del potere e della
politica, c' erano grandi dirigenti che avevano al centro il prodotto e sapevano
dire no ad un certo tipo di pressioni. Oggi c' è uno scadimento di qualità e di
competenze nella gestione dell' azienda. Una parte dell' azienda lavora alla
grande e un' altra parte è prona ai poteri politici. In una forma di
vassallaggio che mi fa molta tristezza».
A caldo la vicenda Fedez è sembrata grave, ma i
dettagli messi assieme nei giorni successivi hanno ridimensionato la denuncia?
«Sì certo, c' è stata l' abilità da parte di Fedez
di saper trasformare in evento una piccola cosa di cui nessuno si sarebbe mai
occupato. Questa storia racconta la debolezza culturale di una struttura che non
capisce che non si possono dire certe cose. Fedez sarà pure bravo a gestire il
marketing di se stesso ma è anche un artista che deve parlare di ciò che vuole
sul palco. E invece tutti hanno finito per parlare del caso. Lo stesso Salvini
non ha potuto rispondere a Fedez. Devi ammiccare, devi invitarlo a prendere un
caffè. Morale della storia: non "puoi" censurare Fedez che ha milioni di persone
che lo seguono. L' aveva detto Umberto Eco diversi anni fa che saremmo diventati
schiavi dei social».
In una rete privata margini di libertà sono
teoricamente superiori ma non sarebbe credibile negare le pressioni anche in
questo ambito. Vero?
«Sfido a chiedere a qualunque dei miei colleghi se
Cairo abbia mai fatto una telefonata a Mentana, a Floris e a tutti gli altri per
chiedere qualcosa! Io sono a La7 da quattro anni e nella mia decisione sul
futuro peserà il mio senso di libertà. Perché io faccio una televisione che è al
"limite". Le battaglie contro Bonafede e le scarcerazioni dei mafiosi. O quella
che ho fatto, isolato, contro Arcuri non avrei mai potuto farle altrove».
Da parte di un politico ci sono tanti modi per
esercitare una pressione: non vengo se mi pressi troppo o se mi fai trovare
interlocutori sbagliati.
«Sa cosa ho detto ai miei? Ragazzi, lo vedete, da
quanto ho "toccato" certe corde, non viene più nessuno dei big! Di Maio,
Zingaretti, nessuno. E ho aggiunto: sappiate una cosa: forse dobbiamo cambiare
idea sulla valutazione di un programma. Il valore si misura a sottrazione, sei
non hai molti nomi importanti, significa che lavori bene! Se non vengono, vuol
dire che stiamo facendo un lavoro importante, che dà fastidio».
Chi sono più permalosi? Quelli di sinistra, quelli
di destra o i Cinque stelle?
«Permalosi i politici? Direi che dovremmo farlo
noi un mea culpa: oramai ci sono politici che vogliono in anticipo le domande. E
allora, pur di avere il politico forte, ti accordi, non fai le domande! Se ci
dobbiamo appiattire meglio non averli».
Una ricetta per limitare l' invadenza dei politici
in Rai?
«Impossibile. La politica in Italia non è ancora
matura per fare un passo indietro e forse non mollerà mai. Soprattutto i
programmi che oramai contano più dei Tg».
Ha mai sospettato che la semplificazione del
linguaggio dei talk show, ragionare per buoni e cattivi, vincitori e perdenti ha
spalancato la strada all' antipolitica?
«Oggi la politica si fa per social e per slogan e
forse anche noi siamo stati in parte responsabili. Ma non siamo certo
responsabili dell' incapacità della politica di programmare ad una settimana.
Pensano solo all' oggi».
FdI: “Concertone? No, Festa dell’Unità.
Fedez esprime il furore ideologico di sinistra sulla Zan”.
Marta Lima domenica 2 Maggio 2021 su Il Secolo d'Italia. La
passerella di Fedez al Concertone? Matteo Salvini l’ha presa con
filosofia, citando Buddha e la meditazione, che dovrebbe praticare maggiormente
Fedez. Dopo il delirio di Fedez sul palco del Primo Maggio (video) il leader
della Lega lo ha invitato a bere un caffè, per parlare di libertà e di diritti”.
“Adoro la Libertà. Adoro la musica, l’arte, il sorriso. Adoro e difendo la
libertà di pensare, di scrivere, di parlare, di amare. Ognuno può amare chi
vuole, come vuole, quanto vuole. E chi discrimina o aggredisce va punito, come
previsto dalla legge. È già così, per fortuna. Chi aggredisce un omosessuale o
un eterosessuale, un bianco o un nero, un cristiano o un buddhista, un giovane o
un anziano, rischia fino a 16 anni di carcere. È già così”, scrive Salvini su
Fb. “‘Canta che ti passa’ invece Fedez preferisce fare un comizio, trasformando
il ‘concertone’ in un festival dell’Unità vecchio stile. E, dal palco in diretta
Rai3, mentre pubblicizza indirettamente la Nike indossando un cappello logato,
il politico-cantante insulta, con tanto di nomi e cognomi, rappresentanti del
mondo associativo pro Life, la cui ‘colpa’ è quella di criticare il ddl Zan e
l’introduzione del reato di omontrasfobia”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli
d’Italia, Isabella Rauti, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità,
Famiglia e Valori non negoziabili. “La smodata esibizione del cantante –
prosegue Rauti – è la conferma del furore ideologico del ddl Zan e
dell’intolleranza verso tutti coloro che dissentono dal ‘pensiero unico’.
Così, abusando del servizio pubblico pagato da tutti noi e senza possibilità
alcuna di contraddittorio, viene lanciato ed imposto un messaggio politico a
senso unico, funzionale alla più generale offensiva gender. Le esternazioni di
Fedez sono l’ulteriore conferma di voler reprimere la libertà di espressione e
di opinione di chi la pensa diversamente”, conclude.
Sgarbi fulmina Fedez: “Non sei un artista
ma un militante”. La Rai: “Telefonata tagliata ad arte”.
Marta Lima domenica 2 Maggio 2021 su Il Secolo d'Italia. “Se
decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un
comizio per attaccare i tuoi avversari. Diversamente, il tuo ruolo non è quello
dell’artista, ma di un militante che utilizza il servizio pubblico per
propagandare le proprie idee politiche”. E’ durissimo Vittorio Sgarbi su
Twitter, dopo il comizio andato in scena ieri al Concertone del Primo Maggio,
con accuse di censura rivolte alla Rai dal rapper e un monologo politico rivolto
contro la Lega e contro la legge Zan. Dopo le accuse lanciate ieri da Fedez, “la
direzione di Rai3 conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli
artisti intervenuti al concerto del Primo Maggio – richiesta invece avanzata
dalla società che organizza il concerto – e di non aver mai operato forme di
censura preventiva nei confronti di alcun artista”. E’ quanto si legge in una
nota rilasciata dopo il video pubblicato su Twitter dal rapper con la
registrazione della telefonata con la Rai 24 ore prima dell’evento. In
riferimento al video pubblicato sul suo profilo Twitter da Fedez, notiamo che –
prosegue la nota – l’intervento relativo alla vicedirettrice di Rai3 Ilaria
Capitani (l’unica persona dell’azienda Rai tra quelle che intervengono nella
conversazione pubblicata da Fedez) non corrisponde integralmente a quanto
riportato, essendo stati operati dei tagli. Le parole realmente dette sono: “Mi
scusi Fedez, sono Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai3, la Rai non ha proprio
alcuna censura da fare. Nel senso che… La Rai fa un acquisto di diritti e
ripresa, quindi la Rai non è responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe
altro, né di quello che lei dirà.” E ancora: “Ci tengo a sottolinearle che la
Rai non ha assolutamente una censura, ok? Non è questo […] Dopodiché io ritengo
inopportuno il contesto, ma questa è una cosa sua.”
Ignazio Stagno
per ilgiornale.it il 5 maggio 2021. È salito sul palco per attaccare, per fare
un sermone, per usare uno spazio del servizio pubblico (pagato dai contribuenti)
per fare propaganda politica senza contraddittorio. Al di là della polemica su
presunte censure preventive o meno, Federico Lucia ha scelto di ignorare il tema
centrale del concertone del Primo Maggio, il lavoro, per mettere nel mirino il
suo nemico preferito la Lega. Di certo le citazioni degli esponenti della Lega
riportate nel discorsetto di Fedez sono da condannare, ma resta il fatto che le
sedi per il confronto politico sono altre. Eppure ancora una volta il campione
di moralismo, l'uomo che incarna tutte le libertà moderne (tranne quella di
ascoltare le ragioni altrui) è salito sul pulpito e ha moralizzato tutti in nome
del Ddl Zan. Mentre Fedez sciupava il suo intervento per parlare del disegno di
legge contro la omotransfobia, milioni di lavoratori, che magari in passato
hanno votato a sinistra, vedevano definitivamente morire sul palco del 1 maggio
la tanto amata lotta di classe e i diritti rivendicati per più di un secolo. Più
importante (e soprattutto più figo) per il signor Lucia parlare del mondo Lgbt e
del Carroccio. Il messaggio che ha voluto regalarci Fedez per la festa del Primo
Maggio è il seguente: vi spiego io quali sono i valori in cui credere, vi dico
io qual è la parte giusta in cui stare e soprattutto vi dico io chi sono i
"buoni" e chi sono i "cattivi". Poi l'ambizione di avere una parte del Paese ai
suoi piedi adorante sui social a scrivere "come è bravo", "quanto sto godendo".
Un ego smisurato quello di Federico Lucia che però non ha avuto il tempo di
controllare il suo passato. Già perché il moralizzatore che col bazooka della
retorica e del killeraggio politico contro la Lega ha di fatto ignorato i
lavoratori nel giorno della loro festa, ha scordato quando dal pulpito del rap
offendeva e insultava chi garantisce la sua sicurezza e soprattutto custodisce
lo Stato di diritto in cui Federico pontifica dai palchi. Basta rispolverare il
testo di una sua canzonetta di qualche tempo fa per rendersi conto della
coerenza del signor Lucia. Il testo che va ricordato è "Tu come li chiami". In
pochi pseudo-versi, Fedez attacca forze dell'ordine e militari: "Tutti quei
figli di cani, tu come li chiami, carabinieri e militari, io li chiamo infami,
tutti quei figli di cani". Parole chiare che non meritano commenti. Qui non c'è
odio, sia chiaro. Il moralizzatore segnala l'odio altrui, le sue sono
"opinioni", la sua è "arte", guai a toccaglierla. Lui è libero di insultare chi
vuole, anche le divise, perché vive in un Paese come il nostro. Ma almeno ci
risparmi le lezioncine col microfono in mano. Impari dai suoi testi in libertà
cosa significa davvero democrazia.
Giuliano Guzzo per "la Verità"
il 5 maggio 2021. Dopo lo show di Fedez al concertone, la sinistra ha preso ad
adorare il ddl Zan come mai prima, quasi come testo sacro, un vangelo
progressista da approvare a tutti i costi. D'accordo, ma agli italiani la norma
interessa davvero? Anche se non c' è conduttore televisivo né influencer che osi
porsi il dubbio, è uscito un sondaggio che svela quello che in fondo tutti
sanno: alla stragrande maggioranza degli italiani di identità di genere,
transgenderismo e dintorni interessa ben poco. Si tratta d' una rilevazione di
cui ha dato notizia ieri sulla Stampa la scrittrice Marina Terragni e promossa
con una raccolta fondi da varie sigle femministe: Se non ora quando, Radfem
Italia, Libreria delle donne, Udi. I dati rilevanti emersi attraverso tale
indagine sono almeno tre. Il primo riguarda l'atteggiamento rispetto alla
partecipazione di atlete trans agli sport femminili, tema assai caro alla Casa
Bianca, dove Joe Biden ha emesso un apposito executive order permissivo in tal
senso. Ebbene, si è visto come il 56% degli interpellati dissenta da questa
linea, il 14% non sappia e solamente il 30% ne sia favorevole. E questo è il
dato più arcobaleno di tutti. Sì, perché la scelta del sesso a prescindere da
quello di nascita, con una semplice e rapida autodichiarazione, convince invece
appena il 20% dei cittadini, con quasi il 70% (68, per la precisione) che si
dichiara convintamente contrario. Musica non diversa, anzi, per i farmaci che
bloccano lo sviluppo di bambine che si sentono «dell'altro sesso»: solo il 13%
degli italiani è favorevole al loro impiego. Insomma, sette italiani su dieci,
se non di più, rifiutano quell' ideologia gender che, inutile girarci attorno, è
il cuore pulsante del ddl Zan. Sì, perché ritorna in almeno due passaggi
centrali del testo. Anzitutto nel primo articolo della norma - precisamente alla
lettera d) del primo comma - là dove si definisce l' identità di genere come
«identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se
non corrispondente al sesso, indipendentemente dall' aver concluso un percorso
di transizione». Ma anche l'articolo 7 del testo, quello sulle iniziative di
sensibilizzazione contro l' omobitransfobia «per le scuole di ogni ordine e
grado», è evidentemente permeato da una visione antropologica tale per cui il
genere altro non è che «identificazione percepita e manifestata di sé». Ecco che
allora il sondaggio svelato dalla Terragni diventa assai scomodo. Così scomodo
che pure il quotidiano che l' ha riportato - la citata Stampa - ha provato
maldestramente ad insabbiarne i contenuti con un titolo furbetto: «Scegliere il
proprio genere? L' Italia si spacca in due ma prevale il fronte del no». «Il
titolo della Stampa "minimizza"», protesta la stessa Terragni sui social. In
effetti, cosa ci sia di spaccato «in due» in uno scenario che vede almeno sette
su dieci degli interpellati contrari ad una certa idea, lo sa solo il titolista
della testata diretta da Massimo Giannini, assai portato per il genere fantasy.
Ma per tutti gli altri, abituati a leggere i numeri - e pure a comprenderli -,
la sostanza del sondaggio promosso dal fronte femminista è chiarissima: sulla
norma di Alessandro Zan, quello che una volta si sarebbe definito Paese reale ha
le idee ben diverse da quelle chi vive negli attici milanesi di City life.
Dopodiché, ovvio, la sinistra fa bene a tenersi stretti i suoi influencer. Basta
che poi, alla prossima batosta elettorale, non si mettano nel mirino i
sovranisti, che sfondano per il semplice fatto che, a quelli «civili»,
continuano ad anteporre altri diritti. Tipo arrivare a fine mese.
Antonio Padellaro per “il
Fatto Quotidiano” il 5 maggio 2021. "In realtà questo è un depistaggio per il
funzionario della Rai", gorgheggiavano Elio e le Storie Tese al Concertone del
Primo maggio 1991. Citato dopo il caso Fedez come la storica censura in diretta
del servizio pubblico di lorsignori. Con alcune differenze rispetto a quanto
accaduto un trentennio dopo. A cominciare dal contenuto della canzone
"Sabbiature", al cui confronto il monologo dell'influencer milanese sulla legge
Zan è una tenera filastrocca di Natale. A ritmo di rock: "Perché anche Andreotti
è stato giudicato dalla corte inquisitoria per un caso di depistaggio. Nelle
indagini sul tentato golpe Borghese. Il caso poi è stato archiviato come del
resto altri 410 su 411. E gli unici sfigati che non sono stati archiviati sono
stati Gui e Tanassi. Per il caso della Lockheed. Ma d'altra parte Tanassi era il
segretario del Partito socialdemocratico. E come lui Pietro Longo che era nella
P2 . E dopo di lui Nicolazzi è stato inquisito per le carceri d'oro. Ma tutto
questo è stato archiviato in nome dell'amore". Perché quei birbanti sventolavano
i panni zozzi dei politici potenti al cospetto del popolo italiano (ascolti
boom) senza sermoneggiare ma prendendo per i fondelli tutto il cucuzzaro.
Compresi i papaveri di viale Mazzini. "Come anche il caso delle armi all'Iraq.
In cui era coinvolto l'attuale presidente della Rai Manca. Poi il caso è stato
archiviato ma il popolo italiano si chiede perché. Evidentemente il popolo
italiano non è deficiente. Se tutti gli anni elegge questi uomini. È perché ha
capito che loro lo fanno nel nome della nazione. E nel nome dell'amore". Sapremo
poi che in Rai scoppia l'iradiddìo. Ma Elio è incontenibile: "Urliamo anche ti
amo a Ciarrapico l'attuale presidente della Roma. Lui vendeva il pesce c'ha una
fedina penale lunga così. Poi ha conosciuto Andreotti, è diventato il re delle
acque minerali. Ha avuto un prestito di trentanove miliardi con cui ha comperato
la Fiuggi". Stacco, appare il cerimoniere Vincenzo Mollica con faccia
d'ordinanza, scaraventato sul palco per arginare la montagna di merda che sta
travolgendo i palazzi della Capitale. Farfuglia: "Cerco di capire una cosa.
Stiamo passando dalla Rete tre alla Rete due? Benissimo. No ancora no". Geniale.
Lui si è fatto scudo umano mentre oscurati dalla diretta quei disgraziati
continuano a cantare: "Ti amo Ciarrapico. Ti amo per l'emissione di assegni a
vuoto". Imparate gente, imparate come si scortica davvero il potere. E come si
censurano i veri rompicoglioni. Senza spararsi sui piedi.
Estratto dell'articolo di
Stefano Cappellini per “la Repubblica” il 5 maggio 2021. Negli anni Novanta il
partito-azienda era Forza Italia. Negli anni Venti sono i Ferragnez. (…) Nella
dinamica del partito-azienda - un flusso quotidiano di post, tweet, foto,
streaming, un reality h24 che produce egemonia come gli intellettuali organici
negli anni Cinquanta, lo strutturalismo nei Settanta e Maria De Filippi negli
anni Zero - Ferragni fa la politica, Fedez fa il politico. Lei ci mette la
visione, lui le ansie militanti. Dopo il Concertone è tutto un chiedersi: farà
politica? È il nuovo "fortissimo" punto di riferimento della sinistra? Il nuovo
papa straniero? Di certo nessuno, a sinistra, si azzarda a dargli torto. Del
resto, se Fedez attacca i beceri leghisti anti-gay, che fai, non gli dici bravo?
Glielo dici. E intanto è già scattata la legge del beduino, o con lui o contro
di lui, e se ne contesti i metodi sei amico dei censori, e se vedi l'ombra del
grillismo più vieto sei colluso con Pillon, perché la filosofia di genere, su
cui si scannano da anni anche le femministe, è non binaria ma il dibattito
nell'era dei social è super binario: o di qua o di là. E Fedez sa far scattare
l'interruttore del circuito come pochi altri. La centralità di Fedez si basa
sulla nuova catena del valore: visibilità, consenso, royalties. È insomma già
tutto molto politico senza bisogno di scese in campo e nuovi partiti. Perché la
politica questo è oggi, mica i programmi elettorali e le mozioni in Parlamento.
(…) Fedez vende, intraprende, sponsorizza, conduce ma ha ancora la saltuaria
ambizione di rimarcare il suo spirito anti-sistema. Quale sistema? Come quale
sistema? Il Sistema, maiuscolo. Come tutti i sedicenti scomodi ha la tendenza a
seguire il flusso ma con la posa del contestatore, condivide con buona parte
della sua generazione la presunzione di essere controculturale anche quando fa
il bagno nel conformismo, "sono fuori dal coro" dicono oggi tutti i migliori
coristi e i tempi sono questi, in un bar del 2021 sarebbe l'avventore
qualunquista a scagliarsi infuriato contro il Nanni Moretti di Ecce bombo
rivendicando il coraggio e la scomodità dei suoi strali contro il magna magna
("E che siamo, in un giornalone? Ve li meritate i giornaloni!"). (…) Fedez ha
vinto la battaglia con la coscienza ideologica e quindi la battaglia
dell'esistenza. Ora le ha cantate a Salvini, e domani le canterà alla sinistra
che lo applaude e al centro che non si schiera, e ci sono buone probabilità che
lo farà citando gli indifferenti di Gramsci, il bacio Perugina dell'impegno
prêt-à-porter. Ma, nel caso, non si illudano i "compagni" già sedotti sul ddl
Zan.
Santoro ora si inchina a Fedez: "Pagherei
il canone per lui". Luca Sablone il 2 Maggio 2021 su
Il Giornale. Il giornalista elogia il rapper italiano dopo il discorso in onda
sulla Rai: "Grazie, ci hai fatto assaporare di nuovo il profumo della libertà".
Anche Michele Santoro si aggiunge al fronte che è andato in difesa di Fedez. Il
rapper italiano, diventato adesso il punto di riferimento della sinistra, ha
tenuto un discorso al Concertone del Primo maggio per schierarsi a favore del
ddl Zan e per attaccare alcuni esponenti della Lega. Il marito di Chiara
Ferragni ha inoltre pubblicato un video sui social per denunciare ciò che
definisce un tentativo di censura da parte della Rai, anche se da Viale Mazzini
hanno tenuto a smentire questa versione. L'ultimo a difendere il cantante è
stato il giornalista, intervistato da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7.
L'ex conduttore di Servizio pubblico ha voluto ringraziare Fedez per la prova di
coraggio che ha dimostrato nelle scorse ore: "Grazie Fedez perché ci ha fatto
assaporare di nuovo un profumo che era stato cancellato dalla Rai, ovvero quella
della libertà". Sostiene che persone come Fedez potrebbero rappresentare un buon
motivo per cui pagare il canone: "Io il canone non lo pago volentieri per vedere
Salvini nei telegiornali che non solo parla senza contraddittorio, ma con quelle
immagini di repertorio che rullano come in nessuna altra circostanza civile nel
mondo". E ha criticato i monologhi concessi agli esponenti dei partiti a cui
viene consentito di tenere dei veri e propri comizi televisivi senza che i
giornalisti pongano domande: "Ci stiamo rassegnando a questa situazione, e
vogliamo parlare di libertà?". Santoro però ha stigmatizzato gli interventi dei
politici italiani - tra cui l'ex premier Giuseppe Conte ed Enrico Letta -
domandandosi chi ha cancellato quel profumo di libertà dalla Rai: "L'hanno
cancellata i loro partiti, così come Salvini e la Meloni". Successivamente ha
rimproverato la Rai per la gestione che ha adottato nel corso dell'emergenza
Coronavirus: "Si è autoridotta sia come lavoro negli studi, sia come format dei
programmi. Quindi ha assecondato l'andamento della pandemia". Invece a suo
giudizio doveva essere il "centro di una risposta per i lavoratori
dello spettacolo", duramente colpiti dalle restrizioni imposte per combattere la
diffusione del Covid-19. Secondo il giornalista nessun sistema può impedire né
l'esercizio di una libertà costituzionale né il diritto di autore di esprimersi
liberamente, soprattutto quando il contesto viene visto come appropriato: "Non
c'è più bisogno di censurare nessuno semplicemente perché non c'è più libertà.
Quando non c'è libertà cosa devi censurare? La censura diventa una cosa
superflua".
Mezz'ora in più, Lucia Annunziata: “Fedez
ha ragione, le scuse di Salini non bastano”. Altro terremoto su Rai3.
Libero Quotidiano il 02 maggio 2021. Lucia Annunziata ha
assunto una posizione ferma e inequivocabile su quanto accaduto sul palco del
concertone del Primo Maggio, dove Fedez ha denunciato le “mostruosità omofobe”
della Lega e ribadito il suo sostegno al ddl Zan, che il partito di Matteo
Salvini sta ostacolando in ogni modo consentito al Senato. Ma la polemica più
travolgente riguarda proprio la Rai, sbugiardata da una telefonata pubblicata da
Fedez in cui si sente la vicedirettrice di Rai3 e i suoi collaboratori chiedere
al cantante di “adeguarsi al sistema”, intimandogli di non fare nomi e cognomi
sul palco del concertone. “Sono completamente d’accordo con quello che ha detto
Fedez”, ha esordito la Annunziata in apertura di Mezz’ora in più. “Penso che
abbia il diritto di dire quello che vuole, come tutti - ha continuato -
sull’intervento della Rai abbiamo già avuto diverse prese di posizione, la più
forte è stata quella del segretario del Pd che ha detto di aspettarsi delle
scuse insieme a parole chiare. Le scuse sono arrivate da parte
dell’amministratore delegato Salini, basta o no per chiudere questo caso?”. A
rispondere è stata la stessa Annunziata: “Per me non basta, la Rai spesso è
stata attaccata per aver fatto interventi non appropriati. Nel servizio pubblico
non può esistere alcun sistema a cui adeguarsi. La Rai deve aprire una
discussione, specialmente in un momento come questo, e deve avere un rapporto
più chiaro con l’editore, che ricordiamo essere direttamente lo Stato. Si apra
questa discussione - ha chiosato - e sia franca, chiara e definitiva”.
Raffaella Silipo per "la Stampa" il 3 magio 2021.
Good job boy. E poi cuori, applausi, mani alzate, muscoli e sorrisi: corre sui
social, tra pensieri ed emoticon, l'abbraccio dei colleghi a Fedez, dopo il
monologo sul palco del Primo Maggio: da Levante a Mahmood, da Achille Lauro a
Elisa fino a Claudio Santamaria, un coro che mescola speranze, frustrazioni e
paure accumulate in questi mesi di lockdown e concerti azzerati, con la
sensazione di essere considerati «categoria socialmente inutile». Come dice Emma
Marrone: «Do tutto il mio sostegno a Fedez! Lo stesso che avrei voluto ricevere
io ogni volta che in questi anni mi sono esposta mettendoci la faccia e mi è
stato detto dai politici: "pensa a cantare"». E invece gli artisti vogliono
pensare E cantare. Per contare. A partire da Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, in
passato presentatore del Concertone, «un palco - sottolinea - che per me è casa
e che ha senso di esistere per trasmettere dei messaggi. Si è parlato di
politicamente corretto, ed è vero che la discriminazione non è nelle parole ma
nelle intenzioni. Ma non è vero che siamo tutti uguali. Questo Paese e la sua
classe politica sono ancora in larga parte razzisti e omofobi, e questo è
vergognoso». Un tema, quello dell'inclusione, molto vicino alle nuove
generazioni come la giovanissima Gaia, anche lei al Concertone, «commossa ed
emozionata» dalle parole di Fedez: «Potrebbe sembrare un piccolo passo
"politicamente parlando", ma umanamente questo discorso ci sta dando qualcosa di
molto più speciale, la speranza nell'Amore, così luminoso che porta con sè una
voglia di vivere che un po' mancava a tutti noi». Un piccolo passo che unisce le
generazioni, fino ad arrivare al decano Vasco Rossi - «Bravo! Questo è BUON
servizio pubblico» - e a dama Ornella Vanoni : «Non ho parole da aggiungere. Più
d'accordo di così non si può essere». Non solo il mondo della musica: per il
regista Gabriele Muccino «la politica non è più cosa da Palazzo. Torna nelle
piazze. La libertà di espressione è la colonna portante della democrazia e della
nostra Costituzione. Ricordiamocelo sempre». Anche le due sorelle Guzzanti
difendono orgogliosamente il diritto a esprimersi liberamente dal palco: «Se
tutti quelli a cui viene chiesto costantemente di rinunciare ad esprimersi
liberamente, reagissero con un centesimo dell'energia di #Fedez - dice Sabina -
avremmo una splendida tv, informazione vera e soprattutto intelligenza che
circola». Mentre per Caterina, reduce dal successo di Lol, «esporsi, impuntarsi,
esigere, tremare e andare avanti. Il primo maggio 2021 è di Fedez e dei diritti
civili». E Paola Turci dà appuntamento «l'8 maggio a piazza della Scala. Tutti
per il DDL Zan».
Chiara Ferragni sulle parole di Fedez:
“Non potrei essere più fiera di così”. Jacopo Bongini
il 2/05/2021 su Notizie.it. Anche Chiara Ferragni ha commentato l'intervento che
il marito Fedez ha tenuto sul palco del Concerto del Primo maggio: "Non potrei
essere più fiera". A pochi minuti dall’intervento di Fedez sul palco del
Concerto del Primo maggio non è mancato il commento della moglie Chiara
Ferragni, che da casa stava seguendo la diretta dell’evento. Nelle storie
pubblicate sul suo profilo Instagram, l’imprenditrice ha elogiato il
comportamento del marito, affermando di essere fiera di come Fedez sia andato
contro gli stessi vertici della Rai pur di far valere la sua libertà di
espressione. Com’è possibile ascoltare nelle storie pubblicato sul suo profilo
nella notte tra l’1 e il 2 maggio, Chiara Ferragni ha affermato: “Comunque
ragazzi non potrei essere più fiera di così, per quello che ha fatto Fede
stasera. È veramente avere il coraggio di andare contro tutti per dire ciò che
si pensa e non è cosa da poco. Sono superfiera”. “Volevo ringraziare tutti voi
perché vi sento molto uniti ed è bellissimo leggere quanti di voi sono stati
toccati da questo discorso. È il potere della condivisione come dico sempre”, ha
poi aggiunto l’imprenditrice, che assieme al marito da sempre sostengono le
cause dei diritti civili in Italia. Poche ore prima peraltro, Chiara Ferragni
aveva pubblicato un piccolo estratto dell’intervento del marito Fedez mentre
esponeva il suo intervento sul palco del concerto. Nel corso della serata, il
rapper aveva infatti lanciato un appello al presidente del Consiglio Mario
Draghi affinché facesse qualcosa per i lavoratori del mondo dello spettacolo e
attaccato duramente la Lega per il suo atteggiamento contro il Ddl Zan e contro
i diritti civili in generale: “Il Senato ha tempo di ridare il vitalizio a
Formigoni, ma non di tutelare i diritti di chi viene discriminato”. In un
successivo post su Twitter, Fedez aveva poi smentito le parole della stessa Rai
che negavano di aver esercitato qualsiasi forma di censura nei suoi
confronti: “La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri
sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai suoi
collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non
posso fare nomi e cognomi”.
Da repubblica.it il 2 maggio 2021. Neppure il
Covid intacca uno dei "must" del concerto del Primo maggio, la polemica
politica, con il duello a distanza tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e
il rapper Fedez. Già prima dell'esibizione si erano venuti a sapere i contenuti
al vetriolo contro il Carroccio, il tutto condito dalle accuse del marito di
Chiara Ferragni di aver subito un tentativo di censura dalla Rai. Nel suo
discorso che, annunciato, nel pomeriggio aveva suscitato la reazione preventiva
del leader leghista su Twitter, il rapper e influencer milanese ha attaccato le
posizioni della Lega sul ddl Zan e ne ha criticato alcuni esponenti elencando le
loro frasi e definendole omofobe. Salvini in serata ha risposto con un post su
Facebook in cui, tra le altre cose, ha scritto: "Chi aggredisce un omosessuale o
un eterosessuale, un bianco o un nero, un cristiano o un buddhista, un giovane o
un anziano, rischia fino a 16 anni di carcere. È già così. Reinvito Fedez a bere
un caffè, tranquilli, per parlare di libertà e di diritti". "Le banalità dette
da Fedez fanno parlare. Le proteste della gente da più di un anno senza lavoro
no. L'Italia si merita Fedez?". Così su Facebook il senatore Fdi e presidente di
Asi Claudio Barbaro.
Pd e M5S difedono Fedez. Ma oggi Pd e M5S
intervengono a difenderlo. Con Letta e Di Maio in prima linea. "Condividiamo le
parole di Fedez e ci aspettiamo che la tv pubblica si scusi" afferma il
segretario dem Enrico Letta a Radio 24. "Un paese democratico non può accettare
alcuna forma di censura", aggiunge su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio. Sulla stessa linea anche il presidente del Lazio Nicola Zingaretti e la
sindaca di Roma Virginia Raggi. "Fedez ha citato frasi ed espressioni di alcuni
politici della Lega. Forse ora se ne vergognano, ma certo la soluzione non può
essere la censura di un artista" scrive Zingaretti su Instagram. "Ricordiamoci
che ci sono esseri umani - prosegue - picchiati e offesi solo per quello che
sono. Dovrebbe essere naturale approvare una legge che li tuteli. Questa è la
legge Zan e va approvata". "Fedez è stato un grande e ha ragione. Bisogna
ripartire dal lavoro, dal sostegno a chi è rimasto indietro e dai diritti di
tutti" è il tweet di Raggi. "Parole di una semplice verità quelle di Fedez sul
palco del concertone- scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra
Italiana Nicola Fratoianni - inutile che ora la Lega si agiti, fra loro ci sono
i campioni dell'omofobia e dell'odio. C'è voluto il coraggio di un giovane
artista per smontare la loro ipocrisia. Grazie Fedez".
Pd e M5S chiedono dimissioni vertici Rai. Pd e M5S
sono compatti anche nel chiedere le dimissioni dei vertici Rai responsabili
della censura. "C'è poco da discutere, si colga questa occasione per fare ciò
che finora non si è stati capaci di fare: siano rimossi i responsabili di questo
scempio e si dia al servizio pubblico la dignità necessaria all'informazione di
un Paese civile! Un sincero grazie a Fedez per aver denunciato, non è da tutti",
afferma sui suoi canali social Giuseppe Brescia, presidente della commissione
Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle, postando
la telefonata dei vertici Rai al cantante. Sulla stessa linea anche i dem Bordo
e Provenzano. "Dopo quanto avvenuto ieri, non c'è un attimo da perdere: è
opportuno che i vertici dell'azienda coinvolti in questa vicenda rassegnino
immediatamente le dimissioni. La libertà di espressione in Rai dovrebbe essere
tutelata sempre. A nessuno può essere consentito di minare questo valore",
dichiara il deputato dem Michele Bordo, membro della commissione di Vigilanza
Rai. "Mettere le cose in ordine. 1 Grazie Fedez. 2 Ma dov'è la sinistra? se
discutiamo di #ddlzan è grazie al pd. 3 E i diritti sociali? i diritti si
tengono e il #primomaggio i lavoratori lottano per la libertà di tutti. 4 Lo
scandalo è nella rai. I nuovi vertici vi pongano fine, aggiunge su Twitter
Giuseppe Provenzano, vicesegretario Pd. "A prescindere dal merito di quello che
Poi ha detto Fedez, che io condivido, oggi qualcuno dovrebbe chiedere scusa a
nome della Rai. E qualcuno dovrebbe dimettersi. Perchè non è accettabile in
democrazia e nella nostra tv pubblica censurare le libere opinioni di un
artista" dice Emanuele Fiano, deputato Pd. "Il Paese ha bisogno della legge Zan
ed ha bisogno di voci indipendenti pronte a battersi per la libertà di
espressione e i diritti" aggiunge l'ex presidente della Camera Laura Boldrini.
La nota di Rai3: "Nessuna censura". Da parte sua
la direzione di Rai3 in una nota conferma di "non aver mai chiesto
preventivamente i testi degli artisti intervenuti al concerto del Primo maggio -
richiesta invece avanzata dalla società che organizza il concerto - e di non
aver mai operato forme di censura preventiva nei confronti di alcun artista. In
riferimento al video pubblicato sul suo profilo Twitter da Fedez, notiamo che
l'intervento relativo alla vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani (l'unica
persona dell'azienda Rai tra quelle che intervengono nella conversazione
pubblicata da Fedez) non corrisponde integralmente a quanto riportato, essendo
stati operati dei tagli. Le parole realmente dette sono: 'Mi scusi Fedez, sono
Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai3, la Rai non ha proprio alcuna censura da
fare. Nel senso che... La Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, quindi la Rai
non è responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe altro, né di quello che
lei dirà [...] Ci tengo a sottolinearle che la Rai non ha assolutamente una
censura, ok? Non è questo [...] Dopodiché io ritengo inopportuno il contesto, ma
questa una cosa sua".
Usigrai ai partiti: "Lasciate libera la Rai".
"Nella Rai Servizio Pubblico non può esistere alcun "sistema" cui adeguarsi.
Nella Rai Servizio Pubblico ci si deve adeguare esclusivamente ai valori del
Contratto di Servizio, quindi a quelli della Costituzione. Detto questo, vedere
i partiti che si accapigliano sulla vicenda Fedez è il trionfo dell'ipocrisia"
scrive l'Esecutivo Usigrai in un comunicato. "Perché noi un "sistema" in Rai lo
denunciamo da anni: ed è esattamente quello della partitocrazia, che - a partiti
alterni - occupa il Servizio Pubblico. Come del resto accadrà ancora una volta
nelle prossime settimane con il rinnovo del CdA. Lasciate libera la Rai,
lasciate libere le idee, lasciate libere l'informazione e l'arte. Gli unici
limiti che si possono legittimamente porre sono quelli imposti dalle leggi e
dalla nostra Costituzione".
Dagospia il 2 maggio 2021. Dal profilo facebook di
Enrico Mentana. Se esponenti politici di ogni ordine e grado sui temi della
lotta all'omotransfobia, del politically correct e del diritto vaccinale sono
costretti a inseguire, copiare, criticare e ripostare Fedez, Pio e Amedeo e
Checco Zalone, non significa forse che c'è più vita nel mondo dello spettacolo
che sotto il cielo grigio della politica?
Il protogrillino dei centri sociali usa i
giovani come arma politica. #Fedez. Daniele Dell'Orco
il 2 Maggio 2021 su Il Giornale. Era presente in piazza al primo Vaffa-Day e
scrisse l'inno per i grillini, da anni fa politica contro il centrodestra e ora
usa i social, il rap e il vittimismo per fare presa sui giovani sempre più
disorientati. È il capostipite dell'era degli influencer in politica. Federico
Leonardo Lucia, in arte Fedez, il protogrillino antagonista che usa i social e
il rap per arrivare a milioni giovani che i politici non sanno più raggiungere.
Cresciuto a pane e centri sociali come il Leoncavallo di Milano, Fedez è
diventato in breve tempo il cantore numero 1 della fetta post-ideologica di
millennias. La sua ascesa ebbe inizio nel 2014-15 quando la politica si accorse
della necessità di iniziare a parlare meno il politichese e più la lingua dei
ragazzi. Erano gli anni in cui Matteo Renzi si presentava col giubbotto di pelle
ad "Amici di Maria De Filippi", e in cui Beppe Grillo iniziava a capitalizzare
il suo odio per il Palazzo veicolato tramite il neo-linguaggio "aperto a tutti"
della comicità. Se l'Elevato era il capopopolo giusto per trainare il pubblico
adulto, la sua perfetta stampella per assoldare i giovani, invece, fu proprio
Fedez, il rapper che iniziò a seguirlo prima da spettatore nei primi Vaffa-Day
(era presente in piazza Cairoli nel settembre 2008) e poi lo aiutò a dipingere i
contorni "di sinistra" del Movimento 5 Stelle. A cominciare dall'inno, "Non sono
partito", scritto da Fedez e particolarmente osteggiato da quelli che all'epoca
erano i nemici pubblici principali dei grillini: gli esponenti del Partito
Democratico. Quel testo, intriso di attacchi al Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano e alla "trattativa stato-mafia", venne impugnato proprio da
alcuni onorevoli del Pd, che chiesero a Sky di cacciarlo da X-Factor. Ironia
della sorte, oggi i dem parlano di tentativo di "censura" per via di un comizio
di Fedez sulla tv di Stato, ieri provavano a far pressioni addirittura su
un'emittente privata pur di farlo fuori. Si deve a quei tempi anche l'inizio
della faida con la Lega e con esponenti politici di centrodestra come Carlo
Giovanardi, Maurizio Gasparri e ovviamente Matteo Salvini. Tutto previsto in un
canovaccio meta-politico che serviva al M5S per studiare un'opposizione al Pd
diversa da quella dei leghisti. A forza di studiare il giusto codice
comunicativo per sostenere la battaglia contro la vecchia politica, Fedez è
diventato più bravo dello stesso Grillo, ed ha iniziato a padroneggiare alla
grande una sorta di populismo-rap attraverso cui ha vergato rime che a
rileggerle oggi fanno davvero sorridere. Una su tutte: "Generazione televoto coi
cervelli sotto vuoto / Sempre più risucchiati dal televuoto", è il ritornello
della sua "Generazione-boh", anno del Signore 2014. Sembra una vita fa visto
che, complice la sua joint-venture amorosa/aziendale con Chiara Ferragni (a sua
volta bersagliata in una sua canzone "Vorrei ma non posto" composta insieme a
J-Ax poco prima dell'unione sentimentale iniziata nel 2016) la strategia
comunicativa di Federico ha fatto un salto di qualità. Non più spot pubblicitari
da vendere sui social per poche decine di migliaia di euro, bensì la costruzione
di una megaindustria con un catalogo di prodotti da sfogliare: gadget, smalti,
capi d'abbigliamento, format tv, podcast, talent show ma pure concetti e tesi
politiche. Come fossero in fondo la stessa cosa, ossia una leva per aumentare la
portata dell'"influenza". Su chi? Ma proprio su quella "generazione televoto" di
giovani post-ideologici disorientati e disinteressati a qualsiasi cosa non si
muova su Instagram. Quando l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha
chiamato alle armi Fedez e Chiara Ferragni nell'ottobre del 2020 per aiutarlo a
far arrivare ai ragazzi le corrette istruzioni sulle norme anti-Covid, i
Ferragnez non si sono più fermati. C'è anche da sottolineare, però, che sono
stati capaci di tirare su su 4,4 milioni di euro per costruire una terapia
intensiva e subintensiva del San Raffaele. Un grande gesto, sicuramente. Ma poco
dopo, hanno iniziato a condurre stress-test continui sulla politica locale e
nazionale. Sempre portando avanti battaglie gradite al mondo liberal e
soprattutto facili da inculcare nella mente dei giovani "copiaincolla". Ne sono
dei chiari esempi la crociata contro la Regione Lombardia sui vaccini e la
presunta "corsia preferenziale" dedicata alla nonna di Fedez (quando in realtà
al Pirellone stanno inanellando record su record nell'inoculazione di sieri,
senza che i Ferragnez lo dicano), e soprattutto l'appoggio incondizionato al ddl
Zan. Lo stesso onorevole dem, Alessandro Zan, primo firmatario della legge, è
diventato a sua volta un personaggio pubblico grazie al suo nome spiattellato di
fronte a milioni di persone (gli account social di Fedez e Chiara Ferragni messi
insieme raggiungono 35 milioni di utenti) che altrimenti avrebbero ignorato la
sua esistenza. Cos'hanno in comune queste due crociate? Sono intrise di
idealismo, presunta superiorità morale, senso di ingiustizia sociale,
disuguaglianza. E soprattutto, hanno lo stesso bersaglio: la Lega e Matteo
Salvini. A condire il tutto, per generare ancora più hype, l'asso nella manica
narrativo che sui social va sempre per la maggiore: il vittimismo. Il presunto
tentativo di censura subito dalla Rai altro non è che un modo per manipolare ad
arte gli avvenimenti e far passare Fedez automaticamente dalla parte del giusto,
come un Giordano Bruno senza macchia e senza paura voglioso di scardinare un
"sistema" retrogrado, bigotto, patriarcale. I leader politici più interessati al
gioco delle parti, cioè i giallo-rossi, hanno preso le sue difese. Conte dice:
"Io sto con Fedez. Nessuna censura". Letta addirittura ribalta completamente la
realtà: "Per colpa di Salvini abbiamo passato 20 giorni a parlare solo della
calendarizzazione del ddl Zan", scrive quando invece è stato proprio Fedez a
monopolizzare l'agenda politica italiana con il dibattito intorno alla legge per
spostare l'attenzione da tutto il resto. Tralasciando il fatto che anziché
lottare contro il "sistema" Fedez rappresenta il "sistema" (è inattaccabile dai
media, è amico del politicamente corretto, è testimonial di colossi come Amazon
e Nike), a riprova del fatto che il suo vittimismo si basi sulla cattiva fede, è
arrivato il comunicato ufficiale della Rai, attraverso cui Ilaria Capitani,
vicedirettrice di Rai3, ha diffuso la conversazione intercorsa col rapper senza
tagli, e in passaggio dice chiaramente: "La Rai non ha proprio alcuna censura da
fare. Nel senso che la Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, quindi la Rai
non è responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe altro, né di quello che
lei dirà - e infine - Ci tengo a sottolinearle che la Rai non ha assolutamente
una censura, ok? Non è questo [?] Dopodiché io ritengo inopportuno il contesto,
ma questa è una cosa sua". Fedez usa i taglia e cuci, gli escamotage, i colpi di
teatro nelle stories di Instagram per elevare la sua immagine, consapevole del
fatto che il suo pubblico lo proteggerà, o semplicemente ignorerà le
contraddizioni, l'ipocrisia, la partigianeria delle sue istanze. Se il suo
interesse fosse davvero il tema sociale, e non il potere persuasivo, se volesse
davvero essere solidale con le vittime di violenza, come mai ha preferito il
silenzio di tomba sul video del suo mentore Beppe Grillo?
Da repubblica.it il 7 maggio 2021. L'ex compagna
di Silvio Berlusconi Francesca Pascale si scaglia contro Forza Italia dopo le
dichiarazioni di Antonio Tajani sulla famiglia. In vista della festa della
mamma, il coordinatore nazionale degli azzurri ieri infatti ha detto che "una
famiglia senza figli non esiste", scatenando la polemica di Pd e M5S. Contro
queste affermazioni scende oggi in campo Pascale, da sempre anche sostenitrice
della legge Zan (anche questa nuovamente difesa in un'altra storia su Instagram)
e dei diritti della comunità Lgbt. Ecco "perché non voto più Forza Italia",
scrive l'ex del Cavaliere in una storia su Instagram in cui riporta l'articolo
di ieri di Repubblica, accompagnata con le note di "The End" dei Doors.
La sinistra riparte da Fedez e i grillini
lo vogliono in Rai: per Salvini tanto odio social.
Piero de Cindio su Il Riformista il 3 Maggio 2021. Fedez sale sul palco del
concerto del primo maggio annuncia di essere stato censurato dalla Rai e attacca
la Lega su ddl Zan e questioni civili. Questa è la sintesi della festa dei
lavoratori nel secondo anno di pandemia appena trascorsa, che ha scosso i social
e l’opinione pubblica. Se l’obiettivo era accendere i riflettori sulla legge
Zan, la politica ha intrapreso un percorso ancora più intricato e tortuoso
accendendo il dibattito sull’indipendenza della Rai e la sua lottizzazione
politica. Il modus con cui Fedez ha informato i suoi fans è stato oscuro e poco
chiaro nei metodi. Non è un caso che ha registrato la telefonata di 11 minuti e
mezzo avuta con la produzione Tv, esterna alla Rai, e con la vicedirettrice di
Rai3 Ilaria Capitani, e ne ha montato un breve video dove si evinceva una
intimazione a censurarlo nel fare i nomi e cognomi sul palco. Nominativi di
politici della Lega che si sono macchiati in questi anni di dichiarazioni che
andrebbero perseguite aldilà del Ddl Zan perché discriminatorie. Questa
polemica, come davvero poche a livello nazionale fino ad oggi, ha scatenato su
Twitter la bellezza di 120.523 tweets contenenti la parola Fedez, 3.102.027 di
likes, 380.174 condivisioni, 41.969 citazioni e 125.171 commenti secondo una
ricerca del data journalist Livio Varriale. I tweet più visualizzati sono stati
quelli dello stesso cantante che ha racimolato quasi 2 milioni di
visualizzazioni al video della telefonata e più di 150.000 mi piace. A godere di
un enorme successo su questa vicenda è stato l’ex Premier Giuseppe Conte che con
il suo “Io sto con #Fedez. Nessuna censura.” ha incassato la bellezza di 54 mila
likes. In classifica si evincono i nomi illustri di Laura Boldrini, Emma
Marrone, Ermal Metal con il suo tweet dissacrante “@Fedez dimostra di saper
suonare benissimo! Come gliele ha suonate mamma mia! #fedez”, Sabrina Guzzanti e
gli attivisti per i diritti LGBT l’onorevole Alessandro Zan, padre putativo
dell’omonimo decreto, e l’avvocato Cathy la Torre.
TOP LIKES. “La strategia di Fedez non è stata
naturale e lo si nota prevalentemente da due aspetti” dichiara al
Riformista Livio Varriale “Il primo è che ha pubblicato una telefonata montata
in modo da essere utile alla sua tesi. Secondo, invece, il placement di due
prodotti presentati nei giorni precedenti, tramite notizie di ufficio stampa,
che hanno guadagnato maggiore visibilità con il discorso del primo maggio
essendosi l’artista presentato sul palco con lo smalto che egli stesso produce,
indirizzato guarda caso a un pubblico LGBT, e la presenza sul cappellino del
marchio dell’azienda produttrice delle scarpe. C’è però una legge nella
comunicazione in rete: chi la spara prima, quello vince e tutti i conflitti di
interesse di Fedez sono passati in secondo piano seppur curiosamente ricordati
da personaggi che condividono con lui la lotta contro la Lega e Salvini come
Selvaggia Lucarelli, Potere al Popolo e nostalgici della sinistra di Gramsci.
Compensazione della realtà distorta dal cantante oppure invidia dei colleghi per
aver occupato la sedia vuota di un eventuale social leader di sinistra?”.
MENZIONI. Dal punto di vista delle menzioni il
discorso invece cambia con il protagonista sempre al primo posto che si porta
con se molti attori protagonisti. I primi sono il Pd e Alessandro Zan, poi i tre
di destra Salvini, Borghi e Crosetto con Pillon in fondo alla classifica. Ruolo
marginale per Enrico Letta e in fondo alla top 20 c’è la moglie di Fedez, Chiara
Ferragni. “Qui si evince quello che accade quando si mette in piedi un dibattito
social acceso soprattutto su Twitter. – Spiega varriale – In questo caso la
politica è stata tirata in ballo su più fronti come responsabile dell’assenza di
libertà di espressione e di disinteresse verso tematiche sensibili come la legge
Zan. C’è anche da sottolineare come messaggi simili siano poi utilizzati come
giustificativo a ripagare "della stessa moneta" gli avversari politici ed è per
questo che gli esponenti della destra occupano le posizioni più alte in blocco”.
HASHTAG. Anche nella classifica degli argomenti
più utilizzati c’è ovviamente Fedez, ma passa anche il messaggio del Ddl Zan che
si trova declinato in più forme semantiche nella top 20. Grande spazio per la
Rai ed il concertone del primo maggio. Presenti anche Salvini e la Lega come
oggetto di contestazione del pubblico ma secondo Varriale “dire come fanno molti
che la polemica messa in piedi da Fedez non abbia portato l’attenzione sul
decreto Zan, facendola passare in secondo piano, non è del tutto corretta. E’
corretto invece dire che se anche Fedez fosse stato mosso da uno spirito sociale
forte, la politica ha sviato il discorso sulla Rai e sulle Nomine che dovranno
farsi tra poco. Non è un caso che ad accogliere l’invito di Fedez siano stati
Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Roberto Fico che con l’avvento di Draghi hanno
perso maggiore rappresentatività nella tv di stato che conta. D’altro canto, non
mi sorprenderebbe vedere sulla tv pubblica lo stesso Fedez con una sua
produzione essendo stato San Remo un’esperienza non proprio gratificante dinanzi
al pubblico della tv che tutti gli influencer della rete disprezzano, ma in
fondo dimostrano sempre di voler comprare”.
Piero de Cindio. Esperto di social media, mi
occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format.
·
A
morte i Maschi.
Sono un maschilista. Ma con
giudizio. Di
Pasquale D’Aiuto su ilsudonline.it il 29 ottobre 2021. Sono un maschilista. Ma
con giudizio. Dopo l’assurda crocifissione di questi giorni del mio adorato
Prof. Barbero, reo di non aver omaggiato la consueta banalità imperante sulla
questione del c.d. gender gap, ho deciso di vuotare il sacco: sì, sono un
maschilista. Ma con giudizio. Allora: tutte le storielle sulle donne sono vere.
Ad esempio, non sanno fare la svolta a sinistra, figuriamoci parcheggiare; anzi,
la guida non è proprio affar loro. Certo, statisticamente provocano meno
incidenti ma devo dedurre che riescano a fuggire, sennò non c’è soluzione. Ah,
poi pensano soltanto alle scarpe ed alle borse (probabilmente anche alla guida,
così si spiegano molte cose): servirebbe una casa intera dedicata agli
accessori, e non basterebbe. E si ostinano a non comprendere il calcio: provate
a far loro capire il fuorigioco! Io, per ripicca, detesto borse e scarpe e sono
un perfetto sportivo da poltrona. Le donne non possono essere chef: quelli veri
sono tutti uomini. Infatti io faccio solo il caffè, così la mia si perfeziona. E
poi, quanto parlano! Ti pongono problemi che riguardano tempi lontanissimi, tipo
la settimana prossima; ma io non so se arrivo vivo a domani… Per non dire del
pianoforte, tema a me carissimo: solo noi maschi abbiamo la necessaria vigoria
per suonare ad alti livelli (scusate, qui la provocazione la devo proprio
sospendere: ascoltate Marta Argerich suonare Bach e poi ditemi. E sì, lo so che
c’è Glenn Gould, lo so).
Ecco, la scienza mi assolve:
il tono della voce delle donne è un trapano per il mio cervello – è dimostrato,
vedete qui, ad esempio, (..), ma anche qui, per un commento interessante: (...)
Le nostre madri, mogli, sorelle spendono i soldi della famiglia per gli abiti
dei bambini: ma non gliene avevamo comprati una ventina, un lustro fa? Che ci
devono fare, con tutte queste tute, queste maglie e questi calzini?! Oh,
naturalmente, le donne hanno sempre mal di testa. Dicono che pensano in
prospettiva, dicono. Menomale che noi maschi siamo ben saldi sull’oggi. E quanto
litigano tra di loro: se accade, c’è da divertirsi! Del resto, il termine
“isterica”, non a caso, è riferito soltanto alle donne, poiché hystéra, in
greco, significa “ventre, utero” (ma come è bello scriverlo in greco, visto che
ho fatto il Classico, vivaddio:
hστέρα!). E se lo diceva Ippocrate,
allora possiamo stare tranquilli. E poi, ci chiedono sempre le stesse cose,
magari mentre siamo occupati a non fare quel che ci hanno domandato prima… e,
intanto, Osimhen s’invola verso la porta avversaria ed io non ci sono,
non-ci-sono, dimenticatevi di me! La verità
è che ogni mattina io mi alzo, mi lavo la faccia, vado allo specchio – io, che
mi reputo mediamente colto e mediamente sensibile – e mi ripeto: non lo fare.
Non farti plagiare da questa società maschilista, che santifica la concorrenza
sleale tra i sessi fingendo equità, mentre una donna deve sentirsi in colpa se
desidera un figlio, se vuole stare più di tre mesi dopo il parto accanto alla
prole, se intende allattare al seno. Un sistema che ciarla di famiglia ma non la
favorisce in nessun modo, tanto ci pensano le madri (ed i padri che “aiutano in
casa”: ma che vuol dire?! La casa è della famiglia, io aiuto me stesso!); che
non tollera la depressione post partum, che non si sforza di comprendere le
crisi chimiche che avvengono nei loro corpi; che, invece di affermare: “Sì,
uomini e donne sono diversi, ma proprio fisicamente: teniamone conto per una
vera parità!”, strombazza: “Viva la parità! Uomini e donne sono uguali!”, e poi
chi s’è visto, s’è visto. Però, poi, questa società s’interroga per quale
ragione, invece di fare figli, quelle ingrate “rubino” i posti di lavoro agli
uomini – con un terzo dello stipendio in meno, però! Io sono un maschilista.
Potrei dire pentito, ma sarebbe riduttivo: sono un maschilista che prova ad
immedesimarsi. Ma mica ci riesco sempre: ad esempio, vorrei rinchiudere in una
torre altissima tutto il gentil sesso a distanza di cento metri da me durante le
partite del Napoli. Giusto per un paio d’ore, beninteso. E reclamo il mio
sacrosanto diritto di fare battute sui tic e le nevrosi femminili! Ma, al
contempo, devo ammettere che, nei miei geni, drogati da millenni di spaventosa
disparità di genere, qualcosa mi suggerisce cose del tipo che sarebbe un mio
diritto naturale trovare il polpettone e le pantofole pronte quando torno a
casa, mia moglie perfettamente truccata e pettinata e i bambini a letto, come in
un film degli anni cinquanta. E pazienza se non c’è la doppia entrata e se
accanto avrò una persona insoddisfatta: vuoi mettere, il polpettone?! Però io,
almeno, lo so che nasco maschilista, e non è mica colpa dei miei genitori.
Riconosco che devo fare uno sforzo, provo ad essere uno di quei “consapevoli”
che invocava Barbero; soprattutto, ho capito – ed è questo il punto dolente –
che noi uomini dobbiamo tutti smetterla di fingere di essere naturalmente
paritari ed ecumenici, ammettere che nasciamo maschilisti, fare qualcosa di
concreto per ribellarci a questa impronta genetica e cambiare le cose, a partire
dagli atti più semplici. Il primo dei quali è la consapevolezza. Senza
rinunciare alle battute, però. Quelle, lasciatemele. Sennò rinuncio.
Dagotraduzione da Study Finds il 21 ottobre 2021.
Secondo un sondaggio su più di duemila americani, gli uomini piangono in media
quattro volte al mese, 48 in un anno. Le donne, invece, tre volte al mese (e 36
in un anno). Anche lo stereotipo secondo cui gli uomini non cercano un aiuto
professionale per la loro salute mentale non sembra proprio centrato: due terzi
degli intervistati maschi si è rivolto a una specialista quando ne ha avuto
bisogno, mentre solo la metà delle donne si è fatto aiutare. Il sondaggio,
condotto da OnePoll per conto di Vida Health, ha confermato che quasi il doppio
degli uomini (il 63%), rispetto alle donne (il 34%), tende a nascondere il fatto
che si sta facendo aiutare. Gli uomini ammettono che proverebbero imbarazzo
(50%), vergogna (40%) o paura (39%) se le persone a loro vicine scoprissero che
stanno andando in terapia. Al contrario, solo il 23% delle donne intervistate
proverebbe imbarazzo, il 17% vergogna e il 16% paura. Questi sentimenti di
vergogna potrebbero essere il motivo per cui gli uomini che sono in terapia
hanno ammesso di fare abuso di alcol (49%), sostanze (40%) o di praticare
autolesionismo (35%). Comportamenti meno comuni tra le donne. Solo il 27% ha
riferito di abusare di alcol, il 23% di sostanze e il 20% di fare ricorso
all’autolesionismo. Solo il 32% di tutti gli intervistati è d’accordo sul fatto
che gli uomini sono più emotivi e hanno quindi più possibilità di soffrire di
salute mentale. Il 55% infatti che le donne abbiano sistemi di supporto migliori
rispetto agli uomini, e quindi maggiori probabilità di ricevere aiuto per la
salute mentale. «Sappiamo che per molti uomini essere additati come vulnerabili
e in cerca di aiuto è uno stigma» ha detto Mark Hedstrom, direttore esecutivo
statunitense di Movember, in una dichiarazione. «Come società, dobbiamo
abbattere queste barriere e aiutare gli uomini a capire l'importanza di aprirsi
e ricevere aiuto durante i momenti difficili. Dobbiamo anche prenderci cura
l'uno dell'altro. Controllate gli uomini nella vostra vita: potrebbero
letteralmente essere una conversazione che salva una vita». Nel complesso, quasi
i due terzi degli intervistati concordano sul fatto che c'è ancora uno stigma
che circonda le persone che desiderano aiuto per la loro salute mentale: il 61%
delle donne e il 69% degli uomini. Indipendentemente dal genere, il 40% del
sondaggio ritiene che gli uomini abbiano maggiori probabilità di affrontare
questo stigma, rispetto al 34% che pensa che le donne abbiano maggiori
probabilità di affrontarlo. È interessante notare che il 43% dei baby boomer (57
anni e oltre) pensa che gli uomini debbano affrontare uno stigma sulla salute
mentale, ma solo il 15% di loro pensa che sia probabile che le donne lo
facciano. La fonte di quello stigma? Entrambi i sessi dicono che il più delle
volte sono i loro amici e la loro famiglia. Gli uomini credono che gli amici
abbiano molte più probabilità di stigmatizzarli (19%), mentre solo il 13% delle
donne dice lo stesso. «Negli ultimi due anni abbiamo fatto enormi progressi nel
destigmatizzare i disturbi della salute mentale, ma c'è ancora tanto lavoro da
fare, specialmente per gli uomini», aggiunge Chris Mosunic, PhD, Chief Clinical
Officer di Vida Health. «Così tanti uomini sentono il bisogno di tenere i propri
sentimenti per sé, nascosti e protetti, altrimenti verranno etichettati come
deboli e inferiori. In realtà, comprendere quei sentimenti, abbracciarli e
cercare l'assistenza che può aiutarli a sentirsi meglio è solo la cosa più
coraggiosa e più forte che una persona possa fare».
Roberto D’Agostino
per vanityfair.it il 28 agosto 2021. Ricordate? Un tempo la terra era infestata
da curiose creature chiamate uomini. Ai tempi delle nostre nonne i maschietti
scorrazzavano liberamente diffondendo i loro sozzi costumi, le loro esigenze
senza limiti, la loro spietata libidine. Poi, la favola è finita. Il femminismo,
le pari opportunità, Metoo, hanno seminato in ogni dove mine anti-uomo. Tagliano
il pene, rubano il seme, fanno le iene. Pensate alle cose che i maschi fanno
bene, oggi: moda, cucina, arredamento, acconciature. Alle Olimpiadi di Tokyo un
atleta americano è stato sorpreso a fare l’uncinetto. Sono tutte cose da
ragazze. E le donne non se ne innamorano perché sono come amiche con qualche
attributo in più. Una volta bocciato il quarantenne perché portatore sano di
depressioni varie; al bando il trentenne perché carrierista-onanista; al diavolo
il cinquantenne coll'acido glicolico a fior di pelle e abitini da fighetto
informato; lasciamo infine perdere i giovani, anche tatuati a cimitero e rapati
a zero, per i quali il sesso non riscuote grande importanza, anzi lo trattano
come cosa tarlata, anche faticosa da trattare, e preferiscono la cannabis del
sabato sera ad una serata scostumata, che cosa resta? Via via, gli unici uomini
rimasti credenti, adepti indefessi all’"urlo della carne", sono i vecchi. Essì,
grazie al cielo, si fanno avanti sessantenni spennacchiati più vicini
all'attualità della prostata che al passato di Proust, settantenni che hanno
sostituito la canottiera con una fascia Gibaud, ottantenni in preda all’overdose
di Viagra. Ecco il “Rara avis”, locuzione latina che significa “uccello raro”,
che crede ancora che la scopata sia mitologica. E voilà si spalancano di nuovo
gli anni beati dei cavernicoli del maschilismo con la libido negli occhi,
dell'"omo è omo e fa banco", che se ne sbatte della riforma pensionistica,
affaccendato solo dalla forma dell'amante. Il vecchiettino ammaccato dal Tempo
crudele, divo di anzianità modello "paziente del dottor Lombroso", che resiste
in tempi di eroi kitsch con il telefonino, si chiama Keith Richards. Per
resistere al logorio dei Rolling Stones, il leggendario mito della vita
spericolata degli anni Sessanta (in poi), icona del binomio “genio e
sregolatezza”, ammise qualche anno fa “Con tutto quello che mi sono fatto,
(compreso uno spinello con le ceneri del padre, ndr), è un miracolo che io sia
ancora vivo”. Stacco violento da quella tipologia rappresentata dai matusa di
una volta, che intristivano ammuffiti accanto al focolare coniugale, mischiando
le carte per l'ennesimo "solitario". Keith Richards e il suo compagno di
vagabondaggi sessuali Mick Jagger, come Highlander sembravano aver raggiunto
l'immunità anagrafica. Forever Young, tra lenzuola di raso nero e champagne nel
secchiello d'argento: stakanovisti del canapé che potevano scegliersi il sesso
preferito e nel numero desiderato. Ma, una volta approdato alla venerabile età
di 77 anni, Keith Richards è costretto ad ammettere di aver perso il suo vigore
fisico ma lo fa con irresistibile spirito: “Fare sesso alla mia età è molto più
eccitante, non puoi mai sapere se stai per avere un orgasmo o un infarto…”
Quirino Conti per Dagospia il 23 agosto 2021. Per
una giovane anima bella residualmente ancora appassionata di Stile (quale
drammatica intempestività!), sarà davvero difficile immaginare le gigantesche
moli di documentazione che anno dopo anno, con continuità, sono state
collezionate da quanti, per vizio o per mestiere, la Moda l’hanno praticata.
Migliaia di faldoni e testi di ogni genere che, per i più prodighi e assatanati
– come nel caso dell’intossicato Karl Lagerfeld –, arrivavano a vere cubature di
materiale cartaceo in ogni idioma possibile: quando la Moda sembrava essere il
nuovo oppio dei popoli e divini parevano coloro che la maneggiavano. Un
accumulo, dunque, depositato in decenni di “mascherature” di ogni genere,
cristallizzato in stratificazioni per ere e cicli. Poi, il virus. E quel colto
arredo da bibliofilo, per pura disperazione (dopo che si era letto di tutto,
persino Le Noeud de vipères del mitico Mauriac), finì per attrarre con il
fascino di un deposito arcano: sperando in chissà cosa, come fossero tavolette
ittite contenenti una criptata Verità. Per le scaffalature “de mulieribus”,
niente di nuovo. Tutto come da copione, essendo argomento consolidato e con
ritualità immutabili da qualche centinaio di anni. Fino a un certo appuntamento
con il destino, corrispondente più o meno alla Milano socialista e gaudente. Lì
tutto sembrò impazzire con pagine di un servilismo ignobile, a vantaggio della
più cinica volgarità: persino la grafica parve dover mutare, con rozzi
citazionismi per quanti non miravano che al più classico business pubblicitario.
Tanto che finanche Armani, il Magnifico, in quel cumulo di ignominie sembrò un
innocente catechista che ancora si interroghi sul sesso degli angeli. Comunque,
con Prada si trovò l’antidoto: tanto severo e amaro, quanto velenosa era stata
quell’ubriacatura. Infine l’ultimo Gucci, e le pagine si fecero concettualmente
severissime, come composte da un filosofo nichilista. Fu così che, da una
stagione all’altra, tanti “nomicchi” sparirono da quei cataloghi patinati dopo
aver impiastricciato di sciocchezze il proprio ciclo da epigoni. Spariti, persi
nel nulla. Irrintracciabili. Il bello – si fa per dire – arrivò alla
scaffalatura con la scritta “de viribus”. Mai recensiti prima in tali dimensioni
– e dunque dentro un linguaggio sperimentale quanto mai ambivalente, se si era
abituati a schiere di maschi in sobrie parate militari e virilissimi spiegamenti
sportivi –, qui la migliore gioventù era catturata dentro schemi formali da
cataloghi di sfrontata esibizione sessuale. Con branchi di ragazzotti
riconoscibili, sempre loro, stagione dopo stagione, tanto estranei a un ruolo
almeno simmetrico a quello femminile, quanto perfettamente a proprio agio solo
nella ridanciana, immatura allusione al più torbido lenocinio. Da secoli
superata l’idea di modelle come merce facile, e ormai levigate dai Grandi come
creature perfette simili a porcellane (anche nei cicli più trash), restava per
il maschio all’alba degli anni Novanta la solitudine di una fisionomia sul bordo
di un meretricio a qualche centinaio di migliaia di lire; convinti dallo
stilista (finalmente padrone di così tanto materiale maschile) a inimmaginabili
trasposizioni, sottoposti a ogni angheria estetica, eccole lì, queste giovani
prede, ad ammiccare sorrisi e piccoli bronci con barbe mal rasate (se a
beneficio di una collezione machista) o penose depilazioni (quando aspiranti al
femminino). Passivi, immobili nel cuore, persino nell’assoggettarsi a parti e
ruoli imposti dal direttore artistico di turno, parti e ruoli peraltro recitati
da cani, come un tormento per quel che restava della loro dignità. Ilari per
contratto (una incontenibile stilista era terribilmente severa su queste forzate
risate a comando), in una bellissima età devastata brutalmente senza ombra di
futuro. Gentili fino all’affettazione pur di poter lavorare, mentre il créateur,
nell’uscita finale, con un buffetto troppo promiscuo esprimeva tutto il suo
potere su quell’harem di guitti arrivati da ogni parte del mondo. Una stagione
dopo l’altra se ne riconoscono ancora nomi e lineamenti: questi, ma anche
quelli, sciupati dalla stanchezza e da un uso che non perdona. Ma chi erano
davvero? Cosa li portava in quegli anni in certe agenzie per poche lire, cosa ne
sarà stato di loro? Per le modelle, la leggenda vuole che ci sia quasi sempre un
buon futuro all’orizzonte. Ma per loro? Cosa può essere garantito a questi
innocenti portatori di ridicolaggini estetiche dopo quel quarto d’ora di
passerelle, sudaticci e con problemi di alloggio? Neppure, salvo gli Armanoidi,
tutelati dalla qualità delle immagini, sciatte e volgari per il tocco decisivo
dell’immancabile proprietario del marchio, che mai avrebbe rinunciato al
massacro di una sua già spietata creazione: specie in zona inguinale o in
immancabili mutande (frequentatissima l’ideona di una rosa rossa tra le labbra).
Comunque, se mai il tempo conserverà queste costose pagine, quale strazio per i
nostri eroi di un momento: che conobbero un’epoca di invidiati stilisti e ora
devono ritrovarli come imperdonabili paraninfi.
Dagotraduzione dal Daily Mail il 27 giugno 2021.
Sei incastrato in un matrimonio che non ti soddisfa? Secondo i ricercatori
israeliani devi correre ai ripari quanto prima per non rischiare una morte
precoce. Analizzando oltre 30 anni di dati sanitari, un team di ricercatori
dell’Università di Tel Aviv ha analizzato i decessi e le cause della morte di
10.000 uomini israeliani. Risultato: quelli che erano infelici del loro
matrimonio, o percepivano la loro unione come un male, hanno aumentato la loro
probabilità di morire per condizioni cerebrovascolari (CVA), come l’ictus o il
blocco delle arterie, del 69,2% rispetto a quelli che erano felici del loro
matrimonio. Se si considerano tutti i casi di morte prematura tra gli uomini, il
tasso di morte è stato del 19% più alto negli uomini che hanno affermato che il
loro matrimonio era insoddisfacente. Gli autori dello studio affermano che le
autorità sanitarie dovrebbero promuovere la terapia matrimoniale come un modo
per migliorare la salute degli uomini e aiutarli a vivere più a lungo. «Il
nostro studio mostra che la qualità del matrimonio e della vita familiare ha
implicazioni sulla salute per l'aspettativa di vita», ha detto l'autore dello
studio, il dottor Shahar Lev-Ari. «Gli uomini che hanno riferito di aver
percepito il loro matrimonio come un fallimento sono morti più giovani di quelli
che hanno vissuto il loro matrimonio come un grande successo». Come parte dello
studio, i ricercatori hanno condotto analisi statistiche in un database che ha
iniziato a raccogliere dati negli anni '60. Per 32 anni hanno monitorato la
salute e il comportamento di 10.000 uomini, tutti dipendenti statali israeliani,
prestando molta attenzione alla morte per ictus. All'inizio dello studio, la
maggior parte dei partecipanti aveva 40 anni e da quando è iniziato negli anni
'60 un totale del 64 per cento è morto a causa di una serie di malattie.
«Volevamo analizzare i dati raccolti longitudinalmente utilizzando vari
parametri per identificare i fattori di rischio comportamentali e psicosociali
in grado di predire la morte per CVA e la morte prematura per qualsiasi motivo»,
ha detto Shahar Lev-Ari. All'inizio dello studio lungo 32 anni, ai partecipanti
è stato chiesto di classificare il loro livello di soddisfazione del matrimonio
su una scala da 1, molto successo) a 4, senza successo. In altre parole, il
livello di soddisfazione per il matrimonio è emerso come un fattore predittivo
dell'aspettativa di vita ad un ritmo paragonabile al fumo e all'attività fisica.
Durante i 32 anni di follow-up, 5.736 soggetti sono morti e 595 sono morti per
ictus. I tassi di mortalità per ictus sono stati del 24% per i più felici e del
40,6% per i meno soddisfatti, con un aumento del 69,2%.
"Perché una donna evira un uomo".
Sofia Dinolfo l'1 Maggio 2021 su Il Giornale. Nella storia
della cronaca nera, ci sono stati diversi casi di evirazione che si sono
consumati per gelosia dopo un tradimento. La criminologa e psicologa Flaminia
Bolzan spiega cosa accade in questi casi. Ha tagliato i genitali al
fidanzato 52enne perché pensava che la stesse tradendo. Un atroce gesto compiuto
la notte del 6 marzo scorso a Taiwan da una 40enne la quale, impugnando delle
forbici, ha reciso il 20% dei genitali della vittima. Un atto compiuto per
vendetta e che ha compromesso definitivamente la vita sessuale dell’uomo. Non è
questo il primo caso in cui per vendetta sentimentale gli uomini sono stati
vittime di evirazione. Uno dei fatti più eclatanti a livello giudiziario e
mediatico è stato quello che ha avuto come protagonista nel 1993 in Virginia
Lorena Bobbitt. La donna, all’epoca 23enne, per vendicarsi del marito violento,
gli ha reciso il pene con un coltello da 18 centimetri. Negli anni successivi in
più parti del mondo non sono mancati altri casi. I più recenti sono quelli che
si sono verificati a Bangkok il 3 luglio del 2018, in Taiwan il 29 luglio del
2019 e in Thailandia il 17 luglio del 2018. Unico movente in questi casi la
gelosia per aver subito dei tradimenti. Senza andare lontano, in un comune
milanese nel dicembre del 2018, una moglie ha minacciato il marito di
evirazione dopo che lo ha scoperto a chattare con diverse donne. Per lo stesso
motivo gli aveva rotto in precedenza il setto nasale. Vi è stato poi un caso a
Genova, nel 2008, dove a commettere il folle gesto, è stata l’amante di un uomo
colta da rabbia perché lui non si decideva a lasciare la moglie. Di questa forma
di vendetta, particolare nel suo genere, parla a IlGiornale.it la criminologa e
psicologa Flaminia Bolzan.
Perché ricorrere a forme di vendetta di questo
tipo?
"Perché nel momento in cui ci si sente lesi,
subentra la necessità psicologica di vendicarsi pareggiando un danno o un
oltraggio che si ritiene di aver subito".
Perché lasciare questo segno indelebile nei
confronti della vittima?
"È abbastanza evidente che si tratta di donne che
si sono sentite danneggiate in quanto tradite, che hanno ipotizzato o comunque
hanno avuto certezza del coinvolgimento sessuale del proprio partner con altre
ragazze. Quindi la vendetta si è orientata sulla volontà di privare l’uomo della
possibilità di porre in essere un nuovo tradimento, perché con l’evirazione il
danno principale è l’impotenza".
La rivelazione di Lorena Bobbitt: "Ecco perché
evirai mio marito"
In che modo il tradimento subito, unito alla
gelosia, possono far scattare una scintilla così forte?
"In questi casi siamo in presenza di personalità
molto disarmoniche perché altrimenti sarebbe molto complesso ipotizzare che
tutte le donne tradite agiscano in questo modo. Si tratta di donne che non sono
in grado di elaborare sul piano mentale il significato dell’aver subito un torto
e quindi agiscono danneggiando l’altro in maniera importante".
Che personalità si cela nelle persone che si
vendicano in questo modo?
"È necessario effettuare un’analisi caso per caso.
Ognuna di loro ha sicuramente delle problematiche nella gestione della
frustrazione, delle emozioni e dei sentimenti negativi conseguenti al torto
subito".
I vari casi di evirazione per vendetta hanno
qualcosa in comune?
"Sicuramente il tradimento. Il tradimento è una
delle principali cause che porta la donna a compiere questi gesti".
Quali possono essere le conseguenze psicologiche
per la vittima?
"Le conseguenze sono piuttosto gravi.
L’impossibilità di vivere l’intimità in maniera normale è un danno che porta a
conseguenze di non poco conto, anche in considerazione di una relazione
sentimentale con una nuova partner in un momento successivo".
Da donnaglamour.it il 24 aprile 2021. Parlare di
sesso tra amiche è più che normale, specialmente quando si è molto in intimità
oramai da lunghissimi anni. Le donne amano raccontare e condividere le loro
esperienze con le loro più carissime amiche e quando lo fanno non si lasciano
sfuggire niente. Infatti, quando una donna va a letto con un uomo, solitamente
la prima cosa che fa dopo averlo salutato è chiamare le sue amiche. Un incontro
last minute, davanti ad un caffè, ecco che anche loro scopriranno com’è
quell’uomo sotto le lenzuola!
Cosa si raccontano le donne? Niente sarà
tralasciato e ogni minimo particolare di quella notte di fuoco verrà raccontata
davanti a quelle tazze di caffè? Ecco cosa si dicono le donne tra di loro quando
parlano di sesso!
– Com’è stato? La prima domanda che probabilmente
si sentono chiedere è proprio questa ed è l’inizio di un lungo e intenso
monologo…
– Le dimensioni. Ovviamente impossibile non
condividere le dimensioni dell’uomo con cui si è stati a letto e se la donna non
ne è rimasta soddisfatta, probabilmente il suo racconto sarà più lungo del
solito…
– Ma è stato bravo? Molto differente dalla prima
domanda, perché anche se è stato bello ovviamente tocca capire se lui è stato
effettivamente bravo e ci ha saputo fare. Con questa domanda non si intende se è
stato bravo a fare coccole e carezze, ma se con i preliminari ha dato il meglio
di sé. Perché è risaputo che anche i preliminari vogliono la loro parte!
– E l’orgasmo? Vuoi non raccontare alle più care
amiche se l’orgasmo è stato raggiunto anche da te? Un punto fondamentale da
sapere e capire sin da subito se sia stato davvero bravo a letto!
– Imprevisti. Se c’è stato qualche problema o un
imprevisto sicuramente verrà raccontato anche questo: insomma, le donne non si
lasciano scappare proprio niente!
Anna Franco per “il Messaggero” il 18 aprile 2021.
IL CASO In un mare di dubbi c'è un punto fisso:
l'uomo nudo è un tabù. Oggi come ieri. Pochi giorni fa Valentino ha pubblicato
su Instagram un'immagine della sua campagna. In posa, in un autoscatto, il
modello e fotografo ventisettenne Michael Balley-Gates.
Lunghi capelli biondi che scendono sulle spalle,
una posa sinuosa da discobolo dell' antica Grecia, ha indosso (per la
precisione, sorregge con un piede) solamente una borsa della collezione Roman
Stud della casa di moda, il resto del corpo è senza veli. In un attimo è
scandalo: sotto la foto fioccano commenti violenti, inorriditi e adirati per la
scelta di un mood maschile che di maschile, secondo i detrattori, ha ben poco.
Nella questione deve intervenire anche il direttore creativo della maison,
Pierpaolo Piccioli, sottolineando quanto un vecchio adagio già aveva tentato di
insegnare, cioè che la malizia è negli occhi di chi guarda. «Il mio compito - ha
affermato - è fornire la mia visione della bellezza in base al tempo che stiamo
vivendo e ciò che consideriamo bello è un riflesso dei nostri valori. Stiamo
assistendo a un grande cambiamento del genere umano. L' evoluzione è possibile
se l' uguaglianza è possibile, se l' inclusività è possibile, se i diritti umani
sono difesi e se la libertà di espressione è protetta e incentivata. Dobbiamo
condannare ogni forma di violenza, odio, discriminazione e razzismo».
L'ANTESIGNANO Da tempo, del resto, lo stilista si
batte per una moda che sia, prima di un modo di vestire, un modo di essere e di
esprimersi, liberi e consapevoli delle proprie scelte e delle proprie emozioni,
al di là di classificazioni, razze e di una sessualità binaria. Eppure la storia
sembra ripetersi. Nel 1971 Yves Saint Laurent posò nudo per la campagna del suo
profumo Pour Homme. In seguito, il suo partner di affari e di vita Pierre Bergé
affermò che quella foto divenne molto dopo «mitica, ma all' epoca non venne
quasi pubblicata, se non da qualche giornale francese». Pudori e raccapriccio
accolsero anche un altro profumo della stessa casa, YSL M7, nel 2002. La
pubblicità ideata dall' allora direttore creativo Tom Ford mostrava un nudo
frontale maschile. Lo stilista americano oggi afferma: «Amo il corpo umano, che
sia di donna o uomo. Lavoro per cercare di migliorarlo, quindi spesso mostro una
sua buona parte o i suoi contorni e le persone lo equiparano a qualcosa di
sessuale, ma non ho alcun problema con la sessualità e coi corpi nudi e non mi
spaventano.
Nella nostra cultura spogliamo le donne per
vendere di tutto, non c' è problema nell' oggettivarle, ma la nudità maschile ci
sfida e ci innervosisce». Quando la rivista Cosmopolitan, nel 1972, provò a
rendere il maschio un oggetto, nello specifico l' attore Burt Reynolds nella
paginona centrale senza veli, la cosa non fu presa bene. Così come destò
scalpore la sfilata di Rick Owens nel 2015 dove era chiaro che i modelli, sotto
le loro tuniche primordiali, non indossassero alcun indumento intimo. «L'
autoritratto di un ragazzo nudo oggi non dovrebbe in alcun modo rappresentare
uno scandalo - interviene Alessandro Dell' Acqua, fondatore e direttore creativo
di N21 - Col mio lavoro ho sempre cercato di definire una fisicità che esprima
una sensualità intuita, tra pudore e voglia di farsi notare. Mai volgare. Per me
è fondamentale dare la possibilità a donne e uomini di rappresentarsi come
vogliono essere. E la fisicità esprime un' esigenza come un' altra di comunicare
se stessi». Ma spesso sono le abitudini mentali a non mutare, a dispetto dei
cambiamenti nel mondo. «Basti pensare che dall' Ottocento fino al secondo
dopoguerra chi possedeva immagini di uomini nudi era passibile di arresto -
racconta Leonardo Iuffrida, saggista e autore del volume Il Nudo Maschile nella
Fotografia e nella Moda (edizioni Odoya) - Il maschio aveva bisogno del vestito
e di un comportamento aggressivo per identificarsi e per ribadire il suo status.
Negli anni Ottanta, si è passati dall' esibizione del vestiario a quella di un
corpo, sì spogliato, ma coi muscoli scolpiti ben in mostra, che sottolineavano
l' appartenenza a un genere pur sempre ritenuto dominante. Adesso che la
pubblicità di Valentino cancella tutto questo e mostra come l' uomo possa usare
il suo corpo in maniera più fluida, saltano tutti gli ingombranti stereotipi
patriarcali».
I SISTEMI SIMBOLICI «E ciò ad alcuni fa paura e
porta a commenti violenti - riassume Riccardo Notte, professore di antropologia
all' Accademia di Belle Arti di Brera - Del resto, il corpo è da sempre un campo
semantico sul quale si giocano infinite battaglie politiche, culturali e
sociali, che mutano a seconda delle culture. L' ambiguità fa sì che i
tradizionali sistemi simbolici si trovino a essere in particolare tensione tra
loro».
·
A
morte i Padri.
Jessica d'Ercole per “La
Verità” il 26 giugno 2021. «Per me bambino, tutto quello che mi ingiungevi era
senz'altro un comandamento dal cielo, non l'ho mai dimenticato, diveniva il
metro determinante per giudicare il mondo. Non era permesso rosicchiare le ossa,
ma tu lo facevi. Non era permesso assaggiare l'aceto, ma tu potevi. A tavola si
doveva solo mangiare, ma tu ti pulivi e ti tagliavi le unghie, facevi la punta
alle matite; tu, l'uomo che ai miei occhi rappresentava la massima autorità, non
ti attenevi alle ingiunzioni che mi avevi imposto», scriveva Franz Kafka in
Lettera al padre, aggiungendo con sarcasmo: «Se al mondo ci fossimo stati solo
noi due [], la purezza del mondo sarebbe finita con te, e con me sarebbe
cominciata la sporcizia». Onorare il padre e la madre non è facile per tutti.
Come scriveva Lev Tolstoj in Anna Karenina: «Tutte le famiglie felici si
assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo». Per cui ci
sono figli che rinnegano i genitori perché da loro si sono sentiti non amati,
traditi o addirittura sfruttati. Jackie Coogan, il monello che accompagnava
nell'omonimo film del 1921 Charlie Chaplin, i suoi li portò in tribunale perché
sperperarono i 4 milioni che lui guadagnò principalmente grazie a quella
pellicola. Dopo una causa infinita Coogan riuscì a ottenere solo 126.000 di quei
dollari ma, in California, il suo nome venne dato a una legge, il Coogan act,
una norma a tutela dei guadagni degli attori bambini. Peggio andò a Gary Coleman
che vide i genitori adottivi, in combutta con il suo manager, dilapidare tutti i
suoi compensi. Solo per Il mio amico Arnold prendeva 100.000 dollari a episodio.
Adottata fu anche Christina Crawford che aveva un pessimo rapporto con la madre
Joan. Nel suo memorabile libro Mammina cara - divenuto poi un film con Farrah
Fawcett - la giovane Crawford descrive la famosa attrice come una mamma,
violenta e alcolizzata, interessata più alla sua fama che ai propri figli.
Sostiene di non essere stata adottata per amore, ma per una trovata
pubblicitaria: «Una volta tentò di strangolarmi». Dopo la pubblicazione le due
non solo non si parlavano più ma Joan ha escluso lei e suo fratello dal
testamento milionario. Odiava suo padre Danny Quinn, settimo figlio di Anthony,
secondo della costumista italiana Jolanda Addolori. Nel 1997 dichiarò: «È un
mostro. Sì, per anni l'ho odiato, sognavo di ammazzarlo, di spaccargli una
grossa pietra in testa, di dargli fuoco». E poi: «Non parlo con mio padre da tre
anni esatti. Ho troncato ogni rapporto, siamo due persone completamente diverse,
con due strade diverse. Non c'è nessuna speranza di dialogo né di nient' altro
tra noi due», ha ripetuto poco prima del 2001, anno della morte di Anthony
Quinn. Non onora il padre pure Angelina Jolie, figlia di Jon Voight. I due non
si sono parlati per 10 anni dopo la morte della mamma, Marcheline Bertrand,
scomparsa nel 2007. Poi dopo una lunga terapia la Jolie decise di perdonarlo per
amore dei suoi figli: «Hanno bisogno di conoscere il nonno», salvo poi
ricredersi e continuare a litigare con il padre via social. Come lei suo figlio
Maddox ha rinnegato il padre Brad Pitt, e, sempre come lei, ora vuole cambiare
il cognome in Jolie. Infelice fu l'infanzia anche della prima moglie di Brad
Pitt, Jennifer Aniston. Nel 1999 con il libro From Mother and Daughter to
Friends la figlia si è scagliata contro i genitori: «Erano crudeli e mi hanno
sempre fatta sentire una nullità». L'attrice ha puntato il dito contro Nancy
Dow, sua madre, solita descrivere nei dettagli ogni suo difetto: «Per mia madre
io ero sbagliata in tutto». Si sentiva invece tradita dai suoi, entrambe drogati
e alcolizzati, Demi Moore. Nell'autobiografia Inside out racconta che da ragazza
fu violentata, e che il molestatore, dopo aver fatto i suoi comodi, le disse:
«Come ci si sente a essere fottute per 500 dollari?». La Moore si dice convinta
che non ci fu una transizione economica ma che la madre semplicemente gli
accordò il corpo della figlia quindicenne: «Fu un tradimento devastante,
impossibile da perdonare». Genitori alcolizzati anche per Drew Barrymore: «I
miei non sono mai stati lì per me, erano assenti, non riuscivo a gestire i miei
problemi». Il padre era sempre ubriaco e la madre, quando non trascorreva le
serate di festa in festa, le passava a vendere gli effetti personali della
figlia star su Ebay. Così a 12 anni la piccola Barrymore era dipendente da alcol
e droghe, a 13 era in un centro di riabilitazione, a 15 in tribunale per
chiedere l'emancipazione. Altra star che ha chiesto l'emancipazione è Macaulay
Culkin, l'indimenticabile protagonista di Mamma ho perso l'aereo. Sfruttato dai
suoi - lo obbligarono a girare 15 film in sette anni - con il solo scopo di
mettere le mani sul suo patrimonio da 17 milioni di euro. Il tribunale lo
obbligò a restare con la mamma ma i suoi denari furono custoditi dal contabile
di famiglia. Quando se ne appropriò però li dilapidò in alcol e droghe e solo
dopo dieci anni e un percorso di analisi è tornato al cinema. Ha portato suo
padre in tribunale anche Meghan Markle. Alla duchessa del Sussex non è andato
giù che lui pubblicasse una lettera di lei sulla stampa britannica. È da allora
che i due non si parlano più, lui non è stato invitato né al matrimonio reale né
per la nascita di suo nipote. Ma le cose non stanno andando meglio neanche al
marito, Harry d'Inghilterra, che a quanto ha dichiarato nelle sue interviste a
Oprah Winfrey dopo aver divorziato dalla casa reale, ha inveito contro
l'educazione glaciale di corte che a suo dire gli fu inferta dal padre, il
principe Carlo. Crescita anaffettiva anche per lo scrittore Michele Mari, figlio
del grande designer Enzo Mari, che per tutta la vita ha avuto un rapporto
difficile con un padre «spartano, intransigente, drastico, dogmatico. Un
carattere impossibile, incapace di dialogare. Se volevo sopravvivere dovevo
nascondermi in me stesso []. Da piccolo sognavo che si aprissero delle botole
che lo inghiottivano. Era il sogno di un bambino angosciato», senza però mai
rinnegarlo davvero: «Credo però di averlo anche amato molto, con un sentimento
per me irrisolto». Freddo e impassibile nei confronti dei figli era Joe Jackson,
papà di Michael: «Un padre attento, più di ogni altra cosa, al nostro successo
commerciale». Ma da piccolo il re del pop voleva solo un papà che gli
dimostrasse amore, «e mio padre non l'ha mai fatto. Non mi ha mai detto ti
voglio bene guardandomi negli occhi, non ha mai giocato con me. Non mi ha mai
portato a cavalcioni, non mi ha mai buttato un cuscino o un palloncino d'acqua».
Per anni il rapporto fra i due fu impossibile ma alla fine Michael lo perdonò:
«Col tempo, l'amarezza ha lasciato il posto alla grazia. Più che rabbia, sento
assoluzione, più che una rivincita voglio riconciliazione. E la rabbia iniziale
ha lasciato il posto al perdono». Ed è proprio questo, secondo papa Francesco,
lo spirito del quarto comandamento. Onorare il padre e la madre anche se questi
non sono perfetti perché dice il Pontefice: «Può essere facile, spesso, capire
se qualcuno è cresciuto in un ambiente sano ed equilibrato. Ma altrettanto
percepire se una persona viene da esperienze di abbandono o di violenza. La
nostra infanzia è un po' come un inchiostro indelebile, si esprime nei gusti,
nei modi di essere, anche se alcuni tentano di nascondere le ferite delle
proprie origini. Ma la Quarta Parola dice ancora di più. Non parla della bontà
dei genitori, non richiede che i padri e le madri siano perfetti. Parla di un
atto dei figli, a prescindere dai meriti dei genitori, e dice una cosa
straordinaria e liberante: anche se non tutti i genitori sono buoni e non tutte
le infanzie sono serene, tutti i figli possono essere felici, perché il
raggiungimento di una vita piena e felice dipende dalla giusta riconoscenza
verso chi ci ha messo al mondo».
Dagotraduzione da Study Finds il 21 giugno 2021.
L'infertilità maschile colpisce oltre 20 milioni di uomini in tutto il mondo. È
la causa di circa la metà dei casi di infertilità tra le coppie che desiderano
concepire un bambino. Ora, un nuovo studio sta facendo luce su una mutazione
chiave che danneggia la capacità dell'uomo di riprodursi. Le scoperte rivelano
anche un percorso per correggere il problema e ripristinare la fertilità a
milioni di potenziali genitori. Negli uomini affetti da grave infertilità, si
sviluppano malformazioni nel flagello dello spermatozoo, la coda che è
fondamentale per il movimento. Queste code diventano più corte, irregolari,
arrotolate o addirittura scompaiono del tutto. Quando ciò accade, lo spermatozoo
non può nuotare per raggiungere e fecondare un uovo. Gli autori dello studio del
Guangzhou Women and Children's Medical Center affermano che molte mutazioni
genetiche possono portare a malformazioni dello sperma. Alcuni di questi
problemi genetici colpiscono la guaina che ricopre lo sperma e i mitocondri, che
ne alimentano il movimento. Altri danneggiano la vescicola acrosomiale, una
piccola sacca che rilascia enzimi che consentono a uno spermatozoo di successo
di abbattere il rivestimento esterno di una cellula uovo in modo che possa
iniziare la fecondazione. Per il loro studio, i ricercatori Na Li e Ling Sun
hanno raccolto campioni di sperma da uomini infertili. Hanno identificato un
individuo con più difetti che stavano colpendo i suoi flagelli spermatici. Dopo
aver analizzato questi campioni, il team ha scoperto una specifica mutazione
genetica in una proteina spermatica relativamente sconosciuta: la proteina 2
interagente con la guaina fibrosa (FSIP2). Questa proteina è un componente della
guaina fibrosa dello sperma. «La guaina fibrosa copre le code degli spermatozoi
che si trovano negli esseri umani, nei topi e in altre specie in cui avviene la
fecondazione all'interno del corpo dell'animale», spiega Li in un comunicato
stampa. «Offre alle code dello sperma flessibilità e forza, necessarie affinché
lo sperma nuoti nel mezzo denso e appiccicoso del corpo umano prima di
incontrare l'uovo. È interessante notare che gli animali il cui sperma nuota
nell'acqua perché la fecondazione avviene al di fuori del corpo, come i pesci, o
non hanno la proteina FSIP2 o, al massimo, ne hanno una versione difettosa». Per
studiare questa particolare mutazione e la funzione di FSIP2, i ricercatori
hanno esaminato due gruppi di topi. Un gruppo è stato progettato per avere la
stessa mutazione FSIP2 dell'unico uomo sterile. L'altro gruppo di topi è stato
progettato per produrre più della normale quantità di proteina FSIP2. I
risultati rivelano che anche i topi con la mutazione sono diventati sterili,
proprio come il paziente umano. Il loro sperma conteneva meno spermatozoi vivi e
più della metà non sapeva nuotare correttamente. D'altra parte, i topi che
producono in eccesso la proteina FSIP2 sono rimasti fertili e in realtà hanno
avuto oltre sette volte più spermatozoi super lunghi rispetto ai topi normali.
Gli spermatozoi molto lunghi sono in grado di nuotare più velocemente,
rendendoli più propensi a fecondare un uovo e riprodursi.
DAGONEWS il 25 marzo 2021. La dottoressa Sheanna
Swan, scienziata ambientale, ha parlato nel suo nuovo libro intitolato “Count
Down” dell’impatto dell’inquinamento ambientale sul sistema riproduttivo umano.
In particolare, il libro esamina l’effetto dei ftalati, sostanze chimiche
utilizzate nella produzione di materiali plastici, sul sistema endocrino che
produce ormoni. «Sta nascendo un numero sempre più grande di bambini con peni
piccoli e genitali malformati come conseguenza diretta dell’inquinamento
ambientale» afferma la dottoressa. Le ricerche di Swan sono cominciate con
l’analisi della sindrome da ftalati, inizialmente osservata in topi di
laboratorio: i ricercatori hanno concluso che i feti esposti a questi agenti
chimici presentavano più alte probabilità di avere genitali rimpiccioliti. Negli
umani, inoltre, la dottoressa ha scoperto che i neonati maschi che erano stati
esposti agli ftalati nell’utero avevano una distanza anogenitale più breve, una
misura spesso collegata al volume del pene. I ftalati vengono impiegato nella
produzione industriale per rendere i materiali plastici più flessibili, e la
dottoressa afferma che i bambini vengono esposti agli ftalati tramite il
contatto con cibi e giocattoli. Difatti, i ftalati simulano l’ormone estrogeno,
interrompendo la produzione naturale di ormoni nel corpo umano e causando
un’interferenza nello sviluppo sessuale nei neonati. Uno studio pubblicato nel
2017 ha rilevato che i livelli di sperma negli uomini nei paesi occidentali sono
diminuiti di oltre il 50% negli ultimi quattro decenni dopo aver esaminato 185
ricerche che hanno coinvolto quasi 45.000 uomini adulti sani. Swan ritiene che
il tasso di fertilità in rapida diminuzione significhi che la maggior parte
degli uomini non sarà in grado di produrre sperma entro il 2045.
Dagotraduzione dall'Abc il 21
maggio 2021. Entro poche generazioni il numero degli spermatozoi umani potrebbe
scendere a livelli inferiori a quelli considerati adeguati per la fertilità. Lo
sostiene l'epidemiologa Shanna Swan nel suo libro "Countdown", che raccoglie una
serie di prove a supporto della sua tesi: in 40 anni il numero di spermatozoi
degli uomini occidentali è precipitato di oltre il 50%. Proiettando questi dati
nel futuro, è facile prevedere che dal 2060 i maschi non avranno quasi più
capacità riproduttiva. Le ricerche sul numero degli spermatozoi non sono una
novità. Già negli anni '90 alcuni studi si erano soffermati sul conteggio, ma i
risultati erano stati fortemente criticati per il modo in cui venivano
registrati i conteggi. Così nel 2017, uno studio più approfondito ha provato a
mettere ordine nei dati. Gli scienziati hanno scoperto che tra il 1973 e il 2011
il numero di spermatozoi degli uomini occidentali era sceso tra il 50 e il 60%,
una media tra l'1 e il 2% l'anno. Ed è a questo conto alla rovescia che fa
riferimento il titolo del libro di Shanna Swan. Questo calo ha determinato un
altro fenomeno: l'aumento degli aborti spontanei e delle anomalie nello
sviluppo, come il pene piccolo, l'intersessualità, i testicoli non discesi. Ci
sono molti fattori che possono aver determinato questa tendenza. Dal 1973 ad
oggi il nostro stile di vita è cambiato, sia nella dieta che nell'esercizio
fisico. Ma negli ultimi anni i ricercatori hanno individuato un momento cruciale
per la salute riproduttiva degli uomini: la fase fetale. È durante la «finestra
di programmazione» per la mascolinità - il momento in cui il feto sviluppa le
caratteristiche di genere - che un'interruzione nella segnalazione ormonale ha
un impatto sulle capacità riproduttive. A causare l'interferenza ormonale sono
le sostanze chimiche presenti nei prodotti che utilizziamo tutti i giorni. Sono
loro che impediscono agli ormoni di funzionare correttamente nella fase chiave
del nostro sviluppo. Si chiamano «Interferenti endocrini (EDC)» e sono ovunque:
nel cibo e nelle bevande, nell'aria che respiriamo, nelle creme e nei detersivi.
Hanno natura diversa, possono essere plastiche, pesticidi o additivi chimici,
alcuni sono programmati proprio per agire sugli ormoni, come la pillola
contraccettiva o i promotori della crescita usati negli allevamenti, ma
soprattutto, questi EDC si disperdono nell'ambiente. La madre li trasmette al
feto durante la gravidanza. Anche gli animali sono afflitti dallo stesso
problema: i cani da compagnia, per esempio. Studi sui visoni d'allevamento in
Canada e Svezia hanno collegato i prodotti chimici industriali e agricoli con il
calo degli speramatozoi e lo sviluppo anormale dei testicoli e del pene. Lo
stesso effetto è stato osservato negli alligatori in Florida, nei crostacei come
i gamberetti nel Regno Unito e nei pesci che vivono a valle degli impianti di
trattamento delle acque reflue in tutto il mondo. Anche gli animali che vivono
lontani dalle fonti di inquinamento ne sono vittime: un'orca spiaggiata in
Svezia nel 2017 è risultata uno degli esemplari biologici più contaminati mai
segnalati. In alcuni casi, le anomalie osservate nella fauna selvatica sono
collegate a composti chimici molto diversi da quelli osservati negli esseri
umani. In comune però hanno la capacità di interrompere il normale funzionamento
degli ormoni che determinano la salute riproduttiva. Nel Regno Unito, il
Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali sta attualmente
elaborando una strategia in materia di sostanze chimiche che potrebbe risolvere
in parte questi problemi. L'UE, nel frattempo, sta modificando le normative
sulle sostanze chimiche per evitare che le sostanze vietate vengano sostituite
con altre dannose. In definitiva, la pressione pubblica potrebbe richiedere
interventi normativi più forti, ma poiché le sostanze chimiche sono invisibili -
meno tangibili delle cannucce di plastica e dei camini fumanti - potrebbe
rivelarsi difficile.
Leonardo Di Paco per "la
Stampa" l'1 luglio 2021. Ai giovani chiedete tutto ma non di non mettere su
famiglia o fare figli: uno su due vi risponderà «no grazie». Lo rileva un
sondaggio commissionato dalla Fondazione Donat-Cattin all' Istituto demoscopico
Noto Sondaggi: il 51% dei ragazzi interpellati ammette infatti di non
immaginarsi genitore, il 30% stima che a 40 anni avrà un rapporto di coppia ma
senza figli, mentre il restante 20% pensa che sarà single. Un allarme che la
ministra per la Famiglia Elena Bonetti raccoglie con preoccupazione: «Il tema
della denatalità, della scelta della genitorialità sempre più rimandata, è sia
sintomo che causa di una situazione di difficoltà del Paese. Un Paese che non è
in grado di esprimere una forza giovane, innovatrice, è un Paese che non ha
prospettive di un Welfare sostenibile», spiega la ministra durante un convegno
organizzato a Torino in occasione del trentennale della morte dell'ex ministro e
intitolato, non a caso, "Culle vote". «Dopo l'esperienza drammatica che abbiamo
vissuto questa progettazione del futuro passa dalla possibilità delle persone di
immaginarsi una famiglia. O si cambia il paradigma delle politiche sociali o non
otterremo mai uno sblocco in questo senso», aggiunge la ministra. Nello spiegare
le ragioni per cui faticano a immaginarsi genitori i ragazzi intervistati -
tutti tra i 18 e i 20 anni - parlano di fattori che riguardano la sfera sociale
più che un'avversione netta alla genitorialità in sé. In particolare le
preoccupazioni riguardano la carenza di lavoro (87%), seguita dall' assenza di
politiche adeguate per la famiglia (69%). Una percentuale analoga di ragazzi,
però, parla anche di crisi delle relazioni stabili mentre solo un ulteriore 37%
ritiene i figli un ostacolo in quanto condizionano la vita. In relazione alla
volontà di non avere figli i giovani possono essere divisi in tre categorie,
spiegano i ricercatori: c' è chi ha un atteggiamento definito «narcisista» per
cui ritiene che un figlio, e più in generale legami stabili, limitino la propria
libertà; chi manifesta la paura di non potersi permettere economicamente questa
possibilità e infine chi assicura di non volere figli per mancanza di fiducia
nella società e nel futuro. Un concetto ripreso da Bonetti: «Il tema della
denatalità viene spesso guardato dal punto di vista degli effetti devastanti che
può provocare. Un Paese che non è in grado di garantire una sufficiente presenza
di forza giovane, che è quella che interpreta l'innovazione e le scelte del
futuro, è un Paese che non solo non ha la prospettiva di un welfare sostenibile,
ma che nemmeno può interpretare quel necessario slancio di rinnovamento che di
fatto possa garantire lo sviluppo per tutta la collettività». I timori sui
rischi di un inverno demografico per il nostro Paese, viene ricordato dalla
Fondazione, vennero denunciati proprio da Carlo Donat-Cattin: «Da ministro della
Sanità, lo fece nel settembre del 1986 a Saint Vincent, e già allora sollecitava
un radicale cambio delle politiche per la famiglia. Vedeva l'Italia come un
paese "in scadenza" sulla base di dati che gli aveva fornito il demografo
Antonio Golini». Dati confermati anche dalle proiezioni di alcune compagnie di
assicurazione, che tuttavia furono contestati da alcuni giornali che accusarono
il ministro di nostalgia verso politiche demografiche del ventennio fascista. Le
"culle vuote" di questi anni hanno però confermato le sue previsioni».
Ragazzi sempre meno fertili? Parla
Gianluca Tornese dopo i risultati dello spermiogramma.
Le iene News il 21 marzo 2021. Nel servizio di Aurora Ramazzotti
abbiamo chiesto a 11 influencer di sottoporsi allo spermiogramma, il test che
misura la fertilità maschile. Uno di loro, Gianluca Tornese, ha ricevuto una
brutta notizia e il giorno dopo la messa in onda ne ha parlato in diretta
Instagram con la Iena. “È difficile per me parlarne, mi è caduto il mondo
addosso”. L’influencer Gianluca Tornese parla in diretta Instagram con la Iena
Aurora Ramazzotti dopo il servizio andato in onda venerdì 19 marzo in cui
abbiamo chiesto a 11 influencer di sottoporsi allo spermiogramma, il test che
misura la fertilità maschile. Qui sopra un estratto dalla diretta Instagram. I
giovani del 2021 hanno davvero perso il 50% della fertilità rispetto ai loro
coetanei del 1980? La notizia è riportata dal New York Times. Per questo
con Aurora Ramazzotti abbiamo chiesto a 11 influencer di sottoporsi al test. “La
conta degli spermatozoi è diminuita di più del 40% negli ultimi 40 anni”, dice
Stacey Colino, scrittrice specializzata in temi di salute e psicologia. Tutto ci
fa pensare che potrebbero diminuire ancora. Le cause? Clima, inquinamento, cibo,
stress e tanti altri fattori legati alla modernità. “Non è ciò che mangiamo,
ma quello che ciò che mangiamo assorbe dalla plastica in cui è impacchettato”,
sostiene. Così abbiamo chiesto ad Angelo Sanzio, Tommy A Canaglia, Denis Dosio,
Claudio Sona, Gianluca Tornese, Mariano Catanzaro, Nathan Lelli, Luca Alberici,
Giampaolo Calvaresi, Marco Cucolo, Lucas Peracchi di sottoporsi allo
spermiogramma e per quasi tutti loro è stata la prima volta. Uno degli
influencer, Gianluca Tornese, ha ricevuto una brutta notizia e ha avuto il
coraggio di aprirsi con noi in modo che quello che ha scoperto possa essere per
altri un monito a farsi controllare. “Su undici influencer sono l’unico che è
risultato poco fertile, quasi niente”, spiega Gianluca nella sua diretta
Instagram dopo la messa in onda del servizio, nel quale il medico, alla lettura
dei risultati, gli ha spiegato che “potrebbe essere una cosa momentanea. Bisogna
capire la causa”. “Mettetevi nei miei panni, mi è caduto il mondo addosso”,
continua. “Sono fidanzato da due anni, sogno un futuro con la mia ragazza e con
dei bambini. Sentirsi dire determinate cose è un po’ dura”. Ma Gianluca ha
deciso di parlarne apertamente: “il servizio è utile per tante persone e tanti
ragazzi per prevenire e fare il test”. “Ho ricevuto tantissimi messaggi di
conforto”, racconta a Aurora Ramazzotti. “E anche messaggi di tantissime coppie
che stanno intraprendendo un percorso. Io nel frattempo ho fatto tutto il
possibile, mi sono affidato a una squadra che fa tutto. Mi hanno consigliato
di fare tutti gli esami e poi di rifarli tra tre mesi per vedere le differenze,
nel frattempo mi hanno dato delle cure da fare. Vediamo tra tre mesi come va.
Nel caso fosse davvero così ci sono altre tecniche”.
DAGONEWS l'1 febbraio 2021. E se il motivo per cui
non riuscite ad avere un bambino fosse che fate troppo poco sesso? Un team di
scienziati dell’Università di Modena ha monitorato 431 coppie che si erano
rivolte alla fecondazione assistita, ma aveva dovuto interrompere il trattamento
durante il lockdown: di queste in 34 - circa l'8% - hanno procreato naturalmente
senza alcun aiuto. Come mai? Quando i medici hanno parlato con le coppie hanno
scoperto che avevano fatto sesso tre o quattro volte a settimana durante la
quarantena. La maggior parte delle donne che hanno concepito erano più giovani e
avevano subito un trattamento per la fertilità per periodi più brevi. Le coppie
che non erano riuscite a concepire facevano sesso una o due volte a settimana.
In un rapporto, pubblicato sulla rivista Andrology, i ricercatori hanno detto:
«L'alto tasso di gravidanze in un lasso di tempo molto breve rivela una causa di
infertilità spesso inesplorata: la frequenza dei rapporti sessuali. Il
trattamento per la fertilità dovrebbe essere rivolto a coloro che ne hanno
veramente bisogno, evitando un trattamento non necessario per quelle coppie in
grado di concepire naturalmente».
DAGONEWS il 23 gennaio 2021. Le spettacolari
immagini di un rito di passaggio di una tribù etiope all’interno della quale gli
uomini combattono per conquistare una moglie e per mostrare mascolinità. Non si
tratta di un’esibizione, ma di una violenta e sanguinosa lotta tra i Suri che,
lottando per il prestigio, si massacrano con dei lunghi bastoni, proteggendosi
solo con degli elmetti fatti in casa. Le lesioni, a volte, sono così profonde
che i combattenti muoiono o portano sul loro corpo segni di cicatrici per tutta
la vita. Il governo etiope ha bandito i combattimenti con il bastone nel 1994,
ma continuano a far parte della vita tribale. Il fotografo Xavier Gil Tabios, 62
anni, di Barcellona, si è recato nella Valle dell'Omo per assistere al
tradizionale rito di passaggio. I turisti sono spesso sgraditi e le tribù hanno
già affermato che trovano offensivo essere fotografati senza permesso. Ma Tabios
ha trascorso una settimana con il popolo Suri riuscendo a convincerli a poter
assistere: «Combattono per dimostrare mascolinità, per vendetta personale e per
conquistare una moglie. I partecipanti combattono a due a due fino a quando non
rimane un solo vincitore. L'area può essere un posto inospitale. Devi negoziare
economicamente per accedere a una celebrazione come questa e speri sempre che la
violenza non vada fuori controllo. Alla fine siamo dovuti scappare quando un
clan è arrivato con le pistole in cerca di guai. È un'area complicata, ma esorto
comunque le persone a provare questa esperienza unica e irripetibile».
Riccardo Pelliccetti per "il Giornale" il 14
gennaio 2021. Il governo Conte continua a cancellare le norme dell'era Salvini
ministro. Dopo i decreti sicurezza, è la volta delle diciture sulle carte
d'identità per i minori di 14 anni e sui moduli d'iscrizione a scuola: saranno
ripristinati «genitore 1» e «genitore 2» al posto di «madre» e «padre», che il
leader della Lega aveva reintrodotto quando guidava il Viminale. L'annuncio è
stato dato ieri dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, durante il
Question Time alla Camera rispondendo a un'interrogazione di Fratelli d'Italia.
«Il 15 ottobre 2020 è stata proposta una ulteriore modifica del decreto del
dicembre 2015 finalizzata a ripristinare nella disciplina di emissione della
carta d'identità elettronica la parola genitori, in sostituzione di padre e
madre, per garantire conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento
europeo e superare le problematiche applicative segnalate dal Garante dei dati
personali», ha detto Lamorgese. La ministra ha spiegato che il precedente
decreto presentava anche problemi di privacy. «Il Garante per la protezione dei
dati personali ha rilevato che l'applicazione delle nuove disposizioni ha
comportato notevoli criticità, in termini di protezione dei dati e di tutela dei
minori, nei casi in cui i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale
non siano riconducibili alla figura materna o paterna, ora espressamente
previste, e rappresentano la necessità di adeguare le disposizioni al quadro
normativo introdotto dal regolamento europeo in materia di trattamento dei dati
personali». Immediate le reazioni dell'opposizione con il leader della Lega in
testa. «Con tutti i problemi che ci sono in Italia, al governo si preoccupano di
cancellare padre e madre per sostituirli con Genitore 1 e 2 - ha detto Salvini
-. Prima vanno a casa, meglio è». Quando era ministro, nel 2019, aveva spiegato
la reintroduzione di «padre» e «madre» dicendo di voler ripristinare «i ruoli
biologici». «Difenderemo la famiglia naturale fondata sull'unione tra un uomo e
una donna», aveva affermato. Ma i più scatenati sono i parlamentari di Fdi. «In
questo anno in cui sono triplicati gli sbarchi clandestini e la criminalità
organizzata sta lucrando sulle difficoltà economiche degli italiani, la
preoccupazione più grande del governo è quella di togliere dalle carte
d'identità la dicitura padre e madre, sostituendola con i tristemente famosi
genitore 1 e genitore 2 - ha affermato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia -.
Siamo basiti da quelle che sono le priorità di questa maggioranza che dimostra
ancora una volta di ignorare i bisogni reali degli italiani». Reazioni indignate
anche da Forza Italia. «Questa iniziativa, richiesta dal Garante della Privacy
per adeguarsi a nefaste normative che, come spesso accade, arrivano dalla UE e
trovano zelanti sostenitori nel nostro Paese, rappresenta l'ennesimo attacco
alla famiglia e alle figure di padre e madre - ha detto il senatore Maurizio
Gasparri -. Una spersonalizzazione delle figure genitoriali fatta passare come
una necessità burocratica ma che vede schierati in prima linea i sostenitori di
questa e di altre folli iniziative. Continueremo a difendere le nostre posizioni
di libertà rispetto a questa forma di omologazione che si cerca ormai di imporre
in troppi settori. L'Autorità della privacy si ricopre di vergogna e con essa
quanti assecondano una scelta che cancelleremo quando saremo al governo grazie
al voto, consegnando all'oblio i casi umani di Conte e Renzi».
“No a genitore 1 e 2”, insulti a don
Patriciello: «Vomita odio». La solidarietà di Giorgia Meloni.
Giovanna Taormina domenica 17 Gennaio 2021 su Il Secolo D'Italia.
«Solidarietà al parroco di Caivano don Maurizio Patriciello, accusato
dall’Arcigay di Napoli di “vomitare odio” e essere uno “speculatore sociale”
solo per aver espresso la sua posizione sulla decisione del governo di
reintrodurre “genitore 1” e “genitore 2″». Lo scrive su Facebook il presidente
di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «È esattamente questa la censura dei
tolleranti di professione, gli stessi che vorrebbero col ddl Zan introdurre un
reato di opinione per punire, mettere in carcere e rieducare chi non piega la
testa al pensiero unico. Una follia che continueremo a combattere perché la
libertà non può essere discriminata». A Famiglia Cristiana.it don Maurizio
Patriciello ha raccontato l’attacco di cui è rimasto vittima: «Ho messo un post
su Facebook per dire che sono per dare un nome a un padre e una madre. L’Arcigay
di Napoli mi ha dato dell’odiatore, del trumpista e ricoperto di insulti a mezzo
stampa. L’intolleranza totalitaria dei tolleranti mi preoccupa». Tantissimi i
commenti al post e i messaggi di solidarietà a don Maurizio Patriciello. Scrive
un utente: «Questo scempio culturale, morale e infine anche legislativo ha una
regia molto più in alto. Di chi si dimena nel nostro paese ( piccoli esseri
senza patria e senza Dio). Don Maurizio tu sei nel giusto e rispondi a Colui che
ha creato l’ordine naturale di tutto,(altro che chi sono io per giudicare).Sei
un coraggioso sacerdote in questo mondo rovesciato». E un Altro osserva:
«Possono fare leggi, possono scrivere montagne di libri questi miseri politici
possono legiferare una marea di puttanate, ma la realtà, la natura non si cambia
per formare una famiglia ci vogliono un padre e una madre, questo è un dato di
fatto, tutte le altre cose che vengono fatte, dette, dai politici sono solo
marchette per comprare i favori e voti, delle varie organizzazioni». C’è poi chi
ribadisce: «Solo Padre e Madre, chiunque sia diversamente orientato sessualmente
non abbia la pretesa che gli altri si adeguino. Semmai saranno loro a doverlo
fare».
Valentina Errante per “il Messaggero” il 15
gennaio 2021. Potrebbe essere una rivoluzione. E ancora una volta la Corte
Costituzionale colmerebbe un vuoto normativo, supplendo all' inerzia del
legislatore. La questione è da anni al centro del dibattito politico, ma il
dossier è fermo in parlamento. Ora i giudici della Consulta, che avrebbero
dovuto pronunciarsi sulla legittimità della legge che impedisce a una coppia non
sposata di dare di comune accordo al figlio il solo cognome materno, hanno
deciso di sciogliere definitivamente il nodo, affrontando un tema che avevano
già definito indifferibile. Conclusione: ieri la Corte ha sollevato davanti a se
stessa, circostanza già di per sé assai rara, la legittimità costituzionale
dell' articolo del codice civile che in questi casi prevede l' attribuzione del
cognome paterno. Una procedura inconsueta, che si è quasi sempre conclusa con
bocciatura delle norme esaminate. Il problema, insomma, sarebbe a monte, e non
nel fatto che una coppia di Bolzano, di comune accordo, non possa scegliere il
cognome della mamma. I dubbi di costituzionalità riguardano quell'uso normativo,
che trova riscontro nel codice civile, in base al quale, se il figlio è
riconosciuto, avrà il cognome paterno. «Questione pregiudiziale», rispetto a
quella sollevata dal Tribunale civile di Bolzano. Cinque anni fa la Corte aveva
sollecitato un intervento del legislatore per riformare in maniera organica
«secondo criteri finalmente consoni al principio di parità» la questione del
cognome da attribuire ai figli. Da allora, però, non è cambiato niente, con i
progetti di riforma rimasti al palo. E così, ancora una volta, la Consulta dà
una scossa al Parlamento.
LA VICENDA. Secondo i giudici di Bolzano l'
attuale formulazione dell' articolo del codice civile portato all' esame della
Corte sarebbe in contrasto tanto con l' articolo 2 della Costituzione (che
tutela i diritti inviolabili dell' uomo) sotto il profilo della tutela dell'
identità personale, quanto con l' articolo 3 della Carta («Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso») sotto il profilo del riconoscimento dell' eguaglianza tra donna e
uomo. Non solo, per il Tribunale civile,: ci sarebbe anche la violazione degli
articoli 11 e 117, primo comma della Costituzione, in relazione agli articoli 8
e 14 della Cedu e agli articoli 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali
dell' Unione europea (Cdfue), che riguardano il rispetto della vita privata e
della vita familiare e il divieto di discriminazione.
VUOTO NORMATIVO. I giudici sono andati oltre. Dopo
una lunga camera di consiglio hanno deciso che, per pronunciarsi, devono
esaminare il problema alla base: quel passaggio che prevede, nel caso di figli
nati fuori dal matrimonio e riconosciuti contemporaneamente da entrambi i
genitori, l' attribuzione del cognome paterno potrebbe avere fatto il suo tempo.
Le motivazioni arriveranno nelle prossime settimane, ma la decisione finale, per
la quale bisognerà ancora attendere, a questo punto, sembra scontato. Anche in
questo caso, il giudice relatore della decisione è Giuliano Amato, lo stesso
della sentenza del 2016, che già aveva dato una picconata all' automatica
attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, dichiarandola
incostituzionale «in presenza di una diversa volontà dei genitori». Quella
sentenza, che riponeva comunque le sue speranze nella capacità di intervento del
Parlamento, definì l' impossibilità per la madre di dare al figlio sin dalla
nascita il proprio cognome «un' irragionevole disparità di trattamento tra i
coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia
dell' unità familiare». Ora si potrebbe aprire un altro varco, nel nome della
parità.
La Corte: "Dare il cognome del padre è
retaggio patriarcale". La Consulta si esprime su un
caso presentato dal tribunale di Bolzano: il sistema del cognome paterno "non è
più compatibile con il principio costituzionale della parità tra uomo e donna".
Federico Garau, Venerdì 12/02/2021 su Il Giornale. Dare ai figli il cognome
paterno è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia? A quanto pare
ne è convinta la Corte costituzionale, che arriva senza mezzi termini a definire
tale sistema, utilizzato sino ad ora, come "una tramontata potestà maritale, non
più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale
dell’uguaglianza tra uomo e donna". Affermazioni pesanti, che non mancheranno di
suscitare discussioni. Ancora una volta si torna a parlare di famiglia e parità,
così come era avvenuto in merito alla questione genitore 1 e 2, tema ancora oggi
oggetto di accesi dibattiti. Ma andiamo con ordine. Secondo quanto riferito
dall'agenzia Agi, il problema sarebbe stato sollevato nel 2019 dal tribunale di
Bolzano, il quale aveva deciso di presentare un'istanza in cui veniva chiesto un
chiarimento in merito alla costituzionalità della norma del Codice civile che
stabilisce, in caso di mancato accordo fra genitori, di dare ai figli il cognome
del padre (articolo 262). In caso di accordo, è possibile dare al figlio il
cognome della madre, invece di quello del padre? Quando suddetto accordo non è
presente, invece, prevale ancora la trasmissione del cognome paterno? La
risposta della Consulta potrebbe incidere sulle future famiglie. Nelle
motivazioni dell'ordinanza n.18 depositata in data odierna, i giudici parlano di
un sistema "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia". La norma,
dunque, non rispetterebbe la parità e l'uguaglianza fra i genitori. Non solo. La
Corte sottolinea anche il fatto che "la prevalenza attribuita al ramo paterno
nella trasmissione del cognome non può ritenersi giustificata dall’esigenza di
salvaguardia dell’unità familiare, poiché "è proprio l’eguaglianza che
garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in
pericolo", in quanto l’unità "si rafforza nella misura in cui i reciproci
rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla
parità"" (sentenza n. 133 del 1970). La Corte spiega inoltre che "qualora
venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in
cui manchi l’accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone
l’acquisizione del solo cognome paterno". Si verrebbe così a riconfermare "la
prevalenza del cognome paterno, la cui incompatibilità con il valore
fondamentale dell’uguaglianza è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza
di questa Corte (sentenze n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006)". Inoltre "in questo
quadro, neppure il consenso, su cui fa leva la limitata possibilità di deroga
alla generale disciplina del patronimico, potrebbe ritenersi espressione di
un’effettiva parità tra le parti, posto che una di esse non ha bisogno
dell’accordo per far prevalere il proprio cognome". Nell'ordinanza la Consulta
aggiunge che "pur essendo stata riaffermata la necessità di ristabilire il
principio della parità dei genitori – si è preso atto che, in via temporanea,
“in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare
organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di
parità”, “sopravvive” la generale previsione dell’attribuzione del cognome
paterno, destinata a operare in mancanza di accordo espresso dei genitori".
Dunque si attende un intervento da parte del Parlamento italiano. Anche se, fino
ad oggi, "gli inviti ad una sollecita rimodulazione della disciplina – in grado
di coniugare il trattamento paritario delle posizioni soggettive dei genitori
con il diritto all’identità personale del figlio – sinora non hanno avuto
séguito". La Corte ha quindi deciso di valutare se la norma che "in mancanza di
diverso accordo dei genitori, impone l’automatica acquisizione del cognome
paterno" sia concorde con gli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione.
Festeggia Valeria Valente senatrice del Pd e presidente della Commissione
Femminicidio. "La sentenza con cui la Consulta ha definito l'attribuzione del
cognome paterno ai figli "retaggio di una società patriarcale" e di una
"tramontata potestà maritale" è storica", dichiara la parlamentare, come
riportato da AdnKronos. "Viene riconosciuto pieno valore al principio
costituzionale di uguaglianza tra uomo e donna. Ora starà al legislatore
garantire il diritto delle donne a trasmettere il proprio cognome alle figlie e
ai figli e a disciplinare come questo potrà avvenire. Di certo, non potrà più
essere dato per scontato che il cognome della figlia o del figlio sia in
automatico quello del padre".
·
Revenge Porn. Dagli al Maschio.
Fabio Amendolara per "la
Verità" il 2 Novembre 2021. Se un over 14 autorizza la ripresa di un filmino
hard non si configura il reato di produzione di materiale pornografico: lo ha
stabilito una freschissima sentenza delle Sezioni unite della Corte di
cassazione che, il 28 ottobre, ha di fatto legalizzato le riprese tra partner. A
patto che restino alla coppia e non vengano diffusi. La pronuncia fornisce una
nuova lettura della legislazione e ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.
Si ritiene, infatti, che non abbia tenuto in considerazione la facilità di
diffusione via Web, aprendo così quella che viene ritenuta «una breccia
pericolosa». Ecco la massima: «Nel rispetto della libertà individuale del minore
con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale», hanno valutato i
giudici, «il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con
persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell'articolo 609 quater del codice
penale, si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tale
ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico,
sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e
siano destinati all'uso esclusivo dei partecipi all'atto». La Corte, presieduta
da Margherita Cassano, esponente di Magistratura indipendente, allieva di Pier
Luigi Vigna e in magistratura dal 1980, con Giulio Sarno relatore ed estensore,
ha anche stabilito che «al di fuori dell'ipotesi descritta, la destinazione
delle immagini alla diffusione può integrare il reato di cui all'articolo 600
ter, primo comma codice penale (il reato di pornografia minorile, ndr), ove sia
stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale
pedopornografico». Viene quindi ritenuto un reato, «[...] allorché una qualsiasi
delle condotte di diffusione o offerta sia posta in essere successivamente e
autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei
limiti sopra indicati». Il video, insomma, deve rimanere privato. Il quesito
arrivato alle Sezioni unite era questo: «Se, e in quali eventuali limiti, la
condotta di produzione di materiale pornografico, realizzata con il consenso del
minore ultraquattordicenne nel contesto di una relazione con persona
maggiorenne, configuri il reato» di produzione di materiale pornografico. Già
nel 2018, le Sezioni unite avevano escluso che il maggiorenne che produce il
materiale pornografico «utilizzi il minore» se le riprese sono effettuate
«nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia
caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, sicché
le stesse siano frutto di una libera scelta e destinate ad un uso strettamente
privato». «Si mettono le mani avanti», ha valutato il giudice della Cassazione
Giacomo Rocchi su La nuova Bussola quotidiana (analisi ripresa dalla Onlus
Provita e famiglia sul suo sito Web e rilanciata anche da Radio Maria), «è
necessario che il minore abbia acconsentito alle riprese per una sua "libera
scelta". Emerge la foglia di fico della "libertà", ma è inevitabile chiedersi:
sarà libera di dire di no la ragazzina di quindici anni coinvolta in una
relazione intima e fisica con un uomo che ha il doppio della sua età, quando
questi le propone di riprendere i loro rapporti sessuali? E che uomo
(maggiorenne) sarà quello che propone o accetta la proposta di effettuare
riprese di questo tipo?». Rocchi, però, contesta anche le valutazioni «sull'uso
esclusivo dei partecipi dell'atto»: «Come si è detto, la diffusione, prima o
poi, avviene. Spesso e frequentemente è impossibile risalire a chi ne sia
l'autore». E Rocchi si chiede «che senso ha riconoscere rilievo al desiderio di
due persone di rivedersi nelle loro performance sessuali? Si tratta di attività
che può interessare soltanto il maschio trentenne oppure che può creare problemi
psicologici alla ragazzina o al ragazzino coinvolti». L'ulteriore valutazione di
Rocchi è legata a questioni di politica giudiziaria: «Una parte della
magistratura si è avviata sulla strada de "diritti" e non riesce più a vedere
quando è davvero necessaria una tutela e quando, al contrario, si tratta di
insidie e di decisioni che mettono in pericolo le persone fragili e la società».
Per questo motivo, secondo Rocchi, «la proclamazione del diritto dei minorenni
ai rapporti sessuali con chiunque e di qualunque tipo mette in pericolo tanti
ragazzini in crescita rispetto alle mire di adulti che, perché no?, vogliono
vivere un'esperienza particolare». La toga quindi si chiede: «Ci sarà davvero un
rapporto sentimentale tra una quindicenne e un adulto? Ma soprattutto: se questo
adulto utilizza un telefono cellulare o una macchina fotografica per le riprese
degli incontri sessuali con il/la quindicenne, davvero è possibile inquadrare il
tutto nel diritto del minore a esprimere la sua sessualità?». Un aspetto,
questo, che il giudice censura in modo durissimo, ritenendolo un «tradimento
palese della volontà del legislatore».
Laura Bogliolo per “il
Messaggero” il 2 settembre 2021. «Non voglio che succeda anche ad altri, per
questo ho deciso di denunciare tutto pubblicamente e di metterci la faccia».
Andrea Giorgini, 23 anni, romano, ha pubblicato su Facebook un post nel quale
raccontava di essere stato vittima di revenge porn. «Qualcuno sta facendo
girare alcune mie foto riprese durante una videochiamata - ha scritto - provando
senza successo a estorcermi dei soldi». «Al terzo giorno di terrore ho deciso di
raccontare tutto - dice Andrea al Messaggero - il mio post è stato un grido per
dire basta, non devo vergognarmi della mia vita sessuale e non devo vivere nel
timore che qualcuno infanghi la mia reputazione perché ha mie pose sessuali».
Andrea, studente, attore comico emergente, esperto di comunicazione nel settore
politico, racconta: «Una ragazza che non conoscevo mi ha contattato su Facebook,
diceva di essere di passaggio in Italia, aveva tra gli amici alcuni dei miei,
abbiamo quindi iniziato a parlare poi abbiamo fatto una videochiamata su
Facebook nella quale si è presentata in pose sessuali, l'ho fatto anche io e
all'improvviso ha proiettato il mio video dicendomi che lo avrebbe pubblicato
online per rovinare la mia vita professionale». Giorgini parla di «una strategia
di paura premeditata». Ma ha trovato la forza di reagire. «Ho avuto - dice - la
prontezza di prendere in mano la situazione». E così ha anticipato le mosse dei
suoi aguzzini e ha raccontato su Facebook delle «foto riprese durante la
videochiamata e la richiesta di soldi, 3.700 euro». Ha quindi chiesto ai suoi
contatti di condividere il post «affinché la minaccia estorsiva cessasse e
nessuno si sorprendesse se trovava foto di me sessuali». «Dice che lo manderà al
mio luogo di lavoro, ma io lavoro presso me stesso - si legge nel post nel quale
Giorgini ha denunciato quello che gli stava accadendo - Dice che lo manderà ai
miei cari, così sapranno quanto vado fiero del mio corpo, dopo una vita spesa a
mortificarmi. Dice che lo manderà a un sito porno». Poi la spiegazione del
perché ha deciso di non arrendersi e di non lasciarsi sopraffare. «La banalità
del revenge porn è racchiusa nel senso di queste due frasi: derisione e stigma.
Per un attimo volevo nascondermi - scrive - ma poi ho pensato alle tante vite
spezzate da un gesto simile, alla lista dei corpi violati a cui mi sarei
aggiunto, ma sapete che vi dico? Questa storia non ha senso». E aggiunge: «Non
devo vergognarmi della mia vita sessuale, non ho fatto nulla di male e sono
andato a denunciare tutto alla polizia postale». Per un giorno il telefono di
Andrea ha continuato a squillare ossessivamente, era tartassato dalle richieste
di soldi. Poi su consiglio della polizia postale ha reso privato il suo profilo
Facebook, e ha oscurato la lista degli amici in modo che la catena del ricatto
potesse fermarsi. Dopo un po' il telefono ha smesso di squillare. L'assedio era
finito. «Hanno visto che non ho più paura e così hanno smesso di cercarmi». E
ora, con la sua testimonianza spera di dare coraggio a chi, come lui,è vittimadi
revenge porn. «Ci metto la faccia - conclude -spero la mia esperienza possa
servire anche per i casi in cui l'aguzzino è un partner o una persona fidata.
Alla cultura dello stupro rispondiamo con coraggio e fierezza dei nostri
corpi».
Dagotraduzione dal Daily Mail
il 26 luglio 2021. Wayne Rooney tiene di nuovo banco sui social. L’ex calciatore
da questa mattina viene preso in giro per aver chiamato la polizia dopo una
serata con una modella e le sue amiche. Rooney, sposato con 4 figli, avrebbe
festeggiato nella notte tra sabato e domenica insieme ad una modella, Tayler
Ryan, e alle sue amiche, Elise Melvin e Brooke Morgan, tutte di 21 anni. Gli
amici delle ragazze hanno raccontato che l’ex calciatore ha invitato la modella
e le sue amiche al suo tavolo Vip nell’esclusivo club Chinawhite per «la notte
più selvaggia della loro vita» anche se «non c’è stato alcun contatto sessuale,
è stato solo una fantastica serata». Taylor ha pubblicato per i suoi 13.000
followers le foto di lei seduta con Rooney su un divano. Un'immagine mostra
Rooney che indossa una felpa con cappuccio nera e jeans e agita il braccio in
aria mentre tiene in mano un bicchiere di vino. La serata è proseguita in un
albergo di Manchester, dove Rooney però si è fatto prendere dal sonno. Le
ragazze ne hanno allora approfittato per qualche scherzo. Mentre l’attaccante
inglese è addormentato su una sedia, le ragazze si spogliano in mutande nella
loro camera d’albergo. Una di loro ha pubblicato una foto del suo sedere accanto
a Rooney con la didascalia: “Mooney Rooney”. Un’altra immagine mostra una delle
ragazze che fa un segno di pace accanto a Rooney mentre l'altra è sdraiata sul
letto in mutande. Didascalia "Sleepy Wayne". L'amico ha detto: «Si stavano tutti
divertendo a ballare con Wayne e i suoi amici e a postare su Snapchat, ma non
riuscivano a smettere di ridere quando è svenuto. Hanno deciso di divertirsi un
po'». Quando Rooney si è svegliato, se n’è andato furioso e sembra che abbia
contattato la polizia per denunciare l’accaduto. Il calciatore ha detto agli
agenti che credeva di essere stato incastrato. Questa mattina i fan sembravano
perplessi che l'avesse presa con così poco spirito e si chiedevano quale reato
pensava fosse stato commesso. Uno di loro ha scritto: «Quale crimine? Wayne
Rooney è stato costretto sotto la minaccia delle armi a passare la notte in un
hotel con due donne». Un altro ha scherzato: «Wow...se questo è un crimine
iscrivimi a Gaffer! Farò un po' di quell'allenamento precampionato!»
Da "repubblica.it" il 5 marzo
2021. Bad Luck, banging or Loony Porn del regista Radu Jude ha vinto l'Orso
d'oro della Berlinale. Lo ha reso noto il festival quest'anno in edizione
virtuale a causa della pandemia, l'Orso d'argento invece va a Maren Eggert per
la migliore interpretazione alla Berlinale per il film I'm your man, della
regista tedesca Maria Schrader. Il film rumeno racconta l'epopea di un
insegnante, interpretata da Katia Pascariu, che si ritrova al centro di una
gogna mediatica quando un video privato in cui fa sesso col proprio compagno
viene messo in rete. La storia ricorda in parte quella della maestra d'asilo
piemontese licenziata per un caso di revenge porn. Il film di Jude è stato
completato durante la pandemia e quindi mascherine e distanziamento sociale
fanno parte integrante della storia. "Bad Luck Banging or Loony Porn" del rumeno
Radu Jude era forse il più audace dei 15 film in lizza per il primo premio
dell'Orso d'Oro alla Berlinale. Il film si apre con un video porno dall'aspetto
estremamente reale di Emi, un'insegnante di storia della scuola media a
Bucarest: si tratta di una clip amatoriale che ha girato con suo marito che
diventata virale su PornHub e finisce sui telefoni dei suoi colleghi, degli
studenti e dei loro genitori. Il video finisce per condannarla
all’allontanamento sociale mentre Emi lotta per salvare il suo lavoro e la sua
reputazione. Il conflitto esplode in una surreale riunione genitori-insegnanti
in cui rappresentanti delle istituzioni rumene, tra cui la chiesa ortodossa, i
militari e la classe professionale nouveau riche, mettono Emi alla gogna in una
sorta di processo farsa. Sebbene il sex tape sia l'argomento in questione, la
difesa di Emi dei bambini rom a scuola, la sua insistenza nell'insegnare la
complicità della Romania nell'Olocausto e il riferimento al sessismo dei
colleghi diventano tutti motivi d’attacco. «Molte delle cose di cui Emi è
accusata sono cose di cui sono stato accusato nei commenti online sui miei film
precedenti - ha detto Jude all'AFP - Gli spettatori sono invitati a fare un
confronto tra la cosiddetta oscenità di questo video porno e l'oscenità pubblica
della società, dell'ipocrisia».
"Commedia della disperazione".
Girato interamente l'estate scorsa durante la pandemia di Covid-19, il film è
stato girato tenendo conto della maggiore "aggressività" nell'aria. «Questa
diventa una metafora - persone con mascherine che cercano di gridarsi addosso -
ha raccontato Jude aggiungendo di essersi ispirato alle chat a volte isterica su
WhatApp tra i genitori della scuola dei suoi figli - Quando si tratta di bambini
ho la sensazione che a volte i genitori rinunciano alla facciata, rinunciano
alla gentilezza e vanno più direttamente ai loro valori». Tuttavia non si tratta
di ridere della fragilità umana: «C’è una commedia sulla disperazione, c’è una
commedia sulla sessualità, c’è una commedia sulla condizione umana a seconda
dell'angolazione dalla quale si guarda. Ma questo non esclude l'essere infuriati
o arrabbiati con alcuni aspetti della società».
Maestra licenziata per i
video hot diffusi dall'ex. Lui: “Ho sbagliato, non volevo farle del male”.
Le Iene News il 19 maggio 2021. Aveva diffuso tre anni fa nella chat del
calcetto immagini privatissime dell’allora fidanzata. Da lì è iniziato l’incubo
di revenge porn e gogna pubblica di Giulia che, come ha raccontato alla nostra
Nina Palmieri, le ha fatto anche perdere il suo adorato lavoro di insegnante
d’asilo. Dopo le prime condanne, l’ex è stato appena affidato ai servizi sociali
per un anno e si dice pentito. “A un figlio insegnerò a rispettare le donne. Non
ho mai voluto farle del male. Quando ho inoltrato le sue foto intime nella chat
del calcetto, non ho riflettuto sulle conseguenze. Mai e poi mai avrei
immaginato un simile scandalo. Sono pentito. Non è una frase fatta: sono
veramente dispiaciuto”. Sono le parole del pentimento dell’ex della maestra
d’asilo del Torinese che nella primavera del 2018 diffuse foto e video immagini
privatissime dell’allora fidanzata condannandola così a un lungo e terribile
incubo. Nel febbraio scorso, nel servizio di Nina Palmieri che vedete qui sopra,
abbiamo incontrato Giulia, che per questa storia terribile aveva perso il lavoro
e che ci ha raccontato la sua disperazione: “La verità verrà fuori, ma io
rimango sempre la maestra p***ana”.
IL PENTIMENTO DELL’UOMO. L’ex
fidanzato, oggi ventinovenne, oggi esprime parole di pentimento con il Corriere
della Sera e a La Stampa, dopo che è stata appena decisa dai giudici la
sua messa in prova ai servizi sociali per aver commesso i reati di violenza
privata e violazione della privacy. Per dodici mesi allenerà una squadra di
calcio di ragazzini con problemi di disabilità. Se supererà questo periodo
correttamente, dopo aver risarcito il danno, chiuderà così i suoi conti con la
giustizia. “I bambini sanno donare grandi emozioni, è un’esperienza che mi
accrescerà dal punto di vista umano”, dice. “Ho sbagliato. Ho fatto un errore,
per ingenuità e per goliardia. Non pensavo che qualcuno potesse conoscerla. Era
una chat chiusa, riservata ai compagni di spogliatoio. Doveva rimanere tutto
circoscritto in quella stanza virtuale. Invece la situazione mi è sfuggita di
mano. Le ho chiesto scusa. Non mi aspettavo che quelle foto venissero divulgate
e che potessero essere usate contro di lei. Ma con il suo licenziamento non ho
nulla a che fare”.
“Se avessero diffuso alcune
mie immagini intime, anch’io mi sarei vergognato e arrabbiato. Ma sono convinto
che se il protagonista di quelle foto fosse stato un uomo, i commenti sarebbero
stati di un altro tenore. E anche l’attenzione mediatica sarebbe stata diversa”,
prosegue. E promette. “A un figlio insegnerei ad avere rispetto per le amiche e
per le ragazze che potrebbe frequentare”.
L’INCUBO DI GIULIA. L’uomo,
come vi abbiamo raccontato nel servizio, ha condiviso foto e video intimi di
Giulia su una chat di WhatsApp del calcetto. Dentro c’è anche il papà di un
alunno della ragazza. Li vede anche la moglie, arrabbiatissima. Gli scatti con
nome e cognome purtroppo iniziano a girare. “Ti voglio prendere a schiaffi, ti
affido giornalmente mia figlia e il pensiero che la sua maestra fa certe cose,
mi fa schifo”, dice una mamma di un’alunna a Giulia. “Ho sbagliato a fidarmi di
un ragazzo”, le risponde. “So che vuoi denunciare questa persona, se le tue
intenzioni rimangono quelle, io parlerò direttamente con la direttrice spiegando
tutto e togliendo mia figlia dal nido”, replica la mamma. Lei aveva chiesto al
ragazzo, per risolvere le cose in maniera civile, di rimuovere foto e video
dalle chat senza doverlo denunciare. “Mi ha risposto che ormai circolavano e che
potevo andarmene da casa”, spiega la maestra. Non le rimane altro che
denunciarlo. Lui inizia a minacciarla: “Se mi arriva la denuncia, mando tutto a
tutti fai tu… E lo viene a sapere anche la tua famiglia. Vedi tu che fare,
abbiamo sbagliato entrambi, sai a che cosa vai incontro”. In quelle giornate da
incubo di tre anni fa, Giulia viene isolata e continuano gli insulti da parte
dei genitori dei suoi alunni. “Se lei è zocc*** e manda i messaggi non deve
mettere in mezzo le persone che li hanno mandati”, dice un papà. “Per quanto
quest’uomo possa aver "fatto schifo" tra virgolette, lei non è da meno”,
risponde una mamma. “La responsabilità è sua”, insiste il papà. Alcuni genitori
della classe inoltrano foto e video alla direttrice e le chiedono di prendere
provvedimenti. “Mi ha detto che non potevo più lavorare lì perché sarebbe stato
visto come l’asilo delle pu***ne”, sostiene Giulia. “La direttrice mi ha
obbligata a firmare le dimissioni, altrimenti mi avrebbe licenziato scrivendo
quello che è successo”. Ci sarebbe stato pure una sorta di “processo”
nell’istituto. Giulia firma, ma per un vizio formale quelle dimissioni non sono
valide. La direttrice alza il tiro inviando un messaggio vocale nella chat delle
maestre: “Cercatela di indurre a far qualcosa di sbagliato, ogni qualcosa che
succede chiamatemi perché io lo prendo come pretesto per mandarla via. Ce l’ho a
morte non voglio neanche vederla”. Alla fine la direttrice passa a una sorta di
provvedimento disciplinare e al licenziamento (poi, per questo, Giulia è stata
risarcita). “Mi hanno fatto sentire in colpa, ma la forza di non stare zitta è
stata più forte”, dice la vittima di questa terribile storia di revenge porn e
gogna pubblica. Il 19 febbraio scorso sono arrivate le condanne: 13 mesi per la
direttrice e 12 per una mamma. Nina Palmieri ha incontrato sia l’ex che la
direttrice. Lui, ammettendo l’errore e chiedendo comunque scusa, aveva avuto
toni un po’ diversi da quelli odierni: “Questa cosa è stata molto
ingigantita, io ho fatto una cavolata da ragazzino…”. La direttrice ha preferito
il totale silenzio. Giulia non aveva più trovato lavoro per il clamore della
storia: abbiamo provato ad aiutarla per le cattive referenze e come potete
vedere qui la solidarietà è arrivata.
Maestra d'asilo licenziata per video
hard, arrivano le condanne. Le Iene News il 23
febbraio 2021. Il fidanzato manda le sue foto private in una chat WhatsApp con
dentro anche alcuni genitori dei suoi alunni. Per questa maestra d’asilo di 20
anni inizia un incubo non ancora finito che parte dal licenziamento. Dopo 3 anni
la direttrice e altri sono stati condannati. Invece lei non ha ancora trovato
lavoro e chiede aiuto a tutti voi. “La verità verrà fuori, ma io rimango sempre
la maestra p***ana”. A dirlo è Giulia, una 20enne che adorava il suo
mestiere: insegnare ai bimbi d’asilo. Lei è la maestra di Torino che da vittima
di un subdolo abuso si è ritrovata colpevole, una presunta colpevolezza che le
sta rovinando la vita da tre anni. Giulia conosce un ragazzo, lo frequenta e se
ne innamora. Inizia a condividere con lui alcune foto e video intimi. Sono
immagini private che però non rimangono tali. Il ragazzo le condivide in una
chat di WhatsApp, dove dentro c’è anche il papà e la mamma di un suo alunno. Gli
scatti con nome e cognome iniziano a girare. “Ti voglio prendere a schiaffi, ti
affido giornalmente mia figlia e il pensiero che la sua maestra fa certe cose,
mi fa schifo”, dice una mamma a Giulia. “Ho sbagliato a fidarmi di un ragazzo”,
le risponde. “So che vuoi denunciare questa persona, se le tue intenzioni
rimangono quelle, io parlerò direttamente con la direttrice spiegando tutto e
togliendo mia figlia dal nido”, replica la mamma. Lei aveva chiesto al ragazzo
di rimuovere foto e video dalle chat senza doverlo denunciare. “Mi ha risposto
che ormai circolavano e che potevo andarmene da casa”, spiega la maestra. Così
non le rimane altro che denunciarlo. Ma nel frattempo lui inizia a minacciarla:
“Se mi arriva la denuncia, mando tutto a tutti fai tu… E lo viene a sapere anche
la tua famiglia. Vedi tu che fare, abbiamo sbagliato entrambi, sai a che cosa
vai incontro”. In quelle giornate da incubo di 3 anni fa, Giulia viene isolata e
continuano gli insulti da parte dei genitori dei suoi alunni: “Se lei è zocc***
e manda i messaggi non deve mettere in mezzo le persone che li hanno mandati”,
dice un papà. “Per quanto quest’uomo possa aver fatto schifo tra virgolette lei
non è da meno”, risponde una mamma. “La responsabilità è sua”, chiosa il papà. A
questo punto i genitori inoltrano foto e video alla direttrice e le chiedono di
prendere provvedimenti. “Mi ha detto che non potevo più lavorare lì perché
sarebbe stato visto come l’asilo delle pu***ne”, sostiene Giulia. “La direttrice
mi ha obbligata a firmare le dimissioni, altrimenti mi avrebbe licenziato
scrivendo quello che è successo”. Giulia firma le dimissioni, ma per un vizio
formale non sarebbero state valide. A questo punto la direttrice avrebbe alzato
il tiro inviando un messaggio vocale nella chat delle maestre: “Cercatela di
indurre a far qualcosa di sbagliato, ogni qualcosa che succede chiamatemi perché
io lo prendo come pretesto per mandarla via. Ce l’ho a morte non voglio neanche
vederla”. La direttrice emette un provvedimento disciplinare e il licenziamento
che però sarebbe decaduto per ingiusta causa. “Mi hanno fatto sentire in colpa,
ma la forza di non stare zitta è stata più forte”, dice Giulia. Tutto questo
succedeva nel 2018, ora sono arrivate le condanne. Con la sua denuncia il
ragazzo per un anno sarà in prova ai servizi sociali per aver commesso i reati
di violenza privata e violazione della privacy. Nina Palmieri si mette sulle sue
tracce: “Questa cosa è stata molto ingigantita, io ho fatto una cazzata da
ragazzino…”, dice lui. Invece la direttrice dell’asilo deve rispondere di
violenza privata e diffamazione. Anche una mamma è stata condannata per i suoi
messaggi in quella chat.
Irene Famà per “La Stampa” il 15 gennaio 2021. «È
stata una gogna scolastica». Il pubblico ministero Chiara Canepa non ha dubbi.
Quella maestra appena ventenne, che ha visto le foto osè inviate privatamente
all'ex fidanzato prima finire in una chat degli amici del calcetto poi passare
di cellulare in cellulare, è stata messa alla berlina. Dalla dirigente
dell'istituto che, preoccupata per l'immagine dell'asilo, l'avrebbe costretta
alle dimissioni. Da quei genitori che l'hanno additata come una poco di buono.
Preoccupati non della situazione della giovane, ma che l'ex ragazzo non finisse
nei guai. Ieri il magistrato ha chiesto le condanne: un anno e due mesi per la
preside, un anno per la madre di una bambina. Accusate, a vario titolo, di
violenza privata, diffamazione e diffusione indebita di immagini personali.
Altro che «aiutare la giovane». Altro che «atteggiamento protettivo. L'intento
di danneggiare la persona offesa emerge dalle chat» sostiene il pm. Inizia dalla
posizione della madre di un'alunna. Lei, dell'esistenza di quelle foto, l'ha
scoperto dal suo compagno. «Volevo aiutarla - ha detto davanti al giudice
Modestino Villani - Ci siamo incontrate in un bar e confidate come amiche. Lei
ha capito quando le ho detto che se avesse denunciato, avrei tolto mia figlia
dall'asilo. Ormai ero coinvolta nella vicenda e temevo ripercussioni sulla
bambina». Come mai ha condiviso quegli scatti con altre madri? «Non sapevo come
comportarmi». I messaggi vocali sentiti in aula raccontano un'altra storia. Di
battute volgari e insulti. «Dille di smettere di fare la maestra se vuole fare
la p…». Del tentativo di convincere la giovane a non denunciare l'ex fidanzato.
«Se non vuole essere svergognata, deve fare la seria lei. È meglio che non
denunci». E ancora: «A me non me ne frega niente che venga licenziata, io non
voglio essere messa in mezzo, né io ne mio marito». Ecco. A parere del
magistrato, la questione è proprio questa: «L'obiettivo della signora era che la
ragazza non denunciasse l'ex fidanzato, perché ci sarebbe finito di mezzo anche
suo marito». Insomma. Tutti preoccupati di salvare la propria reputazione. Di
quella della maestra poco importava. Due pesi e due misure. «Per quanto lui
possa aver fatto schifo - si legge in un messaggio - lei non è da meno». Anche
la preside ha detto di voler voluto aiutare la giovane. Ha parlato di «gogna
mediatica». Il pm ha ribattuto con «gogna scolastica. La dirigente ha agito con
l'intento di costringerla alle dimissioni perché il buon nome dell'asilo era
stato leso». Ieri, in aula, avrebbero dovuto essere sentiti anche l'ex fidanzato
della giovane, assistito dall'avvocato Pasquale Ciricosta, che per questa
vicenda ha ottenuto la messa alla prova. E altri due amici del calcetto, che
invece hanno patteggiato. Si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere.
La giovane, assistita dagli avvocati Domenico Fragapane e Dario Cutaia, ora
vuole giustizia. E cerca la forza per ritrovare la fiducia in se stessa e negli
altri. Un percorso non facile. I suoi familiari hanno raccontato il suo
calvario: «C'erano giorni che non voleva nemmeno alzarsi dal letto e anche a
casa i rapporti non sono stati semplici». Ancora oggi, quasi nessuno le ha
chiesto scusa.
Revenge porn, direttrice d'asilo licenziò
maestra vittima della gogna online: condannata. Sarah
Martinenghi su La Repubblica il 19 febbraio 2021. Un anno e un mese per violenza
privata e diffamazione. La vittima: "Non mi sento risarcita, rivoglio il mio
lavoro". Pene minori a una madre e a una collega. Ha cercato giustizia contro il
torto subito, la dignità ferita, il lavoro ingiustamente perduto. E l'ha avuta.
Sono state condannate la preside e la mamma di una piccola alunna protagoniste
della vicenda che ha visto una giovane maestra d'asilo umiliata dopo la
diffusione di sue foto intime e private da parte dell'ex fidanzato che le aveva
diffuse in una chat ai compagni del calcetto. La diretta conseguenza era stata
che la maestra aveva perso il lavoro: costretta al licenziamento da parte della
direttrice dell'asilo privato che temeva di perdere rette e che il nome della
scuola venisse infangato per colpa di questa vicenda. Alla direttrice
dell'asilo, che risponde dell'accusa di violenza privata e di diffamazione, ora
il giudice Modestino Villani ha inflitto un anno e un mese: "Siamo tutti lupi
cattivi in una storia raccontata male" ha dichiarato la preside commentando la
decisione. Le immagini erano arrivate subito agli occhi di una coppia di
genitori di una bimba che frequentava la scuola: la madre, assistita
dall'avvocato Flavia Pivano, ora condannata a un anno con pena sospesa, si era
insinuata nella vicenda facendo pressioni sulla maestra affinché non denunciasse
il suo ex fidanzato che aveva diffuso le foto senza il suo consenso. In
abbreviato rispondono della diffusione delle immagini anche il papà della
piccola alunna e una collega di lavoro della maestra: lui è stato assolto,
mentre lei è stata condannata a otto mesi. La sentenza per loro è stata
pronunciata in contemporanea, in un'altra aula. L'ex fidanzato aveva invece già
chiesto e ottenuto un anno di messa alla prova. La ragazza, appena ventenne,
invece, assistita dagli avvocati Dario Cutaia e Domenico Fragapane, aveva deciso
di rivolgersi alla procura sporgendo querela contro tutti coloro che l'avevano
ingiustamente colpevolizzata. In aula ha ascoltato la lettura della sentenza:
"Sono soddisfatta, la verità è uscita fuori anche se dopo anni. Sono sollevata,
so che andranno avanti facendo ricorso ma almeno abbiamo messo un punto fermo.
Nessuno mi ha mai chiesto scusa e ancora adesso per colpa di questa vicenda non
ho più trovato lavoro. Ma io voglio solo tornare a fare la maestra d'asilo" ha
commentato la vittima. "Questa sentenza è importante e dimostra che nessuno
tantomeno le donne debbono essere giudicate per quello che fanno in camera da
letto ma per la loro competenza e professionalità. Non siamo più nell'800 e non
c'è nessuna lettera scarlatta" commentano gli avvocati della maestra Dario
Cutaia e Domenico Fragapane. Una storia terribile avvenuta in un piccolo paese
alle porte di Torino, dove tutti si conoscono e dove pettegolezzi e maldicenze
si diffondono veloci di casa in casa. La giovane maestra, non appena la storia
era arrivata anche alle orecchie della direttrice, era stata portata davanti a
tutte le colleghe e aveva subito quella che la pm Chiara Canepa ha definito una
vera e propria "gogna", raccontando a tutti cosa fosse successo. Era quindi
stata costretta a licenziarsi: "La direttrice mi disse che se non l'avessi fatto
io, l'avrebbe fatto comunque lei, ma in questo modo avrebbe dovuto scrivere
anche il motivo del mio licenziamento che sarebbe stato un marchio per tutta la
vita. Mi disse che non avrei più trovato lavoro nemmeno per pulire i cessi di
Porta Nuova". La giovane maestra, in lacrime e disperata, inizialmente aveva
accettato, ma poi aveva deciso di non convalidare le dimissioni: "Fu terribile,
non mi sono mai sentita tanto umiliata - è stato il suo racconto in aula - io
non volevo lasciare il mio lavoro e ho provato a spiegare che ero una vittima".
A quel punto la direttrice, assistita dall'avvocato Valentina Zancan, disposta a
tutto pur di mandarla via, aveva mandato un messaggio whatsapp alle altre
maestre: un audio choc fatto ascoltare in aula al processo. "Per favore, cercate
di indurla a fare qualcosa di sbagliato: qualsiasi cosa succeda mi chiamate e io
lo prendo come pretesto per mandarla via. Fatemi 'sta cortesia, io non so più
cosa fare". E ancora: "Sarà una guerra durissima: con lei ce l'ho a morte, non
voglio più vederla". Il senso era chiaro: la giovane maestra vittima di revenge
porn doveva andarsene, con le buone o con le cattive. E infatti dopo poco era
stata licenziata.
"Ho vissuto anni di inferno". La maestra
vittima di revenge porn perse il lavoro: condannate preside e mamma che
diffusero le foto. Rossella Grasso su Il Riformista il
19 Febbraio 2021. Il suo ex fidanzato divulgò in una chat le sue foto hot nel
gruppo del calcetto. Immagini che erano state intercettate da una delle mamme
dell’asilo di Torino dove la maestra lavorava e diffuse sulle altre chat con la
complicità della direttrice della scuola. Una brutta vicenda che costrinse la
giovane maestra alle dimissioni. Ora il Tribunale di Torino ha condannato a un
anno e un mese la dirigente scolastica e la mamma che aveva inoltrato le
immagini. La dirigente scolastica aveva fatto pressioni sulla ragazza affinchè
si licenziasse, e per questo era accusata di violenza privata e diffamazione; la
mamma di tentata violenza privata e violazione del codice sulla privacy. La
giovane insegnante si è costituita parte civile e ha ottenuto il diritto a un
risarcimento e delle somme di denaro a titolo di provvisionale. Ci sono voluti
due anni per raggiungere questo risultato. Anni in cui la vita della maestra è
stata un vero inferno. Da quando l’ex fidanzato rese pubbliche quelle foto è
scoppiato il caso. “Quel che è fatto è fatto e il danno non si cancella. Ma
almeno con questa sentenza è emersa la verità”, ha commentato la maestra 22enne.
La ragazza ancora non riesce a trovare lavoro ma il suo obiettivo è tornare a
insegnare all’asilo. E a chi le chiede se ha perdonato, ha risposto: “Non provo
rancore, non sono io che devo perdonarli, io la mattina mi alzo e ho la
coscienza pulita”. Le scuse? “Posso anche accettarle ma non me ne faccio
niente”, ha concluso. “Siamo tutti lupi cattivi in una storia raccontata male”.
È l’unico commento rilasciato al termine della sentenza dalla dirigente
scolastica dell’asilo oggi in tribunale a Torino. Intanto l’ex fidanzato pentito
ha risarcito la 22enne, ottenendo il beneficio della messa alla prova: un anno
di servizi sociali.
Irene Famà per "La
Stampa" il 20 febbraio 2021.
«Mi sono sentita un oggetto. Continuavo a chiedere scusa a tutti, vivevo con un
perenne senso di colpa, come se fossi stata io ad aver sbagliato. Ora tiro un
sospiro di sollievo, anche se con quel marchio ancora ci convivo. Non riesco a
levarmelo di dosso». La maestra del torinese vittima di un caso di revenge porn
- perché non c'è altro modo di definirlo, anche se all'epoca il reato non era
ancora stato inserito nella legislazione penale - racconta che malignità,
pettegolezzi, e cattiverie lasciano ferite profonde. Che nemmeno una sentenza
può rimarginare. Nel 2018, il suo ex fidanzato ha divulgato in una chat degli
amici del calcetto delle sue foto intime. Rimbalzate in pochi minuti da un
cellulare all'altro. L'hanno messa alla gogna e costretta a dimettersi
dall'asilo in cui lavorava. Ieri, il Tribunale di Torino ha condannato la
dirigente scolastica a 13 mesi di reclusione, la mamma di una bimba dell'asilo a
un anno e un'ex collega della maestra a otto mesi. L'ex fidanzato ha ottenuto un
anno di messa alla prova, mentre un suo amico, che aveva condiviso le foto con
la moglie, è stato assolto.
Una vittoria?
«Non è ancora finita: un
imputato è stato assolto. Ma gli altri sono stati condannati. E sì, io mi sento
leggera. Anche se è molto complesso riprendere in mano la mia vita».
Perché?
«Agli occhi dei più rimango una
poco di buono. Sono in tanti a pensarla così. È un marchio con cui devo
convivere, che non riesco a scacciare. E mi creda, ora è difficile fidarsi degli
altri».
Lei di quel ragazzo si fidava?
«Di più. L'avevo conosciuto
tramite degli amici e mi era sembrato una persona rispettosa e galante. Delle
donne parlava sempre con rispetto e mi riempiva di attenzioni. Mai avrei pensato
che mandasse agli amici quelle foto che gli avevo donato. Glielo avevo
specificato e mi aveva detto di stare tranquilla».
Poi l'ha tradita.
«Da lui non me lo sarei mai
aspettato. Gli ho chiesto spiegazioni, mi ha risposto che era libero di fare ciò
che voleva. Mi ha anche minacciata dicendo che se l'avessi denunciato avrebbe
mandato quegli scatti a tutta la sua rubrica. Compresi i miei genitori. Poi
quelle foto sono arrivate sino a scuola. Tutti sapevano e io mi sentivo un
oggetto. Continuavo a chiedere scusa».
Eppure non era lei ad aver
sbagliato. Nessuno ha preso le sue difese?
«Nessuno, a parte la mia
famiglia. E i miei avvocati, Domenico Fragapane e Dario Cutaia. Lui mi ha
utilizzata come un trofeo, voleva farsi vedere dagli amici. Ma tutti, dalla
preside alle colleghe, mi hanno girato le spalle. La dirigente aveva paura di
finire nei pasticci, le maestre di mettersi contro di lei e per tanti ero una
poco di buono. Ancora oggi è così».
Il giudice le ha dato ragione.
Non crede basti?
«Dopo la sentenza c'è chi ha
esultato per l'unico assolto. Ha annunciato dei brindisi. Nessuno di loro ha
capito dove ha sbagliato. Ancora oggi sono convinti di aver ragione».
Secondo lei perché?
«Sono una donna. Agli uomini è
concesso tutto. Se al posto mio ci fosse stato un ragazzo, sarebbe stato
considerato un figo».
Cosa consiglia a chi è vittima
di una situazione simile alla sua?
«Di denunciare. Io avevo paura,
sono stati i miei genitori a convincermi. C'è poi la questione social. Non c'è
nulla di male nella sessualità, ma bisogna essere ben consci di chi si ha
davanti. Io avevo diciannove anni ed ero convinta che quelle foto sarebbero
rimaste tra me e il mio ex. Quando delle foto vengono divulgate, fermarle è
impossibile. Se un domani diventerò mamma, darò a mio figlio tutti gli strumenti
per comprendere i social. E gli racconterò la mia storia perché si pensa sempre
che succederà a un altro. Ma quell'altro puoi essere tu. Credo che gli insegnerò
anche un'altra cosa».
Quale?
«A non giudicare. E avere
rispetto per gli altri».
·
L’Odore.
Da tag43.it il 27 giugno 2021. L’odore di una
persona può rivelarci informazioni sullo stato di salute, la dieta e la
personalità. Perfino sulla vita sentimentale. Pur potendo variare in base alle
abitudini o al regime alimentare, l’odore resta una caratteristica così
personale, da non poter essere confuso in alcun modo con quello degli altri. A
dimostrarlo anche un esperimento in cui, davanti a un campione di t-shirt usate,
i candidati sono riusciti a riconoscere e accoppiare quelle di due gemelli
omozigoti solo dal profumo. «Si tratta di un risultato importante perché
evidenzia quanto i geni influenzino il nostro odore», ha spiegato la psicologa
Agnieszka Sorokowska alla Bbc. «Grazie a questo, possiamo immaginare di poter
arrivare a ricavare senza particolare difficoltà le informazioni genetiche di
una persona semplicemente annusandola».
L’odore umano aiuta a trovare il partner giusto.
Ma, al di là degli aspetti scientifici, riconoscere l’odore di una persona può
aiutare nella vita di coppia. Lo confermano i risultati di un’altra ricerca,
nell’ambito della quale ad alcune donne è stato richiesto di classificare, in
base alla gradevolezza del profumo, una serie di magliette indossate da
sconosciuti. La classifica che ne è uscita fuori era identica al ranking
generato attraverso il parametro noto come Hla, dissimilarità degli antigeni
leucocitari umani. Si tratta proteine che aiutano il sistema immunitario a
riconoscere e distinguere le nostre cellule da quelle estranee (e, per questo,
potenzialmente patogene). Il profilo definito dalle Hla è personale, distinto da
quello di chiunque altro. Inoltre da un punto di vista strettamente genetico,
avere un partner con un profilo Hla dissimile sarebbe un vantaggio. «Se il tuo
compagno o la tua compagna hanno un odore e un profilo immunologico diversi dai
tuoi, un eventuale nascituro ha molte più possibilità di avere una resistenza
immunitaria più solida», spiega ancora Agnieszka Sorokowska. Dunque, la
classifica, stilata esclusivamente in base all’odore, vedeva in testa non solo
chi aveva il profumo più gradevole, ma anche un Hla il più lontano possibile dal
proprio. Viceversa, all’ultimo posto, quello con il profilo più simile.
Il ruolo del profumo nel sesso. Per quanto
importante, però, il profumo non è l’unico fattore utilizzato da uomini e donne
nella ricerca del partner. È legittimo preferire determinati odori ad altri, ma
non è un aspetto decisivo nella scelta di una persona a discapito di un’altra.
Discorso parzialmente diverso per la vita sessuale. In uno studio curato da
Mehmet Mahmut, psicologo specializzato nell’analisi degli odori, e Ilona Croy,
docente di psicologia clinica dell’Università di Dresda, si legge come i
soggetti affetti dalla perdita dell’olfatto trovino molta più difficoltà nel
rapportarsi con un’altra persona, mentre le coppie con un’alta dissimilarità
delle Hla, funzionano bene nell’intimità e sembrano avere voglia di allargare la
famiglia. Nonostante i risultati delle ricerche, tuttavia, il collegamento tra
l’odore corporeo e il successo di una relazione è ancora parecchio fumoso. Più
che altro perché tutti gli altri sensi, intervenendo, influenzano le
informazioni ricavate dalla semplice valutazione del profumo.
Odori diversi tra single e persone impegnate.
Quello che, tuttavia, sembra più o meno sicuro è che l’odore differisca tra
single e persone impegnate in una relazione. Un’altra indagine curata da Mahmut
ha rilevato, infatti, che i primi presentano un profumo molto più forte dei
secondi, probabilmente legato a un più alto livello di testosterone. Esiste,
poi, un’associazione tra l’invecchiamento e la riduzione dell’ormone maschile,
situazione potenzialmente riconoscibile negli over 40, sposati e con figli. Ne
deriva che l’odore rifletta in qualche maniera la capacità riproduttiva di una
persona. Insomma, adesso avete tutte le informazioni utili per scegliere il
partner giusto.
·
Il
Sudore.
Giuliano Aluffi per “il Venerdì di Repubblica” il
22 agosto 2021. Il sudore rivelatore": non è il titolo di un racconto di Edgar
Allan Poe, ma un mistero scientifico. Nell'estate del 1996 una donna si presentò
all'ospedale Tygerberg di Città del Capo spiegando allarmata che i suoi vestiti,
in particolare sotto le ascelle e sulla schiena, da diversi giorni si tingevano
di rosso. Il medico Corena de Beer studiò il caso: la donna era sana, e non
perdeva sangue, era il suo sudore ad avere un colore rossastro. Ma perché? A una
visita successiva, De Beer notò che la donna aveva macchie marroncine e
rossastre sulle dita. Interrogata, rivelò di essere golosa delle patatine
"NikNaks Spicy Tomato": ne mangiava fino a due chili e mezzo alla settimana. A
colorare il suo sudore era quindi il pigmento rosso contenuto nello snack. Già,
perché il sudore può rivelare diverse cose sul nostro conto, e non soltanto se
siamo accalorati o nervosi. Lo spiega, nel saggio The Joy of Sweat: the Strange
Science of Perspiration ("La gioia del sudore: la strana scienza della
traspirazione", edizioni W.W. Norton), la saggista Sarah Everts, collaboratrice
del New Scientist e docente di giornalismo scientifico alla Carleton University
di Ottawa, in Canada. «Il sudore può segnalare eccessi alimentari e altri
stravizi, ma non solo» sostiene. «Ad esempio, analizzando le molecole presenti
nelle impronte digitali (che sono un effetto del sudore), si può sia scoprire se
chi ha lasciato l'impronta ha assunto alcol o droghe sia determinarne il sesso».
A proposito di sesso: c'è chi usa il sudore anche per trovare un partner. «Si
chiamano eventi di sweat dating: io ci sono stata, a Mosca» racconta Everts. «La
regola tassativa è che i partecipanti non indossino alcun profumo. Una volta
arrivati, fanno dell'esercizio fisico, e il sudore viene raccolto in ampolle
numerate. Poi ognuno annusa le ampolle altrui e si segna i numeri di quelle che
apprezza di più. Se a me piace il tuo odore e a te il mio, abbiamo un match e
possiamo conoscerci meglio prendendo un aperitivo. L'idea di fondo è che se
anche due persone si piacciono esteticamente, o sono compatibili come
personalità, ma trovano sgradevole l'odore reciproco, tra di loro non si avrà il
colpo di fulmine. Tanto vale perciò affrontare a monte la questione dell'odore».
A eccezione della polizia scientifica e dei cuori solitari moscoviti, ben pochi
apprezzano però il sudore, ospite sgradito di ogni estate, fonte di imbarazzo,
con le sue macchie e il sentore che emana nell'aria, nelle occasioni sociali e
nei momenti delicati. «Nel mondo si spendono ogni anno oltre 75 miliardi di
dollari in antitraspiranti e deodoranti» prosegue Everts. «Nella realtà
antisettica in cui ci piace vivere il sudore rappresenta un tabù, eppure non è
qualcosa di cui vergognarsi: è anzi una specie di superpotere dell'umanità di
cui dovremmo andare fieri». Iniziamo a sudare quando il nostro organismo si
accorge che si sta surriscaldando - per il calore che arriva dall'esterno o per
via dello sforzo fisico - e si attiva per prevenire il rischio di un colpo di
calore. «Evaporando sulla pelle, il sudore cede il calore del corpo all'aria: la
sua unica funzione è abbassare la temperatura corporea. In questo è
straordinariamente efficiente, perché, una volta che si attiva, ci permette di
continuare a muoverci senza problemi, e ad esempio portare a termine una
maratona. Tra gli animali solo i primati e i cavalli hanno questa
caratteristica, che ci ha consentito di diventare formidabili cacciatori. Molte
potenziali prede ci superano nello scatto, ma poi a un certo punto sono
costrette a fermarsi per potersi termoregolare, come fanno i cani: anche loro si
raffreddano facendo evaporare l'acqua del corpo, ma usano a questo scopo la
lingua e non la pelle come noi. Un antico cacciatore umano capace di mantenere
un'andatura regolare, e di seguire le tracce, poteva avere la meglio su
qualsiasi bestia in fuga». Di che cosa è fatto il sudore? Soprattutto di acqua,
sale, proteine, urea e ammoniaca. La maggiore quantità di sudore esce -
attraverso i pori della pelle - dalle ghiandole eccrine, distribuite su tutto il
corpo ma concentrate soprattutto sul palmo delle mani, la pianta dei piedi, la
fronte e le ascelle. Altro sudore è prodotto dalle ghiandole apocrine, che si
trovano sulle ascelle, sul pube e sul petto: sono più grandi delle eccrine,
fanno emergere il sudore dai follicoli piliferi e contribuiscono di più al
cattivo odore. «La colpa è della flora batterica che si annida tra i peli:
batteri come lo stafilococco o il Corynebacterium consumano i grassi portati in
superficie dal sudore e sono le loro secrezioni a maleodorare» spiega Everts. «I
deodoranti fanno effetto distruggendo questa flora batterica, che però si
riforma dopo qualche ora. Invece gli antitraspiranti otturano i pori, impedendo
al sudore di uscire». A creare uno dei primi antitraspiranti fu, agli inizi del
Novecento, il chirurgo americano Abraham Murphey, per impedire che le mani
sudate compromettessero la destrezza col bisturi. Fu sua figlia Edna, nel 1912,
a lanciarlo sul mercato con il nome Odorono, che stava per «Odor? Oh no!». «Non
fu facile farlo accettare al pubblico: conteneva cloruro di alluminio, che
tratteneva per 2-3 giorni il sudore ma irritava la pelle» racconta ancora
Everts. «Il colpo di genio venne nel 1919 all'agenzia pubblicitaria J. Walter
Thompson: nei giornali femminili comparvero pubblicità nelle quali si diceva
alle donne che sì, magari loro non si accorgevano del loro odore, ma tutti gli
altri ne erano ben consci, e anzi spettegolavano alle loro spalle». Nasce così
il cosiddetto whisper copy, una strategia di marketing efficace perché semina
un'insicurezza che si può estirpare solo acquistando il prodotto pubblicizzato.
Tra le idee che sui vari media circolano sul sudore, alcune sono radicalmente
sbagliate. «Come la sua presunta funzione di detox: è un abbaglio che risale
almeno a Galeno, il medico del II secolo d.C. che affermò che "il sudore
ripulisce il corpo dalla materia superflua e potenzialmente dannosa".» «In
realtà» precisa Everts, «espellendo il sudore non ci purifichiamo: questo è il
lavoro che fanno i reni». Galeno credeva anche che con il sudore potessimo
smaltire il grasso corporeo attraverso i pori. «E molti lo credono ancora, anche
per via delle pubblicità che mostrano tute per "dimagrire sudando". Ma il grasso
si smaltisce con l'esercizio fisico, di cui il sudore è solo un effetto». Per
chiarire meglio la funzione del sudore bisognò attendere gli studi di Santorio
Santorio, fisiologo italiano vissuto tra Cinque e Seicento. «Passava giorni su
una speciale sedia appesa al soffitto, che era una grande e precisissima
bilancia, per studiare le variazioni del peso corporeo nel corso della giornata»
racconta Everts. «Fu così che scoprì che non perdiamo peso solo con le
deiezioni, ma anche attraverso quella che lui chiamava "traspirazione
insensibile", ovvero la perdita di microscopiche goccioline d'acqua attraverso i
pori». Pori che nel corpo umano hanno un diametro di 70 millesimi di millimetro
e che corrispondono a una quantità di ghiandole sudoripare eccrine compresa tra
i due e i cinque milioni. Un esercito così numeroso e invisibile da rendere
vana, soprattutto d'estate, ogni battaglia contro il sudore. Meglio
un'onorevole, odorevole resa.
·
Il Pelo.
Pelo o non pelo? La lunga storia della
depilazione dall'età della pietra ai giorni nostri.
Michele Mereu su La Repubblica il 19 luglio 2021. Una pratica obbligatoria nelle
battaglie preistoriche, oggi è diventata uno dei trattamenti di bellezza più
richiesti dalle donne nei centri estetici. Dall'Antico Egitto, in cui i peli del
corpo identificavano lo stato sociale, sino alle celeb che li "indossano" con
orgoglio sui red carpet, come simbolo di accettazione. Ripercorriamo insieme
l'evoluzione della depilazione nel corso dei secoli. Per qualcuno è una
dichiarazione politica, per altri una semplice scelta estetica. Fatto sta che la
depilazione si praticava già migliaia di anni fa. Dalle pietre rasoio
rudimentali ai laser dei giorni nostri, ecco aneddoti e curiosità sulla lotta ai
peli. Prima che la depilazione fosse utilizzata per scopi estetici, radersi i
capelli durante l'età della pietra era una tattica di sopravvivenza, radersi
infatti era una misura di sicurezza durante la battaglia, poiché avere una testa
e un viso senza peli proteggeva dagli avversari che avrebbero potuto afferrare i
guerrieri per capelli o la barba.
Dagospia il 27 giugno 2021. Da dailymail.co.uk.
Ragazze, basta con quest’ossessione del pelo pubico. Passate più tempo a farvi
toccare dall’estetista che dal vostro ragazzo. E non è vero che la vagina liscia
liscia, come quella di una bambina, sia più igienica. D’altronde se i peli là
sotto esistono ci sarà un motivo? Primo tra tutti, quello di proteggere la
fessura più esposta e delicata del corpo di una donna. Sempre più ragazze optano
per rasarsi in parte o del tutto i peli pubici, riportando la vagina al suo
aspetto più infantile. Lo fanno prima del sesso, prima di una festa, dell’estate
o di una visita dal medico, per sentirsi più fresche e pulite. Ma gli esperti
mettono in guardia: la depilazione intima elimina lo strato protettivo della
peluria e aumenta il rischio di contrarre infezioni e malattie sessualmente
trasmissibili. A capo dello studio il dottor Benjamin Breyer, professore
associato presso il dipartimento di urologia di San Francisco: “Crediamo che la
ceretta all’inguine sia associata alla trasmissione di malattie e virus”. Più di
3.316 donne tra i 18 e i 65 anni hanno partecipato allo studio e l’84 per cento
di queste era rasata. “La cosa più evidente dai risultati è che le donne si
fanno la ceretta intima sulla base di numerose pressioni esterne che sono
probabilmente aumentate negli ultimi dieci anni.” Il dottor Tami Rowen, dal
reparto di ostetricia, ginecologia e scienze della riproduzione di San
Francisco, commenta: “La depilazione è diventata un aspetto fondamentale per le
donne del 21esimo secolo”. Tra queste, però vi sono però differenze demografiche
sorprendenti. Le donne che si depilano di più hanno meno di 50 anni sono per lo
più bianche e hanno frequentato l’università”.
·
I Capelli.
Marino Pagano per “Libero
quotidiano” il 15 novembre 2021. Medioevo, sempre ed ancora medioevo. Medioevo
nella testa, se si vuole, sui capelli. Così vuole sicuramente Virtus Zallot,
docente di Storia dell'Arte medievale e Didattica dell'Arte all'Accademia di
Belle Arti Santa Giulia di Brescia, autrice, per Il Mulino (253 pagg,, 26 euro),
di un saggio curioso sin dal titolo. Sulle teste nel medioevo. Storie e immagini
di capelli, per l'appunto. Qualche anno fa, nel 2018, sempre per Il Mulino, era
apparso il suo Coni piedi nel medioevo. Medioevo ovunque, insomma. Il punto è
che il corpo, se è importante oggi, era importante pure nel medioevo. I capelli
come occasione di lettura culturale e sociale - attraverso la mediazione della
creatività dell'arte - di un periodo complesso come quello medievale. Il capello
permette al potere ed alle sue ostentazioni una visione non a tutti i costi
uniforme. Il tutto in esistenze più brevi rispetto alle nostre, ma inserite in
una lettura storiografica che contempla il lungo periodo. E dunque, tanti
cambiamenti in pochi decenni di vita ma tanti in molti secoli. In barba alla
visione pregiudiziale di un medioevo visto come epoca di fissità. I capelli come
«attributo non solo di persona, ma di personalità», scrive l'autrice. Capelli
come proiezione dei sessi, dei gruppi: della riconoscibilità
pubblica. Soprattutto nell'Alto medioevo, la capigliatura dell'uomo ha il suo
risvolto sociale ma anche stretto alla virilità: i capelli lunghi ne saranno il
simbolo, mentre la donna doveva nascondere i capelli col velo, tranne le
vergini, "in attesa" o martiri - e dunque vergini in eterno - che
fossero. Quando e quali i momenti di questo esibizionismo sociale? Siamo a
Firenze, nel '300. Qui Franco Sacchetti fece ironia sulla tradizione femminile
di acconciarsi la testa a forma di torri costituite da cerchi sovrapposti di
capelli veri e finti. Sua la canzone Contro alla portatura de le donne
fiorentine.
Nel Tardo medioevo si affermò
il balzo, struttura a cupola, uovo o turbante, a cui si avvolgevano i capelli.
Noto, in questo senso, il ritratto di Ginevra d'Este da parte del Pisanello,
oggi al Louvre. Facciamo attenzione, intanto, alla possibilità di potersi
atteggiare, di darsi un tono. Ebbene: i pettini, tanto per cominciare,
costavano, erano spesso di materiale prezioso e le classi povere li hanno
conosciuti più tardi. L'estetica, ancora una volta, veicola il messaggio
sociale. Complessità di stile come privilegio, mentre le donne semplici si
limitavano ad imitare le abbienti oppure a raccogliere i capelli, come si è
usato persino fino a pochi decenni fa. La vanità femminile era considerata ai
limiti dello sfacciato dai predicatori religiosi: una forma di peccato, da farsi
perdonare. Con il Tardo medioevo, poi, il rigore di acconciature dalle fogge
talvolta bizzarre sarà totale e capillare (ops!). Sempre tra i ricchi,
ovviamente. Un problema eterno, come sappiamo, è quello di nascondere la canizie
e così, nel medioevo, è codificata la tintura, che tuttavia accompagna la storia
dell'uomo da sempre, sin dal neolitico. Le donne, per le fonti, amano imbiondire
i capelli. Cesare Vecellio, nel suo Abiti e costumi a Venezia, descrive l'uso
delle donne di frequentare la terrazza delle case, l'altana, credendo di
conservare gli aspetti giovani nei capelli, tenendoli esposti al sole per tante
ore. Ma oltre al sole, per le dame veneziane, c'era appunto una tintura, stesa
sui capelli con la "sponzeta", una piccola spugna. Il medioevo, però, oscilla
tra estremi e così, quando serviva, altro che cura e crescita: il capello andava
anche tagliato, sorta di espressione anche rituale. Così Liutprando accorciò i
capelli a Pipino il Breve, re Artù all'eroe Culhwch. E i merovingi? Per loro, al
contrario, i capelli lunghi significavano regalità. Qui l'eredità biblica sembra
chiara. Se si perdevano i capelli, il rischio si faceva alto, compromettendo
ogni aspirazione. Un caso su tutti, quello della regina Clotilde: tra nipotini
uccisi, piuttosto che dai capelli corti, preferì la prima opzione. I capelli
rientrano in pieno nella logica medievale e nelle sue principali sintesi
culturali. Questo acSopra: Pisanello «Ginevra d'Este». In basso, da sinistra: Lo
Scheggia, «Scena nuziale» dal Cassone Adimari; Giovan Pietro da Cemmo, «Sibilla»
(particolare); Ambrogio Lorenzetti «Allegoria del Buon Governo» (particolare)
cade per l'aderenza dei capelli alla vita, all'esistenza. I capelli sono vita,
sono morte. In questo senso, la Zallot ricorda il Petrarca del Trionfo della
Morte, allorché a Laura la vita è tolta proprio mediante lo strappo di un
capello. Come dire: senza il capello si muore. Ed inevitabilmente il lungo
apparato di citazioni, artistiche e letterarie, sta a caratterizzare il volume
nella convinzione di una precisa peculiarità legata ai
capelli. «Significativamente gli scrittori limitano spesso il ritratto fisico
alla descrizione dei capelli, talora citandone soltanto il colore. Pregiudizio
formalizzato, esso informava sulla valenza del personaggio: dei neri e rossi era
meglio diffidare, mentre i biondi garantivano superiorità fisica, etica e
sociale», scrive la Zallot. Un libro completo, perché alla fine si sofferma
anche sulla trattazione del tema del capello nell'evo moderno e contemporaneo,
persino con qualche accenno pop. Un mondo diverso, il nostro, da quello
medievale, va da sé. Dall'immagine che trasmette un sapere simbolico ed
essenziale, tipica dell'età di mezzo, all'attuale culto ipertrofico per
l'immagine stessa. E così, magari, il medioevo ci appare addirittura un
insospettabile maestro di misura. Ancora una volta, va a finire che il millennio
più bistrattato di tutti ci insegna qualcosa.
·
L’occhio vuole la sua parte.
Flavio Pompetti per "Il
Messaggero" il 4 settembre 2021. Prima delle seconda guerra mondiale il Giappone
annoverava più di 90.000 geishe, divise in migliaia di case di accoglienza
disseminate per l'intero paese. Oggi i ranghi sono ridotti a poche centinaia,
confinate in ristoranti d'alta classe che organizzano banchetti per i ricchi e
per i turisti. Le specialità artistiche sviluppate dalle donne che scelgono
questa professione sono in declino, e le limitazioni imposte dall'epidemia di
Covid rischiano di seppellire una delle arti più antiche ancora coltivate
nell'isola asiatica. La Cnn ha di recente dedicato ai fiori di Tokio, questo il
nome con le quali le professioniste dell'accoglienza erano conosciute nel loro
periodo d'oro, un articolo che passa in rassegna le trasformazioni che la
professione ha subito nel corso degli anni, fino alle condizioni di precarietà
nelle quali versa al momento. Le geishe sono l'incarnazione di canoni estetici
accumulati nel corso di secoli, e che in gran parte erano già formati in
Giappone prima della fine del primo millennio. Nella accezione più moderna sono
ragazze che le famiglie indigenti destinano alla professione per salvarle da una
vita di stenti. «Le geishe erano un grande business e parte integrante della
società, ma ora sopravvivono solo come cultura da preservare», spiega Hisafumi
Iwashita, professore alla Kokugakuin University. Le geishe sono tenute a
rimanere celibi, ma possono lavorare finché vogliono senza andare in pensione. È
ciò che sta facendo, a 80 anni, Ikuko, che non solo è a capo dell'Akasaka Geisha
Association, ma è anche una geisha praticante. «Stiamo lottando per la
sopravvivenza - spiega Ikuko - Tutto quello che possiamo fare è allenarci
costantemente per essere pronti a esibirci in qualsiasi momento». Ma mentre il
futuro è incerto per molti nel settore, la ottantenne Ikuko affermato che la
professione le ha dato l'indipendenza economica, liberandola dalla pressione
della società per sposarsi e fondare una famiglia. «Questo è il miglior lavoro
che una donna possa avere, sono in buona salute e di buon umore fino a questa
età. Non ho rimpianti per aver scelto di diventare una geisha». L'apprendistato
dura più di un anno, durante il quale le candidate sono istruite al canto e al
trucco cosmetico, ma anche all'arte della conversazione colta. Le geishe devono
saper danzare e mostrare un portamento impeccabile nei movimenti. Una volta
formata, il fiore è la quintessenza della raffinatezza. La sua presenza
arricchisce l'ambiente e propizia le trattative tra i clienti maschi, sia nel
commercio che nella politica. Il luogo che le raccoglie oggi è il ryotei, il
ristorante di lusso di gusto tradizionale nei quali si svolgono i banchetti. I
clienti siedono a gambe incrociate dopo aver rimosso le calzature intorno a
tavolini bassi, e le geishe si muovono intorno a loro con la grazia di movimenti
levigati dalla ripetizione ossessiva. Nel corso dei secoli alcune di loro sono
assurte ad un tale livello di celebrità e di riverenza da diventare tesoro
nazionale vivente, la massima onorificenza artistica insignita dal governo
giapponese. Tale stato sociale è oggi minacciato da una parte dalla
democratizzazione della professione. I banchetti organizzati dalla classe ricca
e aristocratica sono sempre meno numerosi. Al loro posto sono i turisti
stranieri affluenti a riservare i ryotei, e i consigli aziendali, a volte anche
composti da sole donne. L'emancipazione della società giapponese ha reso poco
rilevante l'immagine di una donna-ancella perfetta, specializzata nel servire e
nell'accudire il piacere e l'intrattenimento del maschio intorno ad una
tavola. L'epidemia ha poi aggravato la crisi del settore. Le geishe vengono
pagate sulla base degli ingaggi, e il numero dei banchetti è caduto
drasticamente negli ultimi due anni.
Maria Luisa Agnese per
il "Corriere della Sera" il 3 agosto 2021. Saranno una quarantina di uomini,
ottanta occhi che guardano verso quella ragazza di forme sontuose che incede
verso di loro, tutti maschi in grigio, con al centro quella macchia bianca di
fiera bellezza ripresa di schiena e pochi altri elementi di contorno, una
lambretta, la ruota di una bicicletta e l'insegna Zucca a far capire che siamo
sulla soglia della Galleria Vittorio Emanuele nella Milano di metà anni
Cinquanta, ai tempi del pre boom economico. Quella di Mario De Biasi è una
fotografia che va famosa nel mondo con il titolo Gli italiani si voltano e che
oggi non si potrebbe scattare o perlomeno se si scattasse sarebbe accolta da
tali e tante polemiche che sarebbe bollata come atto ultra politicamente
scorretto, invece di finire come è finita anni dopo in mostra al museo
Guggenheim di New York scelta da Germano Celant come manifesto per la sua mostra
«The Italian Metamorphosis 1943-1968», per raccontare proprio un mondo ormai in
dissolvenza. Le fotografie rappresentano quasi plasticamente lo spirito del
tempo e vanno incorniciate nel loro periodo e non giudicate a posteriori, anche
perché come in questo caso ci aiutano - cogliendo il loro impatto generale in un
primo tempo e poi andando a fondo ad esaminarne i dettagli - a ricostruire la
storia materiale del momento, facendole interagire con quello che viene
tramandato dalla tradizione orale. Perlomeno quando sono foto alfa come questa
del fotografo De Biasi che è stato una specie di rabdomante della sua
contemporaneità, un occhio presentissimo nei grandi avvenimenti della storia
come negli eventi sociali. Fra gli inviati di punta della rivista Epoca , ai
tempi fiore all'occhiello del parterre Mondadori, ha fatto reportage dal mondo
(tra gli altri quello sulla rivolta d'Ungheria del 1956), e ha fotografato
personalità come Marlene Dietrich, Brigitte Bardot, Sophia Loren. Gente famosa,
rivoluzioni, luoghi sconosciuti, con la macchina fotografica come protesi o
meglio parte della sua anatomia, un terzo occhio sempre con sé. Questa immagine
ormai iconica e parte del corpus della nostra memoria collettiva di cui parliamo
in questa pagina si è presentata davanti all'obiettivo di De Biasi alla fine di
una giornata spesa dal fotografo in giro per il centro di Milano, da Piazza San
Babila alla Galleria, in compagnia di una bella ragazza che gli faceva da
testimonial per un servizio che era stato commissionato dal settimanale Bolero
Film. La fanciulla si chiamava Moira Orfei era una trapezista acrobata di 23
anni della grande famiglia di artisti del circo, ancora sconosciuta (non ancora
lì attrice famosa che sarebbe diventata musa per Fellini e Pietro Germi, anche
se qualcuno già preveggente quel giorno le chiese l'autografo) che corrispondeva
ai canoni della bellezza del tempo e incedeva con una sua libera fierezza mentre
si accingeva ad affrontare quel muro di sguardi maschili, una scena da paesino
del Sud alla Malena, e invece eravamo nel cuore della Milano del 1954 che già si
avviava a diventare forza trainante del boom dell'Italia post bellica. Che
sguardo avrà avuto la fanciulla, vista da davanti? ci si potrebbe chiedere. E la
risposta è nell'immagine speculare sempre scattata da De Biasi in cui Moira si
allontana con sguardo noncurante. «Il fotografo gioca allegramente con la
situazione sociale e il cliché dell'occhiata torbida del maschio italico, e lo
fa con una composizione che abbonda di curve» ha notato non senza britannico
humour il sito Vintage everyday . «La ruota della bici, i paraurti dello
scooter, le teste degli uomini, la camminata basculante della donna; persino
l'insegna Zucca evoca le curve (quasi ) in ogni lettera, e in italiano ha doppio
significato, l'ortaggio e la testa vuota». Sul cliché del periodo Gli italiani
si voltano si era performato poco tempo prima un regista come Alberto Lattuada,
girando proprio con questo titolo un episodio del film-inchiesta a più mani
L'amore in città , ideato da Cesare Zavattini nel 1953. Lattuada, che di sguardi
maschili e bellezza femminile se ne intendeva parecchio, aveva scoperto negli
anni Carla Del Poggio (poi sua moglie), Catherine Spaak, Valeria Moriconi,
Dalila Di Lazzaro, Nastassja Kinski, Clio Goldsmith, Barbara De Rossi. Nel suo
episodio Lattuada fa scendere e salire per le strade di Roma un piccolo esercito
di donne di forme fastose, maggiorate del tempo seguite da rapaci sguardi
maschili che oggi, invece di essere accarezzati dalla macchina da presa, non
sarebbero neppure contemplati. Ma anche qui le protagoniste non sono imbarazzate
ma sempre accompagnate da una certa aria di lungimirante indipendenza. Come la
giovane Moira Orfei.
Dagotraduzione dal New York Post il 31 luglio
2021. La sensualità non ha scadenza. E gli scatti dell'estate ne sono una prova:
i più bollenti sono stati pubblicati da donne over 50. Certo alcune star
potrebbero essere state benedette dai geni, ma apparire così in forma non è
proprio facile. «Per sembrare così a 57 anni ci vuole lavoro… è tutta una
questione di manutenzione» ha detto di recente l'attrice e star del reality Lisa
Rinna, che ha appena compiuto 58 anni l'11 luglio. Ecco uno sguardo ad alcune
delle star più in voga dai 50 anni in su e ai segreti del loro successo
anti-invecchiamento, dalle filosofie di fitness e superfood alle procedure
costose.
Jennifer Lopez, 52. La focosa cantante e mamma di
due figli insiste che il suo viso e il suo corpo siano naturali. Poco dopo aver
lanciato la sua linea di prodotti per la cura della pelle, JLo Beauty, l’artista
ha risposto alle critiche su Instagram. «È solo la mia faccia... Per la 500
milionesima volta... Non ho mai fatto Botox o qualsiasi iniettabile o intervento
chirurgico!». È innegabilmente attiva - le sue esibizioni prevedono ore di
ballo, dopotutto - e si allena con più istruttori, tra cui la guru del cardio
dance Tracy Anderson. Non si abbuffa di caffè e alcol e si carica di
proteinemagre come manzo e salmone accompagnati da verdure. La Lopez è anche
molto interessata agli integratori, crede nella «bellezza dall'interno», e
pubblicizza la pillola che aumenta il collagene nella sua linea JLo Beauty che
prende ogni giorno. È anche entusiasta della salute dell'intestino e ha
collaborazioni con l’azienda di vitamine gommose Goli - ha detto che l'aceto di
mele gommoso è il suo preferito - e una soda prebiotica alla moda, Poppi.
Demi Moore, 58. Anche se ha abbellito le copertine
delle riviste nuda e recentemente ha posato un selfie su Instagram indossando un
due pezzi del marchio di costumi da bagno Andie, Moore ha lottato a lungo con la
consapevolezza del suo corpo. Nel suo libro di memorie del 2019 "Inside Out", la
leggendaria attrice di "Proposta indecente" ha parlato del body shaming che ha
vissuto da giovane attrice e delle pressioni e del "dolore e della tortura" che
ha sopportato per rimanere magra. «Ho eliminato i carboidrati, ho corso, ho
pedalato e ho lavorato su ogni macchina immaginabile», ha scritto. Ma in un
articolo uscito su Harper's Bazaar nel 2019, Moore ha confessato di aver
abbandonato l'allenamento per quattro anni, prima provare la palestra virtuale
The Mirror. Si dice che gli allenamenti di 15 minuti a basso impatto siano
delicati sulle articolazioni mentre rafforzano e scolpiscono il corpo.
Paulina Porizkova, 56. La Porizkova entusiasma i
follower di Instagram con le sue curve killer, soprattutto contro i critici che
cercano di porre un limite di età artificiale alla bellezza. Il mese scorso,
l'ex modella ha pubblicato una sua foto durante un allenamento, raccontando che
fa sport da tre a cinque volte a settimana: «Lo odio dannatamente», ha detto, ma
ha lodato il metodo Nofar. «Non mi piace sudare e sbuffare», ha detto la
Porizkova, che origini ceche. «Se sedermi su un divano, mangiare una torta, bere
vino e leggere facesse lo stesso per me come esercizio, non ci sarebbe
competizione…. [ma] sono arrivata a scoprire che "lavorare" è quella piccola
pillola perfetta che tutti cercano». A Page Six Style ha raccontato cosa usa per
la pelle: procedure non chirurgiche come la Ultherapy (che rassoda e solleva la
pelle, 5.000 dollari a trattamento), l’Emsculpt (una macchina per il
rimodellamento del corpo) e la penna al plasma (un trattamento antirughe che
costa circa 350 dollari ad applicazione).
Halle Berry, 54. L'attrice ha addominali su cui
puoi bilanciare un Oscar grazie alle ore di sudore che documenta sui social ai
suoi sette milioni di follower. Ha lavorato con l'allenatore di celebrità Peter
Lee Thomas per circa cinque anni. La coppia ha lanciato la piattaforma per la
salute e il benessere, re•spin. L'attrice ha dichiarato a InStyle a marzo che il
programma è incentrato sul fai da te. «Non hai bisogno di un abbonamento a una
palestra per essere sano e in forma», ha detto. Berry preferisce mescolare gli
allenamenti con forza, cardio, yoga e stretching. «Per me, è stato importante
non sovraccaricare il mio corpo», ha detto alla rivista. In una recente
intervista sulla sua collaborazione con il marchio di abbigliamento sportivo
britannico Sweaty Betty, l'attrice ha detto che sta per invecchiare. «Ogni
decennio, mi sono sentita sempre più me stessa», ha detto, sottolineando
l'importanza della cura di sé. «È importante muovere il corpo ogni giorno e
avere un qualche tipo di interazione corporea che ti faccia sentire vivo, anche
se non è un esercizio estremo. Se mediti, ti muovi dentro di te; stai muovendo
il tuo spirito, stai muovendo le energie all'interno intorno al tuo corpo. Se
leggi, questo è movimento. Questo è accendere il tuo cervello e accendere la
fantasia, viaggiare nella tua mente».
Lisa Rinna, 58. La star di "The Real Housewives of
Beverly Hills" ha postato una foto sexy di se stessa all'inizio di questo mese
per festeggiare il suo 58esimo compleanno. Rinna ha rivelato in un'intervista a
Vogue di aver visto per la prima volta un dermatologo all'età di 13 anni. «Mi
hanno messo in un programma e da allora ho sempre seguito una routine di cura
della pelle», ha detto, rendendo un omaggio speciale all'idratante Chicet Bone
Marrow Cream (35 dollari) - fatta con olio di midollo osseo a base di suino - e
usata da 10 anni. «Sembro fresca come una margherita». Rinna ha detto a People a
dicembre di essere una «sporca vegana»: «Sono principalmente vegana, ma se ho
bisogno di mangiare un po' di carne, la mangio». La mamma di due figli ha
rivelato che si allena sei volte a settimana, a volte anche due volte al giorno
secondo OK! mag — alternando lezioni di spinning e yoga. «Penso solo che sia
davvero bello muoversi ogni giorno», ha detto Rinna. «Amo davvero la
combinazione di SoulCycle e yoga. Mi mantiene equilibrata e sana di mente».
Salma Hayek, 54. L'attrice attribuisce alla
menopausa l'amplificazione delle sue ampie risorse. Spiegando che il suo seno
«continuava a crescere», Hayek ha elaborato una sua teoria durante la serie
Facebook di Jada Pinkett Smith, “Red Table Talk”: «Per alcune donne, il seno
diventa più piccolo. Per altre, si gonfia quando ingrassi, o quando allatti
oppure in menopausa. Mi è capitato di essere una di quelle donne a cui è
successo in ogni singolo passo! Quando sono ingrassata, quando sono rimasta
incinta e quando sono entrata in menopausa». L'attrice di “Frida” ha anche
ribattuto agli stereotipi sull'età: «Non ci sono date di scadenza per le donne.
Questo deve andare. Perché puoi spaccare il culo a qualsiasi età. Puoi cavartela
a qualsiasi età, puoi sognare a qualsiasi età, puoi essere romantico a qualsiasi
età”.
Elizabeth Hurley, 56 anni. L'attrice e modella di
"The Royals" non ha motivo di nascondersi, specialmente quando sembra così
sublime. Ha raccontato a E! di aver eliminato gli spuntini a tarda notte.
«Mangia il tuo cibo all'inizio della giornata, così hai più tempo per digerirlo
e il tuo corpo può riposare durante il periodo di sonno», ha detto, facendo
notare il suo modo non tradizionale di allenarsi. «Non vado in palestra, ma sono
abbastanza attiva… Non mi siedo davvero e non mi sdraio sul divano». Per prima
cosa al mattino beve un grande bicchiere di acqua calda. «Ha un sapore
abbastanza disgustoso, ma è fantastico per il tuo sistema digestivo», ha detto.
Sharon Stone, 63. L'attrice di “Basic Instinct”
non è per niente considerata una femme fatale. Non è schiava delle diete, ma è
attenta a una sana alimentazione. «Non mangio cibi lavorati. Non bevo caffeina e
molto raramente bevo bibite gassate o alcol», ha detto al New York Times. «Ma
mangio carne e cioccolato fondente. Zucchero il mio tè se ne ho voglia. Sono
celiaca, quindi non mangio glutine. Altrimenti mangio come una persona normale,
qualunque cosa se ho fame». Adora gli allenamenti di pilates a casa. Ha aggiunto
che la sua filosofia di bellezza «è bellezza interiore. È importante avere una
filosofia, uno stile di vita o una fede che ti mantenga equilibrato».
Naomi Campbell, 51 anni. La leggendaria modella,
51, ha annunciato l'arrivo della figlia a maggio, anche se non è chiaro se la
stessa Campbell abbia partorito, assunto una madre surrogata o adottato la
bambina. Ma è il fisico elegante dell'icona della moda che fa parlare ancora la
gente. Ha sollevato 105 libbre (47 chili) in un video di Instagram del 2019,
facendolo sembrare semplice come sfilare a Parigi. È anche famoso perché,
insieme all'allenatore Joe Holder, trasmette in streaming su Instagram Live i
suoi allenamenti quotidiani, che spesso si concentrano sulle sue gambe scolpite.
«La metà inferiore del tuo corpo ha i muscoli più grandi: glutei, quadricipiti e
muscoli posteriori della coscia», ha detto Holder a Vogue. Aggiunge resistenza
agli esercizi di condizionamento (come i sollevamenti delle gambe a conchiglia
per rassodare i glutei) usando le bande ed è una grande fan dello stacco da
terra, che scolpisce e rafforza la parte posteriore del corpo.
Padma Lakshmi, 50. L’autrice di libri di cucina
"Top Chef" sa tutto di quello che è frizzante. A 50 anni, ha un fisico
seriamente snello allenandosi "almeno" cinque giorni alla settimana, 90 minuti
al giorno, ha detto a Women's Health. Le è stata diagnosticata la scoliosi a 13
anni e un anno dopo ha subito una frattura all'anca e a un braccio a causa di un
brutto incidente d'auto, ma l'attenzione di Lakshmi per il pilates ha cambiato
la sua vita. «Il pilates ha cambiato il mio corpo. Mi ha reso forte in posti in
cui non sapevo di poterlo essere. Ora ho un sedere che non avevo durante la mia
carriera di modella», ha detto alla rivista. Lakshmi, che ha una figlia di 11
anni, svolge circa 35 minuti di salto con la corda nei suoi allenamenti per il
cardio. La chef predilige una dieta a base vegetale e divide i suoi piatti così:
50% di frutta e verdura, 50% di carboidrati semplici, amido e proteine magre.
Inoltre, nel menu ci sono fino a 10 tazze al giorno di masala chai «molto
forte», che si dice riduca l'infiammazione, aumenti l'immunità e aiuti la
digestione.
Da tgcom24.mediaset.it il 25 luglio 2021. Il ruolo
di coniglietta Dolly Parton piace proprio. E così dopo aver espresso qualche
tempo fa il desiderio di posare nuovamente "Playboy", ora che la celebre rivista
non c'è più si è vestita da coniglietta da sola come regalo di compleanno per
suo marito Carl. "Pensa che io sia ancora una ragazza sexy dopo 57 anni insieme
- ha detto in un video su Twitter -, e di certo non cercherò di dissuaderlo". La
copertina da lei realizzata nel 1978 per la rivista di Hugh Hefner è di quelle
passate alla storia. Niente nudo ostentato, a dire il vero, ma Dolly in corpetto
da coniglietta su sfondo rosso mentre si aggiusta il papillon glitterato, è
un'immagine diventata iconica. Il suo sogno sarebbe stato riprodurla all'età di
75 anni, per mostrare come ci si può sentire sexy anche a una certa età. Ma
"Playboy" non ha resistito tanto a lungo. E allora la cantautrice dalle forme
prosperose ha fatto tutto da sola. Ha posato con il medesimo corpetto, papillon
e polsini di quarant'anni fa, facendosi ritrarre. Il risultato poi lo ha
mostrato nel video su Twitter in cui ha voluto spiegare la sua iniziativa. E
tanti auguri al marito Carl, dal quale è inseparabile dal 30 maggio del 1966.
Dagotraduzione dal Daily Mail il 14 luglio 2021.
Secondo un nuovo studio gli uomini con i tratti del viso lunghi e gli occhi
grandi e le donne con il viso magro e gli occhi piccoli sono percepiti come più
promiscui. Esperti australiani hanno chiesto a uomini e donne eterosessuali i
loro livelli di "sociosessualità" – cioè la volontà di impegnarsi in attività
sessuali al di fuori di una relazione, detto anche sesso occasionale. I
partecipanti hanno anche dovuto scattare una loro foto e mostrarla ai
partecipanti del sesso opposto, in modo che potessero giudicare, basandosi solo
sull'aspetto, se fossero interessati alla sociosessualità. Secondo il team, gli
uomini che erano aperti al sesso occasionale in genere avevano facce più lunghe,
fronte più alta, nasi più lunghi e occhi più grandi. Le donne hanno identificato
con precisione queste caratteristiche facciali maschili come indicatori
dell'interesse dei ragazzi per il sesso occasionale. Gli uomini invece
percepivano erroneamente volti femminili più piccoli e più gracili, con occhi
più piccoli e labbra più piccole, come un indicatore dell'apertura delle donne
al sesso occasionale. Quindi, questi potrebbero essere i tratti fisici che gli
uomini cercano quando sono pronti per una notte di sesso, consciamente o
inconsciamente. Ma potrebbero non corrispondere alle intenzioni della donna. In
sostanza, i risultati suggeriscono che le donne sono brave a identificare
correttamente le caratteristiche fisiche che negli uomini indicano interesse per
un'avventura di una notte, ma non viceversa. Gli autori dello studio, della
Macquarie University in Australia, volevano saperne di più sugli indizi della
sociosessualità nei nostri volti. «Quando cerchiamo un nuovo partner, potremmo
cercare cose diverse», ha detto l'autore dello studio, il professor Ian Stephen.
«A volte potremmo cercare di formare una relazione duratura, ma altre volte
potremmo semplicemente cercare un'avventura. Abbiamo deciso di vedere se le
intenzioni delle persone potevano essere rivelate dai loro volti». Per lo
studio, sono state fotografate poco più di 100 persone caucasiche, tutte con
un'età media di 20 anni, a cui è stato chiesto di completare il Sociosexuality
Orientation Inventory-Revised (SOI-R). Questo questionario convalidato misura
l'apertura a rapporti sessuali casuali e non impegnati. «Si è scoperto che le
donne erano davvero brave a giudicare se gli uomini fossero interessati solo a
relazioni non impegnate a breve termine», ha detto il coautore Joe Antar.
«Questa è un'abilità davvero preziosa da avere, in quanto consente alle donne di
prendere decisioni inconsce su quali uomini sono adatti a loro, in base ai loro
obiettivi di relazione». Gli uomini però, non sono stati in grado di esprimere
con precisione giudizi simili sulle donne sulla base delle loro fotografie. In
altre parole, gli uomini non sono stati così bravi a giudicare se le donne
fossero interessate solo al sesso occasionale. «Questo ci ha sorpreso», ha detto
il professor Stephen. «La capacità di esprimere questi giudizi sarebbe davvero
utile anche per gli uomini che stanno cercando di giudicare chi potrebbe essere
interessato a relazioni non impegnate a breve termine e chi potrebbe essere più
interessato a qualcosa di più lungo termine e più serio». Questa differenza ha
portato a un'altra domanda, a cui i ricercatori hanno tentato di rispondere con
l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Il team voleva sapere se le donne
sono migliori degli uomini nel riconoscere i partner sociosessuali per via di
qualcosa nel cervello delle persone che guardano, oppure per qualcosa nei volti
delle persone guardate. «Se la differenza è nei volti, ciò significa che ci sono
informazioni sulle intenzioni di relazione nei volti degli uomini ma non nei
volti delle donne», ha affermato il professor Stephen. In questo caso, dovremmo
essere in grado di insegnare a un algoritmo informatico a formulare
correttamente giudizi sulle intenzioni relazionali degli uomini ma non delle
donne. «Se il computer farà altrettanto bene con i volti di uomini e donne, la
differenza deve essere nel cervello degli osservatori». I risultati sono stati
chiari: l'intelligenza artificiale poteva fare previsioni accurate sulle
intenzioni relazionali degli uomini dai loro volti, ma non sulle donne.
«Pensiamo che questo indichi un ruolo per il testosterone», ha detto Antar.
«Livelli più elevati di testosterone sono associati a caratteristiche facciali
dall'aspetto più maschile e a comportamenti più tipicamente maschili come
l'interesse per le relazioni a breve termine e non impegnate. Poiché il
testosterone svolge un ruolo molto più piccolo nello sviluppo femminile, questo
spiegherebbe anche perché le informazioni sull'intenzione di relazione non
sembrano essere presenti nei volti delle donne. Ma dobbiamo fare più ricerche
per saperlo con certezza». Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Evolution
and Human Behavior.
Dagotraduzione dal DailyMail il 6 giugno 2021. Un
gruppo di scienziati dell'Università del Queensland ha cercato di studiare che
cosa vogliono donne e uomini quando cercano un partner. Per riuscire
nell'impresa, i ricercatori hanno intervistato 7.325 utenti di siti d'incontri,
chiedendo loro di valutare tra 0 a 100 l'importanza di nove diverse
caratteristiche, e cioè: età, attrattiva, costituzione fisica, intelligenza,
istruzione, reddito, fiducia, apertura, connessione emotiva». Sia uomini che
donne hanno ritenuto importanti qualità come la costituzione fisica,
l'attrattiva e i tratti della personalità. Ma le donne hanno dato punteggi
maggiori rispetto all'altro sesso a età, istruzione, intelligenza, reddito,
fiducia e connessione emotiva. I maschi invece hanno assegnato priorità più alte
ad attrattiva e corporatura. «Man mano che gli uomini e le donne invecchiano, le
loro preferenze si avvicinano maggiormente, con entrambi i sessi che
attribuiscono maggiore importanza all'apertura e alla fiducia, mentre
l'importanza relativa alla connessione emotiva è altrettanto importante per
maschi e femmine di tutte le fasce d'età», ha detto il dottor Stephen Whyte,
responsabile dello studio. E mentre entrambi i sessi preferiscono un compagno
fisicamente attraente, i maschi hanno dimostrato di dare maggiore peso
all'attrattiva. «Le femmine sono più selettive riguardo ad altre caratteristiche
perché il loro tempo per la riproduzione è limitato, non possono rischiare di
scegliere male».
La storia del trucco per l'uomo
dall'Antico Egitto ai Maneskin. Michele Mereu su La
Repubblica il 4 maggio 2021. Quante volte abbiamo sentito ripetere questa frase:
"Un tempo gli uomini non si truccavano". Niente di più falso. A smentirlo è la
storia dell’evoluzione dell’uomo, che dimostra come il trucco maschile non sia
per niente una tendenza moderna e il suo utilizzo risalga ai tempi dell’Antico
Egitto. Il motivo? Lo stesso per cui negli anni '70 e '80 lo utilizzavano star
come David Bowie e Prince e oggi cantanti come Achille Lauro, Fedez e i
Maneskin, a partire dal suo frontman Damiano David (nella foto in alto): per
distinguersi, rendersi attraenti e riconoscibili. Il make-up (ma anche lo
skincare) non è più un vezzo da rock star e lo dimostrano le vendite in costante
crescita di cosmetici al maschile e la nascita di linee make-up e skincare con
campagne di comunicazione fluide, come quella di Gucci, oppure dedicate anche o
unicamente al pubblico maschile, come Him/Her Lip Care di Giorgio Armani e la
mini collezione make-up per lui Boy de Chanel. Di seguito le tappe principali
del trucco maschile dall’Antico Egitto a oggi. Il trucco maschile è una costante
nei dipinti dell’epoca: uomini e donne nell’Antico Egitto, infatti, indossavano
grandi quantità di trucco, soprattutto il famoso kohl o eyeliner sugli occhi. In
questa civiltà iniziata intorno al 3000 a.C si pensava che il trucco desse loro
protezione dagli dei Horus e Ra. L'eyeliner, che creavano dalla macinazione di
minerali, come malachite e galena, aveva uno scopo tanto spirituale quanto
pratico: si credeva che proteggesse dalle mosche, dalle infezioni e dai raggi
del sole. In seguito, alcuni studi hanno dato loro ragione, dimostrando che la
miscela di polveri scure aveva effettivamente la capacità di prevenire le
infezioni agli occhi e di proteggerli dal sole. Una delle personalità più famose
dei tempi e appassionate del trucco agli occhi era il Re Tutankhamon, che veniva
regolarmente raffigurato, come espressione del suo potere, con l'eyeliner nero o
verde. Anche l'uso dello smalto risale a quest'epoca: gli uomini lo indossavano
dal 3.200 a.C. a Babilonia, in Cina ed Egitto, usando i colori per indicare una
sorta di gerarchia sociale. Gli uomini dell'Antica Roma invece erano noti per
dilettarsi con il trucco, spesso usando cipria, rossetto e smalto per unghie
sempre per distinguersi.
IL REGNO GENDERLESS DI ELISABETTA I. Durante il
regno di Elisabetta I, gli uomini britannici si truccavano più delle donne.
Erano soliti curare la pelle realizzando maschere con ingredienti naturali, come
uova e miele, proprio come facciamo noi oggi. Inoltre, tutti aspiravano a
un incarnato pallido, per questo utilizzavano polveri bianche per creare una
sorta di cipria rudimentale, utile a sbiancare la pelle. Dopo il regno di
Elisabetta I, il trucco cadde in disgrazia, in parte perché era formulato
(soprattutto i rossetti) con piombo, sostanza tossica, causa di molti decessi, e
in parte per volere della regina Vittoria, al trono sino alla fine del XIX
secolo, che ne vietò l’uso, ritenendolo volgare e associandolo al mestiere della
prostituta. Fu così che gli uomini, così come le donne, smisero di truccarsi
fino a quando l'industria del trucco non si modernizzò, rimuovendo tutto il
piombo dalle formule, cosa che successe tra la fine del XIX e l'inizio del XX
secolo.
ALLA CORTE DI LUIGI XVI. Non è mistero che Luigi
XVI di Borbone divenne calvo all’età di 23 anni, costringendo così
l’aristocrazia francese a utilizzare le parrucche proprio come faceva lui
stesso. Questa moda bizzarra coinvolse anche le donne, che arrivarono ad
indossare parrucche alte anche 75cm, costringendo gli architetti ad alzare le
porte dei palazzi e i costruttori di carrozze ad abbassare i sedili. Uomini e
donne si incipriavano il volto e disegnavano nei finti in tutto il viso. Poi,
per evitare morti da avvelenamento cosmetico, anche in Francia furono ritirati
cosmetici contenenti bianco di piombo, sublimato corrosivo, allume e salnitro.
'900: LA SVOLTA AL FEMMINILE DELLA PUBBLICITÀ.
Quando il trucco tornò di moda, all'inizio del XX secolo, la sua comunicazione
pubblicitaria era interamente concentrata sulle donne. E infatti fu colpa
proprio della pubblicità se il trucco nel corso della storia si trasformò in una
pratica di genere esclusiva, creando una nuova cultura in cui solo alle donne
era concesso truccarsi. Cultura discriminatoria, che in parte va avanti anche
oggi, nella quale i maschi che indossavano il trucco venivano associati al mondo
omosessuale e di conseguenza insensatamente discriminati.
IL RILANCIO DELLE ROCK STAR. Con l'esplosione
della musica rock, il trucco maschile ha assunto un nuovo volto, basti pensare
al look di David Bowie negli anni '70 o a quello di Boy George negli anni '80,
ma anche ai membri dei Kiss. È stato infatti grazie ai glam rocker, ma anche
alle donne e alla popolazione queer, che cambiò l'opinione negativa che le
persone per strada avevano del trucco maschile. Ma il merito non fu tutto delle
rockstar: in quegli stessi anni anche truccatori uomini come Way Bandy e Scott
Barnes (celebre make-up artist ancora sulla scena) si impegnarono a spingere
molto il ritorno del trucco anche per gli uomini, impegnandosi per renderlo una
pratica "normale".
I DUEMILA TRA INCLUSIVITÀ E MARKETING. Dagli anni
2000 in poi il trucco è diventato per gli uomini uno strumento per sottolineare
l’importanza della libertà d’espressione, sfuggendo a stereotipi pericolosi di
una mascolinità tossica. Ecco perché aziende del settore moda e bellezza hanno
iniziato un processo di inclusione con il lancio di linee cosmetiche fluide o
dedicate totalmente a lui. "È il passo giusto per un futuro migliore e non solo
un'operazione di marketing da parte delle aziende. C'è voglia di accettare le
differenze che ci rendono unici, che siano legate all’orientamento sessuale o
all’identità di genere. I marchi della cosmesi conoscono bene l’importanza di
accontentare tutte le esigenze e sanno che se non lo faranno le future
generazioni li escluderanno dai loro acquisti", ci spiega Disha Daswaney,
ricercatrice di tendenze beauty presso lo studio creativo Konkrete.
Rappresentanti di questo nuovo corso del trucco sono anche i cantanti saliti sul
palco dell’ultimo festival di Sanremo. Primo fra tutti Achille Lauro, che ha
rafforzato le sue performance con look gender fluid carichi di trucco, con il
supporto di Gucci Beauty. Oppure Damiano dei Maneskin, che sullo stesso palco ha
mostrato un trucco occhi intenso firmato Yves Saint Laurent Beauté, creato con
matita, ombretto e mascara.
L'USO CONTEMPORANEO ANTI-IMPERFEZIONI. Ma il
volersi distinguere non è l’unica motivazione che porta gli uomini di oggi a
truccarsi. Star e uomini comuni lo usano anche per migliorare il proprio
aspetto, nascondere qualche ruga, camuffare un hungover o delle occhiaie troppo
evidenti. Nei più giovani spesso la spinta arriva invece dalla voglia di
minimizzare l’aspetto dell’acne. Insomma lontano dalle luci della ribalta, il
trucco diventa uno strumento per stare bene con se stessi. Ci sono voluti
migliaia di anni, ma finalmente la nostra società sembra essere pronta ad
accettare di nuovo una pratica che era comune nel 3.000 avanti Cristo: a volte
per andare avanti si deve tornare indietro.
La donna è mobile.
Gabriele Scaramuzza
su Il Quotidiano del Sud il 14 marzo 2021. Continuamente usiamo termini quali
bello e brutto per indicare ciò che approviamo, “ci piace”, o meno. Il valore
che la bellezza genericamente indica ha infiniti aspetti, vari colori; anziché
parlare di bellezza tout-court, preferirei parlare di valore estetico e di
riuscita artistica. La nostra tradizione poi ha offerto una tavolozza ampia e
duttile per dar voce alle principali sfumature della qualità estetico-artistica:
il sublime, il comico, il tragico o il grazioso, persino il brutto; perché
trascurarle? Il bello è forse l’ideale verso cui in vari modi tende la vita
estetico-artistica, ma è generico, e arduo da precisare. Ai discorsi sul Bello o
sul Brutto in genere preferisco la considerazione di singoli eventi artistici, o
di loro scorci parziali. Prendo dunque un caso stranoto, e assai discusso, cui
tuttavia bellezza o bruttezza di per sé mal si adattano: La donna è mobile.
Rigoletto dunque, terzo atto, scena nona, per la terza volta il Duca canta La
donna è mobile. Molti ostacoli si oppongono a definirla “bella”: la banalità dei
versi e della melodia, la situazione, in cui interagiscono la deformità del
protagonista, il sacco, il paesaggio angosciante, dominato da un fiume cupo; gli
echi del temporale e del delitto di poco antecedenti. Eppure la scena, che
sfocia in un finale in cui risuona, struggente, l’aria di Gilda morente, è
artisticamente riuscita, indubbiamente. La censura taccia di “ributtante
immoralità e oscena trivialità” il libretto di quest’opera. Eppure Verdi ne
rivendica l’efficacia estetico-artistica, che non coincide affatto con la loro
bellezza poetica. La donna è mobile è per solito disprezzata per la sua modestia
sul piano estetico; in un’ottica propriamente artistica per contro viene
riscattata la sua “verità” drammaturgica. Ha una sua funzione non trascurabile
nell’insieme del terzo atto di Rigoletto: dalla prima volta in cui viene cantata
in tono scanzonato e derisorio, fino al suo ricomparire, raggelante, verso il
finale. Dove Rigoletto crede che si sia compiuta la sua vendetta, e sente invece
la maledizione incombere su di sé: il canto attesta che il Duca è vivo, nel
sacco si trova la figlia morente. Rigoletto è personaggio angosciante, “beffardo
e patetico insieme”, “falsamente allegro”, “tanto malefico quanto sublime”; ma
benissimo delineato. Come sempre in Verdi, non importa che il cantante abbia una
“bella voce”: può anche “stonare”, purché sappia declamare, recitare con
espressione e verità la propria parte.
Flavio Pompetti per “il Messaggero” l'1 marzo
2021. In prima linea sul fronte di guerra sì, ma con lo chignon e un filo di
rossetto sulle labbra. Cambia il codice estetico per le soldatesse statunitensi.
Dallo scorso venerdì la rigida disciplina che imponeva alle giovani reclute di
assomigliare quanto più possibile ai loro colleghi maschi si è aperto ad
aggiornamenti più realistici, e più consoni all' identità delle donne che
prestano servizio nelle Forze armate.
ACCONCIATURE. Alla base del cambio di orientamento
c'è la massa delle donne che oggi prestano servizio. Negli anni '60 erano appena
il 2%, tutte relegate in funzioni segretariali. Oggi sono più del 15% e hanno
varcato le soglie di mansioni una volta impensabili. La parità è ancora lontana,
specie riguardo alle carriere, con le donne che da poco hanno iniziato a dare l'
assalto ai gradi più alti. Nel frattempo però il numero è abbastanza elevato da
cominciare a far sentire la propria voce e il codice che regola i criteri di
apparenza: AR670-1, è un gradino fondamentale per cominciare a marcare le
differenze. Le lamentele sono partite da dettagli funzionali: fino alla
settimana scorsa chi voleva mantenere i capelli a una lunghezza diversa da
quella richiesta per i maschi doveva arrotolarli in un toupè, o ungerli per
ridurne il volume al punto di farli scomparire dentro l' elmetto. «Era una
manovra faticosa dice la soldatessa semplice Nina Brey e poi i capelli finivano
per spingere l' elmetto fuori dal centro, e portarlo a premere contro la fonte».
Le manovre di contenimento della capigliatura erano poi due volte più punitive
per le soldatesse di colore, le quali spesso hanno capelli crespi che rigettano
il contenimento. Oltre a questo, il codice imponeva un doppio standard che
minava l' identità di tutte le donne soldato, quello tra la vita privata e
quella in divisa. Venerdì scorso le modifiche sono divenute operative. I capelli
lunghi potranno uscire dall' elmetto, purché in forma ordinata e compatta: una
treccia o una crocchia di qualsiasi lunghezza. Una colorazione leggera è anche
possibile, purché non abbia tinte troppo accese. E chi invece sceglie di radersi
la testa potrà finalmente farlo come da decenni era permesso solo ai colleghi
maschi. Misure minime, ma che fanno un' enorme differenza per chi è chiamato a
osservarle. Il concetto fondamentale è che la personalità femminile comincia a
emergere nell' omologazione monocromatica delle forze armate e insieme ad essa
il riconoscimento ufficiale della presenza dell' altra metà del cielo in
baracca. Infine si tratta soltanto di agevolare un maggiore comfort per chi
serve la patria da soldatessa e di aiutare ognuno a sviluppare il massimo
potenziale possibile.
MAGLIETTE PER LE MAMME. Il codice non si ferma a
liberalizzare le norme sull' acconciatura dei capelli. Per la prima volta l' uso
del rossetto viene ammesso, anche per chi è assegnata a funzioni operative.
Anche per le labbra è richiesta moderazione: tinte soffuse e colorazioni
limitate ai mezzi toni. La misura ha permesso di chiarire che anche i maschi
possono coprire le labbra con gel isolante, necessario quando si è esposti alla
possibile contaminazione di agenti chimici. L' ultima novità riguarda le donne
soldato che sono giovani madri. A loro saranno distribuite magliette con tasche
che coprono il seno, e che possono essere aperte senza bisogno di rimuovere la
tuta, per permettere di allattare i propri bambini nei luoghi nei quali sono
autorizzate a farlo. Le modifiche si fermano qui per il momento, ma le indagini
interne in cerca di suggerimenti hanno fatto emergere una parallela esigenza dei
soldati maschi per una revisione dell' AR670-1. Presto si tornerà a discutere di
barbe, finora proibite nei ranghi inferiori, a differenza dei baffi che sono già
consentiti.
BOTOX. I 40 ANNI DEL RITOCCO ANTIETÀ.
Maria Teresa Veneziani per il "Corriere della Sera" il 24 febbraio 2021.
«Probabilmente è l' intervento di chirurgia estetica più effettuato al mondo».
Il botox compie 40 anni e non è mai stato così giovane. Tra gli adepti oggi
conta un numero significativo di uomini (il 20%) e di giovani, 30enni e anche
20enni. «In questi 40 anni si è abbassata notevolmente l' età delle persone che
vi ricorrono. Un tempo ci si arrivava in età avanzata, oggi viene usato per
frenare la comparsa delle prime zampe di gallina attorno agli occhi e i segni di
espressione sulla fronte. Da trattamento curativo a preventivo. Il botulino è
diventato un' arma della medicina estetica», dice Francesco D' Andrea,
presidente della Sicpre, Società italiana di chirurgia plastica
ricostruttiva-rigenerativa ed estetica (riconosciuta dal ministero della
Salute). «Prova ne è che dal suo avvento come presidio anti-aging, gli
interventi di chirurgia estetica per ringiovanire il terzo superiore - la parte
alta del volto che va dall' attaccatura dei capelli all' inizio degli zigomi -
sono diminuiti del 70%». Tutti dicono che non lo fanno e invece tutti vi
ricorrono, assicura Renato Calabria che opera tra Beverly Hills, Milano e Dubai.
Oggi più di sempre. C' è stato un cambiamento fondamentale nel modo in cui
osserviamo il nostro volto. Il lavoro a distanza ha significato ore a guardarci
e mostrarci durante le videochiamate. Il fatto di vedersi proiettati nei piccoli
schermi crea nuove fissazioni riguardo alle nostre facce. «E con l' uso delle
mascherine, lo sguardo si fissa proprio lì, su quelle rughe nella fronte e su
quel ventaglio intorno agli occhi». Nuove ansie che hanno fatto crescere il
numero degli appuntamenti dai medici estetici di oltre il 20%. La richiesta per
lo più è quella di avere un aspetto più rilassato e fresco. Poi ci sono le
giovani che vogliono aprire lo sguardo, alzare il sopracciglio ad «ala di
gabbiano», inseguendo i volti spianati e scolpiti da lipofilling di Kim
Kardashian e Kylie Jenner . Secondo l' American Society of Plastic Surgeons le
procedure per la tossina botulinica sono aumentate del 28% tra 2010 e 2019,
proprio tra i 20 e 29 anni. Grazie alle evidenze scientifiche che ne
dimostravano l' innocuità per l' uso estetico, il botox ha superato lo
scetticismo che lo accolse. «Deriva da una tossina, il batterio clostridium
botulinum , ma viene altamente processata e purificata - continua Calabria -. È
pericoloso affidarsi a chirurghi plastici che non conoscono l' anatomia del
viso». Sono state le star di Hollywood a denunciare l' effetto di un abuso. Con
casi eclatanti di volti pietrificati come quello di Nicole Kidman, che ha
cercato di sdrammatizzare: «Ho smesso di usarlo e finalmente posso di nuovo
muovere la mia fronte!». Tra pentiti e non, sono tanti i personaggi che vengono
chiamati in causa per il volto troppo liscio, da Melania Trump a Madonna, da
Gwyneth Paltrow - «è come se qualcuno ti schiaffeggiasse la faccia con un
elastico di gomma» - a Brooke Shields: «Il segreto è la giusta misura». «Le
richieste aumentano prima degli Oscar, anche se a volte i pazienti sono cauti:
dipende dal ruolo che devono interpretare», sottolinea Calabria che divide la
storia della cosmesi in due ere «BB, before botox e Ab after botox ». C' è anche
una novità nelle applicazioni. La casa produttrice dice di operare solo sui
cosiddetti muscoli della meraviglia, ma si inizia a utilizzarlo sul «codice a
barre» (le rughe verticali attorno alle labbra), per far risalire gli angoli
della bocca o sulle rughe orizzontali del collo.
Maria Teresa Veneziani per il "Corriere della
Sera" il 24 febbraio 2021. «Il botox? L' ho utilizzato una sola volta agli
inizi, negli Anni 90. Ricordo il risultato abbastanza orribile, improvvisamente
ti vedi con quella faccia arcigna, da strega di Biancaneve». Alba Parietti è un
po' stanca di essere chiamata ancora in causa sul tema della chirurgia: «Ho
fatto l' errore di dire la verità e cioè che avevo ritoccato il seno e la bocca
con il silicone. Se tornassi indietro la bocca non la rifarei, ma ho imparato a
conviverci e ora fa parte di me».
Torniamo al botox.
«Oggi viene usato in maniera selettiva e si può
calibrare per migliorare piccoli difetti. La chirurgia estetica va dosata,
scegliendo con attenzione i professionisti a cui rivolgersi. Internet ti
permette di evitare cialtroni che approfittano della fragilità di donne che
invece di curare anima e psiche si buttano sull' estetica».
Però...
«Piuttosto il lifting... Per il momento
temporeggio. Sono quasi arrivata all' alba dei 59 e a ogni 21 dicembre - quando
non lavoro - lo fisso e poi lo annullo. Mi dico "Posso aspettare ancora"».
Come contrasta l'età?
«Geneticamente sono fortunatissima. Utilizzo il
fotoringiovanimento per mantenere la pelle elastica e il laser per togliere le
macchie da mani e decolleté. Prima facevo punturine di collagene ogni sei mesi,
ora di acido ialuronico. Ho grande ammirazione per chi si accetta ma anche per
chi tiene al suo aspetto. Ognuno è libero di decidere come invecchiare».
Massimiliano Parente per "il Giornale" il 14
febbraio 2021. Chi tende a ingrassare, specialmente i maschi come me dopo una
certa età, si renderà conto di una cosa: all' inizio la pancia è un problema, ma
oltre una certa soglia si trasforma, cominciamo quasi a portarla con orgoglio.
Andrés Neuman, nel suo libro Anatomia sensibile (Sur, pagg. 107, euro 13), che è
un contromanuale del corpo umano squisitamente ironico e letterario, a proposito
della pancia scrive: «Contesta instancabilmente l' autorità dei pantaloni e la
censura del metro del sarto. Portare in giro la pancia giusta definisce la
nostra eleganza meglio di qualsiasi abbigliamento. Senza il suo ballonzolare non
si ha enfasi, abbraccio o mancia. Di sicuro qualcuno citerà il suo impaccio
nell' attività fisica. Si potrebbe ribattere che se una vera panza rifiuta le
velleità ginniche, è perché già si allena con il suo stesso andirivieni».
Finalmente, grazie a Neuman, ho una scusa da dire a chi mi dice che dovrei fare
attività motoria perché ho la pancia: non la faccio proprio perché ho la pancia.
Fantastico. È un salvatore di ogni consolidato inestetismo, Neuman. In un lungo
capitolo sui capelli riabilita perfino la forfora, «traccia che le teste
speculative spargono laddove hanno ragionato; quando ci fa visita un' idea, la
forfora è una festa di coriandoli». Non ci avevo mai riflettuto, ma in tutte
queste teste profumate e pettinate che vedo in televisione o su Instagram non ho
mai visto un pensiero. Ecco perché non hanno la forfora. Ah, i piedi. Chi vi
scrive è un feticista, ma ormai siamo centinaia di milioni, grazie a Internet.
Come osserva Neuman: «In epoche non molto remote, ammirarli costringeva ad ardue
imprese, e perfino a matrimoni. Oggi i social ne offrono un catalogo infinito.
Sospettiamo che siffatte piattaforme siano state
progettate espressamente per spiare, ostentare e confrontare i piedi». A
proposito, per chi non lo sapesse, non c' è solo Wikipedia, ma anche Wikifeet,
di cui io faccio uso quando voglio sapere che piedi ha quella tal attrice. Su
Wikifeet trovate i piedi di chiunque, purché famosa. (Nota per gli inesperti: il
feticismo dei piedi è riservato solo ai piedi femminili; ci sono anche feticisti
dei piedi maschili ma nessuno se li fila, perché fanno orrore. Come fanno orrore
gli uomini con i sandali, tipo l' astrofisico Carlo Rovelli). Anche sulla
schiena concordo, la schiena è terribile, perché «nessuna schiena si accontenta
del semplice guardate chi sono: preferisce l' insidioso ricordati chi sei
stato». Schiene curve, schiene dritte, schiene asimmetriche, Neuman è un
cartomante del corpo e per lui tutto ha un significato, perfino i brufoli, «una
schiena con i brufoli è segno di pignoleria nevrotica», mentre «una schiena
sudata sprigiona impegno e passione nel farsi coinvolgere» (boh, qui non saprei,
dipende se è la schiena di Rocco Siffredi o quella di un muratore). Attualissimo
l'elogio del gomito, visto che ormai con il Covid ci si saluta dandosi appunto
il gomito, declinato da Neuman molto poeticamente, perché «chi, se non il
gomito, sa essere insieme punto di appoggio e di inflessione? Chi regge l'
attesa e sopporta gli strusci, esponendo la propria corteccia per il bene del
ramo? Cantare le lodi del suo silenzio è giustizia polemica». In effetti il
gomito è bistrattatissimo, a tal punto che se qualcuno esagera nel bere gli si
rimprovera di alzare troppo il gomito, e non è mai un complimento. E poi, la
vagina. «Niente di più personale e più usurpato. La sua etimologia la riduce a
un semplice involucro: il fodero della sciabola, la guaina del membro. La
vagina, invece, è piena di se stessa. Non è l' origine del mondo, è il futuro
del mondo». Detta così sembra una frase da Murgia (scritta meglio, per carità),
però c' è della verità. Pensate al maschio che possiede una donna, così fiero di
introdurvi il proprio pene. Ma chi possiede davvero il pene, se ci pensate, è la
femmina, l' uomo non può possedersi da solo, il membro maschile è solo un'
illusione di virilità estroflessa. A proposito di pene, Neuman sconsiglia le
depilazioni tanto di moda, perché «un pene rasato guadagna in aerodinamica
quanto perde in ammortizzazione» (per non parlare delle donne depilate, ormai la
norma, i boschetti sono spariti negli anni Novanta togliendo ogni mistero alla
selva oscura, e pensare che la pubblicità contro le pellicce di Marina Ripa di
Meana, vestita solo della sua, fece furore, suscitando inebrianti turbamenti).
Chi ci aveva mai pensato, all'ammortizzazione. Tenera è la notte, in ogni caso,
non solo per Fitzgerald ma anche per i peni: «Il pene anziano ondeggia fra l'
introspezione e la retrospettiva. Sotto la fragilità racchiude un' ultima
infanzia, dove ogni carezza è una madre». Qui, personalmente, sarei ancora più
drastico, visto che ormai nel sesso si definiscono tutti binari (etero e gay) e
non binari (i fluidi), mentre io mi sento più un binario morto.
Natalia Aspesi per “il Venerdì - la Repubblica” il
21 gennaio 2021. La carmen con i tacchi nell'acqua che per misterioso ingegno
registico (Davide Livermore) sfiora il palcoscenico, fa la seduttrice ribelle
cantando Habanera, ha un corpo sinuoso dentro un meraviglioso abito rosso
perfetto per una ribelle seduttrice: è la soprano francese Marianne Crebassa,
bella tra le belle e i belli di A riveder le stelle, il 7 dicembre scaligero
voluto dal sovrintendente Meyer per il popolo di Rai 1, contentissimo del
superbo dono. Il vestito non è stato fatto a misura della diva, lo ha scelto
Giorgio Armani nelle sue collezioni, ed è lo stesso che nella pubblicità del suo
profumo Sì Fiori indossa Cate Blanchett. Taglia da modella, perché se no la
lirica non ti vuole più, non puoi essere una Traviata o una Lucia o una Mimì o
figuriamoci una Butterfly, cicciona, perché come si dice a Milano, anche
l'occhio ormai vuole la sua parte persino nella lirica, non solo in politica
(per le signore): al massimo ti concedono un Wagner, per il cui fragore le
signore taglia 52 vanno benissimo, anche se poi mi mancò il cuore quando vidi un
pur muscoloso tenore non farcela a sollevare una dormiente e immensa Walchiria
luccicante di armature. Ma al grandioso spettacolo di Rai 1 tutte le cantanti
erano belle, e pure i tenori e i baritoni e i bassi, il più fascinoso Plácido
Domingo che tra pochi giorni compirà ottant'anni (qualcuno mormora un po' di
più, il che non spegne la sua seduttività ma forse le sue seduzioni chissà).
Credo che l'ultimo genio tenorile, l'indimenticabile star adorata da tutti, a
portare in scena un corpo di spazioso ingombro, sia stato Luciano Pavarotti, che
io ricordo con un certo disagio in una Aida alla Scala, dentro un saio immenso
color sabbia che lo faceva sembrare più che l'eroe che torna vincitor, la
piramide di Cheope. Ma i loggioni hanno solo orecchie e degli occhi fanno a
meno, e infatti quella sera, in platea, arrivava da lassù una specie di vibrante
affanno innamorato, perso in quella voce squisita. A proposito di una sua Aida a
Houston di qualche decennio fa, il regista Pier Luigi Pizzi, che ha lavorato
molte volte con Domingo, ne ricorda la prestanza e il fascino quale Radames,
allora quasi cinquantenne, con minigonnellino e mirabili gambe nude. Pizzi è
certo che la fisicità sia importante come la vocalità, eppure ha lavorato con
celebrità del canto di vaste proporzioni o un po' troppo in là con gli anni se
in ruoli di giovinette e giovanotti, «ma il mio impegno è sempre stato quello di
arrivare a qualunque costo, con l'aiuto del costume e del trucco se non alla
bellezza almeno alla credibilità». In una Pietra di paragone al Rossini Opera
Festival, Pizzi è persino riuscito a ottenere cantanti molto giovani e
addirittura acrobati, con salti e capriole. Il punto di svolta epocale fu quando
i cantanti capirono che il loro futuro era ormai legato al giro vita. Fu quando
apparve alla Scala una Traviata viscontiana esile come un giunco, ed era la
stessa soprano che un paio d'anni prima, il 7 dicembre 1951 sempre alla Scala,
era stata applaudita nei Vespri Siciliani come una duchessa Elena
particolarmente robusta, quasi una torre di pietra. Era Maria Callas, passata da
90 a 54 chili e quindi pronta a non essere più solo una grande diva del canto
(con indispensabile duello canoro Callas-Tebaldi), ma una star della high
society, con gli Agnelli e i Kennedy, Onassis e Pasolini, gli yacht, l'alta
moda, i grandi balli internazionali. E gli amori infelici, e la morte solitaria,
come in un'opera dove all'eroina è proibito invecchiare. Anche la giovane
americana Lisette Oropesa, che quale lamentosa Lucia avrebbe dovuto in quanto
Lammermour inangurare l'ultimo 7 dicembre scaligero, ha perso 35 chili con una
lunga dieta, molta attività fisica e corse ogni mattina anche con la tempesta.
Sabato 22 febbraio scorso, alla Scala, il pubblico si entusiasmava alla prima (e
purtroppo sola rappresentazione causa Covid) del rossiniano Turco in Italia,
direttore Diego Fasolis, regista Roberto Andò, il bel baffuto Alex Esposito in
vestaglia di rasa accecante quale irresistibile Selim e la deliziosa Rosa Feola
nel ruolo della capricciosa ma onesta Donna Fiorilla: con un abito Regency (tipo
Bridgerton o, per i più esigenti, tipo Guerra e Pace) di velo arancione, una
figurina gentile e scattante da adolescente. Finalmente dice Andò «c'è una
generazione di cantanti-attori che cantano benissimo e interpretano con
sfumature i loro ruoli. Non è questione di bellezza ma di plausibilità. Anche se
a volte la bellezza non guasta». Eppure in passato hanno folgorato i melomani
soprattutto signore indifferenti alla loro ampiezza, come Montserrat Caballé che
ha fatto della sua ciccionaggine un elemento caratteristico del suo carisma e
della sua irresistibile simpatia. E Jessye Norman, uno dei grandi soprani neri
del Novecento che ha usato il suo corpo gigantesco come metafora della sua
maestà canora. Nel 1989, avvolta in un immenso tricolore cantando la
Marseillaise per il bicentenario della rivoluzione francese, pareva un monumento
simile all'Arco di Trionfo. Alla vigilia di Natale su YouTube è risorta dalle
polveri del tempo una Ave Maria che fa parte di un film americano del 1951, Il
grande Caruso, dedicato al tenore napoletano (1873-1921) considerato il più
bravo e il più pagato di sempre, anche se per nulla avvenente, che nel film è
interpretato da un famosissimo americano figlio di emigrati (babbo da Filignano
in Molise, mamma da Tocco di Casauria in Abruzzo): Mario Lanza, alias Alfred
Arnold Cocozza, di gran bellezza meridionale, forse l'unico caso di un grande
tenore che impegnato con il cinema (tipo Arrivederci Roma con Rascel e Marisa
Allasio), riuscì a salire su un agognato palcoscenico d'opera solo un paio di
volte, compreso un Rigoletto alla Scala. Attorno a quella Ave Maria di Schubert
con Mario Lanza che canta in mezzo a una folla di chierichetti si sta
attualmente discutendo tanto per allontanarsi dal frastornante io mi vaccino no
tu no, se il piccino che canta meravigliosamente con voce bianchissima sia come
è probabile tale Michael Collins però con la voce del soprano Jaqueline Allen.
Oppure Pavarotti bambino il che appare più problematico a meno che il nostro Big
Luciano, allora 16enne, fosse nano.
·
Il
trucco.
Barbara Costa per Dagospia il 21 novembre 2021.
“Truccarsi è una cosa da femmine, eh, una volta i maschi mica si truccavano!”.
Basta, che noia simili sentenze, non se ne può più, è ora di resettare il
cervello, almeno fate tinta e messa in piega a quella barba maltrattata, e
passate un po’ di correttore su quelle maschie occhiaie! Fidatevi, ci
guadagnate: che vi costa? Da tempo il make up non conosce più sesso, non si
identifica più in un solo sesso, e un sesso specifico se c’è lo individua tale e
lo mette accanto a chi fluido si trucca, ed è. Basta farsi un giro in rete per
vedere dove sta e va il mondo, la contemporaneità, la vita come è e quale è. Non
esiste più una sola via, una sola legge, non si è giusti se si è solo in un
certo modo o il suo contrario: nel make up si è tutto ciò che si vuole essere e
la moda nessuno più la fa e nessuno più la detta se non chi sui social sta e si
fa vedere come sceglie di essere, truccarsi, vestirsi, pettinarsi, ogni giorno,
giorno dopo giorno. Il trucco si fa fluid, si fa sconfinato, e oggi i tutorial
beauty più seguiti sono postati da coloro all’anagrafe registrati maschi che, di
ciprie e gloss e mascara e ombretti, ne sanno, eccome, e di esperto uso mostrano
e insegnano. Sveglia! Il make up è social, è no gender, e i marchi i più celebri
è questi social no gender make up artist che chiamano a testimonial. Non ve lo
ricordate, che Chanel già tre anni fa lanciava la trousse per uomo con
fondotinta, matite, rossetto e smalti? E che Tom Ford l’aveva preceduta nel
2013? E che è del 2016 la prima pubblicità di un mascara le cui ciglia allungate
all’infinito erano quelle di un boy? E che ci sono make up brand come Fluide,
come Fenty di Rihanna, che rilasciano prodotti him/her, ugualmente adatti sia
per lui che per lei, sia che tu non ti senta una lei, né un lui? E lo sapete
che, secondo ricerche di mercato, i make up for men, e no gender, raggiungeranno
i 166 milioni di dollari nel 2022? Il make up da sempre è e fa cultura, e però
nel 2021 un uomo truccato non equivale più a un non etero: truccarsi non segna
più il superamento di convenzionali confini o una pansessualità rock, glam,
bowiesca. Né riguarda solo le star. Siamo oltre, siamo dove stanno i Måneskin,
la loro schiettezza fluid-sex. I Måneskin sono italiano sì, e internazionale
simbolo di una rivoluzione che è no gender ed è concreta: non è solo immagine, è
ciò che si è. E non si è contro, si è insieme. Le prese in giro estetiche non
hanno più senso in una società che contribuisci a formare come tu sei. Ha le sue
ragioni Manuel Agnelli quando attacca i Duran Duran anni '80, dicendo che
passavano più tempo dal parrucchiere che a far musica, e però anche i Duran sono
stati tassello di una libertà di essere occidentale esteticamente scoppiata coi
capelli lunghi dei Beatles e dei Rolling Stones. Quei capelli fuori norma, per
cui gli Stones quando nei '60 giravano per l’America quella profonda, fobica,
reazionaria, hanno rischiato più volte di venire pestati, e quei capelli lunghi
per cui Robert Plant viene preso a ceffoni da una vecchia alla stazione, e era
lì ad aspettare quel treno che lo avrebbe congiunto a Page e ai futuri Led
Zeppelin, e quei capelli lunghi per cui Joe Perry ha lasciato la scuola a due
mesi dalla maturità e se n’è andato in fabbrica, alla catena di montaggio,
perché la sua chioma non se la voleva accorciare su ordine del preside, cioè
dell’autorità, sono stati prodromi della strada che si percorre e fa l’oggi. Ma
senza clamore. Oggi si fa, lo fanno. Stop. O forse no. Forse il trucco e la
civetteria marchiata sulle donne, concessa alle donne in quanto tali, son stati
solo una narrazione imposta secondo usi etero-normativi. Il make up non è più
chiave di femminilità e non lo è mai stato secondo "Pretty Boys", curioso libro
di David Yi, da pochi mesi uscito: “Per secoli si è omesso di parlare delle ben
note cosmesi di re e comandanti per non farli passare come effeminati, poco
virili sicché poco potenti”, ha detto David Yi al "Guardian". È anche per questo
che l’eterosessualità è storicamente sembrata quale unico sesso regolare da
vivere. La ricerca di Yi è meticolosa, e non parte dal twin hair look degli anni
'90 stilosi fidanzati Gwyneth Paltrow e Brad Pitt, o da una 90s sex fluid già
presente nei primi profumi e vestiti unisex. Yi percorre la storia e mette in
risalto il kajal sugli occhi bistrati dei faraoni dell’Antico Egitto, nero
simbolo della loro forza, e la loro usanza di colorare le palpebre con ombretto
in malachite verde a invocazione degli dei contro le malattie. Yi ricorda di
come la cipria sul viso maschio degli aristocratici alle corti del Re Sole di
Francia e di Elisabetta I d’Inghilterra, fosse appropriato segno di élite. E
l’analisi storica del make up no gender va più indietro, e ritrova nell’uomo di
Neanderthal pirite e pietre luccicanti quali primitivi fondotinta, e nei
vichinghi beauty di grasso di capra e cenere di frassino per la cura e
morbidezza di peli di viso e corpo. Scusate ma: un uomo truccato, quel sapore e
quell’odore che un fondotinta acquista su una pelle maschia, fa bagnare solo
me?
·
Il Reggiseno.
Giusy Dente per donna.fanpage.it il 22 agosto
2021. Si diceva che il seno perfetto fosse quello della misura di una coppa di
champagne: decisamente altri tempi! I canoni estetici sono cambiati parecchio e
con essi il desiderio di adeguarsi a essi a ogni costo, in una folle corsa alla
cosiddetta perfezione. Non a caso, il ricorso alla chirurgia estetica per
ingrandire questa parte del corpo è sempre più gettonato. La mastoplastica
additiva resta uno degli interventi maggiormente richiesti dalla popolazione
femminile, come se si fosse fatta strada una sorta di ‘più grande è meglio è',
in un mondo omologato dove sembra che una taglia in più sia un punto a favore da
acquisire a ogni costo.
Non è il tuo seno a determinare il tuo valore.
L'autostima femminile ha molto a che fare col decollété: è uno degli elementi
che maggiormente influenza la confidenza col proprio corpo e il rapporto con lo
specchio. C'è chi lo vorrebbe più sodo, c'è chi lo vorrebbe meno cadente, chi lo
vorrebbe più piccolo e chi più grande, chi non sopporta che un seno sia più
grande dell'altro, chi ha dovuto dirgli addio. La mastectomia è qualcosa che
mette a dura prova, proprio perché ci si sente privati innanzitutto di una parte
di sé, ma anche di qualcosa che la società tende a identificare con la
femminilità. Si provano imbarazzo e vergogna, come se con quelle cicatrici si
diventasse donne ‘meno valide'. Ma non è così. Che sia abbia un seno solo o due
e qualunque sia la sua misura, va bene esattamente così così. Questo messaggio
stanno cercando di diffonderlo in tantissime sui social, in controtendenza alla
sovraesposizione dei seni giganti che hanno monopolizzato la rete e che sembra
siano l'unica opzione possibile per essere "giuste".
Tutte le tette sono belle tette! Il tuo seno va
bene esattamente così com'è. Per rendere ancora di più l'idea e far passare
forte e chiaro il messaggio, un'influencer tedesca ha realizzato un video virale
sui social, utilizzando dei cartelli su cui ha riportato le varie tipologie di
tette in cui è possibile riconoscere le proprie. E sono state in tante a seguire
il suo esempio e realizzare dei video di simili. Lo scopo è normalizzare il
corpo femminile e allontanare certi modelli che non fanno altro che avvelenare
il rapporto con se stessi. Scorrendo i social ci si può sentire inadeguati, non
all'altezza, mai abbastanza: in quel magma di apparente perfezione sembra che
ogni normalissimo ‘difetto' che si discosta dallo stereotipo sia un errore,
qualcosa di sbagliato. Ma confrontare la propria autenticità con tutto il
fittizio che è nascosto dietro lo schermo di uno smartphone è deleterio. Vale
anche per questa parte del corpo, così sovraesposta e così oggetto di attenzioni
quasi morbose, dovute a una costante sessualizzazione. Come scrive Hannah: "Che
siano piccole, grandi, cadenti o asimmetriche: le tette sono sempre belle così
come sono! E anche i peli sul seno sono normali"!
M.Cor. per La Stampa il 17 luglio 2021. Libere dal
reggiseno: è la nuova - ma non troppo - frontiera della lotta per l'empowerment
femminile rilanciata da Gillian Anderson, star di X-Files negli Anni '90, e oggi
di "The Crown" (nel ruolo di Margaret Thatcher che le ha permesso di vincere il
Golden Globe come miglior attrice non protagonista), che su Instagram ha
condiviso il sollievo per aver detto addio al reggiseno con cui si sente
costrette. I seni poi calano fino all'ombelico? (parole sue) chissene importa:
«È fottutamente scomodo». Le sue follower approvano: «Non indosso mai un
reggiseno e ricevo molti commenti sgradevoli a riguardo, quindi sapere che
Gillian Anderson non indossa più un reggiseno è un'informazione che mi fa più
che piacere!». E il gruppo si allarga. Anche sul red carpet di Cannes molte
nemiche dell'indumento più odiato del momento. Bella Hadid, sorella di Gigi, una
maxi-collana dorata a forma di polmone, senza niente altro. Mentre Sophie
Marceau si è limitata a non indossare il reggiseno. Tra le star arruolate nella
lotta Camélia Jordana, Lætitia Casta e Lou Doillon. Radici lontane Ma la
battaglia anti-bra ha radici lontane. Ricordate i falò (simbolici) dei reggiseni
nel '68? Un simbolo della costrizione del corpo femminile ma anche della sua
ipersessualizzazione dato alle fiamme per distruggere le regole estetiche
dettate dal patriarcato. Qualcuna dirà: «vabbè adesso non esageriamo». Il
reggiseno è anche un indumento per contenere, per «stare più comode nel proprio
corpo», soprattutto quando non si ha una prima ma una quinta taglia coppa D.
Vero. Il problema però è un altro ed è il rifiuto di canoni estetici imposti da
una società impostata su vecchi codici maschili e maschilisti. E quindi il
reggiseno si è trasformato in un'arma di seduzione di massa, con «scomodi
ferretti atti ad alzare quel che cade e a imbottiture per fare credere che li
sotto "chissà cosa trovo"». Insomma, il corpo della donna come un pacco regalo a
sorpresa. Tutto a vantaggio di «lui» non certo di noi a cui bastano dei
reggiseni basici senza cuciture e contentivi come quelli per andare in palestra
(che sono gli unici le cui vendite sono continuate a crescere in questo
periodo). E dire che nel XX secolo il reggiseno (nato nel 1914) rappresentò una
rivoluzione per le donne che finalmente si liberavano dal corsetto. Il diritto a
decidere Ma oggi il ragionamento è più largo e, come dicevamo, comprende il
diritto a decidere come mostrarsi delle donne. Tra le «pasionarie» di questa
battaglia tra le prime ci sono state le coreane. «È assurdo che nel 2020
dobbiamo ancora spiegare che è nostro diritto non indossare un reggiseno in
pubblico», dichiarò l'anno scorso ad ABS News Jiann Woo, regista e co-fondatrice
di un gruppo femminista di Seoul, dopo che una presentatrice tv, perfettamente
vestita, ma senza reggiseno sotto la camicetta, era stata travolta dalle
critiche. Da allora molte donne e molte star rifiutano il reggiseno contestando
la tradizione. Il trend #freefrombra è sempre più forte tra le millennial e, le
più giovani della Gen-Z. Così un oggetto «quotidiano» e «intimo» si candida a
diventare l'arma letale nella battaglia per cambiare una società che si nutre di
stereotipi femminili per frenare il cammino verso la parità. Indecenti? No,
libere.
L'ANNIVERSARIO DEL
REGGISENO: L’IDEA DI VENERE PER LE POPPE DI GIUNONE.
Un nastro rosa, spilli, ago, filo e due fazzoletti: da qui inizia la storia del
rivoluzionario accessorio di biancheria: Dalla leggenda di un regalo nell'Olimpo
al primo capo creato da Caresse Crosby. Mita Borgogno su Il Quotidiano del Sud
il 7 febbraio 2121. Con il reggiseno, o reggipetto, come diceva la nonna, ci
andavo anche a dormire. Non concepivo una vita “senza”. Ora lo sento come una
tortura, uno strumento che imbriglia: carne, ghiandole, grasso e pensieri. Da
quando sono diventata una tettona doc sentire ballonzolare quell’ammasso roseo
ad ogni passo o movimento mi provocava enorme disturbo e imbarazzo. Adesso,
invece, lo vivo come il trionfo del bene sul male. Mi sento come Gollum con
l’anello, Arya Stark e Ago. Potente, padrona di me stessa e del mio corpo.
Almeno finché sto in casa o vado a buttare la spazzatura sotto casa o, santa
zona gialla, mi allungo al solito bar a prendere il classico cappuccino e
cornetto. Quando esco e vado oltre la mia comfort zone, fuori nel mondo, ancora
sono vittima delle convenzioni, dello sguardo degli altri esseri viventi, del
potere del ferretto, quindi spezzo il cerchio magico della mia ribellione e lo
indosso, aspettando solo di rientrare in casa e poterlo togliere. «La fine della
presidenza di suo marito è stata l’equivalente di togliersi il reggiseno dopo
una lunga giornata, in termini di completa libertà o è ancora soggetta a certe
restrizioni?», chiese la comica Gina Yashere a Michelle Obama nel corso di una
intervista a più voci sul Guardian, nel 2018. «Ah! Adoro questa domanda» rispose
Michelle. Giusto per capire quanto fastidioso sia tornato a essere considerato
l’oggetto reggipetto dopo la rivalutazione del post femminismo, superato il
“tremate tremate le streghe son tornate” quando con fierezza lo si bruciava
nelle pubbliche piazze. Sempre sul Guardian, a fine luglio del 2020, Emine
Saner, scriveva un lungo articolo in morte del reggiseno: “durerà la grande
liberazione dalla lingerie dopo il lockdown?”. Centosette anni dopo il brevetto
del primo reggiseno dell’epoca moderna, 12 febbraio 1914, il tema è quindi
ancora aperto. Anzi in pieno rilancio, soprattutto dopo le poppe in bella mostra
su serie di grande successo come Bridgerton e The Great, che sono tutte un
mostrare quelle adorabili “montagnole” che “imitano la guancia” e sono lì,
pronte per sbucare fuori. L’argomento ha fatto talmente tanta presa che
l’autorevole rivista Smithsonian, in duemila battute ha deciso di affrontare
l’argomento: “le poppe al vento di Lady Featherington sono vere o no?”. «I
corsetti e le stecche del periodo della Reggenza erano progettati meno, per
creare la scollatura che il pubblico moderno trova attraente, e più per
sollevare e separare i seni come “due globi rotondi”», afferma perentoria la
storica dell’abbigliamento Hilary Davidson, chiudendo l’argomento corsetti. «I
seni, ci è stato detto per secoli – scrive Emine Saner – devono essere vivaci e
pieni (e i capezzoli non devono essere visibili). L’atto di abbandonare il
reggiseno ha sempre avuto inevitabili connotazioni politiche – come,
noiosamente, ogni scelta personale che una donna tende a fare – al di là della
preoccupazione per le cinghie che scavano dentro e dei ferretti che spuntano
fuori. E il lockdown ha accelerato, piuttosto che creato, una tendenza crescente
verso la liberazione dal reggiseno». Sarà poi vero? I temibili ferretti, solleva
e strizza, tutti un pizzo e un ammiccamento, sono davvero arrivati al capolinea,
preferiti a più comodi oggetti in rude cotone a fiorellini e spallina larga? Non
ne sono affatto certa. In fondo, per dirla alla Kundera, il reggiseno deve
sostenere qualcosa che per colpa di un calcolo errato della natura è più pesante
del dovuto, e perciò ha bisogno di un’armatura supplementare, un po’ come il
balcone di un edificio costruito con imperizia, che si deve puntellare con
pilastri e sostegni perché non crolli. Forse, ripensandoci, potrei tornare al
cestus, un corpetto di cuoio morbido che, secondo la leggenda, fu inventato da
Venere per la prosperosa Giunone. Come prosperosa era Mary Phelps Jacob. Il 12
febbraio del 1914, Mary Phelps Jacob, ventenne ereditiera americana, pronipote
del celebre Robert Fulton, richiese alla United States Patent and Trademark
Office, l’Ufficio Brevetti di New York, il riconoscimento di una sua curiosa
invenzione, ricevendone il 3 novembre successivo il relativo attestato dal
numero 1,115,674, per il “reggiseno senza dorso”. La relazione tecnica del
brevetto recitava: “È tra gli scopi di questa invenzione fornire un indumento
che offra, combinate fra loro, alquante caratteristiche nuove e utili, tra cui
tra l’essere privo della parte posteriore, utilizzabile perciò senza preclusione
con gli abiti molto scollati. È inoltre talmente valido da tornare utile a donne
impegnate in violenti esercizi fisici, o sport come il tennis, senza ostacolare
alcun movimento”. In piena seconda guerra mondiale in effetti il tennis era da
considerarsi un violento esercizio fisico o sport estremo, Il giardino dei Finzi
Contini, insegnano. Un nastro rosa, spilli, ago, filo e due fazzoletti inizia
tutto da qui. Siamo nel 1912, a New York, Mary Phelps Jacob, è giovane e
benestante, ha discendenze nobili e deve partecipare all’ennesimo ballo che la
società impone e che una socialite come lei non può disertare. L’abito che vuole
indossare ha una profonda scollatura ed un tessuto leggero. All’epoca il solo
capo intimo accettabile era un corsetto fatto da stecche di balena. Mary, che
era una tettona, con raccapriccio si accorge che le stecche di balena si vedono
dalla scollatura del vestito e intuiscono da sotto il diafano tessuto. Giammai
le passò in mente di cambiare mise, per cui chiamò la cameriera personale si
fece portare un nastro rosa, spilli, ago, filo, due fazzoletti e creò il suo
reggiseno. Riscosse talmente tanto successo tra le amiche, che le chiesero come
facesse a muoversi tanto liberamente, che capì che dalla cosa poteva nascerne un
affare. Nel frangente Mary, conosciuta come Polly, per distinguerla dalla madre
che aveva lo stesso nome, aveva sposato Richard Peabody e con i fondi del marito
fondò una società, che non funzionò un granché però. Il secondo marito Harry
Crosby, che l’avrebbe spinta qualche anno più tardi a cambiare il suo nome in
Caresse Crosby, la convinse a vendere il brevetto alla Warner Brothers Corset
Company per 1.500 dollari (cifra equivalente a circa 21.000 dollari). Da lì poi
la storia diventa contemporanea. Per amore di precisione bisogna dire che,
precedentemente a Mary Phelps, più di qualcuno aveva già avuto l’idea di creare
un reggiseno, e che altri uffici brevetti di altri paesi avevano rilasciato il
brevetto per una invenzione simile nel 1860. C’è a dirsi anche che il termine
reggiseno fu utilizzato per la prima volta da Vogue nel 1907 e la francese
Madame Hermione Cadolle, durante l’Esposizione Universale di Parigi del 1889
presentò un corsetto tagliato a metà chiamato “soutien-gorge”, cioè
“corsetto-seno”. Nel 2008, poi, durante dei lavori di restauro condotti nel
castello di Lengberg – si legge niente di meno che sul sito della Difesa – nel
Tirolo orientale, diretti da Harald Stadler, dell’Istituto di Archeologia
dell’Università di Innsbruck, in una intercapedine fu trovato un ammasso di
stracci e di rifiuti, per lo più pezzi di legno, vecchie scarpe e indumenti, per
un totale di 2.700 pezzi. Tra gli stracci affiorarono 4 reggiseni, di
modernissimo taglio e un perizoma con due lacci laterali, simile agli odierni
bikini. Che non si trattasse di rifiuti recente fu presto confermato da cinque
analisi al carbonio 14, eseguite nel Politecnico Federale di Zurigo. Nessun
dubbio i reggiseni e il perizoma risalivano al XV secolo, per l’esattezza al
periodo compreso tra il 1440 ed il 1480. Ma la storia dei fazzoletti, dei balli,
della New York del 1910 unite alla figura di Polly Peabody, Polly Crosby,
Caresse Crosby, che nel tempo divenne editrice e scrittrice erotica, “madrina
della generazione perduta di scrittori emigrati a Parigi”, resta la più
sognante, incoronandola ancora oggi come l’inventrice del reggiseno.
·
Il
Bikini.
Da "wegirls.it" il 13 febbraio 2021. Di mode
bizzarre ne abbiamo viste tante, soprattutto in estate, ma quella del bikini
upside down piace molto. In realtà il “trucchetto” di allacciare il bikini sul
seno non è di certo stato inventato oggi, ma quando ad usarlo sono note modelle,
instagrammer o influencer, tutto acquisisce una portata diversa. Ne abbiamo
viste di giovani influencer utilizzare questa tattica nelle scorse estati, in
particolare dai mesi caldi del 2018. Vediamo un po’ la storia di questa moda e
quali sono i modelli di bikini adatti per fare. La prima a
lanciare ufficialmente il nuovo trend è stata la modella italiana, Valentina
Fradegrada; il suo canale Instagram è pieno di foto che mostrano questa
tendenza che consiste nell’indossare il pezzo superiore del bikini al rovescio,
incrociando e stringendo i laccetti sopra o sotto il seno piuttosto che passarli
attorno al collo. Questo permette di tirare e stringere al massimo per rivelare
al meglio la scollatura e dare l’impressione di un seno esplosivo. Non serve
comprare un nuovo costume, tutto quello di cui hai
bisogno per indossare un bikini scollato è avere un costume a triangolo con i
laccetti. In realtà non è necessario metterlo per forza al contrario,
l’importante è annodare le stringhe del bikini sul davanti per avvicinare il più
possibile i seni. Pratico e confortevole? Decisamente no! Immaginiamo di doversi
lanciare in acqua con questo outfit così “precario” per poi ritrovarsi nude in
un attimo. Senza contare la lotta che i seni dovrebbero fare contro la gravità,
visto che allacciando in questo modo il costume non ci sarebbe nessun tipo di
sostegno. Ma di certo non è questo l’obiettivo del sensuale trend, no?
Nonostante alcuni commenti negativi, la maggior parte dei follower sono rimasti
talmente colpiti dalla tendenza dell’estate, da indurre Valentina lanciare una
nuova pagina Instagram, chiamata @Upsidedownbikini_official, proprio per
mostrare questo nuovo stile.
·
Le
Strafatte.
Carla Massi per “Il Messaggero” il 6 giugno 2021.
Alla fine degli anni Sessanta è stata la star svedese dei film Caccia alla volpe
e Il magnifico Bobo con Peter Sellers, allora suo marito. Poi la straordinaria
protagonista de I cannibali di Liliana Cavani e la bond girl in 007 L'uomo dalla
pistola d'oro in coppia con Roger Moore. Una vita da bella, bionda e formosa
quella di Britt Ekland che a ottobre compirà 79 anni. E ora, guardandosi allo
specchio, ha deciso di fare pubblica autocritica. Si confessa ad una rivista
inglese Magazin platinun: «Non mi farei mai più manipolare il mio viso. Sono
venti anni che inietto sostanze per cancellare tutti i filler che ho voluto
durante la mia vita. Ho pagato migliaia di iniezioni per riparare i danni e non
sono riuscita a sciogliere tutto quello che ancora si vede. Tutto questo ha
rovinato la mia esistenza e la mia carriera». Dice di parlare a chi «non sa
fermarsi e poi si pente». Punta il dito, sottolineando con schiettezza che si
riferisce ad esempi da non seguire, verso Donatella Versace, Madonna e Nicole
Kidman. Paragonandola ad una bambola dipinta. Eppure, nel 2020 Il New York Times
l’ha classificata quinta nella sua lista dei più grandi attori del XXI secolo.
«Il mio aspetto è distrutto - insiste Britt Ekland -. Oltre una ventina di anni
fa un grande luminare di Parigi mi convinse a spianare le rughe e rimodellare il
viso con il collagene bovino. Esiti disastrosi. Sono stata costretta a
sottopormi per molto tempo a infiltrazioni di cortisone molto dolorose. E il
risultato non è certo dei migliori». Le sue foto di oggi rimandano un ritratto
nel quale convivono, in modo poco felice, le pieghe di una signora nata nel
1942, i tentativi di sciogliere le sostanze anti-invecchiamento e i gonfiori che
emergono tra labbra e fronte. L'immagine, poco naturale e molto artefatta, deve
aver fatto decidere l'ex moglie, oltre che di Pert Sellers anche di Rod Stewart,
di parlare a voce alta. E fare una denuncia mettendoci, appunto, la faccia.
Un'esternazione ampia, fatta di rimpianti, autocritica, confessioni (ha anche
detto «mi sono sempre tinta i capelli perché il grigio fuori è il grigio
dentro»...) messe all'indice di alcune colleghe. Ma, sorpresa, anche del
riconoscimento ufficiale nei confronti di una quasi coetanea: l'inglese Helen
Mirren, 76. «Un esempio da seguire» commenta la Ekland. Che abbia visto il
divino video-tormentone La Vacinada girato con Checco Zalone nel Salento
Fazzolettone nero in testa abito che scopre la spalla, un tocco di rosso,
leggerezza. Britt Ekland arriva non ultima tra le pentite del ritocchino. Prima
di lei, anche molto hanno parlato Cameron Diaz («I trattamenti hanno cambiato il
mio viso in modo strano»); Gwyneth Paltrow, ormai così attenta ad uno stile di
vita sano e all'insegna della naturalezza durante un'intervista ad Harper's
Bazaar, ha esclamato riguardo i suoi passati ritocchini: «Proverei di tutto, ma
non rifarei più il botox perché avevo un aspetto folle»; Kylie Jenner, la più
piccola delle sorelle Kardashian ormai una vera beauty guru («Ho iniziato troppo
presto a fare i ritocchini, a 15 anni la bocca. Un ragazzo mi disse che avevo le
labbra troppo piccole e, per questo, non sarei mai stata una brava baciatrice»).
DAGONEWS il 26 gennaio 2021. Ci sono delle star
che sembrano aver frizzato la loro bellezza. Fronte senza rughe, niente zampe di
gallina e una pelle straordinariamente liscia. Ma quanto è merito del chirurgo e
quante si nascondono dietro qualche crema miracolosa? Quante devono ringraziare
i loro geni e quante dicono balle?
Jennifer Lopez. Quando una fan ha recentemente
scritto sui social, affermando che il suo aspetto giovanile era merito del
botox, JLo si è ribellata: «Per la 500 milionesima volta… Non ho mai fatto il
Botox o qualsiasi iniezione o intervento chirurgico!». Dopo ha descritto la sua
routine di bellezza. Sarà vero che basta qualche crema?
L'attrice Nicole Kidman, 53 anni, è fotografata a
sinistra nel 2007 e a destra nel gennaio 2020. Il suo segreto è essersi tenuta
lontana dal sole, ma non nega di aver provato le punturine. Nel 2013 ha
raccontato: «Ho provato il Botox, purtroppo, ma ne sono uscita subito e adesso
posso finalmente muovere di nuovo la faccia. Nessun intervento chirurgico per
me. Metto la protezione solare».
La star di Friends Jennifer Aniston, 51 anni,
fotografata a sinistra nel 2010 e adesso. Ha lasciato intendere che avrebbe
potuto divertirsi con il Botox, ma preferisce usare altri trattamenti. Nel 2017
ha detto: «Non sto dicendo che non l'ho provato. Tutta quella roba cosmetica mi
sembra ridicola!». Jen si sottopone a trattamenti laser e Ultherapy che stimola
il collagene.
L'attrice Courteney Cox, 56 anni, nel 2010 a
sinistra e adesso. Per un breve periodo era nota per l'uso di riempitivi, ma nel
2016 ha rivelato di averli sciolti e di non aver più fatto nulla al viso: «Stavo
cercando di tenere il passo con il tempo e ha peggiorato le cose. Ora sono il
più naturale possibile».
Kylie Minogue, 52 anni, è un'altra star che
ammette di aver "provato ma non le è piaciuto". Nel 2009 ha detto che aveva
"sperimentato" il Botox, ma l'anno successivo ha detto: «Il Botox mi ha dato un
brutto colpo. Ho smesso di usarlo qualche tempo fa. Ho le rughe sul viso adesso
e va bene».
L'ex First Lady Melania Trump, 50 anni, a sinistra
nel 2010 e adesso. È famosa per i suoi lineamenti congelati nel tempo e lo
sguardo d'acciaio. La sua fronte è liscia e non ha linee pronunciate tra il naso
e la bocca. Nel 2016 ha detto: «Sono contro le iniezioni; Penso che danneggino
il viso».
L'attrice premio doppio Oscar Renee Zellweger, 51
anni, a sinistra nel 2009 e ora. Si è presa una pausa dalla recitazione per sei
anni dal 2010 per sottoporsi a una terapia per la depressione. Quando è tornata,
sembrava decisamente diversa. Ha negato di aver fatto il Botox, ma il viso
raccontava altro: «Sono contenta che la gente pensi che io abbia un aspetto
diverso. Sto vivendo una vita felice e più appagante e sono entusiasta che forse
si manifesti. Forse sembro diverso».
La top model Elle Macpherson, 56 anni, a sinistra
nel 2010 e adesso. Ha raccontato nel 2019 di essersi dilettata con Botox, ma è
andata oltre: «Ho imparato che un bel sorriso, bei denti, bei capelli, buona
pelle, buon umore valgono mille punturine di Botox, trattamenti per il viso e
maschere».
Lo scorso aprile, l'attrice britannica Kate
Beckinsale, 47 anni, ha scritto su Instagram: «Non faccio il Botox» rispondendo
a una fan che la invitava a smetterla con le punturine.
·
Parliamo del Culo.
Barbara Costa per Dagospia il
12 giugno 2021. Cerchi una femmina esagerata? Per 23 euro ne trovi 25, di
femmine, e che femmine, tette e curve e bocche e labbra e c*li e specie c*li,
tanti c*li, 25 appunto, tutti insieme, nello stesso posto. Te li mette davanti
"Elegant Angel". Belli, grossi, natiche enormi, ma pure piccole, ben tornite,
con un filo di cellulite o senza. Sono 25, i sederi più sexy di sempre, scelti
da Elegant Angel, casa di produzione porno tra le più longeve e attive. 31 anni
di pornografia senza freni, 31 anni di c*li i più rotondi, i più pronti ad
accoglierlo dentro, uno, ma meglio due, e a riempirsi di creampie. "25 Sexiest
Asses Ever! Vol.3" è appena uscito, con la cover colma del bel panettone di
Nikki Delano. Ma tra gli altri sederi che questa compilation presenta ci sono
pronti da leccare quelli di Abella Danger e Angela White, Kissa Sins e Jada
Stevens, Alexis Texas e Olivia Austin, e molti, molti altri. 25 Sexiest Asses
Ever! Vol. 3 è un riepilogo che Elegant Angel offre agli amanti del porno
affinché si scaldino all’arrivo di nuovi lavori che i vaccini anti Covid
finalmente permettono di girare. Il porno riparte, presto a pieno regime, e
Elegant Angel già immette sul mercato "Milf Performers of the Year 2021", in
quanto, Covid o non Covid, la voglia di corpi milf non scema. Segmento della
prestigiosa serie "Performers of the Years" (che Elegant Angel fa uscire ogni
anno a fine anno) nella versione milf le porno danze le apre Cherie DeVille che,
con Silvia Saige, si esibisce in un lesbian, e guarda come (se la) godono! Qui
non tutto è lesbian, tutto è però facial: Milf Performers of the Year inzuppa i
corpi di Lexi Luna, London River e McKenzie Lee e, se per Lexi Luna c’è un duro
e potente anale, e sperma dentro, davanti, e dietro, per tutte ci sono facial
inondanti, goccianti, e che tutte ricevono ingorde, affamate. In uscita, sempre
per Elegant Angel, "Club Elite 5", con Lana Violet, Liv Revamped e lei, lei,
Kayla Kayden, lei che ce lo aveva promesso, che quest’anno avrebbe oltrepassato
ogni porno limite. Qui Kayla ottiene quel che vuole, ottiene tutto l’anale che
cerca e pretende, e… guarda un po’, cosa c’è scritto in evidenza sulla cover:
questo porno è "interracial edition"! Allegri, si respira, credo proprio che
negli USA abbiano finito, di gridare isterici al razzismo per ogni dove. Vi
ricordate delle lagne e delle proteste, rivendicazioni che hanno colpito anche
il porno, per il suo uso del termine "interracial" a titolo di una categoria che
denomina il porno tra corpi bianchi e neri, e tra corpi bianchi e asiatici, e
tra bianchi e sudamericani? La verità è che la voce interracial – e la sua sigla
IR – mai sono stati cancellati dal porno: cavolo, il porno interracial è tra i
più apprezzati, è tra i più visti e quindi girati. Fine di pretestuose e vacue
polemiche, e fine credo per davvero, se è vero che proprio Elegant Angel fa
uscire "Black All Stars 3", porno di 4 ore, e porno pure qui di tanti c*li, di
voraci femmine black, femmine virago, e la cover è piena del c*lone di Cherookee
D’ass, star nera e c*lona (pure nel cognome…). Se tra le novità in uscita a
firma Elegant Angel troviamo "It’s a Mommy Thing 11", capitanato dalla bionda
milf Rachael Cavalli, con le performance della mora milf Crystal Taylor (a lei,
tenetela d’occhio, riservatele attenzioni speciali, la signora ha un corpo
snodato, elastico, capace di sc*pare e farsi sc*pare nelle posizioni più
acrobatiche, i suoi sono porno show), e pure il corale "Starlets 2021", con le
ragazze le più nuove e più spinte e più pronte a pornarle di tutti i generi
(ovviamente capitanate dal bocconcino Scarlit Scandal, best new starlet '21, ma
qui con lei son da lodare le "piccole" Laney Grey e Payton Preslee, e Lily
Larimar che con Scarlit fa IR), dopo un anno dalla sua uscita vende ancora "Milf
Bombshells", porno di Elegant Angel pronto a figliarsi in serie. Se sono
notevoli gli arroventati amplessi tra pornostar di prima grandezza quali Kaylani
Lei e Danny Mountain (qui una deep throat per palati esigenti), e tra Katy Jayne
e James Deen (che se la "sbatte" al muro come solo lui sa fare), questo porno
splende nella prima parte, nel trio Ivy Lebelle – James Deen – Markus Dupree. Li
comanda lei, Ivy Lebelle, gestisce tutto lei, la doppia fellatio, la doppia
penetrazione, il sesso in cow-girl. E alla fine squirta…
Costanza Cavalli per "Libero quotidiano" il 15
aprile 2021. In casa o al lavoro, in auto e al supermercato, abbiamo tutti la
bocca sempre piena di culo. Nessuna parte del corpo è più citata, vezzeggiata,
infamata, schernita, financo travisata. Essa attraversa le epoche intatta,
centrale nei discorsi quanto nella topografia del corpo umano. Tutto ciò che è
fisiologico interagisce con il cervello, è questo il motivo per cui - il culo -
ce l' abbiamo sempre in mente, e pronunciarne il termine, pensateci, per gioia o
per stizza, è scaramantico, quasi religioso: invariabilmente induce nel
portatore del culo nominato la percezione di una invisibile liberazione o di una
inscalfibile sentenza. Una delle opere di Haris Lithos, artista che dipinge
grandi tele con forme astratte monocromatiche e dipinte con il proprio sedere Si
può dire infatti che ognuno di noi dipende molto strettamente dal buon
funzionamento del suo posteriore, almeno quanto, risalendo lungo una immaginaria
linea verticale, dall' efficienza del cuore e del cervello. Il culo è quasi un
oroscopo: può fare cominciare bene o male una giornata, e quando va in tempesta
la può rendere inutilizzabile; una sua protesta sonora può indurre imbarazzi e
un suo comando alla ritirata è senz' appello, può indifferentemente interrompere
un incontro amoroso quanto la stipula di un accordo internazionale.
MODI DI DIRE. Non è quindi strano, ma va
precisato, che nessun culo, scritto o parlato o pensato, viene dal nulla. La
parola in sé viene dal greco "kòilos", che significa vuoto, concavo (cioè l'
ano), da cui discende anche "colon". La maggior parte delle sue declinazioni
popolari ha origini di facile lettura con qualche sorpresa. Per esempio "Avere
culo", e tutte le sue forme contratte o traslate (es. "la fortuna con la C
maiuscola"). Secondo l' etologo Desmond Morris (leggete "L' uomo e i suoi
gesti") le natiche femminili sono un richiamo sessuale primordiale, e in molti
primati le loro dimensioni aumentano durante l' ovulazione: la femmina mostra il
posteriore al maschio, e più grosso è meglio è. Il linguista Ottavio Lurati ha
poi osservato che le parti del corpo collegate alla riproduzione hanno preso un
significato simbolico, sinonimo di vitalità che allontana la morte e le
disgrazie, e quindi di buona fortuna. La variante "botta di culo", invece, pare
si riferisca a una fortunosa spinta da dietro che lancia in avanti, o permette
di balzare in groppa a un destriero, da cui "essere a cavallo", quindi in
vantaggio. Pare che la fonte indiretta dell' espressione sia Virgilio, che ha
legato la figura del cavallo alle fortune di Cartagine e della sua regina
Didone, la quale costruì la città nel luogo in cui rinvenne una testa equina. La
magica relazione fra il posteriore e i favori del caso è entrato anche nella
mitologia contemporanea, grazie alla particolare religiosità di Vittorio Feltri,
che a coronamento della sua (e di molti altri) certezza che senza fortuna non si
va da nessuna parte ha istituito, extra-calendario, un santo apposito da
invocare a piacimento, SanCulo. Il culo nella modernità ha preso molte strade.
"Avere il fuoco al culo" per dire agitazione o fretta, "le pezze al culo" per
dire povertà, "la bocca a culo di gallina" per l' espressione indignata (o
perplessa) con le lebbra strette e piene di pieghine. E poi "faccia da culo"
(cioè senza vergogna), leccaculo (disposto a tutto in cambio di un vantaggio),
"farsi un culo così", che è il rovescio di "fatto con il culo"; "fare il culo" a
qualcuno, essere "culo e camicia". Ma la parte del leone è appalto dell'
onnipresente "dar via il culo", dai molteplici indirizzi, il cui più frequente è
la contrazione "vaffaculo": umiliazione doppia, perché il sedere usato come arma
verbale è anche il bersaglio e proprietà della vittima: nessuno ha mai
minacciato un altro dicendo "ti colpirò con il mio culo".
IN LETTERATURA. Nel passato il culo è stato non di
meno presentissimo: sarebbe ingiusto e anzi marcatore d' ignoranza idealizzare i
tempi andati come elegantemente carenti di quotidiane epistrofi armate sui
fondoschiena altrui. Al contrario, le grandi menti di ogni epoca non hanno avuto
timidezze nell' infarcire le loro opere di fondoschiena e di parti ad esso
accolite. E i compilatori dei manuali del liceo hanno sudato molte camicie a
costruire tratturi linguistici per non citare quelle parole: così hanno
distrutto gente come Catullo, Marziale e Giovenale, solo con Dante hanno
fallito, dato che era impossibile schivare il diavolo che «avea del cul fatto
trombetta» nel XXI Canto dell' Inferno. A proposito di Dante, il cui vocabolario
volgare camuffa spesso le invettive più truci, se il tema vi interessa potete
leggere "Le parolacce di Dante Alighieri" del filologo Federico Saguineti. Per
quanto riguarda il ripristino della verità sugli antichi, oggi che il culo è
stato sdoganato anche nelle traduzioni, dovrete sfogliare una seconda volta
molti classici, ma vi divertirete leggendo Persio, poeta vissuto sotto Nerone,
che scriveva versi difficili nella convinzione che la satira fosse la verità che
si rivela senza bisogno di qualcuno che ascolti, come un barbiere che dice
sottovoce in un buco per terra «Midas ha le orecchie da culo!». Molto più
sfrontato era Catullo («Io ve lo ficcherò su per il culo e poi in bocca /
Aurelio succhiacazzi e Furio frocia sfondata»). L' espressione "Restare con il
culo per terra" pare abbia un' origine medievale: i longobardi usavano esporre
chi veniva punito per debiti facendogli togliere i pantaloni e appoggiare le
natiche sull' erba. Rimanendo all' economia, il nostro amico culo è stato anche
variamente chiamato in causa per inoculare nel popolo pillole di saggezza. Su
uno degli scranni del coro quattrocentesco in legno decorato a bassorilievo
nella Oude Kerk, la chiesa più antica di Amsterdam, è raffigurato un uomo in
posizione evacuatoria sotto il quale è scritta la massima "i soldi non escono
dal retro". Lo scrittore spagnolo seicentesco Francisco De Quevedo si interessò
molto al culo, ne constatò la tensione verso la perfezione sferica e il suo
imperio sul resto del corpo: «Ha un solo occhio, ma è più necessario quello che
i due occhi del viso». Per non dire, facendo un passo indietro al Cinquecento,
dello scrittore francese Francois Rebelais, il cui Gargantua è uno scoppiettìo
continuo: «Affermo e sostengo, che non v' è miglior nettaculo d' un papero ben
piumato () sia per la soavità di quel suo piumetto, che per il temperato calor
naturale del papero, il quale facilmente si comunica al budello culare (),
concludendo che anche la beatitudine di eroi e semidei stia nel fatto che si
nettano sempre il culo con un papero, e tale è altresì l' opinione del nostro
maestro Duns Scoto». Ah: Duns Scoto è stato un importante filosofo scozzese del
Duecento. Inoltre, fu chiamato "Dottor Sottile" ottocento anni prima di Giuliano
Amato, il presidente del Consiglio che, come ricorderete, alle 4 del mattino del
10 luglio 1992 inflisse un prelievo forzoso del 6 per mille dai nostri conti
correnti, mettendocelo indovinate dove.
·
Mai
dire...Porno.
Corrado Zunino per “la Repubblica” il 17 Dicembre
2021. Da noi, i racconti della pornografia assunta in età da scuola media - uno
su cinque ci si avvicina in quella stagione - passano attraverso le parole e le
lacrime di Gabriella. È la madre di Giovanni, 12 anni. A Telefono Azzurro
rivela, agitata: «Ieri ho guardato la cronologia di internet dal pc che usiamo
in casa, mi è crollato il mondo addosso». Decine e decine di url di siti
pornografici. Per un istante, mamma Gabriella, pensa siano connessi al marito. È
fuori per lavoro, però. Giovanni, il figlio, ha solo dodici anni: «È davvero
possibile sia stato lui?» È un ragazzino tranquillo. «Vedo che sta spesso al
pc», dice la madre all'operatore del 19696, «e quando gli chiedo cosa sta
facendo mi risponde che gioca con gli amici. Forse avrei dovuto controllarlo di
più, ma come?» Negli ultimi mesi, ora che mamma fa mente locale, aveva notato un
cambiamento nell'atteggiamento: «Stava sempre chiuso in stanza e anche quando
scendeva per cenare aveva con sé il cellulare. Era costantemente connesso a una
realtà parallela». La signora Gabriella, l'altra mattina, era turbata: «Gli ho
subito parlato e Giovanni ha reagito con rabbia: "Hai violato il mio spazio, tu
non puoi capire". Guardando quant' era lungo quell'elenco, ho pensato a quanti
pomeriggi ci aveva trascorso sopra». Billie Eilish da Los Angeles lo ha detto al
mondo: «La pornografia è una sciagura, credo di averla frequentata dagli undici
anni. Mi ha devastato il cervello». Da noi, si passa per Telegram, con tutti i
rischi connessi alla piattaforma russa. «Mio figlio », questa è Susanna, madre
di Federico, 13 anni, «ha fatto parte di un gruppo all'interno del quale veniva
scambiato materiale pornografico e pedopornografico». Federico, vivaddio, si è
aperto con la mamma: «Ero curioso», le ha detto, «i miei amici lo facevano, sono
entrato nel gruppo e ho chiesto un video porno con persone della mia età. Mi
hanno inviato un file e io ho scaricato un filmato di un uomo con una bambina.
Ce l'ho ancora qui, sul cellulare». Federico è rimasto scalfito dalla visione,
nei giorni successivi ha faticato a dormire, ha avuto incubi. Non era finita:
«Su quella chat, mamma, ho conversato con un utente che mi ha offerto il video
di una ragazza, ma prima voleva vederne uno mio. Mi sono spaventato e mi ha
fatto schifo. Pensavo fosse una cosa normale, tutti alla mia età lo fanno, ma è
stato orribile». Luigi Cancrini, psicoanalista di lunga esperienza, dice: «Vedo
troppi adolescenti che del sesso pensano di sapere tutto e sono, invece, digiuni
nell'alfabeto delle emozioni. L'accesso precoce alla pornografia online ha
creato in questa generazione un divario enorme tra sentimento e sessualità».
Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, dice: «Troppi
colleghi pensano che la pornografia sia liberatoria, invece è un'automobile in
mano ai bambini. Vanno fatti scendere, se no si schiantano». In Italia, Pornhub
ha venti milioni di frequentatori. Il Servizio 114, Emergenza Infanzia, nel 2019
ha ricevuto 2.798 segnalazioni relative a contenuti pedopornografici (erano
state 1.087 nel 2018 e 1.250 nel 2017). Al 66 per cento dei preadolescenti e
degli adolescenti è accaduto di vedere storie inaspettate online: nel 23 per
cento dei casi erano immagini sessualmente esplicite. Già. Tra la popolazione
giovanile il 26 per cento ha conosciuto il sexting (l'invio di messaggi hard),
il 21 per cento dei dodicenni ha messo online immagini proprie senza
rifletterci. Il professor Ernesto Caffo, fondatore di Telefono Azzurro, spiega:
«I ragazzi accedono alle piattaforme senza controllo dell'età, i genitori
scoprono il problema per caso. La pornografia adolescenziale è un'emergenza di
cui si parla poco. Non lo fa la scuola e gli adulti non hanno consapevolezza dei
comportamenti dei figli». Il porno ai tempi d'oggi è ultraviolento,
necessariamente maschilista: le donne acconsentono a qualsiasi perversione
chiesta, imposta. «Abbiamo certificato gruppi di ragazzi che aggredivano una
compagna dopo aver condiviso materiale porno». Altri guadagnano token - gettoni
traducibili in soldi - «dall'esposizione del proprio corpo e delle attività
sessuali con coetanei». La pandemia, sì, ha allargato la base di piattaforme
come OnlyFans. 150 milioni che possono scambiare sesso altrove vietato. Tra i
creator italiani del sito c'è Ciro Di Maio, conduttore e attore tv arrestato il
24 agosto per aver acquistato droga dello stupro. «Dietro certi comportamenti
suicidari », è ancora Caffo, «ci sono storie che i ragazzi non riescono a
cancellare dai social». Un genitore? «Deve parlare con il figlio, limitare i
danni, aiutarlo a elaborare il sicuro senso di colpa che presto proverà».
Gianmarco Aimi per mowmag.com il 17 Dicembre 2021.
Il mondo del porno di nuovo a processo dopo che la popstar Billie Eilish ha
lanciato pesantissime accuse. La cantante 19enne ha infatti rivelato al The
Howard Stern Show – mitologica trasmissione radiofonica americana – di aver
cominciato a vedere filmati pornografici da giovanissima per “sentirsi come i
maschi”. Una esperienza che, però, l’avrebbe traumatizzata: “Da donna, penso che
il porno sia una disgrazia. Ne guardavo tantissimo, ho iniziato presto. Penso
che abbia distrutto il mio cervello e mi sento davvero devastata da questa
sovraesposizione”. Addirittura, la cantante avrebbe iniziato all’età di 11 anni.
Per questo ha aggiunto che anche la percezione dell’anatomia femminile è
completamente distorta: “Sono così arrabbiata del fatto che il porno sia così
amato e arrabbiata con me stessa quando pensavo fosse ok. Il modo in cui
appaiono le vagine è da pazzi. Nessuna vagina è fatta così. I corpi delle donne
non sono così, non usciamo in quel modo. La prima volta che ho fatto sesso non
ho detto no a cose che non facevano per me, perché pensavo di esserne attratta”.
Un dibattito che è arrivato anche in Italia, tanto che oggi su Repubblica la
scrittrice Elena Stancanelli ha ammonito: “Noi adulti abbiamo due compiti:
chiarire che la pornografia non è sesso e batterci perché accanto a quella
tradizionale, fatta di accoppiamenti violenti e maschilisti, ci sia la
possibilità di trovarne un'altra, ugualmente inverosimile, ma con uno sguardo
opposto”. Chi il porno l’ha frequentato da protagonista, benché oggi si dica
lontanissima da quell’ambiente, è Milly D’Abbraccio. Dopo aver vinto nel 1978 il
concorso Miss Teenager Italy, nel 1979 incide il 45 giri Superman Supergalattico
con il nome di Milli Mou e inizia a lavorare in televisione nelle trasmissioni
Galassia 2 di Gianni Boncompagni e Vedette con lo stesso pseudonimo. Macina
esperienze anche al cinema e in teatro con ruoli minori e partecipa alle
selezioni di Miss Italia nel 1985. È nel 1989 che passa alla carriera di attrice
pornografica accettando le offerte di Riccardo Schicchi che la fa entrare nella
sua agenzia Diva Futura. Una attività nell’hard durata fino al 2005, che l’ha
vista protagonista anche in trasmissioni cult come Colpo Grosso (1990), condotta
da Umberto Smaila. L’abbiamo contattata per chiederle un parere sui possibili
effetti negativi del porno, in particolare sui giovani, e Milly ci ha spiegato
un po’ di malavoglia perché, secondo lei, il successo di questo settore è una
questione più fisica che mentale. Oggi ha 56 anni, si dice “ormai disinteressata
al sesso perché finalmente sono in menopausa” e che per far passare la voglia
agli uomini, probabilmente, “l’unico modo è castrarli, come si fa con i
cagnolini che poi stanno buoni”. Ma quando le chiediamo conto del suo profilo su
Escort4You, dove sembrerebbe offrire ancora prestazioni a pagamento, ci saluta
senza fronzoli. Solo che è bastato chiamarla da un altro numero poco più tardi
per conoscere dettagli e tariffe per chi volesse vivere una esperienza da sogno
(e un po’ old school) con una delle pornostar simbolo degli anni ’90. Provare
per credere.
Milly, hai sentito le accuse di Billie Eilish
verso il mondo del porno?
Non mi interessano, davvero del porno non me ne
frega più un cazzo. Lo dico sinceramente. È ormai una cosa superata per me.
Ancora se ne parla?
Non solo se ne parla, ma se ne discute la
pericolosità in particolare per i giovanissimi.
Ma io non faccio più parte del mondo dell’hard e
grazie a Dio sono in menopausa. Quindi non ho più problemi di quel tipo con il
sesso.
Infatti, volevo chiederti se pensi possa causare
problemi ai fruitori del porno, soprattutto se arrivano a quei film o video
molto giovani.
Non è un argomento che mi riguarda, perché io non
ho più testosterone sufficiente per avere voglia di sesso. In menopausa non ne
hai più voglia per nulla, quindi non è più un mio problema. Il problema è il
vostro (degli uomini, ndr) che avete ancora questi impulsi.
Un po’ drastica come soluzione…
Non c’entrano la ragione o la razionalità, ma
soltanto gli ormoni. Ma io non mi pongo neanche più queste domande perché ormai
sono libera mentalmente e posso dire anche finalmente… Quando invece sei giovane
sei tempestato di ormoni e quindi portato alla ricerca continua di sesso.
Ho letto che nel 2019 stavi preparando un libro
sulla tua vita, ma non mi sembra sia uscito.
Non ho pubblicato nulla perché non mi va più di
parlare di sesso. Il libro è lì pronto ma non mi va di farlo uscire. Io sono
fuori dal giro e non voglio neanche più apparire.
Però ho notato che il tuo profilo su Escort4You è
ancora attivo, infatti è lì che ho trovato il tuo numero…
Guarda, ti devo lasciare … Ciao, ciao…
A questo punto Milly D’Abbraccio riattacca il
telefono, ma a noi è rimasto un dubbio: perché dirsi ormai lontana dal mondo
dell’hard e persino dalla voglia di fare sesso e mantenere ancora attivo un
profilo su un sito per contrattare prestazioni a pagamento?
Così, poche ore dopo e da un altro numero, ci
siamo finti un potenziale cliente e abbiamo scoperto che in realtà questa sua
attività prosegue senza sosta: “Pronto, salve, la chiamo dopo aver visto il suo
annuncio su Escort4You e volevo chiederle se fosse possibile fissare un
incontro” esordiamo. E Milly, senza tanti fronzoli, arriva dritta al punto:
“Volevi farlo da me o da te?”.
A questo punto passa immediatamente al prezzo: “Il
costo da me a Roma è di 650 euro per un’ora. Se vuoi fare un paio d’ore sono
1000 euro. Un po’ costoso, non è per tutti ma…”.
Mentre invece se fosse la stessa Milly a
raggiungerci a domicilio ci ha spiegato che il costo sale un po’: “Con le spese
di viaggio sono 750 per un’ora e per un paio d’ore magari riesco a farti 1100
euro, vediamo…”. L’importante, ci tiene a precisare, è che una parte venga
pagata in anticipo: “Mi devi mandare subito l’acconto così blocchi
l’appuntamento”.
Tutto chiaro, no? E a noi non resta che tenere a
bada gli ormoni, anche se abbiamo capito che i soldi, come in ogni questione,
hanno ancora la loro stramaledetta importanza.
Val. Arc. per “il Messaggero” il 17 Dicembre 2021.
«Educazione sessuale». Per Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista della
Società psicoanalitica italiana (Spi) e della International psychoanalytical
association (Ipa), è questo l'unico modo per evitare che la pornografia
distrugga la sessualità dei bambini e degli adolescenti. Un po' come è successo
alla cantante americana di Billie Eilish, che ha raccontato come la pornografia
gli ha distrutto il cervello.
Professoressa, i bambini e i giovani in generale
sono così attratti dal porno?
«I giovani guardano immagini e video pornografici
solo perché li hanno facilmente a disposizione. Non ci sono altri motivi. I
bambini e gli adolescenti sono curiosi, ma purtroppo non sono in grado di
decodificare correttamente i comportamenti che vedono rappresentati e così
rischiano di fare confusione».
Quali le possibile conseguenze?
«Il pericolo rappresentato da questo tipo di
esposizione sono i possibili danni psicologici ed emotivi, dal momento che si
tratta di contenuti privi di significati affettivi o relazionali e spesso
contenenti esempi sbagliati, che mostrano per esempio aggressioni, rapporti
incestuosi o violenza sulle donne. Il bambino quindi rischia di confondere tra
aggressività e violenza. La prima, alle giuste dosi, non è dannosa, è ciò che
noi chiamiamo narcisismo primario. La violenza invece è sempre un grave danno
per la mente, non solo un esempio sbagliato».
Cosa possono fare i genitori dinanzi a un pericolo
così difficile da controllare? «Innanzitutto, i genitori dovrebbero evitare che
i figli abbiano accesso al proprio telefono. Ma qualora questo accada, è
necessario essere presenti e controllare attentamente quello che fanno. In
generale è bene iniziare sin da quando sono piccoli a dare spiegazioni sulla
vita sessuale, sul fatto che è una cosa naturale e che è un'espressione di
sentimenti e amore. Al contrario, non bisogna colpevolizzare i ragazzi. Quello
di cui hanno bisogno è della giusta educazione sessuale. A questo scopo ci si
può anche affidare all'aiuto degli insegnanti a scuola, a un medico o anche ad
un analista».
Nei casi in cui il danno è già fatto, come
comportarsi?
«Se bambini e adolescenti manifestano ad esempio
una dipendenza da contenuti pornografici, attraverso problemi del sonno o crisi
d'ansia quando vengono allontanati da smartphone o pc, dobbiamo considerare
questo come espressione di un disturbo di natura depressiva o della personalità.
A questo punto il problema è più serio e ha bisogno di essere affrontato con un
professionista o uno psicoanalista dell'età evolutiva».
Barbara Costa per Dagospia il 17 Dicembre 2021.
Siamo quinti al mondo! In s*ghe! È un ottimo risultato, e non siamo nemmeno
quelli a cui pene e clitoride non "durano", cioè si ammosciano subito, perché
stiamo davanti a un video porno una media di 9 minuti e 43 secondi, durata non
male e che non può essere messa in dubbio perché è voce e parte del "Report 2021
di Pornhub", la summa della somma delle visite che tutto il mondo – tranne Cina
e Paesi dove internet è sotto controllo governativo – ha fatto su Pornhub, il
sito di porno free più grande e più visto sul pianeta Terra. Pornhub da otto
anni ogni anno pubblica il report annuale di come sul suo sito è porno andata, e
l’Italia nel 2021 è il quinto paese al mondo per quantità di visite! Meglio di
noi soltanto Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, e Francia, ma poi ci siamo noi,
noi che in questo 2021 abbiamo pure "tradito" Pornhub, e durante gli Europei di
calcio, e specie la finale. Pornhub non lo freghi, Pornhub tutto sa, tutto
monitora e mette in conto, nulla dei nostri gusti porno gli sfugge, e l’Italia
segue un trend che è mondiale: se nel mondo la pornostar più vista è per il
secondo anno consecutivo lei, Lana Rhoades, seguita per il secondo anno
consecutivo da Abella Danger, l’Italia come gli altri si scopre Paese porno
patriottico: "italian" è genere più visto e cercato, genere più amato, seguito
da "dialoghi in italiano". I pipparoli sono patriottici e sono fedeli, e
l’analisi dei porno-viaggi fatta paese per paese rivela una passione per le star
nazionali (tranne in Svezia, dov’è "duro" l’amore che gli svedesi serbano al
pornostar americano Johnny Sins). Ma, tornando all’Italia, quali sono le
pornostar più viste nel 2021? La più vista tra tutte è lei, la nostra Malena
Nazionale, Malena la Pugliese, seguita dal sorpasso che Martina Smeraldi fa su
Valentina Nappi. Al quarto posto si piazza Danika Mori (che da pornostar
italiana sezione amatorial, è settima in classifica generale, e qui onori alla
nostra Nyna Ferragni, che è in amatorial Top 20), seguita dall’uccello
indeteriorabile di Rocco Siffredi. Nel 2021, il pornostar maschio più visto è
stato lo spagnolo Jordi El Nino Polla, ma la categoria che al mondo quest’anno
ha fatto sfracelli è l’"hentai": si ha voglia di anime-porno, a discapito delle
Milf (al secondo posto, l’anno scorso erano prime), si ha voglia di porno
"romance", più dialoghi e clip di sesso realistico e con più interazione tra gli
attori, e di porno di gruppo (+40%) e orge (+70 %), come si ha porno-desiderio
di "asian", e di corpi abbondanti: le "culonas" sono al primo posto nei paesi
del Sud America, i c*li grossi e ch*avabili sono i preferiti in Germania, la
"gordinha gostosa" in Brasile. Chissà perché nel 2021 in Ucraina ha fatto
un’enorme ascesa la categoria "cornuti" (+224%). Il porno segue e segna le
abitudini della nostra vita, e Pornhub sa quando vai in vacanza e il porno lo
guardi di meno e a orari diversi perché devi stare col partner, figli, gli amici
(le categorie "scambismo" hanno registrato l’acme la scorsa estate). Il porno è
sempre più legato a quanto succede sui social, e infatti se va in down Instagram
ci si consola in massa su Pornhub (vedi il picco dello scorso 4 ottobre, giorno
di down social). Se ogni settimana in giro per i social c’è una nuova "sfida",
le ricerche su Pornhub dei più di 500 generi porno facenti parti di una
qualsiasi "sesso sfida" ("prova a non sb*rrare", su tutte) hanno fatto il botto
nel 2021, con un +255%. Un +244% registrano le ricerche dei porno "come", e che
sono i video di Pornhub che insegnano ad esempio "come squirtare", "come
succhiare il caz*o", "come mangiare la f*ga", "come farla venire", "come
mettersi il condom", ma pure "come radersi le p*lle". La categoria "insegnante"
è entrata nella Top 20 2021, e per questo motivo: tanto si deve ai video di vere
lezioni di matematica che Changsu, insegnante di Taiwan, carica su Pornhub, e
che di sesso hanno nulla, sono solo lezioni, le quali riportano milioni di
visite. Se le donne in generale e le italiane in particolare si cercano su
Pornhub corpo e prestazioni di Manuel Ferrara, le donne guardano meno
penetrazioni ma tanto "leccate di f*ga" e "ditalini", e ne avevate dubbi? Le
donne guardano ciò che nella realtà a letto le fa godere, e se però nelle
Filippine le donne superano gli uomini quanto a presenza su Pornhub (52% a 49!),
ragazze mie, italiane, datevi una sveglia, perché qui siamo ferme a un misero
29%. Il BDSM è genere di nicchia su Pornhub e quest’anno ha sommato l’1,5% delle
ricerche generali. È però più visto dalle donne, con età pari e superiore ai 55
anni, e tanto a Hong Kong, Svizzera, Germania, Austria, e Paesi Bassi. Pornhub
sa che in Italia come nel mondo il porno si guarda sullo smartphone (83% nel
mondo, 93% in Italia), in sistema operativo Android, su browser Chrome, e
Safari. Pornhub sa che in Italia come altrove sui porno si sta tanto la sera
(dalle 22:00 all’1:00), le mattine dei weekend, di meno il venerdì. Pornhub lo
sa che in Italia c’è il calo durante la cena della vigilia di Natale (ma solo la
prima ora), nel pranzo di Natale (ma ci torniamo il pomeriggio), mentre non ci
siamo per nessun porno la notte di Capodanno. Se negli USA la sera in cui
Pornhub può pure chiudere è quando si gioca la finale Superbowl (e quest’anno la
Florida, stato della squadra che lo ha vinto, ha garantito il picco dopo,
festeggiando a pornate), in questo 2021 in Europa ci sono state 4 persone che
per 2 volte hanno dato rogne a Pornhub, togliendogli spettatori. Chi sono? I
Måneskin, i quali hanno catalizzato l’attenzione la sera del 22 maggio in Europa
quando hanno vinto l’Eurovision (e in Italia e specie in Puglia, regione che per
Damiano ha più mollato Pornhub, al contrario della Sardegna), ma pure e di più
durante l’evento annuale che Pornhub è da tempo che lo sa, che non c’è niente da
fare, l’italiano non si s*ga, no, quelle 5 sere di seguito sta incollato alla
tv, perché… c’è il Festival di Sanremo!
Dagotraduzione dal Sun il 15 dicembre 2021.
Pornhub ha pubblicato i dati sulle preferenze di americani e inglesi tra i
contenuti che offre. Il termine più cercato a livello globale è il porno hentai,
che si piazza al primo posto negli Stati Uniti e al terzo nel Regno Unito. La
parola è usata per descrivere i materiali di anime e manga per adulti, che la
piattaforma ospita a migliaia. «I cartoni animati sono più fantastici del porno
normale», ha detto la dottoressa Laurie Betito, direttrice del Sexual Wellness
Center di Pornhub. «Siccome non è reale, puoi andare oltre, con meno vincoli
rispetto alla realtà. Anche il porno hentai tende ad avere più di una trama e le
persone sembrano essere sempre più attratte dal contesto». Tra le pornostar,
Lana Rhoades è stata la persona più cercata su Pornhub, seguita da Abella Danger
che ha mantenuto il suo posto in seconda posizione. Ma non si tratta solo di
fantasia, poiché si scopre che molti utenti hanno anche un lato romantico. Le
ricerche contenenti "romantico" sono più che raddoppiate, mentre "passionale" ha
registrato un aumento del 139%. Il romanticismo arriva al numero due, insieme a
sesso di gruppo, fitness, scambio, sfida, transgender, goth, coinquilino e "come
fare" tutti nella top ten. La nota piattaforma per adulti ha rivelato le
tendenze nel suo rapporto annuale Year In Review. I dati dell'ultimo anno
mostrano che il Regno Unito è ora il secondo maggior visitatore del sito, avendo
superato il Giappone, mentre gli Stati Uniti rimangono il numero uno. L'utente
medio del Regno Unito trascorre circa 9 minuti e 52 secondi su Pornhub, rispetto
ai 9 minuti e 44 secondi negli Stati Uniti. Nonostante l'enorme crescita
dell'hentai, le ricerche di lesbiche e milf rimangono tra le prime due per gli
inglesi.
Barbara Costa per Dagospia il
5 dicembre 2021. Il porno va a Hollywood! Il porno scende in strada e si fa
vedere da tutti! Tutti possono vedere il porno per strada perché il porno è lì,
enorme, eretto, disteso, su maxi cartelloni pubblicitari per le strade di
Hollywood. Attenzione, cinema mainstream: il porno ti entra in casa, scavalca i
tuoi steccati infischiandosene e invade il tuo territorio issandoci la sua
bandiera. Vuole i tuoi spettatori. Il porno non ci sta, il porno s’è scocciato a
stare da mesi al patibolo, col cappio al collo, ostaggio di nuove leggi miranti
a bandirlo per il lavoro (onesto e tassato) che fa. E allora entra in casa
d’altri, nelle comfort-zone decantate "pulite". Su tutti lo studios porno
"Vixen" alza la testa, attuando una strategia di marketing che a dirla
aggressiva è farle una carezza. Si vuole rinchiudere il porno negli steccati di
una morale imposta dall’alto, decisa da chi, stabilita tramite quale criteri, e
allora il porno… tiè, te lo sbatte per strada, sul muso, chi è, dove sta, e cosa
fa. Stavolta non lo fermate, stavolta lo guardate, pure se non volete, è
pubblicità lecita, pagata e esposta nel rispetto delle regole: si pubblicizzano
belle f*ghe in porno che sono film di genere, film porno vietati ai minori di 18
anni certamente, ma coi diritti di ogni altro concept cinematografico. Davvero
il porno è per le menti più pericoloso e disturbante di un horror, di uno
splatter, di un thriller violento? Attento cinema mainstream, che il porno vuole
giocare e batterti sul tuo stesso ring: è questo il suo scopo ultimo e vero,
entrare nelle piattaforme mainstream le più famose e competitive, e lì mettersi,
in catalogo, accanto a te, in spietata concorrenza. Il porno punta a farsi
riconoscere prodotto tra gli altri, superiore in qualità se lo vale, prodotto
che ogni mente adulta e consapevole forte del suo libero arbitrio può scegliere
se vedere. Il porno non insegue una scena, il porno vuole prendersi la scena, il
porno sgomita una unica scena. Il porno è tale perché perennemente giovane,
perennemente libero, e il fermo imposto dal Covid l’ha fortificato. Il porno è
pronto a forzare fortezze finora proibitegli. Perché no? I soldi non gli
mancano. Il porno scende in campo contro divieti e moralismi, pronto a spazzarli
via e sta caricato a mille: "Muse 2" e "Psychosexual" sono i due porno
battistrada schierati in prima linea per le strade di Hollywood su cartelloni
maxi ostentati: il primo è un serial, il secondo un film a episodi in grado di
rivaleggiare alla grande con un film hollywoodiano. Fidandosi dello script e
della regia della superba Kayden Kross – tre volte consecutive porno premio
Oscar quale Miglior Regista –il porno sfida il cinema tradizionale distribuito
sul web, sia in serial che non. Sotto tutti i punti di vista, recitativo,
registico, di sceneggiatura, fotografia, questi due porno son cinema a tutti gli
effetti. Certo, si sc*pa, forte e chiaro, niente è simulato né fatto intuire e
il sesso è esibito nella sua realtà, eloquenza e crudità e amoralità. "Muse 2" è
la seconda stagione del fortunatissimo 1, e ancora una volta troviamo Maitland
Ward – ricordo, attrice mainstream che nel pieno della carriera ha mollato
Hollywood per il porno, e a Hollywood è pure tornata, e però non lasciando il
porno, inaugurando una prassi che si spera faccia proseliti –nella parte
dell’accusata di molestie sessuali. Hollywood, trema! Perché questo porno
affronta a viso aperto il "tuo" MeToo. Non ti farà piacere sapere che non sta
dalla parte delle donne in quanto tali deboli e vittime, ma mette in primo piano
chi, uomo o donna, è dopo tanto tempo accusato di aver in passato abusato della
sua posizione di potere, anche se donna, di più se è donna, centrando
l’attenzione su ciò che comporta ritrovarsi ostaggio della gogna dei social, sui
quali ci si schiera subito e sempre con chi è vittima (presunta), stando comodi
a postare dalla parte di un Bene che solo a prima vista è tale. In quattro delle
cinque scene di "Psychosexual" splende Gianna Dior, pornostar che dà anima e
corpo a una contorta terapista sposata che non resiste dal portarsi a letto
pazienti, dal fare sesso con sconosciuti nei bagni, dal farsi sc*pare sul
pavimento dal primo che le piace incontrato a un party. Scorrono davanti ai
nostri occhi 10 anni di vita di una donna compiuta nella sfera professionale, ma
inquieta e perversamente affamata in quella sadomaso sessuale, dominata da
compulsioni che a livello medico ella stessa dovrebbe sapere se non del tutto
risolvere, governare. Siamo solo all’inizio. Muse 2 e Psychosexual – e
Influence, eccolo lì, appena sorto, e proprio nel cuore di Hollywood – sono solo
i primi porno maxi cartelloni in sfoggio. Presto altri seguiranno. Resisti a non
alzare lo sguardo?
Dagotraduzione dal Daily Mail
il 25 novembre 2021. Una ex modella di Playboy ed ex residente della famigerata
Playboy Mansion ha sollevato il coperchio su com'era veramente vivere lì. Jenna
Bentley dal Montana si è trasferita nella "Bunny House" - una proprietà
adiacente alla villa - nell'aprile del 2007 e vi è rimasta per un anno fino
all'aprile 2008, durante il quale "The Girls Next Door" è andato in onda sul
canale E!. Per Jenna - che ora ha 32 anni ma ne aveva solo 18 quando si è
trasferita - è stato un «sogno diventato realtà» con feste sontuose,
avvistamenti di celebrità e tutti i comfort di una «casa dei giochi di Barbie
nella vita reale». Ma c'erano anche regole rigide, come la "NDA ferrea" che ha
firmato al momento del trasferimento e il coprifuoco delle 21:00 - che, se non
rispettato, lasciava le donne fuori a dormire sul prato. Jenna, che condivide
scatti sexy con i suoi 15.000 follower su Instagram, sembra avere ricordi
piuttosto rosei della villa. «Anche ora divento così nostalgica perché è stato
un periodo così incredibile - non potranno mai replicarlo», ha detto a Jam
Press. «Non ci sarà mai niente come le sue feste. Voglio dire, la gente pensa
che fossero selvaggi, ma erano più selvaggi di quanto tu possa immaginare».
Jenna ha descritto le feste come "folli", ricordando una notte in cui ha visto
Angelina Jolie, Tommy Lee, Pamela Anderson e Dennis Rodman allo stesso evento.
Ha anche insinuato di aver distribuito sostanze illecite o giocattoli sessuali.
«Spesso andavo in giro con loro con vassoi pieni, offrendoli», ha detto. Sebbene
Jenna abbia vissuto nella proprietà, dove Hugh Hefner teneva uno stuolo di
amiche alla volta, ha insistito sul fatto che non di non essere mai andata a
letto con lui. «Non ho mai fatto sesso con Hef, mai, ma una volta mi sono
imbattuta in lui che faceva sesso. Ovviamente non posso mai dire con chi era»,
ha detto. «Tutto quello che posso dire è che c'erano quattro persone, compreso
lui». Quando Jenna si è trasferita alla Playboy Mansion, ha anche dovuto firmare
un accordo di non divulgazione "di ferro", il che significa che può solo dare
notizie su ciò che ha visto. «Ho dovuto firmare un NDA molto, molto, molto
ferreo, motivo per cui non posso parlare di chi ha fatto sesso nella villa», ha
detto. «Ma ho visto un sacco di celebrità fare sesso lì e ho anche partecipato a
molto». C'erano anche molte regole che Jenna doveva seguire - o rischiava di
essere cacciata. «Sono abbastanza sicura che abbiano fatto controlli molto
severi perché devono assicurarsi che tu non sia un serial killer», ha detto.
«Quello che ricevevi in cambio era incredibile. Voglio dire, anche se avevamo il
coprifuoco alle 21 non era come se fossimo prigionieri. «Non ci era permesso
avere fidanzati, tipo, anche incontrare ragazzi è stato un kick-out immediato».
Tuttavia, apprezzava ciò che la villa aveva da offrire. «Questo posto in cui
abbiamo vissuto aveva cinema, animali, trampolini, stilisti. Era una vera casa
dei giochi di Barbie», ha detto. C'erano dei domestici che facevano tutta la
cucina e le pulizie. «C'era un telefono che chiamavamo "Dial-a-Dream" perché
potevi premere 0 e chiedere tutto ciò che volevi, a qualsiasi ora del giorno o
della notte. Ad esempio, se volevi le patatine di McDonald's alle 3 del mattino,
uscivano e le compravano». Jenna ha raccontato poi di aver vissuto con almeno
altre 12 donne nella villa. «La gente pensa che la notizia che le donne che
sincronizzano il ciclo sia falsa, ma è sicuramente successo in casa!» ha dettp.
«Quei mesi in cui i nostri cicli corrispondevano erano puro caos. Eravamo tutte
sgualdrine e dispettose l'una con l'altra per alcuni giorni al mese». Sebbene
Jenna affermi di non aver mai dormito con Hugh Hefner durante la sua permanenza
in casa, dice che i due condividevano un legame speciale. «Era un sogno
diventato realtà vivere in casa, ti sentivi speciale e che Hef aveva occhi solo
per te», ha detto. «Quando ci sono milioni di ragazze che vogliono essere nella
posizione in cui ti trovi, ti senti sicuramente importante». Ha aggiunto: «Hugh
Hefner aveva solo tre stanze principali nella sua casa per le sue fidanzate e
mogli ufficiali e il resto di noi viveva nella Bunny House». All'epoca, Hefner
usciva con le star di The Girls Next Door Holly Madison, Bridget Marquardt e
Kendra Wilkinson. «Chiunque fosse il compagno di giochi del mese, come me, io
ero Miss April, poteva stare lì gratis per tutto l'anno», ha continuato. «Eri
d’aiuto con la pittura del corpo, i comunicati stampa, uscire con Hef e cose del
genere». «Penso che molte ragazze abbiano cercato di avvicinarsi a Hef in modo
da poter ottenere più soldi, ma quando aveva 80 e 90 anni, non faceva sesso con
nessuna delle ragazze. Si muoveva nelle sue pantofole, dio benedica la sua
anima, penso che tutte noi bionde gli sembravamo uguali a quel punto!». Ha
insistito sul fatto che «Hef aveva davvero un cuore d'oro», era «gentile con
tutti» e «faceva sempre di tutto per far sentire tutti a proprio agio». «Era
anche molto divertente», ha detto. «Avrei voluto passare più tempo con lui».
Hefner, morto nel 2017, ha fondato Playboy Magazine nel 1953, prima che
l'impresa si trasformasse in un impero composto da modelle, locali notturni e la
famigerata Playboy Mansion.
Barbara Costa per Dagospia il
23 novembre 2021. Ma quanto siamo bravi?!? Quanto mondo abbiamo conquistato
quest’anno? E abbiamo buone possibilità di conquistarne ancora, da italiani, nel
porno, ai prossimi Premi Oscar del 22 gennaio. Perché non solo Rocco Siffredi
comanda in porno-America con 12 nomination, ma c’è chi ha fatto meglio di lui,
ed è Axel Braun, italianissimo figlio del porno pioniere Lasse Braun, da più di
2 decenni in USA a porno dettar legge coi suoi porno sofisticati, e che è in
nomination in ben 13 categorie, e il suo "Glamcore", da solo, è in lizza quale
Best Regia, Best Gonzo, Best Fotografia (questa statuetta mi sa che non gliela
toglie nessuno), e Best Colonna Sonora. Sia lode agli italiani andati in America
e che col porno e nel porno tutto hanno scommesso, e oggi se ne gloriano: come
Claudio Bergamin, triestino che, stufo, ha lasciato l’Italia a metà anni '90 e
oggi nel porno è una autorità, e anche quest’anno è nel lotto quale Miglior
Regista Web, e con le sue porno case di produzione somma altre 6 nomination. Se
Maestro Claudio – questo il suo nome nel porno-States – non si può che tifarlo
da quella persona genuina che è, riconosciamo a lui il merito di aver riportato
nel porno (in piena pandemia) Michael Stefano, il quale si bea di 8 nomination,
compresa quella di Migliore Pornostar Maschile (Michael Stefano è nato in
Connecticut ma è figlio di due siciliani immigrati, sicché si può ben fare il
tifo per lui, no?). Michael si innalza nella categoria Migliore Scena di Sesso
Più Oltraggiosa (foursome con Lana Analise preda di tre maschioni) ma pure in
Best Gang-Bang dove concorre con due porno diversi. Ma in Best Gang-Bang l’Oscar
sogno vada a due donne, le nostre Malena e Martina Smeraldi, nominate in Best
Gang-Bang per la loro "69 Dicks Gang-Bang Challenge", diretta da Rocco Siffredi.
A Rocco si devono le nomination agli Oscar di Zaawaadi, porno attrice da lui
lanciata, presente in Best Anal Non USA, contro la nostra grande Rebecca
Volpetti. Entrambe si contendono pure il premio Miglior Pornostar Non USA. È
grazie alla vetrina che le ha dato Siffredi che magari il Best Anal Non USA se
lo prende lei, l’italo-tailandese "esperta" in triple penetrazioni May Thai. E
l’Italia c’è, ancora, con lui, Romeo Mancini, sardo, di Sassari, in nomination
Best Scena di Sesso Orale, e c’è pure lui, il nostro Luca Ferrero, in nomination
per Miglior Scena Sesso di Gruppo. Categoria in cui Siffredi è in gara con due
film, e uno è "Psyco Teens 15", e la scena di sesso di gruppo in questione è
quella tra Lyla Silver, Erik Everard, e la nostra Martina Smeraldi. Adesso due
righe obbligatorie su Steve Holmes e quel suo pene di 60 anni in fulgida
attività: questo signore qui anche quest’anno fa la sua figura con 4 nomination,
e una per doppia penetrazione! Steve sei una porno-roccia, complimenti! Passiamo
ai Premi i più importanti, i più ambiti, come quello di Best Female Pornostar, e
se io l’anno scorso ci ho azzeccato, ma con Emily Willis tifavo pure Jane Wilde,
che tifo di nuovo, e però dico che lo meriterebbe pure Scarlit Scandal, ma pure
Kira Noir, ma pure Gianna Dior, e dico pure che se il Best Pornostar finisse
ancora tra le tettone di Angela White, niente vi sarebbe da obiettare, OK, ma…
quante possibilità diamo a Lulu Chu di vincerlo? Lulu Chu, la cinesina di Wuhan,
colei che a Wuhan c’è solo nata e poi subito adottata e portata negli USA,
quest’anno nel porno tanto ha fatto e sudato da guadagnarsi la nomination come
Miglior Pornostar dell’Anno, a cui ne aggiunge 2 in Best Orgia (in gara con due
film distinti), e uno in Best Orgia Lesbica. Miglior Porno Attore dell’Anno: per
quanto io sia porno-fan di Manuel Ferrara (e dategli la statuetta per la Miglior
Serie Gonzo, la sua "Raw" la merita, e dategli pure un premio anale, ché la sua
serie "Manuel apre i c*li", arrivata alla numero 8, è divina) e per quanto qui,
in lizza, vi sia la crème de la crème dei maschi e dei peni in porno
circolazione, io pure quest’anno insisto per Tommy Pistol (ma dopo Michael
Stefano). Sezione Porno Trans: la trans Aubrey Kate gareggia nel Miglior
P*mpino, insieme a colleghe non trans. Il suo porn documentary "I Am Aubrey" ha
nomination sparse ovunque, in categorie trans e in categorie non trans, è
scontato che dica la sua quale Best Porno Trans, ma fatemi sottolineare che "I
Am Aubrey" vede alla regia Dana Vespoli, ed è in lotta pure per Miglior
Montaggio, che qui è curato da mister John Stagliano. Ne la Miglior Scena di
Sesso Trans, con Aubrey affilano le armi Daisy Taylor, e Emma Rose, e Domino
Presley: chissà, forse la spunterà proprio Aubrey Kate, che si fa sc*pare
"Succubus" da Small Hands. Ragazze celebrate e ritratte su Dagospia fanno la
loro magnifica figura agli Oscar: di Lulu Chu ho già detto, ma c’è Vina Sky che
conquista la nomination in Miglior Scena di Sesso a due etero, per quello che ha
combinato in "South Beach" col grande Jules Jordan (però qui è dura, qui per me
ha buone chances di vittoria Scarlit Scandal sculacciata da Jax Slayher in
"Black Beautie 3"). Vina Sky e Lulu Chu hanno pornato in "Asian Delight" e per
questo brillano in nomination in Miglior Scena di Sesso in Realtà Virtuale. Io
me lo sentivo, che Rachael Cavalli sarebbe stata nominata Miglior Milf, e però
non mi aspettavo la francesina Clara Mia (scoperta, in tutti i sensi, da Pierre
Woodman), già in gara come Best New Starlet Non USA. Come Best New Starlet USA
tanti posti sono occupati dalle natiche delle ragazze della Motley Models (Lily
Larimar, Coco Lovelock, Kylie Rocket…). E "Slayed" spero porti a casa il premio
quale Miglior Sito Novità. Nina Hartley (ma quanta forza ha? È ininterrottamente
nel porno dai primi anni '70) si prende la sua nomination come Best Act No Sex,
e la sua (coetanea?) collega Sally D’Angelo è in gara come Best Porno di
Nicchia. Una curiosità: per la Miglior Scena di Sesso in POV, ci sono le
nomination formato famiglia, cioè le scene girate da attori che si accoppiano
sui set e pure nella vita privata dacché sono veri marito e moglie, e sono Kayla
Kayden e Toni Ribas, Little Caprice e Marcello Bravo, e Annika Albrite e Mick
Blue. E come Direttore dell’Anno, ovvio che siamo tutti per Rocco, ma… vuoi
vedere che per la quarta volta consecutiva questo Oscar lo vince Kayden Kross?
D’altra parte, come trovare un difetto, una pur minima imperfezione, in uno dei
suoi lavori?
Gloria Satta per il Messaggero
il 6 novembre 2021. Il 18 novembre uscirà il film Annette, musical di Léo Carax
in cui tra una canzone e l'altra il protagonista Adam Driver pratica un
cunnilingus all'attrice premio Oscar Marion Cotillard. Si tratta di una delle
rarissime scene di sesso ormai visibili al cinema che, malgrado l'evoluzione
della società e lo sdoganamento progressivo dei costumi, sembra aver rinunciato
a rappresentare esplicitamente l'erotismo. Siamo entrati in un'era di nuovo
puritanesimo? Se lo è chiesto la Bbc che al fenomeno ha dedicato una lunga
inchiesta cominciando dai numeri: secondo una ricerca del portale Imdb, il
database del cinema mondiale, soltanto l'1,21 per cento dei 148.012 film usciti
dal 2010 a oggi contiene sequenze di sesso. Niente a che vedere con i bollenti
anni Novanta di Basic Instinct e Showgirls, picco della febbre erotica del
cinema.
NUOVO PUDORE Invece in questo
periodo chi cerca brividi in sala, a parte Annette potrà contare soltanto su
Benedetta di Paul Verhoeven, storia di una monaca lesbica del XVII secolo (che
usa una statuetta sacra come sex toy) e su Titane di Julia Ducournau, Palma
d'oro a Cannes, la cui protagonista fa l'amore a tutto schermo ma non con un
uomo bensì con una Cadillac. Di chi è la responsabilità del nuovo pudore del
cinema, un tempo sotto accusa per la sua audacia sessuale grazie a cult
amatissimi dal pubblico e bersagliati dalla censura come L'impero dei sensi,
Ultimo tango a Parigi, Il postino suona sempre due volte, Nove settimane e
mezzo, il mitico Basic Instict e solo qualche anno fa Nymphomanmiac?
LE CAUSE L'attuale latitanza
del sesso sul grande schermo ha più di una causa. Una è puramente industriale:
mentre gli incassi, sotto i colpi dello streaming, sono in affanno i produttori
non possono permettersi di perdere il pubblico dei giovanissimi che un divieto
ai minori terrebbe lontano dalle sale. Un'altra ragione è riconducibile al
costume: ormai la pornografia è talmente disponibile sulla rete che la gente non
va a cercarsela anche nel cinema mainstream, cioè per il grande pubblico. C'è
poi da considerare il movimento #MeToo che, sull'onda degli scandali sessuali,
ha imposto nuove regole sulla rappresentazione del corpo della donna, non più un
puro oggetto di piacere ma un soggetto degno del massimo rispetto. Tanto che sui
set anglosassoni è comparsa una nuova figura, imposta per contratto: l'intimacy
coordinator, delegato a sorvegliare le scene di intimità per far sì che
qualunque atto, anche simulato, avvenga con il pieno consenso degli attori.
EVITARE DENUNCE E non solo per
evitare la mercificazione sessuale delle donne ma anche, e soprattutto, per
sventare denunce per abusi o molestie con relativi risarcimenti milionari. Ormai
esistono le star, pagatissime, del settore: Ita O' Brien che ha fondato la prima
agenzia di intimacy coordinators, Amanda Blumenthal che ha soprainteso alla
serie Hbo Euphoria in cui tra orge e droga succede di tutto, Lizzy Talbot che
sul set della serie Netflix Bridgerton ha fatto da terzo incomodo quando il Duca
e la Duchessa di Hastings finivano a letto. La novità è stata considerata da
molti un'ulteriore esasperazione del pensiero politically correct e un limite
alla libertà di espressione dei registi. Ma c'è anche chi l'ha accolta con
sollievo come l'attrice Dakota Johnson che sul set di 50 sfumature di grigio
pretese di eseguire a porte chiuse le acrobazie erotiche con il partner Jamie
Dornan, o come Keira Knightley che, non sentendosi sufficientemente tutelata,
tempo fa ha dichiarato: «Non farò più scene di sesso se a dirigermi non sarà una
donna».
Serenella Bettini per “Libero
Quotidiano” il 28 ottobre 2021. Una volta c'era la trasgressione. Ora non c'è
più nemmeno quella, perché i ragazzini si abituano fin da subito a mostrarsi,
mettersi in rete. Vendersi, addirittura. Foto senza veli, chat erotiche,
immagini di seni, fondoschiena, gambe, piedi, frustini, palette. Ormoni che
girano, valori che si perdono nei meandri di una società sempre più virtuale,
che viaggia verso la totale assenza di pudore: dietro lo schermo si abbatte la
vergogna, magari senza rendersi troppo conto che allo stesso etere si affacciano
persone. L'isolamento dovuto alla pandemia, poi, ha del tutto sdoganato il sesso
già diffuso mercato del sesso online. La gente si conosce su Tinder, dove uomini
e donne passano in rassegna i possibili partner come fossero su un catalogo di
Postalmarket, e poi li contattano. Le persone si conoscono su Tik Tok, su
Instagram. Ma in questi social network non sono ammessi contenuti a sfondo
esplicitamente sessuale. E così ecco che vien creato OnlyFans, piattaforma con
tanto di applicazione nata in Inghilterra nel 2016, dove invece i contenuti
erotici sono ammessi, e gli utenti pagano per poi accedere a questi contenuti
tramite un abbonamento mensile. I protagonisti sono più che altro YouTuber,
modelli, istruttori di fitness, personaggi pubblici. Con la pandemia, da marzo
2020 le iscrizioni sono aumentate del 75%. Secondo la politica della
piattaforma, gli utenti devono avere almeno 18 anni. Peccato che non sia così.
Perché in questa rete ci finiscono sempre più ragazzine. In realtà farsi un
account è facile. Noi di Libero ci abbiamo provato. Si inseriscono alcuni dati e
poi inizia la navigazione. Dentro si trova di tutto. Oltre a chi veramente lo
usa professionalmente, ci sono ragazze in pose alquanto compromettenti,
fantasiose cuoche con scollature vertiginose che impastano farina a suon di
mattarello, ragazzine in pose esplicite, costumi che lasciano intravedere tutto,
maschi dai fisici scolpiti con i glutei in evidenza. Poi, una volta effettuato
l'accesso, se si vuole interagire con l'utente o vedere tutti i contenuti (anche
e soprattutto quelli più "intimi"), scatta il pagamento e ti viene chiesto di
inserire il numero di carta di credito. Dopodiché si entra nel mondo proibito.
Ci sono ragazze carine che sui social come Instagram o TikTok pubblicano foto in
costume provocanti, e che poi nella descrizione del profilo aggiungono il link a
OnlyFans. «Gli adulti che vi accedono - spiega a Libero Davide Dal Maso, docente
di social media ed esperto di Generazione Z e digital, nonché fondatore della no
profit Movimento Etico Digitale sulle potenzialità e i rischi del web - pagano
una quota mensile per vedere questi contenuti. Così la ragazza in questione, che
magari è minorenne ma è riuscita facilmente a iscriversi con un trucco, riceve
una parte di quella quota mensile per ogni abbonato alle sue foto, generando in
certi casi delle grosse somme. Alcune ragazze fanno un sacco di soldi. Qualcuna
ha anche lasciato il lavoro». In effetti OnlyFans non nasce come piattaforma
dove pubblicare contenuti pornografici o altro, solo che la sua politica
"elastica", a differenza di altri social che oscurano persino le opere d'arte se
mostrano corpi nudi - vedi la "Fontana delle Tette" a Treviso -, è in breve
diventata un contenitore virtuale all'interno del quale pubblicare anche
contenuti erotici. Ad agosto scorso OnlyFans con una nota su Twitter aveva
annunciato un cambiamento di politica. Il tweet era rivolto ai "sex worker", per
l'appunto i "lavoratori del sesso". Ma questa non è l'ultima frontiera. L'altra
perversione che sta aumentando anche in Italia è il caso delle cosiddette
dominatrici finanziarie. Una moda importata dagli Stati Uniti, dove la donna usa
l'uomo come fosse un bancomat. Anche qui accade, direte voi. Ci sono donne che a
farsi mantenere dai mariti sono l'asso di coppe. Ma qui la storia è diversa. Qui
uomo e donna non si conoscono. La donna considera l'uomo solo per i suoi soldi.
Lo "possiede". L'uomo diventa schiavo dopo aver risposto ad annunci come
"diventa il mio schiavo", appunto, e la donna gli prosciuga il conto. Facile,
no?
Barbara Costa per Dagospia il
16 ottobre 2021. Perché nel porno non si usano i preservativi? È la domanda che
spesso mi fanno, e io vorrei sapere chi ha messo in giro una palla tale, e però,
mi si ribatte, nei porno i preservativi non si vedono mai. E non è vero, non in
tutti i porno è così, altrimenti perché "Wicked", studios famosissimo, avrebbe
solo da 1 anno decretato la loro eliminazione? Via i preservativi, è ciò che
Axel Braun – italianissimo e premiatissimo regista porno attivo da 3 decenni, in
Wicked da 7 anni e da uno a capo della produzione – ha preso come prioritaria
decisione: ciò ha destato scalpore, in un marchio da sempre pro-condom quale
Wicked, eppure "Going in Raw" e "Glamcore", primi porno by Wicked senza lattici
barriere, hanno registrato il record di visualizzazioni, sicché ottimi e lauti
ricavi. Che la presenza del preservativo nel porno non piaccia a chi il porno lo
guarda, è la più usata tra le spiegazioni: non nego abbia una sua validità e,
seppur vi sia tra le categorie anche il "condom porn", professionale e
amatorial, ramificato in varie sottospecie a seconda del modo in cui uno o più
preservativi vi siano impiegati, chi guarda il porno si vuole eccitare e far il
suo amichetto alzare senza minimi "impicci" che ne smorzino l’arrapamento visivo
e di conseguenza fisico (lo stesso discorso si può fare per le mutande, e
infatti: vi siete mai chiesti perché a differenza delle colleghe gli attori
porno non le indossino quasi mai e siano già nudi quando si slacciano i
pantaloni? Se la donna a farsele togliere o a da sé seducentemente sfilarsele
più tempo ci mette più l’erezione al di là dello schermo è contenta, come ne è
contento il clitoride di chi la guarda, va da sé che per visivamente eccitarsi
se le mutande maschili non ci stanno, è meglio), dicevo, le ragioni dell’assenza
dei condom nei porno sono pratiche e sono fondamentalmente due. Una, i
preservativi nel porno si rompono, spessissimo, e non perché il porno sia
taccagno e ne usi di scadenti, ma perché i preservativi sono parecchio
resistenti in quanto destinati a coiti normali e non ai coiti innaturali messi
in scena dai performer, e soprattutto quelli che rientrano nel "rough-porn",
ovvero il porno violento che poi violento sul serio non è (è violenza recitata).
Seconda, e più importante, i tessuti di ano e vagina verrebbero gravemente
irritati dall’eccessivo sfregamento e dal prolungato contatto con uno e più peni
con preservativo. Perché le scene date al pubblico sono il risultato finale,
visionato e montato: il sesso che si vede non è girato in quella sequenza, se
non in casi e scelte mirati, e non dura il tempo che si vede, né le posizioni
sono nella stessa successione che viene a noi servita. Ad esempio, una scena
anale tra una attrice e un attore superdotato esige una preparazione in entrata
del super pene pari anche a un’ora per un sesso anale che in ciò che si vede non
dura quanto si crede ma è frutto sì di sesso vero, reale, effettivo, ma pure di
abilità porno recitatoria e di furbizie registiche e relative angolazioni. Ne
consegue che, a mettere a lungo dentro ano e/o vagina pur più volte intensamente
lubrificati un pene con condom, anche se non tutto il tempo nella sua interezza
comunque in parte, l’attrito col lattice può portare a infiammazioni e ferite
anche serie. Ogni tanto la legge – e negli USA quella statale, il porno non cade
sotto giurisdizione federale – ci prova a indire disegni di legge come pure
referendum per l’introduzione obbligatoria dei preservativi nei porno. E ogni
volta è un buco nell’acqua, e ogni volta una tale legge non passa, nemmeno se
accompagnata dalla (pazza) idea di dare allo spettatore porno la facoltà di
denunciare nome e cognome dell’attore e della casa di produzione in cui egli
vede un pene in azione "nudo". Non passa perché gli utenti porno non sono
delatori né dei loro beniamini né in primis di se stessi e di ciò che nel loro
privato godono vedere e fare. Non passa perché l’obbligatorietà del condom
renderebbe arduo se non impossibile filmare scene che implicano sperma (facial,
creampie, bukkake, ecc.), cioè tra i generi i più amati (e redditizi). Non passa
perché il porno "ricatta" contee e stati che lo scocciano con tali proposte di
legge, minacciando non tanto velatamente (alcuni studios lo hanno fatto) di fare
fagotto e di andare a girare altrove, recando danni economici mica da ridere (il
porno fa girare un mucchio di soldi su cui ci paga belle tasse). Non passa
neanche con le buone intenzioni di proteggere la salute dei e delle pornostar.
Perché i performer porno sono persone strapulite, che lavorano su set a livello
igienico pari a una sala operatoria, ma specie perché ogni attore nel porno
professionale è obbligatoriamente sottoposto a tassative analisi cliniche, che
non solo se non le fa non lavora, ma dati clinici che sono ogni 7 giorni
inseriti in un database che ne monitora lo stato di salute. Un performer porno
infetto è chi non ottiene la spunta verde nel database, ed è chi non dentro al
porno ma fuori di esso ha avuto rapporti sessuali non protetti: immediatamente
egli è dal database individuato e fermato come sono individuati e fermati tutti
quei performer con lui venuti sessualmente a contatto. Solo così il porno si
tiene estraneo a sessuali pandemie, e c’è da lodare la recente decisione di
"legare" il database del porno americano a quello europeo aprendo un laboratorio
di analisi a Budapest, unito via web a quello USA. L’uso del preservativo in
ogni scena porno è anche a discrezione dell’attore e/o dell’attrice. Ci sono e
ci son sempre stati performer – maschi e femmine – che si rifiutano di girare
senza. Tra le più famose, la nostra Ilona Staller: nella sua autobiografia
ufficiale, ha dichiarato di non aver mai girato scene di penetrazione senza
preservativo, e così di essersi salvata da John Holmes, il quale con lei ha
girato "Carne Bollente" ed era malato e lo sapeva, e a nessuno lo diceva né
tantomeno spiegava il motivo per cui il suo enorme e stracelebrato membro
faticava così tanto a rizzarsi.
Pierangelo Sapegno per “La
Stampa – Specchio” il 4 ottobre 2021. Salvatore sembra un oste, con la pancia
che avanza prima di lui. Gli manca il grembiule nero, ma adesso vedrai che ti
consiglia le sue melanzane alla parmigiana. Però fa il regista del film porno e
si chiama Axel Ramirez. E non ha mai cucinato una melanzana in vita sua. C'è
l'attore, quello più giovane e prestante, che deve dire «piacere, io sono
Maverick». Non sembra difficile, solo che è la decima volta che rifanno la
scena. Lui dev'essersi un po' indispettito, perché adesso lo dice quasi
sbuffando, come se volesse far capire che era venuto qui per fare altro. Anche
lei è venuta qui per fare altro, le calze nere, un bel balcone davanti, tacchi a
spillo, lo sguardo concentrato che ti sta prendendo le misure. Allora? Che
vogliamo fare? Matteo ridice la battuta velocemente, cerchiamo di sbrigarci. E
l'oste s'arrabbia: «Nooo, devi far vedere la tua sorpresa, perché voi vi siete
già incontrati, vi conoscete». E certo che si conoscono. Il regista scuote la
testa: «Quando un film ha una bella trama, come questo», spiega, «io ci tengo
che tutto sia fatto bene. Voglio che loro migliorino». Giusto. Il film
s'intitola Top Gun, una parodia porno di quello vero. La sceneggiatura, dice
Salvatore, lo ricalca a grandi linee. Così, a spanne. E per forza. Sei attori in
tutto, 4 maschi e due donne, sei giorni di riprese, un cameraman che poi è anche
il montatore, e 2000 euro massimo di budget. Come ci si riesce? «Riusciamo».
Commento serafico del produttore. Max Biondi, fatalismo napoletano. Si gira
tutto qui in questa villetta di Ischia, guarda che mare. Ma gli effetti
speciali, il costo della troupe, la trasferta, gli affitti? «No, la villetta è
del regista... Ci mettiamo d'accordo». Umma umma. Il fatto è che il porno è in
crisi, spiega Max. «Siamo rimasti solo in 4 o 5 case di produzione in Italia.
Dieci anni fa erano 50. Siamo gli ultimi indiani». Sicuro? Secondo un'inchiesta
di Think2money «il giro d'affari del porno è quantificabile in circa 97 miliardi
di dollari», una cifra astronomica. Tanto per capirci, Hollywood con i suoi 600
film all'anno produce 10 miliardi di dollari, e tutta l'industria
cinematografica mondiale genera ricavi per 15 miliardi. «Il porno in Usa fattura
più soldi della Major League Baseball, la National Football League e la NBA
combinate insieme». Gli attori arrivano a contratti che superano i 250mila
dollari all'anno. Il marchio di Jenna Jameson, star dell'adult entertainment
vale 30 milioni di dollari l'anno, quasi come Brad Pitt, che ne guadagna 32.
«Eh, ma quelli so' americani», ribatte Biondi. «Un altro mondo». E comunque lui
i suoi film li piazza, appunto, negli States. «Li vendo su Avn Stars,
piattaforma ufficiale dell'Oscar porno». A quanto? «Li metto lì, poi il costo va
da un minimo di 7 dollari a un massimo di 15. Dipende, ho girato Matrix,
Cleopatra, insomma parodie importanti». E non vi fate soldi? «Nooo. Lo faccio
principalmente per passione». Davvero? «Eh sì, certo. Io, sin da adolescente
andavo nei teatri a vedere le pornostar. Ci sono proprio portato. Perché prima
facevo l'attore». Dove? «Eeeh, dove. Al cinema. Sono un ex attore di Pupi
Avati». E poi com'è finito nel porno? «Perché sono molto ambizioso e volevo
sfondare. Nei film tradizionali più di piccoli ruoli non riuscivo a fare. Allora
ho intrapreso la carriera dell'hard, e lì ho spaccato veramente». Solo che
adesso diciamo che si sopravvive. Il fatto è, protesta, che l'Italia paga una
crisi unica, «lo vede come siamo messi». Lui finché tira quest'aria resta qui a
Ischia, li gira tutti qui i film, guarda che luce, il mare fermo, il cielo
chiaro e un lampo giallo al parabrise. Cosa c'è di meglio? Poi sì, i soldi
contano, sono importanti, «ma senza passione non si vive». Lo dice Max Biondi,
pensierino della sera. Ormai il mondo è cambiato, oggi comanda internet, bisogna
adeguarsi. Ecco, sul web, la rete offre ben 260 milioni di siti porno visitati
quotidianamente da più di 300 milioni di utenti (75 per cento uomini, 25 donne),
Pornhub da solo raccoglie 81 milioni di utenti ogni giorno, 800 ricerche al
secondo e 4 milioni di video caricati in un anno, mentre Youporn genera 2,1
miliardi di pagine viste al mese. Dove sta la crisi? «Ma quelli sono siti
gratuiti. Loro guadagnano, e guadagnano tantissimo, sulla pubblicità». Già, ma
senza film non potrebbero esistere. «Vero». E allora? Allora diciamo che
qualcosa resiste, che forse c'è anche chi ci campa bene. In fondo, Francesco
Guzman, l'altro attore, una tuta da pilota che gli sta un po' troppo stretta e
la testa pelata, ammette che lo fa per i soldi, perché in realtà lui nasce come
attore di teatro e di cinema: «Ho lavorato con Bellocchio, con Pierfrancesco
Favino, con Michele Placido, ho lavorato con i professionisti. Michele Placido
aveva grande stima di me». Dice che ha fatto L'ombra di Caravaggio con lui. «Mi
parlava con affetto e mi spiegava la parte: solo tu puoi farla bene». Che parte?
«Facevo il prete. Dico una cosa sola, ma per me è importante. Anche con Favino,
viene vicino a me, mi dà una mano sulla spalla e gli do la battuta, capito? Gli
dico ciao». Cioè, faceva il figurante? «No. Questo è figurante speciale. E
comunque ti pagano bene. Il figurante è quello che non dice niente». Beh, il
porno dovrebbe pagare meglio. «A casa mia lo sanno che faccio questo. Parliamo
di soldi, mi capisce? E i soldi fanno comodo. Io non vado sul set per fare una
scopata con l'attrice. Io vado lì per lavorare. Perché, diciamo le cose come
stanno, io vengo da tanti anni di teatro e ho imparato una cosa prima di tutto:
la serietà». È così che si impegna con l'attrice. Lei, con il suo bel davanzale
e le forme procaci, non è proprio di primo pelo, ha 41 anni ed è ucraina anche
se si chiama Veronica Belli. Durante gli intrecci amorosi, si profonde in
complimenti abbastanza trasversali e incoraggianti sulle misure. In questi casi,
Axel Ramirez non fa ripetere le scene. «Ogni attore ha i suoi segreti e le sue
tecniche e ci sono determinate situazioni in cui è meglio non intervenire».
Salvatore ha girato 11 film porno fino adesso e spiega che c'è stato «un bel
salto di qualità con queste ultime parodie. Prima erano solo scene di sesso,
adesso arriviamo a un recitato anche di venti pagine». Ricorda di aver
cominciato a 24 anni a fare il regista. Mai pensato di fare l'oste. Primo film
La prigione oscura, un horror, «lo puoi vedere su Youtube», dice. Poi ha
preferito l'hard. Per lo più dietro la cinepresa. Ma fa anche l'attore. «Sono
vanitoso, mi piace apparire. Pure in questo, io e Max recitiamo delle parti, per
dare più sostanza alla sceneggiatura». Chiaro. «Io faccio la parte del sergente
cazzuto che urla sempre. E Max il comandante che incontra gli allievi della
scuola aeronautica». Tutto qui intorno, nella villetta di famiglia, casa e
lavoro. Se non ci fosse il recitato, due amplessi e via. Invece, siccome Ramirez
fa ripetere le scene all'attor giovine, Francesco a un certo punto comincia a
fremere, perché rischia di perdere il traghetto. «Non ci siamo coordinati bene
sugli orari», si lamenta. Allora Salvatore accelera con grande soddisfazione di
Matteo, che chiaramente è venuto qui pensando di fare altro. Alla fine, il
regista dà uno strappo in macchina al porto a Francesco. Tutto bene. Molto
casereccio. Alla fine Guzman ha solo una cosa da dire perché ci tiene tanto. «Il
mio sogno». Sul porno? «No. Il mio sogno è di lavorare con Quentin Tarantino. So
che viene a Roma, a metà ottobre, ho già comprato il biglietto. Mi piacerebbe
salire sul palco del più bel teatro del mondo, il San Carlo di Napoli, e fare un
film con Tarantino». Da figurante? «Figurante speciale. Per cortesia!».
Da liberoquotidiano.it il 2 ottobre 2021. In
Spagna è grande polemica dopo la decisione di un giudice di archiviare il caso
di 80 donne - tra cui alcune minorenni - filmate nell'agosto del 2019 mentre
urinavano in una strada nascosta, durante una festa di paese. I video sono stati
pubblicati su siti a luci rosse a pagamento a loro insaputa. Per il tribunale
spagnolo, non c'è alcun reato visto che le vittime sono state filmate in un
luogo pubblico. "Nella piazza i bagni pubblici erano troppo pochi per i 30 mila
partecipanti. Le lunghe file ci hanno costretto a cercare un posto nascosto",
racconta a Repubblica Jennifer, una delle vittime. "È stato un amico a dirmi che
alcuni video della festa stavano circolando sui siti por***. Quando ho trovato
il mio ho iniziato a piangere e a farmi prendere dal panico", racconta sempre
Jennifer che insieme all'associazione Mulleres en igualdade Burela ha avviato
un'azione legale per chiedere alle autorità di aprire un'indagine che non solo
identifichi i colpevoli, ma agisca contro i siti web che hanno diffuso i video
senza consenso. Ma il giudice Pablo Muñoz Vázquez ha confermato la sentenza di
marzo secondo cui in questi video non ci sarebbe "alcuna intenzione di violare
la privacy o integrità morale" visto che le vittime sono state filmate in un
luogo pubblico. Le indagini portate avanti privatamente dalle donne raccontano
una storia diversa. "Quando hanno posizionato le videocamere sapevano
esattamente che le donne sarebbero andate lì perché è un posto nascosto",
racconta Jennifer. Jennifer e le altre vittime sperano di non dover aspettare
ancora per la giustizia che meritano. "L'associazione non si arrende e andrà
contro la sentenza. Vogliamo sapere chi sono i responsabili, cancellare tutti i
video e impedire che tutto questo accada ad altre donne".
Barbara Costa per Dagospia il 19 settembre 2021.
#FreeBritney?!? Dal padre presto sì, ma dal porno proprio no! La cantante
Britney Spears è protagonista del suo terzo porno… sto scherzando! È online la
nuova porno parodia su Britney Spears, impersonata dalla pornostar Kenzie
Taylor. Questo porno, "Free Britney", canzona e pornifica le note pene della
povera Britney e la campagna mondiale #freebritney, con cui i suoi fan anni sui
social hanno lottato per la liberazione della loro beniamina dalla tutela del
padre che, dal rapato crollo psichico della figliola, ne gestiva scelte di vita,
e soprattutto tanti, ma tanti, soldi. Fare porno mettendoci (abusivamente) in
mezzo le star della musica e i loro guai veri o presunti, si fa, eccome, e da 30
anni, ma ci si guadagna a ondate. Vi sono dei periodi in cui si girano
porno-parodie senza sosta, e gli sceneggiatori i più sagaci sono chiamati agli
straordinari per sfornare porno-plot efferati, e le più grandi pornostar
esortate a darsi da fare, col sesso ma pure con una recitazione un minimo
credibile. Niente viene lasciato fuori o al caso: alle popstar le pornostar
fanno il porno verso in abiti, trucco, hit e postura, e più le stesse popstar
hanno flirtato col porno nei video social o musicali, più nei porno veri vengono
prese in giro e sommerse di sesso spietato. Basta storpiare i loro nomi, e ben
marcare che è una "parody, and not the real", per scampare i casini legali. E i
fan apprezzano, e cercano questi video, i cui trailer diventano virali poiché
montati "puliti", senza scene hot, e caricati e fatti girare anche dai siti di
news e gossip che ne riprendono il nome della star pornizzata in questione. Se
la pop-porn-parody è attiva dagli anni '80, Britney Spears ne è stata a sua
insaputa protagonista fin da "… Baby, One More Time", sua prima hit e video,
storpiati e parodiati in "Fuck Me Baby One More Time": qui la scolaretta in
simil Lolita by Adrian Lyne porneggia ogni azione che nel videoclip fa soltanto
intuire. Nulla da Britney fatto in seguito è stato dal porno tralasciato: i suoi
videoclip più sozzi, la tuta rossa in latex di "Oops!... I Did it Again" (nel
porno "Oops!... I Fucked him Again"), le orge umide di leccate in "I’m a Slave 4
U", i nudi in "Womanizer", il c*lo fotocopiato il "Toxic"… tutto fa porno,
diventa materiale porno, titillando e scatenando l’istinto eversivo insito nella
pornografia. Prima "vittima" della pop-porn-parody è stata Madonna, con la sua
"Like a Virgin", nel video girato a Venezia subito virato in adattamento porno,
e poi col suo corsetto a punta by Gaultier pornograficamente "usato" a dildo,
fino a che Madonna ha lei apertamente sfidato il porno, più che accarezzandolo e
ben poco mimandolo dal video "Justify my Love" in poi. Le due arti si sono fuse
e infiammate in Adriana Chechik, super pornostar la quale ha parodiato Madonna
(e Marilyn Monroe) in una porno versione di "Diamond are a Girl’s Best Friends",
dove i diamanti hanno altra forma e "funzione". Ma sono tantissime le star della
musica che hanno il loro clone porno. Con Jennifer Lopez si è avuto un coito tra
pop e politica: "Not Jennifer Lopez XXX", del regista Will Ryder (celebre per
aver firmato una porno parodia sulla presidenza Obama attualmente anatema,
"White House Orgy", con il presidente nero che fa sesso e orge con sole donne
bianche, cornificando Michelle interracial-mente), che trasforma la porno
attrice Renae Cruz in una Jennifer Lopez rincorsa dai paparazzi e dalle
richieste di terroristi pazzi suoi fan sfegatati, i quali, per un suo concerto,
e "dopo-concerto", sono disposti a far la pace col mondo intero. La J.Lo del
porno è preda di paure e ardori, il concerto non sa se farlo, però… (in questa
porn parody le scene all’esterno della Casa Bianca e a Capitol Hill sono state
girate sul posto: si può fare, il porno ha ottenuto legali autorizzazioni). Pure
Lady Gaga è nel porno (parody) dalla sua prima hit, "Poket Face": il suo look è
passato identico ma denudato in "Porn This Way", ma il suo porno più famoso è
quello girato con… Beyoncé! Vi ricordate il loro duetto in "Telephone", e il
trashissimo video? Quello con le lattine di Coca cola messe a bigodini,
ambientato in un carcere. Lattine-bigodino e carcere sono pure nel porno "This
Ain’t Lady Gaga", con le due cantanti che hanno i corpi delle pornostar Helly
Mae Hellfire e di Rihanna Rimes. Qui però Lady Gaga e Beyoncé più che cantare ci
danno sotto a strap-on. Se reality della musica come "X-Factor" sono passati al
porno per merito di Rocco Siffredi ("XXX Fucktory", la versione italiana, e la
più porno parodiata è Arisa), e se i popstar maschi sono per lo più parodiati
nella da una parte dei fan agognata ma nella realtà improbabile passione omosex
(i gruppi pop anni '90 Take That e Spice Girls sono stati fatti pornare in orge
omosessuali e non, tra loro e non, al pari dei protagonisti dei telefilm cult
"Friends" e "Beverly Hills 90210"), e se Hustler ha fatto delle porn parody
garanzia di dissacrazione delle credibilità delle star musicali e dei reality
("Keeping it up for the KardASSians", è la porno-serie di Kim e culone sorelle)
è "Katy Pervy" la porn parody con più popstar "prestate" al porno: oltre a una
Katy Perry che qui svela quello che fa dietro le quinte (tornate di blow-job per
"allenare" gola e voce), e che lei "Kissed a Girl" mica per finta e con una sola
e una volta sola e solo in bocca, appaiono in porno-sequenza le porno caricature
di Justin Bieber, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Snoopy Dogg, Kesha (e Bieber è
suo malgrado pornato in "Bustin Beeber Never Say Never", e da protagonista). Ma
una pazza scatenata come Miley Cyrus, dopo aver cavalcato quella bomba, nuda,
nell’iconico video "Wrecking Ball" (diretto dal genio divenuto innominabile
Terry Richardson) poteva non finire porno "triturata"? Eccola in "Molly’s
Wrecking Ballz", di cui "World Class" è lo spin-off in resa gang-bang. E, per
chi la preferisce, c’è pure in performance porno da Hannah Montana.
Tutto quello che avreste
voluto sapere sulle scene di sesso nei film.
E non avete mai osato chiedere, dai «calzini copri-pene» ai coreografi del sesso
alle protesi. Gabriele Gargantini su il Post.it il 3 settembre 2021. Tra tutte
le cose che il cinema deve fingere, una delle più difficili è il sesso. Durante
il sesso – quello vero – si è di solito particolarmente spontanei, e quindi è
difficile che il sesso dei film – quello finto – riesca a replicare quella
spontaneità. Di queste cose si è accorto chiunque abbia visto una scena di sesso
in un film: cioè quella cosa, come ha scritto il sito Messy Nessy Chic, «che, se
sei un bambino o un ragazzo, accade proprio mentre i tuoi genitori entrano nella
stanza». Oltre che per il risultato (bella scena/brutta scena), il sesso al
cinema e nelle serie tv è interessante per le molte domande su come funziona, su
come viene preparato e girato e sulle precauzioni che si prendono: cose valide
sia in una qualsiasi fiction Rai che in un film da centinaia di milioni di
dollari. Le risposte passano da molte cose: complicate clausole contrattuali,
«calze copri-pene», coreografi del sesso, protesi, mutande color carne e addetti
agli effetti speciali che, in post-produzione, aggiungono peli pubici al
computer.
La scena. Nel caso di
produzioni affidabili e relativamente grandi, gli attori iniziano le riprese
sapendo già se dovranno girare scene di sesso o di nudo, anche parziale. La
prassi, soprattutto in America, vuole che almeno 24 ore prima di una scena di
sesso agli attori vengano date indicazioni il più dettagliate possibile sul tipo
di scena da girare. Se tutto è ok, gli attori danno l’assenso e si presentano
sul set pronti a girare. Non esistono pratiche universalmente condivise, ma ci
sono un po’ di approcci consigliabili. Spesso si lascia agli attori un po’ di
tempo da soli, perché possano dirsi delle cose, rompere la tensione e
concentrarsi meglio. Quasi sempre, soprattutto in anni recenti, si fa in modo
che durante le riprese siano presenti solo le persone strettamente
indispensabili: gli attori, ovviamente, e poi il regista, il cameraman (due, in
certi casi), il fonico e pochi altri (che se non sono indispensabili, nel
momento della ripresa vera e propria a volte si girano dall’altra parte). Anche
nel caso di grandi produzioni, difficilmente una scena di sesso richiede più di
dieci persone oltre agli attori impegnati nella scena. Insomma, si fa il
possibile per garantire un po’ di privacy agli attori (fare finta di fare sesso
mezzi nudi con trenta sconosciuti che ti osservano a braccia conserte non è
facile) ma soprattutto per limitare al massimo la possibilità che qualcuno possa
registrare immagini o video degli attori, per poi diffonderle illegalmente.
Qualcuno ha anche raccontato di volte in cui, per mettere un po’ più a loro agio
gli attori, tutte le persone presenti al momento della scena sono rimaste in
mutande. A un certo punto, quando tutti i non-indispensabili sono andati a
prendersi un caffè e il regista è magari rimasto in mutande, la scena si gira.
Gli attori fanno sesso
davvero? No, ovviamente. È cinema, non porno. Ci sono alcuni casi di film non
considerati pornografici che contengono penetrazioni o veri atti sessuali, ma
sono davvero rari. Ci sono poi casi in cui “si dice” (senza nessuna conferma o
prova) che gli attori abbiano davvero fatto sesso durante quelle scene. È
impossibile dire se sia vero o no: a seconda dei casi sono leggende
metropolitane o voci messe in giro per far risultare un film più “vero” o
“scandaloso”. Bisogna dire poi che, anche se un film dovesse davvero contenere
del sesso, sarebbe nell’interesse di chi lo promuove non dirlo con certezza,
perché porterebbe a un rischio di censura. Uno dei “si dice” più noti riguarda
la scena di sesso tra Richard Gere e Debra Winger in Ufficiale gentiluomo ma,
appunto, è un “si dice”.
Gli attori sono nudi? Quasi
mai. Innanzitutto perché raramente è previsto che li si veda del tutto nudi,
soprattutto nel caso degli attori maschi. Quando non sono nudi, gli attori
indossano normali mutande, e a volte persino pantaloni (le gambe spesso non si
vedono) o mutande color carne (poi si può comunque sempre sistemare tutto in
post-produzione). Ci sono però casi in cui le scene di sesso richiedono che ci
sia uno stretto contatto fisico tra gli attori. In quel caso gli attori
indossano quello che nel gergo di Hollywood è noto come cock sock, un calzino
copri-pene. Ci sono vari modelli di calzino copri-pene, e in realtà il nome è in
parte fuorviante: è fatto perché ci possa finire dentro anche lo scroto. I cock
sock in genere hanno una corda per fare un nodo che tenga il tutto
sufficientemente al chiuso. Per le attrici esistono invece dei relativamente
semplici adesivi per coprire i capezzoli e quelli che, sempre a Hollywood, sono
noti come snatch patch, un adesivo da mettere tra le gambe per coprire la vagina
ed evitare indesiderati contatti con organi sessuali di altri attori o attrici.
Ci sono anche casi in cui le attrici hanno indossato parrucche pubiche
(o merkin). Iniziarono a usarle nel Medioevo le prostitute, a volte per coprire
i segni di certe malattie. Kate Winslet ha detto di averne usata una per The
Reader, perché il film e l’ambientazione richiedevano la presenza di peli pubici
e, dopo anni di depilazione, sarebbe stato difficile ottenere un risultato
simile senza parrucca pubica. Poi, come sa chi ricorda la storia di John e Judy
in Love Actually, esistono le controfigure. Si dice che in molte scene di 9
settimane e ½ ci sia una controfigura di Kim Basinger. E ci sono dei casi in cui
gli attori, di solito dopo aver messo mutande color carne, usano delle protesi:
succede quando un pene si deve vedere ma non si vuole che quel pene sia quello
dell’attore. Sono state usate protesi in Nymphomaniac, il film di Lars Von Trier
che è anche uno di quei film in cui c’è del vero sesso. Ma è meno facile di come
pensiate. La produttrice Louise Vesth spiegò: «Abbiamo ripreso gli attori che
fingevano di fare sesso e poi le controfigure che facevano davvero sesso, e in
post-produzione abbiamo unito le cose. Quindi: dalla vita in su sono gli attori;
dalla vita in giù sono le controfigure». Anche nelle grandi produzioni, a volte
le soluzioni sono molto più semplici: per risolvere contatti indesiderati a
volte basta per esempio un cuscino messo nel punto giusto tra i due corpi. Per
il sudore, ogni set fa storia a sé, e dipende anche dal tipo di sudore che si
vuole ottenere.
Come si decide cosa usare e
come fare?
Come nel sesso vero, il
principio di base è non fare niente che metta a disagio l’altra persona (o le
altre persone). In genere se ne parla con gli attori e si cerca di fare in modo
che ognuno sia a proprio agio e faccia il possibile per mettere i colleghi a
loro agio. Attori e attrici hanno contratti molto dettagliati che prevedono cosa
devono fare e cosa no, e in genere i registi non dovrebbero forzare nulla: ma ci
sono storie di registi particolarmente insistenti, di attori o attrici che si
sono trovati a disagio o di attori e attrici che dicono di aver improvvisato e
di essersi invece trovati bene. Ovviamente, poi, già è strano girare scene di
sesso piacevole, gioioso e consenziente. Tutto diventa decisamente più
complicato quando sono scene che contengono una qualche forma di violenza.
Prima di girare la scena, la
si prova? Esistono resoconti molto diversi fra loro. Qualcuno dice che è meglio
provare e riprovare (anche vestiti e senza contatto fisico), per evitare che uno
degli attori faccia qualcosa che possa risultare sgradevole o fastidioso ad
altri. Esistono anche persone che si sono specializzate nella coreografia delle
scene di sesso nel cinema e in tv, e nella consulenza agli attori: si sa che ci
sono stati coreografi del sesso in Westworld e in The Wolf of Wall Street, per
esempio. Qualcuno ritiene invece che sia meglio lasciare che gli attori possano
improvvisare: il regista e produttore Judd Apatow dice di preferire questo
secondo approccio perché «se viene provato e riprovato, oppure troppo pensato,
alla fine sembra un brutto porno soft-core proiettato su un grande schermo».
Alcuni attori hanno detto che a volte bere un po’ aiuta a rilassarsi e lasciarsi
andare il giusto: Adrian Lyne – regista di 9 settimane e ½ , Proposta indecente,
Lolita e Allucinazione perversa – ha detto che è capitato che prima delle scene
di sesso di Attrazione fatale Michael Douglas e Glenn Close bevessero «champagne
e margarita».
Come viene girata,
tecnicamente, la scena? Qualche regista usa una sola cinepresa, per evitare di
essere troppo invasivo con gli attori. Altri ne usano due: in questo caso il
vantaggio è che la stessa cosa può esser ripresa da due punti, riducendo la
necessità di dover fare più e più volte la stessa scena. Come quasi sempre nel
cinema, pochi secondi sullo schermo corrispondono a ore e ore di ripresa, e
magari decine di riprese della stessa scena: tutto questo rende i “si dice”
effettivamente improbabili. Seamus McGarvey, direttore della fotografia
di Cinquanta sfumature di grigio, ha detto che per alcune scene di quel film si
scelse, in certi casi, di usare cineprese controllate a distanza, per lasciare
soli gli attori. È probabile che durante ogni scena di sesso ci sia, accanto al
letto, il regista che dice “adesso girati di qui”, “fai questo”, “guardala
intensamente” e così via. È anche probabile che, con tante luci puntate addosso,
magari sotto qualche coperta, faccia piuttosto caldo. Se sono nudi o quasi,
finita la scena gli attori trovano in genere qualcuno che li attende con
pantofole e accappatoio, da indossare per tornare in camerino.
Le eventuali erezioni sono un
problema? I resoconti e le interviste dicono che, nella maggior parte dei casi,
gli attori non hanno erezioni. Ma ovviamente è una cosa che può
succedere. Jean-Marc Vallée – regista di Wild, Dallas Buyers Club e Big Little
Lies – ha detto di non aver mai visto un attore con un’erezione, ma che non vuol
dire che non abbia mai visto un attore eccitato: «È tutto molto tecnico, ma
siamo umani e sono nudi, e si toccano». Sean Connery raccontò che prima delle
scene di sesso era solito dire alle attrici: «Scusa se mi ecciterò, e scusa se
non mi ecciterò». Seth Rogen raccontò di aver sentito un’intervista in cui
Connery ne parlava e di averla detta a sua volta sul set di un film: spiegò però
che se non sei Sean Connery non suona così bene.
Cosa ne pensano gli attori e
le attrici? Molti attori e attrici hanno detto di sentirsi piuttosto a disagio,
durante le scene di sesso. Hugh Grant invece ha detto: «Mi sono sempre piaciute,
anche se forse dovrei dire di no. La risposta-tipo è “Oh, non è sensuale con
tutti quei tizi che ti fissano”. Io le ho sempre trovate molto eccitanti». Lena
Dunham ha detto: «Non capisco quando dicono che è una cosa meccanica e fredda. È
come se qualcuno stesse facendo sesso con te. È una cosa che ti confonde».
Secondo Michael Shannon il sesso finto nei film è «come il vero sesso, ma senza
il piacere. C’è tutto il resto: l’orrore, la paura, l’ansia, la tristezza e la
solitudine».
I contratti, dicevamo. Ne ha
parlato di recente Hollywood Reporter, spiegando che dopo il caso Weinstein e
tutte le sue conseguenze le cose sono un po’ cambiate. «Ora viene richiesto meno
nudo», ha detto l’avvocato Jamie Feldman, che si occupa di contratti di attori e
attrici: «Le persone stanno più attente a questi temi, a come formulano le loro
richieste e a come ogni cosa può essere percepita».
Feldman ha spiegato che
esistono delle specifiche clausole contrattuali relative alle scene di sesso. Si
chiamano nudity rider e sono molto dettagliate. I nudity rider possono parlare
del colore degli adesivi copri-capezzolo, del numero massimo di persone
consentite sul set durante le riprese di certe scene, o (con molto dettaglio)
delle parti di corpo visibili. Queste clausole regolano anche le scene girate
con controfigure, visto che agli occhi degli spettatori quelle che vedono non
sono controfigure. Sta agli attori decidere cosa vogliono, e sta ai loro agenti
riuscire a imporre ogni loro richiesta. Già dai tempi di Sex and the City, per
esempio, Sarah Jessica Parker chiede una clausola che le permette di non
comparire nuda: «Alcune persone fanno richieste peculiari, come una stanza
d’albergo piena di candele di un solo colore. Io non faccio richieste strane. Ho
solo questa, sulla nudità». Certi contratti prevedono anche che attori e attrici
possano avere il pieno controllo e l’eventuale diritto di veto sulle loro scene
di sesso o nudo. Si dice ce l’abbiano per esempio Emilia Clarke per Game of
Thrones e Elisabeth Moss per The Handmaid’s Tale. I nudity rider prevedono anche
indicazioni su cosa fare delle scene girate ma non inserite nel film, che si
cerca di eliminare.
Perché si fa tutto questo?
Nella grandissima parte dei film, le scene di sesso sono strumenti: servono per
dire allo spettatore che “tra questi personaggi, succede questa cosa”. Per
questo spesso basta suggerire il tutto (vediamo due che si baciano e iniziano a
spogliarsi, e poi, dopo un taglio, li vediamo abbracciati nel letto la mattina
dopo). Quando vediamo il sesso nei film, spesso non si va oltre quelle che
Richard Brody definì sul New Yorker «le abitudinarie convenzioni pneumatiche
fatte da contorsioni e sospiri». Si dice che scrivere di sesso sia tra le cose
più difficili per uno scrittore, perché si deve evitare sia il ridicolo che il
volgare: probabilmente è lo stesso per il cinema. Alcuni tra i migliori registi
e attori ci riescono; molti altri no. Comunque, più di tutto e nonostante le
loro difficoltà, le scene di sesso ci sono perché, come si dice, «sex sells»: il
sesso fa vendere.
DA leggo.it il 30 agosto 2021.
Un maxi-risarcimento da 30mila dollari, pari a 25 mila euro, per aver gettato
una collezione di riviste e film di genere porno del figlio. È la sentenza del
giudice distrettuale Paul Maloney, magistrato del Michigan (USA) arrivata dopo
che il 43enne David Werking aveva vinto la causa contro i suoi genitori. I
genitori dell'uomo dovranno anche pagare 14 mila dollari di spese processuali.
Il giudice aveva richiesto una perizia per stimare il valore della collezione
porno gettata via. David era tornato a vivere a casa dei genitori per 10 mesi,
dopo aver divorziato, quando ha scoperto che le scatole della sua collezione di
materiale pornografico erano state buttate via. «Francamente, David, ti ho fatto
un gran favore a liberarti di quella roba»: le parole del padre in una mail al
figlio, dove ha spiegato di aver agito in qualità di proprietario di casa del
figlio. Ma David, non curante delle loro giustificazioni, ha trascinato i
genitori in tribunale, sostenendo che non avevano il diritto di disporre di suoi
beni.
Barbara Costa per Dagospia il 14 agosto 2021. Dove
hai pornato a Ferragosto? Mare o montagna? L’hai fatto a due, a tre o in una
pazza ammucchiata? Se è stato una delusione, una noia mortale, e tu sei una
persona che trova irresistibile rotolarsi sull’erba, e ti ecciti alla vista
della sabbia bagnata, appiccicata sulla pelle abbronzata, gocciolante, che
sembra spermata, i siti porno hanno quello che fa per te: "sex on the beach",
"mountain sex videos", "beach videos", sono queste le categorie che racchiudono
i porno giusti e roventi da sbirciare dal tuo smartphone. Gli incastri più
indecenti, le pratiche più sadomaso, tutto quello che ti piace e ti accende
viziose fantasie, indurendoti piacevoli "vette", lo trovi anche in versione
estiva. I summer porn videos si dividono massimamente in due varianti: amatorial
e no. Infatti, giù la maschera: niente è più amatorial e voyeuristico che
sc*pare e farlo in spiaggia davanti agli altri. Siti porno e non solo, d’estate
si riempiono di video di gente che sfoga e gode di travolgenti libidini in
spiagge "alternative", dove tutto è concesso per chi vuole e con chi. E non solo
gli amatorial, ma anche le vere pornostar sanno come "sporcarsi" su sabbie
dorate e sfrenarsi in amplessi porno-basici. E che c’è di più porno basico di
una maratona di fellatio in spiaggia? Qui uno dei lavori più "afosi" è un beach
porn di Angela White, girato su una spiaggia australiana e in POV amatorial:
Angela sfoggia le sue tettone in primo piano, vi ci passa in mezzo il pene del
fortunato di fronte a lei, mettendoselo tutto e più volte in bocca. Poi si
ferma, apre le gambe, scosta il triangolino verde del suo slip, vi infila le
dita insalivate e passa a mostrarti come sa godere da sola. E quando a te sembra
di non farcela più, ecco che si riprende quel pene, per porno-stordirlo con le
sue mani e la sua bocca. Se non sai resistere, se giudichi un delitto mollare le
tue porno abitudini perché sei in vacanza con la tua metà, e non hai certo
chiuso per ferie i tuoi svaghi onanistici, allora cerca la tua pornostar
preferita in versione porno-summer: e qui rifatti gli occhi insieme a me con la
nostra Valentina Nappi nel suo beach porn con Chris Diamond. Qui Valentina è in
spiaggia, in bikini, (almeno all’inizio) e se la spassa come porno le pare. Non
c’è sconcezza che non si conceda, il suo corpo meraviglioso è padrone di ogni
amplesso e di ogni posizione, è questo uno tra i suoi porno più "umidi",
grondante sperma e orgasmi. Dagli un’occhiata, e mi darai ragione. Se però credi
che il solleone propizi depravati intermezzi lesbo, goditi Asa Akira, il suo
corpo infangato e affamato di sesso in "A Day of Fun at the Beach": qui Asa
Akira e Kerry Louise sono insaziabili, sia nel foursome, sia nei brevi ma
incandescenti allacci a due. E per le signore? Non è mia intenzione lasciare
nessuna Dago-lettrice a porno-bocca asciutta. Mie care, non credo rimarrete
deluse da "Slutty Girls Love Rocco #4", un threesome girato da Rocco Siffredi in
beach porn, dove il nostro immortale stallone sottomette alle sue sudicie voglie
due bambolone, e con loro si esibisce all’aperto, su un molo, in uno scenario
esotico. E non vanno sottovalutati i porno di Siffredi girati in piscina, sui
lettini della sua Academy. Se infatti il tuo fine-agosto non prevede né
montagna né mare, ma il sollazzo di una piscina, allora tra i "pool porn" ti
segnalo quello – coreografato – con Jana Cove e Tanya James, due bionde sirene
infoiate. Non solo in piscina, ma è in barca che Tori Black si è fatta pornare
più volte, e da più maschi alla volta: gustatela in uno dei suoi "boat porn".
Peccato sia illegale girare porno nei musei e nei luoghi d’arte, altrimenti
avremmo fantastici porno culturali. Tuttavia, gli intellettuali pip*aroli
possono rimediare con gli amatorial in materia, cioè con quei video di persone
comuni arse dalla voglia di farlo nelle tradizionali mete d’arte agostane. I
siti porno sono invasi da tali intriganti e vietatissime performance…! E ci sono
pornostar che si spogliano e si toccano in video dei loro porno giri
"culturali", postati nei loro canali porno privati. Non terminare le tue vacanze
senza dare un’occhiata ai summer porn vintage: qui la fa da padrona la
bombastica Jenna Jameson, i suoi beach porn lo faranno venir duro – nel mio caso
umida – in eterno. A mio parere bastano i suoi shooting di nudo in spiaggia, per
iniziare a porno-sudare! E affinché la tua lussuria estiva non si chiuda senza
porno-romanticismo, clicca su "Outdoor Romance Leads to Hot Fuck", un porno
chic, dove si sc*pa di sera, su un terrazzo, in doggy-style, su un enorme divano
bianco. Un porno coi fuochi d’artificio assicurati. Lo guardi e quasi ti
dimentichi che anche questo Ferragosto è passato, e con lui tra poco pure le
ferie!
Barbara Costa per Dagospia il 14 agosto 2021. Cosa
fa più rosicare? Quello che una persona ottiene e tu no. Nel porno si rosica,
tanto e spesso, la rivalità tra pornostar è atroce, l’antagonismo asfissiante. E
vendicativo. Senti che è successo a Dave Rock, padre padrone di "Motley Models",
agenzia di attrici porno autorevole e rinomata: in pieno boom metooista, è stato
denunciato – via social – di aver fatto sesso non consensuale con una delle
modelle prese in agenzia. Dave si è immediatamente attivato, opponendo la sua
versione, ovvero che il sesso sì c’era stato, due volte e consensualissimo, e
che la falsa accusa è frutto e vendetta della mancata riuscita della fanciulla
nel porno. In poche parole: la ragazza pensava che, dandola a un boss, avrebbe
ottenuto corsie preferenziali, gloria e fama facili, alla faccia delle altre,
che sul set a pornare si fanno il mazzo. Ma nel porno non funziona così, tu puoi
andare a letto con agenti, produttori, e chiunque detenga una carica (che negli
ultimi anni è sempre meno un uomo etero) e quella persona può pure
raccomandarti, ma se poi tu, sul set, sei una frana in azione, chi ci sa fare ed
è più brava di te (e neanche l’ha data), passa, e va avanti. E tu no. Questo
spiacevole episodio, non so se carico di derive giudiziarie, ha portato Dave
Rock a cambiare le regole della sua agenzia: se prima, eventuali liberi e
consensuali rapporti sessuali tra attrici porno e chiunque a Motley Models ha un
ruolo (capo, manager, fotografo) non erano sanzionati, ché erano nient’altro che
affari privati tra due persone, oggi sono vietati, e chi viene beccato col
pisello o la vagina "in flagranza", viene cacciato. La sua Motley Models ha 11
anni, gestisce un parco di 45 elementi, e la metà sono le ragazze del porno che
più ammiriamo. Motley Models è l’agenzia di Scarlit Scandal, Oscar New Starlet
2021, e anzitutto di Emily Willis, l’argentina che quest’anno si è portata a
casa 9 Oscar, tra cui quello di Migliore Attrice. Per questo c’è fila e bava per
entrare in Motley. E però, è un fatto: spesso è Motley Models che ti nota e
chiama. È quello che quest’anno è successo a Freya Parker, di Fort Collins,
Colorado, che, causa pandemia, ha perso il posto da impiegata e ha iniziato a
esibirsi su MyFreeCams e OnlyFans: in breve, via Instagram, è stata chiamata e
presa in Motley Models. Perché a Motley monitorano e tanto i social, con estrema
attenzione seguono come vi lavorano le ragazze comuni, per individuare quelle
che, spiega Dave Rock, “hanno l’it”: quella scintilla, quel fattore in più, che
può farle elevare nel porno. Nel caso di Freya Parker l’it è la sua pelle,
lucente, nemmeno una lieve screziatura, anche se a Motley e nel porno tutto
esser belle conta fino a un certo punto: Motley Models dà due/tre settimane per
far capire a ogni ragazza come funziona e se a fare porno si sente e trova a suo
agio. Oggi in Motley devi imparare a recitare, abbandonare l’accento natio,
lavorare sui social secondo le leggi dei social per vendere il "prodotto porno"
che sei. Ognuna deve adottare uno stile di vita sano, e dotarsi di una
professionalità e serietà sconosciute a gran parte delle 20enni. Il porno non dà
tempo: o maturi subito, o te ne torni a casa: “Devi avere la pelle dura”,
ammette Charly Summer, 25enne di Boca Raton, Florida, “e metterti in testa che
ti giudicheranno costantemente”, dentro e fuori dal porno. E non solo. “Una
volta dentro questo business”, continua Charly, “devi mostrarti responsabile.
Arrivare puntuali e pronte sui set, con il copione memorizzato, è il minimo.
Devi imparare a stare e confrontarti con persone molto più grandi di te.
Imparare a gestire i tuoi guadagni. Pagare le tasse. Decidere e fare tutto da
sola”. Charly Summer è stata notata e chiamata in Motley per i suoi show hot su
siti di camming. Diplomata, un lavoro part-time in un centro commerciale
(vendeva noci), Charly proviene da una famiglia cattolica conservatrice, e ha
avuto due fidanzati con cui ha fatto sesso prima del porno. Poca esperienza che
non ha inficiato la sua performance con Dredd, pornostar super-stallone dal pene
+30 cm. Se non ha "l’it" Charly! Sul rosicamento nel porno ha qualcosa da dire
Kenzie Anne, 28 anni, californiana, arrivata a marzo a Motley Models e già in
pista, cioè sul set a sc*pare, coi migliori: “Ho fatto la modella per 10 anni,
senza brillare. Ho iniziato a esibirmi in cam per pagare 100 mila dollari di
debiti, senza però far vedere il mio viso. Ho capito che col mio corpo che fa
sesso e lo mostra posso ricavare più soldi di un lavoro cosiddetto rispettabile.
A Motley mi trovo bene, ma il porno è un’industria dispettosa: io sento i
brontolii di invidia intorno a me”. Kenzie Anne, in una manciata di mesi, ha
raggiunto un livello che altre sognano. Per mantenerlo, meglio si guardi dalla
22enne Lily Larimar che, stufa di fare la commessa da Victoria’s Secret, via
social ha fissato un colloquio con Motley Models, lasciando Pittsburgh “con due
valigie, i miei due gatti, e 100 follower su Twitter. Arrivata a Los Angeles, ho
incontrato subito Dave, e dopo 10 giorni ero sul set a girare la mia prima
scena”. È stata ferma 4 mesi con gli studios chiusi per pandemia, per riprendere
questa primavera, sommando 60 scene: “Non ho chissà che aspettative, ma voglio
farlo ora, provarci ora, che sono giovane”. Al suo opposto c’è Coco Lovelock,
20enne cresciuta col mito delle cam-girl e intenzionata a diventare “la più
grande pornostar di tutti i tempi: io prima lavoravo in un fast-food, ma il
porno è il mio presente, e il mio grande futuro”. In questi mesi ha lavorato con
i più forti nomi del settore, il suo porno fetish di dominazione girato con la
superstar Kendra James fa views da capogiro. A differenza delle pornostar del
passato, Coco ha detto a tutti di avere scelto il porno, a cominciare dai suoi
genitori (“non erano contenti all’inizio, ma si stanno abituando all’idea”),
mentre i suoi amici e coetanei non ci trovano niente di male. Al contrario, la
madre di Kylie Rocket, pornostar latina da due anni a Motley, ha saputo cosa fa
la figlia tramite un’azione bizzarra: siccome Kylie era andata a letto col
ragazzo della sua migliore amica, questa qui, incaz*ata nera, si è presentata a
casa Rocket e ha fatto vedere alla mamma di Kylie i video di sua figlia in rete:
“Ma mia madre mi ha difeso e ha detto che posso fare quello che voglio”, rivela
Kylie. Ma sua madre si fa forte dell’altra sua figlia, la gemella di Kylie che,
seppur dotata del medesimo corpo e forme, a quanto pare non è intenzionata a
seguire la sorella, mettendosi in invidiosa competizione. Per ora.
Maurizio Di Fazio per il "Fatto quotidiano" il 6
agosto 2021. Breve video, "Quando esco con gli short e non mi fanno catcalling",
ed esulta, come se avesse appena vinto alle Olimpiadi. Ecco la sua recensione di
sex toys d'ultimissima generazione. Si mette a perorare la causa della
masturbazione femminile, e a mo' di claim: "Vengo anch' io, sì tu sì". Poi
rivela: "Ho smesso di guardare porno per un mese e vi racconto com' è andata".
Oppure: "Perché esordire con una “dick pic” in chat non è una buona idea. Cosa
spinge alcuni uomini a inviare selfie dei loro genitali?". Tei Giunta ha 33
anni, una laurea in Cinema al Dams di Bologna, vive a Urbino ed è tra le prime
sex influencer italiane ed europee. "Cerco di influenzare davvero le persone sul
loro modo di vivere la sessualità" ci dice. La sua avventura è cominciata da
poco, in primavera quando ha aperto il blog OhMyTei! e, a seguire, una pagina
Instagram molto seguita e una rubrica il giovedì mattina su Radio Deejay, nel
programma di Andrea Marchesi e Michele Mainardi. Ma la durata non è tutto, in
certe cose, si sa; conta l'intensità con cui racconta e interagisce su tematiche
ancora divisive o tabù. Istanze Lgbt, superamento degli stereotipi, conoscenza
del proprio corpo, educazione all'emotività. Per un sesso consapevole, inclusivo
e positivo. Sempre con leggerezza "e un tono di voce ironico e diretto":
l'ironia può più di mille simposi. E le dimensioni non sono fondamentali. Se
capita un mini-dotato, è facile bypassare il problema. Come? Tracciando una di
queste posizioni: "gambe in alto", "la montagna" e "cowgirl reverse". Tei le
mima tutte e tre, giocondamente. E quando è l'uomo a non avere voglia, "Maschio
Alfa ca**o duro sempre... o forse no?". Bando a ogni psicodramma latente: Tei
snocciolale ragioni a nostra discolpa eventuale. È il momento di una guida al
sesso anale "in nove passi"; al poliamore (dalla "triade al quad, dal polycule
al tavolo da cucina poliamoroso"); allo squirting ("lo spruzzo diventa
accessibile a tutti!"). Uno sguardo alle fantasie erotiche maschili e femminili,
anche le più indicibili, "le mie risalgono a quando, da bambina, vedevo Sailor
Moon". E "sì, mi considero una femminista. Il femminismo di oggi è per tutti. Si
basa sulla parità, non sulla superiorità di un genere rispetto a un altro". Che
poi non dovrebbero esistere più "brave ragazze o ragazzi", ma solo persone
evolute e libere, sui social e offline. C'erano una volta le domande a Cioè...
Da calciomercato.com il 4
agosto 2021. In principio fu l'Eurovision vinto dai Maneskin, poi Euro 2020 con
l'Italia di Mancini, ora un bel medagliere alle Olimpiadi. Ma non è finita.
Perché c'è un altro mondo parallelo, quello del cinema hard, dove l'Italia sta
vivendo un momento d'oro: per la prima volta nella storia, ci sono 3 italiane
nella top 100 di Pornhub. Tra le più popolari al mondo, quindi, tre Azzurre:
Danika Mori, Valentina Nappi e Martina Smeraldi. Un nuovo tridente italiano.
Dagotraduzione dal Sun il 3
agosto 2021. Nandita Dutta, 30 anni, star del cinema per adulti, è stata
accusata dalla polizia di aver adescato giovani donne inducendole a girare film
pornografici con la promessa di una carriera da attrice a Bollywood. Ad accusare
la donna sono state due modelle: la prima ha sostenuto di essere stata costretta
a girare un video per adulti in un hotel di New Town, a Calcutta in India;
l’altra ha parlato di un servizio fotografico nudo in uno studio a Ballygunge.
Il Times of India ha raccontato che ad entrambe Dutta ha promesso una brillante
carriera. Dutta, che ha 119.000 follower su Instagram e si fa chiamare Nancy
Bhabhi, è stata arrestata nella sua casa di Dum Dum. Anche il suo socio Mainak
Ghosh, 39 anni, è stato arrestato a Naktala per il suo coinvolgimento nella
presunta coercizione. Entrambi sono stati accusati in base a sette reati del
codice penale indiano, inclusa l'aggressione o l'uso della forza criminale a
qualsiasi donna o il favoreggiamento di tale atto con l'intenzione di spogliarla
o costringerla a essere nuda. Sono comparsi davanti a un tribunale la scorsa
settimana e sono stati rinviati in giudizio e affidati alla custodia della
polizia. Un portavoce del commissariato di Bidhannagar ha dichiarato: «Li
interrogheremo per scoprire i loro complici e conosceremo anche altri luoghi in
cui hanno condotto le riprese. Gli domanderemo anche se vendevano video e se
facevano parte di un racket porno più grande». I poliziotti stanno indagando su
un caso simile che coinvolge il marito della star di Bollywood Shilpa Shetty,
accusato di aver realizzato e distribuito film illegali con classificazione X.
Raj Kundra è stato arrestato con l'accusa di aver indotto una donna a girare un
film per adulti con la promessa di un lavoro da attore. E la star del cinema
indiano Sherlyn Chopra ha accusato Kundra di aggressione sessuale nel 2019. Sua
moglie Shilpa è diventata famosa in Gran Bretagna durante la serie del 2007 di
Celebrity Big Brother che ha vinto.
Barbara Costa per Dagospia l'1 agosto 2021. “Per
chi avete consumato più sperma?”. Tanti auguri (in ritardo, accidenti!) a
"Superzeta", il forum sulla pornografia più longevo e famoso d’Italia. Come, non
lo conoscete? Non ci siete mai entrati? Neanche un giretto esterno? Bugiardi,
non vi credo! Superzeta è il forum dei forum, nato 20 anni fa, quando i forum
poco c’erano, e non c’erano Facebook, YouTube, Twitter, figurarsi Instagram e
TikTok, c’era sì Google ma da soli 2 anni, e se lì sopra vi cliccavi "porno",
usciva pure Superzeta, e il porno che Superzeta spiega e dispiega, producendone
un’enciclopedia dal basso democratica e sagace. Porno di tutti i generi, e modi,
e tempi: punto di porno battaglia di Superzeta è "Ifix Tcen Tcen", l’urlo
orgasmante del mitico pornostar francese Gabriel Pontello, urlo che esplodeva su
"Supersex", fotoromanzo porno del porno cartaceo che fu. E se di Pontello e
Supersex non ne sai, te lo dice Superzeta chi è, come e perché! Superzeta nasce
dalla mente di un ignoto giornalista di Milano “a stretto contatto col mondo del
porno per motivi ludici e professionali”. A lui il merito di aver dato uno
spazio agli italiani pornofili: chiunque può diventar forumista di Superzeta,
ognuno su Superzeta può dire la sua, gratis e liberamente, ma non sono accettati
sicché bannati cretini, moralisti, e irrispettosi. Il sesso nella sua forma
rappresentativa che è la pornografia è il tema principe di Superzeta, in topic
che chiunque può aprire, e vi può entrare, partecipare, discutere, immettere
materiale e dire, dire, dire. E in 20 anni di gloria Superzeta si è ampliato, e
ha divagato su argomenti che partono dal porno e abbracciano attualità e vita,
dalla politica al calcio, dalla TV ai social, e tutto quello che un utente vuole
e sa (o crede di) e si prende la responsabilità di postare. La stessa
pornografia produce topic su topic, aperti e chiusi e poi riaperti da un numero
esorbitante di forumisti, una moltitudine di uomini (e donne) dietro i nickname
aventi vite, e identità e professioni le più varie. Superzeta ha ospitato e
ospita anche chat con protagonisti veri del porno vecchi e nuovi, italiani e
non, e Giorgio Grandi, Axel Braun, Roberto Malone, sono solo parte di una lunga
lista. Se il porno di oggi e attori e attrici porno di oggi sono in trend, e se
Valentina Nappi è superzetizzata fin dai suoi esordi, e fin da allora divide i
forumisti in quanto performer pensante e dicente (vedi il topic "Valentina
Nappi: caz*i e caz*ate"), e vuoi mettere “le p*mpe che tira Malena!”, ed ecco
chi loda Martina Smeraldi “come performer tra le migliori, lei è nata per questo
lavoro”, per essere smentito e/o approvato senza che si giunga a un giudizio
assoluto, perché su Superzeta funziona così, evviva, sono altresì stracult i
topic come quello con cui ho aperto il pezzo: “Su chi hai consumato più sperma?”
dà il via a confessioni sincere e inattese. È questa la forza e il bello di
Superzeta, forum orgoglioso di se stesso e allergico alle imposture: dove mai
c’è chi ti dirà con chi veramente si s*ga, e le sue fantasie più trucide e
legittime? Un editore sveglio e con le p*lle dei post di Superzeta potrebbe
farne un libro: quale miglior ritratto, quale immagine più sincera della società
com’è? E non come si vorrebbe fosse o come i professoroni belano di sapere e
saper spiegare! Vabbè, ma su chi si sono pasticciati tanti italiani? Tantissimi
su Angela Cavagna, e su Sophie Marceau “del tempo delle s*ghe”, su Moana Pozzi,
“e su Sabrina Salerno no!?”. Ecco, Sabrina Salerno, regina di topic mai tradita:
Sabrina è fedelmente seguita, sognata e postata. Diletta Leotta scansate, ogni
divetta odierna impari dalla Sabrinona nazionale, le cui presenze in TV e sui
social fanno scimunire i sensi. Sabrina “partiva già bene, ma con gli anni è
migliorata”, Sabrina “mia compagna di piaceri solitari”, Sabrina che “oggi a 53
anni mi piace di più che a 20, io mi ci s*go sopra di più ora!!”. Un forumista
va all’assalto: “Ma quante p*ppe ci siamo fatti su Boys di Sabrina Salerno!?”,
“Io parecchie!!”, “Io su Boys no, ma su lei 'na cifra!”, “E io comprai
addirittura Sexy Sabrina '88!”. Su Superzeta entrano trafelati utenti che
chiedono la verità sul porno, su quanti e quali hanno recitato le ex showgirl
bombe del sesso, bollori che gelano contro leggende metropolitane. Nessun porno
per la Salerno, nessun porno ma qualche erotico per Carmen Russo, la quale col
nome di Carmen Bizet è nel soft "Le porno killers", uscito in versione hard col
titolo "Le (porno?) salamandre", e film dove mai la Russo fa scene di sesso
esplicito. Film uscito in più versioni, con scene porno aggiunte, dove la Russo
non c’è. Allora, tutti sul topic "Il mistero Carmen Russo": la signora ha oggi
un fisico eccezionale, ma le tette se le è rifatte, sì o no? C’è chi risponde
due volte, chi neanche una e che è eresia pensarlo: “Carmen Russo, mmm che
donna, mito adolescenziale, impossibile dimenticare quel c*lo”, chi però posta
foto prima e dopo, di quei seni diventati “due dirigibiloni”, e chi chiosa con
un bel “ma chi caz*o se ne frega? È una milf da perdere i sensi!”. Se l’ex
pornostar italiano Roberto Malone è da qualche forumista giudicato “un triste
figuro, prestato al porno dall’agricoltura”, e se Jenna Jameson, regina del
porno anni '90, è attaccata per non aver mai fatto porno estremo, “è una
pornostar per famiglie”, tra le più bersagliate c’è lei, Selen, ex pornostar tra
le più rimpiante per la sua scelta di smettere, spezzando cuori che si vendicano
con topic quali "Le bugie di Selen". Ma ve la ricordate “in Concetta Licata, con
Ron Jeremy doppiato in un napoletano grezzissimo?”. Non tutti la pensano così:
“Quando faceva porno se la tirava come se facesse Shakespeare al Piccolo Teatro.
Poi si è illusa di diventare una star del piccolo schermo”. Selen “negata per il
facial”, e se c’è chi posta un sacrosanto “bisogna rispettare le scelte di vita
delle persone”, su Superzeta c’è chi non dimentica, fa vedere interviste di
Selen che non vuole parlare del suo passato nel porno e, se costretta, lo
edulcora. Se su Superzeta del porno ci stanno tutti, ci sto pure io, Barbara
Costa di Dagospia. Infatti ci sono forumisti che mi dedicano la loro attenzione,
leggendo e linkando e commentando i miei pezzi. E io però sono “antipatica”,
“una delle cose peggiori di Dagospia”, perché sul porno scrivo “un sacco
d’insulsaggini, se venisse qui la faremmo a pezzi”. Peccato. Caro Superzeta,
altri 20 anni e più di porno forum. Auguri. Anche da me. Col dito medio
alzato.
Barbara Costa per Dagospia il 22 luglio 2021.
Dahlia Sky. Jake Adams. Dakota Skye. Il porno uccide? No. Se non nella misura
del giudizio che da fuori gli si dà. Nel porno si muore, anche per suicidio,
come si può morire in ogni altro ambiente, solo che quando qualcuno si ammazza
nel porno tali tragiche notizie vengono usate dai media secondo la loro imposta
narrazione che serve a puntare il dito contro un settore bollato come il male,
da contrapporre a chi nella vita fa altro sicché fa il bene. La decisione di
porre fine alla propria vita da parte di un attore porno va giudicata – qualora
la si voglia giudicare – quale decisione ultima, definitiva ma personale di una
singola psiche sconquassata da problemi privati empaticamente impossibili da
condividere. Così è fuori luogo il clamore che si è fatto intorno al suicidio di
Dahlia Sky, attrice porno morta il 30 giugno: questa 31enne si è sparata un
colpo di fucile, nella sua macchina, in California, in San Fernando Valley.
Dahlia era nel porno da 10 anni, mieteva successi, e era una ragazza sfortunata
che lottava contro un cancro al seno con metastasi di quarto stadio. Non lo
sopportava più, non ha visto vie d’uscita, e si è tolta la vita. La sua è stata
presenza porno sfolgorante, con decine di nomination agli Oscar per 600 film tra
cui spiccano quelli con Rocco Siffredi ("Rocco’s Coming in America"), Axel Braun
(porn-parody di Star Trek, e Terminator), Manuel Ferrara ("Bailey Blue Wide
Open"). Fonti giornalistiche rilevano che era in povertà. Con quello che costa
curarsi in America, c’è niente da stupirsi se aveva finito i soldi. Era una
senzatetto? Vi sono foto social recenti di lei che distribuisce cibo ai poveri
davanti ai centri di assistenza. La tragedia di Dahlia Sky c’entra nulla con il
presunto squallore che i media additano al porno. Come nulla c’entra la morte
del regista e attore Jake Adams, perito in un incidente stradale il 14 luglio, a
Los Angeles. La sua moto, sulla superstrada 101, presso Encino, si è scontrata
con altri veicoli, e Jake è morto sul colpo. Aveva 29 anni, era nel porno da 5,
nell’ultimo anno anche da produttore. E sempre nell’ultimo anno il suo nome era
brillato nel gossip porno poiché fidanzato con Scarlit Scandal, la giovane e
promettente vincitrice di premi Oscar 2021, tra cui Best Porno Novità. Seppur da
ultimo gossip in crisi, Jake e Scarlit erano la coppia porno più glamour,
scritturati per girare insieme fetish di dominazione. Jake Adams era un ragazzo
laureato in economia, con un breve passato come gestore di ristoranti prima di
iniziare a uscire con la pornostar Penny Brooks, e con lei e grazie a lei fare
il salto nel porno. La carriera di Jake somma 700 film e 263 milioni di views. I
suoi social sono ora "incantati", eternamente fermi al lancio del suo ultimo
porno del 14 luglio. Rimane invece avvolta nel mistero la morte di Dakota Skye,
pornostar 27enne e da un anno fuori dal porno, trovata senza vita in un camper
il 9 giugno. Si vocifera di overdose da Fentanyl, ma una sua zia su Facebook ha
rivelato che Dakota si è uccisa due anni esatti dopo il suicidio di sua madre.
Dakota era cresciuta con questa sua zia, la sua vera madre era
tossicodipendente. Anche Dakota per un periodo aveva fatto uso di droghe, ma sua
zia attesta che da mesi era pulita, e che il gesto estremo è da mettere in
correlazione a una Dakota da poco mollata da suo marito. Ma c’è pure chi dà la
colpa ai social, a haters perseguitanti Dakota Skye per un suo topless davanti a
un murales in onore di George Floyd. Foto hot postata sui social, e qui
giudicata ferocemente irriguardosa. È corretto e necessario quanto scritto da
Rocco Siffredi nel suo "Sex Lessons": negli ultimi tempi sono in aumento, nel
porno – e non solo – i suicidi scatenati anche dall’odio social. Dalle ferite
che provoca. Dall’incapacità di reagirne. Rocco è nel porno dal 1984 e, nei
primi 30 anni della sua carriera, lui annota il suicidio di 5 colleghi: Pavel,
ceco, per anni porno numero uno, e che un giorno si è sparato un colpo in testa
in un bagno su un set perché era il terzo giorno consecutivo che non riusciva a
ottenere una erezione; la pornostar americana Savannah, che si è uccisa dopo un
incidente d’auto che le aveva sfregiato il viso; la francese Karen Lancaume,
dopo le polemiche scatenate da un suo film; gli americani Jon Dough, dipendente
da droghe, e Cal Jammer, uccisosi per una delusione d’amore. Oggi la media è
salita: a fine 2017 in cronaca sono finiti ben 5 suicidi in 3 mesi, di attrici
che non hanno retto l’odio haters. C’è chi sottovaluta tale pressione, dicendo
che bisogna fregarsene, ma la fa troppo facile. Come ogni persona, chi fa porno
cerca nei social sostegno e approvazione di ciò che fa. Ma, coi social, basta un
piccolo errore, una minima caduta, e il fallimento, minimo o grande che sia, è
sotto gli occhi di chiunque, e chiunque si sente autorizzato a dire la sua,
senza appello. Per alcune persone particolarmente fragili, la vergogna e il
senso del ridicolo che si sentono piovere addosso, a valanga, virali, diventano
un macigno impossibile da sostenere. Ha detto Valentina Nappi: “Nel porno non ci
sono più persone instabili e problematiche rispetto a altri settori lavorativi.
Forse è il contrario. Ma la pornostar, con la sua arte, rappresenta il sesso
senza sentimento, e questo è malvisto dalla nostra società, dove vale la regola
che il sesso – specie per le donne – è giusto se è associato all’amore. Di
conseguenza la pornostar è dipinta come una folle, una che ‘per forza’ non sta
bene. E che ha meno diritto di esistere”. E Valentina Nappi ha perfettamente
ragione.
Barbara Costa per Dagospia il 18 luglio 2021. Lei
ha 47 anni, è tailandese, ha (tre?) profili Instagram, da poco è sbarcata su
OnlyFans, e te dice senza mezze parole: lei è lì per te, lei è tanto contenta se
tu la passi a trovare, sui suoi canali social, aperti proprio per te, pensando
soooltanto a te. Tu entra, paga, abbonati, che lei è lì, pronta a farti vedere…
le sue tette! Duang Duen (o Duenn, o Duennn, ma pure Duennnn) è una milf seria
lavoratrice, lei è una "breast creator", cioè una artista-influencer che lavora
tramite i suoi seni che non sono seni normali, sono tettone, enormi, un popputo
rigoglio che sui social fa la sua fortuna. La signora Duen è tra le ultime
arrivate di un esercito di donne che ha invaso i social con i loro esuberanti
davanzali. Donne, ragazze, viste, cercate, amate, pagate per le loro esibizioni
live o per video personalizzati da utenti uomini fuori di testa per le poppe.
Non sto esagerando, basta farsi un giro in rete, tra le pagine che le
raggruppano per taglia, forma, e per fantasia di poppamento, o strusciamento, o
strizzamento. L’orgoglio della zinna grossa ospita solo una parte di
pornostar-influencer, in gran numero sono donne e ragazze comuni che si
esibiscono in pose erotiche: in tantissime si sono buttate poppe in fuori su
OnlyFans sotto pandemia. Un fenomeno che non sembra conoscere requie né confini
o limiti di età, etnia, geografia. Basta qualche clic di seni in posa audace e
ammiccante per ottenere la minima parte di seguito. Per iniziare a scalare la
vetta di fama social tetta dopo tetta, tetta contro tetta. Se queste
star-zinnute non sono pornostar e manco vogliono diventarlo, seguono un po’
tutte lo stesso copione: i loro seni giganteschi sono naturali, e come no, al
cento per cento, tutta madre natura, la chirurgia non c’entra niente, e guai a
contrariarle! Così si fa finta di credergli, è fuor di dubbio che qualcuna di
questi fenomeni delle poppe dica la verità, reduce da uno sviluppo spropositato,
e male non fa a sfruttare tale particolarità per guadagnarci. E molte si
infilano nel politicamente corretto, ergendosi a tette-paladine del body
positive. Senti come te lo spiega la russa Anastasiya Berthier, moscovita 21enne
popputa e risoluta: «Il mio seno è naturale, è diventato grande così nell’estate
dei miei 14 anni. Per il mio fisico ho subito bullismo a scuola, e pressioni
dalla mia famiglia che insisteva io dimagrissi». Anastasiya ha più di un milione
di followers su Instagram, e porta avanti la sua battaglia contro il prototipo
della bellezza russa, bionda e esile: «Per milioni di persone sono io la donna
più desiderabile e perfetta». Anastasiya ci tiene a professarsi artista, lei usa
i social per promuovere le sue creazioni, opere che in pochi si filavano prima
che lei vi postasse accanto il suo petto ipersviluppato. Ma cosa cercano gli
uomini a milioni pazzi delle zinne grosse? Non c’è bisogno di rompere le p*lle a
Freud, te lo svelano senza vergogna che il mito sessuale della donna-mamma
produce le sue erezioni specie se di forme portato all’esasperazione. Sebbene
l’argomento popputo si divida in due schieramenti, gli uomini che amano le tette
grosse e quelli no, i primi che ne esaltano la possibilità di farci s*ghe
spagnole e schizzate di sperma, ai quali i patiti dei seni piccoli oppongono la
difficoltà a godere di grandi capezzoli duri e puntiti, leccornia per lo più
assente nelle tette grosse, i tettofili non disdegnano le siliconate, anzi: come
te la spieghi, infatti, la felicità erettile che provoca la trans, “col suo
pisello, e i suoi popponi?”. I tettofili più fissati li trovi su questa sezione
porno qui: i video delle lotte tra tettone, donne che si sfidano a colpi di
maxi-tetta nel fango, per lo più in massage oliati dove se le sfregano e
succhiano. Se l’abbondanza pettorale ai maschi ispira abbuffate di sesso, per le
donne le tette grosse sono un peso non metaforico: la vita è difficile, irta di
difficoltà. Oltre al ricorso a sarti per abiti e lingerie personalizzata, non
mancano dolori al collo e alla schiena. Per strada le fissano, e molte ragazze
dicono di vergognarsi al mare o in piscina. Seni enormi frutto di più interventi
chirurgici possono richiedere l’innesto di un reggiseno chirurgico interno. E
c’è pure chi soffre di problemi sentimentali per colpa delle tettone. La tedesca
Yvonne Bar, 26 anni, fino a pochi mesi fa lamentava sul "Sun" di non trovare
l’amore, nonostante avesse speso 34.500 euro per rifarsi il corpo, lipofiller e
botox e natiche Kardashian-style, e quattro interventi chirurgici per aumentare
il seno che se non ho misurato male è ora una ottava. Ingrandimento mammario non
ancora finito dacché il pompamento si è arrestato solo causa pandemia. Yvonne
Bar prima lavorava in banca, ora si esibisce su OnlyFans, dove dichiara di
guadagnare di più, e con più soddisfazione. Peccato però che «gli uomini sono
intimiditi dal mio aspetto, sono stufa di uscire con persone così
superficiali». Le pornostar di professione e non, che fino a poco tempo fa, per
farsi un nome, puntavano ogni chance sulle loro tettone vere o rifatte, sono
preoccupate della concorrenza delle breast creator parvenu? Non sembra dato il
riscontro di views e followers che comunque riscuotono: Ana Lorde, il primo nome
che colgo dal mazzo delle bocce, ha 5,7 milioni di followers e non demorde in
cam a sconcezze mammarie, e guarda tette e corpo e video della giapponese Yuu
Sakura: i nipponici smaniano e orgasmano per tettone su corpi e visi imitanti
anime, loliteschi, (a)sessuati, all’occidentale bambolenizzati, manganizzati,
avulsi dalla realtà.
Barbara Costa per Dagospia il 17 luglio 2021.
Rasatela tutta, e passa bene di dietro, tra le natiche: devi essere liscissima.
Sii pulita all’estremo, vestiti semplice. Certo che puoi venire col tuo ragazzo,
o con un amico/a. Non ci sono problemi, puoi pure farti accompagnare da mamma.
Tranquilla, nessuno ci proverà con te. Fidati: il sesso non consensuale, non
girato e non pagato, non è nelle loro regole. Ti faranno domande, vorranno
sapere di te, dei tuoi studi, ti scatteranno delle foto. Vestita e non. Ti
diranno più volte di pensarci bene. Devi volerlo davvero. Anche se lo fai una
sola volta, ragazza, non si torna indietro. Il porno che fai rimane, per sempre,
e tutti lo sapranno e vedranno. Come si entra nel porno, chi chiamare, che mi
fanno, che mi chiedono, sono quesiti legittimi ma se, sul serio, passato il
rischio Covid, vuoi provare ad entrare nel fantastico mondo del porno, ti dico
di toglierti immediatamente dalla testa fantasie di successo e soldi: farcela
nel porno, diventare la nuova Valentina Nappi, è difficilissimo, ci riescono non
in poche ma in pochissime, la stragrande maggioranza gira qualche film, un tot
di scene, anche per studi prestigiosi, e poi, massimo 2 anni… stop, fine.
Sparisce. Non porna più. Premettendo che io qui parlo di come funziona nelle
grandi case di produzione, escludendo il circuito amatorial, ti avverto che il
settore delle pornoattrici è un mulinello, è un ricambio di nomi e corpi
continuo. Sarò cruda: questo è ciò che vuole il mercato, ciò che i boss porno
vogliono, associato al fatto incontestabile che in poche hanno personalità,
cervello e la forza che serve per resistere nel tempo e col tempo, e di andare
avanti in un ambiente dove pesa esternamente la riprovazione sociale e,
internamente, una concorrenza atroce. Bene, fine pistolotto! Allora, dove si
inizia? Cara la mia stellina in cerca di porno, ti indico subito una strada
preferenziale: contatta la Rocco Siffredi Academy (le audizioni riaprono il
2022), tramite il sito, manda le tue foto e, se "colpiscono", sarà l’Academy a
chiamarti. È proprio quello che hanno fatto Valentina Nappi e Malena e tante
altre ma, se pensi che la chiamata di Rocco sia la svolta, frena! Rocco ti
chiama, mica ti ha scelta. In Academy sarà durissima, Rocco è un gentleman
severissimo. Con Rocco studi orale e pratica, ti fai una vera idea di come
funziona davvero il porno, ma non ci sono santi: il porno lo impari facendolo. E
non ti fai nemmeno mezza pornata se non ti fai prima le analisi cliniche di
legge. Il porno di serie A - come l’Academy di Rocco - non si fida delle analisi
che ti porti da casa tua. L’Academy di Siffredi funziona come le grandi case di
produzioni americane. Se vuoi diventare una stella, devi padroneggiare bene
l’inglese, perché il porno business numero 1 è quello negli Stati Uniti. Adesso
tu pensi: ma se arrivo lì, ho svoltato! No, bella, ti sto dicendo che devi
ancora iniziare. Negli States, meglio tu abbia già i contatti con una agenzia
porno, e che ti trovi un agente al top: dopo esserti messa in regola con i loro
test medici (che paghi di tasca tua) sei tu che tramite agente devi a testa
bassa metterti a pornare. Nel porno statunitense niente conta quanto
professionalità e serietà: “Il corpo? Per me conta il 50 per cento”, e qui chi
parla è Mark Spiegler, agente a capo di "Spiegler Girls", agenzia
blasonatissima: chi vi entra, ottiene più chance, sicché, più ingaggi e cachet
notevoli. Per intenderci: è stata una Spiegler Girl Asa Akira, lo sono Angela
White, la nostra Valentina Nappi. Tre star, tre corpi diversissimi l’uno
dall’altro. Ricordati: nel porno non esiste un prototipo di bellezza, puoi
siliconarti tutta e ottenere il nulla. Se sei una tipa sveglia, puoi contattare
Spiegler direttamente dal suo sito, e dal numero di cellulare che lì leggi. Come
dal web puoi contattare agenzie porno USA ed europee che in home-page
specificano che sono alla ricerca di nuovi talenti: hanno una sezione apposita,
con form da compilare e foto da allegare, come ad esempio vedi su "101MOdeling",
e su "Matrix Models". Sorpresa: nel porno ci sono agenzie (come "Erotic Angels")
gestite da donne. Le agenzie USA più importanti sono quelle sui cui siti spicca
la sigla LATATA. Significa che sono le più serie, a diretto contatto con gli
studios i più noti. Sebbene vi siano ottime occasioni di lavoro a Londra,
Parigi, Barcellona, in Europa chi comanda nel porno è Praga, tallonata da
Budapest. Qui, tra le agenzie, "Jul Models" (fondata e diretta da una donna,
l’ex pornostar Juliana Gradi), e "Sandy’s Models". A Praga, "Nikki’s Models",
"Model Mania", "White Models". A Brno, "Vega Agency". Attenta a questo: se sai o
parli/chatti con performer che dicono che hanno iniziato perché erano fidanzati
con attori porno o registi porno… credici: il porno è un mondo piccolo, dove il
passaparola serve, e agisce. Sei entrata a far parte dell’agenzia che volevi?
Non sei ancora arrivata da nessuna parte. Perché nel porno, dopo ogni scena, pur
la più straordinaria, devi ricominciare da capo. Le matricole scelgono cosa
girare (sempre, con consenso verbale e scritto e firmato sui moduli pre-scena,
dove barri cosa vuoi fare e farti fare, e cosa no) ma non i partner con cui
pornare, che spesso sono anagraficamente più grandi. Tu puoi rifiutarti di
girare ogni tipo di scena che non ti va, che non ti senti. Non vantarti di saper
fare una cosa, quando in realtà non ne sei capace. Ti pagano a fine di ogni
scena, il 10 per cento va al tuo agente: se ti chiede di più, sei in mano a un
ladro, mollalo! Se ti forza a girare scene che non ti senti, sei in mano a un
farabutto, molla pure questo! Stai alla larga da chi chiede a te soldi per farti
fare un porno. Le scene soliste e lesbo sono pagate meno di un anal, ancor meno
di anal multipli (che un agente serio, su un set serio, alle esordienti non
fanno fare). Le scene fetish sono ben pagate, ma il fetish è settore di nicchia
dove entrano fior fiori di professionisti. Nel porno le donne hanno paghe più
alte (anche il doppio) rispetto agli uomini. Ma le paghe delle novizie non sono
alte. Nel porno paghe standard non esistono, ogni attrice ha un cachet frutto di
nome, fama, premi vinti, agenzia che la rappresenta. I soldi veri li vedi e li
fai solo se diventi tu un nome. Auguri. Vuoi bypassare agenzia e agenti e
produttori? Apriti un account social tipo OnlyFans, buttati, e porno daje
tutta!!! Se opti per questa strada, i guadagni sono tutti tuoi, tranne la
percentuale che si pappano i proprietari dei social e sappi che quello che ti
arriva sul conto è il netto già tassato. Ci sono altresì pornostar affermati che
contattano via social star in erba per offrir loro di girare scene. Il prezzo lo
stabilite insieme, il frutto va diretto a te, senza intermediari. Anche qui devi
presentare - e esigere, sempre - analisi mediche non anteriori a 14 giorni. Se
fai da sola, fatti furba e registra il tuo nome d’arte e i tuoi domino. Se ti
esibisci in coppia col tuo lui/lei, stendi patti chiari e scritti, così che, se
vi lasciate, i ricavi sono al sicuro. Mi associo a ciò che dicono tutti coloro
che nel porno, sui social e non, sono riusciti a sfondare: trovati un avvocato!
Se fai del porno il tuo lavoro e la tua meta e il tuo scopo di vita, avrai a che
fare con scartoffie, e leggi, e rogne che non ti dico…
Dagotraduzione dal Daily Beast
il 12 luglio 2021. (Questo articolo è stato scritto dalla pornostar Cherie
DeVille). Questa settimana il premio Sex Worker Fearmonger è andato alla blogger
britannica Olivia Petter. Nel suo articolo sulla rivista Glamour, Petter incolpa
i siti pornografici di non mostrare sufficienti video in cui a raggiungere
l’orgasmo sono le donne: un recente studio ha infatti scoperto che solo il 18%
dei migliori video di Pornhub ha per oggetto il piacere delle donne. Ma trarre
conclusioni sull'industria per adulti sulla base di Pornhub è come andare da
Costco, mangiare un campione di insalata di cavolo e affermare che Costco vende
solo insalata di cavolo. Gli omaggi non rappresentano mai un business orientato
al profitto. Se Petter vuole guardare uomini che leccano la fica per 15 minuti,
dovrebbe pagare per il porno. In passato, i siti offrivano film lunghi, ma da
quando Pornhub e altri importanti streamer hanno iniziato a prendere sul serio i
reclami sul copyright, le società trasmettono principalmente clip di film più
importanti. La mancanza di video lunghi è aumentata da quando Pornhub ha vietato
i caricamenti non verificati, ovvero i video caricati da persone che non sono
state in grado di dimostrare la propria identità. Oggi, i professionisti
caricano la maggior parte del porno su Pornhub. Io e i miei colleghi
pubblichiamo su Pornhub solo dopo aver spremuto ogni centesimo che riusciamo a
ricavare da un porno. Ti addebitiamo i nostri migliori contenuti perché il
lavoro sessuale è lavoro e in America vieni pagato per il tuo lavoro. Essere una
pornostar non è una posizione di volontariato. Bellesa, Erika Lust e altre
società porno orientate alle donne creano il tipo di contenuto che Petter
desidera, ma si aspettano che le persone paghino per guardare i loro lunghi
video di mangia-fighe. Vendono video di sesso lesbico realistico, uomini che
fanno sesso orale su donne e intensi orgasmi femminili. Alcune donne acquistano
questi video, così possono guardare gli orgasmi femminili. Se sei disposto ad
acquistare video per adulti, puoi acquistare qualsiasi cosa. Sia che tu stia
cercando di guardare sesso aggressivo, sesso gentile, orale, anale o altro, puoi
trovare tutto. Ma se vuoi qualcosa di nicchia, farai fatica a trovare i video
gratuitamente. Le aziende femministe non possono permettersi di pubblicare clip
gratis perché poche donne comprano porno e questi studi girano video per
guadagnare. Le loro opzioni di guadagno sono scarse perché sono in un'attività
di nicchia. Posso permettermi di pubblicare alcuni omaggi perché migliaia di
uomini comprano il mio porno. Faccio desiderare agli uomini porno di guardare
perché gli uomini spendono miliardi di dollari all'anno in intrattenimento per
adulti. Certo, alcuni uomini vogliono guardare leccare la fica e gli orgasmi
femminili, ma pochi lo fanno e i pornografi rispondono alla domanda. Non abbiamo
deciso che il sesso violento sia il migliore. I clienti lo hanno fatto. Nessuno
nella valle del porno sta protestando sul set, urlando: “Non sto mangiando la
figa davanti alla telecamera! Sono moralmente contrario!” Siamo capitalisti. Se
i consumatori volessero guardare mangiare la figa, starei sdraiata sul mio letto
tutto il giorno, registrando video di uomini che mi mangiano la figa, ma
indovina un po'? Poche donne comprano porno e pochi ragazzi vogliono pagare per
video mangia-fighe! Gli istinti capitalistici dei pornografi sono stati alla
base della nostra industria per decenni. Negli anni '60, Hugh Hefner si rifiutò
di mostrare pube o vagine su Playboy. Bob Guccione ha quindi fondato Penthouse
per mostrare le vagine femminili (o "rosa", come la chiamavano), e ha rubato i
lettori di Playboy. Guccione, tuttavia, si è ben guardato dal mostrare argomenti
tabù. Finché non è entrato Larry Flynt. Pubblicava quasi tutto ciò che gli
uomini desideravano su Hustler. Le vendite di Flynt sono esplose, quindi Playboy
ha iniziato a mostrare le vagine e Guccione ha pubblicato immagini più osé.
Hefner e Guccione hanno cambiato le loro politiche perché è quello che volevano
gli uomini. Il sesso vende e i pornografi creano il tipo di sesso che vende.
Petter si aspetta che altre donne scopino gratis. Il suo punto di vista mi
scoraggia. Uno, ci stereotipa sulla base di uno studio scadente senza condurre
ulteriori ricerche. In secondo luogo, mostra che pensa che il lavoro sessuale
non sia un lavoro meritevole di essere pagato. Ci manca di rispetto, trattandoci
come persone che dovrebbero scopare davanti alla telecamera per il suo
divertimento senza ricevere alcun compenso. Gli uomini possono guardare quello
che vogliono perché lo pagano. Si chiama industria per adulti perché è
un'industria. Pensare di poter ottenere ottimi contenuti gratuitamente è folle.
Il suo peggior reato è che attribuisce a noi la mancanza di piacere femminile.
Tra i cristiani evangelici che cercano di mettere al bando il porno, i
repubblicani dello Utah che cercano di installare bloccanti del porno sui
cellulari e altri attacchi alle prostitute, è più importante che mai per le
donne difendere le prostitute. L'argomento di Petter secondo cui il porno non
mostra il piacere femminile gioca negli stereotipi dell'industria per gli adulti
che la definiscono come sessista e problematica, anche se è uno dei pochi
settori che paga le donne più degli uomini. Gli uomini pagano le donne. Il porno
disponibile sarà disponibile a seconda di chi sarà disposto ad acquistarlo. Se
vuoi cambiare porno, devi pagare per il porno. Se le donne aprono i loro
portafogli ai pornografi, avranno più opzioni porno. Fino ad allora, dovranno
fare i conti con 30 secondi gratuiti di uomini che raggiungono l'orgasmo, e
questo non è un mio problema.
Barbara Costa per Dagospia il
10 luglio 2021. Non è piaciuto, a Massimo Balletti, “giornalista della gnocca”,
il titolo a encomio datogli qui da noi su Dagospia, lui che è stato giornalista,
ma più direttore, della gnocca sì, e meno male che non abbiamo scritto f*ga, per
colui che è uomo d’altri tempi, un signore, un principe, "Il principe
dell’eros", definizione questa sì che gli piace, così tanto che se l’è scelta e
messa a titolo della sua autobiografia. Il principe dell’eros è Massimo
Balletti, colui che è stato per 40 anni a capo dei giornali erotici italiani i
più fulgenti: Men, Playmen, Le Ore, Playboy Italia, Penthouse Italia. Su quali
pagine più scoppianti di corpi discinti misti a cultura il principe Balletti non
ha messo mente e mani!? Sul divorzio che sussiste tra cuore e carne, lui vi ha
regnato e deciso e stampato. Lui, il signore del peccato patinato italiano,
Massimo Balletti, che dalla donna sublimata e elevata, ha ottenuto successo, e
lussi, onori, e bella vita. Le luci della ribalta. Grazie alla gnocca non
chiamata f*ga, per la sua educazione cattolica. E però “quanta f*ga, eh,
Balletti…!” in quanti glielo rimarcavano, ogni giorno, invidiosi della sua
posizione? Non immaginando che Balletti, l’erotismo, non sa bene cosa sia stato
ed è. Quel quid, quel mistero, lui che si è ritrovato a lavorarci per caso o per
fortuna, o perché, come egli stesso scrive, ce lo hanno chiamato. L’erotismo è
oltre, per un uomo che “non è schiavo sessuale, né esageratamente maschio,
attratto dal bello e dal torbido”, ed è frenato “dai sensi di colpa”, quelli
provati da bambino, davanti a un baule vietato e perciò aperto, pieno di foto di
nudi e di sessi, in rapporti lesbo, e etero i più crudi, quelle foto bruciate ma
mai dimenticate, insieme a quel brivido di peccato con cui ha flirtato una vita.
Una vita, tra Milano e Roma, a pensare e creare e a dare sesso. Balletti, cosa
mettere in copertina, qual è la foto e il titolo che più vende, importante è che
al titolo non si pensi troppo, e vende più la donna di un uomo, a meno che
quell’uomo non sia Gianni Agnelli, in foto nudo mentre si tuffa, ed è uno scatto
che fa il giro del mondo. Gli italiani, ma che cosa vogliono, leggere, vedere,
sognare, gli italiani hanno un vissuto segreto che va oltre i romanzi, i film,
la commedia, quotidiana, gli italiani fanno quello che non vuole si sappia e si
dica, bramano quello che di più sordido leggono, di immorale fremono, e che sia
omicidio tra moglie e marito, ricchi e nobili (marchesi Casati Stampa) che mal
cela vizi sessuali depravati, insopprimibili. Lui, Balletti, nel sudicio non ha
mai sguazzato, nemmeno infilatosi per sbaglio, che dico, sfiorato, lui che ha
sempre legato il nudo di donna a un erotismo trecentesco, dantesco, che scorna
contro quello ordinato da Hugh Hefner a Balletti direttore di Playboy Italia,
rivista che dirama un sogno americano preso in prestito. Una carica che è una
galera. Hefner decide e guai a sgarrare, metti le donne che scegli tu ma vuole
lui, prima il gran seno, poi si discute: se è bionda, se è bruna, se è alta, se
non lo è. La playmate è la star, la visione non di una moglie ideale ma di una
donna che con te non ha legami, che sta con te perché vuol starci ma non vuole
da te fedi, figli, obblighi. Vuole il sesso spensierato e consensuale, la
playmate non conosce vecchiaia né stanchezze, è donna giovane e perenne
disponibile, per voglie che sono le sue e magicamente le tue. L’erotismo è nelle
donne la cui pelle nuda fa vendere tutto, o in quelle vano ogni tentativo di
spogliarle, rimaste eterni sogni proibiti? Il desiderio non è nel nudo in sé, né
in ciò che fa e da spettacolo, o forse a volte sì. L’erotismo per il principe
Balletti è seduzione come contrasto, è scompiglio di un piano predisposto:
provocazione? liberazione da schemi e stilemi? Di certo non è un progetto ma
giustificazione per un’escalation di forza erotizzante di corpi slacciati
secondo criterio, mai esagerati o inopportuni. L’alibi culturale è fondamentale:
nudo sì, ma non isolato. Negli anni '70 e '80 in Italia si va in galera per
offesa al pudore, di associazioni a sua difesa, ma pure per il pudore privato di
un singolo cittadino turbato da ciò che ha voluto vedere. Se dirigi l’erotismo
su carta giri il mondo, vai negli Stati Uniti e lì c’è Nixon, alla Casa Bianca a
proibire Gola Profonda, porno che a vederlo accorre chiunque, da Jackie vedova
Kennedy, a Norman Mailer. Negli Usa c’è Al Goldstein, l’editore di Screw, “la
rivista più sporca che si possa immaginare”, Al Goldstein che finisce in carcere
24 volte per oscenità, e pure una volta a Cuba per aver fotografato Raul Castro
senza previa autorità. In prigione per un’idea, del sesso, su carta. A New York,
Balletti conosce e parla al mondo quello buio, quello che qui in Italia se sei
il principe dell’eros scansi, agiatamente ignori, e in quel buio vi scovi i
toy-boy-escort, i ragazzi che si vendono, i p*ttani. Un giornale è bello se
vende, ma in Italia Balletti non riesce a portare Hustler di Larry Flynt,
editore che parla e mostra sesso con imbarazzante concretezza. Balletti lo
incontra, “e perché, mister Balletti, mi vuole prendere in giro?”. Larry Flynt
non lo freghi, il suo sesso su pagina è troppo, come ingoiare e più digerire
Larry che, su carta, fa sc*pare santi e Gesù? Con Flynt l’erotismo si dilata, si
bestemmia, si guarda dentro quella f*ga benedetta, dentro quel buco umido e
scuro per Balletti intoccabile e non nominabile. Si fa Penthouse, però, in
Italia con Balletti direttore, e si va oltre e contro Hefner nelle guerre
pubiche, con foto di femmine senza maschi in mezzo, lesbopictorials costruiti,
levigati, nulla o poco stimolanti davanti alla potenza scabrosa di Flynt. La
donna cambia, la società con essa, il sogno dell’eros su carta lo mina per poi
distruggerlo la pornografia più esplicita che è “un pettegolezzo su un grande
mistero” secondo Ennio Flaiano, e che a Massimo Balletti annoia. È diverso e di
rottura il porno anni '80 di Riccardo Schicchi con Ilona Staller e Moana Pozzi,
e il principe Balletti su Moana spende parole attente: Moana femme fatale,
realtà e leggenda di un corpo sconfinato, immaginario, per uomini devoti,
asserviti. Moana la più desiderata, perfetta eppur lontana da ogni schema.
Mediaticamente insuperabile. È il corpo che vince sul volto, negli anni '90, il
principe Balletti domina con Excelsior, dettando altezzosa estetica dell’eros.
Vendite inaudite. È glamour. Ed è l’ultimo fuoco, perché iniziano a finire, gli
anni per Balletti i più felici, con Basic Instinct che sdogana il termine
"sc*pare" (“la sc*pata dell’anno!”) sul grande schermo, e non solo. Non c’è
rivoluzione, semmai evoluzione, e se c’è stata in Italia quale, se non onirica,
racchiusa nei giornali col sesso di un tempo che fu. Davvero siamo migliorati,
liberi e emancipati, se al libro "Il principe dell’eros" di Massimo Balletti,
libro di storia, d’Italia, di costume, cultura, sono respinte presentazioni,
ignorantemente giudicato libro osceno, indegno, sgradito? Odierni petulanti del
“Quanta f*ga, Balletti?”. “Sì, certo, ma non per te, non per voi”.
Dagotraduzione dal The Sun il
23 giugno 2021. La presentatrice Holly Willoughby ha messo a tacere l’ex
pornostar Miles Long, oggi regista, che sostiene di aver avuto rapporti sessuali
con più di 4.000 donne, durante il programma tv “This Morning”. Ai timori che
gli spettatori si facessero aspettative irrealistiche sul sesso, soprattutto
dopo l’allentamento dei blocchi e il ritorno a una vita sociale più intensa,
Long ha risposto che di «non credere che guardare qualcosa te lo faccia
desiderare di più». «Le persone – ha aggiunto Long – guardano le auto correre,
ma non significa che salgono in macchina e iniziano a gareggiare», oppure
«guardano un documentario sui piloti d’aereo, ma non cercano poi di pilotarne
uno veramente. È una fantasia». «Ma non hanno un aereo a loro disposizione.
Mentre una relazione sessuale è parte normale della vita umana» gli ha risposto
irritata la presentatrice. «In realtà è più probabile che provino ad imitare
quello che vedono o che pensino sia la norma. Credo ci sia una differenza in
realtà».
Barbara Costa per Dagospia il 19 giugno 2021.
Tutti i peni del porno sono dopati. Eh, non esageriamo! Pillole, creme, polveri
ma più di tutto la siringhetta al pene, sì, ci sono, si usano, ma precisiamo
bene: il doping nel porno professionale alto, dove pornano veri pornostar, è
formalmente vietato. Sui set non offrono o chiedono di prendere qualcosa. Sui
set è vietato assumere sostanze perché "farsi" fa male, puoi rimanerci secco,
anche se hai 20 anni e sei nel pieno della forma. Se sul set ti dopi e ti
succede qualcosa, non dico schiatti ma hai un mancamento, o ti viene un
priaprismo e devi correre in ospedale a farti salvare il pene, beh, uno studios
porno non vuole averci a che fare. Non vuole grane, caz*i da pagare per caz*i
andati a male. Però: si sa come gira il mondo, si sa come si assumono queste
sostanze, e nessuno può mettere bocca nel libero arbitrio di un attore che, su
sua decisione e sua responsabilità, assume aiutini chimici che gli garantiscono
una erezione sicura in prestanza e durata. Oggi la siringa nel pene è il dopante
più usato, ci si auto-inietta un farmaco contro la disfunzione erettile che dona
al pene potenza inaudita. Una pratica pericolosissima, e non sono pochi gli
attori che si sono ritrovati con un pene K.O. Non se ne parla, nessuno ammette
che si dopa, e però ci sono attori che hanno dovuto smettere di girare perché si
sono ritrovati col loro amichetto in overdose. Tra i pochissimi se non l’unico
che ha pubblicamente ammesso 10 anni di dipendenza da dopanti da pene e che è
finito di corsa e più volte al pronto soccorso è Danny Wylde, ex attore ora
produttore perché i medici, dopo avergli salvato il pene più d’una volta, gli
hanno fatto capire che doveva smettere di doparsi se voleva continuare una vita
sessuale attiva. È bene essere chiari: se droghi il pene fino alla dipendenza,
arriva il momento che il pene non ti funziona più, diventi impotente e non sc*pi
più sui set, ma nemmeno ti si alza in privato, con chi ti piace e ami. Non tutti
gli attori porno si dopano, e non tutti si dopano allo stesso modo: è
correttissimo dire che ci sono attori che mai se lo drogano, e che riescono ad
avere e mantenere erezioni sui set, sc*pando secondo copione realizzando
performance esagerate tali perché recitate. Lo fanno, ci riescono perché in ciò
consiste il loro lavoro e la loro bravura e, sebbene le loro cavalcate
instancabili siano anche frutto di abile regia e montaggio, è innegabile che
girare porno per un uomo è più complicato che per una donna. È vero che le
pornostar intascano più dei maschi ma è altrettanto vero che, a differenza delle
donne, la carriera di un attore bravo è mooolto più lunga. Un attore porno
dall’erezione affidabile ha più scritture. I registi richiamano e si affidano
agli stessi attori perché quelli su cui si può contare son pochi: un’erezione
andata a male vale scene non realizzate, e soldi sprecati. L’incubo dei
produttori. La scarsità di attori bravi spiega la frode del pene dopato: se
bastasse doparlo per diventare pornostar, di pornostar maschi bravi ve ne
sarebbero caterve. Di massima, per la maggioranza degli attori il doping è
l’ultima risorsa, l’estremo rimedio da usare in genere in questi casi:
gang-bang, scena tra una attrice trans e più donne, scena tra attore e attrice
che non trovano giusta chimica. Da spettatore, in buona fede puoi chiederti
com’è possibile che un uomo, davanti a donne simili, non riesca a eccitarsi.
Dando per assodato che quello che un attore fa sui set non ha NULLA a che vedere
col sesso reale, tra le cause che non permettono a un professionista l’erezione
ci sono non tanto la presenza di più persone sul set – inibizione che dopo le
prime volte ti togli – ma la mancanza di intesa sessuale con la partner, e a
volte blocchi dovuti a odori (puzza) di sesso e di pelle inibenti. In pole, tra
le cause di mancato indurimento, ci stanno le ansie personali che ogni attore
deve ogni volta, in ogni scena, lasciare fuori dal set, e non sempre gli riesce.
Un attore "deve" fare sesso, per lavoro e non (sempre) per piacere. Lui deve to
get hard, to stay hard and to pop, e va da sé che tutti, sul set, contano su di
lui, sulla sua "riuscita". Ha addosso una pressione pazzesca. E gli attori non
sono robot, sono esseri umani, e mai quanto per loro vale il detto "il pene non
vuole pensieri". E fare porno, nello specifico ergersi e venire quando e come si
deve, è un duro esercizio mentale. Serve seria capacità di concentrazione e
autocontrollo. Per decenni si è ovviato a mosce erezioni con le "fluffers":
erano queste delle fanciulle – ben pagate – che sui set avevano il compito di
mantenere "caldo", con bocca e/o mani, il pornostar tra una pausa e l’altra
(come nel cinema tradizionale, anche sui set porno vi sono pause e tempi morti:
è prassi per ogni attore stare sul set dalle 5 alle 12 ore, ma girare una scena
dura circa mezz’ora). Le fluffers non ci sono più per tre motivi: l’arrivo di
farmaci pro-erezione; le crisi economiche dal 2008 in poi, che hanno causato
gravi tagli di spesa ma più per il neo-femminismo le cui istanze ne hanno
decretato il disuso. Oggi il ricorso a fluffers – qualora si riesca a trovarne –
è giudicato riprovevole, altamente non professionale, e molto, molto peggio. Ci
sono attori che non si dopano ma si garantiscono l’erezione in altri modi: un
pornostar è come un atleta professionista, la sua vita è cura del suo corpo ed è
scandita dalle riprese. Ogni attore ha la sua routine pre-riprese basata su
alimentazione e stile di vita sani. La notte prima di una giornata sul set dorme
anche 9 ore. Chi non si dopa arriva all’erezione tramite training mentali,
alcuni assumono caffeina. Gli attori seguono diete proteiche e un po’ tutti la
mediterranea. Prendono vitamine, zenzero, rafano, e arginina, glutammina, zinco
(si dice renda lo sperma più bianco). Fanno regolarmente palestra, sollevamento
pesi e squat (si dice aiuti le spinte penetrative). I pornoattori giapponesi –
che girano in quantità più scene rispetto ai colleghi stranieri, dacché il loro
mercato è più ampio – bevono intrugli d’erbe giapponesi che (si dice) rendono
implacabili le loro prestazioni. Rocco Siffredi, uomo dall’etica porno rigorosa
e ferreo nemico del doping, per anni ogni mattina prima di andare sul set ha
fatto colazione con un frullato composto da un litro di latte, 5 uova, 2 banane,
e proteine in polvere. Oggi lo ha modificato con 6 albumi d’uovo sodo (il tuorlo
è dannoso per il colesterolo), una manciata di mirtilli, una mela, spremuta
d’arancia e caffè doppio con noci e mandorle. Chi ha il pisello più di marmo di
lui?
Francesco Semprini per "La Stampa" il 18 giugno
2021. In Borsa è atteso un pieno di influencer, artisti, sportivi e pornostar.
OnlyFans, la piattaforma online dove si vendono ai sottoscrittori contenuti
prevalentemente pornografici, sta esplorando l'ipotesi di cessione di pacchetti
azionari a nuovi investitori, forse in vista di una quotazione azionaria. I
documenti depositati questa settimana presso la Companies House, l'agenzia
britannica che gestisce i registri di iscrizione delle aziende, hanno mostrato
che Fenix International, la società madre con sede nel Regno Unito di OnlyFans,
ha aumentato il numero di azioni da cento a un milione. Una fonte informata ha
spiegato che il management della società stava ragionando sull'ipotesi di
«ampliare la proprietà», aggiungendo che la struttura del capitale ha «il
potenziale per farlo». La popolarità del gruppo britannico è esplosa durante
pandemia e lockdown, portandolo da meno di 20 milioni a più di 120 milioni di
utenti. La piattaforma consente ai creatori di contenuti, dagli istruttori di
fitness e musicisti alle star dell'erotismo, di caricare e vendere video clip,
messaggi e articoli direttamente ai fan che pagano tra 5 e 50 dollari al mese,
con OnlyFans che prende una commissione del 20% delle transazioni. Sebbene l'ad
Tim Stokely non si sia mai pronunciato sulle ipotesi di quotazione o cessione, è
al momento prevista la vendita di diverse partecipazioni. OnlyFans è un'azienda
a conduzione familiare fondata nel 2016 da Stokely e suo padre Guy, un ex
banchiere di Barclays. L'azienda impiega anche il fratello di Tim, Thomas, come
direttore operativo. Tra i principali azionisti c'è Leonid Radvinsky, il patron
del sito MyFreeCams.
(ANSA-AFP il 18 giugno 2021) - Trentaquattro donne
in California hanno presentato una denuncia contro Pornhub e la società MindGeek
accusandoli di aver pubblicato video nei quali loro subiscono stupri e abusi
sessuali, in alcuni casi quando erano minorenni. Nella denuncia gli avvocati
delle donne sottolineano che l'obiettivo "non è la pornografia" ma "una classica
impresa criminale" il cui modello di business si basa sullo sfruttamento a scopo
di lucro di contenuti sessuali non consensuali e, nel caso delle quattordici che
erano minorenni all'epoca delle violenze, "di traffico sessuale di minori".
Tutte accusano Pornhub di aver approfittato di video caricati a loro insaputa e
quindi senza il loro consenso - spesso da ex fidanzati o molestatori - e
chiedono il risarcimento del danno subito. Serena Fleites, l'unica delle donne
che non è voluta restare anonima ed ha parlato con i media, ha raccontato di
aver scoperto nel 2014 della pubblicazione su Pornhub di un video "sessualmente
esplicito" che il suo ragazzo l'aveva costretta a girare quando aveva solo 13
anni. E nonostante il nome fosse esplicito, "Brunetta di 13 anni", il filmato è
rimasto online fino a quando l'adolescente, fingendosi sua madre, ha chiesto al
sito di rimuoverlo. L'operazione ha richiesto diverse settimane e durante quel
lasso di tempo, il video è rimasto visibile, ha denunciato. Secondo gli avvocati
delle donne, la società MindGeek possiede più di cento siti pornografici e case
di produzione specializzate, tra cui Pornhub, RedTube, Tube8 e YouPorn per un
totale di 3,5 miliardi di visite al mese. La società ha bollato le accuse
definendole "totalmente assurde" e "categoricamente false". L'anno Pornhub era
già finito nella bufera dopo la pubblicazione di un articolo del New York Times
che lo accusava di pubblicare video pedopornografici e filmati di stupri.
Tomaso Montanari per “il Venerdì di Repubblica” il
10 giugno 2021. Nonostante i moniti dei trattatisti e l'impegno dei censori non
è mai stato possibile tracciare un confine netto tra pornografia e arte erotica:
se non altro perché il dominio maschile sulla società richiedeva alle immagini
prodotte dagli artisti anche le funzioni oggi assolte da ciò che chiamiamo
pornografia. La questione è ancora più larga, come ha ricordato lo storico
dell'arte David Freedberg in un libro molto influente (Il potere delle immagini.
Il mondo delle figure: reazioni ed emozioni del pubblico, 1989): «Diciamo pure
che nel mondo occidentale l'osservazione ha sempre avuto luogo attraverso gli
occhi maschili, perché ha sempre avuto luogo attraverso gli occhi di uomini che
desiderano possedere, o possiedono, delle donne». Freedberg cita un ricordo
infantile dello scrittore Maksim Gorkij, aspramente rimproverato per aver posato
su un'icona della Madonna non un casto bacio di venerazione, ma un appassionato
bacio sulle labbra. Le accuse a Caravaggio e a Bernini di aver ritratto
prostitute nelle loro Madonne e nelle loro sante vanno calate in questa
preoccupazione di lunga durata. E d'altra parte Giorgio Vasari racconta che
quando un ingenuo fiorentino chiese al pittore Toto del Nunziata (1468-1525) di
dipingergli una Madonna che non «movesse a lascivia», quegli gliene portò una...
con la barba. Uno dei maggiori scandali della nostra storia artistica legati ad
immagini erotiche travolse Marc'Antonio Raimondi, il grande incisore allievo di
Raffaello. Nel 1524 e poi nel 1527, questi aveva stampato i Modi disegnati da
Giulio Romano: sedici immagini molto esplicite degli amori tra dei ed eroi.
Clemente VII fece gettare in carcere per alcuni mesi Raimondi, e la censura
papale fu abilissima nel trovare e distruggere quasi tutti gli esemplari dei
Modi. Naturalmente si trattava di opere pensate per una fruizione strettamente
privata. La stessa per cui nacque il quadro oggi più celebre in questo eterno
filone figurativo, L'origine del mondo di Gustave Courbet, dipinto nel 1866 come
un ossessivo, singolarissimo ex voto dell'ex ambasciatore ottomano a San
Pietroburgo, l'egiziano Khalil-Bey, appassionato erotomane afflitto dalla
sifilide: che lo teneva appeso in bagno, normalmente coperto da una tenda verde,
come una reliquia o un feticcio. Dopo essere appartenuto al grande psichiatra e
psicoanalista Jacques Lacan, solo nel 1988 si è trovato il coraggio di
appenderlo in un museo pubblico. E ancora oggi, ogni volta che viene pubblicato
sui social o sui giornali, viene travolto da centinaia di commenti indignati. Il
potere delle immagini, evidentemente, non conosce tramonto.
Da "corrieredellosport.it" il 6 giugno 2021.
"Siamo nell'era della dipendenza da video e contenuti pornografici". È questa la
conclusione cui giunge un articolo pubblicato sul numero di marzo di Psychology
of Addictive Behaviors, che indaga su una delle problematiche più comuni dei
nostri tempi, identificata spesso col nome di "uso problematico del porno". I
ricercatori sono volati in Ungheria e hanno raccolto le risposte di un campione
significativo di persone, dal quale emerge che il 45% delle fruizioni è
riconducibile ad un mero "piacere sessuale momentaneo", il 12% è spinto dalla
curiosità ed il 10% dalla fantasia.
Pornografia, le differenze tra uomini e donne
Dividendo invece per genere gli individui
sottoposti al questionario, risulta che, rispetto alle donne, gli uomini hanno
conseguito percentuali più alte nelle risposte quali "piacere sessuale",
"distrazione", "soppressione emotiva", "riduzione dello stress", "fuga dalla
noia", "fantasia" e "mancanza di soddisfazione sessuale". Non si riscontrano
differenze per quel che concerne la "curiosità sessuale" e
"l'autoesplorazione".
L'uso problematico del porno: motivazioni e
conseguenze
Restringendo ulteriormente il campo alla vera e
propria dipendenza dal porno, definita "uso problematico", risulta che
"distrazione", "soppressione emotiva" e "riduzione dello stress" vengano
interpretati come il modo più rapido per smaltire le proprie tensioni e porre un
freno ad ansie e pensieri della vita di tutti i giorni. Una fruizione eccessiva,
però, può comportare nuovi rischi e problematiche, diventando di fatto una nuova
fonte di stress, oltre che causa di conflitti.
L'uso problematico del porno si interseca con la
psicologia, abbracciando determinati tratti della personalità delle persone
(impulsive e compulsive su tutte), soprattutto per quelle che si sentono
sopraffatte o che non riescono a controllare le proprie emozioni.
Alice Mattei per "it.businessinsider.com" il 5
giugno 2021. Lo stato americano del Mississippi è il posto in cui si guardano
più filmati porno nel mondo. La notizia, che ha suscitato più di qualche
risolino, arriva dai dati messi a disposizione dal portale Pornhub che ha
diffuso i dati circa i luoghi nei quali i suoi video sono più scaricati. A quel
che risulta, nel 2019 (ossia prima del boom del 2020) da tutto il mondo, ci sono
state 42 miliardi di visite individuali a Pornhub e ogni giorno 115 milioni di
persone accedono al sito. Fin qui, niente di particolarmente strano. Il dato
interessante però è un altro. Anzi due. Il primo: il posto da cui si registrano
più accessi sono gli Stati Uniti d’America. Il secondo: lo stato che trascorre
più tempo per visita è il Mississippi. 11 minuti e 26 secondi per ogni accesso,
contro i 10 minuti degli altri stati. Non solo. Non è neppure la prima volta che
il Mississippi vince questa particolare palma. Anzi: è sempre stata sua ogni
anno, dal 2012, tranne nel 2015: in quell’occasione, i ‘cugini’ delle Hawaii li
superarono di un secondo.
Dagotraduzione dal DailyMail il 25 maggio 2021.
Priscila Bergmair, l’affascinante moglie del miliardario Bernd Bergmair,
proprietario del sito Pornhub, ha detto che «spera davvero» che suo marito rompa
i legami con il sito web di video sessuali di proprietà della sua azienda. Il
sito, che vanta 120 milioni di visitatori al giorno in tutto il mondo e ha più
traffico online di Netflix e Amazon, è stato oggetto di critiche per i contenuti
offensivi pubblicati, come i video di stupro o «revenge porn». Priscila, che di
professione è una fashion blogger, ha chiesto anche ai governi di stabilire
regole migliori sull’accesso ai contenuti online. L'azienda di suo marito
MindGeek sta affrontando un'indagine dell'FBI dopo che 132 vittime di
sfruttamento sessuale hanno chiesto un’indagine per traffico sessuale. Oltre a
Pornhub, MindGeek possiede anche i siti porno RedTube e YouPorn. Si stima che la
società valga 1,2 miliardi di sterline, con ricavi di 325 milioni di sterline
all'anno. Il signor Bergamir è lo stakeholder di maggioranza di MindGeek.
Pornhub, che ha attirato 42 miliardi di visualizzazioni nel 2019, ha affermato
di non consentire consapevolmente immagini di abusi sessuali su bambini. Ma è
stato costretto a rimuovere più di 10 milioni di video non verificati a seguito
di un rapporto del New York Times. Anche dopo che i video sono stati
contrassegnati e rimossi, le copie scaricate hanno continuato a circolare,
spesso con gravi conseguenze personali. Da allora le società di carte di credito
Visa, Mastercard e Discover hanno bloccato gli acquisi su Pornhub.
Dagotraduzione Psychology Today il 16 maggio 2021.
Un recente articolo di Bothe e colleghi, pubblicato nel numero di marzo di
Psychology of Addictive Behaviors, esamina le ragioni per cui le persone
guardano la pornografia e le potenziali cause da cui scaturisce una visione
problematica della pornografia su Internet (a volte chiamata uso problematico
del porno o semplicemente dipendenza dal porno). I ricercatori hanno utilizzato
tre campioni di volontari in Ungheria. È emerso così che le principali
motivazioni che spingono le persone a guardare video pornografici sono il
piacere sessuale (45%), la curiosità (12%) e la fantasia (10%). Gli uomini hanno
avuto punteggi più alti rispetto alle donne nell'uso del porno per piacere
sessuale, distrazione o soppressione emotiva, riduzione dello stress, fuga dalla
noia, fantasia e mancanza di soddisfazione sessuale. Non sono state riscontrate
invece differenze di genere nella curiosità sessuale e nei motivi di
auto-esplorazione. Per quanto riguarda invece l'uso problematico del porno, per
la maggior parte degli intervistati è motivato da distrazione, soppressione
emotiva e soprattutto riduzione dello stress. Guardare materiale pornografico
può sembrare un modo veloce e conveniente per alleggerire le tensioni, ma se
eccessiva e inappropriata, rischia di diventare esso stesso fonte di stress e di
conflitti. È importante notare che la riduzione dello stress, da sola, non basta
di per sé a provocare un uso eccessivo del porno, ma è più probabile che si
manifesti nelle persone «che usano la pornografia non solo per ridurre il loro
stress ma anche per evitare sentimenti negativi, dimenticare i loro problemi e
fuggire dal mondo reale». Ciò suggerisce che la dipendenza dal porno può
svilupparsi non solo nelle persone con determinati tratti della personalità
(impulsivo, compulsivo, ...), ma negli individui che si sentono attualmente
sopraffatti, incapaci di far fronte o regolare le proprie emozioni con successo.
Quindi, gli interventi psicologici volti ad aiutare questi individui a far
fronte in modo più efficace potrebbero anche prevenire lo sviluppo di abitudini
problematiche di visione del porno. Sono necessari studi futuri per esaminare la
stabilità delle motivazioni che spingono a guardare la pornografia (e la
dipendenza dalla pornografia) e per indagare sui motivi del consumo di
pornografia in persone di altre culture e paesi.
DAGONEWS l'11 maggio 2021. Riuscite a immaginare
di dormire con qualcuno che avete appena incontrato e che ti colpisce in faccia
durante il sesso? O che ti schiaffeggia così forte da non potersi sedere
l’indomani? E che ne dici di essere soffocata durante il sesso? Se non
appartenete al genere di donne alle quali queste pratiche è bene lanciare un
messaggio chiaro al partner e agli uomini in generale. Come spiega la sexperta
Tracey Cox ci sono delle partiche che sono comuni nel porno, ma non fanno parte
dell’educazione sessuale o di come normalmente le cose funzionano in una coppia.
Oggi i ragazzini guardano tanto porno e per loro, quello che accade in quei
film, diventa l’unico modo di agire e di comportarsi durante un rapporto
sessuale. Ovviamente le cose non funzionano così: le attrici che vedete godere
sono pagate per fingere. Quello che piace (per finta) a loro non è detto che
faccia piacere a una partner. Il dolore non piace a tutti. Se ti piacciono le
pratiche sadomaso non c’è nulla di male. Basta parlarne con il partner. In
qualunque coppia che lo pratica si stabiliscono le regole, ma non si può
pretendere che qualcuno che non ama farsi frustare accetti con benevolenza i
lividi sul sedere. Ecco le otto pratiche comuni che le donne nella vita reale
odiano.
Sculacciate dolorose. Il BDSM è uscito dalla sua
dimensione di nicchia quando “Cinquanta sfumature di grigio” è diventato
popolare. Gli strumenti per il bondage hanno visto impennare le loro vendite. Ma
attenzione. Se uno schiaffo leggero può eccitare non si può dire lo stesso per
uno schiaffo che provoca una ferita.
Soffocamento. Tenere una donna per il collo non è
una pratica gradita a meno che lei non acconsenta. Tra i ragazzini è molto
diffusa perché lo vedono fare nel porno, ma bisognerebbe indirizzare i giovani
su un altro tipo di educazione sessuale.
Nessun preliminare. Nel porno, la donna è pronta
solo guardando il pene del partner. In realtà, le donne hanno bisogno di tempo
per eccitarsi, per consentire alla vagina di “bagnarsi” e rendere più
confortevole la penetrazione. Saltare il "riscaldamento" e andare dritto alla
penetrazione - con le dita o con un pene - sposta il sesso da piacevole a
doloroso. I preliminari non sono un lusso. È raro che una donna li salti e un
bacio non la rende pronta.
Schiaffeggiare il clitoride. Un’altra pratica
favorita nei porno: schiaffeggiare il clitoride con una mano, un pene, le dita o
un oggetto. Il clitoride è pieno di terminazioni nervose ed è estremamente
sensibile. Dato che molte donne trovano troppo intensa la stimolazione diretta
del clitoride, immagina come si sente se viene colpito.
Schiaffi in viso. Gli uomini credono che essere
schiaffeggiate in viso ecciti le donne. Ma nessuna in media giudicherà uno
schiaffo come qualcosa di eccitante. Idem se si infilano vigorosamente le dita
nella bocca di qualcuno.
Pene in gola. Il “deep-throating”, ovvero prendere
in bocca il pene fino in fondo, è un luogo comune nel porno.
In realtà, la maggior parte delle donne si
concentra sul prepuzio che è dove si trova la maggior parte delle terminazioni
nervose. Prendere un pene fino in gola è un’abilità. Se lo fa una persona non
esperta si innesca il riflesso del vomito.
Fare sesso anale senza prepararsi. Per farlo
bisogna allenare il retto e nessuna coppia dovrebbe simulare quello che accade
nei porno. Una cosa pericolosa è passare dall’ano alla vagina consentendo un
pericoloso passaggio di batteri. Stessa cosa vale per la bocca.
Eiaculare in faccia. Nel porno si chiama "The
Money Shot": quando un uomo eiacula sul viso del partner. Le pornostar fingono
di adorarlo. Se una donna non lo vuole è assolutamente irrispettoso. Chi diavolo
vuole sperma nei loro occhi o nei loro capelli? Ogni atto sessuale che si
allontana anche leggermente dalla norma deve essere accettato dal partner.
Dunque bisogna semplicemente parlarne.
Barbara Costa per Dagospia il 2 maggio 2021. “Che
io sia una puritana!?” Beh, quasi, cara Oriana Fallaci, e da te, non me
l’aspettavo! Ma ti ho scoperto, in questa intervista hard che ti hanno fatto su
"Playboy" nel gennaio 1976. E qui tu fai a pezzi il porno, l’erotismo, gli
uomini, il femminismo, un certo giornalismo, e pure l’amore. Andiamo con ordine.
Allora, Fallaci, che ne pensi del porno? “A film e foto porno reagisco con
irritazione. Me ne sento umiliata. È un sopruso, una macelleria. È un insulto”.
Nientemeno! Eppure tu, Oriana, pochi anni prima stavi a Chicago, a casa di Hugh
Hefner, uomo di cui eri pazza. A intervistarlo – ovvio! – ma… come miagolavi
innamorata davanti a lui! Lo hai scritto, se non te lo ricordi, te lo rammento:
“Hefner è lì: come un faraone, ed è così giovane… e così consumato dalla
mancanza di luce e dall’eccesso d’amore, con quegli occhi così luminosi, così
intelligenti, così vagamente demoniaci… Lui parla con una voce morbida che ti
spezza. E senza mentire”. Proseguivi in lodi alla Maison, e alla sua piscina e
alla sua cascata, agli incontri erotici e liberi che lì chi voleva poteva avere,
e a non dire delle tue fusa per il letto rotondo e girevole di Hef, e di quanto
a quel tempo "Playboy" per te, Oriana, fosse “articoli eccellenti, e umorismo, e
cultura, e filosofia del sesso quale piacere”. 10 anni dopo, invece, eccoti qui,
inacidita, contro la pornografia: “Dinanzi al sesso propagandato, provo un
desiderio di castità. L’erotismo anziché eccitarmi mi spegne. Mi savonarolizza”.
Suvvia, Fallaci, davvero non c’è nulla che ti ecciti? “Il culto del sesso è roba
da impotenti. È quando uno non "può" che cerca sollecitazioni. E ciò vale per
gli uomini come per le donne. Secondo me le ninfomani sono impotenti come i
dongiovanni”. Quanta severità, Oriana, tu ti scagli contro il corpo nudo pure
perché “è brutto, assomiglia a un polipo, gambe e braccia fanno pensare ai
tentacoli. Un albero è molto più bello. Io sto per l’albero”. Oriana, tu nel
1976, stavi con Alessandro Panagulis, guerrigliero-poeta alcolizzato cronico e
con problemi esistenziali molto seri, e a te, Fallaci, ti riempiva di corna. In
questa intervista non lo dici ma lo scrivi in "Un Uomo", che con lui ci sc*pavi
niente, di sicuro la prima settimana che stavate insieme e poi amen, e comunque,
“lui per me è un fratello”. La vostra è una unione “di idee, di principi”, sesso
zero e forse è per questo che arrivi a dire che “il sesso non è una cosa sporca,
ma è un argomento noioso e una pratica banale. Una ginnastica faticosissima, e
basta”. Vabbè, ma come sc*pa – se sc*pa – la Fallaci? “Quando si fa l’amore, il
sangue si sposta dal cervello al basso ventre. Ma non a me. Io penso sempre,
anche quando faccio l’amore. E non lo faccio mai senza sentimento”. Sì, va beh,
cara Fallaci, hai la memoria corta: tu nel sesso non ti sei mai fatta problemi.
Tu, Oriana, che hai perso la verginità con un gay, o così scrivi in "Penelope
alla Guerra", “un romanzo dove è tutto vero”. Tu, Oriana, che hai fatto sesso
senza sentimenti da donna libera e emancipata negli anni '50 e quindi un
decennio avanti le liberate dei '60. Tu, Oriana che, in una lettera (è in
"Oriana" di Cristina De Stefano) di fronte all’ennesimo uomo che hai sedotto e
abbandonato, ti sfoghi scocciata: “O che è colpa mia se non m’innamoro?”. Ma,
Oriana, che cosa è per te l’amore? “Un lavaggio del cervello che tutti subiamo.
Ci raccontano che senza amore non possiamo vivere ma non è vero. L’amore è
sempre stato il contentino dell’umanità”. Ogni amore è una catena, anche quello
verso i genitori, e tu, Oriana provi “rancore verso tali catene”. L’amore “rende
schiavi, e io lo rifiuto”. Tu, Oriana, non sei come le femministe che tanto
strillano, ma poi “senza un uomo nel letto non sanno stare. Io non sono schiava
degli uomini, io non mi ammalo se non ho un uomo nel letto. Ma chi sta con me
non dimentichi mai, dico mai, che io sono l’Oriana. Se lo dimentica, lo liquido.
E me ne trovo un altro. O nessuno”. Tu, Oriana, qui lamenti che ti credano
lesbica. A Robert Scheer, di "Playboy USA", hai risposto: “Portami tuo fratello,
così te lo dimostro!”, e a analoga domanda di un giornalista di "Life" lo hai
mandato al diavolo. D’altronde il tuo rapporto coi colleghi mai è stato
idilliaco. Natalia Aspesi è “una poverina. È stata velenosa con me. Dicono abbia
il complesso di essere brutta. Mah! Bella non è. La Aspesi odia le donne nella
segreta illusione che ciò le serva per essere accettata dagli uomini”. Si
salvano in poche, si salva Miriam Mafai, non si salvano Enzo Biagi e Montanelli.
Tu lo dici, Oriana, che il giornalismo si regge su “mafiette, cenacoli, per cui
io provo disgusto. Piegarsi a far l’amica sorridente di un Biagi o di un
Montanelli? Per avere che? Un premio letterario!? I premi non vanno a chi li
merita, ma a chi è amico loro”. In Italia non ti perdonano il successo, specie
se meritato. Qui hai ragionissimo, Oriana. Ti lodano solo da morto, se ti va
bene. A te non perdonavano la notorietà internazionale, stratosferica, e i
mucchi di copie vendute e, peggio, da donna non ti perdonavano l’aver ottenuto
successo senza essere figlia di, moglie di, e senza averla data a nessuno. Oggi,
Oriana, nulla è cambiato e se hai successo, pur minimo, in qualsiasi campo, e
non sei figlia, moglie di, ti attaccano su quello che hai tra le gambe, e su
come e con chi – secondo loro – lo usi: “Gli italiani quando non hanno niente
per dimostrare che il tuo successo è un furto dicono che sei cornuto. O
finocchio. Che sei fr*cio. Se sei donna, che sei una poco di buono. La parola
p*ttana andrebbe tolta dal vocabolario”. Già, Oriana, proprio come dici tu.
Senti, com’era Enrico Mattei, direttore de "La Nazione"? “Uno che potrebbe
essermi bisnonno, casca giù da tutte le parti, dal cervello all’inguine”. E
Camilla Cederna? “Ci siamo litigate per Mao Tse-tung. Ma la Cederna ha un
merito: non è invidiosa. Perché non è brutta, o forse perché non è italiana: lei
è milanese”. Aspetta, Oriana, ma gli italiani, come popolo, come sono? “Ci
insegnano a credere che gli italiani son buoni, generosi, che hanno il cuore in
mano: ma non è affatto vero. Sono invidiosi, spesso meschini, e non hanno
affatto il cuore in mano. Tutt’al più hanno il caz*o, in mano, visto che ne
parlano ossessivamente anche quando ne sono sprovvisti”.
COSA VOGLIONO LE DONNE DAL PORNO?
Barbara Costa per Dagospia il 30 aprile 2021. Le donne
vogliono vedere le donne squirtare. Il sesso deve essere reale. Vogliono vedere
che le donne godono ma sul serio, non che fanno finta. I genitali non vanno
posti in primo piano, né per forza devono stare in "azione". Le donne non amano
che le donne sc*pino ogni volta nude. Ma devono vestire abiti "quotidiani", se
taglia 44 è meglio, e indossabili da tutte nella realtà. Non roba che sta bene
solo a una modella, e comunque non devono essere indumenti da m*gnotta. E
nemmeno il trucco. Le donne vogliono potersi identificare con l’attrice che
vedono in video, e questa donna deve essere dal partner baciata in bocca, a
lungo, e leccata tra le gambe a lungo ancor di più. È disgustoso eiacularle in
viso. La donna nei video deve ridere, l’uomo con lei pure, e entrambi devono
parer rilassati. Le donne vogliono vedere per così sapere in che modo introdurre
giochini BDSM nella loro vita di coppia che dura da anni, nella stessa casa, con
doveri e rotture di p*lle quotidiane, rotture che a letto si vogliono
dimenticare. Le donne passano il tempo volentieri sui video di sesso a tre, gli
piacciono le donne bisex che si danno da fare con un uomo e una donna, ma di più
gli piacciono i porno dove sono in tre, ma una donna e due uomini, e questi due
uomini si dedicano al corpo e al piacere della donna, ma pure al sesso tra loro
omosex! Al contrario di tutte queste donne, io non mi ritrovo in siffatte
preferenze formanti statistiche su cui fa fortuna "Bellesa – Porn for Women",
sito porno la cui missione esistenziale è chiara nel nome: fare porno per donne,
seguendo solo i loro gusti, desideri, fantasie. Che, se non combaciano con le
mie, chi se ne importa, perché sono quelle delle donne che davanti a Bellesa
stanno, si toccano, godono. Pagano. Bellesa festeggia il quinto compleanno e
nemmeno la pandemia ha fermato la sua ascesa. La mamma e capo di Bellesa è
ovviamente una donna, Michelle Shnaidman, e lei questo successo te lo spiega
così: “Le donne amano il porno, lo guardano, e pagano per contenuti adatti a
loro. Contenuti che le soddisfino come peculiari consumatrici di porno. Bellesa
basa le sue strategie su quello che le donne vogliono: il nostro pubblico di
donne è una comunità di continuo chiamata a dire la sua su cosa vuol vedere cioè
cosa le fa godere. Le donne vogliono vedere donne sullo schermo che fanno sesso
ma in modo naturale, senza acrobazie. Per questo a Bellesa sono le attrici che
scelgono con chi pornare. Sempre. Poi sul set fanno sesso senza script. Fanno
solo quello che loro vogliono fare”. Per i criteri di Bellesa, vagina e ano
della donna non devono essere in primo piano, spalancati a favore di telecamera:
tale misura è maschilista, arrapa i maschi, non le donne. Sono i clitoridi che
devono prendersi la scena, è la loro stimolazione. Ne consegue che protagonisti
dei porno Bellesa sono i preliminari, che durano tanto, non finiscono mai,
specie se fatti ai capezzoli. Ma tra il pubblico di Bellesa, c’è qualche uomo?
“Sicuro”, risponde Michelle Shnaidman, “e sono tutti i curiosi di sapere qual è
il tipo di porno che eccita le donne”. Che il mercato femmina x femmina nel
porno tiri, cioè funzioni, e frutti soldi, lo ha capito già da anni "Dorcel",
pioniere del porno francese e leader del mercato d’Europa centrale: da tempo
Dorcel si è "(s)doppiato" in nome e sito, dalla cui appunto costola è nato
"Dorcelle", porno per donne fatto però non solo da donne, come lì non sono solo
donne le teste al comando. E se è a fine anni '90 che la pioniera Angie Rowntree
ha fondato "Sssh.com", per dare porno solo alle donne, sono 20 anni che la
stralodata regista Erica Lust (mi) rompe i maroni col suo porno femminista etico
e giusto in quanto ideato da lei che è una donna. Le donne fanno porno diverso e
quindi meglio? Io non sono d’accordo e non lo nascondo: non è il possesso di una
vagina che rende ciò che realizzi – qui il porno, ma vale in ogni settore – un
prodotto oggettivamente migliore. Il porno USA è pieno di donne – etero, omosex,
bisex, pansex – che il porno lo fanno, recitano, dirigono, producono, ma senza
etichette doc dacché femmina. E però il progetto Bellesa va a gonfie vele, vi
lavorano le pornostar più famose, e ormai non è più un progetto bensì una realtà
concreta. È cercato per partnership strategiche e co-branding. Bellesa offre
informazioni sul benessere sessuale oltre a letteratura erotica in e-book, ma
sono i sex toys il suo piatto forte, dopo i video porno. Sex toys che si
comprano scontati su Bellesa, sezione Boutique. Da inizio pandemia, Bellesa si è
alleata con "BuzzFeed", gigante dei media digitali, per inondare di vibratori e
giocattoli del sesso "for women" gli USA e il Canada. BuzzFeed ha posto il suo
nome su "AirVibe", piccolo vibratore di ultima generazione, di femmina colore
rosa, silenziosissimo e carinissimo, che Bellesa giura ti fa morire di orgasmi,
dopo soli 4 minuti che ce l’hai tra le gambe.
Dagospia il 18 aprile 2021. Aurora Snow
per thedailybeast.com. I suoi occhi a mandorla scattano rapidamente verso il
pavimento per timore di apparire troppo impaziente mentre recita il "menù" per
un nuovo cliente. Speciale del giorno: un massaggio con "happy ending" a metà
prezzo. L'uomo finge stupore, sostenendo di essere lì solo per alleviare i suoi
muscoli doloranti dopo una lunga giornata di lavoro. Sorridendo, lei fa
scivolare il kimono seducentemente verso il basso mentre oscilla tra l’intenso
desiderio sessuale e una docile servitù. Questa scena, cliché del centro
massaggi, viene richiesta a praticamente tutte le pornostar asiatiche. Sì, il
porno perpetua gli stereotipi razziali, a volte con noncuranza: del resto si
tratta di intrattenimento, non di educazione. Ma quando un uomo bianco armato
uccide otto persone, sei delle quali donne asiatiche, in tre diversi saloni di
massaggi asiatici ad Atlanta e incolpa la sua dipendenza dal sesso
auto-diagnosticata, naturalmente il porno entra a far parte della discussione.
Il 21enne ha incolpato l'esistenza delle donne per le sue frustrazioni sessuali
non corrisposte, dicendo alla polizia: "Ho dovuto rimuovere la tentazione". Il
fatto che fossero delle prostitute o meno non è rilevante, specialmente se
confrontato all'inquietante stereotipo che tutte le donne asiatiche che lavorano
nei saloni di massaggio lo siano. "In un certo senso, siamo gli educatori
sessuali di persone che non lo ricevono dalle scuole o dai loro genitori",
spiega l'attrice hard Ember Snow, che crede che la maggior parte del porno sia
basato sui fetish. “La persona che recita una scena diventa un oggetto. Non ho
problemi con questo.La domanda è: sono un oggetto positivo o sono un oggetto
negativo? Quello che sto facendo sullo schermo viene visto da qualcuno che
apprezza la mia performance o sono solo uno sfogo per la loro rabbia e
frustrazione di qualche trauma negativo che hanno subito in passato? " Come
attrice filippina, Snow è stata scritturata in molte scene di centri massaggi,
sottolineando che i ruoli che feticizzano la sua etnia erano più prevalenti
all'inizio della sua carriera adulta nel 2017 rispetto ad ora. "I ruoli che mi
sono stati chiesti di interpretare negli ultimi anni sono diventati molto
neutrali in termini razziali", osserva Snow. Ciò però non preclude a una
compagnia di produzione di commercializzare la film con titoli razzialmente
espliciti come “Asian Invasion.” "È una triste verità che gli asiatici saranno
sempre feticizzati, ma ho visto che l'industria sta cercando di prendere
provvedimenti, inserendoci in ruoli in cui siamo solo delle ragazze. Più
succede, meno penso che gli asiatici diventeranno un fetish”, afferma Snow. "Non
si può sfuggire dallo stereotipo della geisha o del centro massaggi. È un
peccato. Ma se hai 25 ruoli non stereotipati per parte in un film con una "sala
massaggi", allora l'impatto diminuisce". Una ricerca di "massaggio asiatico" su
Pornhub produce oltre 6.600 video, alcuni dei quali vantano decine di milioni di
visualizzazioni. Con i crimini d'odio in aumento, le persone incolpano la
stigmatizzazione razziale nell'intrattenimento per adulti. La violenza nei
confronti di asiatici e americani asiatici è aumentata del 149% nel 2020, in
gran parte a causa della pandemia COVID-19. Sono le donne ad essere vittime in
modo sproporzionato, rappresentando quasi il 70% degli episodi di odio segnalati
secondo le informazioni raccolte dai ricercatori di STOP AAPI HATE. Forse le
fantasie tabù non sono al centro del problema, ma la misoginia e il razzismo.
Dopo aver interpretato numerosi ruoli incentrati sull'Asia negli ultimi cinque
anni, Kimberly Chi dà una svolta positiva a ciò che molti potrebbero definire un
aspetto stigmatizzante dell’industria del porno, riformulando abilmente la
conversazione. "Non lo prendo troppo sul serio. Ho interpretato la
massaggiatrice e la studentessa, ma è stato positivo", dice Chi, che si
identifica come asiatica orientale, polinesiana, thailandese e cambogiana. “Le
scene che raffigurano persone di un altro paese che parlano a malapena l'inglese
ma si sentono i benvenuti mettono in luce le differenze e mostrano alle persone
di amare indipendentemente dalla razza, da dove vengono o da quale sia il loro
background." Per Chi gli stereotipi etnici utilizzati nel porno sono un modo
per incoraggiare l'accettazione e celebrare le differenze. "Al pubblico potrebbe
sembrare razzista, ma gli stereotipi che recitiamo fanno parte della realtà",
dice Chi. "Fa parte della cultura e non è qualcosa che ci abbatte, in realtà
stiamo tirando fuori il meglio dalla cultura delle persone". (Chi prende in giro
anche il genere con il suo nome: lo slogan sul suo sito web personale recita
"assaggia un po’ di Kim Chi".) Marica Hase ha una prospettiva unica su come le
donne asiatiche vengono ritratte nel porno, essendo una delle poche attrici a
passare dall'industria dell'intrattenimento per adulti giapponese a quella
americana: “Ci sono solo poche ragazze asiatiche nell'industria pornografica
americana. Quindi penso che essere asiatica mi aiuti davvero a trovare lavoro e
opportunità nel settore." Afferma la Hase. Alla domanda sulle discriminazioni
nel settore, Hase non è riuscita a ricordarne nessuna. "Personalmente, non ho
mai incontrato il razzismo sul set. Ti racconterò una storia interessante. Ho
lavorato con cinque ragazze in un film e stavamo scattando delle foto per la
copertina. Una delle cinque ragazze ha detto che ero una asiatica brutta e mi ha
chiesto perché ci fossi io al centro della foto. Il regista le ha risposto
dicendo che sono una Pet di Penthouse, nonché molto più famosa di lei e volevano
anche mettermi al centro per via dell'illuminazione. Alcune persone potrebbero
credere che sia razzista, ma io non lo penso. A volte è un po' difficile
giudicare cosa sia razzista e cosa non lo sia ", spiega Hase. Secondo Mark
Schecter, proprietario di Adult Talent Managers (ATMLA) lo il razzismo potrebbe
presto diventare un ricordo del passato: la recente emergenza di movimenti come
#BlackLivesMatter dovrebbe spingere l'industria dei film per adulti verso un
futuro più inclusivo. "Adesso è diverso. È un tema più sensibile e non è
sfruttato come prima. Detto questo, ho ancora difficoltà a cambiare il processo
di selezione dei talenti in base alla razza o al colore. È ancora prevalente ",
osserva Schechter. "Anche oggi talenti neri, asiatici, ispanici sono i più
emarginati a causa di quel processo che prevale da tanti anni".
Dagospia il 17 aprile 2021. Justin
Jones per thedailybeast.com. Per molte persone la pornografia è un argomento
tabù. Nonostante il sesso e l’immaginario sessuale facciano ormai parte della
nostra cultura, tendiamo a considerare il materiale erotico ancora come
qualcosa di privato, da nascondere in uno scaffale o dietro la televisione e da
consumare di nascosto. “Siamo convinti di aver inventato la pornografia
hardcore” dice Mark Snyder, direttore del museo del sesso di New York City,
riferendosi all’aumento della domanda di materiale pornografico conseguente al
boom di internet, “ma in realtà è qualcosa che esiste da molto prima di quanto
si pensi”. Ammirando l’ultima mostra del museo, tema “Hardcore: un secolo e
mezzo di immaginario osceno”, si capisce subito a cosa Snyder faccia
riferimento: appena entrati ci si imbatte subito nella letteratura erotica del
1500, farcita di desideri e fantasie sessuali che, a tratti, “possono sembrare
più spinte di qualunque cosa ci sia in giro oggi”, dice Senyder. Lo scrittore
cinquecentesco Pietro Aretino, considerato “il padre della pornografia”, aveva
inserito nelle sue opere “vari discorsi con esplicite allusioni erotiche sulla
corruzione del clero e le ingiustizie sociali, descrizioni dettagliate del sesso
omo ed eterosessuale, parlò di orge e masturbazione in modo diretto e senza
ricorrere a perifrasi o eufemismi”. Il romanzo erotico “Fanny Hill, Memorie di
una Donna di Piacere”, pubblicato in Inghilterra nel 1748, ha fatto il giro del
mondo da quando Joe Cleland lo scrisse nella cella di una prigione di Londra,
dove era stato rinchiuso per non aver pagato i suoi debiti. Il romanzo racconta
la storia di una ragazza, Fanny, che si trasferisce a Londra a 15 anni dopo la
morte dei suoi genitori. Nella capitale diventerà una prostituta, venderà la sua
verginità e scoprirà la masturbazione e altre perversioni sessuali. Fanny Hill è
considerato il primo romanzo pornografico e anche uno dei libri più perseguiti
della storia. Nel 1821, quando si diffuse negli Stati Uniti, il suo editore
Peter Holmes fu accusato di distribuire materiale “volgare e osceno” ma il
processo servì solo ad aumentare la popolarità e l’interesse attorno al libro.
Il caso Fanny Hill portò anche gli americani ha produrre i loro primi
esperimenti di materiale pornografico, i “Fancy Books”, che tramite le
illustrazioni fornivano una guida ufficiosa alle pratiche sessuali. Nel museo di
New York sono anche in mostra i cataloghi dei bordelli che venivano venduti agli
angoli delle strade e che informavano la gente sulle attrazioni dei “palazzi del
piacere” e le loro dame. Una sorta di Yelp! in cui erano recensiti i casini
della città. “La gente pensa che la cultura vittoriana fosse molto puritana –
dice Sneyder – in effetti, questa è l’immagine che volevano passasse alla
storia, ma la gente di quell’epoca era anche molto curiosa, le piaceva esplorare
e documentarsi su ogni aspetto della vita”. Proseguendo nella mostra, si trovano
i “money shot”, foto di eiaculazioni, liquidi corporei, primi piani su organi
sessuali e masturbazioni ma la cosa più interessante sono i giocattoli erotici:
candelieri, manici di scopa e torce venivano usati dalle donne per eccitarsi
all’interno delle loro casette vittoriane. “All’epoca non esistevano i dildo e
le persone si arrangiavano con quello che avevano in casa”, dice il direttore
del museo Mark Snyder. All’inizio del ‘900 si iniziò anche ad esplorare tabù
come orge, sesso omo e travestimenti religiosi, pratiche che all’epoca erano
considerate illegali. Alla mostra ci sono perfino alcune delle prime
documentazioni fotografiche del BDSM: in uno scatto una dominatrice impugna la
sua frusta mentre calpesta la faccia di un uomo, in un’altra una coppia è legata
insieme con delle catene. Un altro pezzo interessante è una collezione di 120
fotografie erotiche scampate alla “Società per la Soppressione del Vizio”, che
nei primi anni venti bruciò più di 160 tonnellate di materiale erotico. Il
passaggio dalle immagini alla pellicola cinematografica avvenne con gli “stag
movie” ma la consacrazione ufficiale arrivò nel 1972 con Gola Profonda, il film
nel quale Linda Lovelace scopre di avere il clitoride in fondo alla gola. Gola
Profonda venne proiettato in tutti gli Stati Uniti e si guadagnò l’apprezzamento
di Jackie Onassis e Truman Capote, incassando più di 6 milioni di dollari. “Gola
Profonda ha segnato l’inizio dell’era del “Porno Chic” – dice Sneyder – e da
allora è cambiato tutto. La pornografia non era più illegale, ma la libertà
d’espressione causò una reazione negativa e che portò il porno ad essere
fortemente denigrato negli anni ‘80. Fu un periodo di cambiamenti molto
interessanti che pose le basi per la moderna industria del porno”.
Gloria Satta per "il Messaggero" il 15 aprile
2021. La prima scena di Bad Luck Banging Or Loony Porn è un pugno nello stomaco:
un rapporto sessuale tra un uomo e una donna consumato in tempo reale senza
filtri né censure, insomma un autentico porno. E sequenze analoghe tornano nel
corso della narrazione. Ma non hanno certo scandalizzato la giuria della
Berlinale che ha assegnato l' Orso d' oro a questo nuovo film del regista romeno
Radu Jude, 44 anni, esponente di punta della Nouvelle Vague del suo Paese, alle
spalle una carriera nel cinema d' autore costellata di presenze ai festival e
premi. «Il sesso non è osceno, lo è molto di più il potere usato per umiliare,
reprimere, sfruttare le persone», chiarisce Jude. Il film, che Lucky Red
distribuirà da domani sulla piattaforma Miocinema.it (prezzo: 6 euro) insieme
con una restrospettiva delle opere del regista, è un ritratto originale,
graffiante, spietato della società romena contemporanea descritta con
irriverente realismo e umorismo feroce. «Volevo raccontare com' è cambiato il
mio Paese 30 anni dopo la fine del totalitarismo e l' avvento della democrazia»,
spiega Radu.
IL PROCESSO. E per denunciare le ipocrisie e i
pregiudizi della società, è partito dalla disavventura della protagonista, un'
insegnante di scuola media (l' attrice Katia Pascariu, 37 anni) che rischia di
venire licenziata perché un video erotico, girato nell' intimità con suo marito,
è diventato casualmente virale sul web. Nel corso di un grottesco processo
allestito nel cortile della scuola, la donna prova a difendersi dagli attacchi
dei genitori dei suoi alunni e a riaffermare con sapienza dialettica la sua
libertà nella sfera privata, sfidando il perbenismo, la morbosità e i giudizi
moralistici sommari. «Non ci sono stati problemi per le scene di sesso, Katia è
una professionista. Ci hanno anche aiutato dei veri attori porno», dice Jude, «e
se il film passerà in tv, le sostituiremo con un codice QR che consentirà agli
spettatori di vederle sullo smartphone». Al di là delle sequenze hard, Bad Luck
Banging Or Loony Porn (letteralmente Sfortuna martellante o porno folle)
racconta la Romania di oggi in una forma narrativa originale: la finzione si
alterna ad immagini di repertorio, aforismi rubati a scrittori e pensatori,
citazioni storiche, considerazioni filosofiche e politiche del regista.
Illuminante la lunga camminata della protagonista attraverso Bucarest mentre la
cinepresa la spia da lontano: «Mi sono ispirato al neorealismo italiano, sono un
fan di Roberto Rossellini», spiega Jude. «La sequenza della camminata illustra i
problemi e le contraddizioni della mia città: cantieri, rumore, differenze di
classe, centri commerciali, gente che non ha i soldi per fare la spesa, violenza
sull' ambiente, individualismo sfrenato. Ecco quello che siamo diventati in 30
anni di democrazia». Sempre nel nome del neorealismo tutti i personaggi del
film, girato durante la pandemia, indossano la mascherina, «ma in Romania è una
lotta far rispettare le regole sanitarie», spiega Jude.
I VIDEO SUL WEB. È un prodotto dei nostri tempi
anche la diffusione incontrollata di video intimi sul web: «Di queste cose ormai
parlano tutti, ecco come ho avuto l' idea del film. Si tratta di un fenomeno
inquietante che denota la perdita di confini tra vita pubblica e dimensione
privata. Internet rischia di inseguire il consenso e azzerare le opinioni, ma
bisogna battersi contro il conformismo. E il cinema, che non racconta la verità
assoluta ma illustra il punto di vista del regista, aiuta a capire, a vedere il
mondo con occhi diversi».
Barbara Costa per Dagospia il 4 aprile 2021. A
Pasqua, tette! E tette e c*li di pasqua-fiocchettati, e corpi nudi baciati,
macchiati, immersi in pasquali bagni di cioccolato, che a rigoli scivola,
appiccicoso, goloso, sui capezzoli indurendoli, e così invitandoti, e sta a te,
indeciso, quale mordere per primo. E uova di Pasqua rotte, aperte, e tu guarda
che caz*o di sorpresa, vale a dire, la sorpresa è proprio lui, il pene, eretto,
in mezzo a uova di Pasqua a erezioni spaccate, frantumate. Ma pure uova di
Pasqua intatte, con coccarda e fioccone e tutto il resto, queste servono così,
si passano così, tra due seni grossi, gonfi, pronti, in primo piano, che voraci
usano tal uovo a mo’ di spagnola. È Pasqua-porno, coi video porno di Pasqua: non
c’è festa, pur se religiosa, che il porno non pornizzi e tratti e trasformi a
suo modo, ad esempio in video di ragazze ingenue, insieme sul letto a scartare e
gustare ovetti, non attente al maschio coniglio bianco in agguato, "affamato",
alle loro spalle. La Pasqua porno prevede sc*pate conigliesche, con coniglio
infoiato e impietoso, e coniglio sadico che non risparmia vagine, coniglio che
non lesina piacere, prima a se stesso, e poi a chi tocca. Pasqua festa da
passare con chi vuoi ma nel porno meglio se tra parenti, meglio ancora se
acquisiti, precisiamo, parenti finti, e infatti i più ammirati sono i
porno-pasqua a incesto, in reunion tra parenti ignari festanti a barbecue e
birra, mentre in camera da letto si scambiano auguri a cavalcioni, in
doggy-style, e in anfratti, su letti improvvisati, o alla bisogna stesi per
terra, mal celati dietro una porta, e si fa contenta la matrigna per una volta
l’anno non più frigida. Ma pure si sc*pa la finta sorella riprendendo tutto,
dall’inizio alla fine, perché dall’altra parte del video, sullo smartphone… c’è
il fidanzato! È questo un porno pasquale amatorial, home-made, che a views va
via come il pane, o meglio come l’uovo, pasquale. Pasqua porno in versione
fetish, coi peni pasqualizzati, truccati, trasformati, a coniglietto pasquale
verniciati, zimbelli di scherzi e scherni che li inducono all’impotenza forzata,
specchianti nella loro mollezza in uova di Pasqua trasparenti. Sono fetish gli
ovetti evacuati, in scodella defecati, da donne col loro consenso e sessuale
gioia ridotte a galline, dai loro master, padroni della loro libidine
masochista. Giochi di ruolo e da schiava-padrone, con donne prone e ferme al
guinzaglio, per Pasqua gallinizzate, donne-galline che depongono uova che sono
ovetti dildo, donne-galline che chiocciano, e poi cambiano, regrediscono in
pulcino e allora pigolano. È tutto registrato, filmato, postato. Per il tuo, il
vostro, nostro...voyeuristico piacere. C’è pure la versione-reverse, con
uomo-gallo, nell’aia della sua mistress, e pur se gallo depone l’ovetto-dildo
uguale. A che serve a Pasqua un uomo se non per ridurlo così oppure in catene,
da padrone crudeli, che ingabbiano peni goffamente burlati, a dar loro forma,
parvenza di coniglio. O pulcino. Finanche papera. E guarda che per chi vive di
tale feticismo farlo, subirlo, è una festa, è apoteosi, è suono a festa di
campane pasquali. Le fellatio si fanno a peni eretti che portano appeso il peso
di veri ovetti di Pasqua colorati. Pasqua di video conigliette lesbiche, a due,
a tre, a tre ma una coniglia è trans, con la sorpresa la più dura che si può
trovare. E conigliette sodomizzate, sì, o coniglie mistress che sodomizzano
uomini, e ancora conigliette che passano Pasqua da sole e la passano mica male,
nei porno dove si denudano a masturbarsi a sc*parsi coniglietti o grossi conigli
a grandezza umana e alcuni sono peluche, e inermi ma bianchi morbidi peli e
orecchie rosate e si infilano dappertutto, danno un piacere e orgasmi che un
sesso e mani altrui non sanno, non arrivano. Basta passarseli tra i seni, e
strusciarseli sul sesso, per venire a ripetizione. Tenerseli fermi, addosso,
supini, tra le gambe aperte, e così trattenere il godimento un tempo più lungo.
In cam a Pasqua è un via vai, uno show di conigliette continuo, e ognuna si
inconiglia da par suo, fa la smorfiosa il suo, finto impaurita o aggressiva, ma
a piacere dello spettatore godente e pagante. Esaltazione del miraggio
hefneriano, la coniglietta ogni volta accondiscendente, donna senza problemi e
che non si fa problemi, ma al pari pure l’uomo, e in cam vi sono anche i
cam-boy, quelli per donne sono pochi, qui il mercato risulta più ampio e più
orientato ai gay. Una donna, o la gran parte di loro, di sola visione vi fa
poco, scarta sì con gusto, e della sorpresa che trova non vuol essere delusa.
Allora si vira ai video a orgia di Pasqua, e specie lesbici con dildo-carote, in
finte camporelle ricreate sui set, come le nostre pasquette sul prato sui plaid,
con ovetti di Pasqua che se li apri sono densi, e ti colano in bocca, sulle
labbra, sul corpo, è cioccolato bianco fuso sogno di sperma (tra i video di
orgia pasqua lesbica, sia dia uno sguardo, o più d’uno, a quelli proposti su
porncorporation.com).
Estratto dell'articolo di Maurizio Di Fazio per
il "Fatto quotidiano" il 21 marzo 2021. Gli organi genitali in bella mostra, di
un 2d che doveva sembrare tridimensionale, piombarono sul grande schermo
italiano nel 1980. Una data assolutamente sintomatica. Il precursore dei
cinematografi dedicati al porno era stato il Majestic di via Lambro, a Milano,
nel 1977. Lo si riconosceva da un lampeggiante dei pompieri all' ingresso. A
luci rosse, appunto. E con un avviso spartiacque: "Immagini non adatte a un
pubblico sensibile". La battaglia con la censura era vinta. […] Anche le
locandine di genere conobbero la stessa sorte. Tutt' a un tratto, spuntarono in
ogni anfratto, nei boulevard del centro e nelle vie di periferia. […] Guarda a
questa riforma, o controriforma, del costume la mostra che sta per debuttare al
Centro per l'arte contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Curata da Cristiana
Perrella […] si intitola Cult Fiction e ha per protagonisti i manifesti dei film
erotici apparsi nelle strade di Napoli e Aversa tra il marzo 1978 e il dicembre
dell' 80. Negli scatti re-installati, qui oltre sessanta, della fotografa
campana Marialba Russo. "Esplosione di una vitalità ormai perversa, ma pur
sempre tale, nella storia della cultura popolare", scrive a proposito Goffredo
Fofi. […] Siamo in territorio softcore, ma la sostanza non cambia. "Oggi al
cinema Mignon La Pornopalla" (titolo originario, The cheerleaders), recita una.
Isabel Sarli è L' insaziabile, tratteggiata in un voluttuoso bianco e nero
stilizzato. Girato da tal Armando Bo nel 1976, pare in Argentina, narra
eufemisticamente le gesta di Carol, moglie di un medico con la fissa delle
avventure pruriginose. E il marito, devoto a Ippocrate, proprio non riesce a
stare ai suoi ritmi. I cine-filologi lamentano: chi ha tagliato su YouTube la
scena campale in cui la signora copula con il fattore nella stalla, mentre i
mandriani spiano l'amplesso dalla fessura? […]
DAGONEWS il 21 marzo 2021. Il vostro uomo non fa
che deludervi sessualmente, andando di continuo alla ricerca di avventure
estreme, sesso acrobatico, ammucchiate e chi più ne ha più ne metta? Tranquille
donne, nulla di strano, non c'è da preoccuparsi. Parola di Tracey Cox,
scrittrice inglese e famosissima esperta del sesso, che ha voluto studiare
attentamente questa fase piena di lockdown in cui il pc è stato visto come unica
via di fuga. Non c’è da meravigliarsi che si è registrata un’impennata di click
a siti a luci rosse che, in Gran Bretagna, ha fatto registrato un più 30%.
Quando (e perche') non preoccuparsi. Ansia, noia,
depressione. Questi gli stati d'animo che portano gli uomini, definiti dalla
santona sessuale come delle "bestiole pervertite", a ricorrere al sesso
individuale come sollievo dalle frustrazioni della pandemia. Una volta superata
quella, assicura, la dipendenza da porno sarà molto meno intensa e tornerà ai
livelli di una volta. Ma nel frattempo? E' importante che ogni partner non si
senta abbandonata, messa da parte, e soprattutto che non pensi di avere un
maniaco sessuale in casa. Dopotutto il porno viene guardato perché è veloce,
sempre pronto all'uso e non porta complicazioni nella vita reale.
Gli uomini non vorrebbero mai stare davvero con
una pornostar. Cox assicura, tramite ricerche, statistiche e interviste, che gli
uomini non uscirebbero quasi mai con una delle donnine viste sullo schermo. «A
me piace che la mia ragazza sia naturale», assicura uno di loro. Si tratta
quindi di innocue fantasie: «Le donne dei porno fanno cose interessanti -
racconta un intervistato - Ma questo non significa che le richiederei alla mia
partner». «Gli uomini fantasticano sul sesso a tre con le spogliarelliste, ma
ciò non significa che vogliano uscire con una di loro» rassicura Cox.
Quando il porno diventa un problema. Il porno
insomma esiste, normalmente, solo finché si arriva al coito, una pratica usa e
getta, totalmente sana che non lascia strascichi e conseguenze nella vita di
coppia. Questo però è valido solo quando la vita sessuale non subisce drastici
cambiamenti; se avvertite un calo, mette in guardia la scrittrice, allora forse
ci sarebbe da preoccuparsi. Il porno è considerata un'attività aggiuntiva, che
nulla toglie ai rapporti a due.
I segnali di rischio. La Cox stila, con precisione
austroungarica, una lista di segnali che dovrebbero fare insorgere qualche
preoccupazione:
- Il porno influenza il suo lavoro, la vostra
relazione o il suo inserimento sociale
-Non riesce ad avere un'erezione senza un video
porno in sottofondo
- Decide di travalicare il limite della virtualità
interagendo con ragazze in webcam, andando da una prostituta o dedicandosi a
incontri occasionali
- Passa più di 11 ore a settimana guardando film
porno
Come affrontare il problema di dipendenza da porno
(se scopri qualcosa online o smette di fare sesso con te). L'esperta del sesso
assicura che in caso di esagerazioni, problemi e vera e propria dipendenza da
porno, l'unica soluzione sia affrontare di petto il fedifrago virtuale, in un
momento di tranquillità, senza farlo sentire un drogato o uno schizzato.
Chiarire che si è disponibili e consapevoli nel parlare della situazione, anche
se lui va subito sulla difensiva. Niente scenate post-blitz sulla cronologia
insomma, anche in questo frangente la sola tattica di snodo è data dal
comunicare efficacemente.
Il sesso online dei fedifraghi contenti
così anche il piacere diventa virtuale. Una sessualità
vera e propria, snaturata nel suo contatto fisico. Basta una connessione:
l’altro prende forma e siamo Avatar di noi stessi. Francescapaola Iannacone su
Il Quotidiano del Sud il 21 marzo 2021. In una società liquida come quella
attuale, dove le certezze mancano e la realtà odierna costruisce ogni giorno le
sue basi sull’indecisione, il tutto avallato dal difficilissimo momento storico
che stiamo vivendo, anche le relazioni “amorose” hanno mutato la loro forma. Se
prima ci si incontrava occhi negli occhi, bocca su bocca per dimostrarsi
interesse emotivo, adesso – causa confinamenti imposti – gli appuntamenti tra
esseri umani si sono trasferiti sulla digitalizzazione. Dentro una società
computercentrica, l’antropologia delle persone sta riscrivendo la sua storia
soprattutto per quello che riguarda il piacere nella sua fattezze corporali.
Durante la pandemia sono aumentate esponenzialmente le relazioni virtuali,
soprattutto per i single che non avendo un compagno di divano per le serie tv o
di letto, hanno pensato bene di intessere la tela di Penelope attraverso la
virtualità facendo in modo che anche il sesso trovasse la sua valvola di sfogo
in un fenomeno definito con un neologismo inglese, “sexting”, ovvero due
partners consenzienti che, attraverso lo scambio in chat di messaggi o
fotografie dal contenuto inequivocabile, provano a stimolare i neuroni
immaginifici del desiderio, cercando di procurarsi piacere. I più impavidi
ricorrono anche al sesso telefonico o alle videochiamate. Una sessualità vera e
propria, snaturata nel suo contatto fisico. Basta una connessione e l’altro
prende forma. A sentire il chiacchiericcio che gira intorno alle confidenze tra
amici, una pratica questa che ha solleticato anche l’interesse dei “fedigrafi
felici”: uomini e donne costretti a vivere sotto lo stesso tetto con il proprio
congiunto per ventiquattr’ore, per non replicare la “Guerra dei Roses”, causa
esaurimento nervoso, si sono dati a questa “pratica alternativa”. Dove trovano
il luogo nascosto ed il tempo per farlo visto che ad oggi la privacy è ridotta
all’osso, queste sono domande senza risposta. Poco importa, la fotografia della
realtà mostra un tessuto sociale dispersivo, fagocitato da una delle più
catastrofiche emergenze sanitarie degli ultimi secoli, ormai algoritmo di se
stesso. In pandemia, dove baci e abbracci sono finiti relegati in quei divieti
che colorano le regioni ogni quindici giorni e per alcuni sfornare pizze è stato
un surrogato per azzittire la libido, le App per incontrarsi attraverso il
“contraccettivo dei pixel”, sono state un vero e proprio escamotage, andando a
sostituire quasi del tutto le passeggiate al supermercato per incrociare lo
sguardo (forse?!) dell’anima gemella, semmai lungo la corsia reparto “porzioni
monodose per single indefessi”. E se l’era digitale permette di creare una
moltitudine di interazioni con l’altro, costituendo un ponte d’unione anche
quando si è a tanti chilometri di distanza, il connettersi ad internet ha dato
luogo anche ad un altro fenomeno: le escort online. In forte aumento le
videochiamate erotiche a pagamento. Quindi anche la prostituzione si è creata la
sua nicchia in smartworking. Secondo gli ultimi dati presi in esame da Escort
Advisor, sito adibito proprio per questo tipo di annunci, attraverso un
sondaggio anonimo condotto tra i suoi iscritti, le stime parlano di quasi 2
milioni di utenti per quello che riguarda l’Italia, il sesso online attraverso
questa modalità ha subito un incremento andando a bilanciare il calo – nel
settore del sesso a pagamento – registrato invece durante il primo lockdown.
Tutto evolve e si adatta in un futuro darwiniano dove la staticità, sembra, non
la si giustifichi più neanche alle statue di marmo. Si sta riscrivendo,
inevitabilmente e senza neanche troppa fatica, un nuovo codice comportamentale
tra le interazioni umane. Avatar di noi stessi, davvero anche l’orgasmo può
trovare la sua piena soddisfazione nelle solitarie pareti di casa? Il prezzo da
pagare, in termini d’identità, è un vuoto così enorme da far diventare la vita
una consistenza nel suo effimero. Certo si fa di “necessità virtù”, come
sostenevano gli antichi, ma se tutto questo poi diventasse l’unica prassi
ricercata? Ogni comportamento umano, nella sua pratica, preso in analisi sul
lungo periodo, rischia di diventare poi regola, depauperando nella sua struttura
originale, quello che dalla notte dei tempi è uno degli aspetti più belli della
sfera umana: il sesso fatto di contatto fisico, scoperta dell’altro, odore,
sapore e godimento. Immaginarsi quel metaforico “spalla a spalla” in 3D, senza
neanche gli occhiali plastificati che fornivano all’ingresso del cinema negli
anni ’90, non procura quell’entusiasmo che invece dà la scarica di endorfine
tattili e visive. È vero che la pandemia ha relegato negli smartphone e dietro
lo schermo di un computer ogni sorta di attività, da quelle burocratiche a
quelle più “ludiche”, ma se per alcune queste modalità possono accelerare il
loro svolgimento per altre è proprio lo svuotarsi del loro significato. Quando
questa emergenza sanitaria sarà finita, si spera il più presto possibile,
bisognerà riappropriarsi anche del contatto con l’altro in diverse forme. Il
distanziamento sociale, che adesso funge da metaforico “muro”, dovrà essere
abbattuto da una serie di gesti volti a riconoscere di nuovo quelle sensazioni
piacevoli che scaturivano nell’abbraccio dentro l’altro. Un compito difficile
per una società che volge lo sguardo verso la visualizzazione compulsiva,
asettica anche nella condivisione se non quella dei post. Ma non impossibile.
Anche perché tra le corsie dei generi alimentari si fanno sempre piacevoli
incontri, le confidenze tra amiche sono una cartina di tornasole.
Elettra Gullè e Emanuele Baldi per lanazione.it il
13 marzo 2021. La pornografia entra a scuola per parlare, in modo sincero e allo
stesso tempo soft, di parità tra i sessi, di piacere e consapevolezza del
proprio corpo. Ad infrangere il tabù è una scuola all’avanguardia come l’Itt
Marco Polo, guidato da Ludovico Arte. Ecco che, rigorosamente online, visibile a
tutti, è andata in scena l’assemblea a cui hanno partecipato Sara Brown,
performer e attivista, e Antonella Questa, attrice e autrice teatrale. È in
particolare su Sara che si sono concentrate le curiosità dei ragazzi. Del resto
lei stessa ha affermato di aver recitato in alcuni cortometraggi di sesso
esplicito. "Ho iniziato nel 2017 con la mia compagna. Non ci sentivamo
rappresentate dai video lesbici e abbiamo voluto rompere gli schemi". Insomma,
un "porno etico", in cui "si supera il concetto del maschio dominatore per
affermare quello della parità tra i sessi". "Hai mai avuto ripensamenti?". "Il
modo di vivere il porno adesso è dannoso per entrambi i sessi?". "Quali sono i
requisiti per entrare nel settore?". Tramite il profilo Instagram della scuola i
ragazzi hanno posto le domande, ‘girate’ in forma anonima alle protagoniste del
dibattito. "All’inizio la mia famiglia ha reagito male - ha ammesso Sara -.
Comprendo il loro desiderio di non mescolarsi con un certo ambiente e dunque
cerco sempre di proteggerli. Purtroppo se si parla di porno i più si riferiscono
a PornHub. Invece è molto di più. Da parte mia c’è il desiderio di tornare al
porno di un tempo, quando la rappresentazione del sesso si univa alla passione,
al racconto di una storia. Adesso invece è tutto ‘usa e getta’. Si inquadra
l’atto e poco più". "Online abbonando situazioni stereotipate, col risultato che
molti giovani nutrono un senso di inadeguatezza - ha aggiunto Questa -. A voi
ragazzi rivolgo un invito: conoscetevi. Ascoltatevi e ascoltate. Anzi, mando un
abbraccio virtuale a tutti quegli studenti che col turpiloquio emerso in alcune
chat hanno mostrato la loro fragilità. È importante che di questi temi si parli,
senza vergogna e paura". E sul tema abbiamo sentito un vero esperto del settore,
l'attore hard Rocco Siffredi. "A Firenze hanno fatto un dibattito a scuola sulla
pornografia? Finalmente, era l’ora. E’ un passo in avanti enorme". A Siffredi,
figura di culto della pornografia, la dignità di quel mondo che lo ha reso una
sorta di icona pop di più generazioni sta molto a cuore.
Siffredi, che entusiasmo.
«E’ una bellissima cosa e chi l’ha pensata è stato
un grande».
Sono stati gli studenti stessi.
«Chiaro. E’ una necessità che loro sentono e che
noi dobbiamo recepire. Dobbiamo connetterci con loro, non più con il nostro
passato. Mio padre solo a 70 anni ha iniziato a parlarmi apertamente del sesso.
’Se non lo faccio con te’ mi disse...».
Ci sono ancora molti tabù?
«Sì. Dobbiamo capire una volta per tutte che il
sesso è una variante della natura. Parliamone naturalmente, senza vergogna. Mi
fa piacere che questa iniziativa arrivi proprio a Firenze».
Perché?
«Perché da voi anni fa un prof bloccò la mia
partecipazione a un incontro. "Non prendiamo lezioni da Siffredi", disse».
Ragazzi e ragazze hanno chiesto se è normale
essere gelosi se il partner guarda video porno. Che ne pensa?
«Sbagliato. Nessuno ci appartiene, ognuno decide
della sua vita. La gelosia è qualcosa di primitivo. Porta alla violenza».
Barbara Costa per Dagospia l'8 febbraio 2021. Che
ogni pornostar si doti di un avvocato! Che si porni secondo la legge,
altrimenti, tutti in galera! Guai ai porno-trasgressori! Sì, va bene, il porno
sarebbe anche d’accordo, ma… quale legge? Se pensate che il mondo del porno
accetti passivo la guerra che gli stanno facendo, e che chini la testa senza
combattere chi lo vuole censurare, blindare, dettargli regole senza capo né
coda, lasciate stare. Il porno non ci sta. No, non ci sta: sul presente e futuro
di Pornhub e soci, e del porno in rete, e dei social tipo OnlyFans che non sono
semplici social ma "luoghi" di lavoro a tutti gli effetti, il porno vuole dire
la sua, vuole guidare un riforma necessaria, ma una riforma che non deve portare
a censure, né togliere nulla alla libertà e all’autonomia conquistate. E allora:
si vuole combattere la pornografia minorile, il traffico di minori, il revenge
porn, il materiale hot che gira in rete rubato? Ottimo, sacrosanto, ma lo si
faccia legiferando leggi applicabili in concreto. I fatti: il mondo del porno è
in subbuglio dopo l’articolo del New York Times, a firma dell’editorialista-star
Nick Kristof, che denuncia come Pornhub sia stato finora scarso nel controllo
dei video che chiunque su Pornhub può postare. È vero, non tutti quei video
ritraggono persone consenzienti: lì c’è una (piccola?) parte di video amatorial
che amatorial non è, nel senso che ritrae atti sessuali non consensuali, e
alcuni con dei minori. Pornhub non li ha controllati e, dopo il boicottaggio
subito da due carte di credito, è intento a far pulizia interna totale. Pornhub
si muove, e gli altri siti? E tutto lo schifo che gira nel Deep Web? Non è che è
stato colpito Pornhub per intimidire gli altri, infine tutti? C’è chi negli USA
mette in dubbio l’imparzialità di Kristof, dicendo che il suo articolo è
oltremodo basato su fonti ricollegabili ad attivisti anti-pornografia legati a
lobby potenti che premono sul Congresso affinché si uccida il porno a suon di
leggi. Lo sostiene su New Republic Melissa G. Grant: questa nota giornalista
dice senza mezzi termini che l’articolo di Kristof - e il pietismo con cui è
scritto - è servito da stura per alcuni senatori americani i quali presentano
disegni di legge anti-porno mica per ripulire il web, ma per bearsi di followers
e fama mediatica. Ci sono disegni di legge come il SISEA, scaduto con la
presidenza Trump, e pronto a essere ripresentato sotto quella Biden. Il SISEA
vuole chiudere ogni sito che “ospita sesso”. Alana Evans, combattiva capa del
sindacato del porno, chiama alle armi. Lei lo dice chiaro: Biden è come Trump
contro il porno in rete, anche Biden vuole togliere il Primo Emendamento di
Internet, cioè la Section 230, cioè la legge del 1996 che esenta i proprietari
di siti dalla responsabilità di ciò che ogni utente sui siti posta. Si vuole
dare responsabilità editoriale ai padroni dei siti, quindi pure a Zuckerberg e
co.? Se sì, quanta e quale? La politica USA vuole imporre regole al web, e
queste regole, dove valgono, solo sul suolo americano? Pornhub è canadese: che
si fa, lo si caccia dagli USA!? E, più importante: per quel che riguarda il
porno - e non solo il porno - si vorrebbe per legge che ogni utente, su un
social (tipo OnlyFans), per ogni azione che voglia lì compiere, minimamente
lasciva… d’ora in poi debba ottenere da chiunque voglia vederla, i dati
anagrafici e un consenso scritto, e da rinnovare per ogni accesso. Questi dati
poi che fine fanno? Vanno in un database (pubblico?) gestito da chi? Ma non
basta: al porno - e affini - si vorrebbe imporre consenso retroattivo! Cioè: non
solo per ciò che attori, cammer, stripper o chiunque amatorialmente d’ora in poi
voglia fare (e a ogni cristo che tali performance da pc/tablet/smartphone voglia
vederne) ma serve pure il consenso di chi il porno non lo fa più, o lo ha fatto
una volta, una scena, finanche amatorial. Come se fosse possibile rintracciare
tutti! E da tutti si vorrebbe "testimonianza" che ogni volta, mentre si compiva
l’atto sessuale “si stava bene, a proprio agio, non pressati” (?!). Se questo
consenso non si ottiene, il video girato non si può più usare. È bandito dal
web. È illegale. Si vuole ripulire la rete da tanta inqualificabile monnezza che
gira: OK, ma come si fa ad assicurarsi - in modo chiaro, fattibile - che
dall’altra parte ogni volta non ci sia un minore, uno/a non in sé totalmente,
uno/a che ogni volta sia consapevole di quel che vuole fare e/o vedere? Come si
fa, quando è uno scherzo mutare la propria identità online? Come dobbiamo agire,
nel rispetto di tutti, e di queste leggi che, seppur in fieri, sembrano seguire
una moralizzazione della società virtuale? Mettiamo bende e bavaglio a tutto il
mondo? Instauriamo una differenza tra siti gestiti dallo Stato e siti gestiti da
privati? Con quelli statali a regole e tasse certe, mentre i privati continuano
a fare come gli pare? Dacché, si valuti questo: i siti, non tutti ma parecchi,
per ciò che mettono a disposizione, possono essere considerati servizio
pubblico? Se sì, quali regole devono seguire? E chi gliele dà? Chi le decide? Si
vuole monitorare il porno online, “abolendo immagini e azioni di sesso
esplicito”. Ditemi: cosa è esplicito? Chi lo stabilisce, il ministero della
decenza!? È esplicito un pene dentro una vagina? Un pene sì, e due no? E due
dentro un c*lo? Seni e capezzoli sono esentati? Due donne e più, insieme,
possono esibirsi? Si possono masturbare? Con dita, dildo, o cosa? E lo sperma?
Che ne si fa? Si censura? E la saliva? Leccata sì e sputata no? Decidere non è
facile. Permettiamo tutto, tranne lo scat? E pissing e squirting? Si possono
fare finti? È un bel casino. Ora che ci penso, sperma, secrezioni, piscio, sono
materia d’arte per qualcuno… e la m*rda di Manzoni!? E poi: una nuova
legislazione non deve minare il lavoro autonomo di chi si mette su OnlyFans e
simili: in piena pandemia, OnlyFans ha fatto il boom, e non si contano gli
accessi di chi, rimasto senza lavoro, trova in OnlyFans fondamentale fonte di
reddito. Che deve fare una persona che vuole ad esempio spogliarsi e dai suoi
webshow guadagnarci? Dotarsi di avvocati e scartoffie, e passare al setaccio
ogni utente, e ogni volta, ad ogni accesso? E qual è l’età "giusta" della
maturità sessuale? 18 anni? E chi lavora col sesso in rete, è un lavoratore
autonomo, sì o no? Quando per legge si renderà chiaro? (faccio notare che
singole persone che sul web fanno porno e/o sexy show home-made, si registrano e
fatturano come impresa). E gli abbonati a un social di porn-web-star, cosa sono,
"clienti"? Per loro, la privacy vale? Il porno vuole cambiare, nel rispetto
delle regole, ma vuole questo cambiamento capire, per assumersene decisioni e
responsabilità. Come da sempre fa. Politici di ogni partito e Paese, attenzione:
il porno professionale, le sue scartoffie, il suo consenso scritto, approvato e
firmato, ce l’ha già! Da anni! Inoltre, sui set, davanti a una telecamera, prima
di ogni scena, ha il viso di ogni attore, con accanto un documento di identità
ben visibile, immortalati a prova di chi quella persona è (come d’ora in poi
farà Pornhub, attraverso un sistema di verifica d’identità digitale). Segue
breve intervista filmata pre scena, che ci attesta la "consapevolezza" di ciò
che si sta per fare. Finito di pornare, ci sono i video post scena e i selfie
post scena, che provano e assicurano che tutti stanno bene, e non si è "fatto
male", e del male, a nessuno.
·
Mai
dire...prostituzione.
Da agi.it il 24 novembre 2021.
Le ragazze nigeriane reclutate e introdotte in Italia venivano vessate,
sottomesse e poste in uno stato di vulnerabilità psicologica, determinato anche
dalla celebrazione di macabri riti "voodoo" a garanzia del debito contratto per
arrivare nel nostro Paese. E' quanto accertato dalla Guardia di Finanza,
coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla procura di Cagliari su
una associazione a delinquere di matrice nigeriana finalizzata al riciclaggio
internazionale di capitali illeciti dedita anche al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina. L'inchiesta ha portato a 40 arresti. Sono
complessivamente 122 le persone coinvolte nel procedimento che ha riguardato il
gruppo criminale dell'Eiye "Supreme Confraternity of Air Lords". Un primo filone
investigativo è originato dall'acquisizione di informazioni - spiega una nota
della Guardia di Finanza - successivamente corroborate con l'acquisizione di una
denuncia di una donna introdotta clandestinamente in Italia, concernenti
l'esistenza di un'estesa rete di persone, operanti tra la Nigeria e l'Italia"
che ha costretto "giovani donne nigeriane, a fronte delle promesse di
opportunità lavorative nel nostro Paese, ad assumersi ciascuna debiti, anche di
25, 50 mila euro, compreso le spese del viaggio verso l'Italia". Debiti che le
vittime avrebbero dovuto saldare per ottenere "in cambio la libertà ed evitare
conseguenze lesive per loro stesse e i propri familiari in Nigeria". Il
provvedimento dell'Autorità giudiziaria di Cagliari, che ha consentito di
liberare le giovani vittime dal vincolo di coazione fisico-psicologico cui erano
costrette.
Dove operavano i gruppi
criminali
Le indagini hanno portato alla
luce "una struttura reticolare suddivisa su tre gruppi criminali radicati,
rispettivamente, in Sardegna (nel cagliaritano), in Piemonte (nel torinese), in
Emilia Romagna (nel ravennate), ma con operatività estesa in altre aree italiane
e transnazionale (in Nigeria, Libia e Germania), dediti alla commissione dei
reati innanzi indicati, ma anche di identificare le vittime, 50 donne nigeriane,
reclutate e condotte da propri connazionali dalla Nigeria". In totale sono state
41 le ragazze destinate alla prostituzione, mentre 9 quelle costrette
all'accattonaggio in aree cittadine ove gli indagati avevano ubicato "postazioni
di lavoro" sottoposte alla loro influenza e gestite da soggetti ("madame" o
"sister/brother") dediti allo sfruttamento delle connazionali e/o addetti al
controllo sul regolare svolgimento delle attività da parte delle vittime e alla
riscossione del pagamento coattivo di un canone mensile di 150 euro per
l'affitto di dette "postazioni". Il denaro, secondo quanto spiega la Gdf, veniva
riciclato prevalentemente con investimenti immobiliari da realizzare in Nigeria
mediante l'utilizzo di corrieri "portavaligie", l'effettuazione di ricariche su
carte prepagate, attraverso canali di money-transfer.
Undici squadre di corrieri
Gli indagati operavano tramite
11 squadre "di corrieri, costituite da un'estesissima rete di collaboratori
scelti per affidabilità ed efficienza, in Sardegna, Piemonte, Veneto, Lombardia
ed Emilia-Romagna. Nove indagati operavano dall'estero (Libia, Nigeria e
Germania) e avevano il compito di trasferire i fondi illeciti diversificando sia
le modalità di occultamento del denaro, sia i corrieri incaricati, sia ancora
gli scali di partenza onde eludere i controlli e diminuire i rischi di sequestri
e sanzioni". Sono stati individuati 7 centri hawala e ricostruiti trasferimenti
di valuta per oltre 11 milioni di euro effettuati dal territorio nazionale alla
Nigeria attraverso ricariche su carte PostePay e Vaglia On Line. L'attivazione
del dispositivo di contrasto valutario dei Reparti del Corpo ha, altresì,
permesso di controllare 44 corrieri partenti da scali aeroportuali italiani in
86 diverse occasioni, e di monitorare il "passaggio" di 1.852.698,83 euro, con
conseguente sequestro di somme per 712.099,32 euro e applicazione di sanzioni
amministrative per 510.244,32 euro.
Da liberoquotidiano.it il 2 dicembre 2021. Viaggio
nel mondo della prostituzione minorile a Non è l'Arena, il programma di Massimo
Giletti in onda su La7, che torna ad occuparsi del tema nella puntata in onda
mercoledì 1 gennaio. Ospite in studio ecco Marianna, una delle ragazze che per
prima, molti anni fa, fece esplodere il caso delle baby-squillo a Roma. E
Giletti, con Marianna, rivive il momento in cui nel 2013, in procura, raccontò
"il primo tassello di questa storia". Insomma, raccontò come iniziò a
prostituirsi: aveva soltanto 15 anni. Il racconto, a tratti agghiacciante, fa
riflettere: "È partito tutto dalla mia migliore amica: così per caso mi disse...
non pensi sia più bello non chiedere più niente a nessuno e avere la propria
indipendenza? Siamo andati a vedere sui vari siti, c'erano annuncia da baby
sitter e dog sitter. All'inizio non ero molto interessata, mi chiedevo: chi
vuole far lavorare una ragazzina di 15 anni? Chi la prende?", ricorda Marianna
davanti ai pm, così come si vede nelle immagini mostrate a Non è l'Arena. "Lei
però - riprende Marianna riferendosi all'amica - ha letto un annuncio, su
Bacheca annunci, che diceva: volete lavorare subito e guadagnare in poco tempo
tanti soldi? Lei ovviamente ha cliccato. Io ho iniziato dopo, lei diceva di
stare bene. Io le ho chiesto: ma non ti crolla il mondo addosso a fare certe
cose? E lei mi dice: questo è il prezzo che devi pagare secondo me per avere
quello che vuoi. Noi vogliamo tanto, penso tutti gli adolescenti... voglio la
macchinetta, voglio quello, voglio quell'altro. Voglio troppo...", concludeva
Marianna.
Maria Latella per il
Messaggero il 24 novembre 2021. La ragazza dei Parioli era una quattordicenne
sola in un mondo di adulti troppo presi da se stessi per occuparsi di lei.
Adulta era sua madre che accettava i soldi di una quattordicenne. «Dove li
prendi?». «Tranquilla, spaccio cocaina». Adulto era l'uomo che le procurava i
clienti. Anche per lui, evidentemente, i soldi contavano più di ogni altra cosa,
inclusa la sua coscienza e la vita di una ragazzina. Adulti, a volte anziani,
erano gli uomini che usavano il suo corpo. Ora Marianna si racconta in uno
speciale in due episodi prodotti da Crime+Investigation in onda ieri e questa
sera sul canale 119 di Sky. Questa conversazione ha, per me e per lei,
soprattutto uno scopo: aprire gli occhi a quei genitori che, per infiniti
motivi, preferiscono non sentire, non parlare. Non vedere. Cominciamo dalla
Marianna di oggi. Hai 22 anni, un lavoro, un fidanzato.
Come hai ricostruito la tua
vita?
«Sono stata in comunità mentre
mia madre era in carcere, condannata per sfruttamento della prostituzione
minorile. Ho ricominciato a studiare, ho preso il diploma da grafica
pubblicitaria e sono tatuatrice. Oggi lavoro in un supermercato, sto al
bancone».
Eri una ragazzina dei Parioli,
ma in casa non c'erano soldi. Quanto era, quanto è ancora, importante per una
adolescente avere accesso a vestiti, borse, scarpe che costano centinaia o
migliaia di euro?
«Possederli, esibirli, mi
faceva sentire parte di un gruppo, di un ceto sociale. Oggi per me non hanno
valore, non sento il bisogno di appartenere a un gruppo perché sfoggio una
borsa, ma per la ragazzina di otto anni fa significava colmare un vuoto.
Comprare quella maglietta costosa significava pensare a me in un momento in cui
sentivo che non ci stava pensando nessuno. Era il mio modo di volermi bene. La
stessa cosa per i taxi. Ho speso tanti, tanti soldi in taxi. Perché? Perché mi
piaceva che qualcuno venisse a prendermi, ad accompagnarmi. Mi sentivo sola e
cercavo di non esserlo».
A che età tua madre ha smesso
di accompagnarti e venirti a prendere? Qual era il tuo rapporto con lei?
«Fino ai miei 14 anni il
rapporto è stato di fiducia reciproca. Andavo bene a scuola e lei si fidava di
me. Poi ho cominciato ad uscire la sera, le dicevo un sacco di bugie e lei si
fidava perché fino ad allora ero stata una figlia modello. Se dovessi dare un
consiglio ai genitori è quello di non accontentarsi delle risposte dei figli.
Parlare, ascoltare, drizzare le antenne quando si capisce che qualcosa non va. I
genitori hanno sensori che non possono ignorare».
Tua madre invece per tanto
tempo li ha ignorati, quei sensori. Perché?
«Questa è una cosa da chiedere
a lei. Ha scelto di non vedere perché era sola e, fondamentalmente, non sapeva
cosa fare. Aveva perduto il lavoro, io ero nella fase più difficile
dell'adolescenza Ha provato a chiedere aiuto ma non è bastato».
Perché?
«La persona alla quale si era
rivolta le consigliò di denunciarmi, ma lei non se l'è sentita. A mia madre
avevo detto che i soldi li trovavo spacciando cocaina».
Sarebbe stato meglio
denunciarti?
«Si. Io con mio figlio lo
farei. Se non fossi in grado di gestire la cosa lo farei. Certo capisco che per
una madre ammettere il fallimento non è facile».
Per mesi, tra il luglio e
l'ottobre di otto anni fa, la tua vita di quattordicenne è stata quella di una
squillo. Ma gli adulti attorno a te non se ne accorgevano? Tua madre, tua nonna,
i professori quando è iniziato l'anno scolastico Nessuno diceva niente?
«Mia nonna è una grande donna,
una lavoratrice, ma io in quei mesi la vedevo poco, un paio di volte a
settimana. Si era accorta del fatto che stavo male, ma con gli adolescenti gli
adulti tendono a pensare è l'età».
E tua madre?
«Mia madre sa di aver
sbagliato. Quando è uscita dal carcere e anche prima si è scusata tanto e ha
tanto pianto. Non era lei a chiedermi i soldi, glieli davo io per aiutarla.
Vorrei dire a quei genitori che fanno finta di non vedere perché non sanno cosa
fare Chiedete aiuto, invece. È un segno di forza e non di debolezza».
Ma la scuola? Neanche a scuola
tra settembre e ottobre si sono accorti di niente?
«Andavo al Giulio Cesare. Un
paio di professoresse mi hanno avvicinato per dirmi Non buttarti via. Ma poi ho
smesso proprio di andarci a scuola e allora hanno cominciato a chiamare mia
madre. Guardi che se sua figlia non frequenta deve ritirarla da scuola».
Tutto qui?
«Sì, ma anche quando le
professoresse hanno provato a parlarmi, io non le ascoltavo».
Perché?
«Perché non mi fidavo degli
adulti e non riconoscevo l'autorità. Ero convinta di poter capire e imparare
tutto da sola. La svolta c'è stata quando ho cominciato a uscire la sera. Stare
fuori di notte mi faceva sentire adulta. Mia madre mi diceva Torna a
mezzanotte.
A mezzanotte a quattordici
anni ?
«Si ma io comunque tornavo
alle 3, alle 4. Ero una bambina convinta di essere diventata adulta. E per mia
madre non era facile gestirmi. Era da sola».
Un consiglio alle mamme che si
trovano da sole a gestire l'adolescenza?
«Tenete unita la famiglia.
Separarsi non significa odiare il proprio ex. Bisogna mettere da parte la
rabbia, anche le ragioni di rancore, e concentrarsi sul figlio. Pensare a lui
per primo». Poi c'erano gli altri adulti. L'uomo che vi procurava i clienti
«Negli anni della comunità ho cercato di pensare a me e basta. Quell'uomo ci ha
usato, come tanti altri si è servito dei nostri corpi. L'ha fatto per denaro, ma
chi fa una cosa del genere deve avere un tale vuoto dentro».
Lui vi vendeva. E gli altri,
gli uomini che vi compravano?
«Ci sono tre ipotesi. O
credevano alla nostra bugia, quando dicevamo di avere 18 anni e non si
accorgevano della differenza tra una quattordicenne e una diciottenne. O si
tappavano gli occhi. Oppure».
Oppure?
«Oppure... Oppure gli piaceva.
Sapevano ed erano attratti da noi per quello. Perché eravamo ragazzine. Comunque
c'è un altro gruppo di adulti che dovrebbe vergognarsi. Quelli che mi hanno
catalogato con due parole messe in croce. Che hanno scritto il mio nome sui
giornali anche se ero minorenne».
Noi giornalisti insomma.
«Quelli che chiedevano Quanto
prendevate per un rapporto a tre? O che hanno titolato Minorenni si
prostituivano per la cocaina. No: le minorenni si prostituivano perché avevano
un problema. Ho deciso di partecipare a questo documentario anche per far
sentire la mia campana. In tv hanno mandato in onda un'intervista che non ho mai
fatto, con una voce mascherata. Io a 14 anni mi prostituivo per soldi, ma loro,
loro non l'hanno fatto per soldi? Quelli che in tv o sui giornali hanno scritto
senza pensare alla violenza che stavano usando contro di noi perché l'hanno
fatto?».
E oggi? Hai fiducia nella
gente o no?
«Si, ho fiducia nel genere
umano perché se ce l'ho fatta io possono farcela tutti. Basta uscire dalla bolla
immaginaria che a volte ci imprigiona. Ho fiducia, sì. Se no non avrei fatto il
documentario. Il mio ragazzo, i miei familiari sono preoccupati delle
conseguenze Ci saranno commenti negativi, di nuovo. Ma ho fiducia. Anche nei
telespettatori».
Daniele Autieri per "la Repubblica" il 18
Novembre 2021. «Ero sotto shock. Quando arrivarono i carabinieri a casa dissi
"Ciao ma'", pensando di tornare in due ore. La rividi dopo tre anni». Il viaggio
di Marianna inizia da lì: la porta di casa che sbatte e la carraia del Palazzo
di Giustizia di Roma che si apre davanti a suoi occhi. Lei, la 14enne che
insieme ad un'amica si prostituiva in un seminterrato dei Parioli, il quartiere
"bene" di una capitale smaliziata e corrotta, si confessa in un'intervista
esclusiva rilasciata a Paola Zanuttini che sarà pubblicata integralmente domani
sul Venerdì. Otto anni dopo il viavai di politici, professionisti, misteriosi
grand commis di stato, quasi tutti rimasti anonimi, che animava il piccolo
appartamento preso in affitto da Mirko Ieni (l'improvvisato "protettore" delle
ragazze condannato a dieci anni di carcere), Marianna si racconta. «Chi non ha
la smania dei soldi a quell'età e soprattutto se vivi ai Parioli dove tutto è un
volere di più, sempre di più? Ma poi hanno montato le cose: non ho mai comprato
una borsa Chanel o Louis Vuitton, io facevo shopping H&M. I soldi li spendevo
per i vestiti, i taxi, tantissimi taxi, le sigarette, le discoteche». Giunta
all'età di 23 anni, al termine di un lungo soggiorno in comunità, quattro anni
di psicoterapia e un diploma all'istituto grafico pubblicitario, Marianna è
pronta per riscrivere la sua storia. O almeno una parte di essa. Lo fa parlando
al Venerdì e partecipando al documentario in due episodi di Simone Manetti "La
ragazza dei Parioli" che andrà in onda su Crime+Investigation su Sky e Prime
Video il 23 e il 24 novembre. «Lo faccio non solo per me - spiega - ma per altre
ragazze e ragazzi in situazioni del genere». Si aprono così le porte del tempo e
in un istante si torna al 28 ottobre del 2013 quando - al termine di un'indagine
lampo condotta dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Roma - i principali
responsabili del giro messo in piedi intorno alle baby prostitute dei Parioli
vengono arrestati. Tra loro c'è anche la madre di Marianna, poi condannata a sei
anni per averla sfruttata. «Ero convinta che le mie bugie fossero credibilissime
- dice oggi - ma essendo una donna intelligente avrebbe dovuto intuire che
qualcosa non andava. Non è la prima madre che sbaglia e non scordiamo che sono
uscita intera da questa storia anche grazie a mia madre e mia nonna che qualcosa
di buono mi hanno insegnato, per esempio la consapevolezza. In comunità ho visto
tante ragazze consapevoli e vogliose di riprendersi la vita». L'adolescenza di
Marianna si consuma in un fazzoletto di conoscenze e di abitudini: il bar
gestito dalla nonna a due passi dal Piper (la discoteca che lanciò Patti Pravo),
il liceo Giulio Cesare di corso Trieste, le mattinate trascorse in strada
marinando la scuola. In quella routine di sigarette fumate condividendo segreti
e desideri si cementa l'amicizia con la sua "complice", la seconda ragazza, più
grande di un anno e forse anche per questo più determinata nel tentativo di
divorarsi il tempo. «Non è questione di cattive compagnie - si difende Marianna
- ma di quanto tu tieni a quella persona che è una cattiva compagnia. Io ho
seguito la mia amica perché l'amavo, avrei fatto qualsiasi cosa con lei e per
lei. È stata una mia scelta». La scelta diventa presto una strada a senso unico.
Mirko Ieni, l'uomo che organizza gli incontri e tiene i rapporti con i clienti,
smista decine di richieste al giorno. Gli incontri prima si tengono in macchina,
poi - quando la domanda aumenta - lo stesso Ieni prende in affitto il
seminterrato a due passi dall'Auditorium di Roma. «Nella mia testa era più
difficile smettere che continuare - ricorda Marianna. - Mi mettevo dei falsi
ostacoli. Come dirlo a mia madre? Come affrontare la vergogna? Come fare a meno
dei soldi? Come passare il tempo prima di diventare grande? ». Domande e
incertezze che offrono un'occasione a decine di uomini (oltre mille i contatti
telefonici ricostruiti dai carabinieri). «Non li giustifico - dice oggi la
ragazza - ma forse non si capiva che eravamo minorenni». A otto anni di distanza
quel dubbio è rimasto nell'aria. Così come l'identità di decine di uomini che
hanno varcato il portone di quello stabile anonimo e borghese in viale Parioli.
Da ANSA il 26 novembre 2021. “Ieri abbiamo
assistito a una pagina di ottima informazione del servizio pubblico sul tema
della violenza contro le donne. Approfondimenti e servizi sono andati in onda
in tutte le edizioni dei tg e dei gr nazionali e regionali. Del resto era
l'impegno dell'Azienda. Lo sottolinea la commissione Pari Opportunità
dell'Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, che però punta il dito sulla
scelta di Porta a Porta di intervistare una delle protagoniste di una storia di
pedofilia di cui fu teatro il quartiere Parioli di Roma e definendo l'intervista
"vergognosa" chiede alla presidente della Rai Soldi "se non si rilevi una
violazione del codice etico" dell'azienda. "Peccato che, nella giornata che
sollecita lo sforzo collettivo di eliminare la violenza sulle donne- scrive la
Cpo Usigrai - Bruno Vespa abbia sentito l'impellenza di cominciare la puntata
con una vergognosa intervista a una delle ragazze (oggi maggiorenne ma all'epoca
dei fatti quattordicenne) protagoniste della storia di pedofilia nel quartiere
Parioli di Roma. Un'intervista dalla quale sono anche spariti, e con le loro
responsabilità, gli uomini che si approfittano di quelle adolescenti".
Da qui la richiesta a Soldi: "Chiediamo alla
presidente della Rai Marinella Soldi, che sappiamo impegnata sul tema, se non si
rilevi una violazione del codice etico della Rai e se non siano stati traditi
per l'ennesima volta i principi sanciti nel contratto di servizio. Servono le
parole giuste per affrontare queste vicende e parlare delle vittime ma anche di
chi le sfrutta, clienti compresi, tema che spesso viene soltanto sfiorato con
meno attenzione e incisività come visto anche nel programma condotto da Serena
Bortone Oggi è un altro giorno, durante il quale peraltro è stato più volte
utilizzato il titolo grafico “baby squillo”. Ribadiamo: la violenza sulle donne
è una questione sociale e culturale. E la prima azienda culturale del Paese-
conclude la commissione usigrai - deve dare l'esempio per scardinare arcaici
stereotipi e favorire il cambiamento".
La difesa di Bruno Vespa: “Rivendico parola per
parola la correttezza deontologica dell'intervista alla "ragazza dei Parioli"
mostrata in apertura della puntata come premessa al successivo segmento di donne
vittime della violenza maschile. E' stata a mio giudizio una intervista
rispettosa, garbata, incoraggiante per la nuova vita della protagonista. Come ho
affermato esplicitamente, esiste un tipo di violenza maschile meno appariscente
di un tentato omicidio ma ugualmente in grado di compromettere irreparabilmente
la personalità della vittima. Mi spiace che a dividermi dall'Usigrai, che mai ha
speso una parola di apprezzamento per una carriera decorosa come la mia, sia la
concezione di base del nostro mestiere”.
Dagospia il 3 novembre 2021. “SONO FISSATI A FARLO
SENZA PRESERVATIVO” - LE RIVELAZIONI SCOTTANTI DI UNA ESCORT A MASSIMO GILETTI:
“I CALCIATORI? È BRUTTA GENTE, NON MI PIACCIONO. VANNO IN GIRO, NON PAGANO I
RISTORANTI, NON PAGANO LE RAGAZZE” - “TI TRATTANO COME LA MERCE. SONO STATA SOLO
CON UN CALCIATORE CHE..”
Da la7.it il 3 novembre 2021. Questa sera tra i
temi di Non è l'Arena ci sarà un viaggio nel mondo della prostituzione. Massimo
Giletti ha intervistato una escort che ha parlato anche del mondo dei calciatori
con rivelazioni scottanti.
Da liberoquotidiano.it l'11
novembre 2021. Quindici minuti di perversioni estreme. Non è l'arena entra nel
mondo della dipendenza dal sesso. Le telecamere nascoste di Massimo Giletti, per
La7, testimoniano quello che accade nelle notti italiane: "Spendo fino a 2.000
euro alla settimana in escort", spiega un ragazzo, sotto anonimato. Quindi, la
confessione di un uomo che ha appena pagato 400 euro ad alcune prostitute per un
festino: "Le ho pagate, sono mie, posso fare quello che voglio", spiega
all'inviato. "Il piacere è sottomettere le persone, schiavizzarle proprio.
Capito?". Sesso, tabù infranti, violenza. "Una ragazza è venuta dopo che gli ho
tirato uno sgabello nella schiena. Sembra un film, ma è tutto vero", confessa. E
poi ci sono clienti che al contrario ribaltano la situazione: "Loro voglio che
li sottometti - spiega una escort -, vogliono che gli fai pipì in bocca, che tu
li frusti, che gli dai schiaffi. Decide lui cosa vuole fare: magari camminare
sul corpo con i tacchi, lasciargli tracce sulla pelle, sangue, schiacciare i
testicoli o tirare i capezzoli. Calci nei testicoli, a me è capitato". Chi sono
i clienti tipo? "Avvocati, giudici, presentatori, attori, gente dello
spettacolo". "Conosciamo un personaggio che si vede ogni giorno in tv", spiega
con candore uno dei frequentatori abituali di questi festini. Visti i costi
imposti da questo vizietto spinto, non è difficile immaginarlo.
La fine di Adelina, che
denunciò i suoi sfruttatori: «Tradita dallo Stato, un’amazzone senza scudo».
Giusi Fasano
su il Corriere della Sera il 10 Novembre 2021. La giornalista Myrta Merlino
ricorda la donna morta apolide. Fece arrestare i suoi sfruttatori. Adelina
Sejdini. Sola e disperata. In tasca un permesso di soggiorno con tre «x» al
posto della nazionalità: Apolide. In testa più coraggio per morire che per
vivere. Adelina 113 ha scavalcato il parapetto del Ponte Garibaldi e si è arresa
al buio, al vuoto, alla vita. Due passanti l’hanno vista andare incontro alla
morte ma erano troppo lontani per provare a salvarla. Pioveva a dirotto, sugli
ultimi battiti del suo cuore, e le lacrime — se ha pianto — si sono perdute
nella pioggia. L’hanno avvicinata per primi gli agenti di una pattuglia della
polizia ferroviaria. Era morta sul colpo, sotto il diluvio romano della notte
fra sabato e domenica scorsi. La vita è stata feroce fino all’ultimo istante,
con quella donna. Ma, per essere sinceri, con lei è stato feroce anche lo
Stato italiano, che avrebbe potuto e dovuto aiutarla in segno di gratitudine per
quello che aveva fatto. E che invece l’ha abbandonata dopo averne fatto un
simbolo.
«Una combattente»
Myrta Merlino, giornalista,
scrittrice e autrice televisiva, dice che Adelina 113 «era una combattente,
un’amazzone senza scudo». La conosceva da anni, l’ha ospita più volte nella sua
trasmissione L’aria che tira (La7), e fatica a trattenere il pianto quando ne
parla, perché è stata l’ultima persona alla quale lei ha chiesto aiuto in
diretta, tre giorni prima di togliersi la vita, «e io non ho saputo cogliere il
suo ultimo sguardo», si rimprovera Myrta. «Con lei ho perso io, ha perso lo
Stato nel quale lei credeva molto, a volte così cieco e ingiusto. Ha perso il
sistema con la sua burocrazia a senso unico. E ha perso la tivù, che al di là
del racconto è impotente. Ho pianto di rabbia e spero che lei ci abbia perdonato
tutti». Chiedere aiuto, per Adelina 113, voleva dire una sola cosa: avere la
cittadinanza italiana. Era il suo unico sogno.
In gommone
Classe 1974, era nata a
Durazzo, in Albania. A 22 anni si era fatta ingannare dall’illusione di un
futuro luminoso in Italia. Lei, come migliaia di altri «incoraggiati dalla
bellezza vista per televisione», arrivò in gommone in questo Paese che «sembrava
un sogno steso per lungo ad asciugare», per dirla con la poetica Pane e
coraggio di Ivano Fossati. Gli uomini delle false promesse ne fecero una
prostituta e una schiava a forza di botte. «Mi tagliarono una gamba con le
forbici e nelle ferite ci misero il sale per farmi più male», raccontò fra le
mille altre cose quando finalmente ne uscì, dopo quattro anni. Aveva giurato a
se stessa che non sarebbe morta schiava e così una notte, a Varese, decise che
nessuno avrebbe più abusato di lei. Chiamò il 113 e si affidò allo Stato. Da
allora per i carabinieri e la polizia, che l’hanno sempre aiutata, è diventata
«Adelina 113», una specie di nome in codice che si è portata appresso anche
durante le indagini e i processi nati dalla sua collaborazione con la Giustizia
(il suo vero nome era Alma Sejdini).
La testimonianza
Con la sua testimonianza fece
arrestare 40 albanesi che decidevano la vita e la morte delle donne finite nei
loro artigli (sfruttatori poi condannati con pene fino a 20 anni di carcere). Ha
sempre collaborato con Procure e forze dell’ordine senza esitazioni né paura, è
stata un esempio per decine e decine di donne che grazie a lei si sono ribellate
al racket della prostituzione, ha portato più volte la sua voce in Senato, anche
alla commissione Affari Costituzionali, come esperta della drammatica situazione
delle prostitute. Ha parlato nelle scuole, ha speso il suo tempo e la sua
energia ovunque abbiano avuto bisogno di lei. Una cittadina modello senza
cittadinanza. Un paradosso. Era stata proprio Myrta Merlino, nel 2019, a
sottoporre il caso all’allora ministro degli Interni Matteo Salvini. E lui se ne
era interessato fino a farle ottenere un permesso di soggiorno speciale, in
attesa delle pratiche burocratiche per la cittadinanza. Ma poi, fra il cambio di
governo e la lunghezza di ogni singolo passaggio burocratico, è finita che
Adelina 113 si è ritrovata di nuovo in balia della scadenza del permesso. Solo
che stavolta aveva un motivo in più per sentirsi sola e disperata: un tumore
molto aggressivo che l’aveva costretta a cicli devastanti di chemioterapia e a
una debilitazione continua. Eppure, se era rimasta ancora in piedi davanti a una
sorte così buia, era stato soltanto per coltivare quel sogno: cancellare dalla
sua vita l’infamia di quelle tre «x». «Io non sono un fantasma senza Stato»,
ripeteva sempre. «Amava l’Italia e si sentiva profondamente italiana», la
ricorda Myrta. «In Albania non ci voglio tornare nemmeno da morta», le aveva
detto lei l’ultima volta che si erano parlate. E così sarà. Resterà qui per
sempre, nessuna «x» la riporterà indietro.
Inutile l'allarme dato da
un amico. Il suicidio di Adelina, le ultime parole nel video: “Non mi hanno
aiutata, mi troveranno nella tomba”.
Gianni Emili su Il Riformista
il 12 Novembre 2021. L’ultimo addio nella diretta Facebook prima che Adelina
Sejdini, 47 anni, si gettasse da Ponte Garibaldi sabato sera: “Non mi hanno
aiutata. Questa notte mi troveranno dentro una tomba”. Il 28 ottobre scorso in
un altro gesto estremo di protesta si era presentata al Viminale e si era data
fuoco. Ricoverata in ospedale, era stata dimessa, poi il 5 novembre era tornata
nuovamente davanti al ministero dell’Interno sempre in protesta. In una diretta
Facebook aveva raccontato che era stata bloccata da alcuni agenti di polizia, e
che per lei era stato emesso un foglio di via da Roma per un anno. Disperata,
sotto il diluvio che sabato si è abbattuto su Roma, si è spenta anche l’ultima
speranza. Adelina è arrivata a Ponte Garibaldi e si è gettata di sotto. Inutile
l’allarme dato da un amico che aveva chiamato dall’Abruzzo il 113 per segnalare
che la donna in un filmato annunciava che si sarebbe uccisa. Un suicidio dettato
dalla depressione, scrivono gli inquirenti, che potrebbero comunque decidere di
aprire un fascicolo per approfondire le circostanze della morte. Gli amici
intanto hanno scritto al presidente Mattarella per chiedere che ad Adelina venga
riconosciuta la cittadinanza italiana per cui aveva tanto combattuto. Adelina si
è portata con sé tutte le speranze e il coraggio con cui aveva sconfitto chi
le “tagliò una gamba con le forbici e le cosparse le ferite di sale per fare più
male”, chi la considerava neppure una schiava, ma una cosa da gestire per ricavo
e per diletto.
Lo stesso coraggio con cui
aveva iniziato la battaglia contro il cancro al seno, gli infiniti cicli di
chemioterapia e gli interventi chirurgici, con cui cercava senza sosta di
vedersi riconosciuta quella cittadinanza che le avrebbe consentito di iniziare
per davvero una vita in Italia, quel Paese che dal suo arrivo aveva aiutato e
supportato nella lotta alla mafia albanese e alla violenza contro le donne.
L’ultimo colpo è arrivato quando, rinnovando il permesso di soggiorno a
Pavia, si era vista offrire la cittadinanza albanese. Un Paese dove mai sarebbe
mai tornata, soprattutto dopo essersi messa in pericolo consentendo l’arresto di
40 persone e la denuncia di altre 80. Ad aiutarla i carabinieri, che lei
chiamava “i suoi angeli custodi”, che mai l’avevano abbandonata e che la
chiamavano affettuosamente “Adelina 112”. Il suo contributo le aveva fruttato un
prolungamento del permesso di soggiorno per motivi straordinari, ma la
cittadinanza italiana non è mai arrivata. Rifiutata quella albanese, le era
stato tolto anche lo status di apolide, con il rischio di dover rinunciare alle
(poche) agevolazioni statali che aveva ottenuto e alla possibilità di fare
domanda per una casa popolare. Gianni Emili
Il saluto allusivo.
Massimo Gramellini su Il Corriere della Sera il 29 ottobre 2021.
Le ordinanze dei sindaci sono un genere letterario a metà tra il grido di dolore
e la manifestazione d’impotenza. Sarà che la lingua italiana, quando viene usata
per regolare e vietare, suona subito poco credibile e macchinosa, producendo
più battute che risultati. Non fa eccezione proibisce «le nudità, gli
abbigliamenti indecorosi e i saluti allusivi». Sul perimetro delle nudità
punibili si potrebbe aprire un convegno di cui Berlusconi si candiderebbe
volentieri a moderatore. Quanto al concetto di abbigliamento indecoroso, è molto
soggettivo e anche piuttosto talebano: come se ogni scollatura e spacco
esagerati fossero sintomi di mercimonio. Laddove però il sindaco di Terni compie
un vero salto di qualità è nel perseguire il saluto allusivo. Già in tempi di
Covid salutarsi è un problema e, al netto di qualche salutatore nostalgico
dell’antica Roma o della Marcia omonima, le strade sono popolate di
sbandieratori d’avambracci, scambiatori di pugnetti e apprendisti tibetani come
il sottoscritto, che congiungono le mani aggiungendovi quel minimo di inchino
consentito dall’artrosi. Adesso la faccenda si complica ulteriormente. Come
funzionerà un saluto allusivo? Basteranno una strizzatina d’occhio o un sorriso
ammiccante a far scattare la multa di 500 euro? Per passeggiare tra le vie di
Terni si consigliano mani in tasca, mascherine e occhiali da sole.
Da leggo.it il 29 ottobre 2021. E' bufera politica
a Terni per l'ordinanza anti-prostituzione firmata dal sindaco Leonardo Latini
che - dal 1 ottobre al 31 gennaio 2022 - vieta a chiunque di mantenere un
«abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare
nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione». Puniti anche
i segni «di richiamo, di invito e di saluto allusivo» con multe dai 200 ai 500
euro. A criticare il provvedimento, insieme ad associazioni cittadine e
opposizioni in consiglio, è la senatrice umbra M5s, Emma Pavanelli. «Invece di
trovare soluzioni ai problemi della città e risollevare l'economia - dice
Pavanelli - il sindaco vuole eliminare la prostituzione vietando minigonne e
scollature e limitando la libertà delle donne. Non siamo in Afghanistan sotto il
regime talebano ma in Umbria». Per il sindaco di Terni però non c'è nessun
divieto di «minigonne o scollature», ma solo l'intenzione di fornire alle forze
dell'ordine «uno strumento per intervenire e impedire fenomeni odiosi come lo
sfruttamento della prostituzione». Latini all'Adnkronos si dice «sorpreso» per
le polemiche divampate sulla sua ordinanza anti-prostituzione e si toglie
qualche sassolino dalla scarpa: «Ci sono ordinanze analoghe in comuni di
centrosinistra e centrodestra, se scoppia la polemica in un comune della Lega e
non in un comune del Pd mi viene da pensare che ci sia un elemento di
strumentalità». Riguardo alle accuse per il testo dell'ordinanza che censura «un
abbigliamento indecoroso o indecente», il sindaco osserva che «L'ordinanza va
letta nel suo complesso, nessuno ha evidenziato che si colpiscono soprattutto i
comportamenti dei clienti. Nessuno intende vietare minigonne o scollature nel
modo più assoluto, non si tratta di vietare tipologie di abbigliamento, ognuno è
libero di vestirsi come ritiene», ha sottolineato il sindaco aggiungendo che al
centro dell'ordinanza ci sono quei «comportamenti diretti in modo non equivoco
ad offrire prestazioni sessuali a pagamento» e che «possano ingenerare la
convinzione» che si stia esercitando la prostituzione.
Giulia Zonca per “La Stampa” il 30 ottobre 2021.
Lei ha gli stivali oltre il ginocchio il collare borchiato, l'amica ha il
giubbotto di pelo verde e la pancia scoperta e non stanno affatto su un
marciapiede, dove le collocherebbe il sindaco di Terni, ma fuori da una scuola
superiore. Una come tante in tutta Italia, in tutto il mondo, nel 2021.
L'ordinanza umbra contro la prostituzione, scritta per essere criticata, pone
più problemi di moda che di coscienza. Il primo cittadino leghista ritiene che
il sesso a pagamento sia un grosso guaio a Terni e ci sta pure che faccia da
palco a un giro malavitoso da stroncare. Sul «garantire sicurezza» è facile
trovare consenso, sul «garantire decoro» si apre la sfilata, di abiti, e
stupidaggini accessoriate. Leonardo Latini, il sindaco in questione, promuove un
illuminato testo per sradicare «l'abbigliamento indecente ovvero il mostrare
nudità» perché potrebbe suscitare «la convinzione di esercitare la
prostituzione». Inutile prendersela con lui, lo scorso aprile, a Cassina de'
Pecchi, 17 km dal centro di Milano, stessa storia in una ordinanza gemella e il
sindaco era una donna, nel 2019, a Massa, «sconsigliati gli abiti succinti»,
prima ancora, nelle Marche, multe «a chi ostenta indumenti trasgressivi».
L'Italia non è divisa tra Nord e Sud ma tra passato e presente. È sempre la
stessa storia, ma è anche una teoria impossibile da attuare a meno di arrestare
in massa chiunque segua la moda. La calza a rete non lascia mai definitivamente
la scena ed è uscita dai bordelli. La pelliccia sintetica colorata sta nei
guardaroba con un'occupazione trasversale: dall'armadio di Naomi Campbell a
quello di un qualsiasi ventenne, di qualsiasi genere, tipo, orientamento e da
appoggiare su qualunque stile. Dal rapper incavolato al romantico fumettoso. Con
i costumi di «The Deuce», serie tv sul boom della pornografia Anni Settanta, ci
hanno fatto collezioni intere: il pantaloncino tagliato sul sedere con i collant
sotto, la camicia elegante con un unico bottone allacciato. E poi c'è il film
che ormai dovrebbe aver sdoganato ogni confine tra l'ambiguità e il/la
fashionista: «Pretty Woman», un classico, dove Julia Roberts faceva
effettivamente la prostituta e i suoi vestiti sono diventati simbolo di
indipendenza. Non certo quelli indossati dopo aver incontrato il principe
azzurro. L'Italia è piena di persone che camminano fasciate in vinile e l'alta
moda ha rilanciato il camp, uso del trash consapevole, sgargiante e
trasgressivo, così tante volte da farlo arrivare fino ai mercati rionali. Il
reggiseno all'uncinetto sfoggiato come top è quasi un capo spalla e dopo il
successo internazionale dei Maneskin è proprio impossibile ignorare l'idea che
esista un look fluido e una vita molto meno etichettabile di quanto prevede
un'ordinanza. Figurarsi se poi il provvedimento è una scusa per nascondere sotto
secoli di polveroso perbenismo un pensiero fin troppo attuale: ogni donna in
fondo è una zoccola e ogni uomo che osa smarcarsi dagli stereotipi maschili un
deviato.
Da “il Giornale” il
18 ottobre 2021. Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez, socialista, ha
annunciato di volere abolire la prostituzione, attualmente non regolamentata,
perché «schiavizza le donne». Alla fine del congresso del Psoe di Valencia,
Sànchez ha sottolineato le politiche avanzate introdotte dal suo governo, come
le leggi più severe sulla violenza domestica e gli aumenti del salario minimo. E
vorrebbe completare l'opera mettendo fuori legge la vendita del proprio corpo da
parte delle donne. «Un impegno che realizzerò. Avanzeremo abolendo la
prostituzione, che schiavizza le donne». Il premier però non ha fornito dettagli
su come intenderebbe procedere. Attualmente la legge spagnola non prevede
condanne per chi fornisce o utilizza servizi sessuali senza esservi costretto a
meno che questo non avvenga in pubblico. Ciò che ha favorito il proliferare di
case di appuntamento in tutto il Paese, molte delle quali operano come alberghi
o comunque come strutture ricettive. Gli attivisti sostengono che questa zona
grigia intorno alla prostituzione alimenta il business. Un business piuttosto
fiorente, se è vero che secondo un sondaggio del 2009 condotto del Centro
statale di investigazione sociale (CSI), all'incirca uno spagnolo su tre ha
ammesso di aver pagato almeno una volta nella propria vita per fare sesso. Il
Psoe ha pubblicato un manifesto incentrato sui diritti delle donne prima delle
elezioni generali tenutesi nell'aprile 2019, una mossa chiaramente intesa a
conquistare l'elettorato femminile. Ma ora forse alle parole seguiranno i fatti.
La storia vera di com’era
lavorare in un bordello negli anni Trenta a Parigi.
Un libro racconta un'epoca
(lunghissima) di prostituzione nella Francia liberale di inizio Novecento.
Redazione Digital su marieclaire.com il 12/03/2017. «Dopo un po' ci furono delle
novità in casa. Un signore veniva a trovarci regolarmente. Aveva l’aria di uno
molto ricco, sempre elegante e pulito, anche se un po' vecchio. Ci salutava come
se fossimo delle vere signore. Si sentiva quasi sopraffatto da tutti i nostri
corsetti un po’ logori, dalle scarpe con i tacchi malconci (…) la cosa buona di
questo signore era che non ci ha mai costretto a fare le cose strane che ci
chiedevano gli altri clienti. Voleva solo scattarci delle fotografie», Marcelle,
Parigi 6 dicembre 1932, ritratta mentre si fa il bidè nella sua stanza del
bordello di Pigalle. Da quelle fotografie degli anni Trenta ne è uscita una
raccolta fotografica illuminante quanto triste, Mauvaises Filles (edito da Le
manifacture de Livres nel 2014) una vera e propria collezione di
fotografie scattate nei celebri bordelli di Parigi. Le cattive ragazze in
questione sono prostitute fotografate per anni da Monsieur x che, nel 1975, ha
poi venduto l’intera collezione di scatti al libraio parigino Alexandre Dupouy.
Quello che ne è uscito è un viaggio nel nudo, nella prostituzione e una profonda
descrizione di cosa significasse vivere e lavorare in un bordello negli anni
Trenta a Parigi, in quella Pigalle (il bordello più frequentato da Monsieur X
era a Pigalle) oggi considerato il nuovo quartiere boho-chic di Parigi. Vice
Francia aveva raccolto la testimonianza di Dupouy definendolo archeologo del
sesso grazie alla montagna di materiale d’epoca che custodisce nella sua
libreria parigina Tears of Eros. La combo di queste fotografie e la sua
conoscenza delle attività dei bordelli negli anni Trenta ha permesso di descrive
un ritratto delle donne che lavoravano nelle celebri case chiuse parigine,
esempio non senza sarcasmo, di un modello che è rimasto nel Nord Europa. «La
ragazza che veniva a lavorare a Parigi in un bordello» racconta Dupouy a
Geoffrey Le Guilcer di Vice.fr «era una ragazza convinta di arrivare qui,
racimolare soldi da mandare alla famiglia in campagna. Ai quei tempi una ragazza
di un bordello arrivava a guadagnare 10 volte più di un artigiano. Pensa che un
operaio a inizio 900 guadagnava 2 franchi al giorno. Una prostituta 20 franchi
in un bordello, 5 in strada». Cosa sconvolge di quelle foto di allora (qui
trovate le foto della stessa epoca MA dell’archivio di Getty Images) rispetto al
concetto attuale di casa chiusa olandese? L’abbigliamento? La moda? Le pose?
Tutte queste cose insieme che sono poi la chiave del progetto fotografico di
Monsieur X. Donne che non sanno porsi davanti alla fotocamera di uno sconosciuto
ma che sono, a loro malgrado, molto più a loro agio nude davanti a uno
sconosciuto. La schiettezza di queste foto è parte integrante del racconto
di chi erano e come vivevano le prostitute di Parigi negli anni Trenta. «Per
quello che era il loro mestiere, e le loro performance, le prostitute dell’epoca
erano paragonabili a delle atlete: per due o tre anni, se andava bene, potevano
lavorare senza problemi. Le malattie erano molto comuni, e l’utilità di quelle
che chiamavano spugne igieniche era pressoché nullo». Poi, una volta contratte
troppe malattie - il che era una prassi - alle ragazze spettava un ritorno in
campagna o una drastica riduzione del lavoro. Oggi, studi sulle percezioni alla
mano, pensiamo di sapere quali siano i profili dei porno-dipendenti online, ma
forse il mare magnum digitale non è affatto così chiaro quanto lo erano le
tradizioni di virilità di inizio Secolo: «in quegli anni Parigi era famosa per i
suoi quartieri a luci rosse, gli uomini in media si sposavano a 35 anni, avevano
tutto il tempo di visitare i bordelli. E c’era sempre uno zio che ti introduceva
in un bordello quando iniziava la pubertà» racconta il collezionista parigino.
Le foto di Monsiueur X sono di forte impatto non solo perché ritraggono ragazze
che vendono il loro corpo, indossano cappellini alla moda, simulano le movenze
delle indossatrici di Coco Chanel pur avendo abiti visibilmente lisi e scoloriti
anche se immortalati in bianco e nero. Sono sconvolgenti perché mostrano la
totale assenza di malizia nel farsi ritrarre, i gambaletti a fasciare il
polpaccio, l’inguine non depilata e il corpo lontanissimo da canoni erotici già
visibili nelle icone del vaudeville dell’epoca. Dietro alle foto di ognuna di
loro Monsieur X segnava il loro nome, riporta il giornalista di Vice.fr: Mado,
Suzette, Gypsi, Mimi, Nono, Pepe, segno che per il fotografo erano personaggi da
seguire nel tempo e infatti vi sono numerosissimi scatti della loro vita nella
casa chiusa quanto in esterna. Spontaneità e imbarazzo, età troppo giovani e
assenza di make-up e malizia: non è un caso che molto spesso le ragazze siano
fotografate insieme con una delle due che solleva la veste dell’altra. Timido
segnale che le prime complici di questa sopravvivenza sono loro: complici di un
nudo per nulla erotico, molto più voyeur, il cui punto centrale è sempre
l’assenza di mutandine (o culotte come nell’epoca) sorretto da una curiosità
morbosa per quella intimità in vendita.
Da escort-advisor.com l'1
giugno 2021. Il 2 giugno 2021 è l’International Sex Workers’ Day, la Giornata
Internazionale dei e delle Sex Workers che operano nel mondo. Una ricorrenza
celebrata anche in Italia, Paese che conta almeno 120.000 professioniste del
sesso secondo una ricerca di Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più
visitato in Europa con oltre 3 milioni di utenti unici mensili solo in Italia.
Lo status lavorativo delle escort è paragonabile a quello dei liberi
professionisti. Se esistesse un ordine professionale, sarebbe il quarto gruppo
di lavoratori indipendenti più numeroso in Italia, alle spalle di medici ed
odontoiatri (366.084), avvocati (243.233), ingegneri e architetti (168.851); ma
prima di farmacisti (98.770), geometri (84.202), commercialisti (68.552),
psicologi (61.068) e infermieri (73.569). In Italia la prostituzione è legale,
ma non esiste una legislazione tale da poter regolamentare il settore con
contratti, riconoscimento del libero professionismo, sindacati, previdenza
sociale. Esistono solo associazioni che liberamente portano avanti la battaglia
per i diritti delle sex workers e per il riconoscimento professionale.
Nonostante i numeri del settore, si è ancora lontani dalla possibilità di una
regolamentazione: In Italia sono oltre 20 milioni i clienti del sesso a
pagamento, ma è radicato nella nostra società che la prostituzione sia
inevitabilmente legata allo sfruttamento. Non si crede possibile la consapevole
e razionale scelta di utilizzare il proprio corpo liberamente per lavorare e
guadagnare attraverso il sesso - spiega Mike Morra, fondatore di Escort Advisor
-, le sex workers potrebbero versare le tasse, ma senza avere nulla in cambio,
vista l’attuale normativa. È un dato di fatto che nei Paesi in cui la
prostituzione è legale e regolamentata i tassi di crimini e pericoli legati a
essa siano nettamente inferiori sia per le escort sia per i clienti, come in
Germania o in Svizzera. Dove invece le sex workers vengono criminalizzate vige
il Far West, come negli Stati Uniti. Non è facile ottenere il numero preciso di
escort che lavorano in Europa. Il motivo principale è la mancanza di una
legislazione che regolamenti il settore e quindi contare quante siano le
operatrici del sesso è difficile. Non a caso, i dati più completi arrivano da
Germania, Spagna, Turchia e altri stati che hanno delle Camere di Commercio e
sindacati dedicati. In Italia, invece, Escort Advisor riesce a darne “un
censimento” grazie al proprio motore di ricerca che indicizza gli annunci
pubblicati sui principali siti di escort in Italia per poter verificare i numeri
recensiti dai propri utenti. Germania e Spagna sono gli Stati europei che hanno
il maggior numero di escort. Sono 400.000 le sex workers presenti nei due Paesi,
numeri confermati da Escort Advisor che con il suo motore di ricerca è attivo
anche in Germania e in Spagna. Qui, oltre ad una legislazione che regolamenta
retribuzione e tutela la salute, ci sono anche dei sindacati dedicati. Segue la
Turchia con 145.000 escort, che beneficiano di una Camera di Commercio di
categoria. L’Italia è quarta con 120.000 escort, dove la prostituzione è legale
ma non regolamentata. Sotto quota cento ci sono l’Ucraina con 50.000, la Francia
con 30.000, il Portogallo con 28.000, mentre i Paesi Bassi ne contano 25.000.
Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in
Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie alle 200.000
recensioni raccolte dal 2015, permette agli utenti di scegliere velocemente e in
sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più
offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. Escort Advisor è il primo
sito di recensioni di escort in Europa, in Italia ha oltre 3 milioni di utenti
unici mensili. È attivo inoltre in Spagna, Germania e UK.
Roberto Pellegrino per "il
Giornale" il 10 maggio 2021. Nella lingua náuhatl degli aztechi che abitavano
l'attuale Messico, le donne che praticavano il lavoro più antico del mondo erano
considerate a metà strada tra sacerdotesse e benefattrici. Erano chiamate
tlatlamiani che, letteralmente significa «colei che porta felicità».
Appartenevano a una particolare casta, non erano soggette a nessuna forma di
schiavitù né violenza, e il loro ruolo aveva un importante valore sociale e
politico, soprattutto in caso di guerra con le altre popolazioni precolombiane.
«Le tlatlamiani erano molto importanti nella società azteca, soprattutto durante
le guerre, perché accompagnavano i soldati per evitare che questi violentassero
o rapissero le donne dei popoli conquistati», ha spiegato al Giornale, Eduardo
Merlo, archeologo messicano che ha portato la mostra «Diosas y mortales» (Dee e
mortali, ndr) con immagini e statue d' arte precolombiane in giro per il mondo,
dal Museo Amparo di Puebla fino al Metropolitan Museum di New York. E in attesa
che la pandemia si congedi, è previsto anche un tour in Europa. «Nella cultura
azteca il popolo conquistato non doveva subire le violenze che, invece,
infliggevano i guerrieri maya agli sconfitti come la decapitazione e l'espianto
a mani nude del cuore da offrire agli dei. Né era permesso ai conquistatori
aztechi di rapire e di violentare le donne perché erano proprio le tlatlamiani
che, dopo la battaglia, entravano in scena per soddisfare i guerrieri, così da
preservare le donne locali». E chi tra i guerrieri aztechi non rispettava le
regole ed era scoperto a violentare un'autoctona, era punito duramente con la
prigionia e l'espulsione dalla casta di guerriero», ha concluso il professor
Merlo. Le prostitute, quindi, partivano per la guerra assieme ai guerrieri,
erano protette e nutrite e rispettate. Apprendevano le basi per combattere,
sapevano maneggiare lance e coltelli, ma non era permesso loro di scendere in
combattimento, potevano soltanto difendersi. E chi osava violarle, era
condannato a morte. Inoltre, gli aztechi, come i calciatori in ritiro, non
potevano compiere attività sessuale il giorno prima di una battaglia, ma era
tutto rimandato ai festeggiamenti della vittoria: solo allora queste donne si
concedevano per soddisfare le voglie post belliche dei soldati. Le tlatlamiani
avevano un'età compresa tra i venti e quarant' anni, molte di loro erano orfane
di guerra o provenivano da famiglie di commercianti e politici. «Godevano di una
doppia paga: un onorario concesso dalla casta che governava per i loro servizi
di guerra e uno da parte dei clienti», ha aggiunto il professor Merlo. Infatti,
le prostitute nei periodi di pace, esercitavano normalmente la loro professione
presso abitazioni comode, pulite e vigilate. In caso di guerra erano reclutate
dai sacerdoti con la supervisione degli alti gradi militari. La storia dei
popoli precolombiani racconta che la più famosa delle tlatlamiani si chiamava
Malintzin, ribattezzata cristianamente Marina, conosciuta meglio come «la
Malinche». Di famiglia aristocratica, fu l'amante del condottiero e nobile
spagnolo Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, che visse tra il XV e il XVI
secolo e fu il primo e il terzo Governatore della Nuova Spagna, un territorio
che includeva tutti gli stati dal Messico fino alla Costa Rica, e, al Nord, dal
Texas fino al Wyoming. La Malinche imparò molto velocemente la lingua spagnola
dei conquistadores e oltre a diventare amante del condottiero estremegno, fece
da interprete tra i politici aztechi e gli spagnoli invasori. Fu lei, Marina, a
presentare Hernán Cortés all' imperatore Motcuhzma Xcoytzin, conosciuto come
Montezuma II, sovrano del potente Impero azteco: la donna fu presente in tutte
le trattative diplomatiche per porre fine alla guerra tra aztechi e spagnoli,
così da arrivare alla fondazione della Nuova Spagna, uno stato con iberici e
precolombiani. «La Malinche, come tutte le prostitute, era una donna molto
curata, indossava gioielli e vestiva elegante con capelli curati e adornati di
fiori. Si decorava parti del corpo con disegni. Inoltre le tlatlamiani erano le
uniche donne a indossare i sandali, come scrive nelle sue memorie il frate
missionario spagnolo Bernardino de Sahagún», ha raccontato il professor Merlo,
curatore della mostra messicana. «Erano le uniche donne che potevano decidere se
sposarsi o no e godevano di una protezione speciale da parte dei politici. Erano
devote alla «dea del Mais» Centeotl che dava loro da mangiare, alla dea
Chalchiuhtlicue «che sorvegliava le acque», alla «dea della Bellezza e dei
Fiori» Xochiquetzal e, ovviamente, alla «dea del Sesso» Tlazolteotl». Con
l'arrivo dei conquistadores nel XVI secolo, pur con la protezione delle loro
potenti dee azteche, le tlatlamiani finirono nelle mani del nuovo dio cristiano
e, soprattutto, della Chiesa di Roma che impose un modello di società in cui le
prostitute, sacerdotesse rispettate e venerate, divennero donne discriminate,
spesso condannate a morte e isolate. «La cultura iberica portò lo sfruttamento
del corpo femminile, i protettori che riducevano le donne azteche in schiavitù e
le rapivano per poi indurle alla prostituzione, come già avveniva in Europa».
Così le tlatlamiani fino a quando resistette la cultura azteca nella Nuova
Spagna, furono rispettate e venerate, poi si mischiarono con le comuni
prostitute spagnole che incominciavano ad arrivare dal vecchio continente. Il
machismo, con il concetto sbagliato che l'uomo avesse sempre la priorità sulla
donna nei suoi bisogni sessuali, aveva cancellato per sempre il ruolo sociale,
culturale e persino diplomatico delle prostitute azteche, che avevano impedito
gli abusi e le violenze sessuali in guerra e i femminicidi per intere
generazioni.
Marco Carta per “il Messaggero” il 26 marzo 2021.
Un business sulla pelle delle schiave del sesso. Con l'inganno e la stregoneria
reclutavano ragazze in Nigeria. Giovani, anche minorenni, che una volta entrate
clandestinamente in Italia, finivano sui marciapiedi di Roma. Si è chiuso ieri
mattina, con una pioggia di condanne - circa 42 anni complessivi di carcere - il
processo con rito abbreviato di quella che era una vera e propria banda che
gestiva il racket nella periferia di Roma, lungo la via Casilina, da Torre
Angela fino alla Borghesiana. Cinque donne e due uomini, tutti nigeriani,
accusati, a vario di titolo, di tratta, sfruttamento minorile e favoreggiamento
dell' immigrazione clandestina. Ecco la proposta: soldi facili, una vita nel
lusso, «vuoi venire in Italia?». Sono in tutto 15 le vittime coinvolte, adescate
in Nigeria da «persone vicine al clan familiare», sostiene l' accusa. «Vedrai
che diventi ricca. Potrai comprarti quello che vuoi», dicevano gli aguzzini.
L' INCUBO. Alle ragazze non veniva nascosta la
loro attività, tuttavia ne venivano esaltati i presunti benefici: «Non avrai
nessuna spesa. Solo guadagni, per comprare borse e profumi». Una volta
reclutate, però, per loro iniziava l' incubo. A spiegare la dinamica del terrore
è una delle «Madame», una donna di 46 anni difesa, insieme al marito, dall'
avvocato Stefano Troiano: «Una volta intercettate, le donne devono andare dallo
stregone per il rito Juju», una sorta di incantesimo a base di amuleti composti
da ossa di animali. L' obiettivo è chiaro: terrorizzare le giovani, «per
garantire il pagamento del debito contratto con la Madame», che anticipa i soldi
del viaggio dall' Africa all' Italia, circa 35mila euro per coprire il trasporto
in autobus fino alla Libia e il transito sui barconi della speranza che le
condurranno sulle coste siciliane.
LA DENUNCIA. A squarciare il velo dell' omertà, è
una delle tante ragazze, ospite di un centro di accoglienza, che racconta tutto
agli agenti della Squadra mobile di Roma. Le parole della giovane schiava del
sesso permettono agli investigatori ricostruire il sistema dell' organizzazione,
capace di muovere centinaia di donne, ma soprattutto ingenti somme di denaro tra
la Nigeria, la Libia e l' Italia, grazie al sistema di money transfert informale
denominato Hawala. Nel novembre del 2019 otto persone finiscono in stato di
arresto, per sfruttamento di almeno 15 giovani, secondo la ricostruzione della
procura. La pena più alta, come richiesto dal pm Roberta Capponi, è quella di 10
anni, inflitta a una delle «Ghost Mummy» - questo è il nome dell' indagine - una
Madame di 39 anni, ribattezzata «Nore», che, dopo aver introdotto illegalmente
in Italia una minore di 16 anni, ne «sfruttava l' attività facendosi consegnare
i proventi», secondo l' imputazione della Procura. Altre due donne e un uomo
sono invece stati condannati a 6 anni e 8 mesi dal gup Antonella Rita Anna
Minunni. Tra le vittime di violenza ci sono anche due giovani ragazze
sopravvissute al naufragio del 23 maggio 2017 in cui 34 persone persero la vita
nel canale di Sicilia. Vive per miracolo, una volta sbarcate in Italia erano
state subito sbattute in strada per ripagare con il proprio corpo quel viaggio
della morte.
Elisabetta Andreis per corriere.it il 18 marzo
2021. Sorridente, vent’anni. Studentessa fuori sede di Economia. Nel tempo
libero, arrotonda. In altre epoche si sarebbe detto che l’attività di questa
ragazza, bellezza stratosferica e naturale, storia comune e per niente ai
margini, è la prostituzione. Ma loro, i giovani — la studentessa di Economia, la
sua coinquilina che frequenta il Conservatorio e l’amico di Scienze politiche,
tutti più o meno del giro — non accettano quel nome. Ne hanno sdoganato un altro
che ai loro occhi neutralizza lo stigma: sex working. «Il marciapiede non lo
vediamo neanche da lontano, ci mancherebbe. In strada ci sono le vittime della
tratta, noi facciamo tutta un’altra cosa — chiariscono subito —. Ci iscriviamo
sui siti di incontri (ecco come funziona) e ci proponiamo come sugar baby.
Vendiamo esperienze e non c’è disparità di potere perché noi abbiamo la
giovinezza, loro il denaro». Tutti sono istruiti e se la cavano bene con
Internet. Alcune conoscenti si mettono in vetrina filmandosi in diretta con le
telecamere collegate ai computer (cam girl), loro invece lavorano con incontri
reali che durano una o più giornate, a volte in trasferta, in via riservata: «La
prestazione sessuale è il cuore di un accordo che però non si esaurisce lì,
comprende anche altro — prova a spiegare la studentessa del Conservatorio —. Una
sorta di relazione, ma finta, perché dell’altro in realtà non me ne importa
niente». Sono parole tristi dette con lucidità. Non c’è bisogno estremo, non c’è
rassegnazione: piuttosto, sembra calcolo. «Sui siti non si può parlare di soldi,
pena l’oscuramento del profilo, per questo la conversazione migra su altri
canali, privati — raccontano ancora —. C’è tantissima domanda, anche adesso in
tempo di Covid. Quindi possiamo permetterci di selezionare solo chi ci
interessa, dire se a quelle condizioni ci va bene oppure no. Accompagnarli è una
nostra scelta». Ad ascoltarli pare che questa variabile (avere la possibilità di
selezionare i «pretendenti») renda il lavoro in qualche modo accettabile. Ma
cosa c’è di diverso dal subire una violenza, nell’offrire il proprio corpo? I
tre la descrivono secondo un altro punto di vista: «Ci assumiamo un rischio
quasi imprenditoriale, liberi di smettere in qualunque momento. Mai accetteremmo
di farci controllare da altri, anche se a volte capita che qualcuno si faccia
avanti dicendo di volerci proteggere». Avvicinandosi senza giudizio, per cercare
di capire, si raccolgono confidenze. Il progetto è preciso e lucido. Parla ad
esempio la studentessa di Economia: «Io ho cominciato questo lavoro due anni fa,
lo farò ancora per quattro o cinque, non di più». Obiettivo? «Mi rifiuto di
abitare in un bilocale di periferia in quattro, così invece posso stare appena
un po’ più comoda, in zona Isola, mi pago gli studi e soprattutto metto da parte
i soldi che mi serviranno per fondare una start up o aprire un negozio tutto
mio, invece che restare disoccupata». All’inizio si imbarazzava, della compagnia
erano solo in due a farlo, ma poi altri hanno provato, «anche nostri amici
maschi, ora ne parliamo». Sono parole scioccanti per quello che pare un certo
distacco nel descrivere tutto questo: «Tra noi non ci vergogniamo e se qui
manteniamo il riserbo sull’identità è solo perché i nostri genitori, se solo
immaginassero, non si riprenderebbero più». La strategia è mantenere pochi
clienti fissi in modo da limitare al massimo gli incontri occasionali: «In
questi mesi io ne ho due e con loro guadagno più di seimila euro al mese, solo
se mi va aggiungo qualcosa. Di certo per meno di 300 euro io non accetto di
vedermi con qualcuno». Gli uomini che si propongono sono sempre benestanti,
scapoli o con famiglia, dai 45 anni in su. Confida ancora la studentessa di
Economia: «La vita mi ha dato poche risorse, tra queste la bellezza, la metto al
servizio di quello che mi serve. Vorrei chiarire che non sono soldi facili, è un
lavoro molto faticoso, anche per la cura di sé. Non solo del corpo, devi curare
anche la mente, perché ti preferiscono di buon umore. E non ti puoi innamorare
di nessun ragazzo, o questo lavoro non lo riesci più a fare». Usano parole come
«professionalità» (riferita al genere di sesso che sono disposte a offrire) e
«regalo» (quando in aggiunta ai soldi, lo sugar daddy decide di pagare loro un
vestito o magari i libri dell’università). Imparano a raccontarsi che va bene
così, «facendo questo mestiere si diventa forti», sostengono che ogni incontro
«mette un brivido che si impara a sostenere e quasi desiderare». Raccontano di
esperienze anche terribili, «una volta sono stata legata e gettata nella vasca
da bagno a lungo, credevo di morire. Volevo denunciare, ma a chi, e cosa avrei
potuto dire?». Poi si rivestono e partono. Vanno in ateneo a studiare, come ogni
giorno, in mezzo ai coetanei.
DAGONEWS il 26 febbraio 2021. Parker Westwood ha
32 anni ed è una sex worker che vuole puntare un faro sulla sua professione
cercando di raccontare apertamente ogni segreto del suo lavoro, dando la parola
alle sue colleghe. Ha iniziato in pandemia con una serie di podcast e ora ha
dato la parola a dominatrici e spogliarelliste che spiegano senza tabù com'è
offrire servizi sessuali in cambio di soldi. In una serie di interviste intime,
Westwood scava in profondità e infrange i tabù per svelare i segreti del loro
mondo: dalla vita in lockdown, a come è cambiato il lavoro fino al sesso per chi
ha una disabilità. Un’immagine diversa rispetto a quella promossa da chi non è
del settore. «Siamo dipinti come malvagi - ha detto alla Reuters - Più
cercheremo di capirci l'un l'altro, meglio staremo». Westwood ha lanciato
l'ormai appuntamento bisettimanale con i suoi podcast da gennaio dopo aver
esplorato come vendere sesso in sicurezza durante la pandemia nella sua città
natale di Detroit. Il risultato - "Guida galattica per una prostituta" - ha
attirato ascoltatori da ogni parte del mondo, dall'Australia al Cile. «Le nostre
storie sono potenti perché non vengono raccontate spesso - ha detto - Siamo così
abituati a operare nell'ombra». Molte lavoratrici del sesso sono critiche su
come i media mainstream dipingono il loro settore, sia che si tratti di
pubblicare foto o di pubblicare storie che confondono il loro lavoro con il
traffico sessuale.
Simona Maccaferri per “La Riviera” il 17 febbraio
2021. Sofia (nome d’arte) ha 41 anni compiuti a ottobre ed e la escort più
“votata” della provincia di Imperia. Le sue recensioni l’hanno fatta balzare al
primo posto tra le quasi 500 donne che hanno scelto di fare “il mestiere più
vecchio del mondo” nel nostro ponente ligure. La Riviera l’ha contattata e lei e
stata ben felice di raccontare la sua storia.
Sofia da quanto tempo fa questo lavoro?
“Ho iniziato nel 2014 e quindi quest’anno sono 7
anni”.
Era già una donna quindi. Quale lavoro faceva
prima?
“Ho lavorato nel settore alberghiero, ero
caposala. Poi il mio datore di lavoro e morto e io non ho più trovato nessuno
co- me lui quindi ho deciso di cambiare settore. Mi sono “buttata” nel mondo
dell’arte. Mio padre e un noto ebanista e io ho iniziato a lavorare con lui. Tra
i tanti lavori che abbiamo fatto, anche quello di riprodurre frutta e ver- dura
che venivano messe nelle vetrine oppure che venivano usate in televisione. Poi
ho smesso perché mi rendevo conto che quel lavoro non mi avrebbe dato la
possibilità di concretizzare il mio sogno. Io volevo lavorare nel settore
immobiliare, diventare un’imprenditrice. E nessun lavoro mi avrebbe per- messo
di guadagnare abbastanza per realizzare questo progetto”.
Quindi per questo motivo ha deciso di mettersi in
gioco e di diventare una escort?
“Si. All’inizio ammetto che non e stato facile. Ho
risposto a un annuncio di un centro olistico a Chiasso, in Svizzera e sono
andata. E stata un’ esperienza non positiva tanto e vero che sono stata solo 10
giorni. Ricordo che una ragazza un giorno mi mise una mano sulla spalla e mi
disse: “Qui dentro la cosa più pulita e il sesso”. A quel punto lasciai Chiasso
e mi trasferii a Lugano. Li ho preso una camera in affitto e ho iniziato la mia
attività che devo dire mi ha reso bene, guadagnavo dai 200 ai 400 Franchi a
cliente. Inoltre sono stata anche chiamata da un’associazione che collaborava
con gli ospedali. In pratica fornivo le mie prestazioni in ospedale a persone
disabili o inferme. Ho conosciuto anche giovani di 20/25 anni che non potevano
esprimersi con il corpo, ma che comunque ne avevano bisogno. E stata un’
esperienza molto importante che mi ha formato molto”.
Lei poi ha lasciato la Svizzere e si e trasferita
ad Aosta.
“Si sono stata per qualche anno ad Aosta dove ho
avuto modo di capire come i clienti siano diversi a secondo delle regioni di
provenienza. I valdostani e i piemontesi ad esempio amano il sadomaso. Qui in
Liguria invece il cliente e molto più riservato ma ha un grande potenziale”.
Lei e arrivata a Sanremo un anno fa. Ha già una
clientela affermata?
“Si devo dire che, nonostante la crisi per il
Covid, comunque ho un buon giro di clienti”.
Qual e il target di età di chi si rivolge a lei?
“La fetta grande comprende giovani dai 19 ai 26
anni e i 50enni. Anche se ci sono persone più mature”.
Lei ha 41 anni. Come si spiega che dei ragazzi
molto giovani scelgano di venire da lei?
“E stata una domanda che io ho fatto loro. E
alcuni mi hanno detto che, a parte la curiosità e il fatto che mi vedano come
una Milf, c’è l’aspetto umano. Mi hanno riferito che le discoteche, luoghi dove
di solito attingono giovani, sono piene di ragazze che non hanno “spessore”, che
sono vuote. E loro hanno bi- sogno di altro. Ecco perché scelgono me”.
Passando invece agli uomini piu “maturi” perchè
decidono di chiamarla?
“I motivi sono diversi. C’è chi si trova in un
matrimonio che si sta sgretolando e quindi cerca qualcosa che in casa non trova.
C’è chi magari ha una malattia e in famiglia deve dimostrarsi forte e sceglie di
venire da me perché sa che qui può mostrare tutte le sue debolezze. C’è chi
vuole “giocare”. C’è chi viene da me solo per avere della compagnia. A volte mi
rendo conto che certe persone più che di me avrebbero bisogno di uno
psi-coterapeuta”.
Leggendo le sue recensioni si evince che lei sia
una per- sona che da molta importanza al cliente, e alle sue esigenze non solo
“sessuali”.
“Si assolutamente. Per me l’aspetto umano e molto
importante. E forse proprio per questo sono stata la più “votata”. Il tempo che
il cliente passa con me non e tutto dedicato solo alla prestazione ma anche al
dialogo. Io di norma do un’ora di tempo disponibile ma in realtà a volte mi
capita di passare più ore con la persona. E infatti non metto mai appuntamenti
ravvicinati. E metto anche un numero limite di clienti al giorno che e non più
di cinque. So che alcune ragazze ne hanno anche 10. Ma cosi si perde la qualità
del servizio almeno come lo intendo io".
Con questo lavoro lei fa en- trare in casa persone
“sconosciute”. Non ha paura. Oggi ci sono tanti “pazzi” in giro e la cronaca
racconta quasi giornalmente di femminicidi e stalker.
“Si vero ma quando prendo un appuntamento cerco di
capire anche telefonicamente con chi
ho a che fare. E dopo 7 anni di attività un po’ di
esperienza me la sono fatta. Quindi certe persone non le faccio venire a casa
mia”.
E con il Covid? Ci sono state delle precauzioni
maggiori?
“A parte il fatto che lavoro meno pero devo dire
che non ci sono stati grandi problemi a parte alcuni clienti che arrivano con la
mascherina e non se la levano per tutto il tempo che stiamo insieme. Il che mi
fa anche sorridere se pensa al contesto”.
Lei e stata sposata?
“No non sono sposata ma convivo da 17 anni con il
mio compagno che non e dell’ambiente. E un artigiano, un idraulico”.
Quindi quando ha deciso di fare questo lavoro
eravate insieme da 10 anni. Cosa le ha detto?
“Devo ammettere che quando glielo ho comunicato si
e dovuto sedere!!. Poi ha capito che era un lavoro come un altro e che lo facevo
per poter realizzare un sogno. Non e mai stato geloso e in alcuni casi e anche
diventato amico di qualche mio cliente”.
Le e mai capitato di innamorarsi?
“Si due volte. Una qualche anno fa. Una storia
andata avanti per 3 anni, Poi quando questa persona voleva sposarmi io ho
troncato il rapporto. E poi ora sono innamorata di un uomo di Sanremo che pero e
sposato”.
La sua famiglia sa della sua professione?
“Mia mamma no. Non ho vo- luto dirglielo perchè
sono sicura si preoccuperebbe e voglio che viva tranquilla. Mio papa lo ha
saputo. L’uomo con cui sono stata 3 anni e che voleva sposarmi, quando l’ho
lasciato per vendetta e andato da mio padre a dirgli che io facevo questo
mestiere. Mio padre in quell’ occasione e stato magnifico. Bluffando ha risposto
che lo sapeva e che se ero contenta per lui non era un problema. A mio fratello
invece l’ho detto io. E anche lui non si e scandalizzato”.
Lei come si vede tra qualche anno?
“Credo che fra una decina d’anni tante cose non
potrò più farle anche perché é un lavoro faticoso sia fisicamente che
emotivamente. Pero spero di avere la possibilità di scegliere di continuare
facendo una cernita maggiore sempre finalizzata a poter continuare la mia
attività imprenditoriale. Io credo che se una fa questo lavoro per avere i soldi
per comprare borse e vestiti firmati e poco intelligente. Questo lavoro non deve
essere fine a se stesso. Deve essere un mezzo per realizzare i propri sogni".
Nel suo lavoro c’è qualcosa che non tollera?
“Si. Non ammetto l’uso di droghe, le persone
minorenni o fragili e non voglio avere ragazze che lavorano per me”.
Lei lavora in un palazzo in centro a Sanremo. I
suoi vicini non le hanno mai detto nulla?
“I miei vicini non sanno il lavoro che faccio.
Nessuno si e mai accorto di nulla. Tengo molto alla privacy. Anche quando do un
appuntamento non dico mai dove abito. Lo scoprono una volta arrivati”.
Dadospaia il 5 febbraio 2021. Comunicato Stampa:
Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, presenta la
Classifica delle Top Escort del 2020 con un talk show in stile "Notte degli
Oscar" condotto dal noto speaker radiofonico Fabio De Vivo, online sul sito dal
2 febbraio 2021. Una presentazione unica nel suo genere: un conduttore in abito
elegante che alterna le premiazioni a curiosità sul settore, sei escort
professioniste che si raccontano e mostrano senza vergogna, in un momento
dedicato solo a loro, in una location allestita nei particolari. Una sorta di
“Oscar delle escort”, che però hanno votato gli utenti con le oltre 80.500
recensioni scritte solo nel 2020. Niky di Roma (113 recensioni) e Veronika di
Milano (53) sono rispettivamente la escort e la escort trans migliori d’Italia
per l’anno 2020. Oltre a loro sono state altre quattro le professioniste che
hanno ricevuto una nota di merito attraverso le recensioni degli utenti del
2020. Due i "riconoscimenti speciali" consegnati, uno a Rachele dalla provincia
di Monza per il maggior numero di recensioni mai ottenute su Escort Advisor
(225) e Lena di Bergamo per come ha affrontato il 2020, raccontato dalle sue
recensioni. Due le "menzioni emergenti": Lola della provincia di Novara e Vicky
Lopes di Milano. La classifica è stilata direttamente dagli utenti: in base al
numero delle recensioni ricevute nel 2020 e al loro punteggio, oltre al grado di
affidabilità degli autori delle recensioni. Le escort vengono premiate
direttamente dagli utenti proprio attraverso il racconto delle loro esperienze.
Le classifiche riservano sorprese e nelle top 10 risultano professioniste da
tutta Italia. La Classifica di Escort Advisor rappresenta tutte quelle escort
che non si improvvisano nel sesso a pagamento, ma che investono nella propria
reputazione. Sono donne che scelgono questo lavoro, che si impegnano per essere
le migliori - commenta Mike Morra, fondatore di Escort Advisor - Lo vediamo bene
dalla presentazione che abbiamo organizzato quest’anno, non sono di certo
ragazze di strada o sfruttate: eleganza, intelligenza e professionalità
caratterizzano ognuna di loro. Con un evento del genere presentato da un
professionista come Fabio De Vivo continuiamo a sdoganare un argomento da sempre
considerato “scandaloso” ma anche a sensibilizzare sul tema della sicurezza e
trasparenza che le recensioni garantiscono a utenti ed escort. I dati del 2020
del settore. Nonostante il 2020 abbia rallentato l’andamento del settore Escort
Advisor ha registrato numeri non indifferenti, come 80.500 recensioni scritte,
23.101.343 di utenti unici annui, 258.125.465 profili escort visualizzati e
419.031.429 ricerche sul sito. Una diminuzione è stata invece riscontrata nella
presenza nazionale di escort: -22%. A questo sono riconducibili anche
significative variazioni nei prezzi delle escort. Escort Advisor riesce a
ricavare il prezzo medio grazie alle recensioni scritte dagli utenti nel 2020 e
nel 2019. Per dettagli sulle statistiche divise per comuni e province del 2020 e
per il confronto con il 2019 non esitare a contattarci.
Barbara Costa per Dagospia il 23 gennaio 2021.
Abbasso Kamala Harris! Signori, il "Daily Beast" ha una nuova editorialista, si
chiama Cherie DeVille ed è una pornostar! E il primo bersaglio della nuova penna
giornalistica è la neo vice presidente degli Stati Uniti, sì donna, sì liberal,
sì dalla parte dei non etero, ma pure una arci-nemica della prostituzione! Non è
una novità, che la signora Kamala avversi il sesso mercenario, è così da quando
ha iniziato la sua carriera in campo giudiziario. La vicepresidente (scusa ma
secondo te: perché molti insistono a definirla “di colore” come se pure la pelle
rosa non fosse colorata, ma soprattutto perché insistono a chiamarla “afro”,
quando afro non lo è affatto essendo figlia di un’indiana e di un giamaicano?!)
Kamala Harris ha un curriculum fitto, è una tutta d’un pezzo, tutta law & order,
e proprio non sopporta che ci siano donne che offrono sesso per soldi. Soltanto
le donne?!? Kamala, quanto sei indietro! Metti sotto accusa solo le vagine
mercenarie quando il mondo dalla notte dei tempi è pieno di prostituti che danno
pene e c*lo, e davvero non riesci a concepire che ci siano persone che
liberamente si prostituiscono? Queste persone (e una bella parte dell’opinione
pubblica) considerano ciò che fanno una autonoma professione, e ci vorrebbero
anche pagare le tasse! Ma per te Kamala no, non se ne parla, non è possibile, e
da procuratrice distrettuale di San Francisco fermamente ti sei opposta a una
iniziativa popolare che chiedeva di legalizzare la prostituzione per togliere
i/le squillo dalle strade, dai magnaccia e da una vita infernale. Non sia mai!
Per te, Kamala, “le prostitute sono donne vulnerabili” (aridaje, ci stanno pure
i piselli!!!) e regolarizzarle “è ridicolo: la prostituzione fa proliferare
droga, caos, le malattie sessualmente trasmissibili, e compromette la qualità di
vita di una comunità”. È qui che entra a gamba tesa (e a coscia tornita, e a
tettone agguerrite) Cherie DeVille, pornostar e fisioterapista laureata, attiva
e con licenza in regola, perché Cherie porna a Los Angeles e segue i suoi
pazienti in studio a Nashville: Cherie vota democratico, e le fa rabbia che una
persona preparata come Kamala Harris sia così bigotta in tema di prostituzione.
Il fatto è che la realtà è tutto il contrario di quanto dice Harris: è proprio
la non legalizzazione del sesso mercenario che non toglie i/le prostitute dalle
strade e dalla tirannia dei magnaccia; è proprio la vita non libera che fanno –
e che molte non vogliono fare e sono costrette dai magnaccia a fare – che le
porta a una vita di caos. È proprio tale sudiciume che dequalifica i quartieri
dove una prostituzione illegale espone corpi e violenza e squallore allo sguardo
altrui. Cherie DeVille se la prende con Harris anche per la sua lotta ai siti
web che permettono a chi vuole prostituirsi di reclamizzarsi. Infatti, da
procuratore federale della California, Kamala Harris ha fatto chiudere dei siti
accusati di traffico di minori. Erano siti che sì ospitavano tale monnezza, ma
pure la réclame di gente onesta. Il web è un toccasana per chi vuole in libertà
prostituirsi, perché ti mette a diretto contatto coi clienti: sei libera, decidi
tu, senza magnaccia-intermediari. L’accusa di Cherie DeVille si collega alla
guerra in corso contro Pornhub: è sacrosanto togliere i video di minori e di
violenze e postati senza il permesso di chi in quei video appare, ma il
boicottaggio fatto a Pornhub da 2 grandi nomi di carte di credito ha portato
Pornhub a buttare nel secchio video in cui di illegale nulla c’è. Video pure di
Cherie DeVille, entrata nel porno a 34 anni, cioè da Milf: alcuni suoi porno
legali titolati "mommy", "stepmom" e simili, sono finiti nel cestino di pulizia
generale di Pornhub, togliendo a Cherie fonti di reddito. Vice-presidente
Harris, sveglia! Ma non come nel 2019, quando parevi rinsavita, e proclamavi di
averci ripensato, sulla prostituzione: quella volta dicesti che “forse non
dovremmo criminalizzare condotte sessuali che non danneggiano chi le fa”, e per
questo… niente più galera per le donne, siano puniti i clienti, che li si
identifichi col numero di targa delle auto, anche attraverso la delazione!
Niente da fare, mi sa che Harris non cambia idea, da senatrice ha pure votato sì
al FOSTA-SESTA Act, la legge che rende responsabili i siti porno per ciò che gli
utenti fanno e dicono sulle loro piattaforme (un pasticcio: pensata per
combattere il traffico di minori, colpisce chiunque online offra servizi legali
legati al sesso, quindi anche prostitute e pornostar, le quali dovrebbero
chiedere a ogni utente-cliente età e consenso, e poi inserirne i dati in un
database gestito non si sa bene da chi). Cherie DeVille ha ragione quando scrive
che non è giusto che le società di carte di credito decidano di togliere a un
lavoratore la capacità di fatturare in legalità: le carte di credito sono
l’unico strumento legale che pornostar e chiunque via web lavori col e nel sesso
ha per ricevere soldi. Ancor di più sotto pandemia: come le sue colleghe, Cherie
DeVille ha trasferito il suo lavoro porno online, e chiede ai neoeletti alla
Casa Bianca che intervengano decisi anche sulle arbitrarie censure che Mark
Zuckerberg fa sui social contro chi vuole esporre il suo corpo per
pubblicizzarlo. Giustissimo combattere la pornografia minorile e chi ne fa
social-abuso, ma perché immettere in questo calderone censorio le pornostar, le
spogliarelliste, ma pure chi fa massaggi? Nel 2021, dove altro sponsorizzi la
tua attività se non via social? Non è finita qui: c’è chi difende lo zelo di
Kamala Harris dicendo che Cherie DeVille in realtà la attacca perché rosica!
Vorrebbe esser lei al posto della Harris, e invero Cherie ci ha provato, si è
candidata alle scorse primarie, in ticket col rapper Coolio. Hanno presentato il
loro programma copiato pari pari a quello di Bernie Sanders, con già pronta
parte della loro squadra di governo: la modella Kennedy Summers alla Salute, la
modella Khloe Terae agli Esteri, la pornostar Alix Linx alle pubbliche
relazioni. Poco dopo si sono ritirati per “sostegno insufficiente” (tradotto:
non se li è filati nessuno!), sebbene il porno presidential-ticked girato da
Cherie abbia fatto buone views. Meglio le è andata su un altro "versante"
politico: sua la porno-parodia di una Hillary Clinton oralmente in fiamme per
Donald Trump, nel porno "Making porn great again". Altri tempi!
Da "corriere.it" il 24 gennaio 2021. Sulla
piattaforma on line in cui espone i suoi video erotici, ha scelto di farsi
chiamare MelaZeta. È il suo dna da informatica ad aver avuto la meglio, in
questo caso. Sui computer Apple è il comando rapido per «tornare indietro»;
questa MelaZeta invece si mostra e si spoglia sul sito OnlyFans, si muove
sinuosa davanti alla sua telecamera, indossa completi intimi e ha decine di
followers (fans) che apprezzano e acquistano le sue performance. «Sono padrona
del mio corpo e mi gestisco da sola, nessuno può toccarmi, sono al sicuro nella
mia camera e guadagno i soldi che mi servono per pagare il mutuo». Un lavoro,
insomma, e di questi tempi non è poco. MelaZeta è una trentenne trevigiana;
faceva la segretaria fino all’autunno 2019, poi ha fatto la cameriera, è stata
lasciata a casa all’improvviso e si sa cos’è successo nel 2020: l’emergenza
Covid ha spezzato ogni consuetudine e ha impedito a molti giovani, come lei, di
trovare un’occupazione e uno stipendio certi. Si è arrangiata con qualche lavoro
precario ma i soldi non bastano, i conti non tornano. Ha fatto un tentativo con
internet e, per ora, per sistemare quel che le serve, funziona. La ragazza col
maglioncino a collo alto, jeans e anfibi, si sa trasformare in una seduttrice di
pizzo e malizia. Onlyfans, sito inglese, esiste dal 2016. L’anno scorso anche in
Italia è diventato un fenomeno social soprattutto fra i giovani (e non solo): i
contenuti non sono necessariamente espliciti, ci sono fotografie sensuali e
riprese di vita quotidiana, le protagoniste sono ragazze semplici, di provincia,
o influencer di fama internazionale. Tutto alla luce del sole, protetto e
garantito.
Melazeta, come hai cominciato?
«Era ottobre, c’erano scadenze da pagare. Mi è
sempre piaciuto farmi foto su Instagram, ricevevo reazioni positive. Poi
qualcuno mi ha suggerito di provare questo sito, ho utilizzato le stesse foto».
Senza pandemia e problemi di lavoro, l’avresti
fatto o è stata una questione economica?
«La mia è totalmente un’esigenza economica».
E si guadagna?
«Il primo mese non molto, a novembre seimila euro.
Quando facevo l’impiegata erano mille euro al mese. Ah, e vorrei precisare: è
tutto limpido, pulito, su ogni euro pago le tasse. Sono una sex worker, niente
di male».
Come funziona?
«Sul tuo profilo carichi le immagini che produci.
Ci sono abbonamenti e contenuti da “sbloccare” con dei pagamenti. Per partire
però serve avere già una fanbase perché il profilo funziona se hai tanti utenti.
Più contenuti vendi, più il tuo profilo cresce in visibilità. Il mercato è
enorme, l’offerta ampia. Anche la domanda».
Fai le foto da sola?
«Certo. E non si vede mai il mio viso. Molte foto
sono umili, credo si veda di più quando una ragazza è in costume al mare».
Sembri molto sicura di te, hai un buon rapporto
con il tuo corpo?
«Non proprio. Però cerco di riprendere i dettagli
più belli, quello che si può valorizzare, questo sì mi piace».
Qualcuno direbbe che il tuo lavoro è
squalificante, che stai vendendo il tuo corpo.
«C’è sempre chi dirà che è un retaggio del
patriarcato, che le donne credono di decidere per sé e invece rispondono a ciò
che vogliono gli uomini. La realtà è una: io ho una concezione del corpo molto
effimera. Oggi ci siamo, domani no. E ci sono dei problemi economici in questo
periodo. Se posso fare video nella sicurezza della mia camera, non vengo
importunata, in pieno rispetto delle normative Covid, le entrate sono
certificate, non sono su una strada, vendo immagini con cui pago il mutuo e le
bollette.... Beh, ci metto la firma. Rispetto chi non lo fa e chiedo lo stesso
rispetto».
Hai mai avuto problemi con i clienti?
«No, mai. E poi scelgo io a chi vendere. Sono
indipendente».
Non ti crea disagio questo lavoro?
«Perché? Non lo vedo come un tabù, lo trovo anzi
un po’ ironico. E poi è come andare in una boutique, dove la commessa ti
conosce, ti segue, rispetto a comprare su un sito di e-commerce. Qui il servizio
è su misura».
Giulia Sorrentino per "Libero quotidiano" il 12
gennaio 2021. Se dici Dubai i sinonimi sono ricchezza, bella vita,
spensieratezza. Sotto l'occhio del ciclone in questo momento perché non sono
rispettate minimamente le regole per il Covid, non è così rigida come si
racconta anche sotto altri aspetti. Ma cosa si cela dietro quella patina di
dorata perfezione? Basta aprire i social per qualche istante per capire che
tenore di vita hanno determinate persone che poco silenziosamente si aggirano
per le strade di Dubai. Tra pernottamenti in hotel super stellati e dotati di
ogni confort però non è così brillante come può sembrare. Sono molti gli
italiani che si recano lì per sviluppare il proprio business. Ma come si diventa
imprenditori a Dubai? Grazie a Luca Valori, imprenditore di 26 anni che vive a
Dubai da circa un anno, apriamo il vaso di Pandora che gli emiri tentano di
tenere chiuso affinché i fari non vengano accesi su scandali tramite
dichiarazioni compromettenti.
Come mai hai deciso di andare a Dubai?
«Io sono andato a Dubai per un discorso fiscale e
perché chi era lì mi raccontava che fosse una città super tranquilla, con una
vita spettacolare, dove avrei potuto svolgere il mio lavoro di consulenza e Drop
shipping (ovvero prendere dei prodotti puliti dalla Cina e rivenderli sul
mercato mondiale tramite internet). L'Italia per quanto riguarda la tassazione
ammazza l'imprenditoria, li non è così. Dubai era raccontato come se fosse il
paradiso, ed è questa l'immagine che circola sui social, tant'è che la maggior
parte delle persone ha questa visione di quel luogo».
Cosa hai trovato?
«Ho notato che lì è pieno di italiani, che in
massa stanno arrivando e che si distinguono in due categorie: quelli che
scelgono Dubai per aprire le loro società mantenendo la residenza fiscale in
Italia, e sono molti, nonostante ciò sia del tutto illegale, e quelli che invece
partono dall'Italia per prendere la residenza a Dubai».
E come funziona lì per iniziare l'attività? È così
semplice?
«Vanno lì, aprono la società pagando circa 15.000
euro e la società assume il proprietario della società stessa come
amministratore e quindi hai il permesso di diventare residente. Tutto ciò
richiede circa un mese. Per prendere la residenza e trasferire completamente il
tutto dall'Italia serve anche un contratto d'affitto annuo.
Che incremento hai avuto a livello economico?
«Circa il 100% perché la tassazione sui prodotti
venduti all'estero a Dubai è pari a zero. Ma se vendi qualcosa sul territorio
paghi solo il 5% di IVA. Quindi tendenzialmente si va lì per vendere all'estero
avendo questo tipo di agevolazione economica».
E da parte dell'Italia che tipo di controllo c'è?
Ammesso che ci sia.
«Nessuno. Fai solo l'iscrizione all'AIRE (italiani
residenti all'estero) e basta. Ma ora è un fenomeno diffusissimo, c'è una
quantità esorbitante di italiani che si sta riversando lì, ed è il motivo per
cui io me ne voglio andare, oltre al fatto che la gran parte della popolazione
(di cui tantissimi sono provenienti dal Pakistan) è per la maggiore sottopagata
e sfruttata».
Spiegati meglio, cosa c'è di Dubai che non ti
torna?
«Sono ancora residente lì, ma sto valutando la mia
dipartita perché ho visto la quantità di gente che arrivava ma soprattutto la
tipologia di vita che vogliono e non mi appartiene, perché per quanto riguarda
le ragazze non rispecchia i miei valori, diciamo che sicuramente a Dubai è
impossibile trovare l'amore».
In base ad altre testimonianze, l'amore vero
difficilmente si trova a Dubai, perché pare che ci sia un tasso di prostituzione
elevatissimo, nonostante la prostituzione sia un reato che li viene punito con
almeno quattro anni di reclusione, fenomeno che riguarda soprattutto ragazze che
arrivano dall'Italia e dall'est Europa con quell'obiettivo perché sanno che di
lavoro ne trovano molto. Dati shoccanti, perché sembra che il cachet di ciascuna
possa arrivare anche a 15mila euro a sera quando si trova l'uomo giusto che ne
voglia scegliere più di una con le quali festeggiare una serata in compagnia.
Che la solitudine fosse il male del secolo si sapeva, ma non pensavamo fino a
questo punto. E se vi dicessimo che la paga media di un tassista o muratore è di
circa duecento euro mensili? La classe media è un'utopia e le ragazze a
pagamento pare che siano parte dell'alta società, date le cifre che riescono a
raggiungere. Inizialmente si può cadere in fallo, pensare che ci si trovi
difronte ad una ragazza qualunque, perché l'approccio ovviamente è quello dei
più classici, ma mentre si sorseggia un drink arriva secca la frase "sono
duemila dirham l'ora" (circa duecento euro) con una nonchalance ed un sorriso
disarmanti. Questa la paga media, l'ora, che consente loro di avere il tenore di
vita che poi sciorinano su Instagram, con calici di champagne e una macchina di
lusso affittata (in cash, perché non è controllato il denaro contante, bensì ben
accetto) giusto il tempo di uno scatto che le rende agli occhi dei followers
modelli da seguire. Ragazze ben vestite, talvolta con orologi al polso da
centomila euro che vanno e vengono dal bancone del bar di lusso, che passano
dalla camera 33 a quella 36 in una sola serata, e ciò quando il lavoro è poco.
Locali in cui la percentuale di uomini si aggira intorno al 30% mentre le donne
sono appunto circa il 70%. Ma questa è la Dubai che a noi non è concesso vedere,
perché le autorità sono severissime verso chi risiede lì e s' azzarda a rivelare
i segreti del sottobosco degli Emirati, tanto che non consentono il giornalismo
d'inchiesta, impedendo l'utilizzo di telecamere per riprendere fatti rilevanti
di cronaca e non solo. Quindi diciamolo chiaramente, non è tutto oro quel che
luccica, soprattutto se è consentita una prostituzione a livelli così elevati,
una prostituzione non legalizzata, condannata ardentemente nei palazzi, ma
adulata nei salotti in cui il velo si dissolve diventando perizoma.
·
Cornuti/e e mazziati/e.
Signore e signori. Ambra,
Boccassini e l’idea che il tradimento tra adulti sia la cosa più devastante che
possa capitare.
Guia Soncini su L'Inkiesta il 16 Ottobre 2021. Con l’indignazione
per il tapiro all’attrice tradita e per le rivelazioni dell’ex magistrato su
Falcone sembra di essere tornati nel mondo di Pietro Germi. E da quando le
diciassettenni, le uniche peraltro che avrebbero diritto a considerare le corna
una questione di vita o di morte, vengono adulate come fari culturali? Dio, come
mi manca Pietro Germi. Mi manca fino alla profondità, la vastità e l’altezza che
l’anima mia può raggiungere allorquando persegue, irraggiungibili agli sguardi,
i fini del bene e della grazia ideale. (Sì, sto scempiando quella poesia che vi
sembra di riconoscere ma non siete proprio sicuri: è Elizabeth Barrett Browning,
la declamavano in una puntata di Saranno famosi quand’eravate piccoli e avreste
dovuto studiare Tacito invece di guardare la tele). Mi manca Pietro Germi in
questo secolo a lui successivo che è a lui contemporaneo: chissà dove pensavate
di vivere, voi che abitate il tempo congelato, immobile, di Signore e signori,
di Divorzio all’italiana, di Sedotta e abbandonata. Ho sospettato fossimo
quell’Italia lì la settimana scorsa, quando Ilda Boccassini veniva accusata
d’aver diffamato Francesca Morvillo svelando d’aver avuto, trent’anni fa, una
relazione con suo marito, Giovanni Falcone. Quella al capitolo fedifrago delle
memorie di Ilda Boccassini è stata una reazione comica. Custodi della morale
matrimoniale si battevano il petto come prefiche al funerale della monogamia. Mi
tornava in mente la vedova di Spencer Tracy che, a Katharine Hepburn – amante di
lunghissimo corso del marito, a tutti gli effetti un matrimonio parallelo – che
le telefona, risponde «ma io credevo tu fossi un pettegolezzo». Solo che allora
era il 1967, un anno dopo Signore e signori. Sono passati mille anni, in termini
di costumi di coppia, parrebbe – e invece. E invece ricopio il commento che più
mi è piaciuto all’uscita del libro dello scandalo; il commento, su Facebook, di
una signora – Eleonora, non vi dirò sotto che articolo di che giornale, né ve ne
svelerò il cognome – che unisce il contemporaneo non sapere niente di niente
mai, e lo scandalizzarsi come le beghine messe in scena da Germi: «Ma Falcone
era sposato? Questo non l’ho capito. Perché, se lo era all’epoca, la signora è
una maleducata, priva di sensibilità verso i parenti della moglie. Perché farli
soffrire? Non mi piace!». Per Eleonora i parenti di Francesca Morvillo, che
quarantaseienne morì in un attentato assieme al marito e alla scorta,
soffriranno perché la signora era, aspettate che continuo l’articolo con una
mano sola mentre con l’altra m’attacco a una tenda per meglio significare la
drammaticità di questa condizione invero rarissima nonché grave, cornuta. Ebbene
sì, signori della corte: cornuta. Mi piacerebbe che Eleonora fosse un’eccezione,
ma la vicenda di Ambra mi ha fatto capire che no, siamo proprio convinti che le
corna siano la cosa più devastante che possa capitare (sospetto non sia colpa di
Anna Karenina che si butta sotto al treno ma del coniglio da compagnia bollito
dell’amante in Attrazione fatale: la mia generazione era giovane e
impressionabile). Se siete appena tornati da Marte, riassumo. Ambra Angiolini –
attrice, madre (sì che c’entra), e madeleine del boncompagnismo, carattere
fondativo della nazione – conclude la sua relazione con Massimiliano Allegri –
tizio a me ignoto che ha a che fare col giuoco del calcio – e riceve perciò la
visita d’un inviato di Striscia la notizia, il quale le consegna un brutto
oggetto che, storicamente, la trasmissione consegna a chi abbia fatto una brutta
figura. (Che concetto da provincia germiana, la «brutta figura»). Scusate la
premessite ma devo precisare che, tra un inviato televisivo che t’impone
un’intervista che non hai concesso, e chiunque altro sia l’intervistato
renitente, io sto e starò sempre contro il varietà televisivo che t’impone
d’alzargli gratis gli ascolti, anche qualora l’intervistato fosse Priebke.
Figuriamoci se è Ambra Angiolini. Tuttavia, quando l’opinionismo accorre in
massa a dire ad Antonio Ricci che come ha potuto essere così atroce, così
insensibile, così irrispettoso d’una situazione così delicata; quando le
presunte corna d’una storia d’adulti vengono trattate come se invece che di
corna stessimo parlando di terrore miseria e morte; quando le diciassettenni
vengono trattate come fari culturali (la figlia di Ambra e di Francesco Renga,
la diciassettenne Jolanda, unica ad avere l’età giusta per considerare le beghe
sentimentali questione di vita o morte, come Giulietta Capuleti, è intervenuta
sui social, la cui livella ci fa trattare allo stesso modo un intervento di
Jolanda Renga e uno di Angela Merkel); ecco, quando accade tutto questo io mi
chiedo se ci abbia dato di volta il cervello. Quando Elena Stancanelli – ieri
sulla Stampa – scrive «sono stata tradita dall’uomo con cui stavo e questo fa di
me una persona ridicola? Ho capito bene?», io, senza neppure sapere se Ambra
fosse d’accordo col programma (quando si tratta di gente dello spettacolo, i
programmi aggressivi sono spesso più complici di quanto lo siano coi carneadi),
senza sapere niente dei fatti, osservo la tenda cui ci siamo tutte attaccate
alla prima occasione in cui far sfoggio delle nostre priorità, e penso quant’è
strano che non ce ne sia stata neanche una, ne sarebbe bastata una, che dicesse
«ahò, ma erano solo corna»; neanche una, ne sarebbe bastata una, che alle accuse
di vessare le donne abbia risposto che gli uomini sono cornuti almeno
altrettanto (almeno); e poi penso a quanti soggetti sprecati, e a cosa avrebbe
saputo farne Germi.
Giampiero Mughini per Dagospia
il 16 ottobre 2021. Caro Dago, sarà perché invecchio sempre più pericolosamente
fatto è che sempre più pregio il valore della discrezione, del non far rumore
mentre cammini, dello scansarti e del non esserci anziché esserci a tutti i
costi sui media e compagnia cliccante. Un valore che è talmente in
controtendenza rispetto alle voghe e ai valori della nostra società da diventare
rarissimo e dannoso per chi lo pratica. Naturalmente ero stato fra coloro che
erano rimasti sbalorditi della consegna del Tapiro di “Striscia la notizia” ad
Ambra, persona e donna che conosco e apprezzo: e che è la testimonianza vivente
di quanto Gianni Boncompagni, che la scoprì “ragazzina”, ci azzeccasse sempre
nei suoi giudizi. (E a proposito di Boncompagni e della sua “Non è la Rai”, ho
apprezzato molto che Aldo Grasso, un critico televisivo di cui condivido appieno
il 90 per cento di quello che scrive, si sia detto “pentito” del non avere
apprezzato a suo tempo quella formidabile invenzione televisiva.) Mai e poi mai
l’avrei scritto da quanto mi sembrava banale, certo era sconcertante che un
segno di dileggio venisse appioppato a una donna di cui sembrava che fosse stata
“lasciata” dal suo uomo dopo una relazione durata quattro anni. Solo che le cose
a quanto pare non sono andate così. Ambra, che è donna di spettacolo e donna
intelligente, pare abbia concordato la scenetta con i finti pirati di “Striscia
la notizia”. Ha intuito che da quella sceneggiata ne sarebbe venuta per lei un
gran guadagno massmediatico, e difatti mezza Italia dopo quella scenetta tifa
(giustamente) per lei. La società fondata sulla comunicazione massmediatica,
secondo cui l’importante è esserci, trionfa ancora una volta. Ambra non ci fosse
stata, ne avrebbe avuto solo danni sotto forma di disinteresse, di silenzio su
di lei, di non esserci per l’appunto. Al suo posto in quei giorni avrebbe magari
trionfato una qualche sciacquetta qualsiasi che si fosse resa “visibile” per il
più banale dei motivi. E del resto in una società dominata dal rumorio della
comunicazione di massa, come fai a distinguere tra motivi “banali” e motivi che
non lo sono. Impossibile. Esserci esserci esserci. A tutti i costi. A cominciare
dall’esserci sui social a qualsiasi costo e in qualsiasi circostanza. Senza di
che, è il caso mio, la tua condizione diventa eguale a quella degli antifascisti
esuli in Francia e dunque lontanissimi dalla realtà italiana degli anni Venti e
Trenta. Non esisti, non esisti proprio. Un mio amico che stava sui social due
tre ore al giorno, mi diceva che quando usciva un suo libro era come se duemila
copie fossero già immediatamente vendute. A coloro con i quali aveva duettato a
colpi di clic per mesi e mesi. Malato di discrezione come sono, se esce un mio
libro non ne accenno neppure ai miei amici. Una volta la Feltrinelli mi aveva
invitato a parlarne in una delle sue librerie romane. Di quell’appuntamento non
ne feci parola con nessuno. Nella saletta si radunarono venti o venticinque
persone, non una di più. Vendetti due copie del libro. Mi direte che questa è
spocchia. Ossia l’altra e prelibata faccia della discrezione. Ma certo che lo è.
Perché solo
la Angiolini merita tutela? Il doppiopesismo smascherato dal tapiro.
Francesca
Galici il 18 Ottobre 2021 su Il Giornale. Per il tapiro d'oro ad Ambra Angiolini
è sceso in campo anche il ministro Bonetti: perché non è accaduto quando a
ricevere il tapiro sono state altre donne? La storia d'amore tra Ambra
Angiolini e Massimiliano Allegri si è conclusa. Non è la prima e non sarà certo
l'unica, i loro fan se ne faranno una ragione. Ma da giorni non si fa che
parlare di loro due ma soprattutto di Ambra, a quanto pare tradita dal suo ex. E
anche qui, non è che sia l'unica ad aver subito questa sorte, la social guru
Giulia De Lellis ci ha fatto pure un libro dal titolo "Le corna stanno bene su
tutto". E se lo dice lei, chi siamo noi per contraddirla? Ma la querelle per la
quale la Angiolini è stata eretta quasi a povera vittima e sulla quale, a detta
di alcuni, non si può scherzare è nata quando è entrata in scena Striscia la
notizia. Le femministe strombazzanti hanno iniziato a lamentare il fatto che è
stato crudele consegnarle il Tapiro d'oro, nato come riconoscimento nei
confronti degli "attapirati", ossia tristi. Addirittura in favore dell'attrice
si è spesa anche Elena Bonetti, ministro per le Pari opportunità e per la
famiglia. "Queste vicende non devono mai essere spettacolarizzate. Certamente si
è scelto di andare dalla donna e non dall'uomo. Ma conosco Ambra, donna di
grande coraggio e ha retto questa situazione con grande dignità", ha detto ai
microfoni di Radio Capital. Un inasprimento del clima al quale il tg satirico di
Canale5 ha provato a mettere una pezza, alleggerendo il tutto e lasciando che
fosse il tapiro stesso a rispondere al ministro, segnalandole tutti i casi in
cui il tapiro è finito nelle mani di uomini e donne dopo la fine della loro
relazione. "Come vede, mi sono sempre fatto un punto d'onore di rispettare le
Pari opportunità. Lei, invece, cara Ministra, sembra non considerare Diletta
Leotta degna della sua tutela, con il solito doppiopesismo rivelatore", si legge
nel comunicato. In effetti, non si ricordano altre volte in cui ci si è
stracciati le vesti per un tapiro consegnato a una persona tradita.
"Quanti sepolcri imbiancati, prosseneti, finti moralisti o semplici ciarlatani,
individui in crisi di astinenza o semplicemente bisognosi dell'esternazione
quotidiana si sono sentiti autorizzati a pontificare sull'argomento", chiosa in
chiusura di comunicato il tapiro. Ma tutto questo va contestualizzato, perché
Striscia, dopo che si è sollevato il polverone, ha mostrato il fuorionda della
consegna. Ambra, dice il tapiro, "non ha mai manifestato a Staffelli la minima
volontà di non essere intervistata, come risulta evidente durante tutto il
servizio. A telecamere spente, inoltre, Ambra si è raccomandata con Staffelli
che in sede di montaggio non venissero compiute azioni che stravolgessero il
senso di quello che lei aveva detto: richiesta naturalmente accolta". Se il
clima era disteso e non c'è stata nessuna richiesta di spegnere le camere o di
non trasmettere il servizio da parte dell'attrice, cos'è successo dopo? Non si
sa, però gli avvocati di Ambra Angiolini hanno annunciato che si riservano di
procedere "in considerazione dell'illegittima intromissione e conseguente
spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del
signor Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia". Ai legali ha risposto
ancora una volta il tapiro d'oro: "Mi sono limitato a raccontare quello che è
visibile a tutti nel filmato pubblicato sul nostro sito, a prova di ogni
smentita. È evidente la volontà di trasformare l’episodio in una telenovela".
Striscia la notizia consegnerà ora un tapiro al tapiro?
Francesca Galici.
Giornalista per lavoro e per passione. Sono una sarda trapiantata in Lombardia.
Amo il silenzio.
Non solo Wanda e Icardi.
L'eterna "incornata" che fa la storia del calcio.
Tony Damascelli il 18 Ottobre
2021 su Il Giornale. Dai 14 figli di Garrincha fino a Buffon, Terry e Balotelli:
tradire è un classico del pallone. Raccontano che Garrincha sia stato padre di
quattordici figli, raccontano pure che i suddetti non siano tutti della stessa
madre ma sparsi un po' per il mondo, quello del football in particolare,
frequentato dal fenomeno brasiliano. La storia è antica, dunque, di tradimenti
di sesso, di famiglie spaccate, di matrimoni finiti, di clamorosi divorzi. Wanda
Nara ha scoperto che «mi tesoro» come Lei chiamava Mauro Icardi, se la intende
con una sventola (si può scrivere o è oggetto di sessismo acuto?) compatriota,
Eugenia Maria Suarez detta China ma avendo una nonna giapponese. Lo stesso
Icardi aveva portato via la succitata Wanda al sodale Maxi Lopez con la quale la
strepitosa Nara aveva dato alla luce figli tre. Raccontano che Gigi Buffon abbia
messo le corna ad Alena Seredova preferendole Ilaria D'Amico e la ragazza di
Praga si sia vendicata unendosi ad Alessandro Nasi che, in un certo senso, è tra
coloro che ha garantito il salario di Buffon. Raccontano che John Terry, ex
capitano del Chelsea, somigliante assai a Kevin Spacey, abbia approfittato di
Vanessa Perroncel ma questa era moglie di Wayne Bridge, sodale di squadra di
John, al punto da rinunciare alle convocazioni in nazionale, per evitare di
incontrare il vigliacco al quale Fabio Capello, per punizione, tolse pure la
fascia di capitano. Si potrebbero raccontare storie cento di Diego Armando
Maradona e delle sue prestazioni in orizzontale, le battaglie sull'eredità
coinvolgono parenti vicini e lontani. Ha un buon album di figurine private Mario
Balotelli che conta un numero di amori traditi superiori ai gol realizzati. Ci
fu il caso di Wilfied Zaha ceduto dal Manchester United perché scoperto a filare
con la figlia dell'allenatore David Moyes. Si narra del colombiano James
Rodriguez che perse la testa per la modella russa Helga, conosciuta ad una festa
in casa di Cristiano Ronaldo. Nulla di strano se non che la relazione esplose e
proseguì mentre Daniela Ospina, la moglie di Rodriguez, stava in Colombia con
tutta la famiglia appresso. L'olandese Virgil Van Dijk ha commesso un fallo da
cartellino rosso, lasciando la moglie per Georgie Lyall, buona fantastica però
attrice nota di film porno, sulla stampa inglese grandi reportage e fotografie
della coppia beccata ignuda in albergo. Restando nel mondo hard non va
dimenticato Faustino Asprilla che consigliò moglie e figli di andare in Colombia
perché il clima di Parma era umido, freddo, nebbioso, malinconico e per
combatterlo Faustino pensò di buttarsi su Petra Scharbach, tedesca affascinante
e divertente. L'ex difensore di Napoli, Vicenza, Juventus, Roma e varie, Luciano
Marangon, soffriva di solitudine e andava per discoteche, si scaldava prima
delle partite con un team di donne belle, lo accompagnava Ruud Krol che così
spiegava alla propria moglie: «Vado da Luciano che è sempre solo». Non male, si
fa squadra anche così. Si segnalano anche vicende colossali di presidenti di
serie A capaci di colpi di mercato in casa altrui. Il mondo del calcio vive di
finte in campo e anche fuori. Basta non stupirsi. Un tempo dalle tribune si
urlava: «Arbitro cornuto!», ormai l'insulto non va più di moda, è superato.
Basta consultare l'almanacco e scegliere una figurina tra le tante dei
calciatori e ripetere lo stesso strillo. Nemmeno il Var potrebbe smentirlo. Tony
Damascelli
Non solo Icardi e Wanda
Nara: amori, gossip, tradimenti da Rooney a Courtois, da Tiger Woods a Ryan
Giggs.
Lorenzo Nicolao su Il Corriere della Sera il 19 ottobre 2021. Gli scandali hanno
macchiato la vita di molti sportivi: dall’allenatore Nba Derek Fisher licenziato
per le amanti al divorzio da 50milioni di Giggs, dalla escort di Rooney alla
sauna di Glushakov ai tradimenti seriali di Tiger Woods.
Cuori spezzati
Ci sono campioni che fanno
riempire le pagine dei giornali con le loro gesta sportive e altri che
intrattengono il pubblico anche con le loro vicende fuori dal campo, affari in
teoria privati che spesso diventano scandali pubblici. La lite data in pasto ai
social tra Wanda Nara e Mauro Icardi è solo l’ultimo caso di una coppia che ha
sempre dato un grande contributo al gossip, ma non mancano i precedenti, nel
calcio e non solo, di star sportive al centro delle attenzioni per le vicende
sentimentali. Una squadra molto numerosa.
Wayne Rooney e la escort
Di questo club fa parte lo
sventurato Wayne Rooney, che in Gran Bretagna non è mai riuscito a stare troppo
lontano dai locali e da situazioni scomode. La moglie Coleen e i quattro figli
non hanno affievolito la fama di donnaiolo dell’ex attaccante del Manchester
United. Tra vari scandali, quello che i tifosi e gli appassionati ricordano è la
frequentazione della escort Jennifer Thompson, una serie di incontri dal costo
equivalente di 1.500 euro a notte, proprio quando la consorte era incinta del
primo figlio.
Ryan Giggs tradimento da 50
milioni
Sempre tra gli ex Red Devils,
Ryan Giggs in campo ha avuto una carriera encomiabile, ma non si può dire
altrettanto della sua vita privata. La storia che ha generato tanto scalpore
Oltremanica è quella con la cognata, un tradimento — durato ben otto anni — che
ha portato innumerevoli polemiche ed è costato all’ex ala dello United quasi 50
milioni di euro.
Alex Lacazette e la doppia
vita
Beccato dal quotidiano
britannico The Sun, l’attaccante dell’Arsenal Alex Lacazette ha di fatto avuto a
Londra una doppia vita. Non ha lasciato la sua compagna storica Manon Magovero,
ma ha al contempo frequentato Funda Gedik, appariscente hostess di un nightclub.
La vicenda non poteva passare inosservata ai quotidiani popolari di un Paese che
nelle cronache sportive dà ampio spazio alle vite private degli sportivi. In
un’intervista, l’amante ha dichiarato di essere sempre stata trattata come una
principessa: «Si comportava come il ragazzo ideale, quando mi ha detto che era
fidanzato sono rimasta scioccata».
Ashley Cole preso a pugni
In Gran Bretagna scandalo
anche per l’ex terzino di Chelsea e Roma Ashley Cole che anche in Italia non ha
mai smesso di fare la bella vita. Dopo la separazione con la popstar
Cheryl tantissimi flirt e vita mondana, ma sembra essere stata appurato dai
tabloid che la liaison con la modella di Playboy Melissa Howe, fatta di incontri
passionali e della frequentazione dei locali di Londra più esclusivi, fosse
iniziata quando il difensore era ancora sposato. In una di queste serate, Cole è
stato anche preso a pugni in un locale della City, ma non dalla moglie, bensì
dalla sorella gemella di Melissa, Carla Howe, anche lei playmate. Quasi certo
che avesse anche lei un conto in sospeso con il giocatore.
Thibaut Courtois e la vicina
di casa
Neanche il portiere
belga Thibaut Courtois è riuscito a evitare guai sentimentali quando giocava nel
Chelsea. Al Daily Star Elsa Izac ha confessato la sua storia segreta con il
portiere, allora suo vicino di casa. L’estremo difensore sembrerebbe essere
anche il padre del figlio di lei, concepito proprio mentre la compagna ufficiale
di Courtois era incinta di lui. Un imbarazzo non indifferente rivelato
direttamente alla stampa.
Hulk e la nipote della moglie
L’attaccante brasiliano
Hulk ha addirittura sposato la nipote della sua ex moglie. La relazione con
Camila Angelo, che ha fatto tantissimo parlare i tabloid russi quando la punta
giocava per lo Zenit San Pietroburgo, è stata addirittura spiegata dall’addetto
stampa del calciatore, nel vano tentativo di superare l’imbarazzo. Ora Hulk fa
comunque coppia fissa con la nuova fiamma e i due sarebbero anche in attesa di
un bambino.
Denis Glushakov la sauna sui
social
Sorpreso in sauna dalla moglie
Darya in compagnia della presunta amante nel 2018. Questo il caso scottante
di Denis Glushakov, l’ex capitano dello Spartak Mosca e ora centrocampista in
forza al Chimki. La vicenda è finita in tribunale. Per la moglie la donna era
una prostituta, per il giocatore e gli avvocati difensori solo un’amica di
vecchia data, con la quale non c’era stato nulla. Tutta la scena è stata però
filmata dalla moglie in diretta e subito diffusa sui social media.
Juan Carlos Osorio
Passando agli allenatori, si
ricorda certamente la vicenda di Juan Carlos Osorio, ex c.t. del Messico che ai
Mondiali di Russia del 2018 avrebbe accompagnato la squadra con moglie e amante.
In patria la relazione con la giovane amante, una celebre giornalista messicana,
ha fatto completamente impazzire le cronache rosa. Durante gli ottavi di finale
contro il Brasile, sembra che le due donne occupassero posti molto vicini in
tribuna, a pochi metri l’una dall’altra, in un silenzioso e omertoso imbarazzo
generale.
Derek Fisher
Negli Stati Uniti, anche nel
mondo Nba, si bada molto alla reputazione, tanto che l’ex allenatore dei New
York Knicks Derek Fisher è stato licenziato perché, da vero latin lover, aveva
frequentato diverse amiche dei suoi giocatori e anche l’ex moglie di uno di
loro, Matt Barnes. Per quest’ultimo caso il triangolo amoroso è terminato
addirittura con una rissa, quanto basta per spaccare lo spogliatoio e
costringere il club a liberarsi dello scomodo allenatore.
Tiger Woods
Su tutti gli altri resta però
irraggiungibile il caso del campione di golf Tiger Woods, un sexgate che per un
periodo ha condizionato anche la sua carriera e ha costretto la leggenda a
ricorrere a un centro per disintossicarsi dal sesso. La moglie si è inferocita
più volte, ma l’infedeltà del marito è stata scoperta quando lui aveva già
collezionato il record di oltre cento frequentazioni clandestine, tra hostess,
segretarie, giornaliste e modelle, come la svedese Nordegren, che avrebbe avuto
dal campione addirittura due figli. Woods ha promesso di non ricascarci, ma è
difficile uscire dall’imbarazzo quando periodicamente un’altra ex amante si fa
avanti e racconta alla stampa nuovi particolari.
Stefania Medetti per La Stampa
il 10 settembre 2021. Dici tradimento e pensi subito a una relazione
extraconiugale, ma come lo chiami quando tuo marito paga le escort? «È evidente
che siamo in un’altra categoria», ammette Claudia (il nome è di fantasia), 48
anni, due figli, una carriera in una prestigiosa azienda multinazionale e un
segreto sussurrato alle amiche più fidate. «Nel nostro caso, la tana del
Bianconiglio è più profonda di quanto potessi immaginare». «Dopo vent’anni
insieme pensi di conoscere una persona, ci si abitua un po’ alla presenza
dell’altro. Forse è proprio per questo che non ci siamo accorti di quanto la
distanza fra noi fosse cresciuta». In quella incrinatura che diventa una crepa,
la coppia si è persa. «Difficile dire: è stato lì, è successa quella cosa o
quell’altra. Quando passi da due a quattro, con la famiglia che cresce e il
lavoro da seguire, diventa tutto più complicato». Claudia non cerca
giustificazioni e non fa sconti al comportamento del marito. Piuttosto, parla
per mettere in ordine i pezzi di un puzzle. «Non abbiamo prestato attenzione ai
segnali, abbiamo lasciato che accadesse. Forse, il primo campanello d’allarme è
stato quando ha cominciato a essere critico nei miei confronti, irritabile e
anche un po’ distaccato dalla vita della nostra famiglia». Nulla di
macroscopico. «O forse avrei dovuto notare che, nell’intimità, ero sempre io a
cercare lui. Lì per lì, però, non ci fai caso. Non stai mica a contare le volte,
no?». Eppure, a posteriori, Claudia riconosce che avrebbe dovuto far caso alle
reazioni inconsuete del marito, andare più a fondo quando la sua vita parallela,
come un’ombra, iniziava a palesarsi nella vita di coppia. «Un paio di volte l'ho
visto chiudere al volo una schermata al computer. Era chiaro che stava guardando
un porno». Ma gli uomini, dice Claudia, «sembrano costruiti per negare, per non
ammettere, per sminuire, rivoltare la frittata. Quando ho chiesto un confronto
sull’argomento, mi ha detto: "La maggior parte degli uomini guarda il porno e
anche le donne". Come se ci fosse qualcosa di sbagliato in me, se preferisco
invece leggere un libro. Ho pensato: va bene, non sono mica sua madre». Poi
arrivano i messaggi sospetti sul cellulare. «Ha negato fossero persone diverse
dai colleghi e, in definitiva, mentito. E io non ho avuto l’animo di mettermi a
curiosare in un oggetto tanto personale». Altre volte, capitava che i suoi
viaggi di lavoro durassero troppo a lungo: «Avevo iniziato a drizzare le
orecchie. Nutrivo sospetti, ma nessuna prova di quello che percepivo sotto la
superficie della nostra quotidianità». La svolta per Claudia è arrivata
inaspettata per una dimenticanza del marito, una specie di lapsus freudiano: «Ho
trovato un biglietto nella sua valigia, stessa città della sua ultima
trasferta». Ha chiesto spiegazione, e davanti all’evidenza dei fatti l’intero
castello è crollato. «Siamo sprofondati in un lungo silenzio. Lui ha provato a
negare, ma si è trovato di fronte un muro. Mi è sembrato quasi sollevato. Ho
pensato a Raskol’nikov, quando si libera del peso del suo crimine in Delitto e
Castigo». Secondo Chiara Nardone, psicologa e psicoterapeuta, è tipico che si
presenti la sensazione di liberazione da parte del marito. «Quando si confessa,
è come se lasciassimo cadere il fardello del tradimento direttamente sul
partner. In altre parole, scarichiamo la responsabilità di scegliere il futuro
della coppia sull’altra persona, che viene messa in una condizione emotivamente
scomoda, in bilico tra razionalità e cuore». Per qualche giorno, Claudia non è
riuscita a dire nulla. «Sarà che dentro di me stavo aspettando questo momento.
Sarà che, proprio per quella distanza che si era creata fra di noi avevo
iniziato a recuperare i miei spazi - il tennis e la meditazione - e avevo
ricominciato a ritrovarmi. La scoperta non mi ha travolto come un’onda. È stata
piuttosto una marea che sale lentamente, con tutta una gradazione di sentimenti
che continuo a elaborare anche oggi». Claudia ha osservato la situazione con
razionalità: «Ho detto ok, posso fare qualcosa contro di lui, posso distruggere
tutto quello che abbiamo costruito in questi anni. Oppure posso fare qualcosa
per noi, come coppia e come famiglia. Invece di prendere una decisione di
pancia, ho preso una decisione di cuore». Quello che ha fatto pendere l’ago
della bilancia, alla fine, è stato mettere le cose in prospettiva. «Non ho
guardato alla nostra storia come una partita a due. Ho guardato alla nostra
storia come una storia nella storia, quella delle generazioni». I nonni, i
genitori, i figli e i nipoti. «Nella mia famiglia non se ne è mai parlato, ma
sono segreti di Pulcinella. Mio nonno tradiva mia nonna, mio padre tradiva mia
madre. Ognuna di queste coppie ha giocato la partita a modo proprio. I miei
nonni erano separati in casa, sotterrata l’ascia di guerra, non si sono mai
riconciliati. Fra i miei genitori ho sempre percepito un grande freddo, una
distanza inspiegabile». Nella famiglia del marito, stesso copione: la nonna era
rimasta in silenzio, la madre aveva fatto la valigia. «È come se un filo
invisibile legasse tutte queste vite e io non voglio che i nostri figli, per
quelle alchimie misteriose della psiche, si ritrovino invischiati in qualcosa di
analogo. Vorrei che questa catena finisse con noi». Claudia decide di non
chiudersi la porta alle spalle. «Lei ha scelto di gestire il suo futuro
piuttosto che subirlo», commenta Nardone. «Analizzando le modalità di reazione
delle generazioni precedenti, ha scelto di fare quel che pensava sarebbe stato
meglio per se stessa, per recuperare la coppia e 'salvare' i figli». Però,
Claudia ha posto al marito una condizione: la terapia. «Da soli non ne saremmo
mai usciti. Dopo la prima seduta mi ha detto: "Non pensavo che pagare per il
sesso fosse equiparato a una dipendenza. Non avevo capito che ripetevo uno
schema, credevo fosse una valvola di sfogo allo stress". Ho intravisto la
solitudine che io, in tutta onestà, avevo contribuito a creare». «L'interazione
tra due partner è sempre un processo circolare», ricorda Nardone: «Se un attore
cambia la sua modalità di approcciarsi, automaticamente conduce l’altro a
cambiare». Claudia prende atto che la sua coppia era più fragile di quanto
immaginasse. «Non è che uno esce di casa una mattina e paga una prostituta.
Abbiamo percorso le tappe in discesa: il bisogno di distrazione che diventa
abitudine, fino alla dipendenza». Poi c’è quella che Claudia chiama «una stanza
chiusa a chiave». «Se penso al "cosa" ha fatto e ai rischi cui ci ha esposti
sento un nodo allo stomaco. Ho temporaneamente archiviato questo pensiero in un
angolo della mente in cui ho impedito alla mia immaginazione di entrare. Anche
se un giorno so che dovrò affrontarlo». La terapia sta aiutando la coppia a
rimettere le cose in prospettiva, a ricostruire la fiducia e l’intimità andate
in frantumi. «La sfera intima è forse la più difficile da recuperare, ma è anche
quel volano che fa ripartire a pieno regime la relazione di coppia», spiega
Nardone. «E non stiamo parlando solo del sesso, ma anzi di quella complicità
insita nei piccoli gesti quotidiani: una carezza, un bacio, un messaggio
inaspettato». Il Covid, paradossalmente, ha dato una mano. «Con il lockdown, nel
bel mezzo della pandemia, per lui è stato impossibile andare a cercare altre
donne! È stato un detox forzato», scherza Claudia, che si considera una donna
tradita, ma non sconfitta. «Una donna diversa avrebbe fatto una scelta diversa e
non sto giustificando la mia. È stato sbagliato decidere di andare avanti
insieme? A parte questi episodi e il fatto che non abbia parlato con me delle
sue difficoltà, mio marito è un padre presentissimo e un buon compagno di vita».
«La nostra relazione di prima non c’è più. Al suo posto, adesso, ce n’è
un’altra, impostata su basi diverse». Claudia sa che tutto è cambiato ma è anche
convinta che la direzione presa sia quella giusta: «Parliamo di più e quando lo
facciamo scelgo bene le parole. Non dico mai "quello che hai fatto", ma dico
"quello che ci è successo"». Le parole, sottolinea la psicologa, sono
importanti: «Gli esseri umani interpretano la realtà attraverso le parole che
scelgono per descriverla. Pertanto, è fondamentale che si cambi registro
comunicativo all'interno della coppia per migliorare la relazione con sé stessi
e con l’altro». C’è un’ultima considerazione che ha spinto Claudia verso la
ricostruzione del rapporto: la convinzione che non esistano vite prive di
dolore. «Ogni persona ha la sua parte di difficoltà con cui fare i conti. Il
dolore assume semplicemente forme diverse. Non puoi evitarlo, puoi solo passarci
attraverso». Secondo Nardone, la storia di Claudia è paradigmatica: «È un
esempio perfetto di come il progetto di coppia non sia mai un gioco a somma
zero, in quanto si vince o si perde entrambi sia a livello individuale sia a
livello relazionale».
DAGOTRADUZIONE DA dailymail.co.uk
il 28 aprile 2021. Di solito accade dopo circa un mese: Siete passate dal
"Non posso credere di averti trovato!" a sentirsi abbastanza coraggiose da
condividere le parti più grintose del vostro passato che potrebbero non essere
così lusinghiere. A volte, questo vi avvicina ancora di più. Altre volte, c'è un
'Whoa! Questo non è quello che pensavo fossi! ' che porta a una brusca
interruzione dello sviluppo. Ma il fatto è che tutti noi abbiamo cose nel nostro
passato di cui potremmo non essere super orgogliosi. A volte è qualcosa con cui
non abbiamo alcun problema, ma il nostro nuovo partner sì. Prima di entrare nel
merito di come calmare le acque agitate, voglio chiarire che nessuno dovrebbe
vergognarsi del proprio passato - e quello che avete in mente sono affari
vostri. Ora che avete capito, ecco cosa fare se il vostro partner non ha lo
stesso punto di vista.
Avete avuto molti amanti.
Se seguite
il mio consiglio, questo è un "peccato" sessuale che non dovrete espiare perché
il vostro partner non lo saprà mai. "Allora, quanti amanti c'erano prima di me?"
è una domanda a cui non credo che nessuno dovrebbe rispondere. Il motivo è
questo: i numeri non significano nulla senza conoscere le circostanze. Ecco
perché ridurre una storia sessuale a un numero non funziona. Diciamo che ci sono
due donne, entrambe sulla trentina. La prima ha dormito con 26 uomini, la
seconda con otto. Nessun premio per aver indovinato quale donna sarebbe stata
giudicata più duramente da un partner. Ma era davvero la più promiscua? Ecco
qualche informazione in più: la ragazza che ha avuto 26 amanti, una media di
circa due amanti all'anno da quando aveva 17 anni ed è stata principalmente
single. La ragazza che era andata a letto con otto uomini, aveva avuto quattro
di quegli incontri durante un fine settimana in un resort con i suoi amici,
mentre suo marito stava a casa e si prendeva cura dei bambini. Cosa ne pensate
adesso? Se il vostro partner vi chiede di dare un numero agli ex amanti,
ditegli: 'Non discuto di cose del genere. Penso che sia inutile. Quello che
abbiamo fatto entrambi nel nostro passato è irrilevante, preferisco parlare di
quello che facciamo ora e in futuro. "Ditegli che preferiste lasciare che i
dettagli sulle relazioni passate emergano naturalmente nella conversazione. Le
persone che contano - nel bene o nel male - finiranno per essere discusse. Il
resto non merita menzione. Ciò che le persone di solito intendono quando
vogliono sapere quante persone sono state prima di loro, è "Quanto sono
speciale?" o "Hai più o meno esperienza sessuale di me?". Rassicurateli su
quanto vi piacciono e che buon amante sono e (si spera) smetteranno di
ossessionarsi sul passato.
Troppo tardi! Lo sanno già.
Hanno
sentito da un terzo che avete avuto molti amanti oppure avete già confessato? Se
è un amico che ha puntato il dito, dite: “Non sono sicura del motivo per cui X
te l'ha detto. Sono l'unico che conosce la mia storia sessuale e preferisco
parlare del nostro futuro piuttosto che del nostro passato.” Se avete confessato
la verità e desiderate non averlo mai fatto, dite: 'Mi dispiace se ti senti
minacciato da quanti amanti ho avuto. Te l'ho detto perché mi sentivo al sicuro
nel rivelare informazioni molto intime e confidavo che non mi avresti giudicato
per questo. Spero che sia così.” Se vi stanno giudicando, ditegli - con fermezza
- che il tuo passato è affar tuo e solo il futuro è loro. Quindi fagli sapere
che la discussione è terminata. Se non riescono a lasciar perdere, sarebbe il
momento di riflettere sulla relazione. La maggior parte delle donne ha
abbastanza vergogna sessuale nella propria vita. Di sicuro non ne avete bisogno
da qualcuno che dovrebbe amarti e vuole renderti felice.
Avete un fetish che non
approvano.
La risposta per affrontare questo dipende se vogliate continuare ad assecondare
le vostre fantasie. Supponiamo che vi piaccia un leggero BDSM: l'idea di fruste
e catene vi eccita e in passato avete frequentato club fetish. È qualcosa che in
precedenza vi piaceva ma ora siete felici di lasciar perdere perché il vostro
partner non è coinvolto? In tal caso, il miglior punto di partenza è istruire il
tuo partner sul vostro fetish. Ad esempio, se si tratta di BDSM, fate qualche
ricerca sul legame tra piacere e dolore (troverete molto) e le ragioni
psicologiche per cui fa appello a così tante persone (di nuovo, in abbondanza),
poi parlatene con loro. Dite: "So che non approvi/non capisci perché ho
esplorato X sessualmente ma volevo spiegarti perché mi piaceva". Ci sono molti
miti urbani che circondano qualsiasi comportamento sessuale non conforme al
gioco di coppia "standard". Dissolvete quelli più ovvi e incoraggiate il vostro
partner a chiedere domande. Chiedete perché lo trovano così ripugnante/poco
attraente? Potrebbero essere sorpresi, o persino incuriositi, una volta fornite
le giuste informazioni. Sono rimasti ancora meno colpiti dopo che avete spiegato
tutto? È il momento per la conversazione "quello che ho combinato prima sono
affari miei". Non è il loro posto o il loro diritto giudicarvi su ciò che avete
scelto di esplorare sessualmente prima di incontrarli. Le fantasie di una
persona sono sempre state il "che schifo" di un'altra. Supponendo che il vostro
fetish non sia qualcosa di così estremamente scioccante che farebbe impallidire
anche l'amante più permissivo e avventuroso, non importa se non piace a loro
personalmente. Dovrebbero rispettare il vostro diritto al piacere. Ancora una
volta, chiariste che non chiederete scusa ma siete aperte a dare spiegazioni e
dovrebbero capire che rifiutate di essere giudicate. Se vi vergognate, parlate
del perché e forse spiegate le circostanze che hanno portato alla vostra
decisione di assecondare i vostri desideri. Prendiamo tutti le decisioni
migliori in base a ciò che abbiamo a disposizione in quel momento.
E se volessi continuare ad
assecondare il mio fetish?
Rompere una relazione per un fetish potrebbe sembrare estremo, ma
dipende da quanto divertimento ottenete dal sesso senza di esso. Se il vostro
partner non condivide l’interesse, potrebbe essere un campanello d’allarme che
non siete compatibili in altre aree. Anche se lo siete, quello che da evitare è
che si sentano spinti a provare qualcosa che non vogliono e che vi sentiate
insoddisfatte facendo sesso che non ti eccita. Avete due opzioni in questo
scenario: trovare un nuovo fetish che interessa a entrambi o concedervi un
assolo, se possibile. Ciò potrebbe significare usare giocattoli sessuali,
guardare porno o praticare in sicurezza i setish su voi stesse. Se il partner è
d'accordo, potreste interpretare la fantasia senza farlo davvero (un piccolo
scherzo potrebbe persino indurlo a cambiare idea). Un'altra opzione se siete
entrambi aperti è avere una relazione aperta o ricevere un "pass" per concedervi
delle scappatelle occasionali.
Avete tradito i partner
precedenti.
La ricerca non funziona a vostro favore per questo: la maggior parte supporta il
detto "una volta imbroglione, per sempre imbroglione". Un vero traditore seriale
non ha una bussola morale e spesso non vedrà nulla di sbagliato nell'essere
infedele. Ma non siete voi, vero? (Se lo fosse, difficilmente stareste facendo
clic su una storia su come espiare i tuoi peccati sessuali - i veri imbroglioni
non pensano di averne). È probabile che voi abbia tradito per un altro motivo.
Alcune persone tradiscono nelle relazioni in cui non sono felici. Altre hanno
relazioni per punire per un partner che ha fatto loro un torto, oppure se si
sono sentite ignorate o non amate. Spiegate le circostanze alla base del motivo
per cui avete fatto quello che avete fatto. Rassicurate il partner che la vostra
relazione è diversa dal resto, caricando su molte ragioni lusinghiere sul
perché. Potreste anche voler parlare di come vi troviate mentalmente in un posto
molto diverso ora rispetto ad allora, sempre se è vero. Se chiariste che vi
pentite di quello che avete fatto, le circostanze ora sono completamente diverse
e che non avete intenzione di tradirle mai, potrebbero decidere di darvi una
possibilità. Ma probabilmente ad alcune condizioni. Molte persone che scoprono
che il loro nuovo partner aveva l'abitudine di tradire in passato potrebbero
chiedere di essere completamente trasparente, almeno all'inizio. Sì, significa
conoscere la password per i vostri account, magari essere autorizzati a
sbloccare il vostro telefono, forse anche configurare un'app di monitoraggio. Se
intendete onestamente mantenere il naso pulito, questo potrebbe essere qualcosa
su cui siete d'accordo. Sì, è un'invasione della privacy. Ma se siete d'accordo
che potreste correre il rischio, è nel vostro interesse essere d'accordo. Una
volta stabilita la fiducia, è allora che potete rinegoziare più libertà.
Dagotraduzione per Dailymail.com il 16 aprile
2021. Su Reddit circola un thread diventato virale in cui alcune donne, che
pensano di essersi accontentate quando hanno scelto il loro compagno di vita
rinunciando al vero amore, raccontano come vivono oggi la loro relazione. Le
storie si alternano: chi divorzia dopo anni di infelicità, chi si è innamorato
del partner e oggi è felice. «Vent’anni di matrimonio e tre figli dopo, siamo
ottimi partner e formiamo una grande squadra. Tuttavia, sono un po’ triste per
quanto poco abbiamo in comune oltre questo» scrive un’utente. Un’altra ammette
che «non è sempre facile». Ancora: «Mio marito mi adora ed è un brav'uomo ma non
mi soddisfa intellettualmente, è emotivamente immaturo e siamo su pianeti
diversi per quanto riguarda il desiderio sessuale. È una lotta, ma non è un
incubo». «Abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma ad essere onesti, era lui -
solo che non lo sapevo in quel momento. A volte "quello giusto" è un ideale
basato su priorità giovanili, ma con la maturità ti rendi conto che alcune di
queste qualità non sono più così importanti...» Tuttavia, non tutti sono stati
così fortunati nelle loro relazioni nel corso degli anni. «È triste e noioso, ma
sicuro» ha condiviso un’altra utente di Reddit. «Mi manca "quello giusto" a
volte, ma siamo solo amici e non potremmo mai essere più di questo. O va così
oppure è la solitudine totale, così almeno ho un compagno, il sesso e qualcuno
che mi ama davvero. Anche se darei il mio braccio destro per avere il mio vero
amore, ma eccoci qui». Molte delle donne che hanno commentato il thread hanno
detto di amare i loro partner ma di non essere innamorate di loro. «Sta andando.
So che non è giusto, ma è una brava persona», ha scritto una mamma. «A volte
voglio molto di più. In questo momento, mi costerebbe così tanto andarmene, e lo
amo. I nostri figli hanno un ottimo sistema di supporto tra di noi e viviamo una
vita dignitosa». Altre hanno parlato dei loro divorzi, insistendo sul fatto che
la vita è troppo breve per stare con qualcuno che non ami: «Finalmente è finita
poco meno di tre anni fa, dopo un decennio di alti e bassi. Ora voglio vivere
una vita felice con qualcuno, quello giusto». Un’altra: «Ci siamo sposati e
abbiamo avuto figli troppo giovani. Sono single da due anni e mi sono
letteralmente innamorata di me stessa! Meglio essere felici e soli che soli e
sposati».
Eleonora Barbieri per “il Giornale” il 14 aprile
2021. Per spiegare che lavoro faccia, Lawrence Josephs parafrasa Amleto:
«Tradire o non tradire? Questo è il problema». Professore di Psicologia alla
Adelphi University, nello Stato di New York, psicoterapeuta familiare e di
coppia nella capitale mondiale della psicoterapia di coppia, la Grande mela,
Josephs è un esperto di Infedeltà (Raffaello Cortina Editore, pagg. 322, euro
26), come si intitola il suo saggio. All'inizio del quale esprime un
comprensibile e «speciale debito di gratitudine» verso la (da oltre trent'anni)
moglie Laura...
Professor Josephs, lei spiega che l'infedeltà è un
trauma a tutti gli effetti, tanto che spesso i traditi soffrono di disturbo
post-traumatico. Perché?
«Il tradimento sessuale è un trauma perché
qualcuno di cui ti fidavi e su cui facevi affidamento ti ha ingannato, perciò
non puoi più credere che ti dica la verità. Inoltre, sentire che il tuo partner
preferisce fare sesso con qualcun altro provoca insicurezza, gelosia e
umiliazione. Ti può fare sentire sessualmente inadeguato e, quindi, non
attraente e non amabile».
Provoca angoscia?
«Certo, ti preoccupi che il tuo partner possa
abbandonarti, e tutte le sue rassicurazioni del contrario suonano false. Puoi
essere pieno di rabbia omicida e sopraffatto dal desiderio di farla finita.
Senti che la tua vita e la tua innocenza sono rovinate per sempre».
C'è un dibattito diffuso sul fatto che la
poligamia sia «naturale» e la monogamia «culturale». Che cosa dice la scienza?
«La monogamia è naturale perché in nessuna specie
la cura paterna si evolve senza la monogamia. D'altra parte, anche l'infedeltà
può essere adattativa: gli uomini possono avere figli con più donne, mentre le
donne possono ottenere materiale genetico migliore per la prole e maggiori
risorse. Quindi sia la monogamia, sia l'infedeltà sono naturali».
E che cosa è culturale?
«Gli atteggiamenti nei loro confronti. La maggior
parte delle culture ha un doppio standard, che favorisce l'infedeltà maschile.
Quando si tratta di riproduzione, l'umanità ha strategie di accoppiamento
plurime e dispiega quella migliore a seconda della situazione».
Perché allora l'infedeltà suscita tanto dibattito,
anche ideologico?
«Perché noi intuiamo quale sia il nostro interesse
riproduttivo individuale e non vogliamo che sia messo a rischio, o giudicato».
C'è un atteggiamento tipicamente maschile o
femminile verso l' infedeltà?
«È più probabile che gli uomini tradiscano
cercando del sesso casuale, e le donne alla ricerca del romanticismo che manca
nel matrimonio. Ma entrambi, maschi e femmine, si sentono egualmente
traumatizzati dal tradimento».
Il 23 per cento degli uomini coniugati e il 12 per
cento delle donne coniugate ammettono relazioni «extra», e il tasso sale fra i
non sposati. In futuro l'infedeltà regnerà sovrana?
«I tassi di infedeltà e di cambio di partner sono
più elevati fra i teenager e i giovani adulti, che praticano una monogamia con
benefit. Con il matrimonio e la famiglia, i costi dell'infedeltà salgono... Le
persone sembrano diventare più monogame con l'età, anche se perfino gli anziani
sono infedeli».
Perché la gelosia è così importante nelle
relazioni?
«Le persone vogliono sentire che la loro relazione
romantica è unica e speciale. Se puoi essere rimpiazzato da un rivale, beh, non
sei così unico e speciale, e la tua autostima ne risente. Ti senti inadeguato
nel confronto sociale rispetto al rivale che ti ha rubato l'affetto, l'amore e
il desiderio sessuale del partner. A nessuno piace essere rimpiazzato».
La gelosia è un sentimento universale?
«Sì, perfino nelle società sessualmente
permissive, dove i tassi di infedeltà sono alti, ci sono comunque la gelosia e i
crimini passionali, e gli uomini si rifiutano di crescere figli che sospettano
non essere biologicamente loro. La possessività sessuale sembra universale nella
natura umana ed è per questo che di solito i traditori sono ipocriti: vogliono
fare sesso con più partner, ma non vogliono che i loro partner facciano
altrettanto».
Si può predire un comportamento infedele?
«Le persone che hanno un grado elevato di
narcisismo, psicopatia, intelligenza machiavellica e hanno un attaccamento
insicuro, mentre hanno bassi livelli di autenticità, empatia, riflessività e
senso di colpa è più probabile che siano infedeli».
E quali sono i fattori che più scatenano il
tradimento?
«Frustrazione sessuale per gli uomini sposati e
mancanza di intimità emozionale per le donne sposate».
Quali sono le reazioni comuni a un tradimento?
«Dolore, gelosia, umiliazione e rabbia omicida
sembrano essere risposte universali e trasversali, in tutte le culture».
E come influenza la vita delle persone?
«Influenza la vita dei figli, causando gli stessi
problemi emotivi di un divorzio. E crea un danno alla reputazione all'interno
della comunità di riferimento».
Si può tornare a essere una coppia dopo un
tradimento? E come?
«Ricostruendo la fiducia. Il partner tradito deve
tornare a credere che il partner infedele non sia più un bugiardo e un
imbroglione. Non tutti, però, vogliono guarire dall'infedeltà. Alcuni possono
non perdonare e cacciare il partner infedele, altri pretendono una non-monogamia
consensuale per restare all'interno del matrimonio».
La fedeltà è ancora possibile, nel nostro mondo?
«Sì, in molte culture la fedeltà è ancora più
comune dell'infedeltà. Alcuni tradiscono una volta sola e poi non lo fanno più,
perché stanno troppo male per ciò che hanno fatto. I casanova seriali non sono
la norma... La maggior parte delle persone sogna di avere una relazione di
successo sessualmente esclusiva e a lungo termine e insiste nel provarci. Alcuni
non ci riescono mai; altri invece, dopo molti tentativi, ce la fanno».
DAGONEWS il 17 gennaio 2021. Avete mai spiato il
vostro partner? Pensateci prima di farlo visto che oggi è diventato talmente
semplice che una singola tentazione potrebbe rovinarvi la vita. Parola della
sexperta Tracey Cox che spiega come dallo “spionaggio” non arrivano mai buone
notizie. «Se lo fai per "rassicurazione", smetti di prenderti in giro. Spiare
non placa le tue paure, alimenta la gelosia perché se trovi qualcosa che sembra
sospetto, ti faRà diventare pazzo visto che non puoi chiedere spiegazioni. E il
nostro cervello fa sempre un ottimo lavoro nell'immaginare il peggio. Se ti
arrendi e confessi quello che hai fatto, il tuo partner (giustamente) si sentirà
indignato perché non ti sei fidato e hai invaso la sua privacy. Si perde in ogni
caso. Chi ha spiato il partner non lo rifarebbe e il motivo è nelle loro
storie».
Le storie di chi ha spiato il partner. «Ogni volta
che ho ficcato il naso, ho trovato qualcosa che non mi piaceva. Quasi sempre non
era nulla, ma ogni volta che trovi qualcosa, ti divora dentro e non puoi fare a
meno di confrontarti con il tuo partner. Poi c'è - inevitabilmente - un litigio
enorme, ti dà una spiegazione perfettamente logica e ti senti un idiota».
«Quando il mio ragazzo si è trasferito da me, ho aspettato che andasse al lavoro
e poi ho controllato ogni cosa. Sono stata ricompensata da vecchie lettere
d'amore e foto di lui con altre donne. Aveva 42 anni, ovviamente aveva un
passato. Mi ha colpito. Volevo disperatamente chiedergli se mi amava più di
quelle altre donne, ascoltare le storie dietro a quelle foto. Alla fine, ero
così disperata che ho confessato quello che avevo fatto e ho chiesto
rassicurazioni. Mi ha guardato, è andato in camera da letto, ha fatto le valigie
e mi ha mollato. Ha detto che non aveva senso continuare se non aveva la mia
fiducia». «Ho spiato e beccato il mio partner e non me ne pento. Mi aveva
tradito con la mia migliore amica. Sono andata direttamente da un avvocato e
siamo stati in grado di usare quello che avevo trovato come prova per ottenere
un accordo di divorzio più equo». «Il problema dello spionaggio è che crea
dipendenza. Diventa un'abitudine. Ero sospettosa per un rapporto che aveva con
un’amica e lui si fidava e ha lasciato il computer acceso. Ho subito stabilito
che aveva uno schema. Se le cose andavano bene tra noi, non aveva nessun
contatto. Se andavano male si metteva in contatto con quella persona. Dopo un
po', ho capito che non gli interessava altro che essere amici e lui non sarebbe
mai andato via, ma non riuscivo a smettere di ficcare il naso. Inutile dire che
la relazione è finita». «Molto tempo fa, sono tornato a casa presto e ho
scoperto che mia moglie faceva sesso virtuale con un ragazzo che aveva
incontrato online. Ci siamo subito separati, ma lei mi ha detto di voler
lavorare al matrimonio e di non avere una relazione con lui. Non sentivo di
potermi fidare di lei e, conoscendo la sua password, sono entrato nei suoi
account di posta elettronica e sui social media. Ho scoperto che aveva parlato
male di me con tutti e aveva ancora in programma di incontrare questo ragazzo di
persona. Avevo il cuore spezzato. Pensereste mai che potremmo stare ancora
insieme? Siamo sposati da 12 anni, abbiamo due figli e un mutuo». «Se non avessi
spiato mio marito, non avrei scoperto che non solo aveva una relazione, ma aveva
messo incinta una donna».
Quali sono le cose peggiori trovate durante lo
spionaggio. «Un paio di mutande logore in tasca». «Lunghe ciocche bionde di
capelli sul sedile posteriore della nostra macchina. I miei capelli sono corti e
castani». «Ho guardato nel cesto della biancheria e ho scoperto che le sue
mutande erano macchiate di sperma e non avevamo fatto sesso quella settimana».
«È arrivato tardi dopo una serata fuori con i ragazzi e io ero sospettosa, così
mi sono offerta di dargli un pompino. Puzzava come se avesse appena fatto sesso
e ho trovato una ciocca di capelli - che non era la mia - avvolta intorno alla
testa del suo pene». «Ho scoperto una foto del pene del suo collega». «Una pila
di giocattoli sessuali che erano stati usati e non lavati». «Dalla cronologia è
emerso che guarda ore di porno gay».
Simona Bertuzzi per “Libero
quotidiano” il 28 febbraio 2021. Non è un partito e non è femminista ma è come
se lo fosse perché vanta un mucchio di iscritte incazzate decise a chiedere la
testa del maschio di turno. Sono le donne tradite del nuovo millennio. Si
trovano in rete come al tavolino del bar. Non sussurrano, non si lasciano
scappare risatine isteriche, scrivono come forsennate sulla tastiera del
portatile sfogando rabbia e frustrazioni chi reclama vendetta, chi cerca una
spalla su cui piangere, chi sceglie di andare avanti ma non si dà pace perché la
fine di un amore è un tarlo che scava l' anima. La maggior parte scopre il
tradimento per caso, qualcosa che sfugge al controllo del compagno, un attimo di
distrazione, il cellulare mollato sulla credenza, e le martiri della
cornificazione (categoria umanissima, a tratti letteraria) agguantano l' iphone,
scandagliano whatsapp, violano password, scovano il messaggio riposto in una
memoria parallela mentre un sudore freddo corre lungo la schiena, le gambe
tremano e l' ansia sfocia in rivoli che sputano conati di bile... oddio non
respiro, oddio mi trema la terra sotto i piedi ecco perché non fa l' amore con
me, ecco perché ha finito il viagra, ecco perché si è messo a dieta, ora lo
chiamo e lo insulto, vendetta lenta e violentissima, anzi lo uccido, oppure
resto e lo lascio parlare, ci sarà una ragione, magari sono io quella sbagliata,
oh povero amore mio, dai che passa e poi forse torniamo insieme.
SALE DELLA VITA. Non
spaventatevi ma di confessioni così se ne trovano a mucchi in rete. Pagine
facebook nate dal nulla. Mogli tradite, fidanzate tradite C' è persino un sito
che non ci ricama sopra, donnetradite.it, e raccoglie le storie di tante donne
che sono state tradite o lo saranno a breve e non lo sanno. I primi messaggi
sono di sette anni fa, gli ultimi di aprile, che anche il covid ha spento gli
entusiasmi dei fedifraghi. Entriamo per curiosità e per umana debolezza e si
apre una valle di lacrime, lenzuola sgualcite, ammiccamenti alla scrivania,
rapporti clandestini, scuse diaboliche, dove il maschio non ne esce benissimo e
le donne paiono appartenere a una silenziosa confraternita che è quasi un
ristoro e una forza per cuori afflitti. Ciò che proviamo - scrive la fondatrice
ovviamente tradita quando stava per credere alla favola dell' amore eterno -
«non è un dolore nuovo ma una sofferenza che molte donne hanno sperimentato o
sperimenteranno. Il che ci fa forse sentire meno uniche nel nostro martirio».
Decine i messaggi di sfogo. E nulla è lasciato al caso. Il tradimento ha una sua
fenomenologia, è un' abitudine antica che serpeggia nelle vene e corre lungo i
secoli. Intendiamoci. Chi scrive non pensa che il fedifrago debba essere
necessariamente maschio - il tradimento appartiene agli uomini come alle donne e
secondo una recente ricerca cornificare sarebbe il sale della vita e di un
matrimonio perfetto (l' Associazione avvocati matrimonialisti italiani ritiene
che il 55 % dei mariti e il 45 % delle mogli abbia tradito almeno una volta). Ma
chi ha fatto il sito è convinta che gli uomini «aggiungano al tradimento una
noticina di disgusto». E giù i racconti. Si va per fasce di età. 25-35, 36-50,
over 50, in fondo anche le corna richiedono una catalogazione. Fascia 25-35.
Siamo nell' ambito delle fragili studentesse appena uscite dal liceo e ignare
delle tribolazioni della vita. Usiamo nomi di fantasia che la materia è
delicata. Parla Fabrizia: «Sono una ragazza di 26 anni, fidanzata da 9 e speravo
che potesse durare fino alla vecchiaia. 9 mesi fa il mio ragazzo mi confessò che
andava a prostitute» e quasi si sentiva fiero, un salvatore di anime. Cinzia ha
29 anni, lui 4 di più, stanno insieme da una vita ma il ragazzo a un certo punto
fa l' Erasmus, presente i famosi viaggi studio per studenti? beh grave errore,
perché da bravo fidanzato si trasforma in un mostro di doppiezza: «mi ha tradita
6 volte più altre 4 situazioni scabrose, non ha usato protezioni e ha rischiato
di mettere incinta una, ed è tornato a casa portandomi una bella infezione», in
tutto questo ha avuto «due episodi psicotici, uno in cui si è tagliato i capelli
mentre discuteva con me e uno in cui aveva allucinazioni».
«FARFALLONE». Si entra poi
nella fascia 36-50, zona ambigua per definizione e per le famose crisi della
mezza età. Esperienza disastrate alle spalle, la consapevolezza che se ti
mollano adesso sei finita e quella maledetta menopausa che ti guarda di
traverso. E dunque trovi la Stefania cornuta e mazziata che si sente un tantino
presa per il culo, perché l' altra stavolta è un lui. Morale «lui si era messo
su una chat di feticisti dei piedi e un tizio lo aveva contattato e gli aveva
chiesto sue foto nudo con piedi in evidenza e poi ha organizzato un incontro in
albergo». Saveria invece ha 46 anni, lo stesso uomo da che ne aveva 15 e si è
accorta solo adesso che il consorte è un maniaco sessuale. In pratica dopo un
pomeriggio di sesso in cui lei lo accontenta come una geisha, il maritino «è
capace di chiudersi in un' altra stanza e fare sesso con altre donne online». C'
è la signora di 44 anni, che si dichiara sposata da 23 a un deficiente. «Ci
siamo conosciuti da ragazzi. Lui è sempre stato il classico farfallone, che
flirta pure davanti a me, ma che poi non va mai al sodo. Fino a un maledetto
giorno». E che dire della povera Mara, non fa in tempo a seppellire il marito
che il fantasma della buon' anima torna ad assillarla con le cazzate che ha
fatto in vita, «mentre sistemavo le sue cose, ho scoperto che mio marito ha
tenuto un' assidua corrispondenza con molte donne. I messaggi sono affettuosi,
romantici, spesso con fantasie erotiche». E maledetta morte che se l' è preso,
«non ho nemmeno la possibilità di chiedergli spiegazioni» e mandarlo forse a
fanculo. Mariangela ha più di 50 anni ed è incazzata nera. «Ho scoperto un
volgare messaggio di auguri sul suo cellulare Terminava con ti adoro mandrillo
mio! È successa l' ira di Dio! Volevo ucciderlo a coltellate. Lì per lì ha
ammesso tutto, ora nega. Ma io so So che ho trovato medicinali per la
disfunzione erettile, confezioni semivuote che non ha usato con me». Quanta
amarezza.
La segreteria sexy è un cliché
intramontabile. Poi ogni tanto spunta l' uomo tradito. Come Paolo, padre di tre
bei ragazzini, che per la moglie irrequieta si svena e compra l' appartamentino
dove lasciarla sbollire, ma capisce di essere più amico che marito, insomma lei
si diverte altrove. Interessante la sessione dedicata alle amanti che non sono
sempre le stronze che si pensa: «Lui è sposato da 30 anni e io pagherei oro
perché si lasci con la moglie ma sono sempre stata rispettosa del suo
matrimonio. Un mese fa però ho dato una sbirciatina al suo telefono e sta da un
anno con una donna. Voglio morire». Comunque sia chiaro. Questo confessionale di
anime perse si rivolge a tutti gli uomini che tradiscono senza dignità, che
recitano la parte dei depressi, che vedono le loro compagne spegnersi e se ne
fregano. A questo punto per par condicio dovrebbe sorgere un analogo maschile,
una specie di contraltare che dica i peccati delle donne e santifichi un pochino
i maschi. Ma dubitiamo che accada perché tra i signori vige una certa omertà, e
a loro piace raccontare prodezze non certo le corna che hanno sulla testa.
Ps: pezzo leggero da
maneggiare con disincanto, senza scomodare sessismo e affini.
Brunella Bolloli per “Libero quotidiano” il 16
gennaio 2021. Cornuta e mazziata, tradita e condannata: insomma, è andata male a
una cinquantenne ligure che voleva la prova d' amore del suo lui. La donna,
gelosissima, aveva dei sospetti, captava la distanza che si era creata nella
coppia e non si accontentava delle scuse o delle finte rassicurazioni del
compagno: «Ma dai, cara, non fare la sciocchina, va tutto bene, ti amo come il
primo giorno», eccetera eccetera. Balle. Il compagno aveva un' altra e chissà da
quanto tempo la relazione andava avanti, chissà da quanto si destreggiava tra la
fidanzata ufficiale e l' amante, viaggiando per le strade della riviera con
puntatine in Costa Azzurra e cenette nei locali con vista mare. La cinquantenne
dentro si struggeva e forse, come solo certe donne sanno fare, lo riempiva di
domande, dubbi, telefonate per sapere dov' era e, soprattutto, con chi era. Lo
controllava quasi come una stalker, gli faceva il terzo grado, gli dava il
tormento. Il compagno, ovviamente, come solo gli uomini sanno fare, negava
tutto, si arrampicava su salite ripidissime di specchi, inventava la qualunque,
giurava di essere stato con i colleghi, con la mamma, con la bisnonna defunta,
con il maestro d' asilo, dal dentista per l' ennesima carie, perfino con il
peggior nemico pur di tenere nascosta la sua tresca alla consorte. La quale,
sempre più sospettosa, un giorno è entrata in un negozio di elettronica e si è
fatta vendere una Mica, una microspia per intercettazioni a distanza collegata
ad una scheda sim che aveva intestato a suo nome. Ha piazzato la cimice nell'
automobile di lui e si è messa in ascolto. Così ha scoperto il tradimento. La
Mica, infatti, ha registrato gli amplessi dell' uomo con l' amante a bordo dell'
utilitaria, i gridolini di lei e le parole di lui, il quale, evidentemente, non
sapendo dove andare a consumare con la nuova fiamma senza correre il rischio di
essere beccato dalla compagna virago, si appartava in macchina, sulle alture tra
Bordighera e Ventimiglia, dove poteva, ma intanto ovunque andasse la cimice
registrava, per cui addio privacy. La vicenda è cominciata nel 2016 e dall'
amore (malato) si è passati alla trafila giudiziaria. La signora, infatti, pur
di stanare il compagno fedifrago si era trasformata in una 007 in gonnella,
faceva appostamenti continui, scenate, ma anche incursioni nella vita privata
del fidanzato, come quelle attraverso la cimice posizionata sulla Nissan di lui.
La cinquantenne di Valle Crosia, avendo colto in fallo il moroso, dopo lo shock
pensava, forse, di essere pronta per essere assunta alla Cia o in qualche task
force di servizi segreti, tipo quelle che il premier Conte avrebbe voluto
organizzare. Invece è stata condannata a 8 mesi di reclusione per avere vìolato
la privacy della sua "vittima". Il reato si chiama «illecite interferenze nella
vita privata» ed è previsto dal codice penale (articolo 615 bis) anche se,
finora, la casistica riporta molti più episodi a carico dei maschi che delle
femmine, visto che sono più spesso gli uomini a pedinare, fotografare,
registrare le mogli o le ex alla ricerca di presunti amanti o, semplicemente, a
spiare le donne nude negli spogliatoi della palestra o perfino dalla finestra di
fronte (va distinto caso per caso). Il delitto è punibile a querela della
persona offesa, il che significa che il traditore, scoperto, ha denunciato la
tradita. La cinquantenne si è vista applicare dal giudice Francesca Minieri di
Imperia la misura condizionale, subordinata al pagamento di mille euro di
provvisionale e 2mila euro di spese legali. La sua colpa, infatti, è di avere
utilizzato una microspia per intercettare il partner, il quale viveva un incubo.
Il rischio insito in queste attività di spionaggio da dilettanti è che poi c' è
sempre qualcuno più esperto e capace nel ramo. Infatti, quando il cornificatore
ha trovato la cimice sulla sua auto si è rivolto a veri investigatori privati
per la bonifica del mezzo e dell' abitazione, così gli 007 sono risaliti alla
compagna, ormai ex, ed è scattata la denuncia. Forse bastava solo dire prima la
verità.
·
Essere Single.
DAGONEWS il 29 marzo 2021. Volete non fare
arrabbiare la vostra amica single? E allora seguite i consigli dell’esperta di
dating britannica Hayley Quinn che alla rubrica FEMAIL racconta come ci
sarebbero alcune frasi, all’apparenza innocue, che potrebbero causare un
sentimento di “single-shaming”’ perché suggeriscono che una persona dovrebbe
fare del suo meglio per trovare un partner. Ecco le cinque frasi o domande da
evitare per offendere che ci ascolta:
“Non hai ancora incontrato nessuno?” La parola
chiave qui è "ancora", che suggerisce che la persona debba sbrigarsi a trovare
un partner. Inoltre, la frase indica che non ci siano molte scelte riguardo al
fatto se uno abbia voglia di una relazione o meno. Delle ricerche sul sito
Match.com dimostrano che il 59% degli utenti single sono felici delle proprie
vite così come sono; di questo 59%, il 61% vorrebbe trovare un partner, ma non
si precipiteranno in una relazione con la persona sbagliata.
“Conosco la persona giusta per te”. Come tante
altri casi di single-shaming, il problema di questa frase è che è piena di
supposizioni riguardo la persona single e la sua necessità di trovare un
partner. Secondo l’esperta non c’è niente di peggio che obbligare una persona a
entrare in una relazione, anche quando lo si fa con buone intenzioni.
“Ci devono essere file di persone che vogliono
uscire con te”. Anche se può sembrare un complimento, dire a qualcuno di avere
molti ammiratori potrebbe assumere un tono sbagliato. Per esempio, l’idea che
“ci sono tanti pesci nel mare” potrebbe ritorcersi contro nel caso in cui la
persona abbia già speso molto tempo nel cercare un partner. Inoltre, commenti
del genere potrebbero attirare un’attenzione scomoda nei confronti della persona
in cerca di partner.
“Stai frequentando qualcuno di speciale?”
Solitamente, quando si fa questa domanda si sta semplicemente cercando di
chiedere della vita sentimentale, però potrebbe rivelarsi problematica per
diversi motivi: Innanzitutto, molte persone single potrebbero già avere persone
‘speciali’ nelle loro vite; infatti molte persone single hanno tante relazioni
platoniche a cui danno tanto valore come amici o parenti. Secondo, la domanda
suggerisce implicitamente che qualsiasi relazione più casuale non abbia lo
stesso valore di relazioni più ‘serie’. Sarebbe come chiedere “hai già
incontrato il tuo futuro sposo?”
“Perché pensi di essere ancora single?” Così come
negli altri casi, la domanda suggerisce implicitamente che sia sbagliato essere
single, e che ci sia qualcosa da sistemare. Invece di vedere la relazione come
il culmine naturale per tutti, bisogna dare l’opportunità alle persone di
esprimersi individualmente e seguire il proprio destino. Un altro motivo per cui
questa domanda potrebbe essere frustrante è che anche se uno sia in cerca di un
partner, potrebbero non esserci motivi in particolari per cui si è single.



 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996

 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS:



